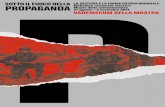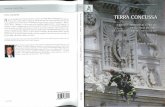La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia): dall'approvvigionamento della...
Transcript of La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia): dall'approvvigionamento della...
1. L’insediamento di San Giusto
Il sito di San Giusto, fino a pochi anni fa del tuttosconosciuto, è stato individuato casualmente nel 1995,durante i lavori per la costruzione della diga sul torren-te Celone (Volpe 1998, 2000a, 2001a, 2001b, 2002 e2003; Volpe et al. 1999, 2001) (fig. 1A). Le ricerchestratigrafiche, che hanno riguardato una superficie dicirca m2 5.000, pari a poco meno della metà dell’areaarcheologica residua (circa m2 12.000) (fig. 1B), hannoconsentito di ricostruire, almeno nelle linee generali, lalunga e complessa storia di questo insediamento ruraledel Tavoliere settentrionale, posto a breve distanza dacentri urbani importanti come Luceria, Aecae (l’attualeTroia) e Arpi. Nell’area di San Giusto, dove verosimil-mente in età tardorepubblicana e primoimperiale eracollocata una piccola casa colonica inserita nella gran-de centuriazione nota nel territorio, fu costruita una
47
grande villa, dotata di lussuosi ambienti residenziali edi un ampio settore produttivo. Nel V secolo alla villa,forse parte delle proprietà imperiali ben documentatenella zona, afferenti al saltus Carminianensis della resprivata (NDOcc 12.18), si affiancò una chiesa a trenavate, provvista di un imponente battistero a piantacentrale e decorata con mosaici policromi e altri ricchiarredi; tra V e VI secolo il complesso paleocristiano siampliò con la costruzione di una seconda chiesa, paral-lela alla prima, specificamente destinata a funzionicimiteriali, ed anche con l’aggiunta di altri vani annes-si, tra cui un piccolo edificio termale. Il complessopaleocristiano di San Giusto, interpretabile forse comela sede della diocesi rurale retta tra la fine del V e iprimi anni del VI secolo, da Probus episcopus Car-meianensis (MGH AA 12, 437; 453), acquisì, quindi, lafisionomia di una chiesa doppia, caso unico al momen-to noto in Puglia e in buona parte dell’Italia centro-meridionale, ma, com’è noto, assai diffuso nell’areaaltoadriatica e in Dalmazia.
Gli strettissimi rapporti di questo sito pugliese conla Dalmazia e in particolare con Salona sono bendocumentati non solo dalla tipologia della chiesa dop-
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia):dall’approvvigionamento della materia prima
alla commercializzazione del manufatto
di Elisabetta Gliozzo 1, Maria Turchiano 2, Consuelo Fortina 1, Isabella Memmi 1, Giuliano Volpe 2
Cooking pottery production in San Giusto (Lucera, Foggia): from raw material supply to the artefact commercialization
Fortuitously discovered during the construction of the dam on the Celone stream, San Giusto site has been object of anemergency intervention in 1995, followed by 4 seasons of stratigraphic excavation, since its definitive submersion in year2000. In 1999, the archaeological investigation brought to light the evidences of several handcraft activities, like wine andgrain production and wool and leather treatment. The discovery of a ceramic kiln is of particular importance because ittestifies the local production of ceramics as well. Within the structure, numerous fragments of globular jars with externalflutes, rounded base and small handles have been found, reasonably produced during the last firing process developed inthe kiln before the abandonment. The archaeometric analysis have been thus finalized to the “reference group” creation, inorder to establish the identity card of San Giusto production and to make available a further instrument to determine theprovenance of other ceramic of unknown origin. Optical microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence, inductively-coupled plasma optical emission spectrometry, scanning electronic microscopy, were applied to the study of the 52 ceramicsamples (36 globular jars found within the kiln and 16 from the archaeological site) and 14 samples of fluvial sediments,occurring in the territory nearby the archaeological site. The analytical techniques applied to the research provided both thechemical and mineralogical-petrographical characterization of the ceramic sherds, of raw sediment and of theirgranulometric fractions (sand, coarse silt, fine silt and clay). The localization of the production site, the typological analysisof the ceramic production and the geological study of the surrounding territory further provided the necessary information toreconstruct the production cycle. The production of the jars implied the local supply of fluvial sediments, avoided acomplicate elaboration of the paste (using as received sediments), used a low firing temperature (between 600°C and750°C) and was surely finalised to satisfy, at least, the local market.
Key-words: cooking pottery, Apulia, San Giusto, reference group, production cycle.
1 Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Siena,e: [email protected].
2 Dipartimento di Scienze Umane - Università di Foggia, e:[email protected]; [email protected].
pia, ma anche dai caratteri dell’intera documentazionearchitettonica, musiva, ceramica. I collegamenti tra laPuglia settentrionale e la Dalmazia erano peraltrodiretti e sistematici, favoriti anche dalla rotta transa-driatica attestata dall’Itinerarium maritimum traSipontum e Salona, i cui porti erano distanti solo1.500 stadi (a Salonas Sipunte stadia MD). La vitadella basilica doppia fu però abbastanza breve. Tra lametà e la fine del VI secolo si verificò infatti unincendio che distrusse il tetto e provocò il crollo deglielevati della chiesa A, che fu abbandonata e in partespogliata di alcuni elementi architettonici, forse ancheper effetto di un ridimensionamento demografico einsediativo del sito e delle campagne circostanti. Sipreferì adottare una scelta rapida ed economica, con-sistente nella ristrutturazione della chiesa B, che fupertanto dotata dei dispositivi necessari per le funzio-ni liturgiche (recinto presbiteriale, sedile per il clero,ecc.) assommando i caratteri liturgico e funerarioprima distinti nei due edifici gemelli. Alcuni interven-
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
48
ti di ristrutturazione riguardarono anche il battistero,che però conservò sostanzialmente la sua fisionomiaoriginaria. L’uso cimiteriale si estese progressivamen-te al nartece e ad alcuni vani annessi alla chiesa. Siapur fortemente ridimensionato, il complesso paleocri-stiano restò quindi in funzione, anche se con una vitasempre più stentata soprattutto nel VII-VIII secolo:nei vani annessi, nel nartece ed anche nel battisterofurono realizzate povere sepolture. Infine tra i crollifurono ricavati rozzi ricoveri, frequentati forse preva-lentemente da pastori (sono stati rinvenuti resti difocolari, fondi di capanne, sepolture realizzate tra lemacerie). Non sembra quindi che l’abbandono dell’e-dificio di culto e dell’insediamento circostante siastato causato da un singolo episodio ma appare proba-bile che si sia prolungato nel corso del tempo, tra VIIe VIII secolo, nel quadro di un generale spopolamentodella pianura a vantaggio di siti di altura (Volpe2001a, De Fino, Romano 2001).
G.V.
1. - A) Posizione geografica ed immagine aerea del sito di San Giusto. B) Planimetria delle aree indagate.
2. La fornace
La fornace, a pianta sub-circolare con pilastrocentrale, è assimilabile al tipo I/a della tipologia pro-posta da N. Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio1971-1972, 1985), corrispondente al tipo I A dellaclassificazione della Le Ny (Le Ny 1988) (figg. 2A-C). È orientata in senso Ovest-Est, con praefurnium
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
49
posto a Est in modo da essere in asse con le correntidel vento di Ponente predominate in questa zona (fig.2A). La camera di combustione e il prefurnio eranocompletamente interrati. Il taglio per la fossa di fon-dazione della struttura, costruita contro terra, fu rea-lizzato in strati di terra che hanno restituito quantitàsignificative di reperti ceramici e vitrei databili intor-no alla metà/seconda metà del V secolo d.C., utili aifini della definizione del terminus post quem per lacostruzione della struttura produttiva.
Il praefurnium, a forma di corridoio lungo circa m1 e largo mediamente cm 50, con i lati leggermentedivergenti verso l’imboccatura (da cm 40 a 60), eradelimitato da due spallette laterali (US 4189-4190)costruite, in blocchi di argilla concotta. La spallettameridionale (US 4190) presenta tracce di un rifaci-mento (US 4191), leggibile nell’impiego esclusivo dispezzoni di laterizi nel paramento interno e sulla cre-sta della struttura; non è possibile cogliere l’eventua-le entità di tale restauro, resosi necessario, probabil-mente, in seguito al cedimento di questa parte dellastruttura, non essendo stati rilevati, in altri punti dellafornace, ulteriori indizi riconducibili ad un eventualeintervento di ristrutturazione.
I muri perimetrali della camera di combustione(US 4052) (diametro variabile tra m 2,71 e 2,81) era-no realizzati con spezzoni di laterizi di dimensioni va-riabili, alcuni dei quali posti con l’aletta in facciata, avista e rivolta verso l’alto, a contenere frammenti la-terizi di minori dimensioni, legati da malta. Le pareti,internamente, erano rivestite da uno spesso strato diargilla concotta e rubefatta dal calore delle cotture.
Il pavimento del forno e del prefurnio era costitui-to da terra battuta (fig. 2B); il rinvenimento, sulfondo (US 4117), di numerosi frammenti ceramicicarbonizzati, mescolati a terra ricca di elementi car-boniosi costituisce, forse, un indizio utile alla rico-struzione delle modalità di formazione della strati-grafia all’interno della fornace e, indirettamente,delle cause che possono averne provocato l’abbando-no. Si potrebbe ipotizzare che questo strato si sia for-mato in relazione alla caduta, sul fondo della cameradi combustione, delle ceramiche in cottura conse-guentemente al crollo del piano forato, o di parte diesso (fig. 2C).
A sostegno del piano forato (US 4053) un pilastrodi forma sub-circolare (il diametro oscilla tra cm 72 e80), costruito con blocchi di argilla concotta, squa-
2. - A) Veduta aerea della fornace. B) La struttura a scavoultimato. C) La fornace in corso di scavo con le olle al suointerno.
drati (cm 36x30x10, 23x10,5, 25x8,5, 26x8, 23x9,21x9), posti in filari ’sfalsati’. Il piano di cottura nonè stato rinvenuto in situ; tuttavia sulla base degli ele-menti recuperati dagli strati di crollo all’interno dellacamera di combustione, è possibile presumere chefosse costituito da blocchi squadrati di argilla concot-ta, rinvenuti in stato frammentario, caratterizzati dafori grossomodo cilindrici.
Uno spesso strato di malta, individuato nell’areacircostante la fornace, costituisce la traccia del pianod’uso relativo alla struttura. È molto probabile che ilpraefurnium, parte della camera di cottura e, forse,l’area circostante fossero coperti da una tettoia pog-giante su basi in pietra e in parte sui muri perimetra-li, con una intelaiatura di sostegno costituita da travilignee. A brevissima distanza dalla fornace, in pros-simità del lato meridionale della camera di combu-stione e della spalletta del prefurnio, sono stati indi-viduati alcuni buchi di palo, posti a distanza moltoravvicinata tra loro, nei quali si possono, forse, rico-noscere le tracce dell’alloggiamento degli elementilignei. La presenza di una tettoia è documentata,principalmente, dal rinvenimento, all’interno dellacamera di combustione e del praefurnium, di unagrande quantità di frammenti di laterizi, prevalente-mente tegole con alette, caratterizzati dalla presenzadi consistenti tracce di malta. La sistemazione dellatettoia a protezione del praefurnium e di parte delforno poteva assicurare non solo la buona riuscitadelle operazioni di cottura, ma anche il riparo dellearee circostanti e doveva essere funzionale a garanti-re lo svolgimento delle attività connesse ai processidi produzione. Sfugge l’articolazione planimetricadell’area circostante che doveva essere organizzatain zone adibite alla tornitura, vasche per la decanta-zione dell’argilla, luoghi per l’essiccazione delleceramiche, vani per la conservazione dei materialicotti e da cuocere, magazzini per il deposito deicombustili, spazi destinati ai rifiuti e allo scarico deimanufatti scartati. I mezzi meccanici, prima dell’av-vio degli scavi, nell’attività di sbancamento funzio-nale alla regolarizzazione dell’area interna all’invasodella diga, hanno distrutto questa porzione del quar-tiere artigianale.
La fornace sembra essere stata in attività per unperiodo abbastanza ristretto. Una ’esplosione’ cau-sata, verosimilmente, da un incontrollato aumentodella temperatura potrebbe aver provocato il crollo
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
50
del piano di cottura che avrebbe trascinato con sé,nella camera di combustione, anche il materiale incottura. Il termine finale dell’attività della strutturapuò essere definito soprattutto grazie ai materialirinvenuti negli strati di obliterazione depositatisinell’area circostante. Gli strati di crollo (US 4070 e4084) all’interno della camera di combustione,hanno restituito due frammenti pertinenti alla sco-della di sigillata orientale Hayes 3 C, n. 9. Il rinve-nimento, nelle stratigrafie più tarde, di frammenti disigillata africana attribuibili alle forme Hayes 80 B-99, Hayes 104 A e di alcuni frammenti di sigillataorientale pertinenti alle scodelle Hayes 3 H, consen-tono di inquadrare l’abbandono intorno alla metàdel VI secolo d.C.
3. - Fotografia e disegni di alcune olle prodotte nell’impiantoartigianale.
3. Le ceramiche
All’interno della fornace, sono stati rinvenutinumerosi frammenti di olle cotte in occasione del-l’ultima utilizzazione della struttura prima del suodefinitivo abbandono (una prima nota su queste cera-miche è in Leone, Turchiano 2002) (fig. 3). I vasi inquestione costituiscono un insieme molto omogeneoper la ricorrenza di una serie di caratteri morfologici;le uniche variabili sono rappresentate dal profilo edall’inclinazione dell’orlo, dal disegno delle anse edal profilo del corpo. L’omogeneità, rilevabile anchenei dettagli tecnici, come la costante presenza di sca-nalature sul corpo e le anse molto piccole, può rap-presentare la spia di una standardizzazione dei pro-cessi di lavorazione.
Le olle si caratterizzano per una sostanziale omo-geneità: gli orli sono estroflessi, caratterizzati da unascanalatura funzionale all’alloggiamento del coper-chio, i corpi assumono un profilo globulare, conpareti scanalate, i fondi a calotta (fig. 3). La maggiorparte degli esemplari sono muniti di anse di dimen-sioni molto ridotte, impostate sull’orlo, non rimon-tanti. I diametri variano tra cm 16 e 22; gli unici dueesemplari quasi integralmente ricostruiti misuranorispettivamente cm 16 (Ø) x 19,8 (h) (tipo 1.1) e cm17 (Ø) x 17,4 (h) (tipo 1.5). Lo spessore delle pareti èpiuttosto sottile (in media 0,6 cm). Sono state indivi-duate tre ’varianti’ in base al differente profilo del-l’orlo, rispettivamente concavo, nel gruppo numeri-camente più significativo (tipo 1), convesso o conca-vo ma caratterizzato da una profonda scanalaturasulla faccia superiore (tipo 2) e, infine, a profilo con-vesso (tipo 3); sono documentati anche pochi esem-plari di pentole con orlo a tesa e corpo approssimati-vamente cilindrico (tipo 4). L’atelier produceva,verosimilmente, anche coperchi.
In particolare, le molteplici soluzioni morfologi-che adottate nella realizzazione delle piccole anse,decisamente poco funzionali perché difficili da impu-gnare, potrebbero rappresentare eventuali segnidistintivi, quasi la ’cifra’ di questa produzione.
È difficile definire la ’tradizione artigianale’nella quale inserire la produzione ceramica di SanGiusto. Questo gruppo così omogeneo di olle pre-senta molteplici paralleli con ceramiche documenta-te in ambito italiano, prevalentemente in contesti dietà tardoantica, ma senza dubbio uno degli aspetti
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
51
macroscopici e più significativi per la comprensionedei fenomeni produttivi, commerciali e ’culturali’, èla similarità con i materiali del Mediterraneo orien-tale.
Le ceramiche, sul piano morfologico, sembranoinfatti ispirarsi a esemplari originari dell’area egea.Olle dalla tipologia simile, definite «CorrugatedCoocking Pot», risultano essere piuttosto frequentinelle stratigrafie di numerosi siti del Mediterraneoorientale e occidentale a partire dal II secolo d.C. finoall’VIII secolo d.C. Sono attestate, ad esempio, aBerenice, a Cartagine tra i materiali importati in con-testi degli inizi del VI secolo, ma soprattutto in ambi-to orientale, ad Atene, a Knossos, a Elateia (Focide),a Corinto, a Samos, a Egina, a Chios, a Stobi, aPatras, a Tocra, Tolmeita, Cirene, Gsar Tecasis, DuraEuropos, Kythera, Hadrianopolis, Ramla (Malta).
Nel panorama del Mediterraneo occidentale, inFrancia, a Marsiglia, si segnalano i rinvenimenti trala ceramica importata.
Il tipo di olla globulare, biansata, con pareti sca-nalate e fondo a calotta, è documentato ad Albinti-milium di probabile produzione locale, prevalente-mente negli strati tardoromani, ma è sporadicamen-te attestata anche in stratigrafie di II-III secolo d.C.(Olcese 1993), a Classe-Ravenna in un contesto diVI secolo d.C. (Fiumi e Prati 1983), a Cosa (Dyson1976), a Roma, nei depositi della Schola Praeco-num, databili alla metà del V secolo d.C. (Whi-tehouse et al. 1982), a Ostia tra i materiali importatidi origine egea, probabilmente focese in base adanalisi archeometriche (Coletti e Pavolini 1996). Lacultura materiale di San Giacomo degli Schiavoni,in Molise, evidenzia bene la presenza di ceramiche’Aegean-type’, verosimilmente di importazione, inun contesto datato al 420-430 d.C. (Albarella et al.1993). Di particolare interesse risulta essere il con-fronto con materiali attestati in Abruzzo, a Crecchioe in altri siti in contesti di VI-VII secolo (Staffa1986, 1998) e in Campania, a Napoli, dove nell’areaarcheologica di via Carminiello ai Mannesi, ritro-viamo, in stratigrafie di V-primo terzo VI sia olle diproduzione locale, sia esemplari di presunta impor-tazione orientale (Carsana 1994. Le analisi minero-petrografiche hanno rivelato, in via preliminare, unacompatibilità con l’area egeo orientale).
In ambito pugliese olle morfologicamente moltosimili sono documentate nella villa di Agnuli, in stra-
tigrafie di V-VI secolo d.C. (Volpe et al. 1998), nellacittà di Herdonia prevalentemente in contesti tar-doantichi (Annese 2000, Turchiano 2000), anche senon mancano esemplari databili agli inizi III secolod.C. (Annese et al. 2000), nelle stratigrafie tardoanti-che della fattoria di Posta Crusta (Leone 2000), aCanosa (Cassano et al. 1985), a Egnathia in un con-testo del tardo VI secolo d.C. (D’Andria 1977), aRutigliano (Lavermicocca et al. 1987), nella necro-poli dei Cappuccini a Brindisi, in corredi di III secolod.C. (Cocchiaro 1988), nell’insediamento rurale diSan Giorgio (Brindisi), in un contesto chiuso inqua-drabile tra IV e inizi VI secolo d.C. (RingraziamoMarinella Valente per l’informazione).
In relazione alla problematica della trasmissionedei modelli formali, è interessante sottolineare il rin-venimento di olle morfologicamente analoghe a quel-le prodotte nell’atelier di San Giusto, in alcuni sitisull’opposta sponda dell’Adriatico: in Albania, tra imateriali dagli scavi nella fortezza di Onhezmos,inquadrabili tra IV e VI secolo d.C., nella necropolidi Rodik in Slovenia, ma soprattutto in numerosi sitidella Dalmazia e dell’Istria. Ceramiche da cucina diproduzione egea sono state rinvenute nel carico dialcuni relitti affondati lungo la costa dalmata, datatial II secolo d.C., come quello di Izmetiste nei pressidelle isole di Pakleni (Ilakovac 1968. Per un quadrocompleto delle attestazioni della ceramica da cucinaegea nell’area dell’Adriatico si veda Istenic, Schnei-der 2000), di Nerezine alle isole Losinj, di Viganj nelcanale Peljesac, di Ilovik (Jurisic 2000). L’ipotesi, per
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
52
queste ceramiche, di una provenienza dall’area egeae, in particolare, focese, è stata parzialmente confer-mata dalle analisi archeometriche effettuate su unnucleo di campioni; le indagini su alcune casseruoledi tipo ’egeo’ provenienti dal sito diLjubljana/Emona hanno, invece, evidenziato un’ori-gine locale (le analisi archeometriche sono stateeffettuate da G. Schneider e pubblicate in Istenic,Schneider 2000).
Dai confronti bibliografici proposti emerge, siaper le Aegean coocking ware importate dall’areaegea, sia per le olle di produzione locale, una diffu-sione relativa prevalentemente a località del Medi-terraneo orientale e dell’arco adriatico; le attestazio-ni nel Mediterraneo occidentale riguardano centricome Napoli, Ostia, Roma, Albintimilium, Marsigliao Cartagine, città interessate, in tutta l’età tardoanti-ca, dai traffici commerciali delle principali rottetransmarine.
Vasi analoghi agli esemplari di San Giusto percaratteristiche morfologiche e tecniche sono, dun-que, documentati in aree geograficamente e cultu-ralmente diverse, soprattutto in località situate nelMediterraneo orientale e lungo l’arco adriatico. Sesi è, dunque, in presenza di una corrispondenza ditradizione morfologica ’internazionale’, apparente-mente unitaria, tra oggetti fabbricati in luoghi moltodiversi e anche in periodi differenti, ciò non vuoldire postulare una caratterizzazione unitaria, chesappiamo essere inesistente sul piano economico epolitico. Le ’interferenze’ maggiori si registranosoprattutto con l’opposta sponda dell’Adriatico: se
Campione Forma Campione Forma Campione Forma Campione Forma
* SG 6 Olla * SG 27 Olla * SG 41 Olla SG 68 Pentola* SG 7 Olla * SG 28 Olla * SG 42 Olla SG 69 Pentola steccata* SG 8 Olla * SG 29 Olla * SG 43 Olla SG 70 Pentola steccata* SG 9 Olla * SG 30 Olla * SG 44 Olla SG 71 Olla* SG 10 Olla * SG 31 Olla * SG 45 Olla SG 72 Olla* SG 12 Olla * SG 32 Olla * SG 46 Olla SG 73 Olla* SG 13 Olla * SG 33 Olla * SG 47 Olla SG 74 Olla* SG 14 Olla * SG 34 Olla * SG 48 Coperchio SG 75 Olla* SG 21 Olla * SG 35 Olla * SG 49 Coperchio SG 76 Olla steccata* SG 22 Olla * SG 36 Olla * SG 50 Coperchio SG 77 Coperchio* SG 23 Olla * SG 37 Olla SG 64 Tegame SG 78 Coperchio* SG 24 Olla * SG 38 Olla SG 65 Tegame SG 79 Clibanus* SG 25 Olla * SG 39 Olla SG 66 Tegame SG 80 Presa steccata* SG 26 Olla * SG 40 Olla SG 67 Tegame SG 82 Piano forato
Tabella 1Elenco dei campioni ceramici selezionati per l’indagine archeometrica.
I reperti rinvenuti all’interno della fornace sono contrassegnati con il segno *.
esiste una sorta di koiné formale nel Mediterraneoorientale e, in parte, in quello occidentale, fra mediae tarda età imperiale e Altomedievo, un ruolo cardi-ne nella trasmissione dei modelli formali va forsericercato nell’Adriatico. I collegamenti con l’oppo-sta sponda adriatica dovevano essere infatti diretti esistematici, come testimonia anche l’unica rottatransadriatica sicuramente documentata dall’Itine-rarium Maritimum per Siponto proprio con Salona,il cui porto era raggiungibile effettuando un tragittodi 1500 stadi (Itin. Marit. 497.7).
È possibile che la produzione ceramica di SanGiusto si inserisca nel solco di una tradizione arti-gianale sorta originariamente, nel corso del II secolod.C. in area egea e sviluppatasi successivamente, perun arco di tempo ampio, con variazioni morfologi-che relativamente significative in differenti aree geo-grafiche. Non deve stupire la longevità di tale tradi-zione morfologica soprattutto in relazione alla cera-mica da fuoco, nell’ambito della quale si registranomutamenti tipologici minimi, talvolta per periodimolto lunghi.
Probabilmente, l’avvio di tale produzione nel sitodi San Giusto fu mediata da esperienze maturate nonsolo in ambito del Mediterraneo orientale, ma anchedell’area adriatica, come emerge da altri dati peculia-ri di questo sito relativi, per esempio, alla tipologiadella chiesa doppia che trova stringenti analogie pro-prio con il complesso episcopale di Salona, e dall’a-nalisi degli aspetti iconografici e degli apparati deco-rativi, musivi e architettonici.
M.T.
4. I materiali e la selezione dei campioni
Cinquantadue campioni ceramici (tabella 1) sonostati sottoposti ad indagine chimica e minero-petro-grafica: trentasei campioni sono stati prelevati tra leceramiche da fuoco sicuramente attribuibili all’atti-vità della fornace, mentre sedici campioni di cerami-ca da fuoco sono stati selezionati tra i reperti cerami-ci di incerta provenienza, rinvenuti all’interno dell’a-rea archeologica. All’interno di questo set di campio-ni, quarantanove sono stati prelevati da olle concorpo globulare scanalato e fondo arrotondato, men-tre tre sono stati prelevati dai coperchi. Un ulteriore
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
53
campione è stato prelevato dal piano forato dellastruttura produttiva.
Una parte consistente dello studio ha inoltre pre-visto il campionamento e l’analisi dei sedimentiaffioranti nel territorio circostante l’area archeologi-ca. Nei sedimenti fluviali circostanti il sito di SanGiusto (Jacobacci et al. 1967, Bonardi et al. 1988), 7campioni sono stati prelevati in altrettanti siti: lungole rive dei torrenti Iorenzo (SGA 3, 9), Celone (SGA1, 2, 8, 11) e Vulgano (SGA 7).
5. Metodologie di indagine
Le indagini minero-petrografiche sono state effet-tuate mediante microscopia ottica (OM) e diffratto-metria di raggi X (XRD). Lo strumento impiegato èun diffrattometro Philips PW 1710, con anodo dirame, in condizioni di tensione e corrente rispettiva-mente di 45kV e 25µA (Dipartimento di Scienzedella Terra - Università di Siena). Le analisi chimichehanno previsto l’impiego della fluorescenza di raggiX (XRF), della spettrometria ad emissione al plasmacon accoppiamento induttivo (ICPMS-OES) e del-l’attivazione neutronica (INAA). I contenuti in ele-menti maggiori, Ba, Be, Sr, V, Y e Zr sono stati deter-minati mediante spettroscopia al plasma ad accoppia-mento induttivo (ICPMS), fondendo il campione inuna miscela di litio metaborato-tetraborato. L’ICP-OES è stata ulteriormente utilizzata per determinare icontenuti di Ag, Bi, Cd, Cu, Ni, Pb and Zn ma la pre-parazione del campione ha previsto la dissoluzionedel campione in quattro acidi (idrofluorico, perclori-co, idroclorico e nitrico). L’attivazione neutronica(INAA) è stata impiegata per determinare i contenutidi As, Au, Br, Co, Cr, Cs, Hf, Ir, Mo, Sb, Sc, Se, Ta,W, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, U e Th mentrel’analisi in fluorescenza di raggi X (XRF) ha fornito icontenuti di Ga, Nb, Rb e Sn. Le analisi INAA eXRF sono state condotte presso gli Activation Labo-ratories (Ontario, Canada). Le analisi XRF dei sedi-menti sono state altresì eseguite a Siena mediante unPhilips MagicX-Pro.
Gli strumenti impiegati per l’ICP-OES sono unThermo Jarrell Ash Enviro II (Activation Laborato-ries, Ontario, Canada) ed un Perkin Elmer Optima3000 (Activation Laboratories, Ontario, Canada). Glistrumenti impiegati per l’XRF sono un Philips 2400(Activation Laboratories, Ontario, Canada) ed un
54
Philips MagicX Pro (Dipartimento di Scienze dellaTerra, Università di Siena). La perdita alla calcinazio-ne è stata determinata portando il campione a 1050°Cper due ore.
Ulteriori indagini tessiturali e microchimichesono state eseguite mediante microscopia elettronicaa scansione (SEM-EDS). Lo strumento utilizzato èSEM Philips XL30, equipaggiato con uno spettrome-
tro a dispersione di energia (EDS) Philips EDAXDX4 (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Uni-versità di Siena).
I sedimenti sono stati sottoposti a vagliatura, inmodo tale da poterne indagare le differenti frazioni(sabbia, silt grossolano, silt fine e argilla). I sedimentital quali e le frazioni granulometriche sono state poianalizzati mediante microscopia ottica, XRD e XRF.
Tabella 2. I risultati delle analisi chimiche effettuate su 52 campioni ceramici, 7 campioni di sedimenti ed i relativi separati. Gli ossidi sono espressi in peso %, gli elementi in ppm (nd.=non determinato).
Le ceramiche da
fuoco rinvenute all’interno della
fornace
Le ceramiche da fuoco rinvenute all’esterno della
fornace
I sedimenti
(SGA 1-3, 7-9, 11)
I separati
(SGA 1-3)
Sabbia Silt grossolano Silt fine e argilla
Campione
media
(n=36) dev.
st. media
(n=16) dev. st.
media (n=7)
dev. st.
media (n=3)
dev. st.
media (n=3)
dev. st.
media (n=3)
dev. st.
SiO2 60,51 2,54 60,43 10,3 42,52 4,0 39,51 8,24 49,43 5,32 45,04 2,1
Al2O3 15,67 1,65 15,32 2,66 9,90 1,4 6,26 3,05 6,94 2,33 13,4 0,65
Fe2O3 5,45 0,56 5,16 0,93 2,77 0,9 2,28 1,11 2,08 0,8 5,07 0,2
MnO 0,15 0 0,11 0,05 0,11 0,0 0,15 0,03 0,17 0,03 0,11 0,03MgO 2,07 0,17 1,66 0,49 1,50 0,3 1,28 0,67 1,22 0,45 2,02 0,22
CaO 5,47 2,44 4,49 2,21 19,46 3,6 26,11 8,55 19,61 5,88 12,76 1,8
Na2O 1,28 0,14 1,31 0,28 0,43 0,2 0,81 0,41 1,16 0,27 0,55 0,12
K2O 3,49 0,35 3,33 0,59 1,94 0,3 2,16 1,02 1,9 0,47 2,12 0,34
TiO2 0,67 0,06 0,63 0,12 0,44 0,1 0,25 0,16 0,33 0,14 0,67 0,01
P2O5 0,18 0,03 0,17 0,05 0,19 0,0 0,17 0,09 0,17 0,05 0,18 0,02
LOI 5,06 2,77 4,89 2,37 20,66 3,4 21,01 6,33 16,98 3,62 17,56 1,5Ba 675,2 70,2 665,5 140,9 411,8 112,0 644,3 260,8 543,7 84,2 422,7 75Sr 292,8 32,9 264,4 61,8 379,8 108,6 758 97,4 540,7 98,4 384 54Y 28,6 4,1 27,4 5,6 18,7 3,4 13 2,6 18 3,6 25,3 1,5Zr 227,5 44,1 228,2 48,5 133,0 26,3 68 30,8 157,3 28,7 164,3 8,4Be 4,3 1,5 4,2 1,2 nd. nd. 2 1 2 1 3,3 0,6V 110,2 6,6 100,3 19,4 67,75 17,4 53,7 37,2 45,3 24,2 106,7 7As 16,2 4,3 15,4 4,7 nd. nd. 6 2 6 1 12,3 2,9Br 7,8 3,7 5,4 4,1 nd. nd. 6,3 5,9 6 4,4 15 6,1Co 16,7 2,1 14,6 3,1 9,83 3,2 11,3 2,9 13,3 3,2 15 3,6Cr 101,1 63,7 97,6 66,3 60,92 12,7 29 11,9 39 11 94 6Cs 10,1 3,4 9,8 2,7 nd. nd, 3,3 2,9 3,1 1,9 7,3 1,4Hf 5,7 1,3 5,1 1 nd. nd. 1,3 0,5 3,5 0,4 3,6 0,3Rb 156,4 37,1 150,7 32,6 90,33 24,2 86,7 38,7 85,3 25,7 132,7 39,6Sb 1,1 0,5 0,9 0,3 nd. nd. 0,6 0,1 1,4 1 1,3 0,2Sc 13,1 1 11,4 2,2 nd. nd. 5,9 3 5,5 1,9 12,4 0,1Th 17,3 4,2 17 3,7 8,17 2,6 5,1 2,5 6,1 2,3 12 0,8U 2,7 0,6 2,6 0,7 1,92 0,8 1,7 0,4 2,1 0,5 2,3 0,1La 50,8 11,5 47,7 10,5 22,33 8,3 21 7,4 22,2 6,6 40,7 1,7Ce 91,5 17,3 84,5 19,7 42,33 14,6 33 11,5 40 7,6 64 3,2Nd 36,5 6,5 34,7 8 nd. nd. 16,7 7,2 18,7 6 25,3 1,5Sm 6,8 1,3 6,4 1,4 nd. nd. 3,6 1,3 4,1 1 6,4 0,2Eu 1,5 0,3 1,4 0,3 nd. nd. 0,8 0,3 0,9 0,2 1,3 0,1Yb 2,8 0,5 2,6 0,5 nd. nd. 1 0,3 1,6 0,3 2,4 0,1Lu 0,4 0,1 0,4 0,1 nd. nd. 0,2 0 0,2 0 0,4 0Cu 29 4,8 27 6,6 nd. nd. 12,7 10,1 14,7 6,8 44,3 16,3Ni 45,8 23,7 45,7 29,3 28,42 5,6 19 1 26 5 42,7 7,1Pb 30,9 7,2 31,9 7,5 20,33 7,2 25,3 1,5 52,3 19,9 31,3 30,5Zn 87,3 10,5 80 14,2 51,92 12,4 18,7 19 33,3 15,3 89,3 2,1
Tabella 2I risultati delle analisi chimiche effettuate su 52 campioni ceramici, 7 campioni di sedimenti ed i relativi separati.
Gli ossidi sono espressi in peso %, gli elementi in ppm (nd = non determinato).
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
6. Risultati
6.1. Analisi in diffrattometria di raggi X
Le ceramiche da fuoco. Le analisi diffrattometri-che sono state effettuate su di un totale di 36 campio-ni ed hanno mostrato la presenza di mica, quarzo, K-feldspati, plagioclasi, ematite, calcite e pirosseno(principalmente augite ma anche iperstene). Questirisultati non discriminano le produzioni di ceramicada fuoco rinvenute all’interno ed all’esterno dellafornace, in quanto gli spettri ottenuti sono perfetta-mente confrontabili.
I sedimenti. L’analisi diffrattometrica è stata con-dotta sui 7 sedimenti tal quali e sulle tre frazioni –grossolana, intermedia e fine – ottenute per i campioniSGA 1-3. Le fasi mineralogiche riconosciute nellatotalità dei campioni sono le miche (illite e muscovite),la clorite, il quarzo, la calcite, i K-feldspati, i plagio-clasi ed i pirosseni (augite ed iperstene). I picchi dellemiche corrispondono prevalentemente all’illite e,meno frequentemente, alla muscovite. Il quarzo e lacalcite rappresentano le fasi principali sia nei sedimen-ti, sia nelle frazioni. I K-feldspati ed i plagioclasi pre-sentano picchi di scarsa intensità – se confrontati conquelli del quarzo e della calcite – ma acquistano unamaggiore rilevanza nelle frazioni grossolane. I picchidei pirosseni corrispondono prevalentemente all’augi-te e, meno frequentemente, all’iperstene e sono gene-ralmente di minima intensità o addirittura assenti.
6.2. Analisi in microscopia ottica
Ceramiche da fuoco. L’analisi minero-petrografi-ca condotta mediante microscopia ottica ha indivi-duato due gruppi di impasti.
Il primo gruppo (fig. 4A) è rappresentato da qua-ranta campioni, di cui trentuno rinvenuti all’internodella fornace e nove nel sito di San Giusto. Gli impa-sti sono caratterizzati da una tessitura seriale, da unbasso grado di sinterizzazione e da uno scheletro(~15-20%) in cui i granuli hanno una forma preva-lentemente subarrotondata e dimensioni medie intor-no ai 0,2 mm. Le fasi mineralogiche identificate sonoquarzo, sanidino (fig. 4C), plagioclasi, clinopirosseni(pleocroici sul verde) frequentemente geminati ezonati, ortopirosseni, anfiboli tipo orneblenda,muscovite, biotite, granati e minerali opachi. Sonostati inoltre individuati frammenti litici vulcanici,aggregati di quarzo policristallino e rari granuli arro-
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
55
tondati di quarzo microcristallino. Lo studio micro-paleontologico ha identificato una microfauna com-posta, in ordine di abbondanza, da frammenti di mol-luschi (fig. 4D) e da foraminiferi sia planctonici chebentonici.
Il secondo gruppo (fig. 4B) è costituito da ottocampioni, di cui sette rinvenuti nel sito di San Giustoe uno all’interno della fornace. Gli impasti presenta-no un grado di sinterizzazione più spinto e un mag-gior rapporto scheletro-matrice, con dimensioni deigranuli più grandi (~0,5 mm) e forma prevalentemen-te spigolosa. La frazione non argillosa è principal-mente costituita da quarzo e feldspati (plagioclasi esanidino) mentre in quantità nettamente inferiorisono presenti muscovite, biotite, minerali opachi erari frammenti di piccole dimensioni di orto-clinopi-rosseni, a volte geminati, e di anfiboli monoclini.Oltre a questi minerali sono stati osservati frammentidi metarenite, quarzo policristallino e frammenti diorigine vulcanica. La microfauna presente, peraltroin quantità molto ridotte, è composta essenzialmenteda foraminiferi.
Il piano forato. L’analisi dell’impasto ha eviden-ziato numerose analogie sia dal punto di vista mine-ralogico che micropaleontologico con i campioniappartenenti al primo gruppo. Uniche differenze sonorappresentate dalla presenza di una microfauna piùabbondante e dalla calcite primaria non alterata dallacottura. Non sono stati osservati segni di sinterizza-zione dell’impasto.
Sedimenti. Le argille SGA1, SGA2 e SGA3 pre-sentano uno scheletro abbondante (~20-25%) congranuli di dimensioni comprese tra i 0,3 e i 0,4 milli-metri e forma prevalentemente subarrotondata. Leprincipali fasi mineralogiche sono quarzo e feldspatie, subordinatamente, muscoviti, pirosseni, anfiboli eminerali opachi. Sono stati inoltre osservati ancheframmenti litici di origine vulcanica, frammenti dimetarenite, granuli arrotondati di quarzo microcri-stallino, calcite primaria e grumi argillosi ricchi diresti fossili. L’analisi della microfauna ha riscontratola presenza di abbondanti frammenti di molluschi edi foraminiferi sia planctonici (numerose globigeri-ne) che bentonici.
6.3. Analisi in microscopia elettronica a scansione
Le analisi mediante microscopia elettronica ascansione sono state condotte su 14 campioni rappre-
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
56
Fig. 4. - Fotografie al microscopio ottico di alcuni campioni ceramici rappresentativi: A) primo gruppo di impasti (nicolsincrociati); B) secondo gruppo di impasti (nicols paralleli); C) cristallo di sanidino all’interno di un impasto ceramico diprimo tipo; D) frammento di mollusco. Immagini in elettroni retrodiffusi: E) cristallo di sanidino; F) plagioclasio con smesco-lamenti di K-feldspato; G) K-feldspato con smescolamenti di plagioclasio; H) cristallo zonato di augite; I) cristallo di iperste-ne; L) cristallo di orneblenda.
sentativi ed hanno consentito di ottenere informazionitessiturali di dettaglio e di analizzare la composizionechimica delle fasi mineralogiche.
Il corpo ceramico presenta un basso livello di sin-terizzazione – come già osservato mediante micro-scopia ottica – ed i cristalli non presentano bordi direazione.
La composizione chimica delle fasi è costante intutti i campioni. Le principali fasi individuate sono labiotite, l’illite, la muscovite, il sanidino (fig. 4E), i pla-gioclasi, l’augite (fig. 4H), l’egirina-augite e l’iperste-ne (fig. 4I), l’orneblenda (fig. 4L) e la pargasite. I feld-spati presentano frequenti smescolamenti, ovvero, èpossibile osservare K-feldspati con smescolamenti diplagioclasio (fig. 4G) e viceversa (fig. 4F).
L’indagine in microscopia elettronica a scansioneha inoltre permesso di confermare la descrizione del-la microfauna acquisita mediante microscopia ottica.Le ceramiche da fuoco presentano numerosi fram-menti di molluschi, tipici di ambienti continentali efluviali. In misura minoritaria sono inoltre presenti iforaminiferi, sia bentonici sia planctonici. La presen-za di foraminiferi, ovvero microrganismi marini, puòessere dovuta all’azione erosiva, esercitata dal torren-te sui sedimenti di origine marina.
6.4. Analisi chimiche
Le ceramiche da fuoco. I risultati ottenuti median-te l’analisi chimica degli elementi maggiori, minoried in tracce di 52 campioni ceramici sono mostrati intabella 2. I contenuti di Au, Ag, Cd, Bi, Ir, Mo, Se, Ta,W e Tb non sono stati riportati perché inferiori al li-mite di rilevabilità.
Il gruppo di campioni prelevati dalle olle rinvenu-te all’interno della fornace è piuttosto omogeneo. I va-lori di deviazione standard sono, infatti, piuttosto con-tenuti per tutti gli elementi maggiori, minori ed intracce. Da osservare il moderato contenuto di CaO cheindica l’utilizzo di una materia prima non calcarea, diorigine fluviale o lacustre. Le olle prodotte nella for-nace hanno una composizione chimica ben confronta-bile con la composizione dei campioni di ceramica dafuoco rinvenuta all’esterno della fornace. Questo se-condo nucleo di materiali include molteplici tipi cera-mici ed è pertanto più articolato rispetto al preceden-te, sia dal punto di vista morfo-tipologico, sia dal pun-to di vista chimico (valori di deviazione standard su-periori rispetto a quelli ottenuti per il gruppo di olle
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
57
rinvenute all’interno della fornace). In generale, que-sto gruppo di materiali si contraddistingue per conte-nuti elevati in SiO
2 e modesti in CaO.
I sedimenti. L’analisi chimica di alcuni sedimentie delle rispettive frazioni è riportata in tabella 2. Aifini di questo studio, sono da osservare con attenzio-ne i contenuti in elementi maggiori e soprattutto inCaO. Rispetto alle ceramiche, i sedimenti presentanocontenuti superiori in CaO e contenuti inferiori inSiO
2, Al
2O
3, Fe
2O
3, K
2O ed in gran parte degli ele-
menti minori ed in traccia.Tali differenze risultano ancor più accentuate se si
confronta la composizione dei corpi ceramici conquella delle frazioni granulometriche. Ad esempio, icontenuti in CaO sono ancor più elevati rispetto aquelli determinati per i corpi ceramici.
E.G., C.F., I.M.
7. Discussione e conclusioni
L’integrazione delle informazioni derivanti dallostudio morfo-tipologico delle diverse classi cerami-che, dalla ricostruzione dell’attività della fornace edall’indagine archeometrica sulle ceramiche e sui se-dimenti hanno permesso di ricostruire l’intero cicloproduttivo impiegato dagli antichi fornaciai di SanGiusto e di creare il gruppo di riferimento per la pro-duzione delle olle in ceramica da fuoco.
Approvvigionamento della materia prima. I datiottenuti mediante l’analisi chimica e mineralogica per-mettono di affermare che i depositi fluviali sono statiutilizzati per la produzione della ceramica da fuoco.Innanzitutto, la composizione mineralogica delle cera-miche da fuoco (gruppo primo e secondo) è compati-bile con quella ottenuta per i sedimenti fluviali. In se-condo luogo, l’analisi micro-paleontologica individuanei sedimenti i medesimi tipi di molluschi riconosciu-ti nelle ceramiche. Oltretutto, la composizione del pia-no forato coincide con quella delle olle ed è ragione-vole assumere che il piano forato sia stato fabbricatocon materiali approvvigionati localmente. Le differen-ze riscontrate negli impasti mediante microscopia otti-ca rendono conto dell’eterogeneità del contesto in esa-me e sono spiegate proprio dall’utilizzo di sedimentialtrettanto eterogenei quali quelli fluviali. D’altrocanto i due gruppi sono stati rinvenuti all’interno del-la fornace, presentano le medesime fasi mineralogi-che – sia pure in quantità relative variabili – e sono di-
stinguibili esclusivamente sulla base della grandezzadei cristalli e della quantità di microfossili. In ultimaistanza, occorre osservare che la composizione chimi-ca e mineralogica delle ceramiche da fuoco non per-mette di considerare quali possibili fonti di approvvi-gionamento i sedimenti di origine marina, affiorantinel territorio circostante.
L’unica difficoltà è presentata dai risultati ottenutimediante le analisi chimiche dei sedimenti. La compo-sizione chimica dei sedimenti, infatti, non è perfetta-mente compatibile con la composizione delle cerami-che (ad esempio, i tenori in CaO sono generalmentemolto più elevati nei sedimenti che nelle olle), e que-sta differenza può essere spiegata se si considera – an-cora una volta – l’estrema variabilità composizionaledei sedimenti fluviali rispetto a quelli continentali. Ol-tretutto, le divagazioni fluviali ed i fenomeni erosivicreano una situazione eterogenea che non necessaria-mente coincide con quella sfruttata nell’antichità.
Preparazione dell’impasto. Le analisi condotte inmicroscopia ottica e microscopia elettronica a scan-sione suggeriscono di ricostruire due tipi di prepara-zione dell’impasto. Una preparazione estremamentesemplice e moderatamente laboriosa, in cui non ven-gono aggiunti elementi estranei al sedimento di par-tenza, né vengono separate alcune frazioni granulo-metriche, ed un secondo tipo di preparazione in cuiviene lavorato un impasto caratterizzato da una mag-giore frazione sabbiosa.
Funzionalità del manufatto. In rapporto alla fun-zionalità del manufatto, la scelta della materia prima èopportuna. La ceramica da fuoco necessita, infatti, diimpasti magri, scarsamente plastici, costituiti da ma-trici prevalentemente sabbiose, ricche di quarzo e os-sidi di ferro e povere di calcari e fondenti (Cuomo diCaprio 1985).
Tecnologia del fuoco. Le osservazioni tessiturali ela composizione mineralogica dei campioni suggeri-scono una temperatura di cottura compresa tra i 600°e gli 800°C. La tessitura dei corpi ceramici presenta,infatti, un basso livello di sinterizzazione, i cristallinon presentano bordi di reazione indicativi di medieed alte temperature, la calcite è presente ed è priva dialterazioni, l’illite è presente mentre i minerali argil-losi quali la clorite sono assenti.
Produzione e commercializzazione. Le ceramicherinvenute all’interno ed all’esterno della fornace mo-
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
58
strano la medesima composizione chimica e minero-petrografica. Questa osservazione non prova che tuttii materiali indagati siano stati prodotti dalla medesi-ma fornace ma indica un comune approvvigionamen-to delle materie prime probabilmente da depositi flu-viali circostanti.
Scarsi sono gli elementi di cui si dispone per tenta-re di ricostruire i rapporti tra la produzione dell’atelierdi San Giusto e i mercati, le eventuali modalità di ven-dita e diffusione del prodotto e il tipo di commercio.Analizzando la ’geografia’ di diffusione in altri siti diconsumo e gli ipotetici canali di distribuzione, è appar-so molto difficile ipotizzare l’esistenza di una produ-zione non solo destinata all’autoconsumo, ma rivoltaanche al commercio, sia pure di carattere regionale oinfraregionale attraverso la rete delle nundinae. Uncondizionamento, in questo senso, è stato rappresenta-to dalla limitata disponibilità di coevi contesti di mate-riali provenienti da scavi stratigrafici e dalle scarse pre-senze di tali ceramiche attestate in ambito locale; po-chissimi frammenti sono stati rinvenuti nei siti indivi-duati attraverso le ricognizioni nella valle del Celone.
È probabile che il Celone, oltre a garantire l’ap-provvigionamento idrico, indispensabile per tutte leattività manifatturiere (ceramiche, tessili, conciarie) eper le esigenze quotidiane, assicurasse l’eventualetrasporto dei prodotti finiti; è stata, infatti, ipotizzatauna parziale navigabilità almeno nel tratto finale.Lungo il percorso del torrente si snodava anche untracciato viario, molto probabilmente risalente già adetà pre- e protostorica, che andò acquistando maggio-re importanza in età romana e, in particolare, in epocatardoantica. La via garantiva un collegamento tra Ae-cae, Arpi e il porto di Sipontum; il sito di San Giusto,inoltre, dista mediamente circa Km 10-12 da impor-tanti città come Luceria, Arpi ed Aecae.
L’analisi comparata della composizione chimica eminero-petrografica delle argille delle ceramiche diSan Giusto e delle medesime classi di materiali rinve-nute in altri siti (come Herdonia, Posta Crusta, Agnuli,siti individuati nella valle del Celone, Siponto, Cano-sa) è ancora in corso e, in futuro, potrebbe consentiredi evidenziare alcuni trend importanti soprattutto alivello regionale e microregionale. Si consideri, inol-tre, che alcuni elementi inducono a ritenere possibile lapresenza, nel sito di San Giusto, di una nundina.
E.G., M.T., C.F., I.M., G.V.
La produzione di ceramica da fuoco di San Giusto (Lucera, Foggia)
59
Albarella U., Ceglia V., Roberts P., 1993, San Giacomodegli Schiavoni (Molise): an early fifth century a.Ddeposit of pottery and animal bones from centraladriatic Italy, BSR, LXI, 157-230.
Annese C., 2000, Le ceramiche tardoantiche delladomus B. G. Volpe (a cura di), Ordona X. Ricerchearcheologiche a Herdonia (1993-1998), Bari: Edi-puglia, 285-342.
Annese C., De Felice G., Turchiano M., 2000, Cerami-che della prima e media età imperiale dai riempi-menti delle latrine della domus A. G. Volpe (a curadi), Ordona X. Ricerche archeologiche a Herdonia(1993-1998), Bari: Edipuglia, 251-265.
Bonardi G., D’Argenio B., Di Nocera S., Marsella E.,Pappone G., Perrone V., Pescatore T.S., SenatoreM.R., Sgrosso I., Ciaranfi N., Pieri P., Ricchetti G.,Brancaccio L., Cinque A., Di Girolamo P., MorraV., Ortolani F., Torre M., Turco E., Amore F.O.,Ciampo G., de Capoa P., Taddei E., 1988, Cartageologica dell’Appennino meridionale, Firenze:Selca.
Carsana V., 1994, Ceramica da cucina tardo-antica edalto-medievale. P. Arthur (a cura di), Il complessoarcheologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli(scavi 1983-1984), Galatina: Congedo, 221-258.
Cassano R., Laganara Fabiano C., Volpe G., 1985, Areadel tempio di Giove Toro a Canosa. Relazione preli-minare, AMediev., 12, 501-515.
Cocchiaro A., 1988, La necropoli. A. Cocchiaro e G.Andreassi (a cura di), La necropoli di via dei Cap-puccini a Brindisi, Fasano: Schena, 63-229.
Coletti C.M., Pavolini C., 1996, Ceramica comune daOstia. M. Bats (a cura di), Les céramiques commu-nes de Campanie et de Narbonnaise (Ier s. av. J.-C.- IIe s. ap. J.-C.). La vaisselle de cuisine et de table,Naples Centre J. Bérard, 391-419.
Cuomo di Caprio N., 1971-1972, Proposta di classifica-zione delle fornaci per ceramica e laterizi nell’areaitaliana, Sibrium, 11, 371-461.
Cuomo di Caprio N., 1985, La ceramica in archeologia.antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi diindagine, Roma: L’Erma di Bretschneider.
D’Andria F., 1977, Osservazioni sulle ceramiche in Pu-glia tra tardoantico e altomedioevo, ASNP, VII/1,75-89 e tavv. I-V.
De Fino M., Romano A.V., 2001, L’Ager Aecanus: traproprietà privata e proprietà imperiale, in M. Pani(a cura di), Epigrafia e territorio. Politica e società.Temi di antichità romane, VI, Bari: Edipuglia, 43-89.
Dyson S.N., 1976, Cosa: the utilitarian pottery, MemA-mAc, XXXIII.
Fiumi F., Prati L., 1983, Note sulla ceramica comune,in Ravenna e il porto di Classe, venti anni di ricer-che archeologiche tra Ravenna e Classe, Imola,118-126.
Hayes J.W., 1972, Late Roman Pottery, London.Ilakovac J., 1968, Keramika iz antickog broda potonu-
log kod Paklenih otoka, Diadora, 4, 193-102.Istenic G., Schneider G., 2000, Aegean cooking ware in
the Eastern Adriatic, ReiCretActa, 36, 341-348.Jacobacci A., Malatesta A., Martelli G., Stampanoni G.,
1967, Note illustrative della carta geologica d’Italiaalla scala 1:100.000. Foglio 163 – Lucera, Roma:La Litograf.
Jurisic M., Ancient shipwrecks of the Adriatic marittimetransport during the first and second centuries AD,BAR International Series, 828, 2000.
Lavermicocca N., La Notte G., Pacilio G., 1987, Sant’Apol-linare in Rutigliano. Storia, scavo, restauro, Ruti-gliano.
Le Ny F., 1988, Les four de tuiliers gallo-romains.Métodologie, études technologique typologique etstatistique-chronologie, Documents d’ArcheologieFrançaise, 12, Paris (editions de la Maison desSciences de L’Homme, Paris).
Leone D., 2000, Le ceramiche tardoantiche della fatto-ria di Posta Crusta. G. Volpe (a cura di), Ordona X.Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998),Bari; Edipuglia, 387-436.
Leone D., Turchiano M., 2002, Aspetti della circolazio-ne delle merci nell’Apulia tardoantica tra importa-zioni e produzioni locali. L’Africa Romana, Atti delXIV Convegno di studio (Sassari 7-10 dicembre2000), Roma: Carocci, 857-890.
Olcese G., 1993, Le ceramiche comuni di Albintimi-lium. Indagine archeologica e archeometrica suimateriali dell’area del Cardine, Firenze, All’Inse-gna del Giglio.
Staffa A.R., 1986, Ricognizione nel territorio di Atri:problemi di una presenza volturnese, AMediev., 13,437-460.
Staffa A.R., 1998, Le produzioni ceramiche in Abruzzotra fine V e VII secolo. L. Saguì (a cura di), Cerami-ca in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno inonore di John W. Hayes (Roma 11-13 maggio1995), 2 voll., Firenze: All’Insegna del Giglio, 437-480.
Turchiano M., 2000, La cisterna e il suo contesto.Materiali tardoantichi dalla domus B. G. Volpe (acura di), Ordona X. Ricerche archeologiche a Her-donia (1993-1998), Bari: Edipuglia, 343-384.
Volpe G., 1996, Contadini, pastori e mercanti nell’Apu-lia tardoantica, Bari: Edipuglia.
Volpe G., 2000a, Alle origini del cristianesimo in Dau-nia: San Giusto e le sue ecclesiae. R. Infante (a curadi), Cristianesimo e cultura in terra di Capitanata,Foggia, 15-27.
Volpe G. (a cura di), 2000b, Ordona X. Ricerchearcheologiche a Herdonia (1993-1998), Bari: Edi-puglia.
Volpe G., 2003, San Giusto e l’Apulia nel contesto del-
Bibliografia
Elisabetta Gliozzo, Maria Turchiano, Consuelo Fortina, Isabella Memmi, Giuliano Volpe
60
l’Adriatico tardoantico. In L’archeologia dell’A-driatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Con-vegno Internazionale (Ravenna 7-9 giugno 2001),Frenze: All’Insegna del Giglio, 507-536.
Volpe G., 2001a, Linee di storia del paesaggio dell’A-pulia romana: San Giusto e la valle del Celone. E.Lo Cascio e D. Storchi Marino (a cura di), Modalitàinsediative e strutture agrarie nell’Italia meridiona-le in età romana, Atti del Convegno Internazionale(Napoli 11-13 giugno 1998), Bari: Edipuglia, 315-361.
Volpe G., 2001b, San Giusto: un insediamento ruraleapulo nel quadro dell’Adriatico. In Io Adriatico.Civiltà del mare tra frontiere e confini. Catalogodella mostra (Ancona, Fondo Mole Vanvitelliana 6maggio-5 settembre 2001), Milano, 139-145.
Volpe G., 2002, San Giusto, lo scavo, la mostra e Dalloscavo di San Giusto al 'Progetto Valle del Celone'(un aggiornamento sulle ricerche 1998-2001). G.Volpe (a cura di), San Giusto. La villa, le ecclesiae,Guida alla mostra, 2a ed., Bari: Edipuglia, 15-103.
Volpe G., Casavola L., D’Aloia F., Pietropaolo L., 1998,Le ceramiche tardoantiche della villa di Agnuli. L.
Saguì (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo,Atti del Convegno in onore di John W. Hayes (Roma11-13 maggio 1995), 2 voll., Firenze: All’Insegna delGiglio, 723-734.
Volpe G., Biffino A., Giuliani R., 2001, Il battistero delcomplesso paleocristiano di San Giusto (Lucera).L'edificio battesimale in Italia, aspetti e problemi,Atti dell’VIII CNAC (Bordighera 1998), Firenze:All’Insegna del Giglio, 1089-1130.
Volpe G., Favia P., Giuliani R., 1999, Chiese rurali del-l’Apulia tardoantica e altomedievale. Ph. Pergola (acura di), Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII sec.), Atti della giornata tematica dei Seminaridi Archeologia Cristiana (Roma, 18.3.1998), Cittàdel Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cri-stiana, 261-311.
Volpe G. (a cura di), 1998, San Giusto. La villa, leecclesiae. Primi risultati dagli scavi nel sito ruraledi San Giusto (Lucera): 1995-1997, Bari: Edipu-glia.
Whitehouse D.B., Barker G., Reece R., Reese D., 1982,The Schola Praeconum I; The Coins, Pottery,Lamps et Fauna, BSR, L, 54-101.
























![[JOURNAL ISSUE] 2014_E. Casetta, V. Giardino (a c. di), Mettere a fuoco il mondo. Conversazioni sulla filosofia di Achille Varzi, Isonomia](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bcfae3e8acd9977059b4e/journal-issue-2014e-casetta-v-giardino-a-c-di-mettere-a-fuoco-il-mondo.jpg)