I tegami da fuoco dal complesso Tempio-Criptoportico di Urbs Salvia: dati preliminari e analisi...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I tegami da fuoco dal complesso Tempio-Criptoportico di Urbs Salvia: dati preliminari e analisi...
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares,
Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry
The Mediterranean: a market without frontiers
Edited by
Natalia Poulou-Papadimitriou, Eleni Nodarou and Vassilis Kilikoglou
BAR International Series 2616 (I)2014
Volume I
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2616 (I)
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. Volume I.
© Archaeopress and the individual authors 2014
Cover illustration: Early Byzantine amphora from Pseira, Crete (photo by C. Papanikolopoulos; graphic design by K. Peppas).
ISBN 978 1 4073 1251 4 (complete set of two volumes) 978 1 4073 1249 1 (this volume) 978 1 4073 1250 7 (volume II)
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
553
I TEGAMI DA FUOCO DAL COMPLESSO TEMPIO-CRIPTOPORTICO DI URBS SALVIA: DATI PRELIMINARI E ANALISI ARCHEOMETRICHE
MARZIA GIULIODORI1, VALERIA TUBALDI2, ELEONORA PARIS3, CINZIA MARTINELLI3
1 Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell’antichità, piazza C. Battisti
1, Macerata; [email protected] 2 Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, via Birarelli 18, Ancona; [email protected]
3 Università degli Studi di Camerino, Dipartimento di Scienze della terra, via Gentile III da Varano, Camerino; [email protected]; [email protected]
The excavations conducted since 1995 by the University of Macerata in many contexts of the site of Urbs Salvia (Regio V, Picenum), especially in the Tempio-Criptoportico Complex, have provided new findings concerning the main phases of the colony’s life, from the late republican period to its final destruction and abandonment. Among the large quantity of cooking wares coming from these contexts, this paper focuses on the pan vessel. By comparing the specimens belonging to different layers we analyze the temporal evolution of the shape, the development of the characteristics of the fabrics, and also of the surfaces. The contribution of archaeometric analyses is taken into account and contributes in determining the area of manufacture.
KEYWORDS: URBS SALVIA, TEMPIO-CRIPTOPORTICO, COOKING WARES, POMPEIAN RED WARES, PANS, ARCHAEOMETRY, LOCAL MANUFACTURING.
Il contesto di scavo
Le indagini sistematiche che dal 1995 il Dipartimento di Scienze archeologiche dell’Università di Macerata conduce annualmente sotto la guida di Giovanna M. Fabrini nell’area forense della città romana di Urbs Salvia (Regio V, Picenum) posta lungo la Salaria Gallica (Fig. 1) si sono concentrate in particolar modo sul grande complesso santuariale dedicato alla Salus Augusta (Fabrini 2000; 2001; 2003; 2005, 254-257; Perna 2006). I saggi di scavo eseguiti in diversi parti del monumento (Fig. 2), costituito da un tempio racchiuso entro un criptoportico, hanno permesso di chiarirne almeno in parte le vicende storiche a partire dalla sua costruzione avvenuta sostanzialmente in età tiberiana, obliterando precedenti strutture tardo repubblicane, al suo precoce declino già nella seconda metà del III - inizi del IV secolo, all’individuazione di una fase di spoliazione e abbandono che si colloca tra il V e il VII secolo sino al collasso definitivo della struttura verificatosi in età altomedievale presumibilmente a seguito del terremoto dell’801 (Fabrini et al. 2006, 317).
La fase meglio conosciuta è quella relativa all’impianto del santuario: più in dettaglio il saggio 1, che ha interessato gli strati di riempimento delle sostruzioni del pronao, e i saggi 2 e 5 che, eseguiti sulla fronte occidentale in profondità sino al terreno vergine, hanno restituito contesti riferiti alle più antiche fasi tardo repubblicana ed augustea e alla fase tiberiana per la presenza di ceramica a vernice nera databile dal II a tutto il I secolo a.C., terra sigillata italica di età augusteo-tiberiana, ceramica a pareti sottili, lucerne a volute, vetri e anfore (greco-italica tarda, Lamb.2, Dressel 6A, Dressel
2-4, Camulodunum 184) databili nella prima età imperiale (Fabrini 2000, 121-135; Giuliodori et al. 2007; Cingolani 2006).
Il saggio 4 e il saggio A1 si sono rivelati invece significativi per le fasi di epoca tardo antica.
Il Saggio 4, che ha portato all’individuazione della galleria occidentale del Criptoportico, in particolare nel taglio 2 effettuato in profondità sotto il crollo in situ della copertura della galleria (Fabrini 2000, 140-145), ha restituito una situazione stratigrafica sconvolta forse a seguito dell’asportazione delle lastre pavimentali avvenuta in una fase di abbandono e spoliazione collocabile tra il V e il VII secolo sulla base del rinvenimento di spatheia, LR3 e LR4, di un contenitore monoansato e di ceramica comune a bande a colature (Fabrini et al. 2006, 322-323). Questo saggio ha restituito inoltre una consistente quantità di materiali residuali inquadrabili tra II e IV secolo, quali terra sigillata medio adriatica (forma Brecciaroli Taborelli 12), sigillata africana A/D e C (Hayes 31, Lamb. 40, Hayes 50B, nn. 56-59), lucerne (Deneauve VG, Buchi IXb, Loeschcke VIIIL1), anfore (Dressel 2-4, a fondo piatto, Camulodunum 184, Africana I, Beltràn IIB, Almagro 50), ceramica a copertura rossa e vetri (Isings 32/35, 41, 42a, 43, 44a).
Il saggio eseguito nell’ Ambiente 1 (A1), disposto sulla testata della galleria Nord, ha messo in luce una grande fossa di spoliazione relativa ad un condotto d’acqua di notevoli proporzioni che fungeva da collettore di acque pulite per il Tempio-Criptoportico (Fabrini 2001, 14-20). Il riempimento di tale fossa ha restituito anche in questo caso materiali inquadrabili dall’epoca imperiale fino al
LRCW4
554
VII secolo (terra sigillata africana A/D, C, D1, ceramica africana da cucina, anfore LR1, LR2, spatheia di piccole dimensioni, ceramica a copertura rossa o bruna e ceramica comune a colature) con una particolare concentrazione di reperti che rimandano al III- IV secolo (Fabrini et al. 2006, 319-320).
La grande massa di materiali rinvenuti è in corso di studio e confluirà nella più complessiva pubblicazione di tutte le classi dei materiali. Ad un’analisi quantitativa la ceramica da fuoco è la classe con il maggior numero di attestazioni: più in particolare, risultando evidenti anche ad una prima disamina le differenze morfologiche e di impasto tra il vasellame da cucina rinvenuto in contesti della prima età imperiale e quello restituito dalle stratigrafie tardo antiche, si è focalizzata l’attenzione sui cambiamenti della forma dei tegami e sui relativi impasti per i quali le analisi mineralogico-petrografiche e chimico-fisiche hanno dato un contributo fondamentale. I dati che qui si presentano sono quindi da considerarsi il risultato di uno studio preliminare condotto su tutto il complesso delle ceramiche da fuoco rinvenute nelle campagne di scavo.
[M.G.]
I tegami da fuoco: dati preliminari
Nella batteria romana di pentole da cucina il tegame risulta un componente essenziale. Ad Urbs Salvia esso viene prodotto sia nella classe della ceramica da fuoco con impasto rozzo e refrattario sia in quella della vernice rossa interna associando ad un impasto comunque grezzo una copertura di vernice; entrambe le classi sono articolate in ampie tipologie basate sulle variazioni dell’orlo.
Per quanto riguarda la ceramica da fuoco gli esemplari più antichi provenienti dai saggi 1, 2 e 5 sono inquadrabili prevalentemente nei tipi ad orlo a mandorla (Fig. 3,1) e ad orlo ingrossato con il labbro a sezione circolare (Fig. 3,2) databili, sulla base dei contesti di ritrovamento, alla tarda età repubblicana - prima età imperiale. Tale dato cronologico trova conferma dal confronto, per il secondo tipo in esame, con esemplari rinvenuti in area adriatica, in specie a Pesaro (Bartolini 2008, 109, fig. 13,104) e a Rimini (Biondani 2005, 243, fig. 151, n. 46). Gli impasti in generale si presentano assai grezzi con inclusi evidenti di quarzo, di selce di colore bianco, bianco grigiastro o rosso scuro e di ossidi di ferro. Le superfici hanno una colorazione che varia dall’arancio al rosso scuro, fino al grigio scuro con forti chiazze ed aloni neri per effetto di un’esposizione diretta al fuoco. Ad Urbs Salvia essi si trovano in associazione ad olle con orlo a mandorla (Fig. 3,3) e con orlo estroflesso ingrossato con il labbro a sezione triangolare, olle che, complessivamente nei saggi esaminati, risultano quantitativamente prevalenti rispetto ai tegami stessi, denotando per questa fase una preferenza accordata alla tecnica di cottura della bollitura.
Il saggio 4 tg. 2 e il condotto A1 hanno restituito tegami con tipologie di orlo fortemente differenti rispetto ai
precedenti la cui caratteristica più evidente è il gravitare verso l’interno del vaso. In generale si nota che la tendenza dell’orlo a “rientrare” sembra costituire il risultato di un ampio fenomeno imitativo che prende come modello d’ispirazione la forma della scodella Hayes 61 in terra sigillata africana, diffuso a partire dal tardo IV secolo in tutto il territorio italico e registrato anche in località dell’entroterra (Fontana 1998) come Urbs Salvia dove i prodotti africani costituiscono una presenza modesta (Fabrini et al. 2006, 334-344). Particolarmente diffuso infatti risulta il tegame ad orlo ingrossato verso l’interno e labbro arrotondato (Fig. 4,1); questa forma è nota a Suasa nei contesti tardi del Foro dove viene inquadrata tra l’età flavio-traianea ed il V sec. d.C. (Assenti e Roversi 2010, 284, fig. 6,3), inoltre esemplari con caratteristiche raffrontabili per l’orlo appaiono in altri siti marchigiani quali Cone, Castelfidardo e Portorecanati (Mercando 1979, 109, fig. 17q-r; 199, fig. 117i; 153, fig. 63g; 241, fig. 153p e r) nei quali tuttavia la loro provenienza da contesti sconvolti impedisce di trarre indicazioni cronologiche circostanziate. Frequenti anche le attestazioni del tegame con l’orlo internamente ingrossato con il labbro appiattito superiormente e obliquo verso l’interno e ansa a maniglia quadrangolare (Fig. 4,2) che sembra vagamente richiamare la forma della casseruola Hayes 23B. In entrambi i tipi le pareti risultano nella porzione superiore svasate, mentre in quella inferiore è presente una carenatura che determina la convergenza delle pareti verso il fondo leggermente convesso, caratteristica peculiare questa degli esemplari di Urbs Salvia. Gli impasti appaiono più secchi e meno polverosi al tatto, rispetto a quelli rinvenuti nei saggi 1, 2, 5, dalla frattura più netta e tagliente e dal suono tintinnante.
In questi contesti la presenza dei tegami continua comunque a risultare inferiore alle quote di attestazione delle olle e soprattutto a quelle dei caccabi, pentole queste ultime che, stabilmente diffuse nella cucina romana solo a partire dal I sec d.C. (Olcese 2003, 39), insieme alle forme già in uso ad Urbs Salvia, rispondevano alle accresciute esigenze di una cucina che verosimilmente si può ipotizzare più arricchita e differenziata rispetto a quella delle età precedenti.
Alla medesima fase tarda possono essere ricondotti inoltre tegami con particolari trattamenti delle superfici; nello specifico, dal condotto proviene un tipo di tegame con orlo leggermente introflesso indistinto con il labbro arrotondato e parete curvilinea il cui interno reca bande di politure a stecca alternate a fasce di risparmio (Fig. 4,3). Questa tecnica di finitura delle superfici sembra risentire dell’influenza dei prodotti africani da cucina politi a bande e a strisce che vengono prodotti in Bizacena a partire dalla prima metà del II sec. d.C. (Bonifay 2004, 214-221) ed esportati in Italia dalla seconda metà dello stesso secolo al IV d.C. Tale espediente, oltre a creare un accattivante effetto ottico di avvicendamento di fasce opache a fasce lucenti, aveva probabilmente anche la funzione pratica di aumentare l’impermeabilizzazione delle superfici.
GIULIODORI-TUBALDI-PARIS-MARTINELLI
555
Dall’approfondimento del saggio 4 proviene inoltre un altro tipo di tegame con orlo, anch’esso inclinato verso l’interno e vagamente triangolare, che risulta caratterizzato da una accurata lisciatura riservata esclusivamente all’orlo stesso. Si può ipotizzare che anche questa attitudine alla differenziazione dell’orlo rispetto al corpo del vaso sia determinata dall’influenza esercitata dai prodotti africani ad orlo annerito ampiamente circolanti anch’essi a partire dalla seconda metà del II sec. d.C. (Tortorella 1987, 299).
Alla classe della vernice rossa interna appartengono tegami che nelle stratigrafie più antiche hanno orli a mandorla piuttosto schiacciata e pareti bombate (Fig. 5,1). Essi trovano stretta corrispondenza con un tipo rinvenuto a Bolsena in un contesto datato alla prima metà del I sec. a.C. (Goudineau 1970, 11, Pl. VII couche 3B,6), mentre in ambito marchigiano orli a mandorla sono presenti a Iesi fra la fine del II ed il I sec. a.C. (Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 218, fig. 114, nn. 629-631), a Pesaro (Bartolini 2008, 102-103, fig. 10, 75-76) e a Suasa fra i materiali della fase di fondazione del Foro (Assenti e Roversi 2010, 275, fig. 1,4).
Con lo stesso orlo a mandorla si è poi notata anche la presenza, nei medesimi saggi, di tegami con un altro tipo di impasto che, ad una preliminare analisi ad occhio nudo, presentava caratteristiche macroscopiche completamente diverse da quelle degli altri impasti riscontrati solitamente per i tegami di Urbs Salvia, soprattutto per la presenza di inclusi neri lucenti di natura vulcanica i quali farebbero propendere per un’origine tirrenica dello stesso.
Compaiono nei medesimi contesti anche tegami ad orlo bifido (Fig. 5,2) forma tra le più antiche della vernice rossa interna e quelli con orlo a tesa. L’ingobbio che ricopre i vasi nel fondo e nelle pareti interne ed esternamente solo fino all’orlo si presenta di un colore rosso vivo (M. 2.5 YR 4/8). Gli impasti sono polverosi al tatto, sabbiosi e ricchi di mica.
La classe si presenta con caratteristiche completamente mutate nei contesti tardi. Da un punto di vista tipologico prevale l’orlo estroflesso con il labbro indistinto o leggermente ingrossato esternamente, obliquo verso l’interno (Fig. 5,3), seguito dal tipo ad orlo estroflesso indistinto con il labbro squadrato (Fig. 5,4). Gli impasti sempre micacei risultano più granulosi in frattura e più secchi al tatto ma sostanzialmente omogenei con quelli delle precedenti stratigrafie; ciò che si differenzia in maniera più netta è la vernice che assume una colorazione decisamente più chiara, arancio tendente al beige (M. 5YR 6/6,7/6). Le pareti esternamente mostrano una rifinitura con la tecnica della steccatura o della lisciatura a bande alternate. Il confronto con alcuni esemplari simili provenienti da una tomba di Portorecanati datata al II sec. d.C. (Mercando 1974, 203, fig. 24b-e) permette forse di individuare il termine iniziale per questa produzione.
Per comprendere se le differenze sopra evidenziate, sia morfologiche che di impasto, siano riconducibili semplicemente ad un cambiamento maturato nel tempo nell’ambito di una stessa manifattura probabilmente
locale oppure se vadano ricondotte ad una produzione differente, comunque legata al territorio o di importazione, ci si è rivolti al Laboratorio di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Camerino.
Pertanto si è proceduto ad effettuare una campionatura ragionata degli impasti di fabbricazione dei tegami rinvenuti ad Urbs Salvia, per cui ciascun campione risulta essere rappresentativo di un cospicuo numero di esemplari realizzati con quell’impasto; inoltre si è ritenuto opportuno fornire al Laboratorio alcuni scarti di fornace, provenienti dall’area del Foro di Urbs Salvia, di ceramica inquadrabile all’interno della classe della rozza terracotta per avere un sicuro “referente” dell’impasto di origine locale.
[V.T.]
Analisi archeometriche
Metodologie
I campioni studiati (Tabella 1: Fig. 6) sono stati analizzati mediante il microscopio petrografico a luce polarizzata (OM) e la diffrattometria dei raggi X (XRD) per polveri presso il Laboratorio di Mineralogia dell'Università di Camerino. Lo studio dei campioni in MO è stato effettuato su sezioni sottili di circa 20-30mmq, spessore 30 micron, utilizzando un microscopio NIKON OPTIPHOT-POL, con oculari da 10X e obiettivi moltiplicatori da 2,5X, 4X, 10X e 20X. Lo studio dei campioni con la XRD è stato realizzato utilizzando circa 2g per ciascun manufatto. Le polveri, ottenute per macinazione in mortaio di agata, sono state inserite in un portacampione a caricamento laterale e analizzate al diffrattometro PHILIPS PW 1830, con radiazione CuK a 45kV e 25mA.
Le superfici interne dei campioni VS.101, VS.102 e VS.103 sono state analizzate mediante impiego di microanalisi di raggi X di fluorescenza a dispersione di energia (EDX), abbinata al microscopio elettronico a scansione (SEM) CAMBRIDGE STEREOSCAN S-360, in condizioni operative di 20 kV e 10 nA.
Le analisi effettuate hanno permesso di identificare alcuni parametri fondamentali per la caratterizzazione della ceramica quali: composizione mineralogica dell'impasto, granulometria degli inclusi, quantità e forma della porosità, tessitura del materiale ceramico, presenza e tipo dei frammenti litici e litoidi (Cuomo Di Caprio 1988; Whitbread 1989).
Risultati
Analisi petrografica
L’esame in sezione sottile petrografica per il campione rappresentativo dell’impasto 1 (VS.101) evidenzia una matrice caratterizzata da un'alta attività ottica. È evidente l’aggiunta di un degrassante di granulometria omogenea, molto fine, angoloso probabilmente attribuibile ad
LRCW4
556
un'aggiunta di sabbia macinata (Tabella 2: Fig. 7). Il campione VS.102 (impasto 2), è caratterizzato da una matrice birifrangente, lo scheletro è poco selezionato da un punto di vista composizionale e granulometrico. Sono presenti evidenti frammenti di pirosseni, miche e feldspati. L’analisi del campione VS.103 (impasto 3), mostra una stretta corrispondenza con le caratteristiche evidenziate dall’analisi dell’impasto numero 1 con la sola differenza che qui si rileva una granulometria più grossolana del degrassante utilizzato. Il campione rappresentativo dell’impasto 4 (VS.104) presenta frammenti evidenti di selce e alcuni granuli di chamotte, la granulometria va da medio-fine a grossolana, la forma degli inclusi è molto angolosa. La porosità è elevata e formata da pori allungati ed orientati. Gli inclusi riconosciuti sono attribuibili a quarzo, plagioclasi e frammenti di chamotte. Le due sezioni sottili relative agli scarti di fornace (campioni VS.105 e VS.106) mostrano un'evidente vetrificazione della matrice. La porosità è alta e gli inclusi presenti nell'impasto sono piuttosto grossolani. Tra essi si riconoscono grandi granuli di quarzo e di selce, tra i quali alcuni mostrano un bordo di fusione, altri evidenti fratture che evidenziano una cottura prolungata ad alta temperatura. Si riconoscono anche frammenti di chamotte.
Analisi mineralogica
La composizione mineralogica dei campioni analizzati è stata determinata grazie alle analisi XRD (Tabella 2: Fig. 7). Il campione VS.101 (impasto 1) presenta quarzo molto abbondante, plagioclasi e minerali argillosi in discreta quantità mentre calcite e ematite sono presenti solo in tracce. Il campione VS.102 (impasto 2) è molto più vario dal punto di vista mineralogico, con abbondante quarzo, plagioclasi, minerali argillosi, biotite, sanidino e diopside. L' impasto 3 (campione VS.103) è simile a quello dell’impasto 1, con la sola differenza che al posto dell’ematite troviamo in tracce la fase mineralogica del diopside. Il campione relativo all'impasto 4 (VS.104) presenta invece una composizione mineralogica formata quasi esclusivamente da quarzo, mentre plagioclasi e minerali argillosi sono presenti in modesta quantità. Infine, i due scarti di fornace analizzati (VS.105, VS.106) mostrano la presenza di quarzo, feldspato e diopside.
Analisi microchimica
L’analisi microchimica è stata effettuata sulle vernici della parete interna dei campioni VS.101, VS.102 e VS.103 e ha mostrato come la composizione chimica del pigmento usato nei tre campioni sia pressoché identico. In tutti e tre i campioni si rinvengono Silicio, Calcio, Potassio e Ferro (Fig. 8). L’unica differenza é stata riscontrata nel campione VS.103, che mostra un contenuto di Silicio maggiore rispetto agli altri due campioni.
Conclusioni
Dalla caratterizzazione minero-petrografica i campioni degli impasti 1, 3 e 4 risultano simili tra loro. In particolare, i campioni VS.101 e VS.103 sono molto simili anche per quanto riguarda le caratteristiche tessiturali e gli inclusi presenti e la loro composizione mineralogica, perfettamente compatibile con le litologie a vocazione ceramica presenti in loco, è pressoché identica, con la sola evidenza di tracce di diopside nell’impasto 3. L'analisi petrografica evidenzia come unica differenza tra i due campioni la granulometria del degrassante, che nel campione VS.103 è meno fine rispetto al campione VS.101.
Per quanto riguarda la temperatura di cottura dei campioni VS.101 e VS.103, i dati ottenuti mediante l'analisi XRD hanno evidenziato la presenza di calcite ed ematite che, insieme ai dati delle osservazioni in sezione sottile, suggeriscono temperature di cottura inferiori a circa 850°C (Brisbane 1981; Dominuco et al. 1999) per il campione VS.101 ma una temperatura leggermente superiore per il campione VS.103, vista la copresenza di calcite e diopside in tracce. Il confronto tra le caratteristiche petrografiche del campione VS.104 (impasto 4) e degli scarti di fornace mostra che i tre campioni hanno tutti struttura anisotropa e porosità elevata, impasto poco depurato, presenza di grossi inclusi di quarzo, selce e chamotte. La sostanziale omogeneità tra i campioni di ceramica e gli scarti di fornace, per quanto quest’ultimi mostrino delle caratteristiche dovute ad una eccessiva permanenza a temperature elevate in forno, consente di ipotizzare un processo produttivo simile per questi campioni e, soprattutto, consente di definire le caratteristiche composizionali della produzione locale per le ceramiche caratterizzate dall’impasto di tipo 4 (Rice 1987).
Dalle analisi è invece risultato subito evidente come il campione VS.102 (impasto 2) sia discordante rispetto a tutti gli altri impasti campionati ed analizzati. Sia l’analisi mineralogica che quella petrografica hanno evidenziato l’uso di materiale vulcanico come smagrante e una composizione mineralogica compatibile con una provenienza “tirrenica” del manufatto, nonché una temperatura di cottura molto più elevata rispetto agli altri campioni analizzati. Per questi motivi l’ipotesi formulata dallo studio archeologico di una produzione non locale ma di provenienza tirrenica per questo tipo di impasti è confermata dalle analisi archeometriche. L’analisi microchimica sulle vernici interne non mostra invece nessuna differenza di composizione del pigmento usato né variazioni sulla tecnologia di produzione di quest’ultime.
[E.P.; C.M.]
Considerazioni conclusive
In base ai risultati ottenuti dallo studio preliminare dei tegami da fuoco di Urbs Salvia si possono trarre le seguenti conclusioni:
GIULIODORI-TUBALDI-PARIS-MARTINELLI
557
- le analisi archeometriche hanno confermato le ipotesi formulate su base macroscopica: l’identità di impasto tra i campioni di scarto e i campioni di tegami analizzati comprovano l’esistenza di una produzione locale che sembra continuare per secoli con minime variazioni nei componenti impiegati.
- notevoli risultano le differenze morfologiche che permettono di distinguere nettamente la produzione di età tardo repubblicana e della prima età imperiale da quella del medio e tardo impero;
- si rileva l’utilizzo di particolari trattamenti delle superfici come la politura a bande alternate e la lucidatura dell’orlo nei tegami. Queste caratteristiche, al momento, non sono note nell’area della Regio V, Picenum;
- la ceramica a vernice rossa interna viene prodotta con i medesimi componenti della ceramica da fuoco: sembra quindi ragionevole ipotizzare una produzione locale /regionale anche per questa classe che presenta una granulometria più fine nella produzione antica e meno raffinata nei prodotti di media e tarda età imperiale, i quali sono inoltre risultati cotti ad una temperatura maggiore;
- la provenienza dall’area “tirrenica” del campione di vernice rossa interna si potrebbe circoscrivere all’area campana o etrusco-laziale dove è nota una fiorente produzione di tegami a vernice rossa interna largamente esportati in tutto il bacino mediterraneo (Leotta 2005);
- lo studio complessivo della ceramica da fuoco rinvenuta ad Urbs Salvia potrà dare un contributo notevole alla conoscenza di questa classe non solo per il territorio urbisalviense ma per tutta l’area del Piceno dove le informazioni sul vasellame da cucina di età romana sono ancora assai scarse.
[M.G.]
Ringraziamenti
Le autrici del presente contributo ringraziano la Prof.ssa Giovanna M. Fabrini, Direttore dello scavo di Urbs Salvia, per aver concesso di presentare in anteprima i risultati della loro ricerca.
Bibliografia
Assenti, G. e Roversi, G. 2010. Considerazioni cronologiche sui reperti ceramici da alcuni contesti del Foro. In E. Giorgi e G. Lepore (eds.), Archeologia nella valle del Cesano da Suasa a Santa Maria in Portuno, 275-286. Città di Castello Bologna, Ante Quem.
Bartolini, C. 2008. Lo scavo dell’ex Farmacia Boscia a Pesaro: analisi dei materiali ceramici. Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità XXVIII, 79-131.
Biondani, F. 2005. Ceramica da cucina. In L. Mazzeo Saracino (ed.), Il complesso edilizio di età romana nell’area dell’ex Vescovado a Rimini, 234-254. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Bonifay, M. 2004. Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique. British Archaeological Reports, International Series 1301. Oxford, Archaeopress.
Brecciaroli Taborelli, L. 1996-1997. (Ancona). L’officina ceramica di Aesis (III sec. a.C. - I sec. d.C.). Notizie degli scavi di antichità serie IX, VII-VIII, 5-267.
Brisbane, M. A. 1981. Incipient markets for early Anglo-Saxon ceramics: Variations in levels and modes of production. In H. Howard and E. Morris (eds.), Production and distribution: A ceramic viewpoint. British Archaeological Reports, International Series 120, 229-242. Oxford, Archaeopress.
Cingolani, S. 2006. Contributo preliminare allo studio di materiali vitrei dallo scavo del Tempio-Criptoportico di Urbs Salvia. Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità XXVI, 153-171.
Cuomo Di Caprio, N. 1988. La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d'indagine. Roma, L’Erma di Bretschneider.
Dominuco, P., Messiga, B. e Riccardi, M. P. 1999. An approach to the dynamics of clay firing. Applied Clay Science 15, 393-409.
Fabrini, G. M. 2000. L’area del Tempio-Criptoportico ad Urbs Salvia. Risultati preliminari delle campagne di scavo 1995-1999. Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità XX, 113-158.
Fabrini, G. M. 2001. Nuovi contributi storico-archeologici dall’area del Tempio-Criptoportico e del Foro di Urbs Salvia. Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità XXI, 9-35.
Fabrini, G. M. 2003. Urbs Salvia-Urbisaglia. In M. Luni (ed.), Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria all’età tardo antica, 148-153. Firenze, Nardini Editore.
Fabrini, G. M. 2005. Il nuovo volto di Urbs Salvia: il Criptoportico, l’area templare, il Foro, 1. In G. de Marinis, G. Paci, E. Percossi e M. Silvestrini (eds.), Archeologia nel Maceratese: nuove acquisizioni, 248-261. Macerata, Carima Arte srl.
Fabrini, G. M., Giuliodori, M., Forti, S. e Capponi, C. 2006. Produzioni ceramiche tarde da contesti del Foro di Urbs Salvia. In Tardo antico ed alto Medioevo tra l’Esino e il Tronto. Atti del XL Convegno di Studi Maceratesi, Abbadia di Fiastra (Tolentino), 20-21 novembre 2004, Studi Maceratesi 40, 311-391. Pollenza (Macerata), Tipografia San Giuseppe.
LRCW4
558
Fontana, S. 1998. “Le imitazioni” della terra sigillata africana e le ceramiche da mensa italiche tardo-antiche. In L. Saguì (ed.), Ceramiche in Italia VI-VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, 83-100. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Giuliodori, M., Di Cintio, C., Capponi, C. e Forti S. 2007. Produzione e circolazione della ceramica ad Urbs Salvia tra il III a.C. e la prima età imperiale. In Il Piceno romano dal III sec. a.C. al III d.C. Atti del XLI Convegno di Studi Maceratesi, Studi Maceratesi 41, 389-396. Pollenza - Macerata.
Goudineau, C. 1970. Note sur la céramique à engobe interne rouge-pompéien (“Pompejanisch-Roten Platten”). Mélanges de l'Ecole Française de Rome LXXXII, 159-186.
Leotta, M. C. 2005. Ceramica a vernice rossa interna. In D. Gandolfi (ed.), La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi. Quaderni della Scuola Interdisciplinare delle Metodologie Archeologiche 2, 115-120. Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Mercando, L. 1974. La necropoli romana di Portorecanati. Notizie degli scavi di antichità XXVIII, 142-445.
Mercando, L. 1979. Marche. Rinvenimenti di insediamenti rurali. Notizie degli scavi di antichità XXXIII, 89-296.
Olcese, G. 2003. Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana - prima età imperiale). Documenti di Archeologia 28. Mantova, Società Archeologica Padana.
Perna, R. 2006. Urbs Salvia. Forma e urbanistica. Città antiche in Italia 7. Roma, L’Erma di Bretschneider.
Rice, P. M. 1987. Pottery analysis. A sourcebook. Chicago, The University of Chicago Press.
Tortorella, S. 1987. La ceramica africana: un riesame della problematica. In P. Lévêque e J. P. Morel (eds.), Céramiques hellénistiques et romaines II, 279-327. Paris, Les Belles Lettres.
Whitbread, I. K. 1989. A proposal for the systematic description of thin section towards the study of ancient ceramic technology. In Y. Maniatis (ed.), Archaeometry: Proceedings of the 25th International Symposium on Archaeometry, 127-138. Amsterdam.
GIULIODORI-TUBALDI-PARIS-MARTINELLI
559
Fig. 1. Carta delle Marche con la localizzazione di Urbs Salvia ed il tracciato della Salaria Gallica
LRCW4
560
Fig. 2. Urbs Salvia. Pianta del Tempio-Criptoportico con l’indicazione dei saggi di scavo
Fig. 3. Ceramica da fuoco da contesti di età tardo repubblicana - prima età imperiale: 1-2. tegami; 3. olla con orlo a
mandorla
GIULIODORI-TUBALDI-PARIS-MARTINELLI
561
Fig. 4. Ceramica da fuoco da contesti di età medio e tardo imperiale: 1-2. tegami; 3. tegame con particolare della
superficie interna polita a bande
Fig. 5. Ceramica a vernice rossa interna da contesti di età tardo repubblicana - prima età imperiale: 1-2. tegami;
Ceramica a vernice rossa interna da contesti di età medio e tardo imperiale: 3-4. tegami














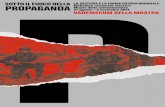
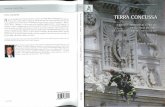


![[JOURNAL ISSUE] 2014_E. Casetta, V. Giardino (a c. di), Mettere a fuoco il mondo. Conversazioni sulla filosofia di Achille Varzi, Isonomia](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bcfae3e8acd9977059b4e/journal-issue-2014e-casetta-v-giardino-a-c-di-mettere-a-fuoco-il-mondo.jpg)














