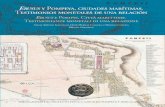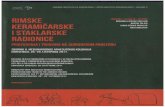Le anfore da trasporto e le monete rinvenute sul Pizzo di Ciminna
Note preliminari su un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 ad Elaiussa...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Note preliminari su un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 ad Elaiussa...
Emanuela Borgia, Veronica IacomiNote preliminari su un complesso industrialeper la produzione di anfore Late Roman 1
a Elaiussa Sebaste (Cilicia)
Nell’ambito delle recenti ricerche condotte a Elaiussa Sebaste 1, inCilicia, è stato individuato un isolato a carattere industriale al cuiinterno è una fornace per la produzione di anfore LR 1 (FIG. 1) 2.Tenendo conto dell’enorme diffusione in ambito mediterraneo del-le anfore di questo tipo in età tardo-antica e proto-bizantina 3 e so-prattutto dell’eccezionalità del ritrovamento di un intero complessoproduttivo in buono stato di conservazione, si è ritenuto opportu-no presentare in questa sede alcune note preliminari, che natural-mente sono passibili di revisioni e modifiche con il prosieguo dellericerche. Poiché contesti di fornaci con i relativi annessi funzionalisono poco noti ed assai raramente indagati in maniera estensiva 4,
* Emanuela Borgia, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze stori-che archeologiche e antropologiche dell’Antichità; Veronica Iacomi, Sapienza Univer-sità di Roma, II Scuola di Specializzazione in Archeologia, Indirizzo Orientale.
1. A Elaiussa Sebaste è attiva, sin dal 1995, la Missione Archeologica Italianadella Sapienza di Roma, diretta da Eugenia Equini Schneider. I risultati relativi allecampagne di scavo fino al 2003 sono confluiti, oltre che in diversi articoli tematici,nei volumi: EQUINI SCHNEIDER (1999 E 2003).
2. IL QUARTIERE È STATO INDAGATO NEGLI ANNI 2005-08. RESOCONTI PRELIMINA-
RI DELLE CAMPAGNE DI SCAVO 2005-06 SONO STATI EDITI IN EQUINI SCHNEIDER
(2006), pp. 564-5; (2007), pp. 300-1. Il rapporto sulla campagna del 2007 a cura diEugenia Equini Schneider è in corso di stampa.
3. L’area di produzione delle anfore LR 1 è da localizzare, secondo le più re-centi ipotesi, tra la Cilicia, Cipro e la regione antiochena. Per tali anfore e per la lorodistribuzione in tutto il Mediterraneo (ed anche nelle regioni più remote, fino al Da-nubio ed alla Scizia) si vedano, da ultimi EMPEREUR, PICON (1989), pp. 236-43; DE-
MESTICHA (2000); DEMESTICHA, MICHAELIDES (2001), pp. 291-2; DEMESTICHA (2003);OPAIT (2004), pp. 294-5; ELTON (2005), pp. 691-3 (che include anche Rodi e partedella Pamphylia tra le aree di fabbricazione); PIERI (2005), pp. 69-85; REYNOLDS
(2005), pp. 565-7; FERRAZZOLI, RICCI (2006); PIERI (2007); FOURNET, PIERI (2008), inparticolare pp. 184-202 per i tituli picti.
4. Scavi sistematici in ateliers che producevano anfore LR 1 sono stati ad oggi
L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1029-1054.
il confronto con altri impianti analoghi, pur se in aree diverse delMediterraneo, risulta di primaria importanza ai fini di una migliorecomprensione dell’articolazione di tali complessi, nonché dei relati-vi processi produttivi.
Il quartiere residenziale sul promontorio
La città di Elaiussa, di fondazione ellenistica, acquisì durante il re-gno di Augusto il titolo di Sebaste ed assunse una notevole impor-tanza durante la prima età romana, prosperando fino agli inizi delIII secolo. Elaiussa conobbe poi, tra il V e il VII secolo, un rinnova-to benessere, testimoniato tanto dalle nuove attività edilizie, intesesia alla costruzione di nuovi edifici che alla trasformazione funzio-nale e strutturale di complessi monumentali preesistenti, quantodalle attività produttive e commerciali.
condotti solo a Cipro (a Paphos, a Zygi-Petrini e a Dhiorios), ma le indagini nonestensive non hanno consentito di delinearne in maniera chiara l’organizzazione inter-na. Cfr. CATLING (1972); DEMESTICHA (2000; 2003); DEMESTICHA, MICHAELIDES
(2001). A Elaiussa Sebaste sono note, oltre a quella in esame, altre tre fornaci per LR1, che tuttavia non sono state ancora completamente indagate (cfr. infra nota 9).
Fig. 1: Elaiusse Sebaste, veduta aerea del quartiere produttivo e industrialenel 2007 (foto S. Ruschena).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1030
Uno dei settori più significativi in questo senso è costituito dalpromontorio dove si sviluppò il nucleo iniziale dell’insediamento edove sono da localizzare, fin dal primitivo impianto della città, iquartieri di abitazione. Le indagini archeologiche ivi condotte apartire dal 2005 hanno contribuito a delineare l’evoluzione diacro-nica di un ampio isolato ubicato lungo la costa meridionale delpromontorio, notevole sia per l’organizzazione topografica sia pergli evidenti sviluppi che esso conobbe dalla tarda età ellenistica alperiodo bizantino 5 (FIG. 2). L’impianto originario del quartiere, se-
5. L’evoluzione topografica del quartiere ricalca, pur se con peculiarità specifi-che, le grandi tappe dello sviluppo urbanistico individuabili in tutta la città. Data l’e-vidente complessità del contesto, in questa sede si affronteranno in via preliminaresolo quegli aspetti utili all’inquadramento della fornace e dei suoi annessi. Lo studiodi dettaglio del quartiere residenziale e industriale, nelle sue trasformazioni diacroni-che, è attualmente in corso a cura di chi scrive; vi confluiranno anche i dati specificirelativi ai diversi materiali rinvenuti, in particolare quelli relativi ai reperti ceramici, ilcui studio è in corso ad opera di A. F. Ferrazzoli e M. Ricci.
Fig. 2: Planimetria del quartiere produttivo e industriale (rilievo di M. Braini).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1031
condo quanto emerso dallo scavo, deve risalire all’età ellenistica(per lo meno a partire dal II secolo a.C.), epoca a cui sono attri-buibili alcune strutture murarie isolate e sporadici contesti strati-grafici. Anche della fase romana (I-II secolo) rimangono rare testi-monianze e scarsi resti monumentali, che hanno subìto una presso-ché completa ristrutturazione in età proto-bizantina. Tale circostan-za non consente allo stato attuale delle ricerche di ricostruire indettaglio l’organizzazione topografica del quartiere, probabilmentegià articolato su terrazze, nei primi secoli dell’impero, né la desti-nazione d’uso delle strutture.
Questo settore della città fu interessato, a partire dal tardo V
secolo, da una completa ristrutturazione, accompagnata da modifi-che radicali e massicci sbancamenti che rimossero quasi completa-mente le strutture pertinenti ai periodi precedenti. L’isolato, adat-tandosi alla conformazione naturale del promontorio, fu articolatoanche in questa fase su una serie di terrazzamenti ricavati regola-rizzando il banco roccioso e posti a quote differenti. Le diverseterrazze risultano raccordate da un sistema di percorsi a gradoni orampe inclinate, generalmente con andamento spezzato. Mentrenella terrazza inferiore, prospiciente la linea di costa, fu installatoun impianto industriale per la produzione di ceramica 6, le terrazzesuperiori ospitavano, invece, strutture adibite a funzioni abitativecon annesse attività artigianali e commerciali (FIG. 3). Le singoleunità edilizie, organizzate talvolta attorno a corti scoperte, eranospesso sviluppate in altezza su due o più piani, come è attestatodalla presenza di scale nonché dagli strati di crollo dei diversi li-velli pavimentali e delle coperture 7. Per tutto il periodo in cui ri-
6. Poco chiara è, allo stato attuale delle indagini, la destinazione d’uso dei vaninel settore orientale della terrazza prospiciente il mare: lo scavo di quest’area infatti,intrapreso durante la campagna del 2008, è tuttora in corso.
7. La quasi totalità degli ambienti indagati era colmata da cospicui strati di crol-lo, pertinenti alle strutture perimetrali così come alle coperture. In particolare, la pre-senza nei livelli inferiori di colmata di resti organici, probabilmente riconducibili adelementi lignei, e di numerosi chiodi metallici ha indotto ad ipotizzare che i solai fos-sero costituiti da fitte travature lignee, su cui poggiava il pavimento del piano supe-riore. In alcuni ambienti (IVa, IVc, IVg, IIf) sono stati infatti rinvenuti lacerti di mas-setto pavimentale, realizzato in malta molto tenace, ricca di inerti, e ghiaia di piccoleo minute dimensioni; in almeno un caso (ambiente IVc) si è potuto appurare che ilmassetto veniva messo in opera sopra ad una sorta di “incannucciata” realizzata congrandi foglie, la cui impronta risulta ancora visibile sulla parte inferiore dei frammen-ti di pavimento rinvenuti.
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1032
masero in uso, questi edifici subirono circoscritte ristrutturazioniche comportarono naturalmente varianti nel sistema di circolazionetra i vari ambienti, nonché forse nelle loro funzioni.
La vita del quartiere si prolungò fino alla metà del VII secolo,quando iniziò l’abbandono dell’area, che condivise la stessa sortedella maggior parte dei monumenti di Elaiussa Sebaste: ciò è resoevidente dai cospicui accumuli di immondizia e scarti di fornace,immediatamente precedenti i livelli di obliterazione e di crollo, at-tribuibili al secondo terzo del secolo, rinvenuti indistintamente intutti i settori indagati 8.
E.B., V.I.
8. In diversi settori dell’area di scavo, e in particolare nel vano Ib, sono statirinvenuti accumuli stratificati di frammenti ceramici, in una concentrazione tale (oltre21.000 frammenti, solo per quanto concerne le anfore LR 1, secondo il computo diA. F. Ferrazzoli e di M. Ricci) da far ragionevolmente ipotizzare che si tratti di attivi-tà sistematiche finalizzate al riempimento di vani caduti in disuso. Non si escludeche, quando già alcune strutture non erano più funzionanti, si siano verificati, primadell’abbandono definitivo dell’area, interventi per così dire d’emergenza (appunto conl’accumulo di materiale di scarto e di immondizie) volti alla creazione di nuovi livellidi circolazione, seppure per un utilizzo parziale e provvisorio.
Fig. 3: Elaiusse Sebaste, veduta generale del quartiere produttivo dalla ter-razza settentrionale: sullo sfondo, a destra, la fornace (foto V. Iacomi).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1033
Inquadramento topografico dell’impianto produttivo
Per quanto concerne più specificamente l’impianto per la produ-zione delle anfore, si deve innanzi tutto evidenziare come esso fuinstallato in un’area relativamente marginale e prossima al mare,analogamente a quanto accade anche nel caso delle altre fornaci at-tualmente note a Elaiussa Sebaste 9: ciò si spiega per evidenti ragio-ni di carattere organizzativo, logistico e pratico 10. Tuttavia il casoin esame risulta peculiare in quanto la fornace era inserita in uncontesto topografico unitario e realizzato contestualmente, di cuifanno parte anche abitazioni e strutture adibite ad altri scopi.
La fornace, è bene sottolinearlo, risultava tuttavia del tutto in-dipendente rispetto alle aree abitative e commerciali che occupava-no le terrazze sovrastanti, munite di propri accessi autonomi. Ilcomplesso industriale era invece accessibile da sud, tramite unarampa inclinata (larga mediamente 3 m) che correva parallelamenteal grande muro di delimitazione meridionale del complesso e chedoveva essere in diretta comunicazione con le banchine e con leeventuali strutture di approdo del porto meridionale. La rampa,
9. Le fornaci per la produzione di anfore LR 1 note ad Elaiussa Sebaste sono adoggi complessivamente quattro (inclusa quella in esame). Gli altri impianti si trovanol’uno all’esterno del muro di delimitazione nord-orientale del palazzo bizantino, l’al-tro sulle pendici settentrionali della collina del tempio, in un settore della necropolisud-occidentale, caduto in disuso a partire dalla fine del V secolo; l’ultimo è stato ca-sualmente portato alla luce a sud di Elaiussa, in occasione dei lavori di rifacimentodella moderna strada costiera. Il fatto che gli impianti per la produzione di anforesorgessero sempre a ridosso della costa e in prossimità del porto, era evidentementedovuto alla necessità di agevolarne il successivo imbarco e trasporto. Si vedano inmerito i resoconti di scavo di EQUINI SCHNEIDER (2006), p. 564, figg. 11-12; ID.(2007), pp. 302-3 e le brevi note di FERRAZZOLI, RICCI (2006), p. 1567, IDD. (2007),PP. 672-3 (solo per la fornace più meridionale), IDD. (cds.).
10. La dislocazione periurbana o extraurbana di impianti come le fornaci, estre-mamente comune, è da ascrivere alla natura dei processi produttivi, che evidentemen-te causavano inquinamento ed arrecavano grandi disagi. A titolo di confronto (e cir-coscrivendo il discorso alla parte orientale del Mediterraneo romano) possiamo citareun atelier per la produzione di anfore LR 1 individuato a Tarsos ubicato all’esternodelle mura (EMPEREUR, PICON, 1989, p. 241) e la fornace di Paphos (DEMESTICHA,MICHAELIDES, 2001, p. 290). Anche i quartieri per la produzione di sigillata a Saga-lassos e a Pergamo furono impiantati extra-muros, cfr. POBLOME et al. (2001), mentread esempio a Romula, in Dacia, gli impianti produttivi destinati alla fabbricazione dilaterizi e vasellame nell’ambito di una villa suburbana erano comunque disposti aimargini della tenuta: cfr. POPOLIAN (1976).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1034
sostenuta a valle da una struttura muraria al momento solo parzial-mente visibile, conduceva ad un’ampia area aperta rettangolare confontana centrale (vano Ii), di cui ancora poco si può dire poiché leindagini archeologiche sono ancora in corso. Sul lato occidentale diquesta piazza, che poteva eventualmente anche assumere la funzio-ne di deposito temporaneo di merci, si apriva l’ampia porta di in-gresso all’impianto produttivo (3,10 m). Non è chiaro se anchel’ambiente a nord dell’area (Ie), che si apre con una sola porta asud, sia da ricollegarsi all’impianto industriale, eventualmente comearea di deposito o ufficio.
Sembra probabile che l’installazione del complesso industriale siastata contestuale alla ristrutturazione di tutto questo settore dellependici meridionali del promontorio. Tale riorganizzazione, avvenutanella seconda metà del V secolo, doveva rispondere quindi ad unprogetto sostanzialmente unitario che prevedeva la realizzazione distrutture per fini domestici o artigianali-commerciali nelle terrazzesuperiori e della fornace con i suoi annessi in quella inferiore. Alloscopo di ricavare lo spazio necessario per la costruzione dell’impian-to industriale fu necessario peraltro operare uno sbancamento moltoconsistente per ampliare la terrazza verso nord. L’impatto di questointervento può essere valutato tenendo conto del fatto che essocomportò, nell’area in questione, la completa rimozione di tutte lestrutture e quindi delle stratigrafie pertinenti alle fasi più antiche (el-lenistica e romana): il banco roccioso fu asportato fino alla realizza-zione di una superficie orizzontale adeguata e fu tagliato a monterealizzando una parete verticale ed esponendo così le fondazioni dialcune strutture murarie preesistenti, di cui fu necessario in alcunicasi operare consolidamenti e ricortinature (FIG. 4) 11.
Articolazione del complesso produttivo
Sebbene alcuni aspetti siano ancora da precisare, l’organizzazionetopografica generale del complesso ed il sistema di circolazione trai vari ambienti risultano chiaramente riconoscibili 12. L’edificio, che
11. Ad esempio l’esposizione delle fondazioni del grande muro occidentale neresero necessaria la ricortinatura, realizzata con blocchetti allettati a scarpa.
12. Nel tentativo di delineare la finalità d’uso dei singoli vani indagati, dal mo-mento che i dati di scavo forniscono elementi labili, la mancanza di precisi termini diconfronto, come si è visto, induce ad avanzare ipotesi basate su considerazioni di ca-rattere meramente induttivo. In stretta contiguità con il settore propriamente produtti-
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1035
si compone di sei ampi vani, è articolato in due settori: quello set-tentrionale doveva verosimilmente ospitare gli ambienti di lavora-zione e di servizio, mentre in quello meridionale si trovavano lafornace stessa e la cisterna per l’approvvigionamento idrico. Unampio corridoio allungato (il tratto orientale del vano Ib) costituivail diaframma e al tempo stesso l’elemento di raccordo e di cernieratra i due settori.
Il complesso era accessibile tramite la porta di cui si è già det-to, situata nella zona sud-orientale, che immetteva nel vano Ig. No-nostante le indagini di scavo non siano state ancora ultimate, appa-re piuttosto evidente che tale ambiente rivestisse funzioni di ingres-so e di smistamento dei percorsi: due aperture lungo le pareti norde ovest lo mettono in comunicazione, rispettivamente, con l’adia-
vo del complesso, come è evidente, dovevano pertanto essere collocati i vani adibitinon solo alla lavorazione e all’assemblaggio, ma anche allo stoccaggio dei materiali ne-cessari a tutte le fasi del processo industriale ed è indubbio che tali aree dovessero ri-sultare disposte in maniera funzionale ad un ordinato (e metodico) svolgimento delleoperazioni di manifattura. Le proposte interpretative avanzate in questa sede si fonda-no pertanto su tali premesse, rimanendo comunque passibili di revisioni e modifiche.
Fig. 4: Terrazza meridionale: i vani settentrionali ricavati dal taglio del ban-co roccioso (foto V. Iacomi).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1036
cente vano If e con la zona settentrionale del complesso. Non sipuò escludere che, in caso di necessità, l’ambiente (di dimensioninon irrilevanti: 4,40 × 4,80/5,00 m) potesse essere utilizzato anchecome deposito temporaneo di materiali.
L’apertura verso nord, certamente carrabile data anche la suaampiezza (3,40 m), dava accesso al corridoio Ib (largo 3,80 m adest, 4,20 m ad ovest): quest’ultimo fu ricavato integralmente grazieal livellamento del banco roccioso 13, regolarizzato da una costipa-zione di argilla atta a creare un livello di calpestio orizzontale. Iltratto orientale del corridoio assolveva funzioni di snodo per la cir-colazione all’interno del complesso, dando accesso a nord al vanoId e di qui al vano Ic, a sud ad Ih e di qui sia alla fornace (Ia) cheal vano con la cisterna (If). Invece l’estremità occidentale era so-stanzialmente un corridoio cieco e pertanto, date anche la sua po-sizione e dimensioni, poteva essere utilizzato come deposito o, an-cor meglio, come ambiente adibito all’essiccazione dei manufatti inattesa di cottura (si tenga presente che l’ampiezza del vano – 4,25m – corrisponde quasi esattamente a quella della camera di cotturadella fornace). Il vano cadde in disuso verosimilmente, come tuttoil complesso, intorno alla metà del VII secolo 14.
Dall’estremità orientale del corridoio si accedeva verso nord al-l’ampio vano Id (8,00 × 6,20 m) che apparentemente doveva esserecompletamente aperto sulla sua fronte meridionale, inframmezzatasolo da un pilastro centrale, di cui rimangono esigui resti. Il pianodi calpestio era ottenuto, anche in questo caso, tramite spianamen-to e livellamento del banco di roccia, regolarizzato con colmate diargilla 15. Non esistono elementi che possano fornire indicazionicerte sulle sue funzioni, per quanto l’assenza di qualunque sovra-
13. Come si è già detto, tale operazione di sbancamento ebbe come conseguenzal’asportazione di tutti i livelli di vita precedenti: gli unici contesti stratigrafici supersti-ti, posti a diretto contatto con il banco roccioso ed a colmarne le lacune, sono carat-terizzati dalla presenza di ceramica non tornita e di lame in ossidiana, reperti chesembrerebbero ricondurre, in attesa di studi più approfonditi, ad un ambito cronolo-gico preistorico.
14. Il piano d’argilla risultava infatti obliterato da un grande livello di colmata,dello spessore totale di circa 1,80 m, in gran parte costituito di scarti e frammenti ce-ramici la cui preliminare analisi suggerisce un’attribuzione alla metà del VII secolo.
15. Tali livelli di vita, che al momento è possibile collocare genericamente nelVII secolo sulla base delle preliminari analisi dei reperti ceramici, devono risalire allafase finale di occupazione del complesso. Questo vano ha restituito solamente accu-muli di blocchetti di calcare in crollo a immediato contatto con il piano di calpestio.
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1037
struttura, l’ampiezza degli accessi – che poteva agevolmente con-sentire anche l’eventuale transito di carri – nonché la posizione aimmediato ridosso del vano di ingresso inducono a non ritenereimprobabile che esso costituisse il deposito per il legname.
Il vano Ic, ubicato immediatamente a ovest del precedente, pre-senta la peculiarità di avere il piano di calpestio, costituito da rocciaregolarizzata con colmate di argilla, ad una quota più elevata di cir-ca 0,90 m rispetto a quello degli ambienti circostanti. In assenza didati archeologici, non è possibile comprendere come esso fosse rac-cordato agli ambienti adiacenti, ma non si esclude che l’accesso av-venisse mediante scale lignee oppure che originariamente esistesseuna struttura in pietra o una rampa poi asportata. L’ambiente inorigine era probabilmente articolato in tre vani rettangolari distinti,come si evince dagli esigui resti dei setti murari divisori, ricavati inparte dal taglio della roccia e che dovevano prevedere delle apertu-re nel tratto sud. Nel vano più occidentale è stato individuato unbacino in pietra di forma circolare, poco profondo (Ø interno 0,31m; prof. 0,23 m), alimentato probabilmente da un condotto prove-niente dalla terrazza superiore e da cui si origina un canale di scoloin tubuli circolari di terracotta 16 (Ø 0,12 m) che corre lungo ilmuro meridionale di tutto il vano per poi interrompersi in corri-spondenza del suo limite orientale (FIG. 5): non è chiaro quindiquale fosse il punto di arrivo di tale condotto, il che inficia anchein parte la comprensione delle sue funzioni. Sembra plausibile ipo-tizzare che questo spazio fosse destinato alla tornitura e all’assem-blaggio dei vasi, come suggerirebbero alcuni indizi – pur se esigui –quali la dislocazione dell’ambiente, la sua ripartizione e la disponibi-lità di acqua; tuttavia le sue dimensioni relativamente ridotte e so-prattutto l’incongruo dislivello rispetto al resto del complesso indu-cono ad essere cauti in merito a questa interpretazione. L’impiantopiù antico di tale vano risale, sulla base dei dati emersi dallo scavodei piani di calpestio, al tardo V secolo, ossia al momento della rea-lizzazione dell’intero complesso; sono stati altresì individuati rifaci-menti attribuibili alla seconda metà del VI secolo, la cui vita prose-guì fino al VII secolo, ossia fino all’abbandono definitivo dell’area.
16. Analoghi allestimenti costituiti da condutture in terracotta che confluivano inpiccoli bacini circolari (confrontabili con quello preso in esame anche per dimensio-ni), sono stati individuati ad esempio nel quartiere dei vasai per la produzione di si-gillata indagato a Pergamo, dove vengono sempre ricondotti al settore di lavorazionee tornitura. Cfr. POBLOME et al. (2001), pp. 151-6, fig. 5.
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1038
Passando ad analizzare il settore meridionale dell’impianto in-dustriale (FIG. 6), il raccordo tra il corridoio Ib a nord, la fornace(Ia) ad ovest e il vano con la cisterna (If) ad est era garantito dalpiccolo vano Ih, dove è stata riscontrata la sovrapposizione di trepiani di calpestio in argilla battuta riferibili a diverse fasi di vitadell’impianto industriale (dalla fine del V alla metà del VII secolo).
Il vano If risultava accessibile non solo da Ih ma anche ad estda una porta che lo metteva in comunicazione diretta con l’am-biente di ingresso (Ig): tale posizione intermedia induce a ritenereche la sua funzione, strettamente legata alla fornace da un lato,prevedesse anche un facile e rapido accesso dall’esterno, pur se at-traverso un’apertura di limitate dimensioni (1,20 m). Le indaginiarcheologiche hanno dimostrato che l’ambiente conobbe due di-stinte fasi d’uso nell’arco di tempo in cui l’impianto industriale fuattivo. Nella prima fase esso risultava suddiviso in due parti (FIG.7): il vano rettangolare a nord doveva essere funzionale all’utilizzodella cisterna scavata nella roccia, la cui imboccatura è in quotacon il più antico piano di calpestio in argilla battuta; la zona meri-dionale dell’ambiente era invece interamente occupata da una vasca
Fig. 5: Vano Ic, bacino circolare e parte del condotto in terracotta (foto V.Iacomi).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1039
Fig. 6: Veduta generale del settore sud della terrazza meridionale (II fase)(foto V. Iacomi).
Fig. 7: Vano If, con la cisterna (I fase) (foto V. Iacomi).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1040
rettangolare (4,55 × 1,40 m; prof. 0,44 m) con fondo e pareti rive-stiti di intonaco idraulico, verosimilmente impiegata per la decanta-zione dell’argilla 17.
La vasca dovette cadere in disuso nella seconda metà del VI se-colo, così come i più antichi piani di calpestio del settore nord,che furono coperti da una serie consistente di livelli di argilla, al-ternati a sottilissimi depositi di sabbia. Successivamente all’oblitera-zione della vasca, l’attività di decantazione dell’argilla dovette esse-re trasferita altrove e di conseguenza dovettero mutare, pur se par-zialmente, le funzioni dell’ambiente: la presenza di un piccolo baci-no (di cui rimane l’impronta) con un canaletto di immissione eduno di scolo, impostati al di sopra dei livelli di colmata, induce asupporre che in questa seconda fase il vano fosse stato adibito allostoccaggio dell’argilla e forse anche alla sua preliminare lavorazio-ne. La grande cisterna ubicata nella parte nord dell’ambiente rima-se invece in funzione e la ghiera di imboccatura fu sopraelevata diun elemento per adeguarsi al nuovo piano di calpestio.
V.I.
La cisterna
La cisterna, interamente ricavata nel banco roccioso, è a pianta cir-colare e sezione troncoconica con pareti concave (Ø inf. 5,50/5,70m; h. dall’imboccatura, esclusa la vaschetta di decantazione: 4,60 m)e, conformemente a tutte le strutture analoghe diffuse ad ElaiussaSebaste e in Cilicia, è priva di adduzione nonché di un sistema discolo. L’imboccatura è costituita da due ghiere sovrapposte, perti-nenti come si è detto a fasi diverse: quella superiore consiste in ununico blocco parallelepipedo di calcare nel quale è ricavata l’apertu-ra cilindrica centrale (Ø 0,53 m), la seconda è composta invece dadue elementi semicircolari giuntati a formare un anello (Ø int. 0,53m). Sulle pareti si conserva per circa il 50% della superficie l’into-
17. I bacini di provenienza delle argille con cui venivano prodotte le anfore LR 1di Elaiussa non sono stati ancora individuati, ma indubbiamente non dovevano essereubicati nelle immediate vicinanze dell’impianto produttivo (analoga situazione si riscon-tra nella fornace per LR 1 di Paphos, cfr. DEMESTICHA, MICHAELIDES, 2001, p. 290).Per alcune analisi eseguite su un numero esiguo di campioni di scarti di fornace di LR1 (provenienti però non dalla fornace in esame, ma da quella ubicata a sud della città),cfr. BURRAGATO et al. (2007).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1041
naco idraulico di rivestimento, mentre sul fondo, lievemente in pen-denza dalle pareti verso il centro, è presente una vaschetta circolareper la decantazione (Ø sup. 1,15 m; Ø inf. 0,46 m; prof. 0,44 m),foderata in questo caso da uno strato di malta idraulica e ghiaia. Lacapacità complessiva è stata calcolata pari a circa 36.200 litri.
All’inizio delle indagini la cisterna, la cui imboccatura era anco-ra coperta dall’originaria lastra di chiusura, era colma per un’altez-za di circa 1,40 m dal fondo (FIG. 8). Il riempimento consisteva indue successivi accumuli di scarti di fornace (quasi esclusivamentepertinenti ad anfore di tipo LR 1B 18), frammisti a poca terra e arari blocchetti di calcare 19: l’interro superiore (spess. 1,10 m), co-stituito prevalentemente di anfore, si data entro la prima metà delVII secolo; invece il più antico strato di colmata (spesso mediamen-te 0,30 m), che copriva il fondo e la vaschetta di decantazione,consisteva di anfore e di brocche in ceramica comune, ritenutepertinenti alla metà del VI secolo 20. Nonostante le ovvie perplessità
18. FERRAZZOLI, RICCI (cds.).19. Data la disposizione assunta dallo strato superiore di accumulo, appare evidente
che esso si sia formato come conseguenza del butto indiscriminato di materiali all’internodella cisterna, senza che si sia poi provveduto al loro livellamento. Ciò fa pensare adun’azione concentrata in un breve lasso di tempo e dettata da circostanze contingenti,di cui al momento non sono precisabili né la natura né le cause; d’altronde è evidenteche l’utilizzo della cisterna, in seguito a tale colmata, fosse pregiudicato e che dunquel’impianto industriale in questa fase finale non funzionasse più a pieno regime.
20. I materiali provenienti dall’interro della cisterna sono stati sinteticamente presi inesame da FERRAZZOLI, RICCI (cds). Cfr. EQUINI SCHNEIDER (2007), p. 301.
Fig. 8: Cisterna nel vano If: sezione e particolare del riempimento (sezioneM. Braini, foto V. Iacomi).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1042
destate dalla presenza sul fondo di un accumulo di manufatti cera-mici di scarto, sembra doversi ritenere che la cisterna sia rimastain uso anche nella seconda fase di vita del vano If (seconda metàVI-inizi VII secolo), come dimostrato dal già menzionato adegua-mento dell’imboccatura al sopraelevato piano di calpestio.
Il riempimento ha restituito in totale scarti di fornace pertinentia circa 750-780 anfore, di cui 250 esemplari integri (FIG. 9), cui siaggiungono circa 50 brocchette in ceramica comune e 250 elementidistanziali 21. Il fatto che le anfore, anche quelle dei livelli inferiori,fossero in buona parte ancora integre al momento del ritrovamen-to, lascia intuire che esse siano state gettate all’interno della cister-na quando essa era almeno parzialmente piena di liquido 22.
21. Ai fini dello studio tipologico ed evolutivo delle anfore LR 1 i materiali perti-nenti alla cisterna costituiscono senza dubbio un rinvenimento eccezionale: si tratta infattidi uno dei più considerevoli contesti archeologici “chiusi” ad aver restituito un così am-pio numero di anfore tardo antiche (sebbene scarti di fornace), di poco inferiore per to-tale di esemplari (822 anfore in totale) al carico rinvenuto pressoché integro all’internodel relitto di Yassi Ada, per cui cfr. BASS, VAN DOORNINCK (1982), pp. 155-63.
22. Peraltro una traccia scura orizzontale molto evidente, ad un’altezza di circa0,90 m dal fondo, potrebbe indicare la permanenza di un liquido a quella quota perun tempo relativamente prolungato.
Fig. 9: Alcune delle anfore LR 1 rinvenute all’interno della cisterna; sullosfondo la fornace (foto V. Iacomi).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1043
La fornace
La fornace 23 occupa un vano rettangolare (Ia) (largo mediamente4,85 m), delimitato ad ovest, a nord e a sud da strutture murariepreesistenti, ristrutturate in occasione dell’impianto del complessoindustriale (FIG. 10) 24. La camera di combustione è lunga interna-
23. Per un primo resoconto sulla scoperta della fornace, cfr. EQUINI SCHNEIDER
(2006), p. 564, figg. 11-12; alcune notizie sommarie sono state rese note anche daFERRAZZOLI, RICCI (cds.).
24. La struttura muraria meridionale, il cui primo impianto risale all’età tardo-
Fig. 10: Vano Ia, la fornace da ovest (foto V. Iacomi).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1044
mente 6 m ed è larga 2 m (esclusi i pilastrini) 25; essa era chiusaad est da uno spesso muro in argilla pressata rivestito di mattonicrudi (spess. 1,70 m) al centro del quale si apriva l’accesso strom-bato alla camera di combustione (largh. 0,70-1,50 m). La strutturarientra pertanto nella tipologia IIb delle fornaci verticali con un’u-nica camera di cottura, sulla base della nota classificazione dellaCuomo di Caprio 26.
Il piano di fondo della camera di combustione, pertinente al-l’ultima fase di utilizzo della fornace (US 79), è costituito da argillapressata mista a malta, di consistenza molto compatta; esso ha an-damento lievemente concavo verso l’asse longitudinale est-ovestdella struttura. Un sondaggio effettuato nel settore occidentale –agevolato dalla presenza di una fossa realizzata in epoca recente,prima dell’avvio delle indagini archeologiche – ha rivelato la pre-senza di almeno tre piani battuti sottostanti quello oggi visibile, re-alizzati tutti in malta e argilla ed intercalati a tratti da allettamentiorizzontali di laterizi o tegole spezzati. Si conferma quindi l’uso re-lativamente prolungato nel tempo della fornace, che necessitava na-turalmente di continui rifacimenti e restauri. L’impossibilità di ap-profondire il sondaggio per non provocare lesioni alla struttura haimpedito la conoscenza più precisa delle fasi precedenti. Nel corsodello scavo sono state rinvenute solo alcune lenti di cenere sul fon-do, il che farebbe supporre che la fornace sia stata “ripulita”, perlo meno parzialmente, dopo l’ultima cottura; d’altronde, però, leanfore rinvenute in frammenti sugli scivoli (che rientrano nel tipoLR1 B2 27) dimostrerebbero che parte dell’ultimo carico sia rimastoall’interno (FIG. 11). Le pareti nei tratti conservati erano costituiteda argilla pressata rivestita da laterizi in argilla cruda, poi cottasinel corso dell’uso della fornace.
Il piano di cottura era sostenuto, secondo uno schema ampia-mente attestato in fornaci di età romana e bizantina, da archetti inmattoni crudi legati da argilla, intercalati a scivoli obliqui (largh.
ellenistica, assume uno spessore molto considerevole (1,30 m), mentre il muro a nordha uno spessore medio di 0,70 m. Per quanto concerne il muro di delimitazione occi-dentale, anch’esso di età ellenistica nei suoi ricorsi inferiori, vi si individuano diversirifacimenti successivi (spessore 0,90 m in basso e 0,65 m in alto).
25. In una delle fasi di rifacimento della fornace, nel settore di fondo della ca-mera di combustione è stata realizzata una sorta di banchina elevata che ingloba gliultimi due pilastrini, riducendone la profondità di circa 1,30 m.
26. CUOMO DI CAPRIO (1985), pp. 138-43, figg. 18-9.27. FERRAZZOLI, RICCI (cds.).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1045
media 0,30/0,35 m). Ottimamente preservate sono le otto coppiedi pilastrini (costituiti ciascuno da 8 o 9 mattoni; alt. max conser-vata 0,50/0,65 m) su cui poggiavano gli archi, dei quali rimane –solo in alcuni casi – il primo laterizio alle reni. I mattoni costituen-ti i pilastrini misurano mediamente 0,25 × 0,36 m e hanno spessorevariabile da 0,07 a 0,09 m. Si possono ricostruire archi alti, dalpiano pavimentale della camera di combustione, 1,80 m e con dia-metro pari a circa 2 m 28.
Non rimane alcuna traccia in situ del piano di cottura, per lacui ricostruzione si deve ricorrere al confronto con la maggior par-te delle fornaci note, che presentano quasi universalmente un pia-no di argilla forato atto ad agevolare la circolazione dell’aria calda.
Un’altra fornace per anfore LR 1, rinvenuta a Elaiussa Sebastenella necropoli sud-occidentale e meglio preservata in elevato, maancora in parte da indagare, può contribuire alla comprensione di
28. La lieve traccia arcuata che si intravede sul muro che chiude ad ovest la for-nace, il cui andamento coincide grosso modo con quello ricostruibile degli archetti,potrebbe essere intesa forse come l’impronta lasciata dall’estremità occidentale dellavolticina di fondo.
Fig. 11: Fornace, frammenti di anfore rivenuti su gli scivoli della camera dicombustione durante lo scavo (foto S. Ruschena).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1046
come poteva presentarsi il piano di cottura: vi si riscontra la solu-zione di disporre mattoni crudi di taglio ed in orizzontale al di so-pra degli archetti e degli scivoli interposti; su di essi veniva poisteso il piano forato (anche in quel caso non conservato) al di so-pra del quale erano, come è noto, impilate le anfore, inserite verti-calmente nei distanziali, rinvenuti in discreta quantità in tutta l’a-rea 29. I tre gradini in pietra visibili all’esterno della fornace, anord della bocca della camera di combustione, potrebbero esserericonducibili ad una scala funzionale all’accesso al piano di cotturastesso.
Pur se in maniera empirica e fondandosi su parametri di calco-lo teorici che, in quanto tali, possono fornire risultati da intendersicome puramente indicativi, si può tentare di determinare quale fos-se la portata della fornace. La superficie utile della camera di cot-tura è pari a circa 4,05 × 6,00 m, ossia 24,3 m2: considerando ildiametro medio di un’anfora pari a 0,25 m (tipo “piccolo”) e ipo-tizzando che le anfore venissero disposte con adeguati interspazi(1,5 - 2 cm), il numero complessivo di anfore posizionate su ununico livello può essere stimato approssimativamente pari a 330esemplari; se invece si prende in considerazione il tipo più grandecon diametro pari a 0,30 m il numero di esemplari si ridurrebbe a247. Dal momento che le anfore, come è assai plausibile, erano im-pilate su più file e frammiste anche ad altro vasellame, il numerodi vasi prodotti in una cottura è destinato comunque per lo menoa raddoppiare.
Nulla è rimasto della copertura della fornace. In assenza di ele-menti probanti, è opportuno fondarsi sul confronto con analoghiimpianti produttivi in migliore stato di conservazione. Il vano do-veva essere coperto da una volta a botte realizzata in argilla pressa-ta mista ad inerti, provvista delle debite aperture o camini per losfiato dell’aria. Al crollo e disfacimento della copertura deve pro-babilmente essere ascritto lo strato di concotto che copriva l’area eriempiva integralmente la camera di combustione. Non è esclusoche, analogamente a quanto accadde per i piani di cottura, per larealizzazione della copertura fossero impiegati sporadicamente an-che frammenti di laterizi inzeppati nell’argilla: ciò potrebbe giustifi-care l’esigua quantità di tegole rinvenuta nello strato di colmata 30.
29. Per tali elementi, cfr. FERRAZZOLI, RICCI (2007), p. 673, fig. 2b.30. L’impiego nella struttura di copertura di tegole all’interno dell’argilla pressata
troverebbe un parallelo nella fornace di Dhiorios, a Cipro, cfr. CATLING (1972), p. 54.
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1047
Si deve segnalare inoltre la presenza, nell’area antistante la for-nace principale, verso sud, di un’altra fornace più piccola di1,35 × 1,40 m, destinata probabilmente alla produzione di lucer-ne 31 (FIG. 12). Della fornace rimane solo la camera di combustionea pianta rettangolare (0,50 × 1,20 m), con le pareti nord, ovest esud in mattoni crudi (di dimensioni analoghe a quelli della fornacegrande), poi cotti durante il funzionamento della fornace. Ad est sitrovavano invece le due bocche di alimentazione, consistenti in ar-chetti realizzati sempre in mattoni crudi. Per quanto concerne lacopertura, al cui crollo deve ricondursi lo spesso strato argillosoche sigillava anche questa struttura, si deve immaginare una solu-zione analoga a quella suggerita per la fornace maggiore, agevolataperaltro dalle dimensioni ridotte.
Si verrebbe così a confermare un dato già parzialmente emersoin indagini precedenti 32: le fornaci per LR 1 potevano essere carat-
31. Alcuni frammenti di lucerne bizantine sono stati rinvenuti all’interno dellostrato di cenere pertinente all’ultimo utilizzo della fornace, che copriva il fondo. An-che a Paphos, in un vano adiacente alla fornace, sono state rinvenute numerose lucer-ne databili tra il VI e il VII secolo: cfr. DEMESTICHA, MICHAELIDES (2001), p. 290.
Un confronto per una fornace di lucerne, di proporzioni analoghe, ma databilenel III-IV secolo si ha a Berenice in Libia: anche in questo caso vi sono stati rinvenutisul fondo alcuni frammenti di lucerne, probabile rimanenza dell’ultima cottura. Cfr.LLOYD (1977), pp. 125, 212, figg. 24, 39a.
32. La pluralità di tipologie ceramiche prodotte nelle fornaci specializzate in an-
Fig. 12: La piccola fornace per la produzione di lucerne, da ovest (foto V.Iacomi).
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1048
terizzate da una produzione differenziata, forse anche nell’ambitodella stessa cottura, che prevedeva la realizzazione non solo di for-me differenti di anfore ma anche, come nel caso in esame, di cera-mica comune oltre che di lucerne, nella fornace più piccola.
Caduta in disuso e abbandono del complesso
La fine dell’attività del complesso industriale della fornace si puòinquadrare, come si è già accennato, in un arco cronologico piutto-sto definito e relativamente circoscritto. Gli ingenti strati di crolloche coprivano l’area settentrionale della terrazza, consistenti in ma-cerie di diversa natura depositatesi probabilmente in un tempo re-lativamente breve, sono databili nel secondo trentennio del VII se-colo; allo stesso periodo risalgono anche gli strati di argilla cheobliterano la fornace, consentendo quindi di definire il terminusante quem per la caduta in disuso dell’area industriale. Tale crono-logia coincide peraltro con quella dell’abbandono generalizzato ditutto il quartiere. Dal momento che i più recenti scarti di fornace,rinvenuti in grande quantità nel vano Ib, sugli scivoli all’internodella fornace e nella cisterna dell’ambiente If, risalgono alla metàdel VII secolo, si può asserire con un buon margine di precisioneche la fornace dovette smettere di funzionare intorno agli anniCinquanta dello stesso secolo.
Conclusioni
L’individuazione a Elaiussa Sebaste di questa e delle altre tre forna-ci per la produzione di anfore del tipo LR 1 (associate, come si èvisto, ad altre produzioni come ceramica comune e lucerne), oltre
fore LR 1 (probabilmente anche con l’ausilio di diversi forni associati, come accade aElaiussa nel caso del piccolo forno per lucerne) è attestata, oltre che in un’altra for-nace a Elaiussa stessa (FERRAZZOLI, RICCI, 2007, p. 673), anche altrove, grazie allostudio degli scarti di fornace (EMPEREUR, PICON, 1989, pp. 237-41). Se ne possono ci-tare esempi sulla costa nord-occidentale della Siria (ad esempio a Rhosos, dove le an-fore erano associate a ceramica comune e ceramica fine, ad Arsuz, dove venivanoprodotte anche tegole e coppi, e in un atelier a nord di Arsuz nel quale è attestataceramica oltre a tegole), in Cilicia stessa (un grande atelier presso Yumurtallk-Aigaiera specializzato in diversi tipi di anfore – LR 1, Dressel 4, Pseudo-Cos ed un tiponon identificabile con certezza – nonché in ceramica comune; a Karatas-Magarsos idepositi di scarti contengono anche ceramica fine e tegole; la fornace di Soloi-Pompeioupolis, sita ad est della città, produceva anche tegole).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1049
che confermare il ruolo – oramai peraltro unanimemente ricono-sciuto – assolto dalla Cilicia nel processo produttivo di tali conte-nitori, consente di definirne la distribuzione cronologica dal VI allametà del VII secolo, dimostrando che la fabbricazione di tali anforenella regione si prolungò per lo meno fino a questo momento 33.L’importanza del contesto in esame risiede soprattutto nel fattoche si tratta del primo caso per cui si possano formulare conside-razioni puntuali sull’articolazione e sul funzionamento interno diun atelier noto nella sua interezza, nelle sue diverse fasi di vita 34:nonostante la relativa ampiezza degli spazi disponibili, le dimensio-ni e la distribuzione dei vani sono comunque condizionate dai li-miti della terrazza e pertanto l’organizzazione del sistema di circo-lazione interna non poteva garantire al meglio l’indipendenza deipercorsi di argilla, vasi torniti e seccati e combustibile. Per quantopossibile, però, si è tentato di distribuire in maniera radiale attornoalla fornace i vani con funzioni differenziate e peraltro l’ampio cor-ridoio assiale agevolava lo svolgimento delle attività ed il transitodel personale e delle materie prime.
In età proto-bizantina, fino alla metà del VII secolo, Elaiussa Se-baste risulta quindi essere un importante centro portuale cilicio incui si producevano anfore LR 1 per lo stoccaggio di prodotti locali(in particolare vino e forse anche olio 35). Tuttavia la città non do-
33. La mancanza di dati noti aveva fatto supporre sino ad oggi che in Cilicia,così come in Isauria e in Siria, la produzione delle anfore LR 1 si fosse interrottaverso la metà del VI secolo, lasciando il posto alla produzione cipriota. Cfr. PIERI
(2007), pp. 613-4; ID. (2008), pp. 210-2. Gli eventi storico-politici che misero in diffi-coltà la zona costiera sud-orientale dell’Anatolia attorno alla metà del VI secolo po-trebbero essere alla base della cesura – peraltro di breve durata – tra la prima e laseconda fase di vita del complesso industriale elaiussense, ma non ne determinaronola chiusura definitiva.
34. Si viene in tal modo a colmare, pur se parzialmente, una lacuna sovente lamen-tata dagli studiosi nella conoscenza degli atelier. Cfr. da ultimo PIERI (2007), p. 612.
35. La natura del contenuto trasportato nelle anfore LR 1 è ancora oggetto didiscussione. L’orientamento più diffuso tra gli studiosi tende a propendere per l’ipo-tesi che si tratti prevalentemente di anfore vinarie, anche perché molte di esse sonorivestite di pece: BONIFAY, PIERI (1995), pp. 108-9; OPAIT (2004), pp. 297-8; PIERI
(2005), pp. 81-5; PIERI (2007), p. 612); altri suggeriscono invece un uso promiscuoper vino ed olio: VAN ALFEN (1996), pp. 208-9; ELTON (2005), p. 691; FERRAZZOLI,RICCI (2007), p. 673, o esclusivamente per l’olio: REYNOLDS (2005), p. 566. Solo i ri-sultati di analisi chimiche specifiche, su un numero adeguato di campioni, potrannoconsentire di definire in maniera inoppugnabile la questione. Ricordiamo che gli esa-mi effettuati sulle anfore da carico rinvenute nel relitto di Yassi Ada hanno permesso
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1050
veva essere che uno dei numerosi luoghi di produzione e distribu-zione di questo tipo di anfora (che potremmo definire con Rey-nolds “regional type” 36), appartenente ad una ben più vasta retecommerciale a livello regionale ed interregionale, che solo il prosie-guo delle ricerche ad ampio raggio potrà contribuire a definire. Al-tri centri costieri minori della regione potevano fungere, analoga-mente a quanto è stato riscontrato per Cipro nello stesso periodo,da tappe di cabotaggio per il trasporto di tali anfore e per la lorodistribuzione in tutto il Mediterraneo 37.
E.B.
Bibliografia
BASS G. F., VAN DOORNINCK (1982), Yassi Ada. I. A Seventh-Century By-zantine Shipwreck, (The Nautical Archaeology Series, 1), College Station.
BONIFAY M., PIERI D. (1995), Amphores du Ve au VII
e siècle à Marseille:nouvelles données sur la typologie et le contenu, «JRA», 8, pp. 94-120.
BURRAGATO F., DI NEZZA M., FERRAZZOLI A. F., RICCI M. (2007), Late Ro-man 1 Amphora Types produced at Elaiussa Sebaste, in LCRW 2. LateRoman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterra-nean: Archaeology and Archaeometry, (BAR Int. Ser., 1662), ed. by M.BONIFAY, J.-CH. TRÉGLIA, Oxford, pp. 689-99.
CATLING H. W. (1972), An Early Byzantine Pottery Factory at Dhiorios inCyprus, «Levant», IV, pp. 1-82.
CUOMO DI CAPRIO N. (1985), La ceramica in archeologia. Antiche tecnichedi lavorazione e moderni metodi d’indagine, Roma.
DEMESTICHA S. (2000), The Paphos kiln: manufacturing techniques of LR1amphoras, in RCRF, Acta 36, Abingdon, pp. 549-54.
DEMESTICHA S. (2003), Amphora production on Cyprus during the Late Ro-man Period, in VII
e Congrès International sur la Céramique Médiévale enMéditerranée, Actes, Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999, éd. par C. BA-
KIRTZIS, Athènes, pp. 469-76.DEMESTICHA S., MICHAELIDES D. (2001), The Excavation of a Late Roman 1
Amphora Kiln in Paphos, in La céramique byzantine et proto-islamique enSyrie-Jordanie (IV
e-VIIIe siècles apr. J.C.). Actes du colloque tenu à Amman
di verificare tracce di materiale organico in un’unica anfora LR 1, al cui interno siconservava un seme d’uva: VAN ALFEN (1996), p. 203 e n. 28 (con ulteriori riferimen-ti); BASS, VAN DOORNINCK (1982), pp. 164-5, 327-31.
36. REYNOLDS (2005), p. 575.37. LEONARD, DEMESTICHA (2004).
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1051
les 3, 4 et 5 décembre 1994, éd. par E. VILLENEUVE, P. WATSON, (Bi-bliothèque archéologique et historique, 159), Beyrouth, pp. 289-96.
ELTON H. (2005), The Economy of southern Asia Minor and LR 1 ampho-rae, in LRCW 1. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Ampho-rae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, ed. by J. MA.GURT I ESPARRAGUERA, J. BUXEDA I GARRIGÓS, M. A. CAU ONTIVEROS,(BAR Int. Ser., 1340), Oxford, pp. 691-5.
EMPEREUR J.-Y., PICON M. (1989), Les régions de production d’amphores im-périales en Méditerranée orientale, in Amphores romaines et histoire éco-nomique: dix ans de recherche. Actes du Colloque de Sienne, 22-24 Mai1986, Rome, pp. 223-48.
EQUINI SCHNEIDER E. (1999), Elaiussa Sebaste I. Campagne di scavo 1995-1997, Roma.
EQUINI SCHNEIDER E. (2003), Elaiussa Sebaste II. Un porto tra Oriente e Oc-cidente, Roma.
EQUINI SCHNEIDER E. (2006), Elaiussa Sebaste – Report of 2005 ExcavationSeason, «Kazı Sonucları Toplantısı», 28.2, pp. 561-74.
EQUINI SCHNEIDER E. (2007), Elaiussa Sebaste – Report of 2006 ExcavationSeason, «Kazı Sonucları Toplantısı», 29.2, pp. 299-310.
FERRAZZOLI A. F., RICCI M. (2006), Scambi commerciali fra l’Africa setten-trionale e la Cilicia in età tardoromana e protobizantina sulla base delmateriale ceramico dallo scavo di Elaiussa Sebaste, in L’Africa romanaXVII, pp. 1561-72.
FERRAZZOLI A. F., RICCI M. (2007), Elaiussa Sebaste: produzioni e consumidi una città della Cilicia tra V e VII secolo, in LCRW 2. Late RomanCoarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Ar-chaeology and Archaeometry, ed. by M. BONIFAY, J.-CH. TRÉGLIA, (BARInt. Ser., 1662, Oxford, pp. 671-88.
FERRAZZOLI A. F., RICCI M. (cds.), Un centro di produzione delle anfore LR1: gli impianti, le anfore, in LRCW 3, 3rd International Conference onLate Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Medi-terranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Westernand Eastern Mediterranean, Parma-Pisa, 26-30 march 2008.
FOURNET J.-L., PIERI D. (2008), Les ‘dipinti’ amphoriques d’Antinoopolis, inR. PINTAUDI (a cura di), Antinoupolis I, Firenze, pp. 175-216.
LEONARD J. R., DEMESTICHA S. (2004), Fundamental Links in the EconomicChain: Local Ports and International Trade in Roman and Early ChristianCyprus, in Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean.Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens,September 26-29, 2002, ed. by J. EIRING, J. LUND, (Monographs of theDanish Institute at Athens, 5), Aarhus, pp. 189-202.
LLOYD J. A. (1977), The Excavations, in J. A. LLOYD, R. REECE, J. M. REY-
NOLDS, F. B. SEAR (eds.), Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bereni-ke), I, (Lybia Antiqua Suppl., 5), Tripoli, pp. 11-228.
MANNING S. W., MONKS S. J., SEWELL D. A., DEMESTICHA S. (2000), Late
Emanuela Borgia, Veronica Iacomi1052
Roman Type 1a Amphora production at the Late Roman site of Zygi-Petrini, Cyprus, «RDAC», pp. 233-57.
OPAIT A. (2004), The Eastern Mediterranean Amphorae in the Province ofScythia, in Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean.Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens,September 26-29, 2002, ed. by J. EIRING, J. LUND, (Monographs of theDanish Institute at Athens, 5), Aarhus, pp. 293-308.
PIERI D. (2005), Le commerce du vin oriental à l’époque byzantine (Ve-VII
e
siècles). Le témoignage des amphores en Gaule, (Bibliothèque archéologi-que et historique, 174), Beyrouth.
PIERI D. (2007), Les centres de production d’amphores en Méditerranéeorientale durant l’antiquité tardive: quelques remarques, in LCRW 2. LateRoman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterra-nean: Archaeology and Archaeometry, ed. by M. BONIFAY, J.-CH. TRÉ-
GLIA, (BAR Int. Ser., 1662), Oxford, pp. 611-23.POBLOME J., BOUNEGRU O., DEGRYSE P., VIAENE W., WAELKENS M., ER-
DEMGIL, S. (2001), The sigillata manufactories of Pergamon and Sagalas-sos, «JRA», 14, pp. 143-65.
POPOLIAN G. (1976), Un quartier artisanal à Romula, «Dacia», XX, pp.221-50.
REYNOLDS P. (2005), Levantine amphorae from Cilicia to Gaza: a typologyand analysis of regional production trends from the 1st to the 7th centu-ries, in LRCW I. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Ampho-rae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, ed. by J. M.GURT I ESPARRAGUERA, J. BUXEDA I GARRIGÓS, M. A. CAU ONTIVEROS,(BAR Int. Ser., 1340), Oxford, pp. 563-611.
VAN ALFEN P. G. (1996), New light on the 7th-c. Yassi Ada shipwreck: ca-pacities and standard sizes of LRA 1a amphoras, «JRA», 9, pp. 189-213.
Un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman 1 1053