Usseaux - Meana di Susa - Gravere. Colli delle Finestre e delle Fattières. Complesso difensivo del...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Usseaux - Meana di Susa - Gravere. Colli delle Finestre e delle Fattières. Complesso difensivo del...
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoDirezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Quadernidella Soprintendenza Archeologica del Piemonte
Torino zor3 x&
Direzione e Redazione
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemontee del Museo Antichità EgiziePiazza S. Giovanni 2 - lOI22 TorinoTel.0LI-1952MFax0II-5213I45E-mail [email protected]
D irettor e della C o llanaEgle Micheletto - Soprintendente per i Beni Archeologicidel Píemonte e del Museo Antíchítà Egizie
Comítato Scienffico
Marica Venturino GambariGiuseppina Spagnolo GarzoliSofia UggéMatilde Borla
Coordinamento
Marica Venturino Gambari
Comitato di Redazíone
Paola AurinoSimona ContardiValentina Faudino
Segreteria d.í Redazione
Maurizia Lucchino
Editing ed elaborazione immagini
Susanna Salines
Pragetto graf.co e impaginazione
Linel-ab.edizioni - Alessandria
Stampa
Filograf Litografia - Forlì
La redazione di questo volume è stata curata da Paola Aurino,Simona Contardi e Valentina Faudino con la collaborazione diMaurizia Lucchino
Quando non diversamente indicato, i disegni dei reperti sono in scala1:3 (ceramica, vetri), in scala 1:2 (industria litica levigata, metalli), inscala 1:1 (industria litica scheggiata)
Il volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Cassadi Risparmio di Torino e con la collaborazione degli Amici del Museodi Antichità di Torino
È possibile consultare gli articoli pubblicati in questovolume nel sito istituzionale della Soprintendenza:http://archeo.piemonte.beniculturali.itlAttività / Editoria / Quaderni della Soprintendenza Archeologicadel Piemonte
@ 2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoDirezione Regionale per i Beni Culturalie Paesaggistici del PiemonteSoprintendenza per i Beni Archeologici del Piemontee del Museo Antichità EgiziePíazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino
tssN 0394-0160
1
Usseaux - Meana di Susa - Gravere. Colli di Finestre e Fattières
Complesso difensivo del XVIII secolo. Campagne di studio 2007-2012
Il contesto geostorico
Il colle delle Finestre (m 2176 s.l.m.) si estende fra i monti Pintas e Français Peloux e segna il confine fra il bacino orografico della val Sangone - massiccio dell’Orsiera e la dorsale fra le valli di Susa e Chisone, estesa fino al monte Fraiteve a dominio del colle di Sestrière; il colle delle Finestre è l’unico passo all’estremità orientale di questa dorsa-le che consenta un collegamento diretto fra il fondovalle della Dora e quello del Chisone entro i 2000 metri d’altezza (SOIUSA, SZ. 4 - Alpi Cozie, STS.4.II, A n. 3, MARAZZI 2005, p. 88). Da tale collocazione geografica deriva l’importanza strategica del sito in Età Moderna; infatti il cammino che attraversava il colle, sul versante della valle della Dora, scendeva direttamente alla piazzaforte di Susa, mentre dalla parte della val Chiso-ne raggiungeva Fenestrelle e le sue fortificazioni. Fino al 1713 il colle delle Finestre se-gnava il confine di stato fra il Regno di Francia, al quale apparteneva la val Chisone, e il Ducato di Savoia, ma per tutta la prima metà del XVIII secolo, le valli di Pragelato e Oulx, pur appartendo al Regno di Sardegna, rimanevano culturalmente distinte dalle ter-re basso-valsusine, fedeli da sempre alla Casa di Savoia. Il valore strategico-territoriale e più concrete contingenze belliche posero dunque il colle delle Finestre al centro di di-versi interventi difensivi già a partire dal XVII secolo.
Completa il quadro geografico del settore il colle delle Fattières (m 2530 s.l.m.), che si apre poco più ad ovest della cima del monte Pintas (m 2543 s.l.m.), dominante a sua volta il valico delle Finestre. Il colle delle Fattières corrisponde ad una breve cresta fra il Pintas e il Dente della Vecchia e il suo cammino, escludendo la guardia del colle delle Finestre, permetteva un transito più impervio, ma alternativo fra Dora e Chisone; con-seguiva da ciò il valore strategico della posizione delle Fattières, capace di vincolare la tenuta difensiva del colle inferiore. Quello delle fortificazioni dei due colli fu dunque un comune destino, tanto che la titolatura ordinaria delle località nei documenti ammini-strativi settecenteschi è «Finestre e Fattières», evitando la distinzione netta fra i due siti.
Gli interventi di ricerca
Lo studio delle fortificazioni dei colli delle Finestre e Fattières è stato sviluppato nel corso degli anni, dal 2007 al 2012, partendo da notizie varie e diffuse in una bibliografia piuttosto ampia e di vario genere (PEYRONEL 2007, pp. 128-136; SCONFIENZA 2012, pp. 69-80 con bibl.pregressa). Nel 2007 si è presa l’iniziativa per lo sviluppo di una ricerca di natura propriamente archeologica, coinvolgendo i membri del Gruppo Archeologico Subalpino, studenti dell’indirizzo Beni Culturali delle Facoltà di Lettere e Filosofia del-le Università di Torino, del Piemonte Orientale e di Firenze. Il team di ricerca è stato guidato per tutto il periodo da Roberto Sconfienza e da Francesco Rubat Borel fino al 2008; l’intera attività di rilievo archeologico è stata condotta da Carlo Gabaccia.
In via preliminare va segnalato che oggi il sito del colle delle Finestre risulta forte-mente riplasmato dai lavori del 1891 per la costruzione di un forte italiano in muratura e ipogeo presso il grande acrocoro roccioso su cui insisteva il nucleo centrale del com-plesso settecentesco, in buona sostanza obliterata (CORINO-GASTALDO 1993, pp. 140-143; MINOLA 2006, p. 171). Di conseguenza lo studio in situ di queste fortificazioni ha dovuto necessariamente appoggiarsi alla documentazione storico-cartografica e archivi-
2
stica, per procedere ad una corretta interpretazione delle restanti consistenze archeologi-che.
La campagna del 2007 ha preso avvio con una visita generale ai siti, dal colle delle Finestre a quello delle Fattières, secondo i caratteri della “ricognizione autoptica non si-stematica” (CAMBI-TERRENATO 2004, pp. 87-107, 122-144, 161-167; TOSCO 2009, pp. 1-96, 138-164, 234-267); si è poi deciso di intervenire in primis sul monte Pintas e alle Fattières, essendo conservate quasi integralmente a livello del suolo la linea magistrale del campo trincerato e le opere interne. L’azione d’indagine si è sviluppata producendo una schedatura generale di tutti i tratti evidenti e conservati delle fortificazioni conte-stualmente ad una campagna fotografica sistematica ed alcuni rilevamenti grafici, e-semplificativi di particolari della muratura a secco dei trinceramenti; al fine della ricerca è stata elaborata una scheda sperimentale per le strutture di fortificazione campale, ope-rando una sintesi fra le schede ministeriali di Unità Stratigrafica e di Architettura (US e A; SCONFIENZA 2012, p. 85). Si è svolta inoltre una ricognizione alle aree circostanti la cima del monte Pintas, individuando una zona di cava del materiale lapideo per la co-struzione dei trinceramenti e una piccola ridotta con fronte di guardia oltre il colle delle Fattières alle pendici del Dente della Vecchia; a completamento dei lavori è stato realiz-zato il rilievo archeologico generale del campo delle Fattières, tramite stazione totale.
La seconda campagna di studi, attuata nel 2008, è stata indirizzata all’intensificazione delle indagini presso la ridotta superiore sulla cima del monte Pin-tas, nucleo difensivo e strategico del campo delle Fattières. L’intervento è rimasto nei limiti di una ripulitura accurata, ma superficiale delle strutture rasate, senza attuare un vero e proprio scavo archeologico, che avrebbe inevitabilmente compromesso le evi-denze emergenti a livello del suolo e con minime fondazioni; grazie allo studio e alle ri-flessioni sul terreno è stato ricostruito il perimetro e l’aspetto in pianta della ridotta e si sono colti utili indizi per capire le modalità di demolizione dell’opera. Il lavoro è stato completato da una serie particolareggiata di fotografie alle strutture della ridotta.
Nel 2009 non si sono attuati interventi sul terreno, ma il tempo a disposizione è stato dedicato alla ricerca delle fonti manoscritte e cartografiche presso l’Archivio di Stato (Sezioni Riunite e di Corte) e la Biblioteca Reale di Torino. Nell’estate del 2010 la terza campagna di interventi sul terreno si è rivolta alle fortificazioni del colle delle Finestre, le cui consistenze sono conservate assai peggio rispetto a quelle delle Fattières. Il pro-cedimento di studio si è articolato in una prima fase di ricognizione e riconoscimento delle strutture, con relativa campagna fotografica e determinazione dei punti principali per la realizzazione del rilievo; particolari problemi ha causato l’approccio al fronte set-tentrionale del complesso, a dominio del cammino che conduce a Susa, a causa delle ri-plasmazioni conseguenti all’apertura della strada d’accesso al forte ottocentesco. Infine, come nel 2007, le operazioni si sono concluse con l’azione di rilevamento grafico trami-te stazione totale di tutte le strutture riconosciute.
Gli interventi conclusivi per lo studio sul terreno del sistema difensivo dei due colli sono stati condotti nel 2011, attuando una ricognizione lungo il trinceramneto di comu-nicazione fra le fortificazioni del colle delle Finestre e quelle superiori del monte Pintas, per integrare i dati e le osservazioni già maturate nel 2007 e nel 2008. Anche per questa terza componente del sistema è stato prodotto un rilievo, che composto con gli altri due ha permesso di ricostruire graficamente l’aspetto in pianta di tutte le difese e di produrre uno strumento di raffronto immediato fra i dati archeologici e quelli di provenienza ar-chivistica, completati con ricerche ulteriori svolte nel 2012. Attualmente tutto il mate-riale è in corso di rielaborazione per la redazione di una pubblicazione monografica sul
3
sistema difensivo dei colli di Finestre e Fattières, autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeolgici del Piemonte e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-saggistici per le Province di Torino Asti, Cuneo Biella e Vercelli (Prot. n. 1155 classe 31.13.01/41.1, 12-02-2010; Prot. n. 13077 classe 31.13.01/4.6, 17-06-2010).
Le consistenze archeologiche
I resti delle fortificazioni del colle delle Finestre si sviluppano a coronamento dell’altura che fiancheggia ad occidente il passo, la cosiddetta “montagne de la Moutie-re”. Partendo da ovest è evidente un’opera costituita da due trinceramenti simmetrici con rientrante centrale, in muratura a secco, che chiudevano il complesso presso la fale-sia rocciosa alle falde del versante sud-orientale del monte Pintas e difendevano un pas-so secondario, detto “Colletto”, il cui cammino saliva dalle contrade di Madonna della Losa in val di Susa. Esistono inoltre nell’area orientale di quest’opera i resti di un corpo di guardia con il suo trinceramento nord-sud, che segue le falde della sommità della Moutiere e in prossimità del quale, a sud, si sviluppa con andamento sud-ovest/nord-est un poderoso muro a secco rampante lungo il pendio della Moutiere con funzione di tra-versa di copertura per le opere inferiori della linea magistrale. Il fronte meridionale del complesso delle Finestre è costituito da una successione di trinceramenti collegati a li-nea spezzata, che formano nella parte occidentale tre successivi salienti e in quella o-rientale un ampio rientrante ottuso, seguito da un modesto saliente di fiancheggiamento per il tratto finale che discende al piano del colle; il primo saliente occidentale è raccor-dato al vertice con un cammino coperto rettilineo a trinceramento doppio in opera a sec-co, che collegava la linea magistrale delle fortificazioni con le difese, attualmente scomparse, della sorgente dell’Arnerun, nota oggi anche con il nome di “fontana dei Cacciatori”; il rientrante ottuso orientale è dotato di un rivellino in terra con il vertice saliente in corrispondenza del rientrante stesso. Ad est della strada moderna che valica il colle (SP 172) si erge un acrocoro che in antico era cinto dalla prosecuzione dei trince-ramenti della linea magistrale, i quali costituivano un’opera a doppia tenaglia, o bonetto (SCONFIENZA 2011, pp. 53, 74-75), con fossato a chiusura del complesso proprio alle falde del monte Français Peloux; tale assetto delle fortificazioni è documentato dalla cartografia storica, mentre oggi sul terreno l’intero settore è sconvolto dalla presenza di un’area spianata per la creazione di un parcheggio e si colgono poche tracce dell’ingombro dei terrapieni, retrostanti ai muri a secco, appena sulla cima dell’acrocoro, anch’essa spianata nei decenni passati. Il fronte settentrionale, sconvolto come s’è detto dalla strada d’accesso al forte ottocentesco, conserva scarse tracce delle fortificazioni più antiche, sufficienti tuttavia da permettere la ricostruzione di due sa-lienti successivi separati da un tratto di trinceramento rettilineo, secondo il modello del-la “ligne à redans” (SCONFIENZA 2011, pp. 53, 64-67); presso il rene del saliente occi-dentale le tracce scompaiono e poco oltre si innalza il massiccio roccioso centrale della Moutiere, sul quale a nord si agganciano le strutture del forte del 1891, responsabile della distruzione completa della ridotta sommitale del complesso, raffigurata nella car-tografia storica con fronte a tenaglia e a coronamento del massiccio stesso. La tecnica costruttiva di tutte le opere facenti capo al complesso delle Finestre è la muratura a sec-co con l’addossamento di un terrapieno e della banchina di tiro lungo la facciavista in-terna del corpo di fabbrica principale.
Realizzati completamente in terra sono invece i trinceramenti che compongono la lunga comunicazione ascendente dalle fortificazioni delle Finestre fino alla cima del Pintas, raccordata alla linea magistrale del campo delle Fattières. Il primo tratto inferio-
4
re della comunicazione ripropone il modello della “ligne à redans” con lunghi tratti ret-tilinei frapposti a due frecce, o redan, la più alta delle quali presenta un piccolo fianco rientrante per la difesa del raccordo con il trinceramento superiore in corrispondenza di un avvallamento e di un salto di quota; il tratto centrale della comunicazione, adeguan-dosi alla natura del pendio, segue un altro modello di “ligne”, più semplice, con succes-sione di ampi salienti e rientranti (SCONFIENZA 2011, pp. 53, 61-63), fino ad un’ulteriore variazione del pendio, alla quota di m 2480, 90 s.l.m., oltre la quale non è più possibile scorgere a vista il colle delle Finestre e dove si sono rinvenuti i resti molto consunti, sempre in terra, di un’opera a corno con asse capitale parallelo al versante percorso dal-la comunicazione (SCONFIENZA 2011, pp. 54, 75-76); raccordata al corno meridionale dell’opera, che difendeva l’accesso al tratto terminale della comunicazione, si sviluppa un’ultima “ligne à redans”, con due salienti separati da tratti rettilinei, l’ultimo dei quali si collega al fronte meridionale del complesso delle Fattières. L’intera fortificazione del-la comunicazione proteggeva una strada coperta di collegamento fra i due complessi e-ponimi del sistema e impediva la collocazione di una forza attaccante fra di essi, capace di vanificarne la sinergia difensiva.
Il campo trincerato delle Fattières risulta particolarmente articolato e lo studio sul terreno ha indotto la distizione in settori minori, ovvero l’occidentale, il settentrionale, l’orientale, il meridionale e il centrale. Il settore centrale, corrispondente con buona probabilità al nucleo più antico delle difese, presenta un trinceramento in terra a salienti e rientranti, in prosecuzione di quello terminale alto della comunicazione, che conduce alla cima del monte Pintas, su cui sorge la ridotta principale; quest’ultima, denominata “Sant’Antonio”, appartiene al tipo rettangolare con freccia sul lato breve e baraccone interno (SCONFIENZA 2011, pp. 54, 79-80), tutta realizzata in opera a secco. L’area som-mitale del Pintas è contenuta da muri a secco ortogonali fra loro, connessi con il trince-ramento d’accesso e con un secondo discendente lungo il versante nord del monte fino alle prime opere del settore settentrionale. A sud-est della ridotta sommitale si scorgono i resti di due edifici minori, destinati al magazzinaggio di munizioni da fuoco e da boc-ca, collocati in un’area contenuta ad est da un’altra linea di trinceramenti in terra a sa-lienti e rientranti, che si dirige fino al margine del terrazzo, da cui trae origine il mag-gior pendio del versante sud-orientale del Pintas e corrispondente al settore meridionale del complesso. Incassate nel terrazzo fino a contatto con la roccia naturale sono le strut-ture di un baraccone rettangolare, con fronte principale rivolta ad ovest, racchiuso dai labili resti di un trinceramento convesso lungo i margini del terrazzo; un rientrante col-legato al trinceramento appena citato ed esteso in direzione nord-ovest completa le dife-se del settore sud e si raccorda all’ultimo tratto della comunicazione ascendente dalle Finestre presso un varco, costituente l’accesso meridionale al campo in corrispondenza dell’avvio del percorso d’accesso alla ridotta sommitale. Il settore occidentale assume in pianta un perimetro trapezoidale, il suo fronte sud, ben conservato in terra con ancora evidenti le banchine di tiro si allinea alla cresta del colle delle Fattières, il cui transito è segnato da un varco aperto nel trinceramento in corrispondenza del raccordo con la base minore del trapezio; questa fronte estrema è armata da un saliente centrale, puntato ver-so il Dente della Vecchia, e si collega al fronte nord del settore, analogo a quello sud, ma peggio conservato e sviluppato in linea retta parallelamente alle isoipse fino all’altezza della ridotta sommitale. Nell’area interna al settore occidentale esiste un’opera di incremento difensivo, corrispondente ad una doppia tenaglia o bonetto, con fossato antistante, raccordata con il fronte sud e dotata a nord di un trinceramento paral-lelo al fronte settentrionale del settore; la roccia contenuta dal corpo di fabbrica del sa-
5
liente centrale del bonetto è stata utilizzata negli ultimi decenni del secolo scorso per impiantare i plinti di sostegno di un ripetitore RAI, la cui superfice ha fornito la sede per la quota base del rilievo archeologico. Alle loro estremità orientali il fronte nord del set-tore ovest e il trinceramento superiore parallelo si collegano e in quel punto si è stabilito in fase di studio il confine con le opere del settore settentrionale. Quest’ultimo è in buo-na parte costituito da un lungo avancorpo trincerato che segue in discesa il pendio del versante nord-ovest del monte Pintas lungo il margine precipite sul vallone dell’Arneirone dal lato della val di Susa. Il tratto sud-occidentale delle fortificazioni del settore nord sono abbastanza ben conservate, in opera a secco, e associano in successio-ne da ovest un tratto con saliente centrale e uno a cremagliera (SCONFIENZA 2011, pp. 53, 63-64), che copre il cambio di direzione della linea magistrale verso nord. Il fronte occidentale del settore nord segue uno sviluppo subrettilineo, adeguato alla natura del pendio, con un saliente prossimo alla parte terminale; quest’ultima è costituita dall’associazione di una tenaglia più esterna (SCONFIENZA 2011, pp. 53, 73) con un bo-netto interno, occupante la gola della prima, per potenziare il più possibile la difesa e-strema avanzata, dove entrava probabilmente all’interno del campo il cammino ascen-dente dalla val di Susa, stando alla testimonianza della cartografia storica. Lungo il fronte orientale dell’avancorpo nord, costituito da un trinceramento rettilineo inizial-mente in opera a secco e poi in terra, si ergono i resti di un secondo baraccone per il corpo di guardia settentrionale, verosimilmente a due piani.
All’altezza del tratto a cremagliera, lungo il margine precipite sull’Arneirone è stato collocato il limite fra il settore settentrionale e quello orientale, che costituisce il fronte di gola dell’intero complesso. Si tratta di un’area limitata ad est da un trinceramento in terra, costituito da una linea spezzata con un grande saliente puntato verso l’esterno più a nord e uno più piccolo nel tratto finale a sud, che con sviluppo fortemente rampante si raccorda alle difese del terrazzo del settore meridionale. Nello spazio interno del settore orientale, costituito da una fascia aperta compresa fra le pendici del cima del Pintas e il margine trincerato, sono state individuate frequenti tracce di attendamenti, opportuna-mente collocati al riparo nel settore di gola, a partire fin dalla zona di confine con il set-tore settentrionale. Datazioni e periodizzazione
Riguardo alla cronologia delle opere costituenti il sistema difensivo dei colli di Fine-stre e Fattières, grazie alla ricerca d’archivio, è possibile oggi parlare di un intervallo di tempo fra il 1709 e il 1799; l’impianto delle attuali consistenze dei resti visibili al colle delle Finestre, lungo la comunicazione e nei settori centrale e meridionale delle Fattières risale al 1709 e fa capo alle progettazioni di Antonio Bertola, incaricato l’anno succes-sivo alla conquista sabauda del Pragelatese di fortificare l’importante settore strategico del valico fra Dora e Chisone, incorporando nelle nuove opere le preesistenze delle for-tificazioni francesi, risalenti all’ultimo decennio del XVII secolo e la cui disamina è rin-viata alla pubblicazone monografica sopra accennata. La fase di massimo ampliamento delle fortificazioni in esame è da collocarsi durante la Guerra di Successione Austriaca, fra il 1744 e il 1746, quando vennero ristrutturate tutte le opere già esistenti dall’inizio del secolo, per altro oggetto di manutenzione annuale puntualmente documentata dall’amministrazione sabauda, e furono aggiunti alle Fatières i settori occidentale, set-tentrionale e orientale. Gli anni 1793 e 1794, durante la guerra fra il Regno di Sardegna e la Francia repubblicana, rappresentano un’ulteriore stagione di ristrutturazioni com-plete e di poche integrazioni, come presumibilmente il rivelino del fronte sud del com-
6
plesso delle Finestre e il fossato del bonetto occidentale delle Fattières; infine nel 1799 deve essere collocato l’ultimo rifacimento della ridotta sommitale del complesso delle Fattières, causa della forma in pianta attuale dei resti visibili sul monte Pintas, in conse-guenza alla presenza dei contingenti austriaci dell’armata del Suvorov che fronteggia-vano quelli repubblicani francesi attestati al colle delle Finestre. Dall’anno 1800 la di-smissione delle fortificazioni di tutto il sistema difensivo diede inizio alle progressive spogliazioni delle strutture e la loro consegna definitiva alla memoria del passato.
Abbreviazioni bibliografiche
CAMBI F. - TERRENATO N. 2004, Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Roma CORINO P G. – GASTALDO P. 1993, La montagna fortificata. Per i monti della Valle di
Susa: dai forti della Triplice sino alle opere in caverna del vallo Alpino, Borgone di Susa
MARAZZI S. 2005, Atlante orografico delle Alpi. SOIUSA. Suddivisione orografica in-ternazionale unificata del Sistema Alpino, Scarmagno
MINOLA M. 2006, Assietta. Tutta la storia dal XVI secolo ad oggi, Torino PEYRONEL E. 2007, Radici di pietra. Forti e fortificazioni minori in val Perosa, val San
Martino e val Pragelato fra XVI e XVIII secolo, Provincia di Torino e Associazione Culturale La Valaddo, Torino
SCONFIENZA R. 2011, Le pietre del Re. Archeologia, trattatistica e tipologia delle forti-ficazioni campali moderne fra Piemonte, Savoia e Delfinato, Notebooks on Military Archaeology and Architecture edited by Roberto Sconfienza, No. 6, BAR Internatio-nal Series 2303, Oxford
SCONFIENZA R. 2012, Archeologia militare d’età moderna in Piemonte.Lo studio della fortificazione campale alpina, in «Archeologia Postmedievale», 13, pp. 11-95
TOSCO C. 2009, Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricerca tra medioevo ed età moderna, Roma-Bari
Roberto Sconfienza
Didasclie delle figure Figura 1 : Rilievo generale del complesso fortificato dal colle delle Finestre alla cima
del monte Pintas e al colle delle Fattières, eseguito da Carlo Gabaccia nell’autunno del 2011
Figura 2 : Veduta panoramica del sistema difensivo del colle delle Finestre, presa dalle falde del Français Peloux; in primo piano emerge la butta del bonetto estremo orien-tale delle fortificazioni settecentesche, sull’acrocoro della Moutiere si scorgono le strutture del forte ottocentesco e sullo sfondo i trinceramenti in terra di comunicazio-ne con la cima del monte Pintas
Figura 3 : Veduta panoramica dal Dente della Vecchia della cima del monte Pintas sullo sfondo,
con le opere sommitali della ridotta Sant’Antonio e quelle in terra circostanti, e del colle delle Fattières in primo piano con la piccola ridotta occidentale di guardia













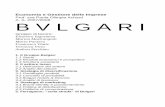



![[2014] Testamento Olografo delle Ombre [translation]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631daffc4da51fc4a3033c94/2014-testamento-olografo-delle-ombre-translation.jpg)















