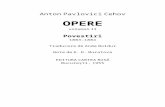Napoli nelle opere di Campanella
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Napoli nelle opere di Campanella
Napoli
1. Dalla necessità biografica alla questione teorica. -- Trattare la questione di
Napoli (nel doppio significato della città di Napoli e del Regno
omonimo) nel pensiero di C. potrebbe sembrare un’impresa non
problematica. Abbiamo a che fare con un autore vissuto a Napoli
durante la propria formazione intellettuale e, oltre al fatto che
fu incarcerato 27 anni nei ‘castelli’ della città, C. è anche un
uomo che ha sofferto nella propria pelle l’attaccamento alla
terra natia e che, fin dai primi testi teorici importanti,
rivendica la sua appartenenza alla lunga linea dei filosofi
meridionali, dai gloriosi letterati della Magna Grecia a
Bernardino Telesio, facendo addirittura della sua Calabria la
fonte prediletta del sapere universale, come scrive nella
Philosophia sensibus demonstrata, nel 1589. Nonostante ciò, Croce
poteva scrivere, cogliendo un primo nodo problematico, che se C.
è «tra i filosofi (meridionali) [...] quello più strettamente
congiunto alle condizioni del suo paese, nel quale fu cospiratore
e tentò una rivoluzione», lo Stilese «è tutto teso verso
un’utopia» che in fin dei conti non concerne proprio il Regno più
di qualsiasi altra parte del mondo cristiano [1]. Non si tratta
qui di discutere un enunciato opinabile (specialmente nella sua
seconda parte), ma di sottolineare che la questione napoletana
nel pensiero di C. si articola in vari segmenti, non senza
paradossi. In primo luogo, conviene fare una distinzione tra la
pregnanza ‘biografica’ di Napoli e quella testuale (anche se
esistono intersezioni tra le due). Inoltre, da un punto di vista
1
strettamente testuale, o teoretico, va notato fin dall’inizio che
Napoli compare in modo esplicito spesso in parentesi, in isolotti
ristretti nel mare magnum della scrittura campanelliana. Se, ad
esempio, la critica cita di frequente la famosa frase su Napoli
nella Città del Sole, si dice meno spesso che essa è un vero hapax del
testo. Conviene poi tener conto della cronologia di tale
questione nei testi campanelliani, per tentare di discernere
un’eventuale evoluzione del suo pensiero. Infine, non si
prescinderà dalla costrizione che impongono all’autore i quasi
tre decenni di carcere che sono decenni pur sempre «napoletani»,
di una Napoli che tutti gli sforzi e tutte le strategie del
prigioniero tendono a fuggire (donde lo statuto particolare, per
esempio, degli arbitrii e dei vari memoriali tra il 1605 e il 1611). E
l’ultimo paradosso risiede forse nel fatto che C. abbia salvato
la propria vita facendosi appunto portare nella capitale,
evitando in tal modo di essere giustiziato immediatamente in
Calabria, come indicano le prime dichiarazioni processuali. Si
potrebbe considerare che, sul filo di un percorso che conduce C.
a programmare fughe successive dalla Calabria, da Napoli e,
infine, dall’Italia, Napoli passa da uno statuto di episodio
biografico a una rilevanza politica, con un conseguente processo
di astrazione che perde di vista buona parte della specificità
delle riflessione sulle condizioni del Regno meridionale.
2. Napoli come ambigua necessità biografica. -- Napoli è un orizzonte
obbligato per il giovane frate, che ben presto non vuole rimanere
circoscritto nell’ambiente calabrese, nonostante l’indubbia
2
ricchezza della vita culturale cosentina (specialmente attorno
all’amato Bernardino Telesio) [2]. Infattti, Napoli era allora
una delle capitali culturali, se non la capitale culturale,
dell’impero spagnolo. È poi largamente avviato il processo che
porterà Napoli a un «destino parigino» – anche se ben presto
interrotto [3]. Una situazione che rafforza il predominio
assoluto della città sul Regno con, addirittura, una capacità di
concentrare in sé la maggior parte delle forze vive del meridione
[4]. Ma, al di là di queste generalità, il ruolo di Napoli per il
giovane C. rimane complesso e ambivalente, difficile da trattare
non solo perché non abbiamo moltissime ricerche concernenti gli
ambienti culturali della fine del Cinquecento napoletano [5], ma
anche perché C., nei testi che ci rimangono, sembra spesso
indifferente nei confronti di questa città. Ne parla in
definitiva poco: non molte lettere sono databili a quel periodo
e, nella Philosophia sensibus demonstrata, è la sua Calabria ad essere
laudata specificamente. Questo è vero anche per una poesia quale
Sovra il monte di Stilo [6], mentre in altre più tarde (come Agl’Italiani che
attendono a poetar con le favole greche) celebra Telesio, se stesso e
l’Italia o Roma in generale, di fronte alla Grecia [7]. Ma C.
venne accolto nella capitale del Regno a braccia aperte. A San
Domenico Maggiore ebbe l’occasione di entrare a contatto con le
cerchie più aperte della vita culturale napoletana. Il convento
sembra infatti essere stato legato all’Accademia laica degli
Svegliati (forse ne fu anche per un certo periodo di tempo la
sede) [8], dove si ritrovavano numerosi letterati cosentini e
3
dove il pensiero telesiano aveva grandi sostenitori (in
particolare Giulio Cortese, che verrà citato nella Dichiarazione di
Castelvetere [9], o ancora Giacomo da Gaeta, interlocutore del
Dialogo contro Luterani e ricordato con ammirazione nella poesia Al
Telesio Cosentino). L’Accademia annoverava anche importanti letterati
della cultura napoletana quali il giovane Giambattista Marino,
Giulio Cesare Capaccio o Camillo Pellegrino. C. visse poi qualche
tempo nel palazzo del marchese Mario Del Tufo (dedicatario della
Phil. sens. dem.) ed è probabile che l’ambiente dellaportiano sia
stato di notevole rilievo per lo sviluppo dei suoi lavori: lo
ricorda egli stesso nel Syntagma a proposito del Senso delle cose e
della magia, che dice originato dal dibattito a proposito del De
humana physiognomia di G.B. Della Porta pubblicato nel 1586 [10].
Rimangono tuttavia molte incertezze sulla natura e la profondità
di questi scambi intellettuali di cui ci rimangono solo poche
tracce. Prevalgono a questo proposito ipotesi fondate su incroci
e indubbie affinità di pensiero (quale la convincente analisi di
Lina Bolzoni delle affinità della poetica di C. con la poesia
neotelesiana di Giulio Cortese, o i raffronti tra i testi di
Della Porta e quelli di C.). Ma si sa anche che ben presto, nel
1592, C. fu indotto ad allontanarsi in seguito ai primi problemi
con l’Inquisizione. Si fa anche l’ipotesi che la chiusura nel
1593 dell’Accademia degli Svegliati fosse stata parzialmente
dovuta alle accuse contro C. Ma il telesianesimo o la simpatia
per la magia dellaportiana avevano davvero bisogno, per
esprimersi nell’Accademia in modo inquietante per il potere
4
spagnolo, di ricorrere all’ancora giovane e poco noto C.?
Inoltre, non va dimenticato che C. si allontana da Napoli con il
chiaro proposito di sviluppare la propria carriera altrove,
soprattutto a Firenze: lo scacco di quel progetto, appoggiato da
Giambattista da Polistena, già provinciale dell’Ordine domenicano
per la Calabria, non deve farne sottovalutare l’importanza.
L’adesione di C. alla cerchia dei letterati-filosofi-poeti
napoletani si configura quindi come una parentesi, e le
motivazioni della chiusura di essa rimangono incerte. Dissenso
politico di fondo con gli aristocratici filospagnoli dominanti
nell’Accademia (protetti da Matteo di Capua, che l’avrebbe anche
ospitata dopo il convento di San Domenico Maggiore) ? [11]
Dissensi teorici con i dellaportiani? Più semplicemente,
inadequatezza dell’ambiente napoletano al suo progetto
universalista? Risulta difficile privilegiare un’ipotesi (ammesso
e non concesso che ci sia bisogno di scomodarne una diversa
dall’evidente necessità di fuggire le prime persecuzioni). Di
Napoli e su Napoli in quel periodo dell’attività di C.
rimarrebbero essenzialmente quattro dati: un riscontro (o una
coincidenza) di stampo politico-amministrativo; un aneddoto
dubbio; un riferimento testuale importante; infine, un rimando
processuale esplicito a quegli anni napoletani. L’atto amministrativo
concerne la decisione di chiudere l’Accademia degli Svegliati il
24 febbraio del 1593: è notevole infatti che l’ingiunzione
provenga addirittura da Filippo II stesso, dopo una consultazione
del suo Consiglio, e che enunci esplicitamente la paura che le
5
sedute avessero conseguenze di tipo politico – un pericolo
giudicato sufficientemente concreto da giustificare un intervento
da parte del re identico a quello di Pietro da Toledo nel lontano
1547. En passant, si segnalerà che la violenza della decisione di
chiusura dell’Accademia ha in comune con la repressione della
futura congiura una sproporzione notevole tra l’entità del
pericolo e la reazione del potere centrale. L’aneddoto rimanda a
una battuta del padre di C., secondo il quale il figlio «venne
tanto grandito che malamente me accettava per patre et pratticava
solamente con Principi e Signori» [12]. È probabile che
l’esperienza napoletana abbia segnato, nel percorso di C., un
salto di qualità che gli dava motivo di credere che fosse
possibile sfuggire alla sua condizione di semplice frate,
insegnante e studioso, contribuendo a fare crescere in lui la
convinzione di avere un destino più alto. La traccia testuale chiara,
posteriore alla sua prima partenza da Napoli (databile al 1595) è
la scelta della città partenopea come luogo dell’ambientazione
per il Dialogo politico contro Luterani, Calvinisti e altri eretici, scelta
rafforzata poi dall’identità degli interlocutori (il telesiano
Giacomo da Gaeta, il poeta-scienziato, principe arciaccademico
degli Svegliati, Giulio Cortese, e l’uomo politico Girolamo Del
Tufo). Le due scelte sono tanto più notevoli quanto dei tre
dialoghi di C. (gli altri due sono la Città del Sole e il Dialogo politico
sopra i passati romori di Francia) questo è l’unico a presentare un luogo
della finzione e degli interlocutori ancorati in una storia e in
uno spazio identificabili. Orbene, questo dialogo presenta due
6
caratteristiche: da un lato, si tratta di un testo esplicitamente
politico, concepito (anche, ma non solo, in chiave strumentale
per dimostrare di essersi ravveduto) come elemento di lotta
ideologica contro tendenze ereticali napoletane, presunte o vere
che fossero; dall’altro si tratta di un testo in volgare rivolto
a un pubblico ampio, come dimostra anche l’importante lettera
dedicatoria al cardinale Bonelli. Il testo è quindi in contrasto
radicale con l’impostazione aristocratica – sia pure
un’aristocrazia della mente – della riflessione degli Svegliati e
specialmente di Giulio Cortese, come mostrano in modo esplicito,
ad esempio, le due dedicatorie scritte dall’amico accademico
Francesco Mauro, detto l’Errante, per l’edizione delle Rime del
Cortese nel 1588. Di ritorno a Napoli all’inizio del 1598, C. è
costretto a lasciare la città dopo pochi mesi. Prima che Napoli
diventi la città mostruosa e oziosa della Città del Sole sarà ancora,
un’ultima volta, il luogo ambito dal prigioniero in una strategia
processuale obbligata. È questo il quarto dato ineccepibile a cui
si alludeva sopra.
3. Napoli come «Caucaso». -- Alcuni degli interlocutori
napoletani, reali e fittizi (nel dialogo citato sopra), del C.
ritornano esplicitamente nella Dichiarazione di Castelvetere [13],
rilasciata il 10 settembre 1599, subito dopo la cattura. In essa
C. allude alle conversazioni avute a Napoli con tre letterati,
accademici Svegliati e/o dellaportiani, come a una delle fonti
del suo primo interesse per l’astrologia e la profezia (sono
ricordati Giulio Cortese e i filosofi-scienziati Giovan Paolo
7
Vernaleone e Colantonio Stigliola, bruniano ed ex compagno nel
carcere del Sant’Uffizio nel 1594). Nel rinvio agli incontri
napoletani di qualche anno prima è in gioco (oltre alla possibile
strategia processuale che porta ad alleggerire le proprie
responsabilità e a ricondurre la sua pratica profetica
all’influenza altrui) la storia stessa del Regno di Napoli. La
discussione astrologico-profetica riguarda infatti le mutazioni
nel Regno considerate imminenti. Parallelamente a tale rimando,
C. insiste fin da subito – e lo ribadirà senza sosta fino alla
fine dei suoi 27 anni di carcere – sul fatto che la congiura non
era anti-spagnola, ma mirava a protestare contro gli abusi degli
ufficiali del Regno e, soprattutto, ad accompagnare i grandi
sommovimenti a venire. In questa logica, non si deve processarlo
per ribellione e lesa maestà (in tale situazione la sentenza
sarebbe stata la pena capitale), ma, casomai, per eresia (come è
noto, a uno stadio successivo, la sua strategia processuale lo
porterà a rifiutare lo scontro dottrinale a vantaggio della
scelta, tutta politica, della follia, che ritorce contro i
giudici la loro stessa logica). In conseguenza di ciò, è doveroso
portarlo a Napoli, o meglio ancora a Roma, in quanto uomo di
chiesa. Non si tratta qui di riprendere la questione del
processo, ma di notare soltanto che C. sceglie consapevolmente di
proiettare la sua azione passata nella storia presente e nel
futuro prossimo del Regno (di qui anche un collegamento esplicito
tra profezia e analisi politica). Si tratta della prima vistosa
svolta, della prima uscita allo scoperto tutta storico-politica
8
del frate. Si potrebbe obbiettare che è ora pacifico che il
ricordato Dialogo contro Luterani, o i Discorsi ai principi d’Italia e la
Monarchia di Spagna, furono scritti almeno in parte prima della crisi
del 1599 e della carcerazione. Ma il dialogo, da un certo punto
di vista, regolava i conti con Napoli, i Discorsi rimangono
incompiuti e la Monarchia, trova proprio grazie alla congiura e al
processo, il suo posto nel dispositivo teorico campanelliano. Il
processo e il carcere sono anche in questa prospettiva il campo
di una riorganizzazione – non solo strumentale – del complesso
piano di studi e di lavori di C.: la questione di Napoli nei
testi citati va riletta in tale prospettiva. Che cosa ci dicono i
Discorsi e la Monarchia di Spagna su Napoli? I Discorsi introducono
un’argomentazione che diventerà ricorrente in tutti i testi
politici di C.: le guerre tra Francesi e Spagnoli (o tra
imperatori e papato nel lontano Duecento e nel Trecento, o più
generalmente le guerre tra cristiani), soprattutto quelle per il
dominio sul Regno di Napoli, sono andate ad unico vantaggio dei
Turchi, il comune ed eterno nemico [14]. Come nella Monarchia di
Spagna, la costatazione non toglie che gli Italiani debbano
preferire il dominio spagnolo a quello francese [15], nonché,
ovviamente, l’impero spagnolo a quello turco, il suo unico rivale
potenziale, perché il Turco estingue i principi e i letterati
[16]. Nella Monarchia di Spagna, viene confermato il destino
imperiale degli Spagnoli. Ma va notato che il caso napoletano è
trattato insieme con quello milanese e in un capitolo dedicato
all’Italia [17], con un elogio dell’unità imperiale e
9
dell’‘amicizia’ italo-spagnola: C. vi anticipa, si potrebbe dire,
alcune delle tesi degli storici moderni sull’impero spagnolo
polisinodale, l’unità imperiale essendo garantita dalla difesa di
interessi incrociati tra i vari regni ‘spagnoli’, o il sentimento
orgoglioso dei Napoletani di appartenere – e non in modo
periferico – a tale Impero [18]. Inoltre nella stessa Monarchia,
diventa per la prima volta più preciso il programma di un buon
governo iberico sul Regno di Napoli. C. scrive che «bisogna
trattare di modo Napoli e Milano che li popoli vicini li
ammirino come felici stati e desiderino d’esser di loro» [19],
incrementando in questo modo l’impero e favorendo la progressiva
unione del gregge cristiano sotto una legge unica. Se si vuole
raggiungere questo fine bisogna «scemar i tributi», «augumentare
l’armi e religione», fare «provvisioni contro li usurai e li
monti di pietà», abbassare i baroni, visitare le carceri per
sorvegliare il corretto esercizio della giustizia, torre «gli
alloggiamenti dei soldati [...] faccendo più gran numero di
galere», dato che «il signore del mare sempre della terra fu
anche signore» [20]. Questi assi portanti dell’auspicato buon
governo ripropongono d’altronde alcune delle principali
caratteristiche dell’analisi di quegli straordinari osservatori
che sono gli ambasciatori veneziani a Napoli [21]. L’elenco delle
proposte campanelliane dimostra poi in modo ovvio che, a parte la
questione delle tasse, i rimedi sono più adatti a Napoli che a
Milano. Soprattutto alla lettura delle due ultime
raccommandazioni: da una parte, favorire un’alleanza permanente
10
con il sovrano pontefice (giacché «se il re col papa s’accosta,
mai può temere, perché nessuno re d’Italia senza suo volere mai
si mutò. E tutte le mutazioni di Napoli, egli le fece» [22]);
dall’altra smettere di vendere terre del Regno ai Genovesi [23].
Ma si tratta di speranze e di auspici campanelliani: la Spagna ha
vocazione a soddisfare queste attese, è il paese meglio preparato
per farlo, benché rimanga uno stato straniero come gli altri e
potrebbe, cosa che si intuisce già alla lettura degli ultimi
capitoli dei Discorsi ai principi, fallire e delludere gli ‘Italiani’
(va notato che C. nei due testi – sarà diverso nella Monarchia di
Francia – non usa mai la parola «napoletani» né «regnicoli» e
parla solo d’italiani e di «popoli d’Italia», come se si
riferisse a una prospettiva globale e peninsulare). Di questo
passo, un’altra lettura potrebbe rovesciare radicalmente
l’analisi e trarre dalle stesse raccommandazioni una severa
critica della situazione nel Regno e della Monarchia spagnola. E
questo spiegherebbe il famoso passo della Città del sole sulla città
di Napoli, la quale si inserisce nel dialogo poetico come un
anti-modello, ma anche come un esempio storico di riduzione
involutiva dello stato a una città con la storica crescita di una
capitale parassitaria sottolineata da tutti gli storici moderni
(con il doppio aumento simmetrico del gruppo nobiliare napoletano
urbanizzato, staccato dalle terre produttive del Regno, e di un
ceto popolare assistito e povero). In modo più generale,
adottando questa chiave, si è potuto rileggere l’intera Città del
sole in funzione della politica annonaria e fiscale napoletana
11
[24]. Ritroveremo d’altronde la convinzione (che è poi un topos
degli economisti del tempo) di una centralità della politica
annonaria nel primo degli Arbitrii sopra l’aumento delle entrate del Regno di
Napoli scritti da C. nel 1608 [25]. L’attenzione di C. per le
condizioni di vita nel Regno, che ebbe la sua importanza per il
progetto della congiura, lascia quindi tracce nei testi, ma senza
che gli assi portanti dell’analisi si differenzino da una
generica denuncia delle tasse, delle forme di circolazione
usuraie della moneta e dei soprusi commessi da baroni o ufficiali
del Regno. C. non coglie ancora questioni capitali, come la
dialettica potere regio/potere aristocratico (centrale nel
dibattito politico tra il 1550 e il 1647), la diversificazione
della nobiltà del Regno, la questione dei Genovesi e della
vendita dei titoli nobiliari, il posto del contributo del Regno
di Napoli nelle finanze e nell’esercito imperiale, la forza del
ceto togale, il peso della ‘quiete’ garantita dal governo
spagnolo [26], il dibattito contemporaneo sulla propensione
napoletana alla mutazione, alle «cose nuove» e all’infedeltà. Se
alcuni di questi temi acquisteranno un peso crescente nella sua
riflessione dopo il 1628, i tre Arbitrii del primo decennio non
mostrano grande interesse per tali tematiche, nonostante
l’insistenza a riprenderne la materia nei vari memoriali degli
anni 1606-1611 [27]. Tale considerazione è ovvia se facciamo il
confronto con il testo quasi contemporaneo di un altro
prigioniero, Antonio Serra, intitolato Breve trattato delle cause che
possono far abbondare li regni d’oro e argento dove non sono miniere con applicazione
12
al Regno di Napoli – un’opera scritta nel 1613 nel carcere della
Vicaria. Pubblicato quell’anno stesso, il testo comprende una
severa critica degli «espedienti proposti come crescere la moneta
propria o bassarla di peso e di lega», la quale critica potrebbe
essere rivolta al secondo arbitrio di C., anche se non si ha
nessuna testimonianza di una circolazione del manoscritto degli
Arbitrii. Come confermano le poesie del carcere, siamo infatti nel
tempo della deplorazione: Napoli è prima di tutto legata alle
mura del carcere, un Caucaso, il luogo dell’infinita prigionia
dalla quale si sogna la fuga, un antro di Polifemo, una caverna
buia. Di questa Napoli le poesie non parlano nemmeno, come se le
spesse mura dei castelli fossero diventate metonimia della città.
Ma rimangono ancora da indagare la vita in carcere per tentare di
ricostituire la rete degli incontri di C. e di questo suo
«magistero ufficioso e sui generis, ma prolungato e importante»
[28]. La situazione cambia quando, finalmente, C. lascia Napoli
per Roma ed è in grado di sviluppare una più libera riflessione
sul Regno. Abbiamo un’anticipazione dei testi successivi nel
memoriale di autodifesa scritto nel 1620 a proposito della
lontana congiura quando C. insiste, per la prima volta, su una
delle accuse che gli furono rivolte: aver voluto consegnare il
Regno al Papa [29].
4. Napoli baricentro della politica europea. – Se consideriamo l’insieme
dei testi storico-politici scritti dal C. tra il 1628 e il 1636,
possiamo constatare una specie di esplosione del caso napoletano
nella riflessione, caratterizzato da una sua presenza continua,
13
nonché da un’argomentazione ricorrente che giustifica il ruolo
assegnatogli. In sintesi, si potrebbe dire che dopo l’Avvertimento
al Re di Francia, al Re di Spagna et al Sommo Pontefice, circa alli passati e presenti mali
d’Italia databile al 1628, C. innalza il caso napoletano a zoccolo
della riorganizzazione dell’assetto territoriale della
Cristianità, in nome di una ‘antica’ convinzione (l’unione
necessaria dei Cristiani sotto il Pontifice) e di un’analisi
invece nuova delle forme del governo spagnolo nel Regno. Il testo
dell’Avvertimento è breve, ma di una rara densità: l’autore
comincia con il ricordare che «per tutte l’historie è noto, e da
santi dottori e da poeti italiani lacrimato, che il Regno di
Napoli è stato cagione, o pur occasione, che la Cristianità
avesse perduto più di cento provincie occupate da Mahomettani e
quaranta più da Luterani e d’altri eretici » [30]. Stabilisce per
la prima volta che né i Francesi né gli Spagnoli hanno potuto
mantenere il Regno pacificamente (assunto paradossale per una
terra a cui, dal 1528, erano stati risparmiati tutti i conflitti
europei). Continua con un’analisi della congiuntura specifica
sorta dalla ribellione olandese in poi: l’indebolimento della
potenza spagnola impedisce una difesa del Regno contro i Turchi
e, a breve scadenza, la Spagna potrebbe perdere sia l’Olanda che
tutta l’Italia e il Nuovo Mondo! In questa situazione, «ottimo et
unico rimedio è, né si può trovar meglio, metter questo Regno in
man del Papa Padre comune ». È anche l’occasione per riprendere
la sua proposta di un Senato dei principi cristiani a Roma per
risolvere i conflitti tra di loro. Il « remedio », come C. sa
14
bene, non verrà accolto: rimane quindi da pregare... ma anche da
« animar tutti Popoli a questo effetto contro quelli che [...]
s’ostinono». A quella data, Francia e Spagna sono ancora
equiparate e trattate nello stesso modo, e l’argomentazione tiene
conto solo di fattori esterni al Regno (Olanda, Turchi, principi
tedeschi eretici). Ma viene pure sottinteso già una potenziale
ritorsione contro quelli che s’ostinano a non capire (e il
bersaglio sono qui gli Spagnoli). In un paradossale movimento del
pensiero di C., l’universalismo imperiale cattolico passa dalla
soluzione del caso specifico napoletano per trasformare Napoli in
unico rimedio alla storica divisione dei cristiani. Possiamo
considerare che si illustra qui l’applicazione territoriale della
comunità dei beni dei Solari alla geopolitica europea (giacché
dare il Regno al Papa significa non darlo a nessuno, ma a tutti i
cristiani – «quel che usurpa un solo di suoi figli, con gelosia
degli altri, saria accommunato a tutti»; «il dar alla Chiesa non
è dare ma metter in comunità»), il che si configura come una
ripresa in chiave territoriale, nell’ambito di un modernissimo
sistema di equilibrio degli stati, della spinta profetica della
congiura per fare partire dalla Calabria la riforma necessaria
della Cristianità. La proposta di consegna del Regno al pontefice
non è poi assurda se si ricorda che essa si trova anche negli
scritti di Sully, ex ministro del re di Francia Enrico IV. In
molti testi successivi (Dialogo politico sopra i passati romori di Francia,
Documenta ad Gallorum nationem, Aforismi politici per le presenti necessità di
Francia, Monarchia di Francia, De politica, ultimi scritti politici ai
15
principi italiani ecc.), C. trae nuove conseguenze di
quest’adattamento radicale della spinta profetico-messianica alla
congiuntura storica sviluppando una critica precisa delle
modalità del governo spagnolo nel Regno. Non è più solo a causa
delle circostanze esterne che il Re cattolico deve rinunciare al
dominio su Napoli, ma anche perché non è stato e non è un buon
principe per il Regno di Napoli [31]. A differenza di quanto
succedeva nei suoi primi testi, C. articola questa volta una
critica precisa del malgoverno spagnolo nel meridione: sistema di
tasse, finanziamento delle guerre spagnole, crisi demografica,
strapotere dei baroni-traditori, dipendenza economica nei
confronti di Genova, predazione dei beni del Regno, assenza di
legittimità della conquista del Regno, miseria popolare
dilagante. Dal punto di vista stilistico, la retorica
dell’‘elenco’, infinito quanto improbabile, diventa una delle
forme predilettte dell’autore per descrivere i mali causati dal
dominio spagnolo o, simmetricamente, le ricchezze potenziali di
Napoli [32]. L’attacco sferrato contro la monarchia spagnola non
si limita a un lamento generico riguardo il malgoverno straniero,
ma si dispiega sempre in modo binario: alle ricchezze infinite
del Regno si contrappone la realtà della sua economia o della sua
demografia scadente per colpa degli Spagnoli, e in tal modo C.
mette insieme due topoi delle descrizioni del Regno di Napoli: il
paese ricchissimo e il paese in preda alla miseria più nera e a
una conflittualità sociale endemica. Secondo la teoria dei tre
‘capi’ [33], mentre l’Impero (o la Germania a seconda dei testi)
16
è il capo dell’essenza e la Spagna il capo dell’esistenza, Napoli
è il «capo del valore», perché da Napoli viene la forza della
monarchia spagnola. Infatti, da Napoli, come da una specie
d’improbabile cuccagna bellica, gli Spagnoli traggono «li soldati
buoni e capitani, piloti, il ferro, il legname, la pece, i
cavalli, i denari, bombarde, archibugi e tutti i necessarii
strumenti della monarchia; oltre le tratte di vini, frumenti,
oglio, cannavi, lini, sale, seta, frutti della terra d’ogni sorte
per sostegno, e uomini d’ingegno per tutte l’arti di guerra e di
pace» [34]. Napoli assume poi il ruolo di testa anche dell’Italia
intera nella misura in cui «tutte le potenze italiane sono come
capelli di questo capo» [35]. Più razionalmente, è colto questa
volta con grande acutezza il ruolo capitale dei Genovesi
nell’economia meridionale [36]. La conclusione di C. non è solo
di tipo conoscitivo: vuole essere radicalmente politica con un
doppio richiamo. Da un parte, ai Napoletani perché si ribellino
(ma il monito è rivolto, di fatto, a tutti gli stati italiani);
dall’altra ai Francesi, perché aiutino militarmente questa
rivolta, ma senza pretendere di mettere piede stabilmente in
Italia [37]. È auspicata una nuova forma d’Impero fondato su un
dominio indiretto e un’inflenza, ma non su un controllo diretto
del territorio. La ribellione è una necessità presente [38],
perché C. considera – non senza esagerazione quando asserisce
che la popolazione del Regno è passata da 8 a 2 millioni [39] –
che è in atto a Napoli una politica di sterminio della
popolazione paragonabile a quella degli Spagnoli in America!
17
[40]. Quando, per la prima volta nel pensiero di C., la questione
napoletana acquista un posto di rilievo, ciò avviene nell’ambito
di une globale redistribuzione delle carte in tutta l’Europa. Per
pensare un Impero ancora possibile, C. torna a pensare come
prioritario il futuro dello stato in cui è nato: lo aveva già
fatto, in un certo senso, quando il progetto di congiura aveva
rappresentato una possibile, sognata e folle, anticipazione
dell’utopia della città solare (e non il contrario). Ma questa
volta la guerra dei Trent’anni è scoppiata, Francia e Spagna sono
apertamente in guerra dal 1635 e la liberazione di Napoli dagli
Spagnoli non è solo una proposta utopica. È diventata un opzione
strategica, come se non gli interessasse Napoli di per sé, bensì
Napoli nei confronti della Spagna, nell’ambito del complesso
equilibrio degli stati europei. Curiosamente, il livello di
astrazione massima del caso napoletano, che diventa totalmente
strumentale al grande disegno dell’unione dell’ecumene sotto il
pastore di Roma, coincide con un ripiegamento quasi
campanilistico che fa della piccola patria la chiave di volta del
destino del mondo.
NOTE. [1] B. CROCE, Storia del regno di Napoli (1925), Bari, 1967, 34. –
[2] Cfr. Bernardino Telesio e la cultura napoletana, Napoli, 1992 e la nota
di F. Giancotti alla poesia n. 68 Al Telesio cosentino, in Poesie, 278-
282. – [3] Cfr. G. GALASSO, Alla periferia dell'impero: il Regno di Napoli nel
periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino, 1994. – [4] G. D’AGOSTINO, La
capitale ambigua: Napoli dal 1458 al 1580, Napoli, 1979. – [5] Il
18
rinnovamento degli studi storici negli ultimi decenni sembra più
sensibile nei confronti dello ‘stato’ napoletano, grazie agli
studi di Galasso e Musi. – [6] Poesie, 480-481. – [7] Ivi, 193-
202. – [8] Cfr M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia, V, Bologna,
1930 (rist. Forni editore, 1991), 280-281, il quale attinge a C.
MINIERI RICCIO, Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli,
«Archivio storico per le provincie napoletane», III-IV, 1879-1879.
– [9] Sul Cortese si vedano gli articoli di L. Bolzoni citati in
bibliografia. – [10] Cfr G. ERNST, Religione, ragione e natura, Milano,
1991 nonché W. EAMON Natural Magic and Utopia in the Cinquecento: C. the Della
Porta circle and the Revolt of Calabria, «Memorie domenicane», 1995, 369-
402. – [11] Ma rimane a questo proposito convincente quanto
segnala L. Bolzoni sui punti di contatto tra le posizioni di
Cortese nella sua Oratione alle potenze italiane e i Discorsi ai principi italiani
di C. – [12] L’aneddoto è trasmesso da AMABILE, Congiura, III, 300. –
[13] Processi, 102. – [14] Discorsi ai principi, 108. – [15] Ivi, 148. –
[16] Ivi, 100. – [17] Mon. Francia, 226 sgg. – [18] Ivi, 220. Cfr.
Italia 1650: comparazioni e bilanci, a cura di G. Galasso e A. Musi,
Napoli, 2002; G. GALASSO, Alla periferia dell’Impero. Il regno di Napoli nel
periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), cit., 23; M. PEYTAVIN, Visite et gouvernement
dans le royaume de Naples (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, 2003, 220-221. – [19]
Mon. Francia, 220. – [20] Ivi, 226-228. Su questo strano detto cfr.
la voce Mare in questo volume dell’EBC. – [21] Cfr le relazioni
dei diplomatici veneziani Lippomano e Leoni in Corrispondenze
diplomatiche veneziane da Napoli. Relazioni, Roma, 1992. – [22] Mon. Francia,
230. – [23] Ivi, 234. – [24] Cfr A. MUSI, L’Italia dei vice-re. Integrazione
19
e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Cava de' Tirreni, 2000. – [25]
Arbitrii in Discorsi ai principi, 167-199. – [26] A. SPAGNOLETTI, Principi
italiani e Spagna nell’età barocca, Milano, 1996. – [27] Lettere, 25, 35,
157, 173. – [28] Secondo il richiamo di Giorgio Fulco, «B&C», II,
1996, I, 2, 33-56. – [29] Processi, 290-313 – [30] AMABILE, Castelli,
II, doc. 241. Vd. J.-L. FOURNEL, T. C. et la Monarchie de France: empire
universel et équilibre des puissances, Firenze, 1997, 1-35. – [31] Mon. di
Francia, 564-566. – [32] Ivi, 440, 564-566. – [33] Ivi, 438-440 e
508-510; Aforismi politici per le presenti necessità di Francia nel 1635, in
AMABILE, Castelli, II, doc. 295. – [34] Mon. Francia, 440, 510, dove si
scrive che Napoli «ha l’arme, soldati, capitani, cavalli,
danari». – [35] Ivi, 510. – [36] Ivi, 450: con le gabelle e
tributi, le «esazioni di Genovesi» sono la terza causa principale
della miseria dei regnicoli; cfr anche Documenta ad Gallorum nationem
e Mon. Francia, 536. – [37] Ivi, 546. –Ivi, 582, e bisogna
cominciare la guerra da Napoli. – [39] Ivi, 564-566. – [40]
Ibidem; cfr anche De Politica, cap. XII, con un’aggiunta nell’edizione
del 1637, assente nell’edizione francofortese del 1623, che
enuncia «è nuovo rimedio degli Spagnoli o sterminare i popoli
come in America o diminuire come nel regno di Napoli perché non
si ribellino».
BIBLIOGRAFIA
G. CORTESE, Rime, Napoli, Gioseppe Cacchi, 1588; P. COLENUCCIO, Del
compendio dell'istoria del regno di Napoli... Di M. Pandolfo Collenuccio... E di Mambrin
Roseo... Con la giunta per tutto l'anno MDLXXXVI. Di Tomaso Costo... - [seguito da]
20
Giunta overo terza parte del compendio dell'historia], Venetia, Barezzo
Barezzi, 1591; A. SERRA, Breve trattato delle cause che possono far abbondare li
regni d’oro e argento dove non sono miniere con applicazione al Regno di Napoli,
1613 [ristampa moderna, a cura di C. Trasselli, Reggio Calabria,
1974] ; T. COSTO, La Apologia istorica del Regno di Napoli di Tommaso Costo.
Contra la falsa opinione di coloro che biasimano i Regnicoli d’incostanza e d’infedeltà,
Napoli, Gio. Domenico Roncagliolo, 1613 ; B. CROCE, Storia del regno di
Napoli, Bari, 1925; L. BOLZONI, Note su Giulio Cortese. Per uno studio delle
accademie napoletane di fine ’500, «Rassegna della letteratura italiana»,
serie VII, 1978, 475-499 ; G. D’AGOSTINO, La capitale ambigua: Napoli dal
1458 al 1580, Napoli, 1979; L. BOLZONI, Conoscenza e piacere. L’influenza di
Telesio in teorie e pratiche letterarie fra ’500 e ’600, in Bernardino Telesio e la cultura
napoletana, Napoli, 1992;; Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli.
Relazioni, [ed.] Istituto italiano per gli studi filosofici,
comitato scientifico Raffaele Ajello, Marino Berengo, Gaetano
Cozzi... [et al.], Roma, 1992; D. HEATER, The Idea of European Unity,
Leicester & London, Leicester university press , 1992; G. GALASSO,
Alla periferia dell'impero: il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-
XVII), Torino, 1994; A. MUSI, L’Italia dei vice-re. Integrazione e resistenza nel
sistema imperiale spagnolo, Cava de' Tirreni, 2000; C. LONGO, Su gli anni
giovanili di fr. T. C. OP (1568-1589), «Archivum Fratrum Praedicatorum»,
LXXIIII, 2003, 363-390.
JEAN-LOUIS FOURNEL
21





















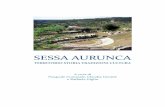







![Opere di Francesco Redi [electronic resource]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63365079d2b728420308455e/opere-di-francesco-redi-electronic-resource.jpg)