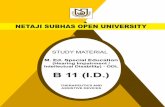Nomi vuoti ed irrealismo
Transcript of Nomi vuoti ed irrealismo
INDICE
Introduzione p. 3
I. Le basi della strategia irrealista 6
II. Alcune difficoltà sui nomi propri trattati alla Russell 19
III. La teoria causale del riferimento 31
IV. I neomeinonghiani 44
V. Entità possibili non realizzate 60
VI. Riferimento senza referenti 72
Conclusioni 89
Bibliografia 91
INTRODUZIONE
Sia S il seguente enunciato: 'Sherlock Holmes non esiste'. Allora, dato che S difficilmente può
essere ritenuto un enunciato falso, il seguente ragionamento sembra ineccepibile:
I) S è della forma (grammaticale) soggetto-predicato.
II) 'Sherlock Holmes' è il soggetto grammaticale di S.
III) S è significativo.
IV) Se S è significativo, allora S è vero o S è falso.
V) Un enunciato della forma soggetto-predicato è vero se e solo se c'è un oggetto designato
dall'espressione che fa da soggetto e tale oggetto possiede l'attributo designato dall'espressione
che fa da predicato; è falso se e solo se c'è un oggetto designato dall'espressione che fa da
soggetto e tale oggetto non possiede l'attributo in questione.
VI) Quindi, Sherlock Holmes c'è, anche se non esiste.
Questo argomento sembra far leva su un'intuizione molto forte del senso comune: se non c'è, in
un qualche modo, la cosa di cui si dice qualcosa, come sarebbe possibile “indicarla” in modo di
poter comunicare di quale cosa si dice qualcosa? Se si vuole stabilire se tale cosa è come si dice
che è, allora deve essere possibile rintracciarla, affinché il confronto con essa permetta di
stabilire quali proprietà le corrispondono e quali non. Anche il dato della non esistenza non
potrebbe essere appurato in relazione a una particolare entità se quest'entità non fosse “presente”
all'interno di ciò che è reale. Altrimenti, come spiegare che sia possibile attribuire il dato della
non esistenza a quella particolare entità in quanto particolare? Chi intende negare l'esistenza di
Sherlock Holmes non intende negare l'esistenza di un qualche tipo di entità; intende, invece,
negare l'esistenza di un individuo in particolare, il che comporta la capacità di distinguerlo da
qualsiasi altro individuo che non sia Sherlock Holmes. Questa concezione viene rinforzata se si
2
considera che, intuitivamente, si rifiuta un enunciato come 'Sherlock Holmes è un mostro che
abita nel Lago di Lochness' e si accetta uno come 'Sherlock Holmes è un detective'. Come
sarebbe possibile ciò se non fosse Sherlock Holmes a rivelare, attraverso la propria natura, quali
attributi gli si addicono e quali non?
Queste intuizioni del senso comune starebbero alla base del pensiero realista1, ovvero, del
pensiero di quei filosofi per i quali parlare di entità che non esistono è parlare comunque di entità
reali, di entità che sono. Tuttavia, accanto ad esse, esistono altre intuizioni del senso comune che
non sembrano accordarsi molto bene con le prime. Ad esempio, se a un individuo gli si
chiedesse, come parte di un lavoro da svolgere, di stilare l'elenco di tutte le persone che sono
vissute in Baker Street dal 1800 in poi, questo individuo con ogni probabilità non menzionerebbe
Sherlock Holmes nella sua lista. Non lo farebbe perché l'ipotetico elenco dovrebbe dire “come
stano le cose” in relazione a Baker Street; vale a dire, l'elenco dovrebbe soltanto includere
individui reali che realmente sono vissuti in Baker Street. E questo presuppone la capacità di
distinguere individui reali da quelli che non lo sono. Ciò sarebbe impossibile se per ogni
soggetto grammaticale costituito da un termine singolare si dovesse ammettere un oggetto quale
il suo referente. Infatti, questo equivarrebbe a fare del termine 'reale' un termine sprovvisto di un
qualsiasi contenuto cognitivo, dal momento che tutto ciò di cui si può parlare (e pensare) non
potrebbe essere che reale.
Altri indizi a favore di una posizione antirealista provengono dall'osservazione di certi fatti
linguistici. Non sembrerebbe che l'intelligibilità di un enunciato in cui il soggetto grammaticale
sembri riferirsi a qualcosa di individuale comporti necessariamente l'ammissione di un oggetto
quale referente di tale soggetto. Ad esempio, l'enunciato:
(1) Il numero naturale più grande di tutti gli altri non esiste
è vero, e malgrado il fatto che l'espressione 'il numero naturale più grande di tutti gli altri'
sembri indicare un particolare numero (il numero naturale più grande di tutti gli altri), non si è
costretti ad ammettere, in una qualche dimensione della realtà, un siffatto numero, dal momento
che il significato di (1) può essere reso perfettamente da:
1 Nel presente contesto, con 'realismo' si intende un realismo “locale”, circoscritto al problema delle espressioneche sembrano riferirsi a individui che non esistono., e non il “realismo” come posizione filosofica generale. Perchiarimenti in merito a tale distinzione si veda Valore 2008.
3
(2) Non c'è un numero naturale che sia più grande di tutti gli altri.
E' chiaro che (2) non è un enunciato della forma soggetto-predicato, e nonostante ciò, dice lo
stesso di (1). Per di più, il sintagma 'il numero naturale più grande di tutti' non compare in (2). E'
da notare anche il fatto che in (2) compare, al posto di 'non esiste', l'espressione 'non c'è', il che è
un forte indizio della non legittimità di operare una distinzione, a livello di significato, tra 'essere'
ed 'esistere'. Quindi, se per poter stabilire la verità di (2), ed afferrare il suo significato, non si
deve rintracciare una particolare entità, lo stesso dovrebbe essere vero in relazione a (1):
l'espressione 'il numero naturale più grande di tutti gli altri', anche se risulta intelligibile, non si
riferisce ad alcunché; è un'espressione “vuota”. L'antirealista avrebbe trovato così il modo di
spiegare l'errore nel ragionamento del realista: la premessa (V) non è vera. Un enunciato della
forma soggetto-predicato può essere vero anche se il soggetto grammaticale non designa
alcunché. Non c'è bisogno di supporre un'entità di riferimento per quest'ultimo, né tra gli esistenti
né tra i non esistenti.
Tuttavia, quando l'espressione che fa da soggetto è un nome proprio, come nel caso di S, è
difficile pensare che l'uso di tale nome possa risultare intelligibile anche in assenza di un oggetto
al quale esso si riferisca. In effetti, sembra che la funzione di un nome proprio sia soltanto quella
di indicare un particolare individuo tra tutti gli altri. Come trovare una parafarsi di S che
significhi lo stesso di S senza che in essa figuri 'Sherlock Holmes', in modo di scongiurare la
possibilità che l'intelligibilità della parafrasi dipenda dalla effettiva capacità di 'Sherlock Holmes'
di indicare un'entità particolare? Anche se non pochi antirealisti hanno tentato di farlo, come si
vedrà nel prosieguo del presente lavoro, i risultati non sono stati quelli che ci si sarebbe aspettati.
Nonostante ciò, la possibilità che ci siano nomi “vuoti”, cioè, nomi che non hanno bisogno di
un'entità di riferimento per poter essere usati in contesti enunciativi intelligibili e con un chiaro
valore di verità, non viene meno. Quindi, c'è un modo di relegare le presunte intuizioni del
realista, alle quali egli affida il compito di sorreggere la sua problematica ontologia, a mere
“impressioni” causate da una inadeguata comprensione del funzionamento del linguaggio
naturale.
4
LE BASI DELLA STRATEGIA IRREALISTA
La teoria delle descrizioni di Russell
Alexius Meinong , ricollegandosi al pensiero di Brentano, sostenne l'idea che un oggetto è
tutto ciò verso cui tende un atto psichico2. Dal fatto che l'intenzionalità sia in grado di dirigere le
nostre rappresentazioni, desideri o qualsiasi altra manifestazione di vita mentale verso oggetti di
varia natura che non esistono, ne consegue che la totalità di ciò che esiste è infinitamente piccola
rispetto alla totalità degli oggetti3. Per essere un oggetto, quindi, basta che esso sia il termine di
un atto intenzionale. Pensare non è possibile se non si pensa a qualcosa, e per il solo fatto di
pensare questo qualcosa, esso diventa oggetto4. Il criterio per stabilire se un oggetto è tale non
è, come ad esempio in Frege, un criterio ontologico, che fa di un oggetto un individuo con
esistenza extra-mentale; è invece un criterio gnoseologico: gli oggetti sono costituiti dal atto di
essere rappresentanti nella coscienza5. Per di più, per poter stabilire se una cosa esiste o meno, se
può esistere o meno, prima la si deve poter rappresentare. Se non fosse così, come si potrebbe
stabilire di quella particolare cosa il suo status ontologico? Ad esempio, per distinguere
l'impossibilità di un quadrato rotondo da quella dell'acciaio fatto di legno si deve far riferimento
a due oggetti distinti. Se non fosse così, l'asserzione 'il quadrato rotondo è impossibile' non
sarebbe distinguibile dall'asserzione 'l'acciaio fatto di legno è impossibile' . Ognuna delle
affermazioni precedenti comporta giudizi differenti, e perché questo sia possibile, sembra
evidente che il soggetto grammaticale di entrambe le affermazioni si riferisce a oggetti diversi6.
Si può dire, allora, che ci sono oggetti che esistono ed altri che non esistono 7, senza che questa
distinzione impedisca che si possa conoscere le loro nature particolari, le loro individualità, e che
possano essere oggetto di riferimento in predicazioni con un valore di verità indiscutibili.
Questa è la tesi meinonghiana dell'indipendenza dell'essenza (Sosein) rispetto all'essere (Sein) di
2 Meinong 1904.3 Ibidem.4 Velarde – Mayol 2007.5 Ibidem.6 Ibidem.7 In realtà Meinog distingue tre modi dell'essere. Certi oggetti possono esistere (gli oggetti concreti), altri invece
non possono mai esistere, come gli oggetti della matematica: tali oggetti semplicemente "sussistono". Infine, unaterza classe di oggetti non può nemmeno sussistere: si tratta degli oggetti impossibili , i quali godono comunquedi un modo minimo d'essere, comune a tutti gli oggetti: l'essere dato. Si veda Meinong 1904.
5
un oggetto. Tale principio stabilisce che la essenza di un oggetto, vale a dire, le sue
caratteristiche individualizzanti, è indifferente al fatto della sua esistenza o non esistenza. Questo
spiegherebbe il fatto che si possano descrivere oggetti inesistenti e anche impossibili facendo
giudizi veri in relazione a loro.
La concezione meinonghiana dell'oggetto sembra abbastanza plausibile, dal momento che si
conforma a certe intuizioni preteoriche dei parlanti. Se si fa uso di un termine singolare quale
una descrizione definita ('il quadrato rotondo') in posizione di soggetto grammaticale all'interno
di un enunciato con l'intenzione di affermare qualcosa, sembra che ciò che si predica ('è rotondo')
debba essere vero di un oggetto particolare al quale il soggetto grammaticale rinvia8. Vale a dire,
deve esserci un riferimento per il termine singolare che permetta il suo confronto con ciò che si
dice di esso. Altrimenti, non si saprebbe di cosa si sta predicando, e di conseguenza, non
potrebbe stabilirsi se l'affermazione come un tutto è vera o meno. Meinong garantisce questa
possibilità per tutti i termini singolari, dal momento che qualsiasi oggetto rappresentabile, per
quanto impossibile o assurdo possa essere, ha sempre l'essere in quanto oggetto di riferimento
intenzionale. Così, sembra salva la significatività delle nostre espressioni linguistiche anche
quando parliamo di oggetti non esistenti, impedendoci di incorrere in contraddizioni. Dire di
qualcosa che non esiste è fattibile perché questo qualcosa è il riferimento di una espressione che
non ha bisogno di esistere per risultare accessibile alla nostra comprensione. Occorre soltanto,
perché tutto ciò funzioni, accettare che 'esistere' non significa lo stesso di 'essere'. Alcune nostre
affermazioni ci impegnano ontologicamente a oggetti non esistenti. Tuttavia, questa presunta
equazione tra realismo e senso comune finisce per esasperare quest'ultimo. Fu Bertrand Russell il
primo ad accorgersene, in un modo alquanto lucido.
Nel famoso saggio On denoting del 1905, Bertrand Russell mostrò che il fatto di usare termini
singolari non comporta che questi contribuiscano al significato della proposizione in cui figurano
nominando o designando qualcosa. In altre parole, un termine singolare che grammaticalmente
occupa la posizione di soggetto, non “verte” su qualcosa indipendentemente dal contesto
enunciativo del quale fa parte. Esiste un notevole scarto tra la forma grammaticale e quella
logica di un enunciato. Pertanto, si deve accedere alla forma logica per comprendere cosa si dice
in realtà con un enunciato, ovvero, per capire a quali condizioni risulterà vero9. Non aver
compreso queste distinzioni portò Meinong a supporre che per ogni sintagma denotativo che
8 Zalta 1988.9 Bonomi 1973.
6
comporta unicità, ricoprendo il ruolo di soggetto a livello grammaticale, debba esserci un oggetto
che costituisca il suo riferimento10. Così, “la montagna di oro”, “il quadrato rotondo”, sarebbero
le cose di cui si parla quando si usano espressioni quali 'la montagna di oro' o 'il quadrato
rotondo'. Invece, si devono analizzare gli enunciati in cui tali espressioni occorrono per scoprire
la struttura profonda del linguaggio e riconoscere i veri soggetti logici, le cose di cui
effettivamente si sta parlando. In questo modo, sarà la realtà ha stabilire la verità delle nostre
affermazioni, attraverso gli oggetti che esistono, e non attraverso misteriose entità che si
assumono facenti parte in qualche modo del nostro “inventario del Mondo” soltanto perché le si
può rappresentare “nella mente”. Ammettere , ad esempio, “il quadrato rotondo” come un
autentico oggetto, equivale ad ammettere oggetti capaci di violare il principio di non-
contraddizione11. Se è vero, in virtù del suo Sosein, che il quadrato rotondo è rotondo, dovrà
essere anche vero, per lo stesso motivo, che il quadrato rotondo non è rotondo. Rispondere a
questa obiezione, come fece Meinong12, indicando che ci sono (in un qualche bizzarro modo
dell'essere) oggetti che per la loro natura non devono rispettare un principio logico, sembra una
manovra ad hoc.
In On denoting Russell concentrò la sua analisi sulle descrizioni definite. Una descrizione
definita non ha un senso autonomo; in se stessa è priva di qualsiasi significato, mentre hanno un
significato le proposizioni in cui essa figura 13. Quindi, per apprezzare quale è il contributo delle
descrizioni definite al significato proposizionale, bisogna ridurre tutte le proposizioni in cui esse
figurano a forme da cui esse sono assenti14. Questo comporta ricorrere a delle parafrasi che
eliminino le descrizioni, mostrando così la reale “forma logica” degli enunciati che le
contengono. Si consideri un enunciato quale
(1) Il figlio di Giovanni è uno studente.
In realtà, (1) equivale alla congiunzione di tre enunciati :
I) Almeno un individuo è figlio di Giovanni;
II) al massimo un individuo è figlio di Giovanni;
III) chiunque sia figlio di Giovanni è uno studente.
10 Russell 1905.11 Ibidem.12 Si veda Meinong 1904.13 Russell 1905.14 Ibidem.
7
Così, chi afferma (1) sta affermando in realtà
(1') C'è almeno un individuo che è figlio di Giovanni e solo un individuo è figlio di Giovanni e
chiunque sia figlio di Giovanni è uno studente.
Formalmente:
∃ x(Fx)∧∀ x∀ y((Fx∧Fy )→ x= y)∧∀w (Fw → Sw) ,
dove F sta per 'essere figlio di Giovanni', e S per 'essere studente'. In modo più sintetico:
∃ x(∀ y(Fy≡y=x)∧Sx)
Una volta esplicitata la reale forma logica degli enunciati che contengono descrizioni definite,
si può apprezzare come i termini singolari, facendo le veci di soggetti, spariscano. Anzi, le
descrizioni definite non appaiono in nessuna posizione, essendo state eliminate. Generalizzando,
la concezione di Russell è che un enunciato della forma 'Il P è Q' equivale alla congiunzione di
tre enunciati in cui non ci sono tracce di descrizioni definite:
I) Almeno un oggetto è un P;
II) al massimo un oggetto è un P;
III) qualsiasi oggetto che sia un P è un Q.
L'espressione 'il P', che in 'Il P è Q' svolge il ruolo di soggetto è analizzata in modo tale che si fa
esplicito il suo contenuto esistenziale. Così, una descrizione definita è in realtà una costruzione
sintattica che non va interpretata facendo riferimento a una particolare entità del mondo, ma
come composta da due affermazioni differenti: una che afferma l'esistenza di un oggetto che ha
una proprietà, l'altra che afferma l'unicità di un oggetto che possiede tale proprietà. Applicando
questa tecnica d'interpretazione agli enunciati contenenti descrizioni definite, si deve considerare
che l'uso dell'articolo definito, quando usato in modo rigoroso, comporta l'unicità15.
15 Ibidem.
8
Dato che l'enunciato originale equivale alla congiunzione di tre enunciati aventi
necessariamente un valore di verità, la congiunzione stessa avrà necessariamente un valore di
verità. Sarà vero se sono veri tutti e tre i membri della congiunzione; sarà falso se almeno uno
dei tre è falso. Perciò, anche se in un enunciato appare una descrizione definita impropria16, la
possibilità di stabilire il valore di verità non viene meno. Infatti, se si analizza un enunciato come
(1) e si assume che Giovanni non ha figli, si ottiene che che le condizioni I e II non vengono
soddisfatte, e perciò la somma logica di I, II e III ha come valore la falsità. Se si assume che
Giovanni ha più di un figlio, la condizione II risulta insoddisfatta, e questo fa si che la somma
logica del complesso abbia anch'essa lo stesso valore di verità. Se invece I e II sono vere, ma
l'unico figlio di Giovanni non è uno studente, la congiunzione sarà falsa. Soltanto nel caso in cui
Giovanni abbia un unico figlio e questo sia uno studente le tre condizioni saranno vere e pertanto
la proposizione conformata dalle tre clausole sarà anch'essa vera. Come si può vedere, non si
presenta nessun caso in cui resti indeterminato il valore di verità di 'Il figlio di Giovanni è uno
studente'. Questo non dipende dall'esistenza di una denotazione per il sintagma denotativo 'il
figlio di Giovanni', e nemmeno dalla sussistenza spettrale di in oggetto meinonghiano associato
ad esso. L'intelligibilità della proposizione non risente della mancanza di un oggetto a cui si
attagli la descrizione definita. La descrizione denoterà qualcosa solo quando le condizioni I e II
saranno soddisfatte. Russell sintetizza il concetto:
Così, a partire da qualunque proposizione possiamo ottenere un sintagma denotativo che
denota un'entità se la proposizione è vera, ma che non denota alcuna entità se la proposizione è
falsa. Per esempio, è vero (o per lo meno lo supponiamo) che la terra gira attorno al sole, e falso
che il sole gira attorno alla terra; pertanto, “la rivoluzione della terra attorno al sole” denota una
entità, mentre “la rivoluzione del sole attorno alla terra” non denota alcuna entità.17
Potrebbe sembrare che, sebbene la descrizione definita contribuisca al significato del enunciato
in cui occorre senza avere una denotazione, chi usa tale enunciato si impegni inesorabilmente ad
accettare l'esistenza del oggetto denotato dalla descrizione. Se diciamo 'Il figlio di Giovanni è
uno studente', parte di quello che diciamo è, stando all'analisi fatta sopra, che esiste un individuo
che è figlio di Giovanni e che esiste al massimo un individuo che è figlio di Giovanni; ovvero,
che esiste un unico individuo che è figlio di Giovanni. Se fosse questa la situazione sempre che
si usa una descrizione, allora sembra che non è possibile negare l'esistenza di qualcosa senza
incorrere in contraddizione. E quindi non si potrebbe dire coerentemente 'Il quadrato rotondo
16 Una descrizione definita 'Il P' è detta impropria quando la proprietà P non appartiene ad alcun oggetto oappartiene a più di uno. Si veda Bonomi 1973.
17 Russell 1905, p. 192.
9
non esiste', poiché nel fare tale affermazione parte di ciò che se afferma sarebbe che esiste un
unico quadrato rotondo. 'Il quadrato rotondo non esiste' significherebbe qualcosa come 'Esiste un
(unico) quadrato rotondo e questo quadrato non esiste'. Paradossalmente, si tornerebbe a la
posizione di Meinong, per la quale ci sono cose che non esistono. In realtà, tutto ciò è
un'illusione. Per capirlo, bisogna comprendere la nozione di ambito o modo di occorrenza di un
sintagma denotativo all'interno di una proposizione.
Si dice che un sintagma denotativo ha un'occorrenza secondaria quando il sintagma figura in
una proposizione p che è un semplice costituente della proposizione che stiamo considerando,
e la sostituzione del sintagma denotativo deve essere effettuata in p, non già nell'intera
proposizione in questione.18
Evidentemente, se la sostituzione va effettuata nell'intera proposizione, come nell'analisi fatto
dell'enunciato (1), l'occorrenza della descrizione definita sarà un'occorrenza primaria. Un
enunciato che si presta a chiarire l'importanza della distinzione stabilita dal logico inglese è:
(2) Il re di Francia non è calvo
Questo enunciato è ambiguo. Potrebbe voler dire due cose diverse:
(2') 'Non è vero che ci sia una e solo una entità che è re di Francia ed è calva'; ma anche
(2'') 'C'è una e una sola entità che è re i Francia e non è calva'19.
Nell'interpretazione (2'), il sintagma 'il re di Francia' ha occorrenza secondaria, trovandosi
all'interno della proposizione ' Il re di Francia è calvo', che è un costituente della proposizione
più comprensiva 'E' falso che il re di Francia è calvo'. Si può osservare che l'operatore logico di
negazione agisce su una intera proposizione. Nella (2''), per il contrario, trattandosi di
un'occorrenza primaria del sintagma nominale, la negazione soltanto agisce sulla attribuzione
della proprietà di essere calvo. Conviene tradurre in linguaggio formale per evidenziare il punto:
(2') ¬∃(∀ y ( Ry≡ y=x)∧Cx)
18 Russell 1905, p. 191.19 Russell 1975.
10
(2'') ∃ x (∀ y (Ry≡ y=x )∧¬Cx)
Se non è il caso che esista un'entità denotata da 'il re di Francia', (1') sarà una proposizione vera,
dal momento che nega la verità della congiunzione formata da 'Almeno un individuo è re di
Francia', Al massimo un individuo è re di Francia' e 'Chiunque sia re di Francia è calvo'. Chi
nega una siffatta congiunzione, naturalmente, nel farlo non si impegna alla verità dei congiunti
presi in isolamento. Quindi, non afferma che esiste un re di Francia o che esiste un unico re di
Francia. Invece chi intende (1) come (1''), afferma che esiste un re di Francia e non esistono più
di uno, e di conseguenza dirà il falso.
Determinare il valore di verità di un enunciato non comporta un riferimento per le descrizioni
che vi figurano. Una volta portata alla luce la forma logica dell'enunciato, le descrizioni vengono
dissolte, per così dire, e il loro contributo al significato si rivela quello di predicare qualcosa di
una variabile 'x'20. Il peso del riferimento oggettivo, che si pensava condizione per l'uso della
descrizione, viene trasferito alla variabile, cioè ad un elemento che non pretende nominare o
designare niente in particolare, ma soltanto riferirsi a un'entità in generale “con quella sorta di
ambiguità studiata che è loro peculiare”21. Da un punto di vista ontologico, la teoria russelliana
permette, nel convertire locuzioni descrittive senza denotazione in affermazioni esistenziali di
unicità, di prescindere da categorie problematiche di oggetti, come quelli di Meinong. 'Il
quadrato rotondo è rotondo' non dice dell'oggetto che è un quadrato rotondo che esso è rotondo.
In realtà dice che c'è uno e solo un oggetto x che è rotondo e quadrato, e questo oggetto x è
rotondo22. Formalmente:
∃ x ((Qx∧Rx)∧∀ y((Qy∧Ry)→ y=x)∧Rx)
il che è falso, e non vero come supponeva Meinong. E' una proposizione falsa perché non esiste
un oggetto siffatto. Parimenti, 'Il quadrato rotondo non esiste' vuole dire che non esiste un (solo)
oggetto che sia quadrato e rotondo. Chi usa questo enunciato usa la descrizione definita 'il
quadrato rotondo' non per affermare che tale oggetto c'è (in qualche spettrale modo) e che non
possiede la proprietà dell'esistenza. Vale a dire, non parla di un particolare oggetto per negarle un
attributo che non gli è essenziale (Sosein); semplicemente, parla degli oggetti che esistono per
dire che nessuno di loro ha le proprietà di essere quadrato e rotondo allo stesso tempo. La
20 Valore 2003.21 Quine 1953, p. 19.22 Russell 1905.
11
distinzione tra occorrenze primarie e secondarie fa si che enunciati esistenziali nei quali il
sintagma denotativo non denota alcunché possano essere intelligibili e soggetti a ricevere un
valore di verità, poiché stabilisce la corrispondenza tra 'il P non esiste' con 'Non è vero che esista
il P'.
Se fosse possibile interpretare 'Il P non esiste' come se la descrizione definita avesse
un'occorrenza primaria, allora sarebbe anche possibile farlo con 'Il P esiste'. Questo vorrebbe
dire che si può trattare 'esiste' alla stregua di predicati come 'alto', 'rosso' o 'calvo'. Ma facendo
così si otterrebbe qualcosa come:
'Esiste un unico oggetto che è P, e questo oggetto è esistente'; formalmente, assumendo che E
sta per 'essere esistente', si ha:
∃ x (Px∧Ex)
Ma dire che x è esistente non è altro che ripetere quello già detto con ' ∃ x ' , perché ' ∃ x '
significa 'x è esistente'23. Quindi, dire che il x è un (unico) P, e che è anche un esistente, non è
dire niente di più di ciò che si dice con 'x è un (unico) P'. Sostenere che ' ∃ x ' non rappresenti
l'esistenza, ma qualcosa di più ampio, come “l'essere”, e fare dell'esistenza, seguendo Meinong,
un attributo speciale il cui ruolo non è quello di descrivere o qualificare un oggetto, di dire come
è un oggetto, è una mossa che lascia perplessi. Infatti, ci si può chiedere come si fa a distinguere
una cosa che esiste da un'altra che non esiste, se 'essere esistente' non corrisponde a nessuna
caratteristica che fa parte dell'individualità della cosa. Se si dice di qualcosa che è pesante, rosso
e duro, l'ispezione di questo qualcosa determinerà l'appropriatezza delle predicazioni usate. Non
si può, invece, ispezionare se questo qualcosa è anche esistente o meno; semplicemente non ha
senso, dal momento che “l'ispezione” non può trovare altro che il Sosein della cosa. Insomma,
“sostenere che l'esistenza è sì un attributo ma non si comporta come gli altri attributi è una
spiegazione che non spiega”24.
Pensare a l'esistenza come un predicato è lasciarsi sedurre dalle forme apparenti delle
proposizioni. 'A esiste' sembra avere la stessa struttura di 'A corre', e 'A è esistente' sembra avere
la stessa struttura di 'A è calvo'. Tuttavia, come si è visto, la struttura logica rivela che esiste una
23 Valore 2003.24 Valore 2003, p. 85.
12
grande differenza tra ruoli grammaticali e ruoli logici. Non sempre un aggettivo ha la funzione di
descrivere un oggetto. Ad esempio, se si dice che il contributo di Giovanni al dibattito è
inesistente, non si sta dicendo che Giovanni ha fatto un contributo, solo che era molto peculiare
in quanto si trattava di un contributo inesistente. Si sta dicendo, semplicemente, che Giovanni
non ha fatto nessun contributo; vale a dire, non si sta parlando di nessun contributo in
particolare25. Il ruolo di 'esistere' non è quello di ascrivere una proprietà a un determinato
oggetto, ma quello di indicare che certe proprietà, per così dire, trovano un oggetto sul quale
applicarsi. L'esistenza sarebbe un predicato di secondo ordine, un predicato che parla di proprietà
e non di individui26.
La strategia riduzionista applicata ai nomi propri
Da un punto di vista semantico, la Teoria delle Descrizioni di Russell permette di eliminare i
sintagma denotativi determinati della categoria dei termini direttamente referenziali: non sono
espressioni che designano qualcosa autonomamente. In altre parole, non sono il soggetto logico
sul quale verte una predicazione all'interno di una proposizione. Secondo Russell, una
espressione capace di rimandare ad un particolare oggetto, esaurisce la sua funzione facendo
ciò27. Il suo contributo al significato della proposizione consiste nell'indicare di quale oggetto in
particolare si dice ciò che si dice. Si tratta di nomi “logicamente puri”, che stanno in un rapporto
diretto e univoco con una realtà extra-mentale conosciuta direttamente28 Sono espressioni che
non hanno, per tanto, un senso fregeano29, giacché non rintracciano il riferimento sulla base di
determinate proprietà che devono essere possedute dall'oggetto. Da ciò si evince che sono gli
unici capaci di sostituirsi alle variabili che appaiono nella struttura profonda degli enunciati, in
quanto nominano l'entità che le variabili si limitano ad indicare in modo indeterminato.
Evidentemente, non avrebbe senso usare un nome “puro” per negare l'esistenza dell'entità a cui
questo rinvia.
Mostrare che le descrizioni non rimandano direttamente ad oggetti che le soddisfino, permise a
Russell di liberarsi di entità indesiderabili, quali “il quadrato rotondo” o “la montagna de oro”.
25 Sainsbury 2009.26 Per una delucidazione della nozione di predicato di secondo ordine si veda Williams 1981,27 Russell 1918.28 Ibidem.29 Frege aveva distinto due livelli nella nozioni di “significato”:il riferimento (l'oggetto a cui rinvia un termine
singolare), e il senso (il modo in cui si accede all'oggetto). Si veda Frege 1892.
13
Ma il progetto di ridurre l'essere a ciò che esiste, poteva vanificarsi se non si era capaci di
mostrare che un'altra categoria dei termini singolari, i nomi propri, potessero essere usati
sensatamente senza comportare necessariamente un riferimento oggettivo. Si pensi a un
enunciato quale:
(3) Pegaso non esiste.
Questo enunciato è senza dubbio vero – se associato alla creatura della mitologia greca, si
intende. Ma non sembra che il termine 'Pegaso' possa contribuire alla significanza di (3) in un
modo che non sia semplicemente quello di indicare “l'oggetto di cui si sta parlando”. Il termine
non ha una struttura grammaticale complessa che permetta la sua scomposizione in elementi
predicativi da disporre diversamente in relazione al vero soggetto logico, come nel caso delle
descrizioni definite, quando si accede alla forma logica dell'enunciato. Allora si potrebbe credere
che, dato che 'Pegaso' non può essere trattato come una descrizione, si è davanti a un nome
russelliano. Tra gli x che conformano il dominio sul quale agisce 'x', ci sarà un x che sia uguale a
Pegaso, il che significa che c'è un x del quale si può predicare l'inesistenza. Formalmente:
∃ x (x=Pegaso∧Ix ) , dove 'I' sta per 'essere inesistente'.
Quindi, 'Pegaso' si riferisce a un oggetto inesistente con il quale si ha un contatto conoscitivo
diretto, poiché solo in questo modo si spiega la possibilità di affermare (3). Ciò dimostra che
' ∃ x ' non spazia soltanto su oggetti esistenti, ma anche su quelli che non lo sono.
Nuovamente si presenta il problema di dover ammettere entità problematiche per rendere conto
dell'intelligibilità di alcune proposizioni che si è in grado di formulare nel linguaggio ordinario.
Anche se Russell in On denoting si era concentrato nell'analisi delle descrizioni definite, aveva
accennato a come questo metodo si potesse applicare anche ai nomi propri del linguaggio
comune:
Una proposizione su Apollo significa ciò che si ottiene quando questo termini venga sostituito
con ciò che esso significa secondo il dizionario di mitologia classica, per esempio “il dio sole”.
Tutte le proposizioni in cui figura Apollo vanno interpretate secondo le regole sopra enunciate
per i sintagmi denotativi.30
30 Russell 1905, p. 192.
14
Ma anche Frege aveva pensato ai nomi propri della lingua naturale come aventi un senso che in
realtà fosse esprimibile da una descrizione, sebbene questo senso potesse variare di persona a
persona; ciò che importava era che l'aspetto referenziale del significato rimanesse invariato:
Per un autentico nome proprio come 'Aristotele', le opinioni circa il suo senso possono
indubbiamente essere differenti tra loro. Si potrebbe per esempio prendere come senso: lo scolaro
di Platone e maestro di Alessandro Magno. Chi fa questo darà all'enunciato “Aristotele nacque a
Stagira” un senso diverso rispetto a chi prende come senso del nome: “il maestro di Alessandro
Magno, nato a Stagira”. Queste oscillazioni del senso si possono tollerare finché la denotazione
rimane uguale, sebbene siano da evitare quando si costruisce una scienza dimostrativa; esse non
dovrebbero intervenire in una lingua perfetta.31
Quindi, per Frege sebbene i nomi propri si usavano in modo equiparabile a descrizioni definite,
se li usava perché erano capaci di rimandare a oggetti particolari. Questo, per Russell, non
sarebbe stato una mossa coerente con i suoi intenti riduzionistici. Se un nome proprio ordinario
poteva essere trattato alla stregua di una descrizione, allora esso non doveva aver bisogno di
denotare alcunché. Comunque sia, questa strategia si rivelerà insoddisfacente. Pensare ai nomi
propri come descrizioni in qualche modo camuffate non permette di capire il reale
funzionamento di molti processi comunicativi che li vedono coinvolti. In particolare, come avrà
modo di stabilire nel presente lavoro, la specificità di “ciò che si intende” con l'uso dei nomi
propri non sembra poter venir resa da nessun insieme di predicazioni, per quanto “ricco” esso
sia, giacché tutta predicazione è sempre generale32. Nonostante ciò, è importante conoscere fin
dove si può portare la strategia riduzionista, poiché il confrontarsi con i suoi esiti può rivelare
molti aspetti particolari del funzionamento dei nomi propri del linguaggio naturale.
Fu Willard Van Orman Quine chi estese in modo rigoroso e coerente la strategia russelliana
delle descrizioni definite ai nomi propri. Secondo questo autore, essendo un nome proprio una
parola sola e non una locuzione descrittiva, la teoria di Russell non può applicarsi direttamente.
E' però sufficiente riformulare il nome come descrizione, in un qualsiasi modo che possa
esprimere adeguatamente la idea associata a quel nome33. Così, se 'Pegaso' non sembra
adeguatamente reso da una descrizione definita quale 'il cavallo alato che fu catturato da
Bellerofonte', si può perfino introdurre un predicato creato ad hoc, come 'essere Pegaso', il quale
31 Frege 1892, pp. 10-11.32 Evans 1982.33 Quine 1953.
15
è non analizzabile34. Questa mossa è possibile perché l'unica cosa importante per applicare la
Teoria delle descrizioni è essere in grado di trovare una descrizione che traduca il termine
originale, cosa che non è affatto una restrizione35. Il fatto che un nome proprio si mostri
ricalcitrante a una riduzione a descrizione definita, sia perché è associato a idee poco chiare, sia
perché ogni individuo gli associa concetti diversi, non è un impedimento insormontabile. Ci
sono molti modi di raggiungere lo scopo, oltre a quello descritto sopra. Si potrebbe tradurre
'Pegaso' con 'la cosa che pegasizza', od ottare per irregimentare enunciati come 'Pegaso vola' in
uno quale 'esiste un x tale che x = Pegaso e x vola', nel quale '= Pegaso' non è più un termine
singolare, ma un predicato ('essere uguale a Pegaso'). Si tratterebbe di un concetto fregeano: una
funzione che ha bisogno di un argomento per poter avere un significato compiuto e che da sola
non può essere applicata su di un oggetto36.
Allora, se si vuole parlare della non esistenza di un essere della mitologia classica come
Pegaso, si potrà esprimere formalmente così:
¬∃ x (Px) ,dove P sta per 'pegasizzare';o
¬∃ x (x=P) , dove '= P' significa 'essere identico a Pegaso'.
La possibilità di parafrasare espressioni contenenti nomi propri in espressioni dove essi
spariscono, come aveva fatto Russell con le descrizioni definite, mostrerebbe, per Quine, che
l'uso dei nomi propri non suppone l'esistenza di oggetti nominati da essi per essere significativo.
Si può, quindi, dire qualcosa come (3) senza timore di incorrere in contraddizione o di dover
ammettere un'ontologia realista. Insistere in sostenere che un nome proprio deve riferire a
qualcosa per essere compreso e per rendere comprensibile l'enunciato in cui occorre, non è che la
conseguenza di non rendersi conto che “c'è un abisso tra significare e nominare, anche nel caso
di un termine singolare che è effettivamente il nome di un oggetto”37. E' importante notare che
non solo i nomi che si sa non rinviano a nessun oggetto, come 'Pegaso', possono e devono essere
trattati allo stesso modo di una descrizione; anche i nomi usati per identificare entità reali sono
passibili di tale trattamento. I nomi, pertanto, non hanno nessun rilievo per le questioni
ontologiche, dato che possono venir eliminati in favore di predicati riferiti a variabili 38. Come
34 Ibidem.35 Ibidem.36 Valore 2008.37 Quine 1953, p. 22.38 Valore 2008.
16
segnala Quine:
Tutto ciò che diciamo con l'aiuto dei nomi può essere detto in in linguaggio che eviti
completamente i nomi. Essere assunto come entità equivale, puramente e semplicemente, a essere
incluso tra i valori di una variabile. Nei termini delle categorie della grammatica tradizionale, ciò
equivale approssimativamente a dire che essere è essere nel campo di riferimento di un
pronome.39
Il progetto russelliano di svelamento delle “forme logiche” sarebbe in questa maniera arrivato,
grazie a Quine, a fare della categoria dell'intera categoria dei termini singolari del linguaggio
ordinario una categoria superflua40.
Tuttavia, come si cercherà di mostrare nel prosieguo del presente lavoro, il comportamento dei
nomi propri del linguaggio naturale rivela che sono altro che superflui. Ad esempio, Quine pensa
che il nome proprio 'N' significa o può essere trattato alla stregua di 'essere identico a N' o 'la
cosa che n-izza'. Non è facile immaginare come risulterebbero comprensibili queste predicazioni
se non facendo appello all'uso effettivo che si fa dei nomi ai quali pretendono sostituirsi. Non si
può comprendere un'espressione quale 'essere identico a N' se non si è capaci di comprendere
l'uso di 'N' in altri contesti linguistici, giacché l'espressione non è un elemento semplice dal
punto di vista grammaticale. Sono proprietà ad hoc il cui scopo è quello di evitare le difficoltà
in cui ci si imbatte nel voler trovare, per un nome, descrizioni che rendano l'individualità
dell'oggetto assunto in una ontologia; nonché siano capaci di mettere d'accordo persone che non
condividono la stessa informazione riguardo al nome e, ciò nonostante, intendono lo stesso
nell'uso che ne fanno. Il problema è che, non essendo concetti “generali” non legati ad individui
particolari per la loro comprensione , i concetti ad hoc non permettono di valutare se un oggetto
“cade” nel loro raggio di azione se prima non si sa quale o come debba essere l'unico oggetto in
grado di farlo. In altre parole, non è chiaro come determinare l'estensione di un predicato del
genere41. Sembrerebbe che l'attributo è fatto su misura delle intenzioni coinvolte nell'uso del
nome proprio: non si può sapere che questo x giovannizza se non si sa che questo stesso x è
chiamato 'Giovanni', il che lo rende sospetto di circolarità.
39 Quine 1953, p. 26.40 Valore 2003.41 Kripke 1980.
17
ALCUNE DIFFICOLTA' SUI NOMI VUOTI TRATTATI ALLA RUSSELL
Operatori finzionali
Chi è un sostenitore della strategia anti – realista di Russell e Quine, nel considerare i nomi
senza riferimento alla stregua di simboli incompleti, sembra costretto a sostenere che qualsiasi
enunciato in cui essi occorrano in modo primario deve risultare falso. Questo perché, come si
ricorderà, il primo congiunto che risulta dalla parafrasi russelliana è sempre falso quando la
descrizione definita non denota alcunché. Così, enunciati quali 'Pegaso vola', 'Zeus è vecchio', o
'Sherlock Holmes è venuto in Italia nel 1945' sono falsi, per la semplice ragione che il termine
che fa le veci di soggetto grammaticale non ha un riferimento: non esiste niente a cui
convengano i predicati impliciti nell'uso de quei nomi. Tuttavia, ci sono molti enunciati che
intuitivamente sembrano veri, anche se dovrebbero non esserlo stando alla Teoria delle
descrizioni.
Si confrontino i seguenti due enunciati:
(1) Eros è il dio dell'amore
(2) Eros è il dio del commercio
Tutti e due, se analizzate alla Russell, sono falsi, dato che non c'è nessun x che eros- izza, come
direbbe Quine. Nonostante ciò, si prova una certa resistenza a non considerare (1) vero. Sembra
che (1) è un'affermazione d'identità vera, mentre (2) non lo è. Allora, dovrebbe esserci una
denotazione per 'Eros', anche se non esistente, al fine di spiegare la diversa valutazione che si
può fare degli enunciati in questione42 .
In realtà, enunciati come (1) e (2) sono ambigui, nel senso che possono essere interpretati come
versioni abbreviate di altri enunciati più complessi. Riferendosi in particolare a entità della
finzione letteraria, David Lewis propose questo approccio:
42 Parsons 1980.
18
Non prendiamo alla lettera le nostre descrizioni dei caratteri di finzione, consideriamole invece
come abbreviazioni di enunciati più lunghi che iniziano con un operatore del tipo “nell'opera di
finzione tal dei tali...” Questa espressione è un operatore intensionale che può essere prefissato a
un enunciato ‰ per formare un nuovo enunciato. Ma poi l'operatore può essere lasciato cadere
per abbreviare, lasciandoci con qualcosa che suona come l'enunciato originale ‰ ma che ha un
senso diverso. 43
Così, se qualcuno dice 'Sherlock Holmes è un abile detective', per esempio, il buon senso e il
contesto dell'emissione verbale – una lezione di letteratura, la spiegazione di un opera letteraria a
chi non la conosce - permetteranno di capire che ciò che tacitamente si voleva esprimere era
l'equivalente dell'enunciato ' Nelle storie di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes è un abile
detective'. Quest'ultimo enunciato ha condizioni di verità diverse rispetto al primo, il quale, se
preso da solo, è falso, poiché Sherlock Holmes non esiste; o privo di valore di verità, se si
predilige una concezione fregeana dei termini singolari44.
Allora , (1) può essere letto, seguendo Voltolini45, come:
(1') Secondo il mito greco, Eros è il dio dell'amore; e (2) come:
(2') Secondo il mito greco, Eros è il dio del commercio.
Chiaramente, (1') è vero, e (2') falso, e questo fatto non dipende del valore di verità di (1) e (2),
i quali possono senza problemi essere entrambi falsi, come vuole Quine; dipende di come stanno
le cose per il mito greco, e delle assunzioni ontologiche del mito greco46. 'Secondo il mito
greco' funziona come un operatore intensionale, un operatore che comporta uno spostamento
delle circostanze di valutazione dell'enunciato sul quale viene applicato. Vale a dire, l'operatore
crea un contesto non vero-funzionale: il valore di verità effettivo dell'enunciato costruito col suo
aiuto non dipende dal valore di verità effettivo dell'enunciato contenuto in esso47. Ben può darsi
il caso che un enunciato di questa forma sia vero tanto nel caso in cui l'enunciato ivi contenuto è
vero, quanto nel caso che non lo sia.
43 Lewis 1978, p.173. E' da precisare che Lewis intendeva servirsi di questo approccio per sostenere un particolaremodo di realismo, come si vedrà più avanti nel presente lavoro.
44 Lewis 1978.45 Voltolini 2010.46 Ibidem.47 Per una spiegazione tecnica in proposito, Prior 1976. Si veda anche Williams 1981.
19
Naturalmente, perché un enunciato come (1') possa essere vero è necessario che 'Eros' non
abbia più, rispetto a (1), una occorrenza primaria. Altrimenti, (1') significherebbe qualcosa che
potrebbe essere reso da:
(1'') Eros, secondo il mito greco, è il dio dell'amore,
che ha un significato completamente diverso da quello che si intendeva nel proporre (1') come
risposta alla presunta verità di (1). Infatti, questa nuova lettura assume un riferimento per 'Eros',
come si può apprezzare se si confrontano le due possibili interpretazioni di (1') quando si
traducono a un linguaggio formale:
(1') Secondo il mito greco ,∃ x (Ex∧∀ y (Ey → y= x)∧Dx)
(1'') ∃ x (Ex∧∀ y (Ey → y= x)∧secondo il mito greco ,Dx)
La prima di queste letture è una lettura, come si suole dire, de dicto; l'altra, di re. Quest'ultima
è falsa, dato che non c'è un x uguale a Eros; quindi, non può essere la lettura che serve a un anti-
realista. Alla strategia riduzionista interessa la possibilità di effettuare un'interpretazione de
dicto degli enunciati come (1'), sotto la quale risultino veri. In questo modo, senza supporre
entità non esistenti come valori possibili delle variabile quantificate, si può rendere conto del
fenomeno associato a (1) e (2). In realtà, le variabili all'interno del operatore intensionale non
spaziano sull'universo di oggetti che permette la valutazione dell'enunciato. Chi dice (1'), per
così dire, non sta intendendo di dire qualcosa di vero su gli oggetti che popolano il suo proprio
mondo, ma riportare l'impegno ontologico del mito. In altre parole, non vuole attribuire a una
dell'entità del suo mondo l'essere Eros e dire delle verità su di lui; ciò che intende è ben altro:
dire delle verità sul mito greco48. Se non fosse questo il caso, sarebbe possibili dedurre da (1'), e
non sola da (1''), per il Principio di Generalizzazione Esistenziale,
∃ x (x=il dio dell ' amore secondoil mito greco) ,
il che vorrebbe dire che ci si impegna ad assumere nella propria ontologia un'entità che è il dio
dell'amore, cosa molto strana e contro-intuitiva.
48 Williams 1981.
20
Il problema è che in alcuni casi gli enunciati con un nome vuoto che fa le veci di soggetto non
fanno appello, neppure implicitamente, alle storie o miti che li coinvolgono49. Sono enunciati in
cui non si descrive, mediante proprietà che gli si attribuiscono nelle storie o finzioni a cui
appartiene, l'oggetto del quale si intende parlare. Pertanto, non si vede come includerli in un
contesto enunciativo più ampio. Ad esempio:
(3) Sherlock Holmes è un personaggio fittizio.
E' chiaro che (3) è vero, ma non perché secondo i romanzi di Conan Doyle Sherlock Holmes sia
un personaggio fittizio. Per il contrario, secondo questi romanzi, Sherlock Holmes è una persona,
una persona in carne ed ossa 50. Quindi, pensare a questo enunciato come la versione abbreviata
di
(3') Secondo le storie di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes è un personaggio fittizio
non spiega la verità di (3). Secondo una lettura de dicto, (3') è falsa; ma lo stesso vale per la
lettura di re, come è facile immaginare.
Se nessuna delle due interpretazioni è vera, allora sembra che (3) ha realmente la forma di un
enunciato che predica una proprietà ('essere un personaggio di finzione') effettivamente
posseduta dal oggetto rintracciabile grazie al nome 'Sherlock Holmes'. Quindi, è un enunciato
che s'impegna a riconoscere tra i valori delle variabili tale oggetto. Ma siccome i personaggi di
finzione non esistono, si dovrà riconoscere che c'è un oggetto (Sherlock Holmes) che possiede la
proprietà di essere un personaggio fittizio e anche quella di non esistere. E il nome 'Sherlock
Holmes' si riferisce a tale entità51.
Problemi con i verbi intensionali
Si considerino i seguenti enunciati: 'Berlusconi sposò Rudy', 'Giovanni colpì una palla' , 'La
moglie di Pietro bacia il vicino dell'appartamento 2'. Tutti quanti hanno come costituente
49 Voltolini 2010.50 Lewis 1978.51 Zalta 1988.
21
grammaticale un verbo transitivo. Chiaramente, affinché possano essere veri, essi devono
possedere un soggetto e un oggetto diretto che denoti qualcosa. Giovanni non può colpire una
palla inesistente, e Berlusconi non può sposare una donna che non esiste. Così, da 'Giovanni
colpì la palla' si può inferire sia (4) che (5):
(4) Qualcosa (qualcuno) colpì la palla
(5) Giovanni colpì qualcosa (che ha lo stesso significato di 'Qualcosa fu colpito da Giovanni')
In questi casi, come è evidente, 'qualcosa' si fa carico del riferimento oggettivo in un modo
indeterminato. Così, (4) esprime la proposizione 'Esiste un x tale che x colpì la palla'; e (5), la
proposizione 'Esiste un x tale che x fu colpita da Giovanni'.
A fianco a quei verbi, nella lingua naturale, esistono molti verbi transitivi che non richiedono
che il loro oggetto diretto (grammaticale) denomini qualcosa per poter contribuire alla
costruzione di un enunciato vero. Esempi di questi verbi sono 'credere', 'cercare', desiderare',
pensare', ma ce ne sono moltissimi altri. Si può desiderare una casa, anche se non esiste una casa
come quella che si desidera, o pensare a un animale mitologico, senza che il fatto che non esista
quel animale renda non specifico il pensiero52. Ogni desiderare è desiderare qualcosa e non altro,
e ogni necessitare è necessitare qualcosa e non altro. Se non fosse così, gli enunciati che
riportano i desideri o necessità di una persona non potrebbero dire niente di preciso e quindi, non
potrebbero essere veri, e nemmeno significativi 53. Sembra, quindi, che la non esistenza di una
denotazione per gli oggetti diretti di tali enunciati sia più apparente che reale. In qualche modo,
direbbe Brentano, i verbi come 'desiderare' o 'pensare' manifesterebbero la capacità intenzionale
della mente di “vertere” o rapportarsi a cose non soltanto assenti, ma anche inesistenti54. Per un
realista, ciò significa che non importa che la cosa sui cui verte un enunciato contenenti un verbo
di questo genere non esista; ciò che conta è che essa sia qualcosa di individuale che abbia le
proprietà necessarie per essere il correlato di una determinato atteggiamento mentale. Comunque
sia, almeno in alcune delle loro interpretazioni, enunciati di questa specie non obbediscono agli
schemi usuali di inferenza, generando così dei contesti intensionali. Ad esempio, a differenza di
(4) e (5), questo enunciato non obbedisce alla generalizzazione esistenziale:
52 Sainsbury 2009.53 Zalta 1988.54 Sainsbury 2009..
22
(6) Giovanni cerca la chiave della macchina
Sembra chiaro che Giovanni cerca qualcosa. Se qualcuno gli chiedesse che sta facendo,
Giovanni potrebbe rispondere “Sto cercando qualcosa” senza problemi. Così, da (6) si potrebbe
inferire:
Qualcosa è cercato da Giovanni.
Ma questo enunciato non può essere considerato una generalizzazione esistenziale, anche nel
caso che effettivamente ci sia una chiave della macchina., una particolare chiave della macchina.
Si supponga che tale chiave non è stata mai prodotta , a causa di qualche disguido in fabbrica, e
molte persone ignare del fatto, tra le quali si trova Giovanni, disperano per trovarla. In questo
caso, non è possibile dire che esiste un x tale che x è cercato da Giovanni, perché non c'è niente
che sia la chiave della macchina. Tuttavia, chi vuole descrivere lo stato mentale di Giovanni, può
continuar a dire “La chiave della macchina è cercata da Giovanni” , indipendentemente dal fatto
che sappia o meno se la chiave esiste. Sembra che lo stato mentale di Giovanni possa essere
descritto indipendentemente dal fatto che la sua ricerca possa vedersi soddisfatta. Non interessa,
neppure, sapere se esiste la cosa che metterebbe fine a la sua ricerca. Quindi, la sua ricerca è
sempre la stessa. Ma siccome il fatto di trovare la chiave della macchina può essere descritto
come una relazione A trova B, che ha lo stesso significato di B è trovato da A, dove 'trova' è un
comune verbo transitivo non intenzionale che mette in relazione due oggetti esistenti, sembra
allora necessario che B, che è la cosa che soddisfa la ricerca di Giovanni, debba poter continuare
ad essere la stessa cosa anche quando Giovanni non può trovare l'oggetto ricercato perché esso
non esiste55. Altrimenti, 'la chiave della macchina è cercata da Giovanni' non sarebbe sempre la
stessa descrizione dello stato mentale di Giovanni, poiché cercare una cosa è diverso da cercarne
un'altra differente. Quindi, c'è sempre una relazione a due termini tra Giovanni e l'oggetto da lui
cercato che definisce la possibilità di dire 'Giovanni cerca qualcosa' ('Qualcosa è cercato da
Giovanni'). Siccome questa relazione non dipende dall'esistenza dell'oggetto della ricerca, ma
soltanto dal suo avere un oggetto come termine, oltre a Giovanni, verso il quale è “diretta”
l'intenzionalità di quest'ultimo, si deduce che tale oggetto c'è anche se non si può stabilirne
l'esistenza. Quindi, 'qualcosa è cercato da Giovanni' è sempre vero, ma non è la generalizzazione
esistenziale a partire da (6), perché da (6) non si può stabilire con certezza logica che esista
qualcosa tale che è cercata da Giovanni. Ciò che si può stabilire è che c'è qualcosa che è cercato
55 Williams 1981.
23
da Giovanni56. Così, la quantificazione non è limitata al regno delle cose esistente, e si dovrà
ammettere che ' ∃ x ' non ha il significato di 'esiste qualcosa tale che', ma quello di 'c'è
qualcosa tale che'. Esistere ed essere non sono lo stesso.
In realtà, questo ragionamento è prodotto da un'illusione linguistica. Il termine 'qualcosa' è un
pronome, ma in quanto pronome non necessariamente è legato, per contribuire al significato
della proposizioni in cui occorre, a stare per un'entità, anche se non specificata. Nemmeno un
pronome quale 'questo' è condizionato in siffatto modo. Ad esempio, si può dire tranquillamente
'Non prendo un dobermann, perché questo morderebbe mio figlio sicuramente'. In questo
contesto enunciativo, 'questo' non riferisce a nessun cane in particolare, semplicemente si limita
a rinviare anaforicamente a un'altra espressione dello stesso contesto: 'un dobermann'57. Non si
può ritenere che 'un dobermann' sia una espressione referenziale, poiché chiaramente non è usato
per denotare qualcosa. Quindi, anche 'questo' non lo fa. Allo stesso modo, se una persona non ha
in mente un libro in particolare da leggere ma dice 'Voglio leggere un libro', non sta parlando di
un libro in particolare, e nemmeno di un libro non particolare, giacché oggetti indefiniti non ci
sono58. Può dire 'Voglio leggere un libro' semplicemente per indicare che non vuole leggere
riviste o comics. Che non si riferisca a un libro particolare lo dimostrerebbe il fatto di non avere
una risposta alla domanda 'Quale libro vuole leggere?', ma sì una alla domanda 'Che cosa vuole
leggere?'59. Comunque, questa persona vuole leggere qualcosa, anche se non c'è un oggetto del
quale dica che è l'oggetto (libro) che vuole leggere. Così, se si dice 'A vuole leggere qualcosa',
questo non farebbe diventare la voglia di lettura di A una voglia vincolata ad un libro in
particolare. L'uso di 'qualcosa' non può, per così dire, conferire denotazione a 'un libro' e, così
facendo, instaurare un rapporto tra A e un libro particolare che non esisteva prima.
Il fatto che 'qualcosa' possa occupare il posto di soggetto grammaticale in un enunciato ottenuto
applicando la forma passiva ad un altro enunciato dove 'qualcosa' occupava il ruolo di oggetto
del verbo, non rivela che 'qualcosa' sia un pronome che stia per il soggetto logico della
proposizione. Come si è imparato da Russell, la forma apparente del linguaggio nasconde la
forma logica, e quest'ultima è l'unica in grado di rivelare di cosa si sta parlano realmente, di cosa
si vuole predicare qualcosa. La denotazione di un termine non è garantita dall'uso sensato dello
stesso. In 'A vuole leggere un libro', se non c'è un libro particolare che A voglia indicare come il
56 Zalta 1988.57 Per un'ampia discussione su i rapporti tra riferimento anaforico e deduzione logica si veda Geach 1962.58 Si veda Dummett 1973.59 Williams 1981.
24
libro che vuole leggere, allora non si sta parlando di nessun libro; si sta parlano di A soltanto, per
dire di lui che vuole leggere un libro60. Se invece ci fosse un libro particolare che A ha “in
mente”, allora non si parla solo di A, ma anche di un oggetto individuale, per dire che tra A e tale
libro si da una particolare relazione61. Dire 'Qualcosa vuole essere letto da A' può essere
interpretato in due modi diversi, di conseguenza. Ma solo in uno di essi, per così dire, 'qualcosa'
serve per esprimere l'impegno ontologico di chi dice 'A vuole leggere un libro'. Parlando in
generale, 'qualcosa' può assumere la forma di un quantificatore innocuo dal punto di vista
ontologico, come evidenza un enunciato come questo: 'C'è qualcosa che Giovanni e Maria sono:
socievoli'62. La stessa lingua naturale trova il modo di indicare la lettura adatta alle circostanze, e
i parlanti in modo “istintivo” evitano l'uso di espressioni quali 'Qualcosa vuole essere letto da A',
che focalizzano l'attenzione sul soggetto grammaticale, quando non c'è effettivamente un
individuo particolare al quale rinvii tale soggetto63.
Il comportamento dei verbi transitivi che permettono letture diverse di uno stesso enunciato può
essere spiegato in termini di operatori intensionali, come quelli visti nella sezione precedente.
Quando non si tratta di stabilire una relazione tra oggetti esistenti, il verbo in realtà funziona
come un operatore non vero-funzionale che genera una proposizione complessa a partire da
un'altra. La verità della proposizione così ottenuta non dipende del valore di verità dalla
proposizione ivi contenuta. Di conseguenza, non dipende dall'esistenza degli oggetti da cui
dipende quest'ultima, se presa isolatamente, per essere vera. In questo modo, il verbo mette in
relazione un soggetto pensante con una proposizione, non con un oggetto64. Per capire come sia
possibile questa capacità di “sdoppiamento funzionale” dei verbi di atteggiamenti proposizionali,
bisogna riconoscere che hanno una struttura concettuale diversa da quella apparente65. Ad
esempio, 'volere qualcosa', parlando con rigore, vuol dire 'voler che qualcosa sia posseduta da',
'voler che qualcuno faccia qualcosa con'; 'cercare qualcosa' vuol dire 'tentare che qualcosa sia
trovata da '; e così via66. Così, tornando all'enunciato (6), si possono ottenere due interpretazioni
di esso:
(6') C'è un x tale che x è una (unica) chiave della macchina e Giovanni tenta che x sia trovato
60 Prior 1971. Si veda anche Prior 1976.61 Prior 1971.62 Sainsbury 2009.63 Dummett 1983.64 Sainsbury 2009.. 65 Williams 1981.66 Williams 1981. Si veda anche Prior 1971.
25
da Giovanni (lettura de re)
(6'') Giovanni tenta che Giovanni trovi un x tale che x sia una (unica) chiave della macchina
(lettura de dicto)
Come si può apprezzare, 'Giovanni tenta che' non è più un verbo transitivo che abbia bisogno di
mettere in relazione due oggetti. Non è un predicato a due posti, ma un predicato a un estremo e
un connettivo all'altro67 . In questo modo, può funzionare sia come operatore intensionale, sia
come semplice componente di un predicato più complesso. In nessuno dei due casi ha bisogno di
entità non esistenti per essere intelligibile. Affinché (6') sia vero, è chiaro che deve esserci un
oggetto tale che sia una (unica) chiave della macchina, con il quale Giovanni è in relazione. Per
il contrario, per (6'') questo non è necessario; l'unica entità che si richiede è Giovanni: solo di
essa si predica qualcosa. Per tanto, da (6''), a differenza di (6'), non si può inferire l'esistenza di
nessuna chiave, neppure di una chiave “intenzionale” che si trova al di là dell'esistenza; non si
può fare ciò, semplicemente, perché non si parla di nessuna chiave. Ciò che si dice di Giovanni è
che a lui interessa trovare qualsiasi cosa che abbia la proprietà di essere una (unica) chiave della
macchina; non si dice di una particolare entità, che ha la proprietà di essere una (unica) chiave
della macchina, che ha anche la proprietà di essere ricercata da Giovanni. La x in 'x è una (unica)
chiave della macchina' è, per così dire, bloccata all'interno del raggio di azione dell'operatore
intensionale. Il fatto che la verità di (6'') sia compatibile tanto con la verità quanto con la falsità
di (6'), potrebbe spiegare l'illusione che la descrizione dello stato mentale di Giovanni sia
indipendente dall'esistenza dell'oggetto ricercato68. Come si è visto, in realtà ci sono due modi
diversi di descrivere l'atteggiamento mentale di Giovanni con uno stesso enunciato.
La strategia eliminativista sembra poter affrontare con successo molte “trappole” che il
linguaggio naturale tende al pensiero. Tuttavia, come nella sezione precedente, i nomi senza
riferimento sono molto problematici da trattare se li si identifica con dei predicati. Si consideri il
seguente enunciato:
(7) Francisco de Orellana cerca “El Dorado”69
Questo enunciato è vero; è un fatto storico. Ma è vero grazie alla possibilità di leggerlo de
67 Prior 1976.68 Williams 1981.69 Si userà l'indicativo presente per non complicare inutilmente l'esposizione.
26
dicto, come risulta chiaro dal fatto che non esiste o non si può sapere se esiste una città quale 'El
Dorado'. Così, seguendo Quine, si può avere come parafrasi:
(7') Francisco de Orellana tenta che Francisco de Orellana trovi un x (città) tale che x
El-doradi-zzi.
Il problema è che non si riesce a comprendere il significato di 'El doradi-zzare' (o 'essere
identico a El Dorado') se non assumendo il significato di 'El Dorado' in modo indipendente dalla
traduzione quineana. E se non si comprende questo nome proprio, non è possibile descrivere in
cosa consisteva la ricerca di Orellana. Un'alternativa è quella di tradurre il nome in una
descrizione non ad hoc, come avrebbero fato Russell o Frege; vale a dire, facendo appello ad
attributi generali, sostantivi70 . Così, “El Dorado” sarebbe qualcosa come 'la città d'oro nascosta
nell'Amazzonia peruviana'. Il problema principale di questa mossa è che si fa dipendere gli
interessi di Orellana dagli attributi scelti per esaurire il significato di 'El Dorado', da chi riporta lo
stato mentale di Orellana, o da chi interpreta il rapporto. Ma non c'è un modo di stabilire quale
elenco di attributi guidava la ricerca di Orellana. Ad esempio, questo esploratore spagnolo poteva
non aver associato all'oggetto del suo interesse la proprietà di essere d'oro. Magari pensò che non
fosse possibile che esistesse una siffatta città, ma comunque pensò che si trattava sicuramente di
una città piena di tesori. Allora, egli non cercò una città d'oro nascosta nell'Amazzonia
peruviana, bensì una città piena di tesori nascosta nell'Amazzonia peruviana. Anzi, Orellana
avrebbe potuto cambiare diverse volte, durante la sua spedizione, la propria concezione della
città ricercata in termini di attributi posseduti da essa. Così, non scoprendo niente
nell'Amazzonia peruviana, può aver continuato le ricerche nell'Amazzonia del Brasile, pensando
forse che le informazioni o interpretazioni relative ai miti o leggende fossero sbagliate. E non
trovando niente in Brasile, può essere tornato a pensare che la città si trovasse in Perù, solo che
sottoterra. Non si potrebbe dire che durante tutto questo ipotetico percorso di ricerca Francisco
de Orellana non abbia cercato sempre la stessa cosa: “El Dorado”.
A questo punto, per evitare l'onere di trovare una descrizione effettivamente “utilizzata” da
parte dell'esploratore, si potrebbe pensare di scaricare il lavoro in un'altra descrizione, una
descrizione “indiretta”. Ad esempio, si potrebbe dire che Orellana cercò 'la cosa che si attaglia
alla descrizione fatta nei miti che parlano della città “El Dorado”. Tuttavia, Orellana può aversi
detto che i miti sono sempre esagerazioni o idealizzazioni; quindi, non cercava qualcosa che
70 Bach 2002.
27
corrispondesse alla descrizione fatta nei miti. Anche se si dicesse che cercava la cosa che di più
corrispondesse ai miti, la situazione non sarebbe in realtà diversa. Potrebbe aver scoperto una
città molto simile a quella dei miti, per scoprire, in un secondo momento, che questa città era
stata fatta deliberatamente in questo modo soltanto perché la popolazione che la eresse non
voleva sentirsi meno rispetto alla mitica razza che avrebbe creato “El Dorado”. In questo caso,
Orellana avrebbe potuto tranquillamente riprendere la sua ricerca, anche se l'unica città esistente
che si adattasse di più al mito fosse quella già trovata.
Alcuni autori pensano che una descrizione definita equivalente a un nome proprio N sia 'il
portatore di “N”' o 'la cosa chiamata “N”' 71. Quando un nome proprio occorre all'interno di un
enunciato come una frase nominale completa, il nome si comporta come un simbolo incompleto,
allo stesso modo che qualsiasi descrizione definita passibili del trattamento russelliano72. Il
nome 'N' è, in queste circostanze, semanticamente equivalente a 'il portatore di “N”', giacché N
esprime la proprietà di una cosa di chiamarsi 'N', una proprietà non sostantiva della cosa, ma
nominale73. Questa proprietà convenzionale permetterebbe di avere un criterio per identificare la
cosa chiamata N, non in base alle proprietà che “definiscono” la cosa, ma soltanto in base al
rapporto creato tra la cosa e l'uso di N per identificare tale cosa74. Senza entrare nei meriti o
limiti di una tale concezione del nome proprio, si può tentare di applicarla al caso di Francisco de
Orellana.
Certamente, sarebbe ingenuo pensare che Orellana si sarebbe dato per soddisfatto nelle sue
ricerche se avesse trovato una città chiamata 'El Dorado', dal momento che potrebbero essere
state create molte città con questo nome in onore al mito. Egli cercava un El Dorado in
particolare, forse quello in grado di dare origine al mito, non qualsiasi cosa che avesse ricevuto
quel nome per le più svariate ragioni. Anche se soltanto ci fosse stata una unica città con quel
nome, questo non farebbe di essa la città ambita da Orellana (si ricordi l'esempio di cui sopra). Si
potrebbe ribattere dicendo che Orellana cerca 'la cosa (città) chiamata (o posseditrice di ) “N”'
dove N è un nome proprio usato nel senso contestualmente determinato per applicarsi a un
oggetto in particolare, e non a qualsiasi omonimo75. In questo caso, resterebbe da chiarire come
sia possibile per un nome proprio essere il nome di un oggetto inesistente. Vale a dire, resterebbe
71 Si veda Bach 2002, Recanati 1993. Anche Prior sostiene una concezione simile: quando il nome occorre non referenzialmente, il nome non è usato, ma menzionato. Si veda Prior 1976.
72 Bach 2002.73 Ibidem.74 Recanati 1993.75 Ibidem.
28
da chiarire come un nome N possa essere usato specificamente, per identificare un oggetto
specifico, quando tale oggetto non esiste e, quindi, non offre all'uso di N un termine di paragone
ultimo che lo distingua da altri usi, anche possibili, di N76. Comunque sia, Orellana potrebbe
aver cercato 'El Dorado' senza sapere che i miti o leggende che guidavano la sua ricerca
menzionassero il nome 'El Dorado'. Ad esempio, chi gli riferì i miti e stimolò la sua ambizione
può aver tralasciato quel dato, sia perché lo considerasse secondario, sia perché non lo avesse
compreso. Allora, l'esploratore spagnolo non avrebbe cercato qualsiasi cosa tale di avere la
proprietà di essere il portatore di 'El Dorado', per quanto specifico si ritenga questo nome. Non si
può dire che se Orellana, in un secondo momento, fosse arrivato a conoscere il nome menzionato
nei miti, la sua ricerca ipso facto sarebbe diventata la ricerca di un'altra cosa. Ciò che si può dire
è soltanto che la sua ricerca avrebbe potuto fare assegnamento su più indizi.
Come si può vedere, gli scenari immaginabili sono teoricamente infiniti. Ma resta il fatto che
quando lo storico scrive 'Francisco de Orellana cercò “El Dorado”', chi legge questo enunciato
capisce cosa cercò l'esploratore spagnolo, senza dover preoccuparsi degli attributi che questi
avrebbe considerato sufficienti o necessari per ritenere la sua impressa riuscita. Così, sembra che
lo storico possa descrivere lo stato mentale di Orellana senza fare appello a nessun particolare
insieme di proprietà che renda il contributo semantico di 'El Dorado'. In altre parole, 'El Dorado'
si comporterebbe come un nome russelliano, capace di esaurire la sua funzione nell'indicare un
oggetto: attraverso di esso la mente entrerebbe in contatto diretto con la realtà, intesa nel senso
più ampio della parola. Questo spiegherebbe come possa esserci un'intesa tra lo storico e chi lo
legge. Il riferimento a qualcosa che c'è, anche se non esiste, sarebbe l'unico modo di capire in
cosa consistesse la ricerca di Orellana, nonché la possibilità di riportare tale ricerca e di
enunciarla in modo vero. (7) parlerebbe non solo di Francisco di Orellana, ma anche di un
oggetto particolare con il quale il primo entrò in relazione.
La strategia riduzionista, che in questo scritto si intende difendere, deve trovare un modo per
evitare simili conclusioni, le quali portano ad un universo ontologico sovraffollato. Si deve
trovare un modo alternativo di trattare i nomi vuoti che non impegni ad entità non esistenti, dato
che questo tipo di “entità” crea più problemi di quanti non sembri risolvere, come si mostrerà in
altre sezioni del presente lavoro.
76 Evans 1982. Si veda anche Evans 1973.
29
LA TEORIA CAUSALE DEL RIFERIMENTO
Differenza tra nomi propri e descrizioni definite
Nello scongiurare le insidie del realismo, la strategia ruselliana di trattare i termini singolari
come espressioni incomplete produce dei risultati pienamente soddisfacenti quando si tratta di
interpretare enuncianti quali “il quadrato rotondo non è rotondo”, in cui il termine singolare è
una descrizione definita. Tuttavia, come si è visto, quando il termine singolare è un nome proprio
“vuoto”, i risultati non sono quelli desiderati. Eliminare un nome in favore di una descrizione
definita, all'interno dell'enunciato in cui il primo occorre, suppone la concezione che la relazione
che si instaura tra il nome ed il suo referente extra-linguistico è una relazione mediata da un
contenuto cognitivo esprimibile tramite una (o più) descrizioni definite. In realtà, la questione
può essere declinata in due modi. Si può pensare al contenuto descrittivo associato al nome come
a un mezzo per fissare il riferimento del nome, o come a un contenuto “traducibile” in una
descrizione che il nome semplicemente abbrevia77. Nonostante ciò, entrambe le concezioni
considerano, per così dire, che il nome funziona perché “dietro” di esso c'è una descrizione. Così,
la descrizione definita fornirebbe un criterio per determinare il riferimento di un nome proprio: il
nome N si riferisce a x se e solo se x soddisfa la descrizione (o descrizioni) associata a N; vale a
dire, N si riferisce a x se e solo se la descrizione associata a N è vera di x. La possibilità di un
parlante di riferirsi ad un oggetto attraverso l'uso di N sarebbe determinata dalla conoscenza
dell'oggetto in questione, in termini di proprietà da esso possedute78. Tuttavia, questo assunto può
essere confutato in modo decisivo. I nomi propri, nella lingua naturale almeno, non sono
equivalenti a descrizioni, né dal punto di vista semantico né da quello epistemologico.
Si assuma che 'Aristotele' abbia come contenuto descrittivo associato o sia la abbreviazione
della descrizione definita 'il più famoso discepolo di Platone'. Se così fosse, allora le seguenti
due proposizioni dovrebbero avere lo stesso valore di verità, secondo il noto principio di
sostituzione salva veritate :
(1) Se Aristotele è esistito, allora Aristotele è il più valente discepolo di Platone.
77 Kripke 1980. Il primo modo è quello propugnato da Frege; il secondo, da Russell.78 Kripke 1980. Si veda anche Kripke 1971.
30
(2) Se è esistito il più valente discepolo di Platone, allora il più valente discepolo di Platone è il
più valente discepolo di Platone.
Ma (1) e (2) non hanno le stesse condizioni di verità. Il secondo dei due enunciati è un
enunciato analitico, e quindi è necessariamente vero. Invece, il primo enunciato non lo è. Infatti,
è possibile concepire o immaginare situazioni controfattuali (“mondi possibili”79) in cui
Aristotele non sia il più valente discepolo di Platone. E' chiaro che, se le cose fossero andate
diversamente da come sono andate in realtà, Aristotele avrebbe potuto non essere il più valente
discepolo di Platone. Non per questo motivo si dirà che in quello scenario ipotetico non è di
Aristotele di chi si sta parlando, anche se non è il più valente discepolo di Platone. Da tutto ciò si
evince che 'Aristotele' e 'il più valente discepolo di Platone' non sono semanticamente
equivalenti: l'uno non vale l'altro. E non sono nemmeno equivalenti a livello epistemico, dal
momento che lo scenario controfattuale immaginato può essere concepito come un fatto reale.
Per chiarire il concetto, si supponga che una ricerca storica effettivamente riveli che Aristotele fu
in realtà molto incapace come filosofo, e le magistrali opere che gli si attribuiscono solitamente
fossero dei plagi. Allora, sostenere, con l'intento di bloccare l'argomento, che la descrizione
definita 'il più valente discepolo di Platone' serve solo a fissare il riferimento di 'Aristotele'
diventa inverosimile, poiché se Aristotele non è mai stato il più valente discepolo di Platone, non
ha senso dire che tale descrizione ha permesso l'identificazione di Aristotele. Infatti, la
descrizione sarebbe dovuta servire ad identificare un altro individuo: l'individuo di cui si può
predicare con verità 'l'essere il più valente discepolo di Platone'. In altre parole, se la descrizione
definita servisse soltanto a fissare il riferimento di 'Aristotele', sarebbe conoscibile a priori la
verità di un enunciato quale 'Se il più valente discepolo di Platone esiste (in “questo nostro
mondo”), allora Aristotele è il più valente discepolo di Platone.' Ma è chiaro che questo non è
vero. Aristotele sarebbe Aristotele anche se il più valente discepolo di Platone fosse un
individuo diverso da quello che si ritiene lo sia (in “questo mondo”).
Anche se si adottasse una visione dei nomi propri come agglomerati di descrizioni, alla stregua
di Searle, la situazione non sarebbe molto diversa. Secondo Searle, i nomi non hanno un
contenuto descrittivo che possa essere delimitato con precisione:
79 Si parlerà più dettagliatamente della nozione di mondo possibile nel Cap. V.
31
Supponiamo di chiedere agli utenti del nome “Aristotele” di specificare quelli che essi
considerano i fatti essenziali e assodati relativi ad Aristotele. La loro risposta sarebbe un
insieme di asserzioni descrittive univocamente referenziali. Ora, la mia tesi è che la forza
descrittiva di “Questo è Aristotele” consiste nell'asserire che un numero sufficiente ma
ancora non specificato di tali asserzioni sono vere di questo oggetto. 80
Ciò equivarrebbe a sostenere che non è necessario che Aristotele possieda tutte le proprietà che
i parlanti gli attribuiscono solitamente, ma che ne possieda, necessariamente, la disgiunzioni
inclusiva81. Allora, 'Aristotele' sarebbe il nome dell'individuo che è il P1 ˅ il P2 ˅...˅ il Pn., dove
'P' sta per qualsiasi delle descrizioni definite associate ad 'Aristotele'. (Si pensi a 'il maestro di
Alessandro Magno', 'il fondatore del Liceo', 'il più valente discepolo di Platone', etc) Questa
disgiunzione di condizioni è, chiaramente, una descrizione definita: 'l'unico individuo che è il P1
˅ il P2 ˅...˅ il Pn'. Tale descrizione può essere abbreviata con 'il P'82. In questo modo, applicando
lo stesso procedimento usato per ottenere (1) e (2), si può ottenere:
(1') Se Aristotele è esistito, allora Aristotele è il P.
(2') Se è esistito il P, allora il P è il P.
Ancora una volta, le condizioni di verità di entrambi enunciati sono diverse. Il primo esprime
una verità contingente, mentre il secondo, una verità necessaria. Affinché (1') e (2') siano
equivalenti da un punto di vista semantico, è necessario che almeno uno dei membri della
disgiunzione abbreviata con 'P' sia vero in qualsiasi situazione controfattuale immaginabile
incentrata su Aristotele. Ma dal momento che nessuna delle proprietà che solitamente vengono
attribuite ad Aristotele è essenziale a quest'ultimo, la somma logica dei predicati P non può
ritenersi una proprietà essenziale ad Aristotele83. Ad esempio, Aristotele avrebbe potuto morire
all'età di sei mesi e, in quel caso, non avrebbe avuto le proprietà che gli si attribuiscono, ma
sarebbe sempre Aristotele84. Se si sostiene che 'il P' è solo un criterio epistemologico per
identificare Aristotele in “questo mondo”, allora Aristotele sarebbe l'individuo che soddisfa, in
“questo mondo”, un numero sufficiente delle descrizioni definite associate ad 'Aristotele'.
Tuttavia, questo criterio è palesemente inadeguato. Uno storico può coerentemente affermare di
80 Searle 1958, p. 255.81 Searle 1958.82 Platinga 1974.83 Kripke 1980.84 Platinga 1974.
32
aver scoperto che tutte le descrizioni definite che si pensava fossero in grado di identificare
Aristotele non riflettessero la verità storica85. Aristotele non sarebbe stato il più valente
discepolo di Platone: egli avrebbe plagiato le teorie di un altro filosofo; non sarebbe stato il
maestro di Alessandro, ma il suo servo; non sarebbe stato il fondatore del Liceo, ma chi prese il
posto del fondatore quando questi morì; etc. Ma, se almeno una delle descrizioni
dell'agglomerato deve essere vera di Aristotele perché questi possa venire identificato, allora non
sarebbe concepibile scoprire di Aristotele che egli non soddisfa nessuna di esse. Ciò
equivarrebbe a sostenere che le scoperte riguardanti Aristotele non riguardano Aristotele, il che è
chiaramente paradossale.
Nemmeno le teorie, come quelle di Recanati o Bach, che equiparano un nome N a descrizioni
quali 'il portatore di N' o 'l'individuo chiamato N', possono fare di tali descrizioni criteri di
identificazione del referente di N; non possono, in altre parole, stabilire cosa si intende con N. Il
motivo è molto semplice: queste descrizioni presuppongono che N possa riferirsi al suo referente
indipendentemente della descrizione in cui N viene menzionato. Se si rispondesse alla domanda
'Chi è Socrate?' con 'E' l'individuo chiamato “Socrate”', è chiaro che non si sarebbe dato un passo
avanti86.
Dalle precedenti considerazioni di natura modale ed epistemologica, si può apprezzare come ci
sia una enorme differenza nel modo di “operare” di nomi propri e descrizioni. I primi sono, nella
terminologia di Kripke, designatori rigidi; le seconde, in genere, designatori non rigidi o
accidentali87. Un designatore rigido designa lo stesso individuo in ogni mondo possibile o
situazione controfattuale in cui l'individuo esiste; un designatore accidentale, no88. Questo fatto
spiega l'insuccesso di una strategia anti-realista come quella russelliana: i nomi propri non
possono essere “ridotti” a descrizioni definite. Questo dato, però, solleva un ovvio problema per
chi intende difendere una posizione irrealista. Se i nomi ordinari non sono equivalenti a
descrizioni, l'irrealista deve trovare un altro modo di eliminare l'apparente impegno ontologico
che comporta l'uso dei nomi vuoti.
85 Ibidem.86 Kripke 1980.87 Kripke 1971,1980.88 Ciò non vuol dire che una descrizione definita non possa venir usata in modo rigido. Quando questo succede, il
contenuto descrittivo della descrizione non ha rilevanza semantica per l'enunciato in cui occorre. Si veda Kripke1980.
33
Il riferimento diretto
La teoria del riferimento diretto o teoria causale del riferimento, sviluppata in modo
indipendente da Kripke e Putnam89, sostiene che i nomi propri e i termini dei generi naturali non
hanno bisogno della mediazione di un contenuto cognitivo, esprimibile attraverso una qualche
descrizione identificante, per poter riferirsi a ciò a cui si riferiscono. Così, chi usa un nome
proprio si “collega” direttamente all'individuo al quale intende riferirsi, anche se non è in grado
di fornire una descrizione che soltanto quell'individuo soddisfi 90. Se i nomi sono designatori
rigidi, lo sono grazie a questa capacità di, per così dire, “saltare” qualsiasi contenuto descrittivo.
Se un parlante usa, ad esempio, 'Aristotele' con l'intenzione di designare Aristotele, riuscirà nel
suo intento non perché è capace di offrire un criterio di identificazione, ne tantomeno perché il
nome 'Aristotele' è soltanto posseduto da Aristotele, ma perché l'individuo al quale intende
riferirsi (Aristotele) si trova all'origine di una catena causale della quale fa parte la stessa
intenzione di riferimento del parlante91. Kripke descrive a grandi linee tale meccanismo:
Nasce qualcuno, un bambino; i suoi genitori lo chiamano con un certo nome. Ne parlano ai
loro amici: Altre persone lo incontrano. Attraverso discorsi di vario tipo, il nome si diffonde
come in una catena, di anello in anello. Un parlante che si trova a un'estremità di questa
catena, e che ha sentito parlare, ad esempio, di Richard Feynman al mercato o altrove, può
riferirsi a Richard Feynman anche se non ricorda da chi egli per la prima volta ha sentito
parlare di Feynman o da chi ne ha mai sentito parlare. Egli sa che Feynman era un fisico
famoso. Un certo flusso di comunicazione che alla fine si estende sino alla persona stessa,
raggiunge in effetti il parlante, che può dunque riferirsi a Feynman anche se non sa
identificarlo in maniera univoca.92
Tale catena causale si appoggia nella conoscenza diretta dell'oggetto che ha avuto chi decise di
battezzare l'oggetto con un determinato nome e fissare, in questo modo, il riferimento dello
stesso, una volta per sempre. La comunità linguistica potrà congiungersi all'oggetto grazie
all'intenzione dei parlanti di rinviare, con l'uso del nome, all'intenzione di riferimento che diede
origine alla catena. Di rinvio in rinvio, i parlanti si passano l'un l'altro l'intenzione di riferirsi allo
stesso oggetto, mantenendo così viva la catena comunicativa93. Non è necessario sapere come ha
89 Si farà riferimento principalmente alla formulazione della teoria data da Kripke, in quanto è l'autore che piùattenzione a dedicato ai nomi propri. Per la concezione di Putnam si veda Putnam 1975.
90 Valore 2001.91 Ibidem.92 Kripke 1980, p. 89.93 Valore 2001.
34
avuto origine la catena; ciò che conta è conoscere che essa esiste e che è stato l'oggetto inteso
nell'uso del nome a generarla. I nomi propri del linguaggio ordinario si comporterebbero come
constanti individuali della logica, contribuendo al significato delle proposizioni in cui occorrono
senza fare appello a nessuna caratteristica o attributo dell'oggetto94. La sua funzione si
esaurirebbe nel stare per l'oggetto e, quindi, si comporterebbero, in modo inaspettato, come
nomi “logicamente puri” russelliani95. Vale a dire, i nomi sono tali perché rinviano ad un'entità
esistente; l'esistenza dell'oggetto e condizione di possibilità dell'intelligibilità del loro uso. In
effetti, se i nomi esauriscono il loro ruolo nel riferirsi all'oggetto che rintracciano tramite una
catena causale, allora tale oggetto deve far parte (o fatto parte) della realtà; altrimenti, non si
spiegherebbe la sua capacità di dare inizio a suddetta catena causale.
Sebbene le considerazioni modali ed epistemologiche che hanno portato a una chiara
distinzione tra descrizioni e nomi propri sono ineccepibili, la teoria che pretende spiegare la
rigidità di questi ultimi, appellandosi all'interazione causale tra parlanti e oggetti esistenti,
comporta enormi difficoltà per l'antirealista. La teoria causale mostra che le strategie di stampo
russelliano per destituire i nomi di qualsiasi autonomia referenziale sono destinati a fallire. Ma,
allo stesso tempo, preclude la possibilità di comprendere come sia possibile che gli enunciati
contenenti nomi vuoti siano intelligibili, e addirittura abbiano un valore di verità. Il motivo è
ovvio: i nomi presuppongono l'esistenza del loro riferimento. Una mossa fin troppo ovvia
sarebbe quella di stabilire che, quando si usano nomi senza referente, ciò che si intende è una
descrizione definita. Così, si potrebbe pensare, la strategia russelliana conserverebbe la sua
utilità, scongiurando le insidie del realismo. Ma questa strada si è rivelata, dalle analisi effettuate
nel capitolo precedente, impercorribile. D'altronde, una mossa del genere comporterebbe la
possibilità di trovare un chiaro criterio per stabilire quando ci si trova davanti a un nome vuoto e
quando no. Non sempre risulta evidente che un nome sia vuoto. Probabilmente lo sia in un caso
come quello di 'Sherlock Holmes'. Ma si pensi a “Nessie'” (il mostro di Lochness). Molte
persone cercano il mostro di Lochness, e non si può avere la certezza della sua non esistenza.
Quindi, non si può essere certi che 'Nessie' sia un nome vuoto. Non sarebbe sensato dire che, se
si trovasse il mostro di Lochness, il nome 'Nessie' diventerebbe il suo nome solo a partire dalla
scoperta di esso, e che prima di tale scoperta 'Nessie' non si riferisse al mostro del lago Lochness.
La teoria causale del riferimento, a causa dei suoi presupposti fondamentali, non è in grado di
fornire il criterio richiesto; anzi, non riesce a proporre un modo di trattare i nomi vuoti che non
94 Ibidem.95 Si veda Evans 1982.
35
faccia collassare l'intero quadro teorico.
Si immagini che uno storico arrivi alla conclusione che Socrate fu, in realtà, un prodotto
dell'immaginazione di Platone unita a molteplici malintesi storici. Di conseguenza, egli afferma:
(3) Socrate non esiste96
Si potrebbe pensare che lo storico non intende una lettura in cui 'Socrate' abbia una occorrenza
primaria , poiché ciò equivarrebbe a sostenere che lo studioso intendesse qualcosa come 'Socrate
non possiede la proprietà dell'esistenza', il che è , se non un non senso, almeno una proposizione
pragmaticamente inconsistente97. Allora, onde evitare tale conseguenza, si potrebbe ritenere che
'Socrate' ha una occorrenza secondaria, in modo che lo storico non si impegni all'esistenza di
Socrate. Tuttavia, se il nome viene usato quale nome “logicamente puro”, nessuna distinzione di
ambito farebbe differenza: le due letture sarebbero equivalenti98. Il nome rintraccia sempre un
esistente, ed in fare ciò esaurisce il suo contributo semantico. Quindi, lo storico non può usare
'Socrate' come un nome senza essere costretto ad ammettere l'entità Socrate. L'alternativa più
plausibile, allora, è che egli intenda con 'Socrate' una descrizione definita99. (3) vorrebbe dire 'Il
P non esiste', dove P può stare per una qualsiasi descrizione, anche molto complessa. In questo
modo, 'il P' potrebbe avere una occorrenza secondaria, il che non impegnerebbe lo storico
all'entità Socrate. Naturalmente, 'il P' rappresenta l'insieme di proprietà solitamente attribuite
dalla comunità (accademica) a Socrate; non può rappresentare l'insieme di proprietà attribuite
dallo storico a Socrate, dal momento che non è possibile attribuire delle proprietà a un individuo
che si ritiene inesistente. Adesso, si immagini che un secondo storico non sia d'accordo con la
tesi del primo, e ritenga che Socrate esiste. Dunque, egli potrebbe affermare:
(4) Socrate esiste,
con la manifesta intenzione di confutare la posizione del suo rivale. Ma, per fare ciò, dovrà usare
'Socrate' allo stesso modo in cui lo usa il primo storico. Altrimenti, non potrebbe contraddirlo.
Infatti, la negazione di 'Il P non esiste' è 'Il P esiste'. Tuttavia, egli potrebbe non essere d'accordo
con questa interpretazione delle sue intenzioni comunicative. Lo studioso potrebbe sostenere che
96 Si usa l'indicativo presente per facilitare l'esposizione.97 Una proposizione è pragmaticamente inconsistente quando è contingentemente falsa, ma la sua falsità è
condizione necessaria per la sua affermazione. Si veda Platinga 1974.98 Per una spiegazione tecnica si veda Williams 1981. Si veda anche Kripke 1980.99 Platinga 1974.
36
con (4) intende riferirsi a Socrate e non a 'Il P', perché anch'egli crede che non esiste nessuno che
sia 'il P'. Vale a dire, il secondo storico è convinto che l'insieme di descrizioni definite che la
comunità (accademica) considera in grado di identificare Socrate non è soddisfatto da nessun
individuo. Dopotutto, la proposizione 'Socrate esiste ma non possiede nessuna delle proprietà che
gli si attribuiscono' è una proposizione perfettamente consistente100. Lo studioso non vuole che si
interpreti il suo uso di 'Socrate' in (4) come una descrizione definita, poiché ciò equivarrebbe,
contrariamente alle sue intenzioni, a non riconoscere il suo disaccordo con il primo storico. E lo
stesso vale per quest'ultimo, naturalmente. Ma l'unico modo di essere in disaccordo è quello di
consentire una lettura di (3) in cui 'Socrate' non stia per una descrizione e, nel contempo, non
presupponga l'esistenza di un suo referente. Vale a dire, si deve riconoscere la possibilità che
'Socrate' sia un nome vuoto non associato ad un contenuto descrittivo particolare, perché
altrimenti (3) non potrebbe mai essere usata per negare (4), e (4) , di conseguenza, sarebbe una
proposizione che godrebbe di una sorta di immunità epistemologica: nessuno potrebbe
dimostrare la sua falsità. Il nome 'Socrate' non potrebbe rivelarsi un nome vuoto. Ma tutto ciò è
molto controintuitivo.
Il problemi che proposizioni esistenziali negative quali (3) pongono alla teoria causale del
riferimento sono molto gravi, e per questo motivo i suoi teorici hanno cercato di trovare modi di
trattarli che permettano di spiegare l'intelligibilità delle proposizioni (non solo esistenziali) che
contengono nomi senza referente.
Alcuni tentativi di risolvere il problema
Keith Donnellan si chiede come sia possibile che proposizioni singolari esistenziali, come (3) e
(4), possano avere un certo valore di verità indipendentemente dal fatto che se i nomi propri che
vi figurano non abbiano un referente o meno:
But a true negative existencial statement expressed by using a name involves a name with no
referent and the corresponding positive existence statement, if false, will also. But in other
contexts, when a name is used and there is a failure of reference, then no proposition has been
expressed – certainly no true proposition. If a child says, “Santa Claus will come tonight”, he
cannot have spoken the truth, although, for various reasons, i think is better to say that he has
100 Ibidem.
37
not even expressed a proposition. 101
Donnellan riflette sul fatto che, all'interno di un quadro teorico come quello della teoria
causale, quando un parlante usa un nome proprio, lo fa con l'intenzione di riferirsi ad un
individuo per attribuirgli una determinata proprietà, attraverso un enunciato predicativo102. Il
parlante avrà successo se esiste un individuo tale che possa essere collegato all'intenzione del
parlante di predicare qualcosa di esso. Se questo accade, quell'individuo sarà il referente del
nome, e il valore di verità dell'enunciato in cui occorre dipenderà dal fatto che l'individuo in
questione possieda o meno la proprietà. L'esistenza del referente del nome è una condizione
perché si riesca ad esprimere una proposizione103. Invece, nel caso di un enunciato esistenziale
negativo, questo potrà essere vero solo se il nome non si riferisce ad alcunché, il che equivale a
dire che sarà vero solo se nessun enunciato predicativo in cui figuri il nome riesce ad esprimere
una proposizione. Quando l'uso di un nome proprio non riesce a rintracciare il referente del
nome, la storia dell'uso di tale nome finisce in un blocco (block): la storia non finisce nel “modo
corretto”104. Queste considerazioni permettono a Donnellan di trovare un modo di interpretare
gli esistenziali singolari negativi che renda conto del fatto che possiedono un valore di verità,
anche se il nome che vi figura non è sinonimo di una descrizione, ne è un termine legato
causalmente ad un oggetto:“If N is a proper name that has been used in predicative statements
with the intention to refer to some individual, then 'N does not exist' is true if and only if thre
story of those uses ends in a block.”105 Così, come nota Evans106, gli esistenziali singolari
negativi, per Donnellan, sarebbero da analizzare in termini metalinguistici: 'N non esiste' è un
enunciato che verte sull'uso di N, e non su un oggetto che N non è in grado di rintracciare.
Questo enunciato non dice niente riguardo a un oggetto; dice, in realtà, che N non ha referente107.
In ciò risiederebbe il suo valore informativo.
Per quanto ingegnosa sia, la teoria di Donnellan incorre in grandi difficoltà. L'autore dice che 'N
non esiste' sarà vero se e solo se la “storia” dell'uso di N, dove con 'uso' si intende l'intenzione
dei parlanti di riferirsi a qualcosa, non finisce come si sarebbero aspettati i parlanti108. Ma si
immagini una situazione nella quale si introduca, nella comunità dei parlanti, un nome vuoto,
101 Donnellan 1974, p.234.102 Donnellan 1974.103 Ibidem.104 Ibidem105 Donnellan 1974, p. 239.106 Evans 1982.107 Ibidem.108 Donnellan 1974.
38
senza che mai sia stata l'intenzione di usarlo referenzialmente. Ad esempio, uno scrittore
potrebbe lavorare in segreto ad un racconto a forma di diario nel quale si “parla” di un certo X,
inventato da lui. E' chiaro che lo scrittore non intende, nello scrivere il suo racconto, usare 'X' per
riferirsi a qualcosa. Si supponga che l'autore finisca il racconto e lo lasci in vista, e un suo amico
lo legga, a sua insaputa. Quest'ultimo, che sarebbe il primo lettore del racconto (oltre allo
scrittore), non riesce a stabilire se si tratta di un'opera di finzione o un genuino diario che, per
qualche strano motivo, sia finito a casa dello scrittore109. Questa incertezza lo tormenta, giacchè
le azioni narrate sono raccapriccianti. Naturalmente, non sarebbe ragionevole pensare che
l'amico, nell leggere il diario fittizio, abbia avuto l'intenzione di riferirsi a X. Non appena ha
finito di leggere il racconto, l'amico si trova davanti allo scrittore. La prima cosa che il primo
dice al secondo é: 'Esiste X?', allo quale lo scrittore risponde: 'No, non esiste X. E' solo un
personaggio fittizio. Non possono esistere persone così cattive.' Non si può sostenere che la
prima parte della risposta dello scrittore non sia un esistenziale negativo vero, giacché X è un
personaggio fittizio. Ma è vero nonostante non sia stato preceduto, in senso assoluto, da nessun
enunciato predicativo che manifestasse l'intenzione di un parlante di riferirsi a X. E' chiaro che
la domanda 'Esiste X?' non comporta un uso referenziale di X, dal momento che essa non è un
enunciato predicativo. 'X è un personaggio fittizio', anche ammettendo che sia un enunciato
predicativo, non fornirebbe la risposta desiderata da Donnellan, perché si produce dopo
l'esistenziale negativo. Quest'ultimo avrebbe potuto costituire da solo la risposta dello scrittore,
senza che risultasse alterato il suo valore di verità, o perdesse la possibilità di averne uno.
Un'altra obiezione, forse più evidente, si può sollevare nei confronti di una teoria
metalinguistica come quella di Donnellan. E' difficile sostenere che, quando una persona formula
o comprende un enunciato singolare di esistenza negativo, ciò che comprende o intende
esprimere tale persona si riduca all'informazione che il nome in esso contenuto è vuoto. Chi
formula o comprende tali enunciati non solo sa che il nome non ha referente, ma sa anche
qualcosa sulle condizione del mondo che rendono possibile il riempimento o non-riempimento
del nome in questione110. Ad esempio, per comprendere un'affermazione quale 'Vulcano non
esiste', si deve almeno avere alcune conoscenze determinate sui pianeti e su ciò che
comporterebbe l'esistenza di un ulteriore pianeta accanto agli altri nove del sistema solare111.
109 Per rendere più verosimile la storia, si può immaginare che lo scrittore è un ispettore di polizia con la passione per la scrittura, e che il suo amico sa che a volte si porta a casa dei documenti che riguardano i casi a cui lavora.
110 Runggaldier e Kanzian 1998.111 Ibidem.
39
Evans, rendendosi conto che un enunciato contenente un nome vuoto112 è in grado di veicolare
informazione di natura specifica, afferma che tali nomi non possono che essere usati, alla stregua
dei nomi non vuoti113. Il motivo è che se non fossero usati in un qualche modo, non potrebbero
essere intelligibili enunciati quali 'Pegaso vola' o 'Sherlock Holmes è un detective'. Per di più,
non si spiegherebbe il fatto che un enunciato come 'Sherlock Holmes non esiste' abbia l'evidente
valore di verità che ha. Così, il problema che deve affrontare Evans è quello di trovare un senso
di “usare” che non impegni la teoria causale del riferimento ad abbandonare il suo presupposto
fondamentale: i nomi rinviano a un oggetto con il quale si ha stabilito un contatto causale e in ciò
risiede il loro contributo semantico alle proposizioni in cui occorrono114. Evans spiega
l'approccio che intende seguire per dare una risposta al problema:
The fundamental idea is to regard utterances containing empty singolar terms used
connivingly as moves in a linguistic game of make-believe. We make believe that there is an
object of such-and-such kind, from which we have received, or are receiving, information, and
we act within the scope of that pretence. It is fairly easy to see that a story-teller is pretending to
have knowledge of things and episodes. But we must recognize that audiences of novels, plays,
films, etc. are also drawn into a pretence. This, it seems to me, is the only way in which we can
make sense of the thoughts and emotions wihich constitute their aesthetic response. More
importantly for our purpose, it is the only way in which we ca make sense of their discourse
'about the characters in the novel' (or 'film', painting', 'play, etc.).115
Nell'uso ordinario, ovvero “fuori” da un qualche gioco di far finta , gli enunciati che non
coinvolgono termini singolari usati con una chiara intenzione referenziale da parte del parlante
hanno un valore di verità, in quanto esprimono una proposizione. Così, 'Il più abile detective
inglese di tutti i tempi abitava in Baker Street' è sicuramente falso. Ma lo stesso enunciato, usato
in un modo complice rispetto ai romanzi di Conan Doyle, è vero, nel senso che la sua verità è
una finta verità. Vale a dire, nell'uso complice, tale enunciato è fintamente vero perché il fingere
la sua verità fa parte del gioco di far finta costituito dai romanzi di Doyle. Questo tipo di
enunciati esprimono sempre una proposizione 116, ciò che cambia è il contesto di valutazione. In
altre parole, la proposizione che esprimono è reale: sono enunciati con un significato reale. Il
problema con gli enunciati in cui occorrono apparenti termini singolari referenziali che non
112 In realtà, Evans non si limita a considerare i nomi vuoti; egli considera, in generale, i termini singolari che non riescono a adempiere alla loro funzione referenziale. Si veda Evans 1982.
113 Evans 1982.114 Si veda Evans 1982.115 Evans 1982, p. 353. Si segue Voltolini nella scelta di tradurre 'make-believe' con 'far finta''. Si veda Voltolini
2010.116 Qui la distinzione tra enunciato e proposizione è fondamentale.
40
designano alcunché è che, se usati fuori da un gioco di far finta, non riescono ad esprimere
nessuna proposizione, e quindi non dicono niente. Tuttavia, secondo Evans, quando si usa un
enunciato di questo tipo in un modo complice per parlare di un oggetto fittizio, nonostante non si
riesca a significare qualcosa, se riesce a far finta di farlo: si fa finta che ci si sta riferendo a
qualcosa117. Questo “far finta” consiste nel fingere che si ha un rapporto causale con l'oggetto118.
Quindi, tali enunciati hanno un significato, anche se finto. Questa mossa permette a Evans di
spiegare “l'informatività” di enunciati come 'Pegaso vola' o 'Sherlock Holmes è un detective'.
Anche se fuori del gioco di far finta non esprimono una proposizione, chi li usa lo fa, anche se
non se ne accorge del tutto, all'interno di un gioco di far finta iniziato nel passato119.
L'idea di Evans è che i giochi di far finta possono essere sfruttati anche per fare delle asserzioni
“serie” riguardo al gioco stesso. Una di queste asserzioni potrebbe essere 'Sherlock Holmes non
esiste'. E' chiaro che non si tratta di una finta verità; è una verità che riguarda il mondo reale. Ma,
perché abbia un valore di verità, è necessario che tale enunciato esprima una proposizione.
Perché ciò avvenga è necessario che chi usa un enunciato come quello debba fare una mossa
all'interno del gioco di far finta per smascherare il gioco stesso come “mondo” fittizio120. Evans
suggerisce che quando un enunciato come 'Sherlock Holmes non esiste' è usato in modo
intelligibile, tale enunciato in realtà sta per un altro che potrebbe rappresentarsi così: 'Non
(realmente (Sherlock Holmes esiste))', dove 'realmente' è un operatore che permette di passare
dal “mondo” fittizio a quello reale121. Vale a dire:
'Really' is a word which, when prefixed to a sentence, produces a sentence such that an
utterance of it is true (absolutely) if and only if the sentence preceded by 'really' is itself such
that there is a proposition expressed by it when it is uttered as a move in the relevant game of
make-believe, and this proposition is true (absolutely) – not merely * true*.122
Così, dato che 'Sherlock Holmes esiste' non esprime una proposizione, ma solo una finta
proposizione, l'enunciato 'Sherlock Holmes non esiste' esprime una verità: la negazione di
'Realmente ( Sherlock Holmes esiste)'123.
117 Evans 1982.118 Ibidem.119 Ibidem.120 Runggaldier e Kanzian 1998.121 Evans 1982.122 Evans 1982, p. 370. '* True*' sta per 'vero all'interno del gioco di far finta'.123 Evans 1982.
41
La sofisticata strategia di Evans sembra permettere al antirealista di evitare una problematica
concezione descrittivista dei nomi vuoti e, contemporaneamente, di evitare l'appello a misteriose
entità di tipo meinonghiano per spiegare l'uso significativo degli stessi. Tuttavia, la proposta di
Evans non si può dire una spiegazione soddisfacente, dato che ci sono nomi che potrebbero
risultare essere vuoti e che non sono usati in contesti di far finta. Si consideri il caso dello storico
che dichiara di aver scoperto che Socrate non è esistito. E' chiaro, dalla discussione fatta nella
sezione precedente, che tale scoperta potrebbe verificarsi. Se ciò accadesse, l'enunciato 'Socrate
non esiste' sarebbe non solo intelligibile, ma anche vero, senza che ci fosse un gioco di far finta a
sostenere l'uso di 'Socrate' durante il periodo storico previo alla scoperta. Non si potrebbe dire
che in realtà c'era un gioco di far finta, solo che non si era consapevoli di esso, perché questo
equivarrebbe a sostenere che attualmente si potrebbe stare verificando tale gioco. Per di più, lo
stesso si dovrebbe dire in relazione a tutti i nomi di personaggi storici, dal momento che di
nessuno di essi si può dire che non potrebbero rivelarsi vuoti. Non ci sarebbe distinzione
possibile tra realtà e gioco, e la strategia di Evans non potrebbe fare affidamento a uno dei suoi
presupposti fondamentali. L'intera proposta collasserebbe su se stessa. La strategia di Evans,
allora, non risolve il problema originale: come possono i nomi vuoti contribuire alla significanza
degli enunciati in cui occorrono? In particolare, come possono essere usati per negare l'esistenza
di un individuo?
Sembra che l'irrealista si trovi in un vicolo cieco. Se libera dall'onere del riferimento ai nomi
propri del linguaggio naturale e considera questi come descrizione, non riesce a rendere conto
della specificità coinvolta nel loro uso. Se, al contrario, gli restituisce la capacità di riferirsi
direttamente agli oggetti senza la mediazione di un contenuto descrittivo, non riesce a spiegarsi
come sia possibile usarli per parlare di oggetti che non esistono. Tuttavia, c'è un modo di
superare questo impasse. Ma prima di illustrare questa alternativa, è importante mostrare come le
alternative realiste non siano vie da percorrere.
42
I NEO MEINONGHIANI
Neomeinonghiani
Si è visto come, per rendere conto di alcuni enunciati con evidente valore di verità, sembri
ineludibile dover ammettere che ci sono entità non esistenti come riferimento di certe
espressioni. 'El Dorado' e 'Sherlock Holmes', ad esempio, sebbene non siano termini che si
riferiscono a oggetti esistenti, sono in grado di riferirsi a oggetti che in qualche modo devono
essere, perché altrimenti verrebbe meno la possibilità di comprendere certi enunciati dove essi
figurano. Da questo fatto risulterebbe ovvio che l'universo di entità sul quale “verta” il
quantificatore ' ∃ x ' non coincide con quello delle sole entità esistenti. L'esistenza sarebbe una
proprietà che può convenire o meno a un oggetto, non una determinazione di ordine superiore
che serve ad indicare meramente il fatto che certi predicati vengono soddisfatti da qualcosa124.
Allora, il simbolismo logico dovrebbe essere adattato a questa esigenza, in modo di chiarire la
funzione del quantificatore “esistenziale”. Si può decidere che ' ∃ x ' abbia il senso di 'c'è',
mentre 'E!' vada interpretato come quantificatore che spazia solo su ciò che esiste; oppure 'Σ'
potrebbe essere utilizzato come quantificatore particolare che non implichi l'esistenza, ed
inserire nel linguaggio formale il predicato di esistenza 'E'. In questo modo, ' Σ x ¬Ex '
esprimerebbe molto semplicemente l'idea che c'è un'entità tale che questa non esiste125.
L'esistenza potrebbe essere, come riteneva Meinong, l'avere una collocazione spazio-temporale,
o comprendere anche ciò che egli chiamava sussistenza; potrebbe anche essere l'avere poteri
causali126. Il punto è non permettere che l'essere venga confuso con l'esistenza, perché le cose
possono essere tali anche quando sono solo il termine di un atto intenzionale.
I seguaci di Meinong avrebbero potuto negare che 'c'è qualcosa tale che è quadrata e non
quadrata' sia una contraddizione, almeno non nel senso tecnico127; sarebbe tale soltanto se si
interpretasse il 'c'è' come 'esiste'. Solo tra gli oggetti esistenti si verifica che una cosa non possa
possedere una proprietà P e la sua negazione non- P128. Così, se si accetta questa visione , la
124 Runggaldier e Kanzian 1998.125 Berto 2010.126 Ibidem.127 In senso tecnico, una contraddizione ha la forma A∧¬A , dove A sta per una qualsiasi proposizione.128 Parsons 1980.
43
formula
∃ x (Cx∧¬Cx) ,
dove ' ∃ x ' è neutrale rispetto all'esistenza, non comporta che, se un oggetto la verifica, allora
x è C e è falso che x è C, il che sarebbe una contraddizione nel senso tecnico del termine129 . Al
contrario, la formula può venir verificata da un oggetto inesistente, in modo che sia possibile una
lettura della forma x è C e x è non C, la quale non esprime nessuna contraddizione. Sarebbe il
cosiddetto “pregiudizio in favore dell'esistente”130 a non permettere che si veda la possibile
distinzione tra 'non è il caso che x sia C' e 'x è non C'; solo tra gli esistenti non fare la distinzione
è innocuo, per così dire131.
Nonostante tutto ciò, la teoria meinonghiana cela delle insidie capaci di vanificare se stessa. Si
parte dal presupposto che un oggetto è caratterizzato dalle proprietà che possiede (Sosein), anche
se queste sono solo le proprietà con cui lo si rappresenta. Quindi, se un oggetto ha delle
proprietà, allora tale oggetto c'è. Se inoltre possiede la proprietà E (definita nel modo che si
ritenga più adeguato), l'oggetto non solo è, ma esiste. Da queste considerazioni si può ottenere
una sorta di principio generale, uno “schema di individuazione” di oggetti: “Se qualcuno pensa
ad un F, allora qualcosa è un F”132, dove 'F' può stare per una singola parola, una descrizione
definita o un nome proprio. Questo principio, che potrebbe essere chiamato Principio di
Comprensione133, assicura che preso un qualsiasi insieme di proprietà descrivibile, ci sarà un
oggetto che possieda tali proprietà134. Se si considera l'esistenza una proprietà di individui, basta
aggiungerla a qualsiasi gruppo di proprietà per ottenere un'entità che goda automaticamente della
proprietà di esistere135. Così, non solo c'è un quadrato rotondo, ma anche un quadrato rotondo
esistente. Allo stesso modo, ci sarà un quadrato non quadrato esistente. Ma quest'ultimo genera
una contraddizione all'interno del sistema meinonghiano, giacché trattandosi di un oggetto
esistente, la sua natura metafisica non gli darebbe la possibilità di verificare ∃ x (Cx∧¬Cx).
Se lo facesse, si dovrebbe assumere che x è C ed è falso che x è C: una contraddizione a tutti gli
effetti.
129 Sainsbury 2009.130 Si veda Meinong 1904. Si veda anche Parsons 1980.131 E' ironico notare come la distinzione di ambito di Russell sia stata sfruttata dai seguaci di Meinong.132 Sainsbury 2009, p. 53.133 Si veda Berto 2010, Zalta 1988.134 Berto 2010.135 Ibidem.
44
Il problema, come aveva notato Russell, è che questo principio “concede troppo”, dato che
permette di provare l'esistenza di qualsiasi cosa136. Si pensi ad una proposizione contraddittoria
qualsiasi A; si pensi anche ad un oggetto che sia identico a se stesso e tale che A sia
consistente. Allora, secondo un meinonghiano, c'è un oggetto tale che è identico a se stesso e tale
che A è consistente. Ne segue che A è consistente137.
Un'altra stranezza implicita nel Principio di Comprensione è quella di fare, tanto degli oggetti
esistenti quanto di quelli non esistenti, oggetti che godono delle proprietà. Anzi, sono le
proprietà possedute da un individuo ciò che fa di esso l'individuo che è: per ogni insieme di
proprietà c'è uno e un solo oggetto meinonghiano che gode di tutte quelle proprietà138. Le
proprietà godute, ad esempio, da Sherlock Holmes, saranno quelle che permettono di
identificarlo come un oggetto fittizio diverso da Topolino o Don Chisciotte. Intuitivamente, le
proprietà di Holmes sono quelle con cui lo si rappresenta nelle storie di Conan Doyle139: Holmes
è un detective inglese, non uno squilibrato spagnolo che lotta contro i mulini a vento. Così, si
può legittimare l'intuizione comune che accetta un enunciato come 'Sherlock Holmes è un
detective' e rifiuta uno come 'Sherlock Holmes è un topo che parla'. Tuttavia, la stessa intuizione
comune si chiede come sia possibile, per qualcosa che non esiste, il godere delle proprietà. Se
Holmes è un detective, allora dovrebbe essere possibile ingaggiarlo; se abita o abitava a Londra,
allora dovrebbe essere possibile trovare qualcuno a Londra che lo abbia visto o che conosca
qualcuno che lo abbia fatto. Naturalmente, simili aspettative non possono essere soddisfatte. Da
un lato, le proprietà permettono di individuare dell'entità inesistenti; dall'altro, nel farlo, queste
proprietà smettono di comportarsi come ci si aspetterebbe. Come segnala Lewis:
Infine, il meinonghiano deve dirci perché le verità relative ai caratteri di finzione sono isolate, a
volte ma non sempre, dalle conseguenze che dovrebbero implicare. Possiamo dire il vero
dicendo che Holmes viveva al 221B di Baker Street. Mi è stato detto che l'unico edificio al 221B
di Baker Street, allora come ora, è una banca. Non ne segue, e certamente non è vero, che
Holmes viveva in una banca. 140
136 Ibidem.137 Sainsbury 2009.138 Voltolini 2010.139 Ibidem.140 Lewis 1978, p. 172.
45
Tipi di proprietà
Alcuni neomeinoghiani hanno pensato che i problemi suscitati dalla versione naive141 della
concezione di Meinong possono essere risolti appellandosi a una distinzione tra i tipi di
proprietà godute dall'entità non esistenti. Ad esempio, Parsons distingue tra proprietà nucleari e
proprietà extranucleari142. Una proprietà è nucleare quando appartiene all'insieme di proprietà
che determina l'identità dell'oggetto meinonghiano, il suo essere così. Quelle extranucleari,
invece, indicano semplicemente lo status metafisico dell'oggetto, il modo in cui esso si dà, o il
modo in cui si rapporta alle diverse forme dell'intenzionalità143. Così, il Principio di
Comprensione dice soltanto quali oggetti ci sono in base alle proprietà nucleari che si possono
abbinare formando insiemi distinti. Le proprietà extra nucleari non intervengono nella
costituzione degli oggetti e, perciò, non sono ammesse in tali insiemi. Non ci sono due oggetti,
reali o irreali, che abbiano esattamente le stesse proprietà nucleari; e per ogni insieme di
proprietà nucleari, c'è un oggetto che ha tutte le proprietà dell'insieme e nessun'altra proprietà
nucleare144. Come si può apprezzare, le proprietà extranucleari sono irrilevanti a fini
dell'individuazione di un'entità. Parsons è categorico al riguardo: “If x and y have exactly the
same nuclear properties, then x=y.”145. Esempi di proprietà nucleari sono 'essere blue', 'essere
d'oro', 'essere alto'; di quelle extranucleari, 'esistere', 'essere fittizio', 'essere possibile', etc.
L'esistenza non può essere una proprietà nucleare, perché, se lo fosse e si mettessero insieme i
predicati 'essere d'oro', 'essere una montagna' e 'esistere', si dovrebbe concludere, grazie al
Principio di Comprensione, che c'è una montagna d'oro esistente che esiste, il che è ovviamente
falso146.
Tuttavia, è sempre possibile pensare a una montagna d'oro esistente, e quindi, sembra che non
si possa vietare al predicato 'esistere' di far parte di un insieme capace di costituire oggetti. Le
contraddizioni come quelle di cui si è parlato nella sezione precedente si riproporrebbero. Il
quadrato non quadrato esistente avrà la proprietà di esistere, e quindi, sarà un oggetto in grado di
generare una contraddizione. Per salvaguardarsi da questo pericolo, la teoria meinonghiana deve
fare in modo di rigettare l'idea che 'esistente' sia lo stesso predicato extranucleare che 'esistere'.
La montagna d'oro esistente è un'entità che gode della proprietà nucleare di 'essere esistente', ma
141 Si veda Parsons 1980.142 Si veda Parsons 1980.143 Sainsbury 2009.144 Parsons 1980.145 Parsons 1980, p.28.146 Parsons 1980.
46
non di quella extranucleare di 'esistere'. Come aveva già notato Meinong, pensare a qualcosa
come esistente non è lo stesso di attribuire a questo qualcosa l'esistenza147. Si può pensare a
qualcosa rappresentandolo come avente la proprietà di esistere, ma ciò non vuol dire che si
giudichi che tale cosa esista148. In altre parole, è possibile attribuire all'essenza (Sosein) di una
cosa, nell'atto intenzionale di “contemplare” tale cosa, l'esistenza, ma svuotata della fattualità
che le è propria quando la si predica per indicare il modo metafisico in cui un oggetto si dà149. Si
tratterebbe, semplicemente, di trattare 'essere esistente' come una mera supposizione o
assunzione di esistenza150. Ricollegandosi a queste osservazioni di Meinong, Parsons considera
'essere esistente' quale versione diluita (watered-down) di 'esistere'151. Anche se intimamente
collegata con la proprietà extranucleare dell'esistenza, non è essa stessa una proprietà
extranucleare, ma una nucleare152. Quindi, può determinare l'individualità di un oggetto senza
comportare che tale oggetto debba essere un oggetto esistente. In questo modo, c'è un quadrato
non quadrato esistente, ma questo quadrato non esiste. Le limitazioni che affliggono l'entità che
esistono e che non permettono a queste ultime di raggirare il principio di non-contraddizione,
non affliggerebbero le entità che non esistono anche quando sono esistenti, nel senso diluito del
termine.
Questa distinzione tra tipi di predicati permetterebbe di spiegare un altro fenomeno che
riguarda l'ascrizione di proprietà all'entità non esistenti. Si consideri:
(1) Sherlock Holmes è un detective
(2) Sherlock Holmes è un personaggio fittizio
Tutti i due enunciati ascrivono una proprietà a Sherlock Holmes, ma è chiaro che lo fanno in
modo diverso. Sarebbe molto difficile immaginare, per esempio, come un'affermazione quale
'Sherlock Holmes è un detective, ma è anche un personaggio di finzione' possa essere valutata.
Nonostante ciò, (1) e (2), considerati in isolamento, non sembrano creare problemi all'ora di
stabilire il loro valore di verità.
147 Meinong rispose così alle obiezioni rivoltegli da Russell in On denoting. Si veda Lenoci 1972 per la storia del confronto tra i due pensatori.
148 Lenoci 1972.149 Ibidem.150 Ibidem.151 Parsons 1980.152 Ibidem.
47
Seguendo Parsons, (1) mobilita una proprietà nucleare di Sherlock Holmes, essere un detective,
in quanto tale proprietà è una delle proprietà che gli si ascrivono nei romanzi che descrivono
Holmes. Perciò, (1) è vero perché effettivamente Holmes possiede la proprietà di essere un
detective: è una proprietà che fa parte della sua identità. Non ci vuole altro, per capire ciò, che
conoscere come viene pensato Holmes nei romanzi153. Al contrario, (2) non fa riferimento
all'insieme di proprietà costitutive di Holmes, e quindi, non può essere considerato vero in base
alle proprietà assegnate a Holmes da una storia in cui viene rappresentato. Nei romanzi di Conan
Doyle, Sherlock Holmes è un essere in carne e ossa, una persona, non un personaggio fittizio.
L'essere un personaggio fittizio sarebbe una proprietà extranucleare di Holmes, la quale si può
predicare di lui senza dover far riferimento alle storie di cui dipende la sua identità. Così, gli
oggetti fittizi godono principalmente di proprietà nucleari e secondariamente di proprietà
extranucleari154.
Tuttavia, la distinzione operata da Parsons non riesce a chiarire in quale senso un oggetto
meinonghiano può godere di proprietà nucleari nello stesso modo in cui sono godute da un
oggetto ordinario. Se Sherlock Holmes è costituito, tra molte altre, dalla proprietà mobilitata nei
romanzi di Sherlock Holmes di essere un detective, allora è un detective allo stesso modo in cui
lo è uno dei tanti detective rintracciabili nelle pagine bianche. Allo stesso modo, dai romanzi di
Conan Doyle si evince che Holmes non è un personaggio fittizio, ma un essere umano esistente.
In altri termini, si rappresenta Holmes come un esistente. Ma si è visto che rappresentare
qualcosa come esistente non è altro che appellare a una versione diluita (watered-down)
dell'esistenza. Quindi, Sherlock Holmes non è costituito dalla proprietà di esistere, ma da un suo
surrogato, per così dire. La motivazione di tale manovra era quella di evitare che un oggetto
meinonghiano diventi un oggetto che esiste solo per il fatto di pensarlo in possesso di tale
proprietà, il che comporterebbe il dover ammettere che suddetto oggetto è, a tutti gli effetti,
un'entità che si comporta come tutte l'entità che esistono. Il problema è che non si vede perché
non si possa o si debba effettuare la stessa mossa in relazione a una proprietà come quella di
essere un detective. Non è chiaro perché non fare di Sherlock Holmes un oggetto del quale non
si possa dire che è letteralmente un detective, ma soltanto un detective diluito. In questo modo,
non si porrebbe il fastidioso problema di stabilire come sia possibile che Holmes sia un detective
(abilissimo) incapace di risolvere il più elementare dei casi reali che si possano presentare.
153 Sainsbury 2009.154 Voltolini 2010.
48
Come è facile immaginare, nessuna delle proprietà attribuite al personaggio di Doyle nei
romanzi potrebbe non essere “rivista”. Il Principio di Comprensione dovrebbe essere riformulato
in modo di permettere la costruzione di oggetti in base non alla pensabilità di correlati di
proprietà, ma in base a correlati di versioni diluite di proprietà.
Tutto ciò significa che la distinzione tra proprietà nucleari e extranucleari sembra più artificiale
che reale, dato che le versioni diluite di proprietà, che sono proprietà nucleari, sono versioni di
proprietà extranucleari. Prima di tutto, non esiste alcun criterio per distinguere proprietà
nucleari di proprietà extranucleari155. Lo stesso Parsons riconosce che la procedura per effettuare
la distinzione è tutt'altro che incontrovertibile:
It is this: if everyone agrees that the predicate stands for an ordinary property of individuals,
then it is a nuclear predicate and it stands for a nuclear property. On the other hand, if everyone
agrees that it doesn't stand for an ordinary property of individuals (for whatever reason), or if
there is a history of controversy about whether it stands for a property of individuals, then it is
an extranuclear predicate, and it does not stand for a nuclear property. Of course, this “decision
procedure” is a very imperfect one. 156
Ad esempio, si consideri la proprietà di essere un personaggio fittizio. A prima vista, essa
sembra essere una proprietà extranucleare: descrive quei particolari casi di oggetti meinonghiani
che sono entità di finzione, senza venir mobilitata all'interno dei racconti o storie che riguardano
tali entità. Quindi, non fa parte del nucleo di attributi che definiscono l'identità di un oggetto.
Tuttavia, esistono racconti di tipo metafittizio, vale a dire, storie in cui si parla o si vuole mettere
in risalto la natura finzionale della propria storia. In questo tipo di narrazioni si possono trovare
personaggi che sono descritti proprio come personaggi fittizi. Un esempio di questo fenomeno è
Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. In questo romanzo, il personaggio del Padre
viene descritto come un personaggio fittizio, all'interno delle vicende che lo riguardano. Poiché
'essere un personaggio fittizio' è una proprietà mobilitata dalla storia di Pirandello, si ha tutto il
diritto di considerare tale proprietà una proprietà nucleare157.
Naturalmente, il difensore della teoria dei tipi di proprietà potrebbe dire che all'interno della
storia di Pirandello si mobilizza la proprietà diluita di 'essere un personaggio fittizio', e non
quella non diluita. Nonostante ciò, niente vieta alla creatività letteraria di produrre finzioni che
155 Ibidem.156 Parsons 1980, p. 24.157 Voltolini 2010.
49
incorporino finzioni a qualsiasi livello158. Inoltre, la finzione ha la capacità di inglobare qualsiasi
argomento, per quanto serio possa essere. Così, si potrebbe avere una storia metafittizia che
cerchi di farsi beffa della teoria di Parsons sui tipi di proprietà. Una storia del genere potrebbe
essere questa159:
(3) C'erano una volta Jerry, che era un personaggio fittizio, e Terry, che era un personaggio
fittizio diluito.
Allora, per rendere conto di (3), un realista seguace di Parsons dovrà dire che Jerry ha la
proprietà nucleare di 'essere un personaggio fittizio diluito', mentre Terry quella di 'essere un
personaggio fittizio diluito-diluito'. Come non è difficile accorgersi, questa situazione crea i
presupposti per un regresso all'infinito, con la mobilitazioni di proprietà nucleari diluite di grado
sempre maggiore e di natura sempre più oscura160. Infatti, la storia rappresentata da (3) avrebbe
potuto incorporare un altro personaggio, Perry, descritto come personaggio fittizio diluito –
diluito, il che avrebbe significato che Perry avesse la proprietà nucleare di 'essere un personaggio
fittizio diluito – diluito – diluito'161.
Modi di predicazione
Alcuni meinonghiani, onde evitare complicazioni come quelle riscontrate nella proposta di
Parsons, sostengono che non ci sono due diversi tipi di proprietà di cui un oggetto può godere,
bensì c'è un medesimo tipo di proprietà che può essere predicato sia in modo interno, sia in
modo esterno162. Gli oggetti ordinari, esistenti, tipicamente godono delle proprietà predicate in
modo esterno; quelli meinonghiani, per contro, possono godere tanto in modo esterno quanto in
modo interno di esse. Edward Zalta è uno dei più noti difensori di questa distinzione tra modi di
predicazione, la quale diventa, nella sua teoria, la distinzione tra codificare (encoding) ed
esemplificare (exemplifying) una stessa proprietà163. Per capire in cosa consiste tale distinzione,
si ricordi il problema sollevato a proposito di Sherlock Holmes e il suo 'essere un detective'. Se
Holmes è un detective, allora lo è in una maniera molto strana rispetto a un detective reale,
158 Sainsbury 2009.159 L'argomento è di Voltolini. Si veda Voltolini 2010.160 Voltolini 2010.161 Ibidem.162 Ibidem.163 Zalta 1988.
50
giacché non può essere trovato per richiedere i suoi servizi o fargli un'intervista. Secondo Zalta:
The natural way of explaining this difference is to say that fictional detectives don't have the
property of being a detective in quite the same way that real ones do. Real detectives exemplify the
property, whereas fictional detectives do not. We shall say that the latter encode the property,
however. Things that exemplify the property of being a detective exist, have a location in space
and time, are made of flesh and bones, think, solve crimes, and so on, whereas things that just
encode the property of being a detective are abstract and do not exemplify any of these
characteristics. 164
Così, predicare in modo esterno vuol dire predicare di un oggetto che esso esemplifica la
proprietà predicata: la possiede in modo letterale. Invece, predicare in modo interno vuol dire
che l'oggetto la codifica: l'oggetto è rappresentato come avente la proprietà in questione165.
Sherlock Holmes, secondo le storie che lo riguardano, esemplifica la proprietà di essere un
detective e anche quella di esistere, ma ciò non significa che le esemplifichi simpliciter166.
Altrimenti, Holmes sarebbe un detective esistente nel senso ordinario dei termini, e quindi,
dovrebbe esistere. Soltanto le entità esistenti possono essere descritte appellandosi
esclusivamente al modo esterno di predicazione, giacché soltanto queste necessariamente e
sempre “fail to encode properties”167. In questo modo, quando si parla di Sherlock Holmes
dall'”esterno” del contesto finzionale, e si vuole predicare qualcosa di vero su di lui, si devono
predicare in modo interno le proprietà mobilitate dalla storia, perché fuori da tale contesto
Holmes è un oggetto meinonghiano che soltanto codifica le proprietà con cui lo si rappresenta
nella finzione. Tuttavia, si possono anche predicare certi attributi in modo esterno di Holmes,
attributi che possiede nel senso ordinario del termine. Ad esempio, si può benissimo dire che egli
è un personaggio fittizio. La proprietà 'essere personaggio fittizio' è una proprietà esemplificata
dall'oggetto astratto Holmes, una proprietà che esso possiede e che lo caratterizza come un'entità
di una particolare natura metafisica che non deve esistere per essere ciò che è. Lo stesso si
potrebbe dire della proprietà di 'codificare delle proprietà'. L'oggetto che codifica delle proprietà
lo fa in modo letterale, vale a dire, esemplifica la proprietà di 'codificare delle proprietà'.
Dato che un oggetto meinonghiano è per forza un oggetto non esistente, questo deve essere un
oggetto codificatore di proprietà. Quindi, l'unico modo di stabilire se due oggetti sono lo stesso
164 Zalta 1988, p. 17.165 Sainsbury 2009.166 Zalta 1998.167 Zalta 1998, p. 19.
51
oggetto è quello di stabilire che entrambi codificano le stesse proprietà. Soltanto se due oggetti
inesistenti codificano le stesse proprietà possono essere lo stesso individuo168. Due oggetti
ordinari, al contrario, sono lo stesso oggetto solo se esemplificano le stesse proprietà169. Perciò,
sarà vero dire che Holmes è un detective, poiché la codifica di tale proprietà fa parte dell'insieme
di proprietà che costituisce l'identità di Holmes. Se si dicesse che Holmes è una donna, si direbbe
qualcosa di falso, poiché 'essere una donna' non è una proprietà codificata dal personaggio di
Conan Doyle. Sherlock Holmes è l'individuo che è perché codifica un certo insieme di proprietà
che non è codificato da nessun altro individuo. In altre parole, il Principio di Comprensione
diventa nella concezione di Zalta il principio per il quale, per ogni condizione di proprietà, è
sempre necessario che ci sia un individuo astratto che codifica soltanto le proprietà che
soddisfano tale condizione170. Da ciò si può inferire che se un individuo codifica una proprietà,
questo la codifica in modo necessario171.
Non c'è bisogno di appellarsi a versioni diluite di proprietà per spiegare il problema sollevato
dal personaggio del Padre nel romanzo di Pirandello. Il Padre sarà sempre un personaggio
fittizio nel senso letterale, poiché c'è una storia che coinvolge questo oggetto astratto; sarà
possibile parlare di lui dall'esterno dalla storia per categorizzarlo come un'entità fittizia. Ma dato
che all'interno della storia Il Padre viene descritto come personaggio fittizio, sarà anche possibile
dire che Il Padre codifica la proprietà di 'essere un personaggio fittizio', questa volta
considerando le proprietà costitutive dell'individuo mobilitate dal racconto172. Nel primo caso, si
predica 'l'essere personaggio fittizio' in modo esterno; nel secondo, in modo interno173. Tale
distinzione evita il problema di dover trovare il misterioso modo in cui una proprietà non
nucleare possa essere costitutiva dell'identità di un oggetto meinonghiano.
Parimenti, la distinzioni zaltiana permetterebbe di spiegare il caso del “quadrato rotondo non
rotondo esistente” o quello della “montagna d'oro esistente”. Ammettere queste entità andrebbe
in contro a incompatibilità con i fatti o le leggi logiche soltanto se le si considera entità che
esemplificano le proprietà con cui sono descritte. Invece, se le si pensa come oggetti che
codificano quelle proprietà, i problemi non si presentano. Se il quadrato rotondo non rotondo
codifica 'essere quadrato', 'essere rotondo' e 'essere non rotondo', allora non viola il principio di
168 Zalta 1998.169 Ibidem.170 Ibidem.171 Ibidem.172 Voltolini 2010.173 Ibidem.
52
non-contraddizione, dal momento che tale principio dice in realtà che niente può esemplificare
contemporaneamente tali proprietà174. Non può esserci un oggetto che esemplifichi le proprietà in
questione, perché si sa che qualsiasi cosa che sia letteralmente rotonda non può essere anche
letteralmente non rotonda (o quadrata). La contraddizione si produrrebbe se si affermasse che c'è
un tale oggetto, ma affermare che c'è un oggetto che soltanto codifica le proprietà che un oggetto
esistente non può esemplificare non lo è. Non c'è niente di contraddittorio nel rappresentarsi
qualcosa che possieda proprietà contraddittorie175. Anche se un oggetto meinonghiano
codificasse 'l'essere esistenti', la situazione sarebbe la stessa. Codificare 'essere esistenti' non è lo
stesso di esemplificare la proprietà di esistere. Così, “la montagna d'oro esistente” o “il quadrato
rotondo non rotondo esistente” possono essere ciò che sono senza esistere, poiché il fatto di
codificare una proprietà, come l'esistenza, non implica che si esemplifichi tale proprietà176. In
definitiva, non è possibile generare una contraddizione o una incompatibilità con i fatti a partire
dalle proprietà codificate da un qualsiasi oggetto meinonghiano, dato che, per definizione, le
proprietà codificate solo possono essere codificate da oggetti non esistenti. Non si può passare,
per così dire, dal regno della codificazione a quello della esemplificazione, che è l'ambito dove
operano le leggi logiche e si valutano i fatti contingenti.
Come si vede, la distinzione tra modi di predicazione nasce per proteggere le entità
meinonghiane dalle tribolazioni a cui sono sottoposti gli oggetti ordinari, esistenti, i quali devono
rispettare molti vincoli per poter “essere”. Tuttavia, tale distinzione fa, in ultima istanza, degli
oggetti meinonghiani dell'entità di scarsa utilità al momento di voler spiegare i fenomeni
intenzionali ai quali avrebbero dovuto servire di fondamento. Si consideri il caso di “El Dorado”.
Orellana cercava “El Dorado”. Allora, dato che tale città è un oggetto non-esistente, l'oggetto che
l'esploratore spagnolo aveva in mente (quello che si intende nel descrivere la sua ricerca) è
presuntamente un oggetto astratto codificatore di determinate proprietà. Questa entità sarebbe il
termine dell'atto intenzionale di Orellana e, perciò, il riferimento dell'espressione 'El Dorado' in
un enunciato quale 'Orellana cercava “El Dorado”'; in questo modo, si può esprimere un pensiero
completo e intelligibile riguardo Orellana e l'entità particolare a cui egli dedicava i suoi sforzi.
Nonostante ciò, nulla vieta che, dopotutto, in un futuro si scopra che “El Dorado” realmente è
esistito. Una ricerca storica potrebbe dimostrare che questa città fu eretta dagli Inca ma ebbe una
breve vita, poiché lotte intestine all'Impero Inca determinarono la sua distruzione. I miti non
sarebbero tali, almeno fondamentalmente. In questo scenario, il nome 'El Dorado' si sarebbe
174 Zalta 1998.175 Sainsbury 2009.176 Zalta 1998.
53
riferito da sempre a una città che fece parte del regno dell'esistenza. Orellana avrebbe cercato
questa città, e chi descrive la sua ricerca userebbe il nome 'El Dorado' per identificare la stessa. Il
fatto che ci sarebbe comunque un oggetto astratto che codifichi esattamente e soltanto le
proprietà letteralmente possedute dalla città perduta non avrebbe nessuna incidenza su “ciò che si
intende” con 'El Dorado'. Non sarebbe sensato dire che mentre non si credeva all'esistenza
storica di “El Dorado”, il termine farebbe riferimento a un'entità zaltiana, e una volta rivelatasi la
verità, il termine passa ad avere un altro riferimento. In genere, il riferimento dei termini
linguistici non cambia in base alle proprietà che si crede devono essere attribuite all'oggetto che
costituisce tale riferimento177. Altrimenti, non si spiegherebbe il progresso della scienza, ne la
possibilità di disaccordo sulle qualità possedute da un determinato oggetto. Infatti, il disaccordo
presuppone che le diverse posizioni nei confronti di un oggetto intendano lo stesso oggetto; se
non fosse così, semplicemente non ci sarebbe nessun disaccordo: si parlerebbe di cose distinte.
Il punto è che se la versione “codificatrice” di qualcosa che si rivela un esistente non può essere
tale esistente, per il semplice motivo che un'entità “codificatrice” non può esistere, non è per
niente chiaro come un oggetto zaltiano possa costituire il riferimento di qualsiasi nome “vuoto”,
dal momento che non è in grado di garantire la continuità del riferimento verso se stesso. A
esempio, non si può essere certi della non esistenza del “mostro di Lochness”; molte persone
hanno la speranza e anche la sicurezza di riuscire a dimostrarne l'esistenza. Si supponga che un
gruppo di ricercatori attualmente sia impegnato nella ricerca del mostro del lago Lochness.
Ammesso che non esista tale creatura, è sempre possibile immaginare lo scenario contrario.
Allora, è possibile immaginare che la loro ricerca tra un mese darà i frutti attesi: si scoprirà
l'esistenza della fino ad adesso sfuggente creatura. La facoltà dell'immaginazione potrebbe
manifestarsi linguisticamente: “Tra un mese sarà dimostrata l'esistenza del 'Mostro del Lago
Lochness'”. E' chiaro che ciò che si immagina è riferito alla stessa ricerca che attualmente sta
avendo luogo, e non a una ricerca diversa. Se si riesce ad immaginare la ricerca senza intaccare
la sua identità, si deve supporre che l'oggetto della stessa sia sempre il medesimo oggetto della
ricerca attuale; altrimenti, si tratterebbe di un'altra ricerca.
Ebbene, nell'immaginare la scoperta del “mostro di Lochness”, si sta facendo riferimento allo
stesso individuo che è ricercato attualmente dal gruppo di studiosi. Vale a dire, si pensa e si parla
della stessa entità. Ma se tale entità è un oggetto zaltiano, allora immaginare la scoperta del
mostro equivarrebbe ad immaginare che l'entità ricercata è stata sempre un'entità concreta ed
177 Si veda Putnam 1975.
54
esistente diversa da qualsiasi oggetto astratto sussistente, il che vorrebbe dire che si immagina di
aver sempre parlato e inteso un oggetto diverso da quello di cui effettivamente si parla e si
intende. Un oggetto non esistente, agli occhi di Zalta, per definizione non può diventare un
oggetto concreto ed esistente. Così, la situazione immaginaria sarebbe una situazione in cui la
ricerca preserva la sua identità, anche se l'oggetto ricercato non può continuare ad essere un
oggetto zaltiano, vale a dire, non può continuare ad essere se stesso. Naturalmente, questo è
molto controintuitivo. Sembrerebbe che, dopotutto, la descrizione delle attività intenzionali non è
legata ad oggetti di una particolare natura metafisica. La concezione di Parsons avrebbe
sicuramente evitato queste complicazioni, dal momento che nel suo sistema l'esistenza avrebbe
potuto subentrare al posto della non – esistenza, lasciando intatta l'identità dell'oggetto, che viene
definita in termini dalle sole proprietà nucleari.
Il problema fondamentale dei meinonghiani
Tutte le versioni del meinonghianismo hanno in comune un problema di fondo generato
dall'accettazione del Principio di Comprensione. Suddetto principio fu generato per assicurare
che ci fossero sufficienti oggetti non esistenti , in modo tale che ogni possibile pensiero avesse
un oggetto come correlato oggettivo. Tuttavia, questo non basta per chiarire come si possa
stabilire se pensare ad un oggetto F, ad esempio, in un determinato momento, e pensare ad un
oggetto G in un altro, sia pensare allo stesso oggetto o meno178. Se un'entità meinonghiana è
definita dall'insieme di proprietà con cui lo si rappresenta, e soltanto da esse, pensare ad un
oggetto associato ad un altro insieme di proprietà, che differisca dal primo anche soltanto per il
fatto di annoverare una proprietà in più, sarebbe ipso facto pensare ad un altro oggetto179. Ma
tutto ciò è in netto contrasto con la pratica ordinaria. Una persona che abbia letto soltanto il
primo romanzo che scrisse Conan Doyle su Sherlock Holmes non può rappresentarsi questo
personaggio allo stesso modo in cui può farlo chi ha letto tutte le opere che riguardano Holmes,
dal momento che la massa di descrizioni riguardanti Holmes a cui ha avuto accesso il secondo è
molto più grande di quella a cui ha avuto accesso il primo. Tuttavia, entrambi i lettori possono
discutere sul detective fittizio sapendo di intendere lo stesso personaggio. Non verrebbe in mente
a nessuno dei due di dire qualcosa come: “Non so di quale personaggio stai parlando, perché
ancora non ho letto tutti i romanzi di Doyle”.
178 Sainsbury 2009.179 Ibidem.
55
Ammesso che ci sia una cosa tale come l'individuo Sherlock Holmes, il meinonghiano dovrebbe
trovare il modo di non identificare l'insieme di proprietà con cui lo si individua
epistemologicamente con l'insieme che lo individua nel senso metafisico. Un oggetto è
individuato metafisicamente dalle proprietà che fanno di esso l'oggetto particolare che è e non un
altro; individuarlo epistemologicamente, invece, vuol dire pensare ad esso, sceglierlo quale
“argomento” del pensiero. E' plausibile, ad esempio, che un essere umano sia individuabile
metafisicamente per il fatto di aver avuto origine da certi gameti, ma ciò non significa che
affinché possa essere l'oggetto di un discorso sia necessario conoscere da quali gameti esso
provenga180. Anzi, si è capaci di avere in mente o riferirci a qualcosa anche nel caso si rivelasse
che molte delle proprietà che si credeva esso possedesse non fossero effettivamente possedute181.
Qualcuno potrebbe credere che Silvio Berlusconi sia il capo del Partito Democratico e anche un
soggetto con una vita sessuale molto riservata. Non per questo motivo si dirà che le credenze di
queste persone non vertono su Berlusconi; si dirà piuttosto che ha delle credenze sbagliate
riguardo Berlusconi. Il problema del meinonghiano è fondamentalmente quello di non poter
stabilire una chiara distinzione tra i due piani, quello epistemico e quello metafisico, dal
momento che gli oggetti meinonghiani sono, in un certo senso, fatti su misura delle esigenze
epistemologiche. Un non esistente è un'entità che nasce come correlato della rappresentazione di
un oggetto che possiede esattamente le proprietà con cui lo si rappresenta. Quindi, l'oggetto è
metafisicamente condizionato ad essere il possessore delle proprietà che si mobilizzano in un
atto di rappresentazione dello stesso. Ma siccome la rappresentazione dell'oggetto non può non
coincidere con l'oggetto, se si vuole che tale rappresentazione ne abbia uno e non molti tra i quali
non si saprebbe scegliere quello “giusto”, ne segue che l'individuazione epistemologica coincide
con quella metafisica. L'entità che si individua nel pensiero è automaticamente individuata sul
piano metafisico: è l'entità che è perché possiede le proprietà, e solo quelle, che permettono
distinguere il pensiero che “verte” su di essa dai pensieri che vertono su altre entità non esistenti.
Altrimenti, non si sarebbe in grado di stabilire perché la rappresentazione che mobilizza
l'insieme di proprietà [A,B,C,D] è indirizzata verso l'oggetto che possiede A,B,C e D e non verso
l'oggetto che possiede A,B,C,D e E, il che lascerebbe completamente indeterminata la
rappresentazione. Come è facile intuire, la stessa indeterminazione si produrrebbe se una
rappresentazione che mobilizzasse l'insieme di proprietà [A,B,C] potesse rintracciare sia
l'oggetto che possiede solo A, sia quello che possiede A e B.
180 Kripke 1980.181 Si ricordi la critica kripkiana alla concezione di Russell sui nomi propri.
56
Da quanto detto sopra, si evince che non può esserci una rappresentazione non solo sbagliata di
un'entità meinonghiana, ma neanche una incompleta. Il meinonghiano deve allora trovare un
modo di raggirare questo vincolo così forte da permettere situazioni come quella discussa a
proposito dei due lettori dei romanzi di Conan Doyle. Per fare ciò, egli potrebbe dire che in
realtà l'oggetto a cui si riferisce il termine che nomina un essere meinonghiano è l'oggetto al
quale si è avuto accesso grazie ad un'attività di rappresentazione “fondamentale”, alla quale altri
atti di rappresentazione sarebbero subordinati. In questo modo, diversi individui potrebbero
sapere di intendere lo stesso oggetto anche avendo di esso una idea parziale, in termini delle
proprietà che gli convengono. Ci sarebbe una istanza in cui si mobilizzano le proprietà che
definiscono l'oggetto in questione, e alla quale si potrebbe fare riferimento per “ancorare” il
significato del termine. Così, si potrebbe seguire Parsons ed esseri concordi nell'affermare che
Sherlock Holmes è l'oggetto che possiede esattamente le proprietà (nucleari) che si intende lui
abbia nei romanzi di Conan Doyle182. Sarebbero le proprietà ascritte a Holmes da Conan Doyle
quelle che permetterebbero la sua individuazione metafisica. Tuttavia, questa manovra non fa
che spostare il problema. Quando Doyle pubblicò il primo romanzo su Sherlock Holmes, Uno
studio in rosso, nel 1887, le proprietà attribuite al suo personaggio erano meno rispetto a quante
gli sarebbero state attribuite complessivamente nel 1890, quando appare Il segno dei quattro,
secondo romanzo della saga. Allora, chi parlasse di Holmes nel 1887 avrebbe inteso un oggetto
diverso da quello inteso da qualcuno che ne parlasse nel 1890, dal momento che la istanza
“fondamentale” non sarebbe stata la stessa. Non è per niente chiaro perché si debba considerare
il secondo romanzo di Doyle una continuazione dalla rappresentazione di un oggetto iniziata con
il primo romanzo e non la rappresentazione di un altro oggetto molto simile al primo. Vale a dire,
non esiste un criterio ovvio che permetta di stabilire se la prima opera di Conan Doyle è da
considerarsi una rappresentazione incompleta o meno in relazione a un determinato individuo
non esistente. Dopotutto, i presupposti per “convocare” un oggetto meinonghiano nella sua
completezza erano presenti: determinate proprietà, e soltanto esse, venivano attribuite ad un
oggetto183.
Da un'altra parte, se si doveva aspettare alla realizzazione dell'intera opera di Doyle per poter
stabilire l'oggetto a cui si riferisce il nome 'Sherlock Holmes', lo stesso autore, paradossalmente,
non avrebbe saputo di quale entità stessi scrivendo, a meno che avesse in mente tutte le proprietà
182 Parsons 1980, p. 54.183 Sainsbury 2009.
57
che avrebbe mobilitato lungo gli anni ancora prima di iniziare a scrivere. Quest'ultima
alternativa, come lo stesso Zalta184 riconosce, è poco ragionevole. Infatti, in tale caso sembra un
miracolo che Conan Doyle sia riuscito a identificare, tra infiniti individui molto simili,
l'individuo che possedesse tutte e soltanto le proprietà che egli gli avrebbe attribuito lungo i suoi
anni di scrittore185. Il tutto risulta ancora più misterioso se si considera che, trattandosi di entità
non esistenti e carenti di una collocazione spazio-temporale, non c'è la possibilità di interagire
causalmente con esse186.
In definitiva, gli oggetti che il realista meinonghiano propone come spiegazione del modo
naturale con cui si impiegano espressioni non denotanti oggetti esistenti nel fare delle
affermazioni, comunicare stati mentali ed altro, finiscono per rendere inspiegabile la
comunicazione quando essa coinvolge le suddette espressioni, in particolare se si tratta di nomi
vuoti. Il sovraffollamento ontologico a cui conduce il meinonghianismo, ed il suo complicato
apparato metafisico, sono un prezzo troppo alto da pagare per risultati così poco soddisfacenti.
184 Si veda Zalta 2003.185 Sainsbury 2009.186 Berto 2010.
58
ENTITA' POSSIBILI NON REALIZZATE
Mondi possibili
Un altro quadro teorico a disposizione del realista entro il quale concepire l'”essere” delle entità
non esistenti è quello di concepirlo come esistenza in un “mondo diverso dal nostro”. Oggetti
quali Pegaso o Sherlock Holmes non esistono nel senso che non fanno parte del Mondo attuale,
ma esistono in altri mondi che incarnano i possibili stati in cui avrebbe potuto trovarsi il “nostro
mondo”187. Pegaso e Holmes sono entità reali, solo che esplicano le loro proprietà in un Mondo
possibile che non è quello attuale “per noi”, ma in uno che lo è per loro: un mondo tanto reale
quanto “il nostro”188. L'essere attuale non è un priivlegio del “nostro mondo”; è un concetto
relativo: “every world is actual at itself, and thereby all worlds are on a par.”189. Parlare e
pensare a entità come Pegaso e Holmes non sarebbero attività così misteriose in fin dei conti, dal
momento che, almeno in linea di principio, sarebbero attività rivolte ad entità esistenti; sarebbe
come parlare e pensare a Berlusconi o Maradona, ad esempio. Conviene, però, prima di
proseguire, precisare meglio cosa si intende per “mondi possibili”190.
La nozione di mondo possibile è, in primo luogo, uno strumento del quale ci si può servire per
spiegare in quale senso si attribuiscono valori di verità agli enunciati de dicto, nonché per
stabilire le loro condizioni di verità191. Intuitivamente, dire che un enunciato è necessario vuol
dire che è vero in qualsiasi circostanza; dire che è possibile, che è vero in alcune circostanze192.
Ma invece di parlare di circostanze, si può dire che affermare che un enunciato è
necessariamente vero significa che è vero in ogni mondo possibile; affermare che è possibile, che
è vero in almeno un mondo possibile. In questo modo, si può quantificare su mondi possibili: nel
primo caso si afferma che per un qualunque mondo M vale che l'enunciato p è vero in M; nel
secondo, che esiste almeno un mondo M tale che p è vero in M193. Interpretazioni simili si
rivelano ultili anche nel trattamento delle modalità intese come de re: una proprietà conviene in
modo necessario ad un oggetto se esso la possiede in ogni mondo in cui esiste; mentre gli
187 Voltolini 2010.188 Lewis 1986.189 Lewis 1986, p. 93.190 Per una spiegazione più tecnica di quella che si darà si veda Platinga 1974. Si veda anche Valore 2008.191 Rungalddier e Kanzian 1998.192 Valore 2008.193 Rungalddier e Kanzian 1998.
59
conviene in modo possibile o contingente, se la possiede in almeno uno dei mondi in cui esiste.
Ad esempio, Berlusconi è un essere umano in ogni mondo in cui esiste, ma non un uomo ricco,
dal momento che se certi fatti che lo riguardano e ai quali deve la sua fortuna non si fossero
verificati, allora egli non sarebbe attualmente un uomo ricco. Così, utilizzando le modalità de
dicto, se quantifica su tutti i mondi possibili; utilizzando le modalità de re, solo su quelli in cui
esiste l'oggetto del quale si predica qualcosa194. Di conseguenza, Berlusconi non è un essere
umano in tutti i mondi possibili, poiché ciò significherebbe che egli è un individuo necessario.
Berlusconi è un essere umano solo in quei mondi nei quali esiste.
Il mondo attuale potrebbe essere definito come l'insieme di tutti gli stati di cose sussistenti. Se
un mondo possibile è uno dei modi in cui il mondo attuale sarebbe potuto essere, allora un
mondo possibile è un insieme consistente ma non sussistente di stati di cose possibili195. Ma non
un insieme qualsiasi di stati di cose: tale insieme deve essere uno stato di cose massimale o
completo. Come spiega Alvin Platinga:
Let us say that a state of affairs S includes a state of affairs S' if it is not possible (in
the broadly logical sense) that S obtain and S' fail to obtain – if, that is, the conjunctive
state of affairs S but not S' (a state of affairs that obtains if and only if S obtains and S'
does not) is impossible. So, for example, Jim Whittaker's being the first American to
climb Mt. Everest includes Jim Whittaker's being an American. It also includes Mt.
Everest being climbed, something's being climbed, and no American's having climbed
Everest before Whittaker did. Similarly, a state of affairs S precludes a state of affairs
S' if it is not possible that both obtain. Thus Whittaker's being the first American to
climb Mt. Everest precludes Luther Jerstad's being the first American to climb Everest
as well as Whittaker's never havong climbed anything.196
Una volta capito ciò, resta il problema di stabilire che classe di entità sarebbe un mondo
possibile dal punto di vista ontologico197. Se è possibile quantificare su mondi allo stesso modo
che su individui, questo potrebbe indicare che i mondi possibili siano dell'entità individuali alle
quali ci si impegna ontologicamente, ma ciò non risulta del tutto ovvio198. A questo proposito
sono state avanzate due interpretazioni, una che attribuisce alla nozione di mondo possibile una
funzione meramente euristica, e un'altra che invece le conferisce uno statuto letteralmente
194 Ibidem.195 Platinga 1974.196 Platinga 1974, pp. 44-5.197 Valore 2008.198 Ibidem.
60
ontologico.
Secondo il punto di vista attualista o antirealista, un mondo meramente possibile è soltanto un
modo in cui il mondo attuale potrebbe essere. Dire che esistono mondi (meramente) possibili va
inteso nel senso che ci sono molti stati diversi nei quali si potrebbe trovare il mondo attuale, che
è l'unico mondo realizzato199. Di conseguenza, se si quantifica, lo si fa solo su ciò che esiste
attualmente. Parlare di mondi possibili è parlare, in realtà, degli oggetti di “questo nostro
mondo”, immaginando che essi si trovino in situazioni o circostanze diverse rispetto a quelle in
cui si trovano nel mondo attuale200. A rigore, un mondo possibile non è un “altro mondo”, ma
semplicemente un elenco di proposizioni che attribuiscono a degli oggetti reali proprietà che non
possiedono effettivamente201.
Il secondo punto di vista, chiamato realismo modale o possibilismo, considera i mondi possibili
come dell'entità a sé stanti, reali quanto il “nostro mondo attuale”. Vale a dire, i mondi possibili
sono inclusi nell'inventario di ciò che c'è. La realtà non sarebbe limitata al “nostro mondo”, ma
comprenderebbe una molteplicità di mondi, isolati gli uni dagli altri sia spazio-temporalmente,
sia causalmente202. Quindi, non tutti gli oggetti che esistono esistono nel mondo attuale, e la
quantificazione non sarebbe limitata agli oggetti che si trovano in esso. Ogni stato di cose
(consistente) completo possibile è un mondo reale. Così, se un individuo non fa parte del “nostro
mondo”, può benissimo far parte di un altro mondo che si possa concepire come possibilità del
primo203.
Il fatto che non si possa ingaggiare Sherlock Holmes o vedere Pegaso non significa che questi
individui non siano reali e, quindi, non posseggano le proprietà con cui li si descrive nelle storie
o nei miti. Essi sono reali e posseggono tali proprietà, solo che non le esplicano “dove” possano
essere osservati da chi comunque riesce a parlare di loro, perché sono oggetti possibili non
attualizzati rispetto al mondo attuale. I nomi vuoti sono tali solo se si restringe l'universo del
discorso al mondo attuale, ma non lo sono se l'universo del discorso comprende tutta la realtà.
Come dice Lewis, “è falso nel nostro mondo che il nome “Sherlock Holmes”, come usato nelle
storie, si riferisce a qualcuno. Eppure è vero nelle storie che questo nome, come usato nelle
199 Runggaldier e Kanzian 1998.200 Valore 2008.201 Ibidem.202 Lewis 1986.203 Sainsbury 2009.
61
storie, si riferisce a qualcuno.” 204.
Allestire mondi per l'entità non attuali
Se l'entità non attuali hanno delle proprietà che fanno di esse le cose che sono, allora hanno
bisogno di un mondo possibile all'interno del quale manifestarle, allo stesso modo in cui
Berlusconi manifesta la proprietà di essere un uomo ricco in “questo mondo”205. I miti o le storie
che parlano di tali entità, se di esse effettivamente parlano, dovranno considerarsi quali
descrizioni di un frammento dei mondi possibili che costituiscono gli scenari del loro essere, per
così dire. Allora, si dovrebbe trovare una corrispondenza tra mondi della finzione 206 e mondi
possibili; vale a dire, una corrispondenza tra racconti di situazioni e mondi in cui queste
situazioni si vedano “realizzate”. Il problema è che si tratta di un'impresa destinata a fallire: un
racconto, di qualsiasi genere esso sia, è intriso di ambguità e indeterminazione207, il che non
permette che lo si possa usare per rintracciare un mondo possibile completo e consistente.
L'intento del realista consisterebbe in trovare “ciò che è vero in una storia”, ovvero, l'insieme
sia delle proposizioni esplicite sia di quelle implicite espresse dagli enunciati che compongono
una storia, e si basa sul lavoro di David Lewis in relazione al funzionamento degli operatori
intensionali visti nel Cap. II del presente lavoro ('Secondo le storie di Sherlock Holmes...').
L'idea di Lewis è che ciò che in una storia o racconto si da per vero può venir schematizzato nel
seguente modo:
“Nell'opera di finzione F, p” è vero sse in ogni mondo possibile in cui......, p 208.
Sono state proposte due soluzioni per riempire lo spazio vuoto nello schema: il Principio di
Realtà e il Principio di mutua credenza209. Il primo principio potrebbe essere spiegato in questo
modo: se nella realtà è possibile dedurre da un fatto un altro fatto, allora possiamo farlo anche in
204 Lewis 1978, p. 176.205 Si veda Sainsbury 2009 e Voltolini 2010.206 Con 'finzione' si intenderà non solo la finzione letteraria, ma anche altre forme di “rappresentazione”, quali il
mito, la leggenda, etc. Questa pratica è usuale nella discussione sui non esistenti, anche se non sempre resaesplicita.
207 Un'ambiguità si ha quando non si è sicuri se p è vero in una storia o se lo è q; un'indeterminatezza, invece, si haquando p o q è vero nella storia, ma non sono vere né p né q. Si veda Currie 1990.
208 Sainsbury 2009.209 La divisione è presente in Walton 1990 e Bonomi-Zucchi 2003, e si basa su considerazioni fatte dallo stesso
Lewis in Lewis 1978.
62
una narrazione210. Tutto ciò che la storia non menziona o descrive come diverso rispetto al
mondo attuale, va inteso come corrispondente alla situazione del mondo attuale o alle sue leggi.
Vale a dire, i mondi da considerare sono quelli che differiscono dal mondo attuale solo nella
misura che richiede la storia per potersi verificare. Ad esempio, le storie di Sherlock Holmes non
dicono se Holmes ha un neo sulla schiena. Così, ci saranno mondi possibili, che differiscono
minimamente dal mondo attuale, in cui Holmes ha un neo sulla schiena, e mondi possibili in cui
non ha un neo sulla schiena. Il mondo in cui abita Holmes non può essere unico, poiché bisogna
che le indeterminazioni della storia possano essere, per così dire, neutralizzate.
Tuttavia, il Principio di Realtà produce delle conseguenze a dir poco strane. Si supponga che
nel mondo attuale Berlusconi, il giorno 15 di febbraio del 2014, abbia una moneta di un euro
nella tasca destra dei pantaloni. In questo caso, ogni mondo possibile in cui la storia di Sherlock
Holmes ha luogo sarebbe un mondo in cui Berlusconi ha un euro nella tasca destra dei pantaloni
il giorno 15 di febbraio del 2014, dal momento che questo fatto non ha nessuna incidenza sulle
possibilità di realizzazione della storia. Ma ciò vorrebbe dire che, secondo le storie di Sherlock
Holmes, Berlusconi ha un euro nella tasca destra dei pantaloni il giorno 15 di febbraio del 2014.
Si tratta di un risultato indesiderabile: i racconti di Holmes, intuitivamente, non hanno nessuna
connessione con Berlusconi211.
Per rendere conto di obiezioni di questo genere, si è pensato di introdurre il Principio di mutua
credenza. Ciò che è vero in una storia è ciò che sarebbe vero, secondo le credenze esplicite nella
comunità di origine, se le storie fossero narrate come un fatto conosciuto212. Qualcosa è creduto
esplicitamente da una comunità in un certo momento se e solo se più o meno tutti condividono
tale credenza, e più o meno tutti credono che più o meno tutti gli altri la condividono213. Così,
da un fatto narrato in una storia se ne può dedurre un altro se e solo se ciò è creduto in modo
reciproco nella società o comunità in cui ha origine la storia. I mondi possibili in cui, ad
esempio, Holmes abita, saranno i mondi dove le credenze esplicite della comunità alla qualle
apparteneva Conan Doyle sono vere. Naturalmente, ciò che è vero nel mondo attuale non è per
forza creduto vero, sia nel presente, sia nel passato.
Tuttavia, anche questo secondo principio conduce a delle conseguenze problematiche. Si
210 Walton 1990.211 Si veda Sainsbury 2009.212 Lewis 1978.213 Ibidem.
63
consideri questa ipotetica situazione214 : nella Germania nazista un autore scrive un'opera di
finzione in cui, tra i personaggi secondari, appare un compositore ebreo; nell'opera, lo si descrive
appena e non si esprime nessuna opinione razzista nei confronti degli Ebrei. Ma secondo il
Principio di mutua credenza, si dovrebbe concludere che 'Nel racconto il compositore ebreo
appartiene ad una razza inferiore' è un enunciato vero, il che è palesemente falso. La condizione
di credenza esplicita della collettività si rivela una condizione troppo forte: implica che si
possano tracciare con chiarezza i confini del pensiero dominante di una società, come se fosse un
insieme definito di informazioni215.
A questo punto, potrebbe sembrare ragionevole limitare a quelle dell'autore le credenze da tener
in considerazione. Tale mossa non sarebbe esente di perplessità. Infatti, si immagini che se
venisse a sapere che Conan Doyle facesse parte di una setta mistica che abbracciasse la
eccentrica concezione che la terra è piatta. E' chiaro che non per questo motivo i lettori dei
romanzi che parlano di Sherlock Holmes immagineranno il detective inglese camminando su un
pianeta piatto. Nei romanzi di Doyle non c'è nulla che possa far supporre che l'autore avesse la
suddetta credenza. E' altrettanto chiaro che ogni volta che mutino le conoscenze riguardo le
credenze di un autore, non per questo motivo si procederà a controllare se nuove verità implicite
minacciano la possibilità di trovare dei mondi possibili coerenti dove una creatura fittizia possa
esplicare le sue proprietà.
Esiste, però, un problema che concerne entrambi i principi e che sembra decisivo per stabilirne
l'inadeguatezza. Si immagini un racconto come il seguente: “Pietro era una persona molto
intelligente. La sua passione era la matematica. Un giorno, dopo intense riflessioni e calcoli,
dimostrò che due più due fanno cinque.” Pietro non potrebbe essere l'abitante di nessun mondo
possibile, dal momento che non esiste nessun mondo in cui si verifiche che due più due fanno
cinque. Quindi, Pietro non può essere un oggetto possibile non attuale216.
In definitiva, il realista che vuole, sulla base dell'analisi semantiche lewisiane, individuare dei
mondi consistenti e completi in cui collocare l'entità non esistenti, nell'intento di fare di esse
entità possibili ma non attuali, non potrà vedersi soddisfatto; a meno che eserciti una notevole
214 Bonomi-Zucchi 2003.215 Sainsbury 2009.216 C'è, nonostante, chi ha pensato a “mondi impossibili” quali scenari adatti agli oggetti impossibili. In questa
sede non si discuteranno queste posizioni, dal momento che molte delle obiezioni che si possono rivolgere alpossibilismo si possono rivolgere anche ad esse. Per una breve esposizione e critica di tali teorie si veda Voltolini2010. Si veda anche Sainsbury 2009.
64
violenza contro certe intuizioni che riguardano il linguaggio e la comunicazione. E' un errore
pensare che gli enunciati che compongono un racconto possano essere considerati come delle
verità simpliciter217. La realtà può essere pensata come determinata a prescindere dalle azioni di
chi la pensa; le storie, invece, non finiscono mai di essere modellate dalla azione di chi vi accede
e dalla comunità che le preserva218.
Problemi d'identità
Il realista, comunque, potrebbe non sentirsi vincolato all'analisi semantico incarnato dal
Principio di realtà e dal Principio di mutua credenza. Infatti, potrebbe conformarsi con qualcosa
di meno elaborato e che ricorda il Principio di comprensione meinonghiano:
Sherlock Holmes/Pegaso possiede la proprietà F in ogni mondo in cui esiste se e solo se
secondo le storie/miti , Sherlock Holmes/Pegaso possiede la proprietà F219.
Questo principio riflette l'idea che un oggetto possibile debba “realizzare” nel proprio mondo le
proprietà che gli vengono attribuite in un atto di rappresentazione che ha luogo nel mondo
attuale. Anche se può sembrare abbastanza naturale da adottare, il principio in questione rivela
facilmente la sua inefficienza. Basti pensare a Pegaso e a ciò che la mitologia greca dice riguardo
al suo peso. Nei miti greci non si fa nessun riferimento al peso di Pegaso, il cavallo alato. Allora,
la proprietà di pesare x chilogrammi non viene attribuita a Pegaso, ma nemmeno negata. Quindi,
non è il caso, secondo i miti greci, che Pegaso pesi cento o più chilogrammi; e non è il caso,
secondo i miti greci, che Pegaso pesi meno di cento chilogrammi. Secondo il principio in
questione, Pegaso non possiede un peso. Ma secondo i miti, Pegaso è un animale; per la
precisione, un cavallo. Gli animali sono entità fisiche e, come tali, hanno necessariamente un
peso determinato. Pegaso è un'entità fisica, e perciò deve necessariamente avere un peso
determinato. Quindi, nessun oggetto possibile può essere Pegaso220.
Si potrebbe, onde evitare queste complicazioni, essere ancora meno restrittivo per quanto
riguarda l'ascrizione di proprietà agli oggetti possibili, e ammettere che la descrizione del mito
217 Currie 1990.218 Ibidem.219 Sainsbury 2009. In realtà, la formulazione di Sainsbury non menziona i miti, ma si ricordi la nota 206.220 Si veda Sainsbury 2009.
65
possa essere “realizzata” in mondi diversi da oggetti possibili che esauriscano tutte le possibili
combinazioni di proprietà compatibili con la descrizione del mito o storia. Vale a dire, in ogni
mondo di questi ci sarà un oggetto possibile che rappresenta uno dei possibili modi in cui
l'”essenza” determinata dalla descrizione possa realizzarsi221. Così, ci saranno molti mondi in cui
si può trovare Pegaso: ogni Pegaso è una delle diverse possibilità aperte a Pegaso per essere tale.
Allo stesso modo in cui Berlusconi, in un mondo possibile, non è ricco, e ciò nonostante è
sempre Berlusconi, Pegaso, in un mondo possibile, pesa più di cento chilogrammi; in un altro,
pesa cento chilogrammi. E rimane sempre Pegaso. Tuttavia, se si considera che ogni oggetto
possibile è reale, allora ci sarà un Pegaso che pesa ciento chilogrammi, e ci sarà, sullo stesso
piano ontologico, un Pegaso che non pesa cento chilogrammi. Dal momento che sono lo stesso
Pegaso, si dovrà concludere che Pegaso pesa cento chilogrammi e non pesa cento chilogrammi,
il che è contradditorio. E se non sono lo stesso Pegaso, allora è difficile capire come sia possibile
identificare il Pegaso inteso nei miti222.
Le complicazioni vanno oltre a quelle appena discusse. Infatti, non solo non si può stabilire
quale tra tutti gli oggetti possibili sia Pegaso, ma nemmeno si può stabilire se questi oggetti non
rappresentino un modo possibile di essere di un'altra entità. Si consideri il seguente racconto
minimale: “Bobby è un cavallo. E' unico, perché è un cavallo alato.” Dal momento che le
proprietà attribuite a Bobby sono compatibili con quelle attribuite nel mito greco a Pegaso,
almeno alcuni dei possibili Pegaso saranno anche possibili Bobby. L'”essenza” di Bobby può, per
così dire, essere realizzata dallo stesso oggetto che realizza quella di Pegaso. Dopotutto, per
essere Bobby, si richiede l'essere un cavallo alato, cosa che gli oggetti che sono Pegaso
soddisfano automaticamente. Sul fatto di chiamarsi “Bobby”, i miti greci che parlano di Pegaso
non si pronunciano; quindi, in alcuni mondi possibili Pegaso possiede la proprietà di chiamarsi
(anche) “Bobby”. Ma tutto ciò, naturalmente, non autorizza a dire che Bobby è Pegaso. Tali
stranezze arrivano a coinvolgere oggetti attuali, come notò acutamente Saul Kripke:
La semplice scoperta che esisteva veramente un detective le cui gesta assomigliavano
a quelle di Sherlock Holmes non dimostrerebbe che Conan Doyle scriveva su
quest'uomo; è teoricamente possibile, anche se in pratica è improbabile, che quanto
Doyle scriveva fosse pura fantasia che solo per coincidenza assomigliava alla realtà. (Si
pensi alla caratteristica smentita: “I personaggi di questo lavoro sono immaginari e ogni
somiglianza con qualunque persona, vivente o defunta, è puramente accidentale.”)
221 Sainsbury 2009.222 Ibidem.
66
Analogamente, io sostengo la posizione metafisica secondo cui, concesso che non
esiste uno Sherlock Holmes, non si può dire di nessuna persona possibile che essa
sarebbe stata Sherlock Holmes, se egli fosse esistito. Diverse persone possibili distinte,
e persino alcune persone reali, come Darwin o Jack lo squartatore, avrebbero potuto
compiere le gesta di Holmes, ma non ce n'è nessuna di cui possiamo dire che sarebbe
stata Holmes se avesse compiuto queste gesta. Infatti, in tal caso, chi sarebbe?223
Sembrerebbe che ci siano profonde difficoltà concettuali nell'idea che si possa identificare un
individuo possibile con un altro. Vale a dire, la nozione che un oggetto possa esistere in diversi
mondi possibili manca di un criterio chiaro che stabilisca come riconoscere un individuo in un
mondo dove ha proprietà diverse rispetto al mondo che si considera attuale224. Se si usassero le
proprietà attraverso le quali si identifica un oggetto in “questo mondo”, non si arriverebbe
lontano. Ad esempio, si supponga che Socrate esiste in un mondo possibile distinto da questo
mondo. In tale mondo alternativo Socrate detestò la filosofia, non corruppe nessuno, non fu il
mentore di Platone e non bevette la cicuta. Tutte queste proprietà , nel mondo attuale,
permettono di identificare Socrate, distinguendolo da altri individui attuali. Ma nel mondo
alternativo ipotizzato, queste caratteristiche potrebbero appartenere a qualcuno che non le
possiede nel mondo attuale. Forse in quel mondo è Xenophon a possederle. E' chiaro che non si
intende parlare di Xenophon, ma di Socrate. Così, le proprietà usate comunemente per
rintracciare Socrate nel mondo attuale non permettono che lo si faccia nel altro mondo.
Nonostante ciò, se si vuole distinguere Socrate dagli altri individui possibili, si dovrebbe trovare
un insieme di proprietà in grado di distinguerlo in qualsiasi situazione possibile in cui egli sia
presente. Il criterio, allora, deve consistere in alcuna proprietà che Socrate possieda in ogni
mondo in cui esiste, e che in nessun mondo possibile sia posseduta da un'entità diversa da
Socrate225. Ma è ovvio che non si sa quale potrebbe essere questa proprietà, e nemmeno se ci
sia. Siccome non si conosce tale proprietà, ne segue che non si è capaci di identificare Socrate in
un mondo che non sia quello attuale; di conseguenza, l'affermazione secondo cui Socrate esiste
in un mondo possibile diverso dal mondo attuale è incomprensibile, poiché non si sa di chi si sta
parlando226.
223 Kripke 1980, pp. 147-8.224 Questo è il cosiddetto problema dell'identità attraverso mondi. Si veda Platinga 1974 per una spiegazione
approfondita del problema. Per una “soluzione “si veda Kripke 1980. (Kripke non gli riconosce lo status diproblema).
225 Platinga 1974.226 Ibidem.
67
La teoria delle controparti
Considerazioni come quelle analizzate nella sezione precedente portarono Lewis a elaborare la
sua teoria delle controparti. Secondo questa teoria realista, gli individui dei mondi possibili
diversi dal mondo attuale (“nostro mondo”) non sono i medesimi individui del mondo attuale.
Anzi, nessun mondo condivide i propri individui con nessun altro mondo: “nulla è in due
mondi”227. Una controparte potrebbe essere definita come l'individuo x diverso dall'individuo y
ma simile a quest'ultimo sotto qualche aspetto rilevante, che esisterebbe in luogo di y se le cose
fossero andate in un modo diverso da come sono andate nel mondo a cui appartiene y. Quindi,
una controparte è il corrispettivo x in un mondo M di un individuo y in un mondo M', e x è
diverso da y se M è diverso da M'228. In questo modo, la problematica idea di stabilire l'identità
o meno di individui reali ma collocati in mondi altrettanto reali ma diversi, non sarebbe più un
problema per il realista, dato che un individuo non può che essere identico solo a se stesso;
individui appartenenti a mondi diversi, saranno sempre individui differenti e, quindi, non è
sensato chiedersi se sono lo stesso individuo o meno.
Così, la concezione intuitiva di poter descrivere le diverse possibilità o circostanze in cui
avrebbe potuto trovarsi un individuo, in termini di variazioni tra mondi possibili, deve essere re-
interpretata . Il fatto che Berlusconi avrebbe potuto essere un uomo povero deve essere inteso
come il fatto che Berlusconi possiede, in un mondo diverso da quello attuale, una controparte
che è un uomo povero. Non esiste una relazione d'identità tra Berlusconi e la sua controparte, ma
solo una relazione di somiglianza. Come spiega Lewis:
Mentre qualcuno direbbe che voi siete in parecchi mondi, nei quali avete proprietà un po'
diverse e vi accadono cose un po' diverse, io preferisco dire che voi siete nel mondo
attuale e in nessun altro, ma che avete controparti in parecchi altri mondi. Le vostre
controparti vi somigliano strettamente per contenuto e struttura sotto importanti aspetti.
Essi vi somigliano più strettamente che le altre cose presenti nei loro mondi, ma non sono
realmente voi. [...] Sarebbe meglio dire che le vostre controparti sono uomini che voi
saresti stati, se il mondo fosse stato diverso.229
Sembrerebbe naturale pensare che c'è qualcosa di ovviamente sbagliato in questo modo di
vedere le cose. Quando si parla di ciò che avrebbe potuto capitare a Berlusconi, si intende
227 Lewis 1968, p. 92.228 Valore 2008.229 Lewis 1968, p. 93.
68
parlare di Berlusconi, di qualcosa che avrebbe riguardato lui e non un altro individuo
(controparte) diverso230. Nonostante ciò, il realista può sostenere che un nome come 'Berlusconi'
in realtà denota diversi oggetti rispetto a differenti mondi possibili. In questo “nostro mondo”,
denota un particolare individuo; in altri mondi, particolari individui esistenti in quei mondi,
abbastanza simili all'individuo presente in “questo mondo” da essere considerati le controparti di
quest'ultimo. Si tratterebbe semplicemente di un problema di vaghezza relativo al linguaggio e al
pensiero umano231. Si pensi all'espressione 'l'outback' (l'entroterra australiano). La ragione per
cui è non si può determinare dove inizia o finisce l'entroterra australiano non si deve al fatto che
ci sia un oggetto indefinito, con confini indeterminati, chiamato 'l'outback'; si deve, invece, al
fatto che ci sono molti oggetti, con confini determinati, e “nobody has been fool enough to try to
enforce a choice of tone of them as the official referent of the word 'outback.”232. Così, non ci
sarebbe una risposta, a livello metafisico, alla domanda su quale è il riferimento ultimo di
'Berlusconi'233. E, naturalmente, nemmeno a quella relativa al nome 'Sherlock Holmes'234. Il
realista non è più tenuto ad essere in grado di individuare univocamente, in termini di proprietà
possedute, l'oggetto a cui ci si riferisce con un nome “vuoto”.
Tuttavia, rimpiazzare la nozione d'identità per quella di somiglianza, con l'intento di giustificare
la possibilità di parlare degli individui non attuali, conduce a situazioni paradossali. Nel caso di
Berlusconi, 'Berlusconi' denoterà tutte le controparti di Berlusconi235 . Ma ciò sarà possibile
perché l'insieme delle controparti sarà generato a partire dell'individuo attuale che fa parte
dell'insieme. Lewis segnala che la relazione di controparte non è simmetrica236. Quindi, la
controparte di Berlusconi in un altro mondo W non necessariamente ha come controparte
Berlusconi237. Così, la capacità di denotare il Berlusconi di W che ha 'Berlusconi' dipende dal
fatto che con 'Berlusconi' ci si riferisca prima a Berlusconi in “questo” mondo, e non a quello di
W. Il Berlusconi attuale deve, in qualche modo, fissare il riferimento di 'Berlusconi'. Altrimenti,
si rischierebbe di usare tale nome per parlare delle controparti del Berlusconi di W, tra le quali
non si troverà necessariamente il Berlusconi attuale. Il problema è che nel caso dei nomi vuoti,
come 'Pegaso' o 'Sherlock Holmes', non si ha la possibilità di “scegliere”, per così dire, il mondo
di riferimento, dal momento che il mondo attuale è isolato metafisicamente dagli altri mondi.
230 Si veda Kripke 1980.231 Lewis 1986.232 Lewis 1986, p. 212.233 Si veda Sainsbury 2009.234 Sainsbury 2009.235 Un individuo è controparte di se stesso. Si veda Lewis 1968.236 Lewis 1968.237 Ibidem.
69
Non avrebbe senso dire che uno di quei mondi possibili ha un qualche privilegio epistemologico
rispetto ad un altro. Di conseguenza, se uno dei Sherlock Holmes che denoterebbe 'Sherlock
Holmes' ha come controparte il commissario Montalbano, si dovrà ammettere che quando si
parla di Sherlock Holmes si parla anche del commissario Montalbano, il che è assurdo.
Un altro problema che affligge la teoria di Lewis è che la nozione di somiglianza è troppo vaga
e oscura. Dopotutto, ogni cosa è simile ad ogni altra sotto qualche punto di vista 238. Quindi,
sostenere una rassomiglianza senza indicare di quale tipo di rassomiglianza si parla è privo di
significato239. Non è facile stabilire quali proprietà di un individuo siano rilevanti per determinare
quale sia la controparte di esso240. Ad esempio, se si considerasse che le proprietà più importanti
di Aristotele consistano nel suo lavoro filosofico, allora le controparti di Aristotele non
potrebbero essere non filosofi. Ma, in questo caso, dire che Aristotele avrebbe potuto non
dedicarsi alla filosofia sarebbe dire il falso. Tuttavia, è chiaro che Aristotele avrebbe potuto non
fare nessuna delle cose che si ritiene abbia fatto241.
238 Valore 2008.239 Ibidem.240 Kripke 1980.241 Ibidem.
70
RIFERIMENTO SENZA REFERENTI
Comprendere i nomi propri
Nonostante i realisti, malgrado i loro giochi di prestigio logici e metafisici, non riescano a dare
una risposta soddisfacente al problema dei nomi vuoti, gli irrealisti non sembrano essere in una
posizione migliore. Infatti, quest'ultimi, come si è visto, devono affrontare un dilemma di
difficile soluzione. Se il contributo semantico di un nome proprio è una certa informazione
esprimibile attraverso una descrizione definita, allora comprendere un nome vuoto non
comporterebbe particolari difficoltà. Tuttavia, questa elegante soluzione viene smentita dal reale
comportamento dei nomi propri: il nome svolge la sua funzione referenziale anche se tutta
l'informazione sul referente (in possesso dei parlanti) non è vera di esso. Questo fatto porta a
considerare che il contributo semantico dei nomi non è altro che l'oggetto per cui un nome sta.
Comprendere un nome consisterebbe in entrare in un particolare tipo di rapporto causale con il
portatore del nome. Ma questa alternativa teorica conduce all'altro corno del dilemma: come
spiegare l'intelligibilità dei nomi vuoti se non esiste i loro portatore?242 Riservare un trattamento
semantico separato ai nomi vuoti non porta lontano, dal momento che, come a questo punto del
presente lavoro dovrebbe risultare chiaro, non c'è un modo di distinguere a priori se un nome ha
referente o meno.
Secondo R.M. Sainsbury, nel suo Reference without Referents del 2005, questo dilemma non
esaurisce le opzioni disponibili nello spazio logico delle possibili teorie semantiche. Per
Sainsbury, sebbene è vero che non c'è una particolare informazione descrittiva che debba essere
posseduta per comprendere un nome proprio, ciò non significa che comprendere un nome
proprio è possibile soltanto se tale nome ha un portatore. Esiste una posizione intermedia, in
grado di conciliare le intuizioni più importanti dei teorici del riferimento diretto con quelle di chi
difende posizioni alla Russell-Frege. Si tratta di un “minimal Fregeanism, which accepts sense
242 Un altro noto problema che affrontano le teorie causali del riferimento è quello di spiegare il contenutocognitivo diverso che possiedono enunciati quali 'Espero = Espero' e 'Espero = Fosforo'. Se il contributo deinomi si esaurisce nell'oggetto a cui essi si riferiscono, non è facile spiegare il fatto che entrambi gli enunciati non“dicano” lo stesso. Se, invece, i nomi fossero associati a delle descrizioni, il problema non si presenterebbe: duenomi co-referenziali avranno significati diversi.
71
without modes of presentation”243. Sainsbury elabora una proposta semantica che permette agli
enunciati contenenti nomi vuoti di essere intelligibili ed avere un valore di verità, senza che
comprendere tali nomi consista in “afferrare” una condizione in termini descrittivi. Tale proposta
consiste in assegnare a tutti gli nomi propri, abbiano referente o meno, condizioni di riferimento
(reference conditions) non descrittive244. Comprendere il significato di un nome proprio non è
essere in grado di associare ad esso una particolare informazione capace di discriminare un
oggetto tra gli altri, ma conoscere che sarebbe per qualcosa essere il portatore di tale nome.
Sainsbury illustra il punto con delle analogie:
The analogues of knowing the referent of a name are knowing which things a
predicate applies to and knowing which truth-value a sentence posseses. Such
knowledge goes beyond, and also falls short of, what understanding requires. A special
case would be needed for marking the strong requirement for names, treating them
differently from other expressions. The customary view is that understanding a
sentence involves knowing what it would be for something to satisfy it. I do not
challenge this view (it requires only explanation and elaboration rather than rejection);
extending it to names delivers RWR: understanding a name involves knowing what it
would be for something to be its bearer.245
Così, il significato di un nome non viene identificato con il referente dello stesso, ma con le sue
condizioni di riferimento, allo stesso modo in cui il significato di un enunciato viene identificato
con le sue condizioni di verità. Un nome può avere un significato (un “senso”) senza avere un
referente, così come un enunciato può avere un significato anche se non è vero. Il fatto che un
nome non abbia un referente non significa che esso non sia un “autentico” nome, nel senso di
Russell: tutti i nomi sono espressioni referenziali e, quindi, hanno come funzione propria quella
di riferire. Ciò gli permette di avere delle condizioni di riferimento, anche quando le circostanze
del Mondo non consentano loro di assolvere la loro funzione, per così dire, naturale. I cuori, ad
esempio, tipicamente hanno la funzione di pompare del sangue nell'organismo; tuttavia, a volte
non riescono a farlo, e non per questo motivo si dirà che non si tratta di autentici cuori246.
Per stabilire quali sono le condizioni di riferimento dei nomi propri in un modo esplicito e
243 Sainsbury 2005, p. 15244 Sebbene siano i problemi riguardanti i nomi vuoti quelli da cui prende avvio la riflessioni di Sainsbury, la idea
generale trova applicazione anche nei casi di pronomi e descrizioni definite. (Quest'ultime sono considerate daSainsbury termini referenziali). Si veda Sainsbury 2005. Si veda anche Sainsbury e Tye 2012.
245 Sainsbury 2005, p. 94.246 Sainsbury 2005.
72
teoricamente rigoroso, l'autore di Reference without Referents sviluppa un'idea di Mc Dowell
secondo la quale, per un determinato nome N, è possibile intendere la domanda 'a cosa si
riferisce N?' in due modi diversi247. Da un lato, potrebbe essere intesa come se indagasse su un
certo oggetto. Ad esempio, se il nome fosse 'Espero', l'oggetto indagato sarebbe Espero/Fosforo.
Dall'altro, potrebbe essere intesa come se ci si aspettasse una risposta di tipo proposizionale. In
quest'ultimo caso, la risposta corretta sarebbe che 'Espero' si riferisce a Espero, e non che
'Espero' si riferisce a Fosforo, perché la risposta attesa non soltanto deve dire quale è il referente
del nome, ma anche mostrare in quale modo il parlante pensa a tale referente: la risposta deve
rivelare il modo in cui il parlante si rappresenta la conoscenza richiesta per comprendere il
nome. Secondo McDowell, conoscere le risposte di quest'ultimo tipo per un certo linguaggio L,
permetterebbe di conferire un senso ai proferimenti dei parlanti competenti di L, dal momento
che tali risposte possono essere considerate come assiomi di una teoria semantica
interpretativa248 di L. Così, anche se le seguenti proposizioni hanno lo stesso valore di verità,
(1) 'Espero' si riferisce a Espero
(1') 'Espero' si riferisce a Fosforo
solo (1) può essere un assioma che introduca 'Espero' in una teoria semantica interpretativa249,
dato che chi usa 'Espero' per riferirsi a Espero/Fosforo sa che si riferisce a Espero, ma può non
sapere che si riferisce a Fosforo.
Il problema di questa impostazione è che gli assiomi come (1) possono essere veri soltanto a
patto che ci sia un riferimento per il nome proprio di cui si vuole dare il significato. Infatti, se si
volesse introdurre così un nome vuoto quale 'Pegaso', si otterrebbe:
(2) 'Pegaso' si riferisce a Pegaso,
il che è falso, dato che, non esistendo Pegaso, il nome non si riferisce ad alcunché. Per tanto, (2)
247 Si veda McDowell 1977.248 Una teoria semantica interpretativa è quella che si serve di una teoria della verità come di una teoria del senso.
Se si conosce una teoria della verità che comporta per ogni enunciato di un linguaggio L un teorema della forma'l'enunciato di L s è vero sse p' e si conosce anche che questa teoria è confermata dal comportamento verbale deiparlanti di L, allora è possibile usare tale teoria come una teoria del significato.
249 A rigore, l'assioma non è (1), ma '”Espero” si riferisce in italiano a Espero'. L'italiano è il linguaggio L diriferimento. Tuttavia, l'esposizione non risentirà dell'imprecisione.
73
non sarebbe di aiuto per comprendere il senso di 'Pegaso'.
Sainsbury cerca assiomi che possano essere veri a prescindere dal fatto che i nomi abbiano un
referente o meno. Solo in questo modo è possibile una teoria del significato generale per i nomi
propri che sia in grado di trattare nomi vuoti e non vuoti alla pari. A questo punto è che si fa
avanti l'idea di introdurre degli assiomi che esprimano non a cosa si riferisce un nome, ma a
quali condizioni lo farebbe. Così, invece di (1) e (2), gli assiomi per 'Espero' e 'Pegaso' saranno:
(3) ∀x (' Espero ' si riferisce a x≡x=Espero)
(4) ∀x( ' Pegaso ' si riferiscea x≡x=Pegaso)
Tuttavia, questa manovra non è sufficiente, dal momento che da (4), per generalizzazione
esistenziale, è possibile inferire:
(5) ∃y∀x (' Pegaso ' si riferisce a x≡x=y)
il che conduce ad ammettere che c'è un y tale che è Pegaso. 'Pegaso' non sarebbe, dopotutto, un
nome vuoto. In realtà,il problema si presenta solo si se considera che il linguaggio naturale sia
sorretto da una logica di tipo classico; vale a dire, da una logica che ammette solo tra le sue
costanti espressioni a cui corrisponde un elemento del dominio del discorso250. Sainsbury, allora,
propone l'idea che la logica che regge il linguaggio naturale è una logica libera (free logic)251.
Una tale logica è una logica che ammette espressioni ritenute intuitivamente intelligibili senza
esigere per esse un correlato oggettivo all'interno del dominio della quantificazione. Vale a dire,
una logica libera da presupposizioni esistenziali: non si può passare da 'Pa' a ' ∃ x (Px )' senza
premesse addizionali. Per Sainsbury, questa premessa è ' ∃ x ( x=a )' . In questo modo, da (4)
non segue che ci sia qualcosa come Pegaso.
La versione della logica libera che fa al caso della teoria semantica in esame è quella negativa.
Tale logica prevede che ogni enunciato semplice contenenti espressioni referenziali vuote sia
falso252. La scelta dovrebbe essere chiara: affinché (4) possa essere vero, come lo è (3), il
250 Dumitru e Kroon 2008.251 Sainsbury 2005.252 In una logica libera positiva, essi sono a volte veri, mentre in una logica libera fregeana sono privi di valori di
verità.
74
bicondizionale dovrà essere vero in qualsiasi interpretazione di 'x'. Dal momento che 'Pegaso'
non riferisce ad alcunché, il che rende sempre falso il primo membro del bicondizionale,
soltanto se 'x = Pegaso' è sempre falso si potrà ottenere la verità della proposizione complessiva.
In definitiva, la combinazione delle intuizioni semantiche di McDowell con la logica libera
negativa permette a Sainsbury di elaborare una teoria del significato dei nomi propri che
partecipa dei vantaggi delle concezioni descrittiviste e di quella dei teorici del riferimento
diretto, senza avere i loro inconvenienti. Gli assiomi di introduzione dei nomi non fanno appello
a informazione di natura descrittiva di nessuna classe; soltanto fanno corrispondere ad ogni
nome una condizione di riferimento, qualcosa che deve essere vero di un oggetto affinché tale
nome si riferisca ad esso. La condizione, ad esempio, perché un oggetto x sia nominato da
'Pegaso' è che tale oggetto x sia Pegaso253. Siccome nessun oggetto soddisfa questa condizione,
'Pegaso' non nomina nulla, anche se è un nome. Il fatto che sia un nome senza referente, d'altra
parte, non fa venir meno la sua rigidità: se 'Pegaso' si riferisce a Pegaso nel mondo attuale,
allora non ci sono circostanze di valutazione in cui 'Pegaso' si riferisca ad altro che non sia
Pegaso254. I nomi, siano vuoti o meno, hanno un senso che è “singular in what they (purport to)
pick out”255. Vale a dire, i nomi propri conservano quella “specificità” che li distingue dalle
descrizioni definite. Ciò nonostante, dato che i nomi non presuppongono un oggetto come
referente, le distinzioni di ambito russelliane permettono enunciati veri in cui essi occorrono. Ad
esempio, 'Pegaso non esiste' è vero, perché equivale a 'E' falso che Pegaso esiste'. 'Pegaso esiste'
(un enunciato semplice con cui ci si impegna all'esistenza di Pegaso) è falso, come vuole la
logica negativa libera; la sua negazione (un enunciato complesso con cui non ci si impegna
all'esistenza di alcunché) produce una verità256. In questo senso, i nomi possono essere trattati
come descrizioni: l'impegno ontologico si presenta solo quando il nome occorre in ambito
primario, come nel caso di 'Pegaso esiste'.
Arrivare a comprendere un nome proprio
Per comprendere un nome proprio, come si è visto, si deve conoscere la sua condizione di
riferimento. Nonostante ciò, deve essere chiarito come fa un parlante a riconoscere a quale
253 Sainsbury 2005. Questo potrebbe far pensare in una posizione come quella di Quine, ma a differenza diquest'ultimo, per Sainsbury il nome si comporta come una costante logica, e non sta per un predicato.
254 Ibidem.255 Dumitru e Kroon 2008, p. 101.256 La logica libera negativa preserva il principio di bivalenza.
75
condizione di riferimento fa appello un altro parlante che dice, ad esempio, 'Aristotele era un
pazzo', considerando che con 'Aristotele' si potrebbe voler far riferimento ad Aristotele Onassis o
al filosofo macedone. E' chiaro che se si intende il primo non si può intendere il secondo: le
condizioni di riferimento sono diverse; altrimenti, non sarebbe possibili determinare il
significato di 'Aristotele era un pazzo'. In altre parole, non si saprebbe a chi si sta attribuendo la
proprietà di essere pazzo, e la comunicazione sarebbe inspiegabile. Gli stessi assiomi semantici
associati ai due 'Aristotele' sono tipografica e foneticamente identici, quindi, essi non possono
essere di grande aiuto. All'interno del quadro teorico di Sainsbury, non avrebbe senso spiegare le
intenzioni comunicative del parlante appellandosi a un contenuto informativo (soddisfatto
esclusivamente dall'individuo inteso) implicito nel uso concreto di 'Aristotele' che questi, in
qualche modo (forse grazie al contesto), riesce a “rivelare”. Nemmeno avrebbe senso dire che il
parlante riesce a farsi comprendere perché riesce a evidenziare la catena causale che collega il
suo uso di 'Aristotele' con uno degli Aristotele e non con l'altro, giacché questa mossa lascerebbe
senza spiegazione l'uso dei nomi vuoti, introducendo così distinzioni sospette nel modo di
trattare quest'ultimi257. Dopotutto, si deve poter spiegare anche come è possibile distinguere l'uso
di 'Vulcano' per parlare del pianeta postulato da Le Verrier dall'uso che se ne fa nella serie
Startrek.
Sainsbury propone di rendere intelligibile l'uso dei nomi propri appellandosi ad una nozione
particolarmente robusta di pratica di uso di un nome (name-using practice). Ogni nome (i nomi
sono diversi anche se fisicamente identici)258viene individuato da una pratica di uso e, a sua
volta, ogni pratica viene individuata metafisicamente da un atto di “battesimo”. Come spiega
Sainsbury:
A baptism has at most one referent. Each name-using practice involves exactly one
baptism; baptisms metaphysically individuate practices, and thus fix the referent, if any, of
a practice, thought when we wish to know to which practice a given use of a name belongs,
or what the referent of a practice is, it is rare that we can reach an answer by first
identifying the baptism. Normally our evidence is associated information, even though this
is evidence only, and does not make a practice the practice it is. 259
Così, differenti battesimi che coinvolgono il segno N, individuato tipografica o foneticamente,
danno luogo a differenti nomi N, ogni uno dei quali ha una propria storia alle spalle: la pratica di
257 Textor 2010.258 Si veda , per interessanti delucidazioni in merito, Sainsbury e Tye 2012.259 Sainsbury 2005, p. 106.
76
uso che lo collega al battesimo che gli diede origine e fissò, contemporaneamente, la sua
condizione di riferimento. Afferrare il senso del nome che un parlante intende con il suo uso di
esso si riduce a riconoscere la pratica di uso che il parlante intende continuare, e questa
continuazione “is to be judged in part in the light of how we can best make sense of a
speaker”260. Quindi, riconoscere la pratica di uso alla quale si sta partecipando, in modo di
afferrare il senso di N, non comporta essere in grado di individuare metafisicamente tale pratica,
ma di individuarla epistemologicamente, il che si può fare, generalmente, grazie all'informazione
che essa veicola e che la distingue da altre pratiche261. Naturalmente, tale informazione non è ciò
che da il senso di N, dal momento che potrebbe risultare in parte o totalmente falsa. In sintesi,
una pratica “can be thought of as a set of uses with a baptism, B, and containing all the uses
initiated by B and by any member of the B-practice, and all the uses standing in the continuing-
participation relation to any uses in the practice”262.
Sainsbury definisce meticolosamente 'battessimo', affinché il termine sia applicabile anche
quando non ci sia un oggetto coinvolto. Egli sostiene che chi effettua un battesimo può avere due
tipi di intenzioni: oggettuali (object-involving) e descrittive. Le prime consistono nell'intenzione
che, per un determinato oggetto x, x si chiami N; le seconde, nell'intenzione che il P, qualsiasi
esso sia, si chiami N. Di norma, entrambi i tipi di intenzioni vanno della mano: l'oggetto sul
quale si “proietta” l'intenzione oggettuale è lo stesso di quello che soddisfa l'intenzione
descrittiva. Così, per esempio, la donna primipara che battezza con il nome 'Giovanni' il
bambino che ha appena partorito, avrà l'intenzione di chiamare 'Giovani' “questo bimbo qui” e,
simultaneamente, l'intenzione di chiamare 'Giovanni' “il mio primo figlio”. A volte, tuttavia, il
parlante è privo di intenzioni oggettuali, anche se crede di averle263, e nessun oggetto soddisfa la
descrizione delle sue intenzioni descrittive. In questo caso, il battesimo non riesce a a nominare
nulla e si inaugura la pratica di un nome vuoto. Il battesimo riesce a introdurre un nome
significativo, anche se non c'è un oggetto che acquisisca tale nome. Anche se il parlante possiede
effettivamente soltanto delle intenzioni descrittive, questo non vuol dire che il nome introdotto
finisca per diventare una descrizione definita. Così come non ci si può aspettare che, tornando
all'esempio di cui sopra, chiunque usi 'Giovanni' intenda 'il primo figlio di M' (Giovanni può
propagare il uso del proprio nome senza fare riferimento ai fatti inerenti alla sua famiglia); non
ci si può aspettare che chiunque parli di Vulcano (il pianeta postulato da Le Verrier) intenda 'il
260 Ivi. p. 118.261 Sainsbury 2005.262 Sainsbury 2005, p. 112.263 Le intenzione oggettuali possono anche venir presupposte, come nel caso in cui uno scrittore introduce un
nome fittizio. Si veda Sainsbury 2009.
77
pianeta intra-mercuriale' con l'uso di 'Vulcano'. Ad esempio, un individuo potrebbe dire “So che
Vulcano è un pianeta postulato da Le Verrier, ma non so altro”, e non si direbbe che egli non
intendesse “parlare della stessa cosa” di cui parlava Le Verrier quando postulò l'esistenza di
Vulcano. Persino, non è difficile immaginare un futuro ipotetico in cui nessuno sappia rendere
conto dell'evento che diede origine alla pratica del nome264. Il fatto che Le Verrier avesse
l'intenzione di fare di 'Vulcano' il nome di qualsiasi x che fosse il pianeta intra-mercuriale non fa
di tale condizione descrittiva il significato di 'Vulcano'. Al contrario di quanto pensa Kripke,
non è necessario che ci sia un oggetto all'inizio della pratica di uso dei nomi propri.
Potenziare la strategia antirealista
Si era visto come, per evitare di rendere conto della verità che un enunciato quale 'Eros è il dio
dell'amore' può esprimere in determinate contesti, l'irrealista, onde evitare l'impegno ontologico
a entità non esistenti (o esistenti “fuori da questo Mondo”) per spiegare tale dato, si appellasse
alla presenza implicita di un operatore non vero-funzionale. In questo modo, l'enunciato veniva
considerato come l'espressione ellittica di
(6) Secondo il mito greco, Eros è il dio dell'amore.
Così, era possibile un'interpretazione de dicto dell'enunciato, in cui la descrizione che rende il
contributo semantico di 'Eros' fosse data in modo secondario. (6) è vero, è ciò non dipendeva dal
fatto che esistesse o meno un individuo che rispondesse alla descrizione implicita nell'uso di
'Eros'. Fortunatamente per l'antirealista, il fatto che i nomi non siano descrizioni camuffate non
compromette la riuscita della mossa. Infatti, come si è visto, anche i nomi propri possono
figurare in un enunciato con valore di verità senza presupporre entità di riferimento per essi, allo
stesso modo in cui lo fanno le descrizioni. L'enunciato semplice o atomico 'Eros è il dio
dell'amore', preso isolatamente, dato che non esiste Eros, è falso, come vuole la logica negativa
che governa l'uso del linguaggio naturale. Invece, se incorporato all'interno di una proposizione
complessa come (6), il suo valore di verità diventa ininfluente ai fini di stabilire il valore di
verità di questa, il che è coerente con i principi della logica negativa265.
264 Si veda Sainsbury e Tye 2012.265 Sainsbury 2005.
78
Nonostante ciò, ci sono casi in cui non sembra fattibile applicare la mossa di introdurre un
operatore intenzionale. L'enunciato
(7) Sherlock Holmes è un personaggio fittizio
non sembra essere il rapporto ellittico di come stiano le cose secondo una opera di finzione o un
mito; sembra, invece, voler dire come stiano le cose nel “Mondo reale”. Siccome (7) è
indubbiamente vero preso letteralmente e, stando alle apparenze, ha la forma di un enunciato
atomico in cui si attribuisce una proprietà ad un individuo, la sua verità sembrerebbe comportare
che ci sia Sherlock Holmes. Per di più, Holmes non sarebbe un esistente, giacché è un'entità
fittizia. Il realista potrebbe ritenersi in una posizione inespugnabile.
In realtà, (7) è letteralmente vero, ma questo fatto non significa che non ci sia presente in esso
un operatore intensionale. Sebbene il termine 'fittizio' è un aggettivo, la sua funzione non è
quella ordinaria di restringere, per così dire, il raggio di azione del sostantivo sul quale viene
applicato266. Si consideri la classe di tutti i detective. Se si prendessero da questa classe tutti i
membri che fossero anche non fittizi, la classe rimarrebbe vuota. Ma se ci fossero detective
fittizi, questa situazione non dovrebbe presentarsi. Il termine 'fittizio' è un operatore che
potrebbe essere reso da 'In alcune finzioni'267. Così, dire qualcosa come 'Ci sono personaggi
fittizi' non impegna, malgrado le apparenze, a riconoscere la realtà di nessun tipo di entità, dal
momento che non si avrebbe detto altro che 'In alcune finzione, ci sono personaggi'268. Seguendo
questa linea di ragionamento, (7) diventerebbe, come lascia a intendere Sainsbury,
(7') In alcune finzioni, Sherlock Holmes è un personaggio.
Tuttavia, questa formulazione non è del tutto soddisfacente, dal momento che non riesce a
rendere l'idea, implicita nell'uso corrente di 'fittizio', che Holmes non esiste. Si consideri la
situazione seguente: Napoleone, come è noto, appare nel romanzo Guerra e Pace, e questo fatto
fa si che 'In alcune finzioni, Napoleone è un personaggio' sia vero. Sebbene quest'ultimo
enunciato non richieda l'ammissione dell'esistenza di Napoleone, nemmeno la vieta. Infatti, chi
credesse vero tale enunciato potrebbe tranquillamente riconoscere la verità di quest'altro:
266 Sainsbury 2009. Si veda anche Williams 1981.267 Sainsbury 2009.268 Ibidem. Come è facile supporre, criteri simili si applicherebbero nel caso di aggettivi quali 'mitologico' o
'ipotetico'.
79
'Napoleone, in alcune finzione, è un personaggio'. Così, anche se esiste, Napoleone sarebbe un
personaggio fittizio, il che è chiaramente falso. Per evitare questa conseguenza assurda, si
potrebbe proporre la seguente interpretazione di (7):
(7'') (In alcune finzioni, Sherlock Holmes è un personaggio) ˄ ¬∃x (x=Sherlock Holmes)
Come non è difficile capire, (7'') riesce a rispettare le intuizioni dei parlanti riguardanti l'uso del
termine 'fittizio' e, nel contempo, non concede a Sherlock Holmes nessun “essere” al di là
dell'esistenza.
Ci sono casi, però, in cui un enunciato contenenti nomi vuoti non fa riferimento a nessuna
storia né incorpora un aggettivo non ordinario, eppure riesce a imporsi intuitivamente come
vero. Un esempio è costituito dall'enunciato metafittizio:
(8) Anna Karenina è più intelligente di Emma Bovary
In effetti, non esistono finzioni secondo le quali (8) sia vero, ed 'essere più intelligente di'
introduce una relazione che solo può sussistere se vi sono due oggetti che costituiscano i suoi
termini. La verità di (8) comporterebbe, quindi, la realtà dei personaggi che esso menziona.
Il problema è causato dal non rendersi conto che, sebbene(8) è letteralmente falso, nonostante
ciò è possibile considerarlo dalla “prospettiva” che, per così dire, autorizzerebbe a ritenerlo vero.
La “verità” di (8) è, così, solo una verità relativa ad una presupposizione269. Sainsbury,
considerando un caso analogo a quello rappresentato da (8), spiega il concetto:
An irrealist should not simply declare that “The Greeks worshiped Zeus” is false. An
explanation must be given of why it has so often struck both ordinary people and
theorists as true. The suggestion I'll consider is that, for the purposes of conversation,
and sometimes for the purposes of thought, we may presupose things which we know
are not true, and can evaluate other propositions as true or false relative to these
propositions. In the present case, we presupose something we know to be false, that
there is such a god as Zeus; we can evaluate the sentence about the Greeks as true
relative to this presuposition. [...] By contrast, the Greeks didn't seem to pay much
attention to Juno. So even presupposing that there is such a godess, we evaluate “The
269 Sainsbury 2009.
80
Greeks worshiped Juno” as false; a fortiori, it's false if we bracket the presupposition.270
All'interno dell'ambito della presupposizione, è possibile distinguere il vero dal falso, ciò che è
ovvio da ciò che è improbabile, nello stesso modo in cui lo si fa quando si opera senza
presupposizioni che non rispecchiano le proprie credenze. Siccome non c'è inconsistenza nel
credere non-p e, contemporaneamente, presupporre p, questa capacità permetterebbe
all'antropologo interessato, ad esempio, alla religione degli antichi greci, di usare la
“prospettiva” dalla quale quel popolo guardava il mondo per mostrare tale prospettiva (e la loro
ontologia). Così, l'antropologo non deve credere che i greci adoravano Zeus, ne credere
all'esistenza di Zeus; ma soltanto presupporre l'esistenza di Zeus e presupporre che i greci
credevano di adorare Zeus. Naturalmente, se l'antropologo vuole mostrare il punto di vista che
egli ritiene fosse quello dei greci, dovrà anche credere che i greci credessero di adorare Zeus.
'Credere che', così come 'presupporre che', sono operatori intensionali e, pertanto, nelle
descrizioni possibili dello stato mentale dello studioso 'Zeus' non ha una occorrenza primaria e
non impegna ontologicamente ad alcunché. Chi interpretasse 'I greci adoravano Zeus' come
qualcosa a cui credesse l'antropologo avrebbe, semplicemente, non capito quale “gioco
linguistico” si stesse giocando.
Una volta in possesso della nozione di verità relativa a una presupposizione, si può mostrare
come le presupposizioni possano venir amalgamate. Si immagini che ci sia una conversazione
tra tre individui: A, B e C. A dice che ha conosciuto il giorno prima un filosofo di nome
Giovanni Verme, che non è in grado di comprendere la meccanica quantistica; mentre B dice
che il giorno prima ha conosciuto un filosofo di nome Guillermo Marrese, non solo in grado di
comprenderla, ma anche di dimostrare la sua falsità. A questo punto, C potrebbe dire 'Guillermo
Marrese è più intelligente di Giovanni Verme'. La comparazione fatta da C sarebbe
perfettamente intelligibile anche se C non credesse che A o B abbia detto la verità. Anzi, non
deve credere neppure che A o B abbia conosciuto qualcuno il giorno prima. C potrebbe credere
che, ad esempio, A e B volessero deriderlo. Egli, per rendere intelligibile la sua affermazione,
deve solo presupporre che ci siano Giovanni Verme e Guillermo Marrese. Vale a dire, deve
presupporre i due termini della relazione 'essere più intelligente di'. E ciò è possibile anche se la
“fonte” da cui C ricava i due nomi propri (e l'informazione ad essi associata) è distinta271. Non è
difficile vedere come applicare lo stesso ragionamento nel caso di (8): le due fonti sono due
270 Sainsbury 2009, p. 145. Il caso di 'adorare' è il caso di un presunto verbo transitivo in grado di esprimere unarelazione tra un agente e un'entità non esistente.
271 Sainsbury 2009.
81
romanzi distinti. (8) è letteralmente falso e, perciò, non si è tenuti ad ammettere nella propria
ontologia entità quali Anna Karenina e Emma Bovary272.
Per quanto riguarda la strategia irrealista di fare dei verbi che riguardano l'attività intenzionale
della mente verbi che introducono, a livello della forma logica degli enunciati in cui occorrono,
degli operatori intensionali, si ricorderà che tale manovra trovava delle notevole difficoltà
quando era un nome proprio l'espressione che doveva rendere il suo contributo semantico senza
presupporre un'entità di riferimento; vale a dire, senza presupporre una relazione tra un agente e
un oggetto reale. Per rendere l'intelligibilità e la verità di
(9) Francisco de Orellana cerca El Dorado,
senza ammettere l'esistenza di El Dorado, si ricorreva a una lettura de dicto quale
(9') Francisco de Orellana tenta che Francisco de Orellana trovi un x (città) tale che x
El-Doradi-zzi.
Il problema consisteva nell'impossibilità, come si ricorderà, di trovare dei criteri descrittivi
(predicati generali) che dovesse soddisfare un oggetto (città) per poter essere considerato
l'oggetto ricercato da Orellana. Dovevano essere dei criteri condivisi da chi riportasse lo stato
mentale di Orrellana e dal destinatario di tale riporto. Altrimenti, non sarebbe possibile assicurare
che (9) non comunichi proposizioni diverse, a seconda dell'informazione che ogni parlante associ
al nome 'El Dorado'. Inoltre, il non poter conoscere il modo in cui Orellana si rappresentassi
l'oggetto della sua ricerca complicava ancora di più la situazione. Sembrava che in qualche modo
si imponesse una lettura di (9) di tipo relazionale. Tuttavia, una volta compreso che i nomi non
sono riducibili a predicati generali, ma sono designatori rigidi la cui capacità di servire alla
rappresentazione di particolari in quanto particolari non viene meno in assenza di un oggetto che
sia il loro referente273 , il problema viene dissolto. Si potrebbe dire che comprendere il senso
minimale di 'El Dorado' sia il modo minimale in cui i parlanti si rappresentano El Dorado, il che
garantisce, a prescindere dai diversi modi in cui essi si possano rappresentare El Dorado, la loro
intesa: i diversi modi di rappresentarsi El Dorado sono rappresentazioni della “stessa cosa”.
272 Sainsbury ritiene che appellarsi alla nozione di verità relativa a una presupposizione sia un modo più naturale diavvicinarsi, rispetto a quello che prevede l'introduzioni di operatori intensionali, a enunciati quali 'SherlockHolmes è un detective' o 'Pegaso è un cavallo alto'. Si veda Sainsbury 2009.
273 Textor 2010.
82
Anche se molti verbi che danno origine a contesti intensionali si prestano ad essere trattati come
verbi che esprimono atteggiamenti proposizionale, ci sono alcuni che non lo fanno, almeno non
in un modo “diretto”. Si pensi al caso del verbo 'pensare' quando si presenta in una costruzione
quale
(10) Giovanni pensa a Pegaso.
In un caso come questo, non sembra possibile procedere, ai fini di evitare una lettura
relazionale, a una parafrasi in cui una proposizione occorra all'interno di un'altra più complessa
retta dal operatore 'Giovanni pensa che'. Infatti, perché ciò sia possibile, sarebbe necessario
trovare il modo di riempire i puntini in ' Giovanni pensa che Pegaso....'. In altre parole, sarebbe
necessario trovare un predicato che insieme a 'Pegaso' formi una proposizione tale che la
proposizione complessiva abbia le stesse condizioni di verità di (10). Altrimenti, il significato di
(10) non sarebbe reso dalla parafrasi. Ma ciò equivale a dire che per comprendere (10) è
necessario conoscere cosa Giovanni pensasse in relazione a Pegaso274. Tuttavia, le cose stanno in
un altro modo. Se Giovanni stessi pensando che Pegaso vola, (10) sarebbe vero, allo stesso modo
in cui lo sarebbe 'Giovanni pensa che Pegaso vola'; se, invece, egli pensasse (soltanto) che
Pegaso è bianco, (10) sarebbe lo vero stesso, mentre 'Giovanni pensa che Pegaso vola' sarebbe
falso. Così, il soggetto che ritiene vero (10) può credere che esso è vero perché Giovanni pensa
che Pegaso vola; ma se egli scoprisse che Giovanni non pensava ciò, bensì che Pegaso fosse
bello, questo fatto non lo farebbe certamente considerare (10) falso.
Allora, sembrerebbe che (10) è un genuino caso di enunciato semplice che è vero perché si da
una certa relazione tra due oggetti reali. Pegaso sarebbe un “oggetto intenzionale”, come
direbbero i meinonghiani, con il quale il pensiero sarebbe in grado di entrare in contatto. In
realtà, (10) non è un enunciato semplice, ma possiede una struttura semantica “nascosta” 275.
Come spiega Sainsbury:
To think about something is to entertain a suitably related internally singular
propositional content. For example, for John to think about Pegasus is for John to stand
in some attitudinative relation to a propositional content expressible using 'Pegasus'. The
content might be that Pegasus flies, though no restriction is placed. The attitude might
274 Crane 2008.275 Ibidem.
83
be that of believing or imagining or simply entertaining tha proposition; again, there's
no restriction.276
Così, (10) può venir reso da qualcosa come:
(10') ∃A∃P (Giovanni A-izza che Pegaso è P);
dove A è una variabile che spazia su atteggiamenti proposizionali e P una che spazia su
proprietà277.
Come si può apprezzare, 'Pegaso', l'oggetto in senso grammaticale, viene ricollocato in una
posizione in cui il suo uso non comporta nessun impegno ontologico. 'Pegaso è P' occorre
all'interno della proposizione retta da 'Giovanni A-izza che'. Pensare a un oggetto si riduce ad una
attività che coinvolge proposizioni. Se la proposizione coinvolge un oggetto, come sarebbe il
caso se in essa occorresse un nome non vuoto, allora il “pensare a” coinvolgerà un oggetto; se
non lo fa, non278.
Come si è visto, la teoria del riferimento senza referenti, integrata con alcuni accorgimenti di
natura pragmatica e semantica, permette di mostrare come il realista, per spiegare l'uso
intelligibile che si fa di certi enunciati contenenti nomi vuoti in particolare contesti comunicativi
e la loro eventuale verità, non sia legittimato ad introdurre entità non esistenti nell'universo del
discorso. I casi analizzati, sebbene non esauriscono la totalità dei casi su cui può far leva il
Realismo per difendere le proprie intuizione fondamentali279, sono comunque quelli che esso ha
ritenuto, nel suo dissidio ontologico con gli irrealisti, i “territori strategici” da conquistare. Così,
l'irrealista si troverebbe in una posizione di vantaggio.
Alcune complicazioni
Nonostante ciò, la teoria di Sainsbury presenta alcune difficoltà che potrebbero renderla meno
276 Sainsbury 2009, p. 136.277 Sainsbury 2009. Crane propone una soluzione diversa, ma nello stesso spirito. Si veda Crane 2008.278 Sainsbury 2009. Sainsbury mostra come “riduzioni simili“ si possono proporre non solo per altri verbi o
costruzioni verbali intensionali problematici ('ammirare', 'rappresentare', 'avere paura di'), ma anche per certipredicati problematici come 'essere famoso'. ('Sherlock Holmes è famoso', nella sua lettura metafittizia, è unenunciato vero).
279 Si veda, ad esempio, Parsons 1980, Zalta 1988.
84
attrattiva, compromettendo in questo modo la posizione di vantaggio degli antirealisti. Questa
posizione, come dovrebbe risultare chiaro, dipende dalla capacità di spiegare la significatività dei
nomi senza far appello ad oggetti che si trovino all'inizio della loro “storia”. Così, Sainsbury
propone legare la pratica linguistica di un nome ad un atto di battesimo fondante, un battesimo
che non deve necessariamente coinvolgere un oggetto. Tuttavia, sembra che fare dei battesimi
l'asse portante delle pratiche di uso di un nome proprio porti a delle strane conseguenze: i
battesimi permettono che pratiche che con tutta sicurezza si riterrebbero distinte finiscano per
collassare in una sola, e che pratiche identiche non possano essere ritenute tali.
Secondo Sainsbury, una condizione perché un soggetto possa incorporarsi (initiation) ad una
pratica di uso in modo riuscito è che tale soggetto formi la seguente intenzione:
“For all x, if the uses of NN I am now encountering refer to x, then I will use NN to
refer to x “.280
E' chiaro che l'iniziazione alla pratica di un nome non comporterà problemi se esiste un x tale
che gli usi del nome con i quali il soggetto si imbatte si riferiscono a x. In tale caso, gli usi dei
parlanti sono ancorati ad un oggetto x e, quindi, il soggetto può tranquillamente collegarsi alle
intenzioni referenziali di essi: gli basterà avere l'intenzione di fare ciò, come nel modello di
Kripke. Tuttavia, nel caso dei nomi vuoti le cose sono meno chiare. Si immagini che un
individuo A sia testimone momentaneo di una conversazione tra due studiosi di religioni antiche
che parlano di Vulcano (il pianeta intra-mercuriale). A sente per la prima volta il nome 'Vulcano',
e gli unici enunciati che sente in cui figura tale nome sono 'Vulcano è più grande di Mercurio' e
'Vulcano è più vecchio della Terra'. A sa che i due individui sono studiosi di religioni antiche, e
quindi pensa che con 'Vulcano' loro intendessero parlare di un dio di qualche religione antica.
Quindi, A forma l'intenzione di usare 'Vulcano' come è usato dai due studiosi e, anche se crede
che tale nome venga usato per parlare di un dio, riesce comunque a iniziarsi nella pratica del
nome 'Vulcano' (pianeta). Infatti, dato che non esiste il pianeta intra-mercuriale, 'Vulcano' ,
nell'uso che ne fanno gli studiosi, non si riferisce ad alcunché, e perciò ad A basta che 'Vulcano',
nell'uso che egli ne fa, si comporti nello stesso modo. Siccome non esistono i dei delle religioni
antiche, 'Vulcano', nella bocca di A, non riuscirà a riferirsi a nulla. Così, A inizia a usare
'Vulcano' per conto proprio, dicendo cose come “Vulcano è un dio di qualche mitologia” o
“Vulcano è più forte del dio Mercurio”. Un giorno egli decide di informarsi meglio sulle
280 Sainsbury 2005, p. 113.
85
religioni antiche, e così si trova davanti ad un libro in cui si parla della religione romana. In
questo libro A trova molti enunciati in cui compare il nome 'Vulcano', come è facile immaginare.
Nessuna informazione data nel libro su Vulcano (dio romano) lo induce a pensare che nel libro si
parli di un Vulcano che non sia quello di cui parlavano gli studiosi da cui crede aver imparato il
nome 'Vulcano'. Si immagini adesso che A si interessa così tanto alla religione romana da
diventare uno studioso di religioni antiche. Un giorno , egli si trova con i due studiosi dell'inizio
della storia, e intavola con essi una conversazione nella quale tutti i tre producono enunciati
quali: 'Vulcano è un dio minore', 'Vulcano è il dio del fuoco', 'Virgilio, nell'Eneide, parla di
Vulcano'. Sarebbe molto difficile pensare che A, in tale situazione comunicativa, non stia
parlando del dio romano Vulcano, ovvero, che non sia un membro della pratica di uso di
'Vulcano' (dio romano). Ma, stando alla teoria di Sainsbury, A sta parlando di Vulcano (pianeta):
Perché A possa intendere Vulcano (dio romano) con 'Vulcano' (dio romano), è necessario che
egli si sia iniziato alla pratica di 'Vulcano' (dio romano). Ma per iniziarsi ad una pratica è
necessario formarsi l'intenzione di incorporarsi a una pratica della quale ancora non si è parte.
Nel caso di A, egli non ha potuto formarsi tale intenzione, dal momento che non poteva
riconoscere la pratica di 'Vulcano' (dio romano) come diversa da quella di cui era già membro.
Tutti gli enunciati prodotti all'interno della pratica 'Vulcano' (dio romano) ai quali A ha avuto
accesso, sono stati interpretati da questo dalla prospettiva propria della pratica 'Vulcano'
(pianeta). Per A, il segno 'Vulcano' non poteva che significare Vulcano (pianeta), perché l'unica
pratica di cui era membro era la pratica originata nel battesimo effettuato da Le Verrier. A non era
in grado di distinguere epistemicamente entrambe le pratiche, ma ciò non vuol dire che
metafisicamente non fossero distinte e che, quindi, egli non potesse intendere altro che Vulcano
(pianeta) con il suo uso di 'Vulcano'.
Tuttavia, è poco plausibile pensare che A non sia arrivato ad essere un usuario competente di
'Vulcano' (dio romano). Per di più, lo è anche pensare che egli si sia incorporato effettivamente
alla pratica di 'Vulcano' (pianeta), nonostante abbia soddisfatto i criteri per iniziarsi ad essa. Ad
esempio, non ha senso dire che se A durante la conversazione con gli studiosi dicesse “Secondo
la religione romana, Vulcano era il dio del fuoco”, egli starebbe dicendo il falso perché nelle sue
labbra questo enunciato vorrebbe dire 'Secondo la religione romana, Vulcano (pianeta) era il dio
del fuoco'281. E sarebbe altrettanto assurdo ritenere che gli studiosi non avrebbero capito “ciò che
281 Sainsbury spiega che è possibile che un parlante passi da una pratica ad un'altra senza passare per unainiziazione. In questi casi, il parlante realizza un batessimo non deliberato che da origine alla nueva pratica.Anche se ciò fosse fattibile, non risponderebbe al problema qui esposto: non si tratta di spiegare se A dia o meno
86
intendesse” A realmente con quel enunciato. Sembra che, contrariamente a quanto pensa
Sainsbury, un battesimo non sia dopotutto fondamentale per stabilire a quale pratica stia
partecipando un parlante.
L'inadeguatezza dei battesimi al ruolo di individuatori metafisici delle pratiche si può mostrare
anche in un altro modo. Se un battesimo è ciò che rende una pratica la pratica che è, battesimi
non identici individueranno pratiche di nomi con proprietà semantiche diverse. Ma ciò è
controverso, come mostra Textor:
There is now one practice of using the name 'Gottlob Frege' to mention the author of
Foundations of Arithmetic by name. Let us call this practice the 'Frege'-practice. The
'Frege'-practice was initiated by a baptism that took place in Wismar on the 11.12.1848.
Now it is possible that the 'Frege'-practice started slightly later, say on the 12.12.1848.
Certainly a delay of one day would not have made a difference to the practice. Or a
different priest may have performed the baptism, which initiated the 'Frege'-practice. But
is possible that the same baptism has happened a day later?282
Il problema consiste nel fatto che i battesimi sono modalmente fragili; vale a dire, una
espressione quale 'il battesimo di A' non è un designatore rigido: non denota la stessa entità in
ogni mondo possibile283. Invece, la pratica-'Frege' non può essere modalmente fragile, perché se
con 'la pratica-'Frege' ci si potesse riferire a pratiche diverse da quella attuale, allora, in quelle
pratiche, il nome 'Frege' non significherebbe ciò che significa nel mondo attuale: sarebbe un altro
nome. Quindi, le pratiche non possono venir individuate metafisicamente dai battesimi: battesimi
diversi potrebbero dare inizio alla stessa pratica284.
Nonostante la teoria di Sainsbury presenti delle difficoltà non di poco conto, questo non è
motivo per rinunciarvi tout court: una teoria può essere migliorata e resa coerente con i dati
problematici che essa stessa ha contribuito ad individuare. Il modo in cui essa permette un
trattamento dei nomi vuoti, a livello semantico, senza richiedere per essi entità metafisicamente
sospette, è qualcosa che l'irrealista deve provare a difendere se vuole conservare la sua posizione
di vantaggio di fronte ai realisti. Infatti, non ha un'alternativa migliore.
origine a una nuova pratica, ma di spiegare come riesca a passare da una gìa esistente ad un'altra anche essa giàesistente rimanendo “collegato” intenzionalmente alla prima di esse. Si veda Sainsbury 2005.
282 Textor 2010, p. 112.283 Textor 2010.284 Ibidem.
87
CONCLUSIONE
Il realista, per preservare l'idea che, nel linguaggio naturale, gli enunciati contenenti nomi che
non si riferiscono ad oggetti esistenti si riferiscono comunque a qualcosa, finisce per postulare
una ontologia esuberante di oggetti inesistenti ma nondimeno reali. Tali oggetti permetterebbero
al realista di giustificare una fondamentale intuizione: il linguaggio naturale sembra poter essere
usato per parlare di entità non esistenti perché ciò è quello che effettivamente si riesce a fare. In
altre parole, non c'è scarto tra forma grammaticale e forma logica di un enunciato; il soggetto o
l'oggetto grammaticale è sempre un soggetto logico, e un predicato, come 'esiste', sta per un
attributo che un oggetto può possedere o non possedere. Per preservare la semplicità e presunta
“ovvietà” della sua semantica, il realista, quindi, complica la sua ontologia , in modo da avere
accesso ad una inesauribile fonte di oggetti di riferimento per i termini singolari del linguaggio.
Tuttavia, come si è potuto vedere, una siffatta ontologia finisce per rendere inspiegabile l'uso
intelligibile che si fa degli enunciati contenenti nomi vuoti. Gli oggetti che postula il realista
hanno delle condizioni d'identità così problematiche da rendere impossibile stabilire di cosa si
stia parlando quando si usa un nome vuoto. Inoltre, la metafisica propria di tali oggetti, che li
rende inaccessibili dal punto di vista causale, non fa che contribuire a infittire il mistero.
Paradossalmente, ciò che avrebbe dovuto servire a giustificare una concezione del linguaggio
come mezzo trasparente di comunicazione del pensiero, finisce per renderlo un'attività oscura,
indecifrabile.
L'irrealista, invece, grazie alla teoria semantica di Sainsbury, riesce a spiegare come sia
possibile che gli enunciati contenenti nomi vuoti possano non solo essere comprensibili, ma
anche veri, senza dover ammettere nella propria ontologia dell'entità problematiche. L'uso
intelligibile dei nomi, siano vuoti, siano non vuoti, non presuppone che essi siano in grado di
rintracciare alcunché in una qualsiasi “dimensione” della realtà. Perciò, l'irrealista può
preservare, per così dire, una ontologia conservatrice, una ontologia in cui solo c'è ciò che esiste.
E ciò che esiste non deve essere stabilito in base alle entità che un enunciato sembra richiedere
per esprimere una proposizione vera, ma in base alle entità che la proposizione espressa, una
volta svelata la “forma logica” dell'enunciato che la veicola, richiede per essere vera. Così, un
enunciato può sembrare di servire a dire qualcosa su un oggetto, quando in realtà fa tutt'altro; a
88
livello di forma logica, un apparente impegno ontologico può venire smascherato.
Naturalmente, tutto ciò comporta che, ai fini di non complicare la propria ontologia,
l'antirealista debba complicare la sua semantica. Esiste uno scarto molto significativo tra la
forma grammaticale e la forma logica del linguaggio naturale, e solo svelando quest'ultima è
possibile capire quale sia il reale contributo di un nome proprio o qualsiasi termine singolare alla
significatività del discorso in cui esso viene usato. A volte, sono anche necessarie delle sottili
considerazioni di natura pragmatica. Ma, certamente, queste “complicazioni” non costituiscono
un valido motivo per ritenere problematica la posizione dell'irrealista. Dopotutto, il linguaggio
naturale non è sorto grazie ad un ragionamento, e tra i suoi scopi non c'è quello di facilitare il
lavoro del filosofo285.
285 Wittgenstein 1953.
89
BIBLIOGRAFIA
- Berto, F. (2010), L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi impossibili, Laterza,Roma-Bari.
- Bach, K. (2002), Giorgione was so-called because of his name, in J.E. Tomberlin (a cura di)Philosophical Perspectives, 16, Language and Mind, Blackwell, Malden 2002.
- Bonomi, A. (1973), Nota introduttiva, in A. Bonomi (a cura di), La struttura logica dellinguaggio, Bompiani, Milano 1973.
- Bonomi, A. e Zucchi, S. (2003), A Pragmatic Framework for Truth in Fiction, in Dialectica,57, pp. 103-120.
- Crane, T. (2008), Sainsbury on thinking about an object, in Crìtica, Revista Hispanoamericanade Filosofia, 40, pp. 85-95.
- Currie, G. (1990), The nature of fiction, Cambridge University Press, Cambridge.
- Donnellan K.S. (1974), Speaking of Nothing, in S.P. Schwartz (a cura di), Naming, necessityand natural kinds, Cornell University Press, Ithaca 1977.
- Dumitru, M. e Kroon, F. (2008), What to say when there is nothing to talk about, in Critica,Revista Hispanoamericana de Filosofìa, 40, pp. 97-109.
- Dummett, M. (1973), Frege. Philosophy of Language, Duckworth, London.
- Evans, G. (1973), The causal theory of names, in S.P. Schwartz (a cura di), Naming, necessityand natural kinds, Cornell University Press, Ithaca 1977.
- Evans, G. (1982), The varieties of reference, J. Mc Dowell (ed.), Clarendon Press, Oxford.
- Frege, G. (1892), Senso e denotazione, trad. it. Di S. Zecchi, in A. Bonomi (a cura di), Lastruttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973.
- Geach, P.T. (1962), Reference and generality: an examination of some medieval and moderntheories, Cornell University Press, Ithaca.
- Meinong, A. (1904), The Theoiry of Objects, in R.M. Chisholm (a cura di), Realism and theBackground of Phenomenology, Ridgeview, Atascadero 1960.
- McDowell, J. (1977), On the sense and reference of a proper name, in Mind, 86, pp. 159-185. - Kripke, S. (1971), Identità e necessità, trad. it. Di G. Usberti, in A. Bonomi (a cura di), Lastruttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973.
90
- Kripke, S. (1980), Nome e necessità, trad. it. di M. Santambrogio, Bollati Boringheiri, Torino1999.
- Lenoci M. (1972), La teoria della conoscenza in Alexius Meinong. Oggetto, giudizio,assunzioni, Vita e Pensiero, Milano 1972.
- Lewis D. K. (1968), Teoria delle controparti e logica modale quantificata, in D. Silvestrini (acura di), Individui e mondi possibili. Problemi di semantica modale, Feltrinelli, Milano 1979.
- Lewis D.K. (1978), La verità nella finzione, in S. Zucchi (a cura di), Finzioni e verità. Letturedi Semiotica, 2003-2004, The Robin Hood Online Press, pp. 171-190.
- Lewis D.K. (1986), On the plurality of worlds, Blackwell, Oxford.
- Parsons T. (1980), Nonexistent objects, Yale University Press, New Heaven.
- Platinga A. (1974), The nature of necessity, Clarendon Press, Oxford.
- Prior A.N. (1971), Objects of thought, P.T. Geach and A.J.P. Kenny (a cura di), ClarendonPress, Oxford.
- Prior A.N. (1976), Papers in logic and ethics, P.T. Geach and A.J.P. Kenny (a cura di),University of Massachusetts Press, Amherst.
- Putnam H. (1975), Mente, linguaggio e realtà, trad. it. di R. Cordeschi, Adelphi, Milano 1987.
- Quine W.V.O. (1953), From a Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridege,Mass.
- Recanati F. (1993), Direct reference. From language to thougth, Blackwell, Oxford.
- Runggaldier E. e Kanzian C. (1998), Problemi fondamentali dell'ontologia analitica, trad. it. diN. Ferrari, S. Galvan (a cura di), Vita e Pensiero Università, Milano 2002.
- Russell, B. (1905), Sulla denotazione, trad. it. di A. Bonomi, in A. Bonomi (a cura di), Lastruttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973.
- Russell, B. (1918), La filosofia dell'atomismo logico, trad. it. di G. Bonino, Einaudi, Torino2003.
- Sainsbury, R. M. (2005), Reference without referents, Oxford University Press, Oxford.
- Sainsbury, R. M. (2009), Fiction and fictionalism, Routledge, London.
- Sainsbury, R. M. e Tye, M. (2012), Seven puzzles of thought and how to solve them. Anoriginalist theory of concepts, Oxford University Press, Oxford.
- Searle, J. (1958), Nomi propri, trad. it. di G. Usberti, in A. Bonomi (a cura di), La strutturalogica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973.
91
- Textor, M. (2010), Proper Names and Practices: On Reference without referents, in Philosophyand Phenomenological Research, 81, pp. 105-118.
- Velarde-Mayol V. (2007), El objeto puro en Meinong, in Diánoia, 52, pp. 27-48.
- Valore P. (2001), Rappresentazione, riferimento e realtà. Studio su Hilary Putnam, Theleme,Torino.
- Valore, P. (2003), Laboratorio di ontologia analitica, C.U.S.L., Milano.
- Valore, P. (2008), L'inventario del mondo: guida allo studio dell'ontologia, UTET università,Torino.
- Voltolini A. (2010), Finzioni: il far finta e i suoi oggetti, Laterza, Roma-Bari.
- Walton K. L. (1990), Mimesis as make-believe: On the foundations of the representational arts,Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Williams C.J.F. (1981), What is existence?, Oxford University Press, Oxford.
- Wittgenstein, L. (1953), Ricerche filosofiche, trad. it. di R. Piovesan, Einaudi, Torino 1995.
- Zalta E.N. (1988), Intensional Logic and The Metaphysics of Intentionality, The MIT Press,Cambridege, Mass.
- Zalta E.N. (2003), Referring to Fictional Characters, in Dialectica, 57, pp. 243-254.
92