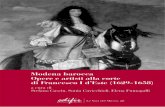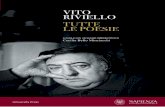“Quasi ella sia stata il centro di tutte”: la ‘concorrenza’ dei pittori forestieri nella...
Transcript of “Quasi ella sia stata il centro di tutte”: la ‘concorrenza’ dei pittori forestieri nella...
20
COMMENTARI D’ARTE
1. Cappella Sistina, veduta dell’interno, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano.
Nel Cinquecento, secondo Fernando Bologna, sarebbe-ro individuabili non meno di sei diverse forme di «consa-pevolezza “nazionale”»: una di queste, le cui radici sonorintracciabili indietro almeno fino a Lorenzo Ghiberti, è sta-ta definita dallo studioso come «la proiezione italiana del-l’esperienza fiorentino-romana» 1. Campione di questa ten-denza fu, ovviamente, Giorgio Vasari, che nella lettera de-dicatoria delle sue Vite a Cosimo I, invariata nelle due edi-zioni torrentiniana (1550) e giuntina (1568), proclamava achiare lettere che gli autori della rinascita delle arti «sonostati quasi tutti toscani, e la più parte Suoi fiorentini» 2. Fun-zionale a questo assunto di base era anche il riconoscimen-to a Sandro Botticelli, da parte appunto di Vasari, del ruo-lo di supervisore nell’esecuzione del ciclo ad affresco quat-trocentesco della Cappella Sistina (fig. 1):
«Et allora gli arrecò in Fiorenza e fuori tanta fama, chePapa Sisto IIII, avendo fatto fabbricare la cappella in pa-lazzo di Roma e volendola dipingere, ordinò ch’egli ne di-venisse capo» 3.
La critica, al contrario, è invece concorde nell’assegna-re, semmai, un ruolo di protagonista in quel ciclo all’umbroPietro Vannucci, detto Perugino, pittore certo non troppoamato da Vasari. Molto più in là si era peraltro spinto l’A-nonimo Magliabechiano (o Gaddiano), che pochi anni pri-ma (1537-1542 circa) era arrivato a definire Perugino «di-scepolo di Sandro Botticello» 4, in un vero e proprio impe-to di fiorentinismo: Botticelli, di appena cinque anni più vec-chio di Perugino, non poteva esserne stato il maestro, seb-bene magari avesse rappresentato per lui un punto di rife-rimento negli anni in cui i due avevano lavorato fianco a fian-co nella bottega di Andrea Verrocchio alla fine degli anniSessanta. Si trattava, ad ogni modo, di una questione chestava a cuore ad entrambi gli autori: la storiografia fiorenti-na non poteva tollerare che nella maggiore impresa ‘inter-nazionale’ di tutta la pittura quattrocentesca italiana, realiz-zata nel centro sovra regionale per eccellenza, Roma, nonfosse stato un fiorentino il direttore dei lavori: l’Anonimo,nel riportare i nomi degli artisti che avevano dipinto nellaCappella al tempo di Sisto IV, specificava orgoglioso accan-to a Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli,“fiorentini”, senza annotare nulla accanto a Perugino e Lu-ca Signorelli. Anche grazie a questi passi dell’Anonimo Ma-gliabechiano e di Vasari è possibile indicare proprio nel ci-
clo delle pareti della Cappella Sistina quello che fu il primocaso di programmatico confronto fra due gruppi di pittoridi provenienza regionale diversa. Non si può naturalmenteparlare di una competizione fra due scuole, poiché il con-cetto stesso di scuola sarebbe nato più tardi, nel corso delCinquecento, per poi essere chiaramente teorizzato solo al-l’inizio del Seicento da Giovanni Battista Agucchi 5, ma i pit-tori attivi nella Cappella Sistina provenivano da due realtàben diverse, Firenze da una parte, e l’Italia centrale dall’al-tra. Si è più volte parlato di un confronto fra toscani e um-bri 6, ma Cristina Acidini Luchinat ha più opportunamentescritto: «nel territorio che si suol denominare Italia centra-le in base ad una convenzione ampiamente storicizzata, gra-zie alla quale viene evitato l’errore di proiettare nel passatopreunitario i confini amministrativi odierni, si registrano pertutto l’arco del Quattrocento intensi e importanti movimentidi artisti» 7. Signorelli, che pure lavorava accanto a Perugi-no, non era certo umbro. Quando nel 1792 Luigi Lanzi die-de alle stampe il primo volume della sua Storia pittorica del-la Italia, dedicato alle scuole fiorentina, senese, romana e na-poletana, trattando della prima egli scrisse:
«Fiorivan costoro a’ tempi di Sisto IV, il quale, avendoeretta la cappella che da lui prese il nome, gli chiamò di To-scana. Furon essi il Botticelli, il Ghirlandaio, il Rosselli, Lu-ca da Cortona, don Bartolommeo d’Arezzo: i quali qui in-trodurrò coi lor seguaci» 8.
Lanzi, che pure non ragionava solo in termini di prove-nienza geografica, e certo non era faziosamente filofioren-tino come l’Anonimo Magliabechiano o Vasari, collocavadunque il cortonese Signorelli e l’aretino Bartolomeo dellaGatta (nato peraltro a Firenze) all’interno della scuola fio-rentina, che avrebbe così dominato la campagna decorati-va quattrocentesca della Cappella Sistina, poiché come scri-veva più avanti lo stesso Lanzi:
«E Sisto IV, che, come dicemmo, cercava per ornar laSistina dipintori per tutta Italia, di Toscana trasse il mag-gior numero; né fuor d’essi vi ebbe altri che Pietro Perugi-no, nato suo suddito, ma divenuto grande in Firenze» 9.
Le cose, in realtà, erano andate in modo molto diverso.Sebbene, infatti, dai documenti in nostro possesso si po-trebbe evincere che i lavori del cantiere fossero equamen-
“Quasi ella sia stata il centro di tutte”.La ‘concorrenza’ dei pittori forestieri nella Roma di Sisto IV e Giulio II
Stefano Pierguidi
21
22
COMMENTARI D’ARTE
2. Cappella Sistina, particolare della parete destra, con la Consegna delle chiavi di Perugino a sinistra e l’Ultima Cena di Cosimo Rosselli a destra, Cittàdel Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano.
te distribuiti fra quattro grandi maestri, a loro volta titola-ri di botteghe distinte (oltre a Botticelli e a Perugino, nelcontratto di allogazione degli affreschi sono menzionati an-che gli altri due fiorentini Domenico Ghirlandaio e Cosi-mo Rosselli), in realtà, se si ripercorre nuovamente la sto-ria di quella memorabile impresa, emerge come sui pon-teggi della cappella fossero sostanzialmente attive due équi-pes di pittori: i fiorentini da una parte e i ‘non fiorentini’dall’altra. Il primo obiettivo degli artisti era quello di de-corare la Cappella il più velocemente possibile, e non si puòaffermare che tutta quell’impresa fosse sotto il segno di unavera e propria competizione. Ma nel momento chiave, quan-do vennero affrescati i due episodi più significativi, ci fu unconfronto diretto, una vera e propria gara, fra Botticelli ePerugino, che eseguirono uno di fronte all’altro, rispettiva-mente, la Punizione di Date Kore e Abiron e la Consegnadelle chiavi a San Pietro (figg. 3-4), opere paradigmatichedi quelli che noi oggi riconosciamo come due stili radical-mente diversi (da una parte il linearismo fiorentino di Bot-ticelli, dall’altro la chiarezza compositiva di matrice pier-francescana di Perugino) 10: è molto probabile che i pittoristessi avessero coscienza di queste differenze linguistiche,espressive, e che in qualche modo si riconoscessero comeesponenti di tradizioni pittoriche diverse.Sisto IV aveva voluto riunire nella sua Cappella quanto
di meglio offriva la pittura del tempo, emarginando propriola Roma di Antoniazzo Romano, ma anche di Melozzo daForlì, da quella selezione antologica di pittori forestieri. Al-l’altezza cronologica del 1480, da Roma, sarebbe stato dif-ficile guardare più in là degli Appennini. Venezia, primadella maturità di Giovanni Bellini, rimaneva un universo asé stante, e si sarebbe potuta al massimo lamentare l’assen-za, per così dire, di un pittore ‘lombardo’: già nel 1466, infondo, Andrea Mantegna era stato invitato a Pisa per «fi-nire di dipingere al Camposanto» 11, e lo stesso Mantegnasarebbe stato più tardi chiamato a lavorare nel palazzettodel Belvedere da Innocenzo VIII. Sisto IV, però, era preoc-cupato prima di tutto di vedere finita il prima possibile lasua Cappella, e non aveva forse una visione dell’Italia arti-stica tanto ampia; questa l’avrebbe invece maturata, certoa partire proprio dalle esperienze vissute nella Roma sisti-na, il nipote del pontefice, il cardinale Giuliano della Ro-vere. Asceso a sua volta alla Cattedra di Pietro con il nomedi Giulio II, per decorare il proprio appartamento in Vati-cano egli avrebbe chiamato pittori provenienti davvero datutte, o quasi, le più significative realtà artistiche della pe-nisola. E, per una strana contingenza storica, proprio nelmomento in cui per la prima volta si trovavano a lavorarefianco a fianco, tra gli altri, artisti milanesi (Bartolomeo Suar-di, detto il Bramantino), veneti (Lorenzo Lotto), toscani(Baldassarre Peruzzi) e dell’Italia centrale (di nuovo Peru-gino), nasceva, ad opera di Raffaello, quella che in seguitosarebbe stata riconosciuta come la scuola romana, giusta-mente definita da Lanzi quasi «il centro di tutte» 12. E po-co dopo, sempre nella Roma di Giulio II, nel prestigioso
cantiere della Farnesina, quel riconosciuto campione dellapittura tosco-romana, Raffaello appunto, veniva messo incompetizione con un esponente di quella veneziana, Seba-stiano del Piombo, che Agostino Chigi aveva personal-mente portato in città. Nasceva così proprio a Roma, adopera prima di tutto dei mecenati e dei pittori, quello chesarebbe divenuto un topos della letteratura artistica, il di-battito sul primato fra il disegno tosco-romano e il coloreveneziano.In merito alle fasi in cui si articolò la decorazione delle
pareti della Cappella Sistina sussistono ancora alcuni in-terrogativi senza risposta, primo fra tutti quello circa la da-ta di inizio dei lavori, e il numero dei pittori presenti nelcantiere in quel momento. Solo dopo il dicembre 1480,quando Sisto IV tolse la scomunica a Firenze, con la ces-sazione delle ostilità tra il pontefice e i Medici scoppiate aseguito della fallita congiura dei Pazzi (26 aprile 1478), sa-rebbe stato possibile per Botticelli, Ghirlandaio e Rossellirecarsi a Roma e prendere parte ai lavori nella Cappella.Perugino, al contrario, prima di lavorare nella Sistina ave-va già affrescato, entro il dicembre 1479, e sempre per con-to di Sisto IV, l’abside della Cappella dell’Immacolata del-la vecchia basilica di San Pietro: egli era quindi presente aRoma, ed era già entrato nelle grazie del pontefice 13. Nelcontratto del 27 ottobre 1481 con il quale i quattro pittorisi impegnavano a dipingere dieci storie nella Cappella Si-stina venivano menzionati quattro storie già eseguite, chesarebbero state successivamente valutate 14. Sebbene recen-temente sia stata proposta una diversa interpretazione diquesto documento 15, non ci sono davvero molti dubbi inmerito all’identificazione di questi affreschi: i quattro giàeseguiti erano i primi, a partire dalla parete dell’altare, dellato destro, quelli cioè con Storie di Cristo, e poiché ne ri-manevano da eseguire ancora dieci, se ne deduce che i duesulla parete dell’altare non erano inclusi nel contratto: o era-no già stati eseguiti, o comunque non erano compresi inquel contratto. Si trattava degli episodi con cui i due cicliparalleli con storie veterotestamentarie e neotestamentarieavevano inizio: da una parte era la Natività di Cristo, dal-l’altra il Ritrovamento di Mosè; al centro era poi anche lapala d’altare, sempre ad affresco, raffigurante l’Assunzionedi Maria. Queste tre opere sono tutte riferite a Perugino daVasari 16, e in genere si ritiene siano state eseguite prima chei pittori fiorentini entrassero a lavorare nel cantiere. Un’at-tenta lettura dei documenti, però, dimostra chiaramente co-me gli affreschi della Cappella fossero eseguiti, come erad’altronde logico, dall’alto verso il basso: furono quindi di-pinti per primi i ritratti dei pontefici tra le finestre del ter-zo ordine delle pareti, poi le storie del secondo ordine, einfine i finti tendaggi del primo (fig. 2). Nel contratto del-l’ottobre 1481, infatti, i ritratti dei pontefici non sono men-zionati, proprio perché a quella data erano già stati tutti af-frescati. Al contrario, nella stima del 17 gennaio 1482, re-lativa alle quattro storie già realizzate 17, i ritratti sono cita-ti ed è specificato che i finti tendaggi erano ancora da ese-
23
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
di tre mesi circa. Il pontefice, e anche le fonti contempo-ranee lo confermano 20, voleva evidentemente vedere la cap-pella terminata il prima possibile: i lavori di costruzione, in-fatti, erano stati portati avanti con grande velocità nono-stante la guerra in corso con Firenze. Non c’è quindi mo-tivo di credere che, una volta che le pareti della cappellafurono pronte per essere affrescate, nella primavera-estatedel 1481, in un momento in cui erano già cessate da qual-che mese le ostilità con Firenze, non si procedesse imme-diatamente a chiamare a Roma Botticelli, Ghirlandaio e Ros-selli. È ben noto come Lorenzo il Magnifico impiegasse piùvolte gli artisti migliori della sua città a fini propagandisti-ci, diplomatici 21: è verosimile, quindi, che i tre pittori giun-gessero tempestivamente alla corte del pontefice, entro l’e-state del 1481 22, e che iniziassero a lavorare nella cappellainsieme a Perugino, cominciando ad affrescare con lui, co-me già detto, i ritratti dei pontefici nel terzo ordine dellepareti 23.Se si accettasse questa ipotesi, se ne dedurrebbe che a
Perugino fu affidata la decorazione ad affresco di tutta laparete d’altare in un momento in cui i pittori fiorentini era-no già attivi nel cantiere. Ma che il Vannucci avesse un pe-so diverso rispetto a quello, singolo, di ciascuno degli altritre firmatari del contratto di commissione dell’ottobre 1481emerge, comunque, anche da un’altra considerazione: quan-do, a quella data, i quattro artisti si impegnarono ad ese-
guire: a quella data i pittori erano impegnati ad affrescarela storie della parete di fronte alle quattro già eseguite, esolo una volta terminati i due cicli con Storie di Mosè e diCristo sarebbero passati a dipingere i finti tendaggi del pri-mo ordine 18. Il rigore con cui venne rispettato questo or-dine dei lavori suggerisce di escludere l’ipotesi che Perugi-no, con l’aiuto della sua bottega, avesse eseguito da solo tut-ti gli affreschi della parete d’altare, dall’alto verso il basso,e che poi, una volta giunti i pittori fiorentini a Roma, inve-ce di eseguire, ad esempio, tutti gli affreschi di una delledue pareti lunghe, si procedesse dall’alto verso il basso. Sesi riflette sulla velocità davvero straordinaria con cui venneportata avanti tutta l’impresa della Cappella, è possibile in-vece suggerire un’altra ipotesi. I lavori di costruzione dellaSistina, avviati intorno al 1477, vennero probabilmente con-clusi nel 1481, non prima del marzo di quell’anno 19: consi-derate le dimensioni dell’edificio, si trattava già di un ri-sultato eccezionale. Nel contratto del 27 ottobre 1481 i pit-tori si impegnavano a terminare tutti gli affreschi (manca-vano, a quella data, dieci storie e tutti i finiti tendaggi inbasso) entro il marzo dell’anno successivo, in appena cin-que mesi quindi, sotto la minaccia del pagamento di unaforte penale. Se ne deduce che per eseguire la serie dei pon-tefici e le quattro storie già terminate a quella data (o for-se sul punto di esserlo), gli stessi pittori, che avevano ac-cettato quelle condizioni, non dovevano aver impiegato più
24
COMMENTARI D’ARTE
3. Sandro Botticelli, Punizione di Date Kore e Abiron, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano, Cappella Sistina.
guire i restanti dieci affreschi, era evidente che qualcuno diloro avrebbe dovuto realizzare una storia (o addirittura due)in più degli altri 24. Si ritiene generalmente che con l’ingressonella cappella di Signorelli, che eseguì (sebbene non tuttoda solo, anzi) le due ultime storie del ciclo mosaico, si apris-se sostanzialmente un’altra fase del cantiere, e che questonon venisse quindi chiuso entro i termini previsti dal con-tratto dell’ottobre 1481 25. È invece più probabile che gli af-freschi eseguiti da Signorelli fossero non semplicemente su-bappaltati all’artista cortonese da Perugino 26, ma eseguitisempre sotto la supervisione di questi, che quindi, al mo-mento della stipula del contratto, si sarebbe impegnato arealizzare quattro dei dieci restanti affreschi, mentre cia-scuno dei tre pittori fiorentini sarebbe stato responsabile disole due storie. Dopo che avevano realizzato i primi quat-tro affreschi con Storie di Cristo della parete di destra (nel-l’ordine, dalla parete d’altare: Perugino il Battesimo di Ge-sù; Botticelli le Tentazioni di Gesù; Ghirlandaio la Vocazio-ne di Pietro e Andrea; Rosselli il Discorso della montagna) ifirmatari del contratto sembrerebbero essere passati a la-vorare, specularmente, sulla parete di fronte, dove Perugi-no affrescò Mosè con la moglie Sefora in Egitto, BotticelliEpisodi della vita di Mosè in Egitto e Rosselli la Consegnadelle tavole della Legge e l’adorazione del vitello d’oro; il ter-zo episodio del ciclo, il Passaggio del Mar Rosso, che ci si
sarebbe aspettati venisse realizzato da Ghirlandaio, essen-do di fronte alla sua Vocazione di Pietro e Andrea, venne in-vece affidato a Biagio d’Antonio, un pittore orbitante nel-la bottega di Rosselli 27. I quattro maestri avevano firmatoun accordo con il fiorentino Giovannino de’ Dolci, archi-tetto della cappella e direttore dei lavori, con il quale si im-pegnavano a realizzare tutta la decorazione nei tempi pre-visti, ma non avevano specificato come si sarebbero divisiil lavoro, ed evidentemente i fiorentini di comune accordo,con i vari aiuti, quale appunto era Biagio d’Antonio, pote-vano alternarsi sui ponteggi a loro piacimento. Allo stessomodo Perugino, dovendo far fronte ad una mole di lavorodavvero considerevole, era affiancato non solo dal suo piùcelebre allievo, Bernardino di Betto, detto Pinturicchio, mastando a Vasari anche da Andrea d’Assisi, detto l’Ingegno,da Rocco Zoppo e forse pure da Piermatteo d’Amelia 28. Èprobabile che la partecipazione diretta del maestro alla rea-lizzazione della pala d’altare, evidentemente molto impor-tante, fosse piuttosto consistente: per questa ragione, quin-di, la realizzazione del Battesimo di Cristo e di Mosè con lamoglie Sefora in Egitto fu lasciata quasi integralmente agliallievi, primo fra tutti Pinturicchio 29. E questo dimostra co-me con ogni probabilità la parete di fondo venisse affre-scata contemporaneamente alle storie delle pareti laterali,non prima: in caso contrario, perché Perugino non sareb-
25
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
4. Pietro Perugino (con la collaborazione di Luca Signorelli), Consegna delle chiavi a San Pietro, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano, Cap-pella Sistina.
di Mosè, mentre non ci sono ragioni di credere che egli aves-se precocemente abbandonato il cantiere. Nella Cappellacome già anticipato, erano insomma attive, sostanzialmen-te, due équipes, quella fiorentina e quella di Perugino. Ilcontratto, infatti, menzionava nell’ordine «Cosmo Lauren-tii Phylippi Rosselli, Alexandro Mariani, et Dominico Tho-masii Corradi de Florentia, et Petro Cristofori Castri Ple-bis Perusini», ovvero prima i pittori «de Florentia», poi (et)Pietro «Castri Plebis Perusini»: la ‘nazionalità’ divideva gliartisti in due gruppi distinti. Certo, nel primo i pittori ci-tati erano tre, e nel secondo uno solo, ma questo semplice-mente perché i fiorentini erano tutte figure di pari livello,o quasi, e quindi non riconoscevano a Botticelli il medesi-mo ruolo guida che aveva Perugino tra i non fiorentini. IlVannucci avrebbe impostato tutta la sua carriera sulla ca-pacità di gestire un gran numero di aiuti, e a un certo pun-to di tenere persino in piedi due botteghe contemporanea-mente, a Perugia e a Firenze, e se anche Signorelli e Bar-tolomeo della Gatta fossero stati presenti a Roma al mo-mento della stipula del contratto, nell’ottobre del 1481, que-sti non sarebbero stati menzionati, esattamente come non
be intervenuto in maniera più consistente in quegli affre-schi? Alla fine del 1481, o magari anche intorno a settem-bre-ottobre, Perugino chiamò a Roma Signorelli, che lo af-fiancò prima nell’esecuzione della Consegna delle chiavi epoi, soprattutto, quasi lo sostituì in quella degli Ultimi fat-ti della vita di Mosè, un affresco impostato da Perugino mapoi realizzato quasi integralmente da Signorelli, con l’aiu-to, a sua volta, di Barolomeo della Gatta (sempre che nonfosse proprio Bartolomeo della Gatta a eseguire il grossodel lavoro) 30. Il cortonese, stando a Vasari, avrebbe infinerealizzato nella controfacciata il San Michele che protegge ilcorpo di Mosè, rovinato dalla caduta di un architrave nel1522 e completamente rifatto nel 1572 circa da Matteo daLecce: l’affresco originario, quindi, è oggi perduto, e nonsappiamo quanta parte in esso avessero avuto Bartolomeodella Gatta o lo stesso Perugino 31. È probabile che Pintu-ricchio, in quel momento, fosse ancora impegnato ad ese-guire parte degli affreschi impostati per primi nella cappella(si ricordino anche le due scene ai lati della pala d’altare):è per questo che la sua mano non è riconoscibile nella Con-segna delle chiavi a San Pietro e negli Ultimi fatti della vita
26
COMMENTARI D’ARTE
5. Pietro Perugino e bottega, Il Creatore in trono tra angeli e cherubini, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza dell’Incendio, volta.
venne menzionato Pinturicchio32. Quando nell’ottobre 1481,giusta l’ipotesi qui proposta, Perugino si impegnò ad ese-guire quattro delle rimanenti dieci scene, avendo egli giàottenuto la commissione di tutta la vasta parete d’altare, piùil Battesimo di Gesù, praticamente si assicurò poco menodella metà di tutto il ciclo quattrocentesco.I fiorentini, comunque, erano pur sempre presenti nel
cantiere in numero maggiore dei pittori al seguito di Peru-gino, e potevano procedere a ritmi anche più rapidi: è ve-rosimile che quando Biagio d’Antonio lavorava al Passag-gio del Mar Rosso si fosse nel novembre/dicembre del 1481.Ghirlandaio non poteva aver abbandonato il cantiere, su-bito dopo la firma del contratto nell’ottobre di quell’anno,ed è plausibile quindi ipotizzare che egli passasse subito alavorare nella controfacciata dove, secondo Vasari, l’artistarealizzò la Resurrezione di Cristo 33, anch’esso rovinato dal-la caduta del medesimo architrave, e poi rifatto da Hen-drick van den Broek, detto Arrigo Fiammingo. È piuttostosorprendente, peraltro, che Ghirlandaio andasse ad eseguirel’ultima scena del ciclo neotestamentario in un momento incui non dovevano ancora essere stati eseguiti i due episodiprecedenti. È possibile peraltro che anche l’Ultima Cena ve-nisse subito impostata: Rosselli poteva contare anche sul-l’aiuto di Piero di Cosimo, oltre che di Biagio d’Antonio,quindi la sua bottega era magari al lavoro su più affreschicontemporaneamente.Secondo la ricostruzione che qui si sta avanzando, il ci-
clo sarebbe stato insomma terminato nei tempi previsti, co-me peraltro è stato già brillantemente dimostrato da JohnMonfasani 34. Improbabile è infatti l’ipotesi che Perugino, emagari anche i pittori fiorentini, avessero lasciato il cantie-re prima della conclusione dei lavori per protestare controun probabile ritardo nei pagamenti da parte del pontefice,notoriamente poco puntuale 35: è forse più opportuno tor-nare a sottolineare che gli artisti avevano firmato un con-tratto che prevedeva delle penali. Se poi si riflette sul fattoche Ghirlandaio, dopo aver eseguito la Vocazione di Pietroe Andrea, era probabilmente passato subito a lavorare nel-la controfacciata, non si direbbe certo che i fiorentini pro-cedessero a rilento, anzi. E Perugino, per non essere da me-no, aveva prontamente arruolato Signorelli e Bartolomeodella Gatta. A capo di una bottega necessariamente moltoefficiente, egli doveva davvero aver lavorato a ritmi forsen-nati. Appena si erano cominciati a smontare i ponteggi dalterzo ordine delle pareti, mentre i fiorentini eseguivano an-cora gli ultimi ritratti della serie dei pontefici, quelli più vi-cini alla parete d’ingresso 36, Perugino si sarebbe subito mes-so a lavorare agli affreschi della parete d’altare. La critica èancora divisa in merito alla ricostruzione dell’aspetto di que-st’ultima, poiché dalla sola lettura delle fonti non è possi-bile stabilire se l’Assunzione di Maria arrivasse solo all’al-tezza dei finti tendaggi del primo ordine, o se al contrarioarrivasse all’altezza del secondo ordine 37. Tutti gli indizi,però, suggeriscono di accogliere la seconda ipotesi 38, e quin-di le prime storie dei due cicli neotestamentario e vetero-
testamentario sarebbero state molto più strette di quelle del-le pareti laterali e di quella d’ingresso. È anche per questaragione che nel contratto dell’ottobre 1481 veniva specifi-cato che sarebbero state stimate le quattro storie già affre-scate della parete destra, poiché quelle sulla parete di fon-do erano molto diverse, più piccole. Non è in fondo sor-prendente che Perugino ottenesse di eseguire da solo tuttala decorazione di quella parete, certo la più importante del-l’intera Cappella: egli aveva conquistato la stima del pon-tefice con l’esecuzione del già citato affresco in San Pietrocon laMadonna in gloria con i Santi Francesco, Antonio, Pao-lo e Pietro, in cui lo stesso Sisto IV veniva presentato allaVergine da San Pietro 39. A Perugino venne quindi com-missionata una raffigurazione della Madonna molto similea quella che egli aveva già realizzato nella basilica, ed eraquella l’immagine più significativa, non solo della pareted’altare, ma di tutta la Cappella, che venne infatti inaugu-rata il giorno dell’Assunzione, il 15 agosto 1483 40. L’artista,che aveva evidentemente un rapporto privilegiato con il pon-tefice, o comunque con la Curia di Roma, eseguì quel la-voro senza firmare nessun contratto. A Perugino, inoltre,che aveva già avuto il compito di realizzare le prime duepiccole scene della parete d’altare, venne affidata anche laprima grande della parete lunga con il ciclo neotestamen-tario: fu egli, quindi, a impostare le dimensioni delle figu-re, a scegliere l’altezza della linea d’orizzonte, a definire ildisegno delle lesene, insomma a determinare tutte quellecaratteristiche che sarebbero poi dovute essere rispettate inognuno degli altri affreschi 41.Una volta che furono terminati anche i primi quattro af-
freschi della parete sinistra, a partire sempre dalla pareted’altare, quando i fiorentini (probabilmente Ghirlandaio,ma forse anche Rosselli) erano già al lavoro sugli ultimi dueepisodi del ciclo neotestamentario, vennero eseguiti, più omeno contemporaneamente, i due episodi con la Punizionedi Date Kore e Abiron e la Consegna delle chiavi a San Pie-tro (figg. 3-4). Si trattava, come è stato sempre riconosciu-to, delle due scene più importanti di tutta la decorazioneda un punto di vista sia teologico sia politico: da una par-te la Chiesa ribadiva il suo primato sulle tesi conciliariste,e dall’altra sottolineava la trasmissione diretta del propriopotere sia temporale che spirituale da parte di Cristo 42. Idue affreschi erano i primi al di là della transenna marmo-rea che, nella Cappella, separava lo spazio riservato ai car-dinali, ambasciatori e dignitari da quello a cui potevano ac-cedere altre figure di una certa importanza ma anche sem-plici pellegrini in visita a Roma 43. Era a loro che la Chiesasi rivolgeva direttamente, con un messaggio forte e chiaro:chiunque fosse stato ammesso in quello spazio non avreb-be certo rivolto lo sguardo alle proprie spalle o, immedia-tamente sopra le proprie teste, agli ultimi due episodi del-le pareti lunghe; quelle affrescate da Botticelli e Peruginoerano le storie nella posizione di maggiore visibilità di tut-ta la Cappella, fatta naturalmente eccezione per la grandepala d’altare sulla parete di fondo. Non è un caso che solo
27
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
poi, di seguito anche se sulla controfacciata, San Micheleche protegge il corpo di Mosè): questo, forse, solo perché Pe-rugino aveva ottenuto di realizzare l’episodio più importantedi tutta la decorazione.La formazione di Perugino, come è noto, è ancora una
questione aperta, discussa 49. Vasari ne faceva un discepolodi Verrocchio:
«Da questi avvisi dunque e dalle persuasioni di molti al-tri mosso, venne Pietro in Fiorenza con animo di farsi ec-cellente; e bene gli venne fatto, con ciò sia che al suo tem-po le cose della maniera sua furono tenute in pregio gran-dissimo. Studiò sotto la disciplina di Andrea Verroc-chio…» 50.
Ma nella vita di Piero della Francesca lo stesso Vasariscriveva che «Fu suo discepolo un Piero da Castel della Pie-ve» 51 identificato già da Padre Sebastiano Resta a fine Sei-cento proprio con Perugino 52. Più recentemente, peraltro,la critica anglosassone ha suggerito l’ipotesi che il Piero daCastel della Pieve menzionato da Vasari sia in realtà il pe-rugino Pietro Galeotto di Ercolano, che in un documentofiorentino del 15 novembre 1473 è detto «al presente di-scepolo di maestro Piero del Borgo» 53. Ma come ha giu-stamente sottolineato Pietro Scarpellini, se è comprensibi-le che Vannucci si dichiarasse “perugino” quando lavoravafuori dall’Umbria, meno plausibile è che Vasari, ragguagliatocertamente da fonti locali, indicasse Pietro Galeotto, natorealmente a Perugia, come un «Piero da Castel della Pie-ve» 54. Semplicemente, come è stato più volte proposto, l’A-retino non si rese conto che quel «Piero da Castel della Pie-ve» su cui aveva recuperato alcune informazioni, era lo stes-so più celebre Pietro che egli diceva nato a Perugia: solonell’edizione del 1568, infatti, Vasari avrebbe aggiunto cheil padre di questi, Cristofano, era originario di «Castello del-la Pieve» 55. La critica ritiene che Perugino, Signorelli e Bar-tolomeo della Gatta abbiano tutti trascorso un periodo nel-la vivacissima bottega fiorentina di Verrocchio, ma non èfacile stabilire se e quando si conobbero tra loro. I primidue ebbero anche una comune formazione pierfrancesca-na, poiché Luca, sempre per Vasari, «fu creato e discepolodi Pietro dal Borgo a San Sepolcro» 56. E anche Bartolomeodella Gatta, che pure era nato a Firenze nel 1448 e lì si eraiscritto alla corporazione degli orefici, avrebbe maturato lapropria cifra stilistica ad Arezzo, a contatto con il grandeciclo pierfrancescano del coro di San Francesco. Si tratta-va insomma di artisti che, sebbene avessero o avrebbero inseguito lavorato anche a Firenze, non erano «de Florentia»come Botticelli, Ghirlandaio e Rosselli. Cortona e Arezzoerano sì parte dello stato fiorentino, ma culturalmente e ar-tisticamente non erano assimilabili alla capitale. Non a ca-so il nome di Piero della Francesca non compariva nei ca-noni dei maggiori artisti del Quattrocento stilati da autorifiorentini, quale ad esempio quello di Cristoforo Landino(1481) 57. Nella celebre Cronaca rimata (1482-1494 circa) di
nella Consegna delle chiavi a San Pietro, tra gli affreschi so-pravvissuti, sia riconoscibile un vasto intervento diretto diPerugino. E tantomeno è un caso che Ghirlandaio, il qua-le avrebbe potuto mettersi subito a lavorare alla Punizionedi Date Kore e Abiron o alla Consegna delle chiavi a San Pie-tro, passasse invece a lavorare nella controfacciata: eviden-temente i fiorentini avevano deciso di lasciare a Botticelli ilcompito di eseguire uno dei due affreschi più importantidella Cappella. Quindi, in qualche misura, Vasari non ave-va tutti i torti ad affermare che Botticelli aveva avuto unruolo direttivo, sebbene questo fosse vero solo all’internodell’équipe fiorentina. Sulla scorta anche del celebre aned-doto vasariano secondo cui Sisto IV avrebbe conferito a Ros-selli la palma della vittoria tra i pittori che avevano lavora-to nella Cappella solo perché, in quanto «persona che ave-va poco giudicio in tal professione»44, era rimasto abbagliatoda tutto l’oro impiegato dall’artista nei suoi affreschi, è sta-ta timidamente avanzata l’ipotesi che Rosselli avesse avutodavvero un ruolo da protagonista all’interno dell’équipe deifiorentini 45. È vero che il nome del pittore è quello che aprela lista degli artisti menzionati nel contratto di commissio-ne degli affreschi, ma questo evidentemente solo perché egliera il più anziano 46: a Botticelli venne dato il posto d’ono-re, e sempre Botticelli aveva eseguito la storia subito suc-cessiva a quella di Perugino su entrambe le pareti, ovverosempre lui era stato chiamato a gareggiare con il capobot-tega rivale 47. Di fronte alla Punizione di Date Kore e Abi-ron, da parte sua, Perugino diede il meglio di sé, e la Con-segna delle chiavi a San Pietro è da sempre considerata ungrande capolavoro, e certo la sua realizzazione più monu-mentale. È stato anche scritto che Perugino e Botticelli sisarebbero accordati, con grande intelligenza, su quale af-fresco eseguire in base anche al loro stile: il primo era cer-tamente più a suo agio con una scena magniloquente, sere-namente impostata, quale doveva essere la Consegna dellechiavi, mentre il secondo poteva meglio di lui orchestrareun episodio drammatico e concitato come la Punizione diDate Kore e Abiron 48. Forse, più semplicemente, Peruginosi aggiudicò ancora una volta l’incarico più prestigioso, poi-ché certo il suo affresco aveva un’importanza, politica e teo-logica, anche maggiore rispetto all’altro. Sarebbe in fondostato logico, infatti, che le ultime tre scene dei due cicli neo-testamentario e veterotestamentario fossero, rispettivamen-te, tutte eseguite dalla medesima équipe. Quando, una vol-ta smontati i ponteggi dal terzo ordine delle pareti, Peru-gino, insieme alla sua ampia bottega, si era messo al lavorosulla parete di fondo, e più o meno allo stesso tempo an-che sul Battesimo di Cristo, non solo aveva potuto stabiliregli standards per tutte le rimanenti storie, ma aveva ancheavuto la possibilità di lavorare contemporaneamente su piùaffreschi adiacenti, e questo non poteva che velocizzare l’o-perato della sua équipe. Invece, per le ultime storie, Peru-gino e Signorelli passarono dalla parete di destra, dove ese-guirono la Consegna delle chiavi a San Pietro, a quella difronte, per affrescarvi gli Ultimi fatti della vita di Mosè (e
28
COMMENTARI D’ARTE
29
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
6. Raffaello e Sodoma, Decorazione della volta della Stanza della Segnatura, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza della Segnatura.
migliorò il suo scolare Pietro Perugino e perfezionò Raf-faello» 63.
Ma, come già detto, per lo stesso Lanzi Signorelli e Bar-tolomeo della Gatta rientravano nella trattazione della scuo-la fiorentina. Sarebbe infatti una forzatura voler vedere nel-le pareti della Cappella Sistina un confronto fra la scuolafiorentina ed un’ipotetica scuola dell’Italia centrale facentecapo a Piero della Francesca: difficile trovare pittori dallacultura figurativa maggiormente composita, e irriducibilead un unico minimo comun denominatore, di Signorelli, Pe-rugino e Bartolomeo della Gatta 64. Solo l’ultimo sarebbestato davvero un interprete appassionato del linguaggio delmaestro di Borgo San Sepolcro. E la conferma a quanto det-to viene anche dalla mancata partecipazione di Melozzo daForlì al cantiere della Cappella Sistina. Per spiegare comemai l’altro grande pittore ‘pierfrancescano’ del Quattrocentoitaliano, da anni attivo a Roma, anche per lo stesso ponte-fice, non venisse chiamato ad affiancare Perugino, Botticellie gli altri, è stata addotta fondamentalmente una ragione:la possibile contemporaneità di quel cantiere con l’impe-gno di Melozzo ai Santi Apostoli, dove egli affrescò l’absi-de della basilica 65. Stefano Tumidei ha però proposto di an-ticipare la datazione di quest’ultima, proponendo come ter-mine ante quem della sua commissione il 1474, anno di mor-te di Pietro Riario, già cardinale titolare della basilica 66. Ilpittore forlivese fu protetto, infatti, soprattutto da Pietro eRaffaelle Riario, prima ancora che da Sisto IV 67. La carrie-ra di Melozzo si svolse in gran parte a Roma 68, ed egli in al-meno un’occasione è pagato per lavori alla Biblioteca Vati-cana insieme ad Antoniazzo Romano (1480-81) 69. Forse pro-prio per questo egli venne escluso dalla rosa degli artistichiamati a lavorare nella Sistina, impresa programmatica-mente internazionale 70. Nella Cappella, quindi, non gareg-giarono pittori fiorentini e umbri, e neanche pittori fioren-tini e pittori pierfrancescani. Ma, pur con tutte queste ri-serve, rimane vero quanto scritto da Scarpellini in meritoal Perugino della Sistina: egli «amalgama e sdrammatizzatutte le asprezze, le complicazioni intellettualistiche, le dif-ficoltà, le contraddizioni dei fiorentini che lavoravano conlui, in quel suo stile cadenzato, ritmico, molto decorativo,moderatamente sentimentale» 71. Proprio dall’impresa ro-mana sarebbe nato il successo davvero sovra regionale diPerugino, che da lì avrebbe imposto la sua interpretazioneaddolcita e ammorbidita della cristallina spazialità di Pieroin tutta Italia 72, uno stile antitetico a quello del Botticellitardo della Natività mistica (1501; Londra, National Gal-lery), raggiungendo una popolarità impensabile per qua-lunque fiorentino dell’epoca 73.Oltre venticinque anni dopo la conclusione dei lavori
nella Cappella Sistina Perugino sarebbe tornato a Roma,chiamato ancora da un pontefice Della Rovere, questa vol-ta Giulio II, per affrescare uno degli ambienti del suo nuo-vo appartamento in Vaticano, quello che in seguito sareb-be divenuto noto come la Stanza dell’Incendio (fig. 5). La
Giovanni Santi, che scriveva da un osservatorio più lonta-no, e quindi privilegiato, quale era Urbino, Piero, Botticel-li, Perugino, Ghirlandaio e Signorelli erano tutti, indistin-tamente, pittori «de Etruria» 58. Si potrebbe quindi pensa-re che anche a Roma Sisto IV guardasse a tutti loro sem-plicemente come a degli artisti toscani, sebbene provenientida varie città, ma se anche questo fosse vero, è certo chenon fosse così per i pittori stessi: secondo lo scrivente è mol-to improbabile che Botticelli o Ghirlandaio affiancasseroPerugino o Signorelli nell’esecuzione di un affresco59. Si trat-tava di artisti provenienti da città diverse, e nel Quattro-cento in Italia città era praticamente sinonimo di nazione 60.A fine Settecento Lanzi avrebbe scritto che Perugino era
per la scuola romana «il suo Masaccio, il suo Ghirlandaio,il suo tutto» 61. Da due secoli, ormai, Raffaello era conside-rato il padre della scuola romana, la sua vera ragion d’es-sere, e Raffaello era appunto, per Vasari come per Lanzi,un allievo diretto di Perugino 62. E risalendo indietro versole origini di quella scuola, Lanzi trovava giustamente Pierodella Francesca:
«Era Borgo [San Sepolcro] una parte dell’Umbria sog-getta alla Santa Sede, quando era nel suo miglior fiore Pie-ro della Francesca…Del resto nel disegno, nell’aria nel co-lorito delle figure par vedere un abbozzo di quello stile che
30
COMMENTARI D’ARTE
7. Raffaello, Galatea, Roma, villa Farnesina, Loggia di Galatea.
chiamata del Vannucci sembrerebbe davvero un omaggiodel nuovo, ambizioso pontefice alla memoria del grande zio:pochi mesi prima di venire a Roma Perugino aveva infattidovuto incassare le aspre critiche dei “nuovi aretifici” fio-rentini (con Michelangelo verosimilmente in testa) alla pa-la dell’altar maggiore della Santissima Annunziata, quellagrande ma fiacca Deposizione dalla Croce che egli aveva li-cenziato nell’ottobre del 1507 portando a termine l’operalasciata interrotta da Filippino Lippi alla sua morte (15 apri-le 1504; la tavola è oggi alle Galleria dell’Accademia di Fi-renze) 74. Ma sulla falsariga della grande impresa della Cap-pella Sistina era prima di tutto la decisione stessa di chia-mare pittori provenienti da tutta Italia 75. Nella vita di Gio-vanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, Vasari ricorda comeil pittore vercellese, ormai da tempo trasferitosi a Siena, ave-va ottenuto l’incarico di partecipare ai lavori decorativi delnuovo appartamento di Giulio II grazie ai buoni uffici diAgostino Chigi, e come lo stesso pontefice, alla vista delleprime, stupefacenti prove di Raffaello, avrebbe ordinato«che si buttasse in terra ogni cosa» dipinta sia da Sodomasia da Perugino. Il Sanzio, secondo il racconto vasariano,avrebbe però salvato, per «bontà e modestia», quando ave-va affrescato Perugino 76, sebbene oggi si tenda a ritenereche la decorazione della volta della Stanza di Eliodoro fos-se risparmiata solo per ragioni di economia di tempo; an-che parte dell’intervento di Sodoma sopravvive nella voltadella Stanza della Segnatura (fig. 6). Vasari ricorda anchegli affreschi eseguiti dall’altro senese, Baldassarre Peruzzi,nel «corridore in palazzo» e nella «uccelliera» 77 fatti co-struire da Giulio II al piano superiore a quello in cui si tro-vavano le stanze poi dette di Raffaello. Si trattava peraltrodi ambienti che facevano parte integrante dell’apparta-mento di Giulio II 78, ed è stato infatti ipotizzato che il mi-lanese Cesare da Sesto e il fiorentino Ubaldino d’AntonioBaldini, allievo di Ghirlandaio, intestatari insieme all’imo-lese Michele del Becca di pagamenti relativi agli affreschial piano superiore, abbiano lavorato anche nella sottostan-te Stanza di Eliodoro 79. Vasari, comprensibilmente, non ri-corda l’intervento di questi artisti, subito licenziati dal can-tiere per far posto alla gloria di Raffaello. E non ricordaneanche come a far parte di quella équipe internazionalefacesse parte anche un veneto, Lotto. I documenti di pa-gamento, come sempre, specificano la città di provenienzadegli artisti: sfilano quindi i nomi di «Baldinus Baldinis deFlorentia», «Cesar Iacobi de Mediolano», «BartholomeusSuardus de Mediolano alias Bramantino», «Johannes An-tonius de Bazis de Vercellis», «Michael del Becca de Imo-la», «Laurentius Lottus de Trevisio», e persino dell’olan-dese «Magister Johannes Ruisch clericus Traicectensis dio-cesis», prima che «Raphael Johannis Santi de Urbino» lisostituisse tutti 80. Come al tempo dei lavori nella CappellaSistina, la chiamata di un pontefice sembra non ammettes-se repliche, e in pochi mesi Giulio II aveva radunato a Ro-ma il più eterogeneo gruppo di pittori che mai si fosse vi-sto al lavoro in Italia. Perugino, come già detto, vantava
rapporti di vecchia data con la famiglia del pontefice, e nonc’è quindi motivo di indagare sulle ragioni che lo riporta-rono a Roma nel 1508. Non sappiamo invece se Cesare daSesto si trovasse già in città da prima: nel cantiere Vatica-no egli comunque strinse un fruttuoso sodalizio con Pe-ruzzi, poiché Vasari afferma che i due lavorarono insiemealla successiva impresa della decorazione dell’Episcopio diOstia (dove si riconosce anche la mano di Michele del Bec-ca) 81. Peruzzi, a sua volta, era a Roma già da qualche an-no: dopo aver disegnato la villa alle Volte per SigismondoChigi a Siena, egli era stato forse chiamato in città dal fra-tello del suo primo committente, il ricchissimo banchiereAgostino, ed aveva già lavorato a Civita Castellana e so-prattutto in Sant’Onofrio 82. Sigismondo Chigi in persona,ma forse sempre agendo attraverso il fratello, aveva racco-mandato al pontefice il Sodoma, che venne a Roma pro-prio per lavorare al cantiere in Vaticano, e dopo il licen-ziamento tornò subito a Siena 83. Anche Bramantino comeSodoma, venne a Roma solo perché chiamato a prendereparte a quell’impresa, e subito dopo, sempre come Sodo-ma, tornò in patria. Mentre non si può escludere del tuttola possibilità che Cesare da Sesto fosse già in città da qual-che anno e avesse prima stretto dei rapporti con Peruzzi 84,non ci sono dubbi che Bramantino e Lotto si recarono a
31
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
8. Sebastiano del Piombo, Polifemo, Roma villa Farnesina, Loggia di Ga-latea.
noto come Sebastiano del Piombo, che appena giunto incittà dovette misurarsi con il medium per lui inedito del-l’affresco. Agostino gli affidò infatti l’esecuzione delle lu-nette di una delle due logge della sua villa alla Lungara, no-ta dalla metà del Cinquecento come la Farnesina, della qua-le Peruzzi aveva già realizzato la decorazione delle volta conl’oroscopo del committente. In quelle lunette, secondo ilracconto vasariano, Sebastiano
«fece alcune poesie di quella maniera ch’aveva recato daVinegia, molto disforme da quella che usavano in Roma ivalenti pittori di que’ tempi» 86.
Le lunette conMetamorfosi da Ovidio di Sebastiano do-vettero fare subito un certa impressione nell’ambiente ro-mano, e subito dopo fu possibile vedere a diretto confron-to la tecnica ad affresco così inusuale adottata dall’artistaveneziano con quella, ormai consacrata dalle imprese vati-cane, di Raffaello. Questi, mentre il collega era probabil-mente ancora impegnato ad eseguire le lunette (inverno1511-12), affrescò su una delle pareti la celebre Galatea(fig. 7), da cui la Loggia stessa avrebbe poi preso il nome;subito dopo, accanto, Sebastiano vi aggiunse il suo Polife-mo (fig. 8). Sebastiano venne quindi messo in competizio-ne con l’Urbinate, in quello che è stato giudicato un pro-grammatico confronto, non più semplicemente fra pittoridi provenienze diverse, ma fra pittori che forse già per i con-temporanei dovevano rappresentare due linguaggi artisticichiaramente e profondamente diversi, il tosco-romano dauna parte e il veneto dall’altra 87, sebbene solo più tardi ne-gli scritti di Paolo Pino (Dialogo di pittura, Venezia 1548),Ludovico Dole (Dialogo della pittura, intitolato l’Aretino,Venezia 1557) e soprattutto nelle Vite dello stesso Vasari,quella diversità sarebbe stata discussa e teorizzata.
Roma perché espressamente chiamati per lavorare nell’ap-partamento dal pontefice. E per loro non ci fu un com-mittente come Sigismondo o Agostino Chigi a fare da in-termediario: fu con ogni probabilità Bramante, primo con-sigliere artistico di Giulio II, a contattare i due pittori. Ilpittore milanese, come dichiarava il suo stesso sopranno-me, si era formato in patria accanto al grande architetto ur-binate, ed è probabile che sempre Bramante, a Loreto nel1508, avesse avuto modo di conoscere ed apprezzare i di-pinti marchigiani di Lotto 85. Se Sisto IV, come già detto,per la decorazione della Cappella Sistina non aveva guar-dato più in là degli Appennini, Giulio II fu in grado di met-tere insieme un’équipe di pittori così straordinariamente rap-presentativa dell’Italia del tempo grazie soprattutto ai con-sigli di Bramante, già forte della sua esperienza sovra re-gionale maturata tra Urbino e Milano. Il programma uni-versalista della politica culturale di Giulio II era evidente,ma questo si sviluppò poi in modo del tutto inatteso. Conl’arrivo a Roma di Raffaello il pontefice decise di disfarsidel pluralismo rappresentato dalle diverse personalità deipittori convocati da tutta Italia per appoggiare la propostalinguistica di uno solo di loro, che sarebbe ulteriormentematurata a Roma per essere poi a sua volta esportata in tut-ta Italia con la diaspora degli artisti della sua scuola all’in-domani del Sacco di Roma del 1527.Che nella Roma di Giulio II si parlasse esplicitamente
di un possibile confronto fra i maggiori pittori delle diver-se regioni d’Italia è poi confermato da quanto messo in at-to nella sua villa suburbana dal mecenate più intelligenteche fosse in città in quella precisa congiuntura storica, ov-vero quell’Agostino Chigi che aveva già aiutato il pontefi-ce ad arruolare i migliori pittori senesi. A Venezia nel 1511,il banchiere riportò con sé a Roma uno dei più prometten-ti artisti attivi allora in città, Sebastiano Luciani, in seguito
32
COMMENTARI D’ARTE
NOTE
1 FERDINANDO BOLOGNA, La coscienza storica dell’arte d’Italia: introduzio-ne alla “Storia dell’arte in Italia”, Torino 1982, pp. 46-47 (per Ghiberti),70 e 80.2 F. BOLOGNA, La coscienza cit., p. 84; GIORGIO VASARI, Le vite de’ più ec-cellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testoa cura di ROSANNA BETTARINI, commento secolare di PAOLA BAROCCHI,Firenze 1966-1994, I, 1966, p. 1.3 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 516.4 CORNELIUS VON FABRICZY, Il codice dell’Anonimo Gaddiano (Cod. Ma-gliabechiano XVII, 17) nella Biblioteca Nazionale di Firenze, Firenze 1893,p. 117.5 Già nel 1446-47, in realtà, Michele Savonarola parla di ‘scuola’ per Pa-dova, ma non esattamente nel senso con cui lo avrebbero fatto in seguito,nel Cinquecento, Pietro Summonte e Giovanni Battista Paggi, cfr. MAR-CO COLLARETA, Scuola, in Dizionario della pittura e dei pittori, a cura di
ENRICO CASTELNUOVO e BRUNO TOSCANO, V, Torino 1994, pp. 129-131;LUIGI LANZI, Storia pittorica della Italia dal risorgimento delle belle arti finpresso al fine del XVIII secolo, a cura di MARTINO CAPUCCI, 3 voll., I, Fi-renze 1968, p. 259.6 Si veda, ad esempio, ANDRE CHASTEL, La grande officina: arte italiana1460-1500 (Paris 1965), Milano 1966; SERGIO GUARINO, Rinascimento aRoma: la pittura da Gentile da Fabriano al Giudizio di Michelangelo, Mi-lano 2004, p. 108.7 CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Pittori fiorentini al servizio dei papi, inMae-stri e botteghe: pittura a Firenze alla fine del Quattrocento, catalogo dellamostra (Firenze, Palazzo Strozzi) a cura di MINA GREGORI, ANTONIO PAO-LUCCI, CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Cinisello Balsamo (Mi) 1992, p. 271.8 L. LANZI, Storia pittorica cit., I, p. 68.9 L. LANZI, Storia pittorica cit., I, p. 273.10 Si veda, a puro titolo d’esempio, quanto scriveva nel 1914, a ventiquat-
tro anni, ROBERTO LONGHI nella Breve ma veridica storia della pittura ita-liana, con introduzione di CESARE GARBOLI, Firenze 1988, pp. 59-64 e 82-83. La gara tra Botticelli e Perugino nella Cappella Sistina, naturalmente,è già stata più volte commentata dalla critica (cfr. in particolare RONA GOF-FEN, Renaissance rivals: Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian, New Ha-ven 2002, pp. 20-22), ma qui si vuole sottolineare come si trattò non solodi un confronto fra due pittori rivali, ma anche fra due équipes di artistidi diversa provenienza regionale.11 SALVATORE SETTIS, GIOVANNI AGOSTI, VINCENZO FARINELLA, Passione egusto per l’antico nei pittori italiani del Quattrocento, in “Annali della Scuo-la Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia”, XVII, 1987,p. 1083.12 L. LANZI, Storia pittorica cit., I, p. 260.13 SYLVIA FERINO-PAGDEN, Perugino al servizio dei della Rovere: Sisto IV eil cardinale Giuliano (appunti per l’attività di Perugino a Roma), in SistoIV e Giulio II mecenati e promotori di cultura, atti del convegno interna-zionale di studi (Savona 1985) a cura di SILVIA BOTTARO, ANNA DAGNI-NO, GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO, Savona 1989, p. 53.14 Il documento è stato pubblicato più volte, cfr. ERNST STEINMANN, DieSixtinische Kapelle, I, Bau und Schmuck der Kapelle unter Sixtus IV, I, Mün-chen 1901, p. 633; LEOPOLD DAVID ETTLINGER, The Sistine Chapel befo-re Michelangelo: religious imagery and papal primacy, Oxford 1965, pp.120-121.15 ARNOLD NESSELRATH, The painters of Lorenzo the Magnificent in the Cha-pel of Pope Sixtus IV in Rome, in The fifteenth century frescoes in the Si-stine Chapel, Vatican City State 2003, pp. 56-59; cfr. anche ARNOLD NES-SELRATH, Perugino tra i pittori della Cappella Sistina, in Perugino: il divinpittore, catalogo della mostra (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria) acura di VITTORIA GARIBALDI e FRANCESCO FEDERICO MANCINI, CiniselloBalsamo (Mi) 2004, pp. 105-113.16 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 605.17 Per la stima del gennaio 1482 cfr. E. STEINMANN, Die Sixtinische Kapel-le cit., p. 634 e D.L. ETTLINGER, The Sistine Chapel cit., pp. 121-122.18 E. STEINMANN, Die Sixtinische Kapelle cit., p. 186; S. FERINO-PAGDEN,Perugino cit., p. 62.19 D.L. ETTLINGER, The Sistine Chapel cit., p. 26; JOHN MONFASANI, A de-scription of the Sistine Chapel under Pope Sixtus IV, in “Artibus et Histo-riae”, IV/7, 1983, p. 14.20 J. MONFASANI, A description cit., p. 12.21 HERBERT P. HORNE, Alessandro Filipepi commonly called Sandro BotticelliPainter of Florence, London 1908, pp. 74-75; CAROLINE ELAM, Art and Di-plomacy in Renaissance Florence, in “RSA Journal”, CXXXVI, 1988, p. 817.22 Ghirlandaio, infatti, a luglio è documentato ancora a Firenze, ma nonpiù a settembre (JEAN K. CADOGAN, Domenico Ghirlandaio: artist and ar-tisan, New Haven 2000, pp. 224-225): doveva quindi essere sceso a Ro-ma, probabilmente con Rosselli e Botticelli, nell’agosto di quell’anno.23 Per l’attribuzione dei pontefici ai vari artisti impegnati nella Cappellacfr. lo schema pubblicato in S. FERINO-PAGDEN, Perugino cit., p. 61.Non si può naturalmente escludere del tutto la possibilità che all’arrivodei pittori fiorentini a Roma, nel luglio-agosto del 1481, Perugino avessegià affrescato la parete d’altare. Si deve però sottolineare che dalle fontisi evince solo che nel marzo di quell’anno i lavori alla cappella erano so-stanzialmente terminati (cfr. nota 19), non che in quel preciso momentosi mettesse mano agli affreschi. A parere dello scrivente l’ipotesi più pro-babile, data la fretta estrema con cui tutta l’impresa venne portata avanti,è che i pittori fiorentini venissero mandati a Roma da Lorenzo il Magni-fico giusto in tempo per l’inizio dei lavori.24 È stato scritto che le disuguaglianze nel numero delle storie da affre-scare sarebbero state in qualche modo compensate anche dal diverso nu-mero dei ritratti dei pontefici già affrescati, poiché ad esempio Ghirlan-daio e Botticelli ne eseguirono di più di Cosimo Rosselli (J.K. CADOGAN,Domenico Ghirlandaio cit., pp. 225-226), ma il peso di una storia era in-comparabilmente maggiore di quello di due o tre figure di papi.25 Cfr., ad esempio, la pur sempre autorevole opinione di JOHN K. SHEAR-MAN, La storia della Cappella Sistina, in Michelangelo e la Sistina: la tecni-ca, il restauro, il mito, Roma 1990, pp. 25-26.
26 Di questa opinione è, ad esempio, CREIGHTON GILBERT, Signorelli, Lu-ca, in The Dictionary of Art, 28, London 1996, p. 700.27 L’attribuzione dell’affresco a Biagio d’Antonio è ormai accettata quasiuniversalmente, cfr. ROBERTA BARTOLI, Biagio d’Antonio, Milano 1999, pp.200-202.28 G. VASARI, Le vite cit., III, pp. 573 e 612-613; a Pier Matteo d’Amelia,come è noto, era stato probabilmente commissionata la decorazione del-la volta della Cappella, che forse non venne realizzata. Rocco Zoppo po-trebbe essere identificabile con il cosiddetto Maestro di Griselda, cfr. CREI-GHTON GILBERT, Griselda Master, in The Dictionary of Art, 20, London1996, p. 684.29 MARGHERITA LENZINI MORIONDO, Signorelli e Perugino, in Nel raggio diPiero: la pittura nell’Italia centrale nell’età di Piero della Francesca, catalo-go della mostra (Sansepolcro, Casa di Piero) a cura di LUCIANO BERTI, Ve-nezia 1992, p. 102; PIETRO SCARPELLINI, Il primo periodo romano, in Pin-toricchio, a cura di PIETRO SCARPELLINI e MARIA RITA SILVESTRELLI, Mila-no 2004, pp. 71-86; FRANCESCO FEDERICO MANCINI, Pintoricchio, Cinisel-lo Balsamo (Mi) 2007, p. 74; FRANCESCO FEDERICO MANCINI, Gli esordi diPintoricchio sulla scena romana, in Pintoricchio, catalogo della mostra (Pe-rugia, Galleria Nazionale dell’Umbria) a cura di VITTORIA GARIBALDI eFRANCESCO FEDERICO MANCINI, Cinisello Balsamo (Mi) 2008, pp. 49-51.30 LUCIANO BELLOSI, in Arte in Valdichiana: dal XIII al XVIII secolo, cata-logo della mostra (Cortona, Fortezza del Girifalco) a cura di LUCIANO BEL-LOSI, GIUSEPPE CANTELLI, MARGHERITA LENZINI MORIONDO, Cortona1970, p. 31.31 Vasari attribuisce esplicitamente a Signorelli i due ultimi affreschi delciclo neotestamentario, ma nella vita di Bartolomeo della Gatta affermache quest’ultimo lavorò nella Cappella con Perugino e Signorelli, cfr. G.VASARI, Le vite cit., III, pp. 460 e 628. Cfr. anche infra.32 Cfr. nota 26.33 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 480.34 J. MONFASANI, A description cit., pp. 9-18.35 RONALD LIGHTBOWN, Sandro Botticelli, 2 voll., London 1978, I, p. 94.36 Nessuno dei pontefici sopra le ultime scene dei due cicli veterotesta-mentario e neotestamentario è infatti attribuibile a Perugino. Poiché nes-suno dei ritratti sembra riferibile a Signorelli, è presumibile che questi nonfosse presente nel cantiere dall’estate dal 1481, cfr. S. FERINO-PAGDEN, Pe-rugino cit., pp. 61-62. Nessun ritratto è mai stato attribuito a Pinturicchio,ma forse la sua mano sarebbe meno riconoscibile di quella di Signorelli seegli lavorava su cartoni del suo maestro.37 Su questa questione cfr. S. FERINO-PAGDEN, Perugino cit., p. 62. JOHNK. SHEARMAN, La costruzione della Cappella e la prima decorazione al tem-po di Sisto IV, in La Cappella Sistina: i primi restauri, Novara 1986, p. 46.38 È impossibile che la pala d’altare si trovasse sotto i due episodi narrati-vi, poiché la Cappella era intitolata all’Assunzione, ed il pontefice atteseil 15 agosto del 1483 per consacrarla (cfr. nota 40): si trattava, quindi, del-l’immagine più importante. Inoltre non sarebbe stato accettabile che le fi-gure della pala d’altare fossero sensibilmente più piccole di quelle dei dueepisodi sovrastanti, né avrebbe avuto senso una pala d’altare così piccolain rapporto alle dimensioni di tutta la Cappella, cfr. D.L. ETTLINGER, TheSistine Chapel cit., pp. 23-22539 LOUISE RICE, The altars and altarpieces of new St. Peter’s: outfitting theBasilica, 1621-1666, Cambridge 1997, p. 216, figg. 109-110.40 Il francescano Sisto IV, come è noto, sostenne con forza il culto del-l’Immacolata Concezione, e l’immagine della Madonna assunta nella Cap-pella Sistina costituiva una variante dell’iconografia (peraltro non ancoracanonizzata) dell’Immacolata Concezione, cfr. RONA GOFFEN, Friar SixtusIV and the Sistine Chapel, in “Renaissance Quarterly”, XXXIX, 1986, pp.218-262, in particolare pp. 228-232. La decorazione di tutte le pareti erastata terminata, con ogni probabilità, nel marzo dell’anno precedente, mala Cappella non poté essere inaugurata il 15 agosto del 1482 poiché pro-prio in quel giorno le truppe di Roberto Malatesta, benedette dal Papa,marciarono su Roma, alla vigilia della Battaglia di Campo Morto: non po-teva esserci momento più inopportuno per la consacrazione della Cappelladel pontefice, e si dovette quindi attendere l’anno successivo, cfr. J. MON-FASANI, A description cit., p. 17.
33
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
ro. Certo Perugino non avrebbe avuto quel ruolo da protagonista che ave-va rivestito nella Cappella Sistina, e sarebbe stato anzi affiancato, sulla me-desima parete, da Biagio d’Antonio: anche questa circostanza potrebbe es-sere stata causa di attriti con la committenza.60 F. BOLOGNA, La coscienza cit., p. 45.61 L. LANZI, Storia pittorica cit., I, p. 273. Il concetto di scuola umbra sa-rebbe nato solo nel primo Ottocento ricevendo una vera e propria consa-crazione con il libro di Alexis François Rio, De la poésie chrétienne dansson principe, dans sa matière et dans ses formes. Forme de l’art, peinture,del 1836, cfr. DONATA LEVI, Cavalcaselle: il pioniere della conservazionedell’arte italiana, Torino 1988, p. 139.62 G. VASARI, Le vite cit., IV, p. 157; L. LANZI, Storia pittorica cit., I, p. 285.63 L. LANZI, Storia pittorica cit., I, pp. 270-271.64 ROBERTO LONGHI, Piero della Francesca, in Opere complete, 3, Firenze1963, pp. 76-77.65 NICHOLAS CLARK, Melozzo da Forlî pictor papalis, London 1990, p. 65(con bibliografia precedente).66 STEFANO TUMIDEI, Melozzo da Forli: fortuna, vicende, incontri di un ar-tista prospettico, in Melozzo da Forlì: la sua città e il suo tempo, catalogodella mostra (Forlì, Oratorio di San Sebastiano) a cura di MARINA FOSCHIE LUCIANA PRATI, Milano 1994, pp. 34-40.67 S. TUMIDEI, Melozzo da Forlì cit., p. 79, nota 192.68 La centralità di Roma per la maturazione del linguaggio melozzesco èstata sottolineata sempre da S. TUMIDEI, Melozzo da Forlì cit., 46-48.69 ANNA CAVALLARO, Antoniazzo Romano e gli Antoniazzeschi: una gene-razione di pittori nella Roma del Quattrocento, Udine 1992, pp. 70-71.70 Tumidei ha sottolineato la sostanziale estraneità della cultura figurativadi Melozzo dalla prolissità narrativa del programma iconografico della Cap-pella Sistina, cfr. S. TUMIDEI, Melozzo da Forlì cit., p. 79, nota 192. Masebbene la maggior parte degli affreschi della Cappella Sistina raffigurinoall’interno della stessa scena più episodi, Melozzo si sarebbe certo trova-to a suo agio a realizzare la Consegna delle chiavi a San Pietro, la storia più‘pierfrancescana’ di tutto il ciclo.71 PIETRO SCARPELLINI, I tempi di Perugino e Raffaello, in Pittura in Um-bria tra il 1480 e il 1540: premesse e sviluppi nei tempi di Perugino e Raf-faello, a cura di FRANCESCO FEDERICO MANCINI e PIETRO SCARPELLINI, Mi-lano 1983, p. 12.72 R. LONGHI (Piero della Francesca cit., pp. 82-83) parlava a ragione diuna “trasformazione a scopi sentimentali dello spazio di Piero”.73 GIOVANNI ROMANO, Verso la maniera moderna: da Mantegna a Raffael-lo, in Storia dell’arte italiana, 2, Dal Medioevo al Novecento, 2, Dal Cin-quecento all’Ottocento, 1, Cinquecento e Seicento, a cura di FEDERICO ZE-RI, Torino, 1981, pp. 26-28.74 Le critiche dei “nuovi artefici” fiorentini sono riportate da G. VASARI,Le vite cit., III, p. 609.75 GIOVANNI AGOSTI e VINCENZO FARINELLA (Qualche difficoltà nella car-riera di Cesare da Sesto, in Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, “Pro-spettiva”, 53/56, 1988/89, p. 327) hanno sottolineato come nei primi an-ni del secolo a Roma non fosse affatto infrequente la formazione ad hocdi équipes composte di pittori dalle provenienze più disparate. Ma questofu possibile proprio a seguito della chiamata a Roma di molti di quei pit-tori da parte del pontefice.76 G. VASARI, Le vite cit., V, p. 385.77 G. VASARI, Le vite cit., IV, p. 317.78 È stato suggerito, anzi, che l’ambiente poi denominato Uccelliera costi-tuisse in origine la biblioteca di Giulio II, cfr. GIOVANNI AGOSTI, VIN-CENZO FARINELLA, Interni senesi “all’antica”, in Domenico Beccafumi e ilsuo tempo, catalogo della mostra (Siena, Chiesa di Sant’Agostino e Palaz-zo Bindi Sergardi), Milano 1990, pp. 588-589.79 TOM HENRY, Cesare da Sesto and Baldino Baldini in the Vatican apartmentsof Julius II, in “The Burlington Magazine”, CXLII, 2000, pp. 29-35.80 JOHN SHEARMAN, Raphael in early modern sources (1483-1602), New Ha-ven 2003, 2 voll., I, pp. 122-128.81 G. VASARI, Le vite cit., IV, p. 317. Sugli affreschi dell’Episcopio di Ostiacfr. soprattutto VINCENZO FARINELLA,Archeologia e pittura a Roma tra Quat-trocento e Cinquecento : il caso Jacopo Ripanda, Torino 1992, pp. 132-159.
41 S. FERINO-PAGDEN, Perugino cit., pp. 58-59.42 J.K. SHEARMAN, La costruzione cit., p. 47.43J.K. SHEARMAN, La storia cit., p. 20.44 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 445.45 EDITH GABRIELLI, Cosimo Rosselli: catalogo ragionato, Torino 2007, pp. 44-45.46 R. LIGHTBOWN, Botticelli cit., p. 93.47 Allo scadere del secolo Rosselli non è neanche menzionati tra i maggio-ri pittori attivi a Firenze segnalati a Ludovico il Moro, allora in cerca diartisti da impiegare nella Certosa di Pavia. I nomi che venivano fatti inquell’occasione erano quelli di Botticelli, Ghirlandaio, Perugino e Filip-pino Lippi, e si specificava che tutti avevano lavorato alla villa dello Spe-daletto di Lorenzo il Magnifico (cantiere dal quale Rosselli era stato esclu-so) e che i primi tre erano stati impegnati anche agli affreschi della Cap-pella Sistina, cfr. MICHAEL BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nel-l’Italia del Quattrocento (Oxford 1972), Torino 1978, p. 24.48 MAURIZIO CALVESI, Significati del ciclo quattrocentesco della sistina, in Si-sto IV: le arti a Roma nel primo Rinascimento, atti del convegno internazio-nale di studi (Roma 1997) a cura di FABIO BENZI, Roma 2000, pp. 334-335.49 Sulla questione cfr. da ultimo PIETRO SCARPELLINI, Riflessioni sugli esor-di di Perugino e TOM HENRY, La formazione di Pietro Perugino, in Perugi-no: il divin pittore cit., pp. 47 e 73-7450 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 598.51 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 266.52 GIULIO BORA, I disegni del codice Resta, Cinisello Balsamo (Mi), p. 266,nota 10.53 DAVID FRANKLIN, The identity of a Perugian follower of Piero della Fran-cesca, in “The Burlington Magazine”, CXXXV, 1993, pp. 625-627; TOMHENRY, Perugino e Signorelli, in Pietro Vannucci, il Perugino, atti del con-vegno internazionale di studio (Perugia 2000), a cura di LAURA TEZA, Pe-rugia 2004, p. 78.54 PIETRO SCARPELLINI, Una postilla pierfrancescana: la scuola dell’artista trasettimo e ottavo decennio del Quattrocento, in “Commentari d’arte”, I, 1995,p. 25; Su Pietro di Galeotto cfr. anche FRANCESCO FEDERICOMANCINI, Iden-tificazione di Pietro di Galeotto, in “Esercizi”, II, 1979, pp. 43-55.55 Nell’edizione torrentiniana delle Vite Vasari si limitava a ricordare chePerugino aveva lavorato anche a Città della Pieve, e che una volta era sta-to derubato mentre andava e veniva tra Perugia e Città della Pieve; cheivi aveva acquistato “molti beni stabili” e che infine era morto in quellacittadina, cfr. Vasari, op. cit., III, pp. 596 e 610-611.56 G. VASARI, Le vite cit., III, p. 63357 F. BOLOGNA, La coscienza cit., pp. 43-44 e 59-60.58 F. BOLOGNA, La coscienza cit., pp. 59-60.59 Di opinione diversa, ad esempio, sono A. NESSELRATH, The painters ofLorenzo cit., pp. 50-51; e T. HENRY, Perugino e Signorelli cit., p. 75, fig. 2.Anche C. ELAM (Art and Diplomacy cit., p. 818), in riferimento ai pittoriattivi nella Cappella Sistina, ha parlato di un team di fiorentini che (conqualche sostituzione) sarebbe stato in seguito impegnato in altri due can-tieri, la decorazione di tre pareti della Sala dei Gigli in Palazzo Vecchio aFirenze (commissionata subito dopo, ma non realizzata; la prima pareteera stata affrescata immediatamente prima da Ghirlandaio) e quella per-duta della villa di Lorenzo il Magnifico allo Spedaletto. Più semplicementeFirenze aveva programmaticamente chiamato a lavorare nella Sala dei Gi-gli i pittori consacrati dall’impresa della Sistina (anche se non è possibileleggere in questa scelta una vera e propria ‘sfida’ al pontefice, come haipotizzato MELINDA HEGARTY, Laurentian patronage in the Palazzo Vec-chio: the frescoes of the Sala dei Gigli, in “The Art Bulletin”, LXXVIII,1996, pp. 275-276), ma questo non significa che Perugino fosse un vero eproprio collaboratore dei suoi colleghi fiorentini. Si deve anzi valutare at-tentamente una circostanza piuttosto strana: nel dicembre del 1482, ap-pena due mesi dopo la commissione degli affreschi della Sala dei Gigli,Perugino venne sostituito da Filippino Lippi, in un momento in cui nes-suno degli altri pittori coinvolti (Botticelli, Biagio d’Antonio e lo stessoGhirlandaio) avevano ancora iniziato a lavorarvi: non poteva trattarsi, quin-di, di inadempienza del pittore. Forse, per quella commissione pubblica,i fiorentini avevano alla fine deciso di non servirsi di un pittore forestie-
34
COMMENTARI D’ARTE
82 CHRISTOPH L. FROMMEL, “Ala maniera e uso delj bonj antiquj”: Baldas-sarre Peruzzi e la sua quarantennale ricerca dell’antico, in Baldassarre Pe-ruzzi, 1481-1536, a cura di CHRISTOPH L. FROMMEL, Venezia 2005, pp. 7-11. È possibile che Cesare da Sesto avesse già lavorato accanto a Peruzziagli affreschi di Sant’Onofrio, cfr. ANDREA BAYER, Cesare da Sesto, in TheDictionary of art, 6, London 1996, p. 355.83 Nei documenti si afferma espressamente: “Magnificus dominus Sigi-smundus Chisius promisit quod magister Johannes Antonius de Bazis deVercellis pictor in Urbe…”, cfr. J. SHEARMAN, Raphael cit., I, p. 125; cfr.anche ROBERTO BARTALINI, Le occasioni del Sodoma: dalla Milano di Leo-nardo alla Roma di Raffaello, Roma 1996, p. 113.84 Cfr. note 82-83.85 PETER HUMFREY, Lorenzo Lotto, New Haven 1997, p. 32. È stato ipo-tizzato che Lotto rimanesse poi a Roma e entrasse a far parte della botte-
ga di Raffaello attiva nelle Stanze, cfr. ARNOLD NESSELRATH, Lorenzo Lot-to in the Stanza della Segnatura, in “The Burlington Magazine”, CXLII,2000, pp. 4-12; ARNOLD NESSELRATH, Lotto as Raphael’s collaborator inthe Stanza di Eliodoro, in “The Burlington Magazine”, LXLVI, 2004,pp. 732-741.86 G. VASARI, Le vite cit., V, p. 87.87 ALESSANDRO BALLARIN (I Camerini di Alfonso I nella via Coperta ed inCastello: analisi dei documenti d’archivio; restituzione dei cantieri edilizi,cronaca della dispersione, in Il Camerino delle pitture di Alfonso, I, Citta-della (Pd) 2002, pp. 241-249) è stato il primo a sottolineare come l’ese-cuzione della Galatea e del Polifemo rappresenti un caso di vero e proprioconfronto fra la pittura tosco-romana e quella venezia. Su questi affreschidella Farnesina cfr. anche CHRISTOPH LUITPOLD FROMMEL, La Villa Far-nesina a Roma, Modena 2003, pp. 93-99.
35
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE