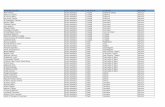Stefanini A, Bodini (2014), Salute e partecipazione della comunita’. Una questione politica....
Transcript of Stefanini A, Bodini (2014), Salute e partecipazione della comunita’. Una questione politica....
vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
SISTEMA SALUTELA RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE SANITARIA
E PROMOZIONE DELLA SALUTEgià Educazione Sanitaria e Promozione della Salute
Sistema Salute. La Rivista Italiana di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute è Organo del Centro sperimentale per l’educazionesanitaria dell’Università degli studi di Perugia. Già diretta da Alessandro Seppilli
Direzione e Redazione: Centro sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli studi di Perugia, via del Giochetto 6, 06126 Perugia / tel.:075.5857357-56-55 - fax: 075.5857361 / e-mail: [email protected] / www.unipg.it/csesi
Direttore responsabile: Filippo Antonio Bauleo, Azienda Sanitaria n. 2, Regione Umbria
Presidente del Comitato scientifico: Maria Antonia Modolo, Università degli studi di Perugia
Redattore capo: Lamberto Briziarelli, Università degli studi di Perugia
Segretario di redazione: Paola Beatini, Università degli studi di Perugia
Editing: Maria Margherita Tinarelli, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute
Autorizzazione del Tribunale di Perugia n. 4 del 17 febbraio 2012
Comitato scientifico: Bruno Benigni, Centro di promozione per la salute “Franco Basaglia” (Arezzo) / Mario Bertini, Società italiana di psicologiadella salute, già professore di psicologia, Sapienza Università di Roma / Francesco Blangiardi, Società italiana di igiene, medicina preventiva esanità pubblica, Dipartimento di prevenzione AUSL n. 7 della Sicilia (Ragusa) / Sabrina Boarelli, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria /Antonio Boccia, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, professore di igiene, Sapienza Università di Roma / FrancescoBottaccioli, Società italiana di psiconeuroimmunologia (Roma) / Lamberto Briziarelli, già professore di igiene, Università di Perugia / AntonioCappelli, Centro italiano ricerca sui servizi sanitari e sociali (Roma) / Carla Collicelli, Fondazione CENSIS (Roma), professore di sociologia dellasalute, Sapienza Università di Roma / Paolo Contu, professore di igiene, Università di Cagliari / Michele Conversano, Società italiana di igiene,medicina preventiva e sanità pubblica, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto / Giorgio Cosmacini, professore di storia della medicina,Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) / Claudio Cricelli, Società italiana di medicina generale / Barbara D’Avanzo, Dipartimento dineuroscienze, Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” (Milano) / Paola Di Nicola, professore di sociologia dei processi culturali ecomunicativi, Università di Verona / Floriana Falcinelli, professore di didattica generale e tecnologie dell’istruzione, Università di Perugia / CarloFavaretti, Health promoting hospital & health services network, Azienda ospedaliera-universitaria “Santa Maria della Misericordia” (Udine)/ Luigi Ferrannini, Società italiana di psichiatria, Dipartimento di salute mentale, ASL n. 3 della Liguria (Genova) / Irene Figà-Talamanca, giàprofessore di igiene, Sapienza Università di Roma / Fabrizio Fornari, Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara / Salvatore Geraci, Areasanitaria della Caritas Diocesana Roma / Mariano Giacchi, professore di igiene generale e applicata, Università di Siena / Guido Giarelli,European society for health and medical sociology, professore di sociologia generale, Università Magna Graecia (Catanzaro) / MargheritaGiannoni, professore di economia sanitaria, Università di Perugia / Marco Ingrosso, professore di sociologia generale, Università di Ferrara /Domenico Lagravinese, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, Dipartimento di prevenzione ASL Bari / GavinoMaciocco, Osservatorio italiano sulla salute globale, professore di politica sanitaria internazionale, Università di Firenze / Maurizio Mori, giàprofessore di medicina di comunità, Università di Perugia / Aldo Morrone, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazionimigranti ed il contrasto delle malattie della povertà, Roma / Pio Enrico Ricci Bitti, Società italiana di psicologia della salute, professore dipsicologia generale, Università di Bologna / Walter Ricciardi, European public health association, professore di igiene generale e applicata,Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) / Paola Rivosecchi, professore di metodologia epidemiologica e igiene, Università di Perugia /Roberto Romizi, Associazione internazionale dei medici per l’ambiente / Tullio Seppilli, già professore di antropologia culturale, Università diPerugia, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia) / Paolo Siani, Associazione culturale pediatri, Ospedale Cardarelli(Napoli) / Gianfranco Tarsitani, professore di igiene, Sapienza Università di Roma / Maria Teresa Tenconi, professore di igiene, metodologiaepidemiologica e medicina di comunità, Università di Pavia / Maria Triassi, professore di igiene generale e applicata, Università Federico II diNapoli / Enrico Tempesta, Osservatorio permanente giovani e alcol, Roma / Maria Giovanna Vicarelli, professore di sociologia dei processieconomici e del lavoro, Università Politecnica delle Marche (Ancona) / Mauro Volpi, professore di diritto costituzionale, Università di Perugia.
Comitato di redazione: Sandro Bianchi, Associazione culturale pediatri (sezione Umbria)/ Sabrina Flamini, Fondazione Angelo Celli per unacultura della salute (Perugia) / Fausto Francia, Dipartimento di sanità pubblica, AUSL Bologna / Patrizia Garista, Università di Perugia / EdvigeMancinelli, Università di Perugia / Giuseppe Masanotti, Università di Perugia / Liliana Minelli, Università di Perugia / Giovanni Paladino,Università Federico II di Napoli / Damiano Parretti, Società italiana di medicina generale (sezione Umbria) / Rossana Pasquini, Università diPerugia / Enrico Petrangeli, Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia) / Giancarlo Pocetta, Università di Perugia / CarloRomagnoli, ASL n. 2 dell’Umbria / Tiziano Scarponi, Società italiana di medicina generale (sezione Umbria) / Francesco Scotti, Gruppo tecnicointerregionale per la salute mentale, Regione Umbria.
261
263
266
270
271
277
284
290
295
308
Editoriale
Dibattito
Monografia
Indice vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
In questo numero
Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, edu-cazioneLamberto Briziarelli
Sul conflitto di interessiPaolo Vineis
Educazione Sanitaria, Servizio Sanitario, Partecipazione
Educazione sanitaria e salute pubblicaAlessandro Seppilli
Intervento alla Tavola Rotonda sulle Unità SanitarieLocaliAlessandro Seppilli
La popolazione: soggetto del sistemaAlessandro Seppilli
Riflessioni sull’educazione sanitaria. Esiste ancora l’edu-cazione sanitaria?Giancarlo Pocetta
Dalla parte della salute: il servizio sanitario nazionaletra prevenzione, cura e saluteFulvio Forino
Salute e partecipazione della comunità. Una questionepoliticaAngelo Stefanini, Chiara Bodini
vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014 Sommario
316
326
340
352
353
357
367
Altri contributi
Recensioni
Schede
Documenti
Notiziario
La promozione della salute attraverso i Social Media: unasfida per la sanità del futuro.Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, GiacomoScaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
La promozione dello screening mammografico: aspettidelle diseguaglianze nell’accessoGabriele Cavazza, Aldo Trotta
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezionisessualmente trasmissibili: la peer education inInAdolescenza-Guadagnare SaluteMarta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio,Antonella Ermacora, Giusy Famiglietti, Claudia Ratti
Oltre la crisi sistemica del Servizio Sanitario Nazionale:immaginare il futuro, a cura di Fulvio Forino, Dedalo 97
CULTURA È SALUTE. La Salute Pubblica a Perugia ein Umbria, attraverso i 60 anni del Centro Sperimentaleper l’Educazione Sanitaria dell’Università di Perugia.Concetti e immagini per promuovere Salute in Italia enel mondo, Perugia, 7-19 novembre 2014, Centro Spe-rimentale per la Promozione della salute e l’EducazioneSanitaria dell’Università degli Studi di Perugia
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 261-262
IN QUESTO NUMERO
Il Centro Sperimentale per la Promozionedella Salute e l’Educazione Sanitaria dell’Uni-versità di Perugia celebra il suo sessantesimoanno di vita. Fondato da Alessandro Seppillinel lontano 1954, oggi ha rinverdito la suaattività, con un nuovo Statuto al quale han-no aderito la Regione dell’Umbria, la Pro-vincia e il Comune di Perugia, nell’ambitodel Dipartimento di Medicina Sperimentaledell’Ateneo perugino, con un gruppo di gio-vani ricercatori per proseguire e ampliare ilcammino percorso sinora.Convinti che stiamo attraversando un mo-mento in cui si evidenzia ancora maggiore lanecessità di un più forte coinvolgimento eresponsabilizzazione dei cittadini nella tute-la e protezione della salute, per la ripresa diun rapporto fiduciario con il Servizio sanita-rio e le istituzioni che lo governano.Per la composizione di questo numero, nell’in-tenzione di sollecitare colleghi e lettori, è statadecisa la composizione di una Monografia dal
titolo Educazione sanitaria, Servizio Sanitarioe Partecipazione.Apre la monografia una serie di contributidel professor Alessandro Seppilli selezionatidal Comitato di redazione sugli specifici argo-menti. La scelta degli articoli è stata basatasul criterio delle “origini” di concetti e prin-cipi delle azioni, quale prova dell’antesigna-nità del Suo pensiero. Riaffermare i principi,non per vantare la primazia dell’“io lo avevodetto”, ma ad uso del tempo corrente perl’azione culturale che si vuole proseguire.Giancarlo Pocetta, Fulvio Forino, Angelo Stefa-nini e Chiara Bodini commentano e indicanogli sviluppi dei temi e le relative problema-tiche.Seguono la Monografia significativi studi elavori su temi di interesse e attualità.Segnaliamo il contributo di Fabrizio Bert etal che presenta una accurata revisione dellaletteratura sul ruolo dei Social Media e delWeb 2.0 per iniziative nell’ambito della edu-
262
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
cazione sanitaria e promozione della salute eanalizza potenzialità e rischi di tali mezzi dicomunicazione. Analisi e problematiche assaicoinvolgenti per tutti gli addetti ai lavori.L’articolo di Gabriele Cavazza e Aldo Trottapropone uno studio sulle disuguaglianze diaccesso ai programmi di prevenzione (scree-ning mammografico) realizzato a Bologna.L’analisi – molto dettagliata sotto il profilosocio-economico – ha riguardato anche ilconfronto sui livelli di non-adesione tra quar-tieri della città: i risultati offrono spunti di
riflessione davvero interessanti.All’educazione tra pari per la prevenzionedelle MST è dedicato il contributo di MartaDotto et al che riporta i risultati del progettonazionale InAdolescenza-Guadagnare Salute intermini di valutazione. La valutazione hacoinvolto tutti i soggetti partecipanti: stu-denti, peer educator e insegnanti.E’ parte del numero la Rubrica Dibattito cheriporta le riflessioni di Paolo Vineis sul temasignificativo e controverso del conflitto diinteressi nel mondo della ricerca.
Editoriale
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 263-265
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, edu-cazioneNow and forever (resistance) promotion, prevention, education
Lamberto Briziarelli
Sempre interrogandoci, dove siamo, dovestiamo andando, con gli occhi bene apertisulla società, “rerum cognoscere causas”,con le nostre radici di igienisti.Nei numeri immediatamente precedentiabbiamo “riesaminato” il cammino del-l’Igiene e l’evoluzione/involuzione del Ser-vizio Sanitario NazionaleOra, per i 60 anni del CSES risorto a nuovavita puntiamo la nostra attenzione sui prin-cipi strutturali, culturali e metodologici sucui si è sviluppata la nostra attività lungoquesto non breve cammino, partendo dallenostre stesse radici, gli elementi fondativielaborati dal nostro caposcuola.Allora, nel lontano 1954, erano stati postiper dare una risposta alle condizioni che ilPaese stava attraversando, con i piedi posa-ti sulle ceneri ancora fumanti di un incen-dio immane, il terremoto di scala dieci delsecondo conflitto mondiale; sono oggi an-cora validi, in quanto e come debbono esse-re rivisti, aggiornati, ammodernati di fron-
te all’oggi?Come è mutato il quadro, il contesto? Qualidifferenze caratterizzano l’oggi da ieri?Negli anni ‘50 quasi tutto era distrutto, ladignità di Nazione, l’economia, il territo-rio, l’assetto ideologico; una potenziale guer-ra civile incombeva sul Paese; come nonbastasse, nel campo sanitario sfide enormierano di fronte ad una collettività malape-na in piedi, la debolezza economica, l’insuf-ficiente copertura di bisogni primari, il pro-fondo mutamento della nosografia, la scom-parsa dei grandi flagelli, verso i quali ave-vamo però strumenti efficaci e l’affermarsidi patologie verso le quali la medicina e lasanità erano assai impreparate. Però era an-che il tempo delle grandi speranze, la vo-glia di ricominciare, la fiducia in un futuroche senza alcun dubbio sarebbe stato miglio-re, doveva essere per forza migliore.Dove siamo adesso? Pur riconoscendo che lastoria non torna mai sui suoi passi, dobbia-mo tuttavia constatare che la vita degli uma-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Ora e sempre (resistenza) promozione, prevenzione, educazione264
ni ha un andamento sinusoidale, un continuosenofontiano salire e scendere, per poi risali-re ed ancora scendere e così continuando.La situazione di oggi è senza dubbio moltodifferente, ricca, anzi ricchissima di poten-zialità, nell’abbondanza di risorse tecnolo-giche e strumentali e, limitatamente al no-stro Paese ed all’Europa, libera da ben set-tant’anni dal rombo dei cannoni e delle mi-traglie, dallo sferragliare dei cingolati, chetuttavia ancora risuonano appena oltre inostri confini, di mare e di terra. Dove tut-tavia nuovi muri, materiali e non, sono sta-ti già rialzati e stanno risorgendo.Ma le sfide che abbiamo di fronte non sonoseconde a quelle di allora, alcune certamen-te peggiori. Il crollo delle ideologie, la finedella dottrina di Yalta e la conseguente guer-ra fredda hanno portato all’affermazione diuna sola nuova dottrina, il capitalismo, cheha visto crollare completamente le sue fon-damenta di fronte alla globalizzazione, conl’affermarsi di una completa dominazionedella finanza sul resto dell’economia. Essendocrollato il comunismo anche la dottrinamarxiana, che aveva avvertito certi perico-li, era divenuta obsoleta. Un solo esempio,il Pil, strumento di misura del benessere,guida alle scelte dei Paesi e regolatore delledecisioni Comunitarie ha mostrato la suainconsistenza, un gigante dai piedi di argil-la che affonda nella palude del neoliberismosfrenato, del tutto incapace di indicare af-fettivamente il livello di vita delle popola-zioni cui si riferisce.Il muro più grande o, se si preferisce, il gran-de fossato, sono quelli che all’interno di cia-scun Paese e fra Paesi esistono fra ricchi epoveri, incommensurabilmente più grandirispetto al passato, ascrivendo alla secondacategoria ceti sociali che fino a pochi annior sono godevano di una relativa agiatezza;
i primi sono pochissimi e racchissimi, i se-condi un numero immenso, in continua cre-scita e sempre più poveri; le garanzie che apartire dagli anni settanta nel nostro Paeseerano a disposizione della quasi totalità de-gli individui, cittadini e non, sono messe inserio pericolo e comunque calano per i menoabbienti, ancorché presenti in linea di dirit-to. Per restare nel nostro campo grandi dif-ferenze esistono nell’assenza e presenza dimalattie, riguardo al diritto all’accesso alleprestazioni sanitarie, alla garanzia dellecure, alla sicurezza ambientale, tra generi,età, luogo di vita, condizioni di lavoro. Cit-tadinanza, abitudini sessuali, etnia, religio-ne sono ancora elementi di discriminazioneprofonda, quando avrebbero dovuto diven-tare ininfluenti nei rapporti societari, pari-tari nei diritti, come sancito già nei patticostitutivi dell’immediato dopoguerra.Ma, seppur differenti, altre grandi sfide ciminacciano e altrettanto grandi, crescendodi pari passo alla crescita delle potenzialitàpositive: morbi più gravi e pericolosi appa-iono e minacciano interi continenti, agentipatogeni verso i quali l’armamentario tec-nologico è impotente; un progressivo de-grado ambientale e crescita di fattori di ri-schio, senza indulgere al catastrofismo, sonosotto gli occhi di tutti e molti se ne stannoaccorgendo, ancorché la maggioranza seguitia comportarsi con proterva e decisa attitu-dine anti-ambientale.I venti di guerra che spirano, ancora fuoridel nostro continente, ci caricano tuttaviadi conseguenze indirette, con la necessità difornire aiuti alle popolazioni sotto attaccoe rifugio a coloro che sfuggono dalla perse-cuzione e dalla fame.E dunque ci troviamo non nelle stesse con-dizioni di allora ma con uguali problemi,molto diversi ma forse più difficili da risol-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Lamberto Briziarelli 265
vere; con la necessità di ricostruire non solole macerie materiali ma quelle morali, cul-turali e politiche, nel trovare nuove formedi convivenza e di cittadinanza, nel rico-struire i corpi intermedi su cui si basa lacostruzione democratica del Paese, nel ri-creare un rapporto di fiducia fra individui,fra questi e lo Stato, insomma in qualchemodo nel rifare ciò che fu fatto allora: rico-struire il Paese.E nel nostro campo, quello della salute edella sua salvaguardia, ci pare che le paroled’ordine, le linee guida non siano cambiate,
anche se gli strumenti operativi possonoessere diversi, adeguati al nuovo punto nelquale siamo oggi giunti. Ma i soggetti sonogli stessi, la centralità della persona e deisuoi bisogni, la parità, la dignità, il sensoresponsabilità, la comunità rimangono im-perativi aristotelici non negoziabili.Come dimostrano anche tutti coloro chehanno voluto ridiscutere con noi sulle paro-le chiave che hanno informato il nostro la-voro, da Alessandro Seppilli in avanti, conle nuove generazioni che percorrono ancoraquel cammino.
Dibattito
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 266-269
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Nel recente Summit delle Nazioni Unitesul cambiamento climatico per l’ennesimavolta si è ribadito che il problema esiste edè urgente (la CO2
è arrivata ai livelli record
di 396 ppm). A fronte della riconosciutaurgenza, tuttavia, non si assiste a un inter-vento deciso ed energico della politica edell’industria. La ricerca di soluzioni ener-getiche alternative e una riconsiderazioneprofonda delle attuali modalità della pro-duzione e dell’uso dell’energia non è ai pri-mi posti delle agende. Uno degli aspetti piùpreoccupanti è l’esistenza di forti conflittidi interesse. Il conflitto di interessi è unodei temi emergenti nel mondo della ricer-ca. Perché la cosa desta preoccupazioni, comeho argomentato in un seminario cui sonostato invitato a parlare a Helsinki su con-flitti di interesse e cambiamento climati-co? Vediamo due esempi.
Sul conflitto di interessi*Conflict of interess
Paolo VineisImperial College London
* Questo testo è tratto, con alcune modifiche, da un capitolo del libro di Paolo Vineis “Salute senza confini”,Codice Editore Torino 2014, ed è stato oggetto di un seminario presso il FIOH di Helsinki il 22 settembre2014.
Primo, la grande industria ha creato orga-nizzazioni sistematicamente volte a instil-lare dubbi sulla bontà della scienza del cam-biamento climatico. Come documenta beneil libro di Oreskes e Conway, Merchants ofDoubt (2010) ci sono diversi modi per get-tare discredito su una tesi scientifica, unodei quali è sollevare costanti dubbi sullavalidità delle prove: è stato fatto storica-mente per il fumo di sigarette, per le piog-ge acide, per l’ozono, per i pesticidi e re-centemente per il riscaldamento globale.Uno degli attacchi più violenti alla tesi delriscaldamento globale è stato pubblicato il27 gennaio 2012 sulle colonne del Wall Stre-et Journal, in un appello firmato da 16 scien-ziati e intitolato “Nessun motivo per esse-re presi dal panico per il riscaldamento glo-bale”. Ai sei punti principali sollevati daicritici ha risposto William Nordhaus, un
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
267Paolo Vineis
economista di Yale che ha dedicato anni allostudio del cambiamento climatico. Nor-dhaus ha mostrato che tutte le argomenta-zioni dei 16 erano faziose e facilmente con-futabili. Ovviamente i 16 contestatori era-no sostenuti dall’industria del petrolio. Ilsecondo esempio è un articolo recente sututt’altro argomento, il ruolo delle bevan-de gasate zuccherate nell’influire sul rischiodi cancro (Boyle e altri, European Journalof Public Health, 2014). Anche di questoha discusso il seminario di Helsinki. L’arti-colo, seguendo le norme editoriali di molteriviste, include nei ringraziamenti la Coca-Cola (che ha finanziato lo studio) ma so-stiene anche che “Gli autori non hanno con-flitti di interesse”. Qui sorge la perplessitàprincipale su un modo comune (anche daparte delle riviste scientifiche, di gestire ilconflitto: la “disclosure” non è sufficiente.Come ha concluso il seminario di Helsinki,“la trasparenza non basta”, non basta cioèdichiarare che si lavora per una certa indu-stria quando si pubblica un articolo scienti-fico: questo non evita infatti l’oggettiva esi-stenza di un conflitto. Secondo tutte le de-finizioni il conflitto di interessi deriva dauna situazione in cui un “agente” (un ricer-catore o un politico, o anche un giornalista)ha un obiettivo primario cui mirare ma ancheun obiettivo secondario che confligge con ilprimo. Il bene primario cui deve tendereun ricercatore che lavora in epidemiologiao in sanità pubblica è la salute della popola-zione, così come l’obiettivo primario delmedico è la salute del singolo paziente. Ilricercatore cade in un conflitto quandol’obiettivo primario confligge con un obiet-tivo secondario che può essere il profitto, lasua carriera, ecc. Nel caso del politicol’obiettivo secondario può essere la rielezio-ne, il finanziamento della campagna eletto-
rale, ecc. Può sembrare banale, ma eviden-temente non lo è: le riviste scientifiche con-tinuano ad accontentarsi della “disclosure”,cioè di dichiarazioni come quella citata so-pra, che non risolvono ma semplicementeportano alla luce il conflitto di interessi.
Nel discutere il conflitto di interessi vi sonoampie differenze culturali tra nazioni: negliStati Uniti è comune l’attività di lobbyinge perfino il fenomeno della “revolving door”,cioè di uomini d’affari che entrano in poli-tica e poi tornano all’impresa. Ma ancheentro l’Europa vi sono grandi differenze. Lamia esperienza personale in due organismigovernativi, uno in Italia e uno in Inghil-terra, è stata istruttiva. Nel Consiglio Supe-riore di Sanità italiano - come in molte isti-tuzioni del nostro paese - non è stato chie-sto a nessuno (almeno finchè ne ho fattoparte) di dichiarare conflitti di interesse,anche se gran parte delle deliberazioni era-no il frutto di negoziazioni tra corporazioni(gli infermieri, gli ortopedici, i chirurghiplastici, ecc.), per esempio nella approva-zione di nuove scuole di specializzazione.In altre parole in Italia la negoziazione è lanorma, le procedure sono blande, e l’esitoè fondamentalmente condizionato da comeciascun attore percepisce la posizione cheoccuperà al termine del processo. Nel Com-mittee on the Carcinogenicity of Chemicals delMinistero della Sanità inglese (un’altra espe-rienza personale) vi è apparentemente più enon meno conflitto di interessi, perchè al-l’industria è concesso farne parte. Tutti de-vono dichiarare il conflitto caso per caso, aseconda delle sostanze di cui valutare la can-cerogenicità. Di fatto, però, il processo èguidato da procedure scientifiche, e il posi-zionamento di ciascuno rispetto agli esiti èsecondario rispetto a una valutazione equi-
268
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Sul conflitto di interessi
librata delle prove. Detto in breve, in In-ghilterra le prove prendono il sopravventosugli interessi, in Italia gli interessi sulleprove (usando il termine “interessi” in sen-so molto lato, non solo quelli economicima anche quelli corporativi). A mio avvisonessuno dei due modelli è ideale; certamentenon quello italiano per il ruolo secondariodella prova, ma neanche quello inglese ovel’industria viene a trovarsi in un ruolo quasiparitario. Rispetto a entrambi è certamen-te preferibile il modello IARC: procedurerigorose, basate sull’evidenza, e trasparenzanei conflitti di interesse con un ruolo esclu-sivamente di osservatori per i rappresentantidell’industria. Questo modello rispecchiaquello che a mio avviso è il principio piùalto stabilito per garantire il funzionamen-to di una democrazia, quello di John Rawlsdetto del “velo di ignoranza”: chi è chiama-to a decidere su una questione pubblica nondeve essere influenzato dalla posizione cheoccuperà come conseguenza della decisio-ne, cioè deve decidere “dietro il velo di igno-ranza”. In tal senso non si vede perchè inItalia le riforme elettorali debbano esserefatte dai partiti, che ne sono i maggiori be-neficiari. Questi temi sono stati largamen-te ripresi - con significative differenze - dalmaggiore rappresentante oggi dell’etica pub-blica, Michael Sandel.
Il conflitto di interessi è molto più diffusodi quanto crediamo ed è spesso sfumato e lasua regolamentazione dovrebbe essere affi-data alle consuetudini e non solo ai regola-menti. Il conflitto di interessi non è esclu-sivamente un portato della corruzione (ovel’Italia è un caso estremo). Per esempio,costituisce un conflitto di interessi entro unastruttura di ricerca il fatto che un direttoredi Dipartimento utilizzi le risorse materia-
li e umane principalmente per gli scopi delproprio laboratorio, anzichè essere super par-tes (in effetti trovare persone limpidamentesuper partes non è comunissimo). Ma esisto-no elementi di conflitto di interessi - al-l’estremo opposto - quasi istituzionalizzatio promossi a livello societario. Ne è unesempio l’enfasi della UE sulla commercia-bilità dei prodotti della ricerca e sull’im-patto comunitario inteso come impatto eco-nomico, di cui ha esperienza chi ha fattodomande di finanziamento alla Commissio-ne. Nel caso del cambiamento climatico, èpossibile - anche se non necessario - chemolte delle soluzioni tecnologiche volte amitigarlo o prevenirlo abbiano un impattoeconomico negativo, e non si traducano invantaggi economici immediati per “small-medium enterprises”. Questo è un conflitto diinteressi nella misura in cui l’insistenza sul-le ricadute economiche finisce per distorce-re la scelta e il disegno di indagini che -lasciate alla sola razionalità della ricerca -potrebbero andare in una direzione diversa.Altri esempi vengono alla mente: spin-offdi Università - creati per commercializzarei prodotti della ricerca della stessa Univer-sità - vengono promossi dalle istituzionifinanziatrici, ma talvolta ciò che è stato sco-perto non ha le virtù che vengono pubbli-cizzate. Un esempio è il kit per identificarele persone che hanno maggiore difficoltà asmettere di fumare, basato sul gene DRD2,con valutazioni contrastanti tra gli articoliscientifici e le promesse commerciali.
Lo stesso mondo della comunicazione è af-fetto da conflitto di interessi. L’obbrobriocostituito dalla par condicio ne è un esem-pio. Non c’è nessun motivo per cui chi so-stiene che i campi di concentramento nonsono esistiti debba avere lo stesso spazio
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
269Paolo Vineis
mediatico di chi sostiene il contrario; laprima teoria è semplicemente falsa, punto.La par condicio è nata in una condizione digrande litigiosità politica e mediatica ed èspesso servita a dare dignità a posizioni chemeriterebbero molta meno pubblicità, comeil negazionismo climatico. La par condicioserve a creare cortine fumogene, attività incui si sono letteralmente specializzati isti-tuti creati dall’industria come il Cato Insti-tute. Dall’altro lato serve agli scopi scanda-listici e spettacolaristici dei mezzi di infor-mazione.
Fino a che questi problemi non verrannochiariti a livello societario è difficile che riu-sciamo a trovare risposte convincenti allegrandi sfide come il cambiamento climati-co. La soluzione non è soltanto la regola-mentazione con regole dettagliate: sappia-mo in Italia che troppe regole possono es-sere controproducenti. Trovo molto effica-ce l’approccio di Sandel basato sul concettosostanziale e non solo procedurale di eticapubblica. Il problema è che le sedi per eser-citare l’etica pubblica e discuterne i presup-posti e le applicazioni sono ben poche. Latendenza largamente discussa da ZygmuntBauman nei suoi libri è la perdita della strut-turazione della società (in quelle che lui chia-ma società liquide) nei tre livelli della mi-crostruttura (la famiglia), la mesostruttura(i partiti, il sindacato, i movimenti) e lamacrostruttura (la società nel suo insieme,
e l’economia). Il cambiamento climatico sista realizzando congiuntamente a una so-stanziale scomparsa delle mesostrutture,sostituite da un rapporto diretto tra gli in-dividui attraverso la rete telematica, eun’ipertrofia delle megastrutture (l’assolutopredominio dell’economia e della finanza).Le conseguenze di questa trasformazionesono tutte da identificare, ma segnano chia-ramente la fine del Novecento, quell’era incui l’etica pubblica veniva discussa nellamesostruttura - come i partiti, le Chiese - esi riverberava sulla microstruttura (le fami-glie). Pertanto, la più grande crisi ecologicadell’umanità si svolge congiuntamente alpiù grande mutamento comunicativo e de-cisionale. Gli stessi concetti sono statiespressi in modo più semplice ma magistraledal grande storico Tony Judt: “I giovani sonoindubbiamente in contatto con i loro similia distanza di migliaia di miglia. Ma anchese gli studenti di Berkeley, Berlino e Ban-galore condividono un insieme di interessisimili, questi non si traducono in una comu-nità. Lo spazio conta. E la politica è funzio-ne dello spazio ...” (Judt, 2010, p. 121). Eancora, a proposito dell’erosione del rispet-to per la sfera pubblica: “Una volta che ces-siamo di dare valore al pubblico anzichè alprivato, prima o poi avremo anche difficol-tà a capire perchè dovremmo dare più valo-re alla legge (il bene pubblico per eccellenza)piuttosto che alla forza” (p. 129).
BIBLIOGRAFIAJudt T. Ill fares the land. Penguin Books, London 2010.Oreskes N, Conway EM. Merchants of doubt.Bloomsbury, New York, 2010
Sandel M. Public philosophy. Harvard UniversityPress, Cambridge (Ma.), 2005
Monografia
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 270
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Educazione Sanitaria, Servizio Sanitario, Partecipazione
Tre contributi di Alessandro Seppilli (1902-1995) – Educazione Sanitaria (1958), Interven-to alla Tavola rotonda sulle Unità Sanitarie Locali (1969) e La popolazione: soggetto delsistema (1971) – compongono la parte iniziale della Monografia. Nel primo sono postebasi concettuali, scopi e contesti dell’educazione sanitaria, nel secondo una anticipatrice ecompleta visione del servizio sanitario nazionale italiano. Infine un contributo sul ruolocentrale della popolazione nel progetto di Riforma.Una sollecitazione alla riflessione per esperti di sanità pubblica: Giancarlo Pocetta esami-na le possibilità di nuovi percorsi per rilanciare e rimotivare un discorso sull’educazionesanitaria oggi; Fulvio Forino descrive la crisi sistemica – culturale, organizzativa e gestio-nale – che attanaglia attualmente il nostro Servizio Sanitario;Angelo Stefanini e Chiara Bodini indagano e riaffermano la partecipazione della comunitàcome processo politico.L’insieme dei lavoro al fine di accendere il dibattito e il confronto su temi centrali dei nostristudi e delle azioni.
Health Education, Health Service, Partecipation
The Monography begins with three contributions by Alessandro Seppilli (1902-1995) –Health Education (1958), Speech at the workshop on local health units (1969) and Thepeople as subject of the system (1971). The first one illustrates the conceptual foundations,aims and contexts of health education, while the second provides a pioneering and com-plete vision of the Italian National Health Service. Finally, a contribution on the crucialrole played by the people within the project of reform.Experts of public health are invited to reflect: Giancarlo Pocetta examines new ways topromote health education these days; Fulvio Forino describes the systemic crisis – whichis a cultural, organizational and management one as well – that our Health System is nowexperiencing; Angelo Stefanini and Chiara Bodini explore community participation andreaffirm it as a political process. The three contributions differ deeply, reflecting the diffe-rent ways of responding the issues that arose through the basic documents.The whole work is aimed at enriching the debate on issues which are central to our studiesand actions.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 271-276
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Educazione sanitaria e salute pubblica*Health Education and Public Health
Alessandro Seppilli
* Lezione conclusiva tenuta al I° Corso estivo di Educazione Sanitaria, Perugia 1958
Definizione, scopi e premesse del-l’educazione sanitariaLe lezioni precedenti spero abbiano servito adimostrare che l’Educazione Sanitaria non èuna cosa semplice e, tanto meno, che si pos-sa facilmente improvvisare.Ciò che è stato detto in questo Corso da esper-ti di diversa formazione professionale e piùancora le vostre discussioni di gruppo e lapreparazione del materiale didattico che voistessi avete realizzato, vi debbono avere con-vinti della necessità di una seria e complessapreparazione e di una duttile e sensibile arti-colazione perché l’opera dell’educatore sani-tario possa in effetti raggiungere i suoi scopi.Cerchiamo di definire questa «EducazioneSanitaria». Abbiamo veduto che essa noncostituisce un semplice travaso di cognizionidal docente al discente; né possiamo identi-ficarla con la propaganda igienica, dalla qua-le, al contrario, profondamente differisce. Lapropaganda igienica, come ogni altra formadi propaganda, si rivolge prevalentemente
all’inconscio, senza richiedere una coscienteelaborazione dei temi da essa proposti. Voisapete che, al limite, la propaganda può diri-gersi all’inconscio saltando addirittura il con-trollo della coscienza: gli esperimenti realiz-zati con la così detta «propaganda sublimi-nare» dimostrano tale possibilità. Inserendoin un film a soggetto, a distanza convenien-te, dei fotogrammi propagandistici, senzanessun legame con il resto delle proiezioni,tali fotogrammi non vengono percepiti dallacoscienza, ma l’occhio li capta e li trasmetteai centri nervosi e il comportamento del sog-getto ne rimane influenzato senza che questise ne accorga. Senza arrivare a questi estre-mi, gran parte della moderna propagandacommerciale è diretta a raggiungere lo stes-so risultato: noi non «vediamo» più un grannumero di cartelli pubblicitari, ma la loropresenza ci condiziona ugualmente e ci in-fluenza nelle nostre scelte. Non si vuole esclu-dere con questo che l’educatore sanitario nonpossa servirsi, in alcuni casi determinati, dei
272
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Educazione sanitaria e salute pubblica
metodi della propaganda, per ottenere risul-tati rapidi di fronte a problemi urgenti e inambienti dove l’opera educativa non abbiamodo di svilupparsi. Ma non è questa la fun-zione fondamentale dell’educatore sanitario.Come ogni altra branca dell’educazione, an-che l’educazione sanitaria richiede la parteci-pazione attiva del discente.«L’Educazione Sanitaria è un intervento socia-le, che tende a modificate consapevolmente edurevolmente il comportamento nei confrontidei problemi della salute. Essa presuppone laconoscenza del patrimonio culturale del grup-po discente e la focalizzazione dei suoi inte-ressi soggettivi, e richiede la rimozione delleresistenze opposte dal gruppo stesso all’in-tervento».Questa definizione, provvisoria, che io sot-topongo alla vostra analisi critica, vuole rias-sumere le premesse e le esigenze di una effi-cace educazione sanitaria: se saremo ben con-sapevoli di tali premesse e di tali esigenze, lanostra opera potrà agire in profondità e an-drà a costituire parte del patrimonio cultu-rale del gruppo sul quale operiamo. Non ri-torno sull’analisi delle singole parti di questadefinizione, perché questa è già stata fattanelle lezioni precedenti: richiamo soltanto lavostra attenzione sulla indispensabilità di cia-scun elemento della definizione stessa e par-ticolarmente su quel termine «focalizzazio-ne» degli interessi soggettivi, che indical’identificazione di quella che potremmochiamare, con un paragone epidemiologico,la «via di penetrazione» del nostro insegna-mento.
ProgrammazioneCiò premesso, quando ci si accinge ad unacampagna di educazione sanitaria, dovremoprocedere alla scelta: del contenuto, dei mez-zi idonei e dell’educatore a ciò destinato. Non
ho nulla da aggiungere ai primi due termini,particolarmente al secondo, dopo quanto viè stato riccamente illustrato nelle lezioni pre-cedenti nelle esercitazioni di gruppo. Piutto-sto richiamo la vostra attenzione sul terzoelemento: la scelta dell’educatore.Noi distinguiamo, in genere, due forme dieducazione sanitaria: l’educazione diretta equella indiretta. La prima si rivolge al grup-po discente senza mediazione, o tutt’al più,con l’assistenza di quei «mediatori fiduciari»di cui già vi è stato fatto cenno, che rappre-sentano una specie di avallo, di garanzia, chel’educatore sanitario offre al gruppo, quandonon sia sufficientemente noto e stimato daesso. L’educazione diretta si fa agli adulti edin genere a gruppi che possono ricevere il no-stro linguaggio e comprenderlo senza biso-gno di «traduzione».Ai bambini, particolarmente nelle scuole ele-mentari, l’educazione sanitaria diretta non èpossibile. Ad essi deve parlare il maestro, il«loro» maestro, con il suo linguaggio e inse-rendo l’educazione sanitaria nell’insegnamen-to globale, che è una conquista della pedago-gia moderna, che va rispettata. E poiché nonè pensabile che tutti i maestri si trasforminoin educatori sanitari, essi dovranno riceveredall’educatore sanitario la preparazione ne-cessaria a svolgere questa parte della loromissione. Meglio se, in questo caso, l’educa-tore sanitario sarà anche esso un maestro,consapevole delle condizioni e delle esigenzein cui dovrà operare il suo discepolo media-tore. Naturalmente l’educatore sanitario,anche in questa sua attività, dovrà trovare illinguaggio e le tecniche più appropriate, senzasdottorare o impancarsi a insegnante dell’in-segnante, ma cercando invece di collaborarecol collega, fornendogli il materiale informa-tivo necessario e assistendolo nella sua pre-parazione, in questo settore inevitabilmente
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
273Alessandro Seppilli
ostico e difficile per lui.Nella programmazione della campagna edu-cativa deve trovare posto anche la predispo-sizione di un piano di controllo dei risultati,poiché sarebbe impossibile eseguire tale con-trollo, a campagna ultimata, se non lo aves-simo previsto sin dall’inizio della campagnastessa, raccogliendo anche i dati necessari alconfronto delle condizioni prima e dopo ilnostro intervento.Così, ad esempio, una campagna di vaccina-zione supportata da una campagna educativanella popolazione non ci consentirebbe digiudicare l’efficacia del nostro intervento senon avessimo prima raccolto con esattezzale condizioni di partenza e non avessimo pre-disposto sin dall’inizio la rilevazione dei datidi arrivo.
EsecuzioneNello svolgimento dell’educazione sanitariail momento essenziale rimane quello dellarimozione delle resistenze.Non basta il buon senso, non basta la sensi-bilità improvvisata dell’educatore: è neces-sario, come si è detto, in principio, identifi-care tali resistenze, conoscerne le cause e cer-care di rimuoverle con i mezzi di cui dispo-niamo, facendo consapevole la popolazionedi questi nostri sforzi e non cercando di car-pirne la buona fede, sia pure a fin di bene.Al termine dell’intervento, poi, si dovrà sem-pre compiere una indagine seria e sistemati-ca di controllo dei risultati, sulla guida di quantoinizialmente disposto prima dell’intervento.
Problemi organizzativiSi è accennato in vari interventi, durante ilcorso, al problema della iniziativa, in campodi educazione sanitaria.In Italia si può dire che fino ad oggi non esi-ste quasi nulla, se si eccettuano pochissime,
lodevoli iniziative locali, in alcuni dei Co-muni maggiori. In Inghilterra, dove l’educa-zione sanitaria ha raggiunto un livello moltoelevato (certamente il più elevato nell’Euro-pa Occidentale) esiste una rete organizzativache copre tutto il territorio nazionale e cheha i suoi nodi negli Uffici Sanitari periferici.Chi deve prendere da noi, l’iniziativa? Lo Sta-to o gli Enti locali, o Enti sorti per iniziativaprivata, come quelli già esistenti in alcunecittà tra cui lo stesso Centro di Perugia? Disolito, in Italia, queste cose nascono dal con-fluire di iniziative multiple diverse: è ciò chesta verificandosi attualmente anche in que-sto campo.La creazione del Ministero della Sanità pone,a mio avviso, l’esigenza fondamentale di unainiziativa centrale. Gli uffici sanitari provin-ciali sono oggi indubbiamente i più qualificatiper offrire «in nuce» un servizio di educazionesanitaria modernamente organizzato.Con questo Corso il nostro Centro ha comin-ciato la preparazione del personale addestra-to a tale ufficio: in un tempo ragionevole nondovrebbe essere difficile poter disporre di al-meno un educatore sanitario per ogni ufficiosanitario provinciale. Tanto meglio se i Co-muni maggiori vorranno fare altrettanto eseguire l’esempio di Perugia che dispone giàdi un educatore sanitario altamente qualifi-cato e di alcune A.S.V. preparate in questosettore.Il Comune di Perugia ha organizzato una retedi «Comitati frazionali di Educazione Sani-taria» che fanno capo al medico condotto ela cui attività viene coordinata dal «Comita-to Comunale di Educazione Sanitaria».La produzione del materiale didattico (flanel-le, filmine, films, pieghevoli, volantini, car-telloni) potrebbe essere sviluppata a cura deiCentri che già provvedono a tale attività. Peri films, ad esempio, il Centro di Cinemato-
274
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Educazione sanitaria e salute pubblica
grafia Sociale di Trieste ed il Centro per laEducazione Sanitaria di Milano; per le fla-nelle abbiamo già preparato parecchio ma-teriale qui a Perugia. Altrettanto potrebbedirsi per le filmine, i pieghevoli, i cartello-ni. La nostra rivista, che è l’unica del generein Italia, costituisce la naturale palestra perlo scambio delle esperienze, per l’incontrodi suggerimenti è proposte, per la informa-zione tecnica su quanto viene preparato erealizzato in Italia e all’estero nel nostrocampo.Queste le grandi linee dei problemi organiz-zativi, come si offrono a noi, in questo mo-mento. Naturalmente, in prospettiva, mol-to di più si potrà fare se, al centro ed allaperiferia, riusciremo a sollecitare la respon-sabile sensibilità degli organi preposti alladifesa della salute pubblica ed alla formazio-ne educativa delle popolazione.Noi vorremmo che anche presso ciascunProvveditorato agli Studi potesse essere pre-sente un educatore sanitario qualificato, perassistere il Provveditore in questo campo eorganizzare la preparazione degli insegnantinel settore. Vorremmo che tutto il corpo in-segnante, di ogni ordine e grado, potesse es-sere raggiunto da una rete capillare che ope-ra l’intero territorio nazionale: ma per que-sto è prima indispensabile formare gli edu-catori sanitari, e non è opera che si realizziper incanto o per decreto legge.
1. Maggiori problemi della salute pub-blica e l’educazione sanitariaPer quanto attiene al contenuto, l’educazio-ne sanitaria non può trattare che argomentidi igiene, e, con qualche riserva, di medicinapreventiva. L’igiene ha per scopo la conserva-zione ed il potenziamento dello stato di sa-lute; in altre parole non si preoccupa soltan-to di evitare le malattie, ma svolge anche
un’azione positiva per assicurare a ciascunindividuo il massimo di efficienza fisica con-sentita dalla sua costituzione e dai suoi pre-cedenti morbosi. La medicina preventivaconfina con l’igiene e comprende pratichemediche, tendenti a evitare aggravamenti ocomplicanze o anche fatti morbosi primari(a rigore le vaccinazioni e la chemioprofilas-si sarebbero pratiche di medicina preventi-va). La medicina curativa non può costituireoggetto di educazione sanitaria: essa è essen-zialmente clinica, vale a dire scienza dell’in-dividuale, e per la potenza e specificità deipresidi terapeutici attuali non può assoluta-mente essere affidata al profano inesperto dicose mediche. In passato, quando la terapiaera molto più generica e molto meno effica-ce, questo era ancora in una certa misuraammissibile. ma oggi ormoni e antibiotici,psico- e neuroplegici, glucosidi ed alcaloidi,non possono essere utilizzati senza danno econ vantaggio, se non da mano molto esper-ta. In altre parole, l’educazione sanitaria nondeve insegnare nè a diagnosticare, nè tanto menoa curare, le malattie; può insegnare il modo dievitare molte di esse o comunque di dimi-nuirne la gravità e può insegnare a ricono-scerne l’esistenza e la pericolosità, indicandoa chi ci si debba rivolgere, al momento op-portuno, per evitare il peggio.Quali sono i problemi più gravi di salutepubblica, sui quali richiamare l’attenzionedella educazione sanitaria?Se il nostro scopo principale è quello di evi-tare le malattie, la risposta a questa doman-da dovrebbe trovarsi in un quadro statisticodella «morbosità», vale a dire della frequen-za con cui le diverse malattie incidono oggisulla salute umana. Tuttavia difficoltà prati-che di rilevazione, che qui sarebbe troppolungo esporre, rendono scarsamente attendi-bili i dati della morbosità; perciò, volendo
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
275Alessandro Seppilli
avere un quadro della distribuzione dellemalattie stesse il più possibile fedele, dob-biamo rivolgerci a un dato più ristretto, mapiù significativo, quello della «mortalità» (valea dire al numero dei morti per ciascuna cau-sa di malattia riferito a una determinata po-polazione).Uno sguardo alla tabella qui riportata ci of-fre appunto l’andamento della distribuzio-ne della mortalità per cause nella popola-zione italiana complessiva nell’ultimo cin-quantennio.
Andamento della mortalità dal 1901 al 1955 cifre re-lative a 100.000 abitanti
nella seconda metà del cinquantennio e si deveindubbiamente in misura prevalente alla sco-perta di strumenti assai efficaci nella lottacontro le malattie infettive e parassitarie (sul-famidici, antibiotici, D.D.T. e composti ana-loghi).Questo ultimo fatto ha provocato anche unospostamento sensibile nella graduatoria del-le cause di morte, facendo scendere di varipunti le malattie infettive e altre, pur non clas-sificate come tali, ma prevalentemente dinatura infettiva, come le malattie dell’appa-rato respiratorio. Naturalmente ciò ha por-tato in prima linea altre classi di malattie,come le malattie dell’apparato circolatorio equelle del sistema nervoso (dove le cause dimorte sono spesso di natura circolatoria), e itumori maligni. Un esame più attento, però,dimostra che la mortalità per malattie del-l’apparato circolatorio e per tumori maligniè anche aumentata in senso assoluto; e l’ana-lisi statistica, eseguita in molti paesi e ancheda noi, chiarisce che tale aumento non è do-vuto soltanto alla diminuzione delle altrecause (chi non muore di malattia infettiva hamaggior probabilità di morire poi per questecause, più proprie dell’età adulta e senile):l’aumento è reale ed assoluto, il che significache queste malattie sono effettivamente aumen-tate in proprio.Ciò non significa che la lotta contro le ma-lattie infettive possa considerarsi superata. Lemisure di «Polizia Sanitaria» hanno allonta-nato da noi il flagello delle grandi epidemiedi peste, di colera, di tifo esantematico; lavaccinazione antivaiolosa ha fatto scompari-re il vaiuolo; il D.D.T. e i suoi succedaneihanno ridotto a entità trascurabile il gravis-simo flagello della malaria. Ma ci sono anco-ra le infezioni da virus (influenza epidemica,poliomielite, meningite virale), contro lequali è del tutto inerme la terapia antibioti-
1901 1926 App. Resp. 448.5 App. Resp. 327.1
App. Dig. 383.4 Mal. Inf. 281,6 Mal. Inf. 367,9 App. Dig. 271,6 Sist. Nerv. 215.6 App. Circo 194.9 App. Circo 198.3 Sist. Nerv. 186,0 Tumori 59.2 Tumori 58,4 Generale 2.197,9 Generale 1.724,0
1950 1952 1955 App. Circo 202,5 245,5 249,5 Sist. Nerv. 149,1 145,0 141,1 Tumori 113,6 125,7 132,0 App. Resp. 106,8 96,0 79,1 App. Dig. 89,8 77,6 59,4 Mal Inf. 69,3 46,1 35,9 Generale 976,4 1.002,1 912,0
Come si può rilevare, la mortalità generaleper tutte le cause è sensibilmente diminuitanel periodo considerato; il che significa chela durata media della vita è aumentata inproporzione, aumentando sempre più il nu-mero degli individui che riescono a raggiun-gere lilla età avanzata. Questa diminuzionedella mortalità è particolarmente sensibile
276
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Educazione sanitaria e salute pubblica
ca. Ed anche infezioni che potrebbero esserepraticamente eliminate (come è avvenuto inaltri paesi) quali la difterite e la tifoide, fan-no ancora molte vittime tra noi per la trop-po scarsa diffusione delle vaccinazioni pre-ventive e per la trascuratezza dell’igiene in-dividuale in ampi settori delle nostre popo-lazioni. Senza dire della tubercolosi, che co-stituisce ancora un grave problema sociale eche potrebbe essere molto più efficacementecombattuta, se meglio fossero conosciuti imodi per difenderci da essa.Nel settore delle malattie infettive la possi-bilità di ulteriori progressi è in gran parteaffidata all’educazione sanitaria: le pratichedi vaccinazione, le indagini di massa (scher-mografia, prove tubercoliniche), le misuredi protezione individuale, non miglioreran-no e non si generalizzeranno se non attra-verso alla partecipazione attiva e coscientedelle popolazioni interessate.Altrettanto può dirsi per le malattie dell’ap-parato circolatorio la cui diffusione non è,come vogliono alcuni, un appannaggio ine-vitabile della civiltà e del progresso, bensìla conseguenza di gravi errori nella alimen-tazione e nel costume di vita, errori evita-bili in larga misura, senza rinunciare alleconquiste del nostro tempo. Il discorso sul-l’alimentazione ci porterebbe molto lonta-no: basti accennare all’abuso di grassi, al-l’indiscriminato impiego di sostanze spessonocive nella preparazione industriale dimolti alimenti, all’uso di antiparassitariestremamente tossici nell’agricoltura, e laesemplificazione potrebbe continuare. Quivoglio richiamare la vostra attenzione su unsolo fattore, che può considerarsi il nemico
pubblico numero uno della salute umana inquesti ultimi anni: il fumo, e particolarmenteil fumo di sigaretta.Indagini statistiche eseguite su vastissimascala hanno dimostrato una stretta correla-zione fra il consumo individuale di sigaret-te e l’aumento della mortalità generale, conparticolare riguardo alle malattie del sistemacoronario (angina pectoris, infarti del mio-cardio, trombosi coronarica); non solo, mail fumo di sigaretta rappresenta indubbia-mente la causa principale dell’enorme au-mento della mortalità per tumori dell’ appa-rato respiratorio, che in questi ultimi anni haraggiunto cifre impressionanti anche da noi.Questo per accennare soltanto ai problemimaggiori, ma l’educazione sanitaria puòsvolgere un’azione molto feconda anche inaltri settori della lotta contro le malattie ela morte; basti citare il gruppo delle malat-tie reumatiche (causa a sua volta del maggiornumero di vizi di cuore), le malattie infettivedell’età scolare (scarlattina, morbillo, varicel-la), gli infortuni stradali (educazione stra-dale) e domestici, le malattie professionali e gliinfortuni sul lavoro.Come si può constatare, c’è lavoro per tutti:medici, A.S.V., insegnanti; soprattutto perquesti ultimi, che non fanno parte delle strut-ture sanitarie ufficiali, ma che indubbiamen-te possono svolgere un ruolo di primissimopiano nella difesa della salute.È sopratutto ad essi che è rivolto questo no-stro sforzo; è sopratutto dalla loro sensibili-tà, dalla loro dedizione e dal loro entusia-smo, che noi ci attendiamo la forza per im-primere un nuovo impulso alla nostra fatica.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 277-283
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Il parlare per ultimo offre qualche vantag-gio, ma offre anche qualche inconvenientee non è molto facile. Si potrebbe stare zittie sarebbe la soluzione migliore, perché tut-to quanto era importante dire è stato detto;si potrebbero raccogliere diversi argomentiche sono stati posti e discuterli, perché ognu-no di questi argomenti offre naturalmentela possibilità di approfondimenti e di pro-spezioni diverse. Ma io scarterò tutte e duequeste soluzioni; la prima perché non mi èconcessa, e la seconda perché credo polve-rizzerebbe l’impostazione della discussione,che dovrebbe seguire a questo mio inter-vento. Cercherò piuttosto di raccogliere daquello che è stato detto ed anche da quelloche, a mio avviso, è importante e non èancora stato detto, ciò che mi sembra ilsucco del discorso, su ciò vale la pena didiscutere seriamente, oggi, in un momentoin cui ci si avvia, o almeno ci si illude diavviarci, a trovare delle soluzioni concretea questa problematica.
Intervento alla Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali*Speech at Workshop on Local Health Units
Alessandro Seppilli
* Estratto da “Notiziario dell’Amministrazione Sanitaria”, anno XXI, n. 12, dicembre 1969
1. Premesse politichePrimo punto: è chiaro, mi sembra, che siamaturo ormai in tutti, che la riforma deiservizi sanitari in Italia, non è una diavole-ria inventata da quelli che hanno voglia diriformare o da preoccupazioni di caratterepartitico, settoriale o politico, ma derivada alcune esigenze, sia di politica generale,sia di tecnica sanitaria, che sono ormai ine-ludibili e che si presentano in tutto il mon-do sostanzialmente in modo analogo, an-che se poi le soluzioni proposte non semprecorrispondono alle attese.Le premesse di politica generale mi sembrache si possano ridurre sostanzialmente inmodo analogo, anche se poi le soluzioni pro-poste non sempre corrispondono alle attese.Le premesse di politica generale mi sembrache si possano ridurre sostanzialmente a due:in primo luogo l’affermazione che il dirittoalla salute, come è stato detto anche daglialtri partecipanti a questa tavola rotonda, èoggi considerato come un diritto primario del
278
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali
cittadino, uno dei diritti che derivano dal solofatto di essere un uomo o una donna, e chequindi, come il diritto alla difesa, per esem-pio, dell’integrità personale, deve essere as-sicurato dalla società, cioè dallo Stato, in-teso nel senso più lato ed espresso poi a tut-ti i livelli, e non può essere, quindi, delega-to a nessuno.Tanto meno, poi, può essere risolto in rap-porti di tipo contrattuale e differenziato subasi categoriali, o corporative, o di qualsia-si genere, anagrafiche o che so io. In altreparole, il diritto ad avere quel tanto che lascienza e la tecnica da una parte, le possibi-lità economiche della società nel suo com-plesso dall’altra, consentono, non può esse-re subordinato alla presentazione di titolivalidi, perché il solo fatto di esistere in que-sta collettività dà tale diritto. Questa pri-ma affermazione, recepita nel preambolodello Statuto dell’O.M.S. ed anche nellanostra Costituzione, oggi possiamo ritener-la tanto più valida, in quanto essa è ormaimaturata nella coscienza civile del nostroPaese.La seconda premessa di politica generale èche la gestione di un servizio come questo deveessere affidata alla cittadinanza come tale,non può venire erogata dall’alto, ma deveessere gestita dagli utenti stessi, che si deb-bono servire di tale servizio.A queste due premesse di carattere politicogenerale, che importano ovviamente alcu-ne conseguenze di cui parleremo, subito, siaffiancano altre premesse che potremo chia-mare di natura tecnico-sanitaria.
2. Aspetti tecniciScopo dei servizi sanitari è la difesa della salu-te, non la protezione economica dal rischio dimalattia come è posta dalle assicurazionisociali. D’altra parte da un secolo e mezzo
circa si va facendo sempre più evidente cheè più economico, più redditizio, prevenireche curare. Se non ché, finché dominavanonella nosologia di tutti i Paesi cosiddetticivili, le malattie infettive, la prevenzioneè consistita essenzialmente in attività nonstrettamente legate all’azione del medico,individualmente, clinicamente operante sulsingolo soggetto. Gli interventi ambientalicontro le cause delle malattie infettive, tuttoquello che è stato fatto da tre o quattro ge-nerazioni di igienisti nel campo della difesadelle malattie da importazione, della boni-fica del suolo, delle acque, dell’aria, sempredal punto di vista della lotta contro le ma-lattie infettive, ha in certo modo creato unaspecie di «specializzazione nella profilassi»ed a staccato in gran parte l’attività preven-tiva (che tradizionalmente era sempre statalegata all’attività del medico generico) daquella che è l’attività terapeutica.L’impostazione mutualistica, poi, della pro-tezione del rischio di malattia, conquistataa poco a poco per la pressione delle catego-rie meglio organizzate dei lavoratori, ha ul-teriormente dissociato le due cose; per cuioggi ci troviamo una gran massa di mediciche di prevenzione non si preoccupa quasiaffatto. Dico «quasi», perché tutti sannobenissimo, che non c’è nessun medico che,di fronte ad una malattia infettiva, non cer-chi di evitare che questa malattia si diffon-da. Ma sostanzialmente i medici terapistise ne occupano molto poco, mentre oggi,con la trasformazione a cui abbiamo assi-stito della nosologia, questa situazione deveessere profondamente cambiata.Oggi, per poter realizzare la prevenzione, ab-biamo bisogno che questa sia portata a livelloclinico, cioè al livello del rapporto individuale.Avremo, sì, una medicina preventiva dimassa, ma anche la medicina preventiva così
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
279Alessandro Seppilli
detta di massa non è altro che una massa diinterventi clinici, individuali. Assicurare uncorretto approvvigionamento idrico, si puòindipendentemente dall’attività dei singolimedici, ma se vogliamo lottare contro lemalattie cardiocircolatorie o contro i tumorimaligni, non possiamo prescindere dal rap-porto individuale medico-paziente.Un altro aspetto del problema, sempre diordine sanitario, è dato dal fatto che la pro-gressiva specializzazione, che è parte inevi-tabile del progresso tecnico e costituisce oggiuna esigenza assoluta in tutti i settori e quin-di anche nella medicina, ha frammentatogli interventi; per cui ci troviamo di frontealla necessità di ricomporli in qualche ma-niera, perché l’individuo è pur sempre untutt’uno e non c’è alterazione della saluteche non si rifletta su tutto organismo.Ciò significa che si fa sentire da una parte ilbisogno di una riabilitazione del medico per-sonale, che si assuma la responsabilità dellasalute dell’individuo continuativamente, edall’altra la necessità di un coordinamentodi quegli interventi specialistici, che inevi-tabilmente dovranno completare l’opera delmedico personale.
3. Il S.S.N.Orbene, da queste premesse, che mi sem-brano ineludibili, sia di politica generale,sia di tecnica sanitaria, deriva l’impostazio-ne della riforma dei servizi, che viene pro-posta oggi in Italia. Secondo tale imposta-zione, si affida allo Stato la responsabilitàglobale dei servizi, con la creazione di un«Servizio sanitario nazionale», inteso comel’osservanza di un compito primario delloStato, come l’istruzione o la protezione del-l’integrità personale o la difesa dei confini ol’esercizio della giustizia; tutte cose: che loStato deve garantire assumendone la respon-
sabilità. Questo, naturalmente, non significache lo Stato debba accentrare nelle sue mani taleservizio, tanto meno ad un livello centralizzato;però, questa responsabilità se la deve assu-mere.D’altro canto, l’esigenza politica suaccen-nata impone che la gestione di questo ser-vizio sia realizzata a livello locale.
Il comprensorioE qui va localizzato un concetto che io ri-tengo di importanza fondamentale per tut-ta l’evoluzione della politica italiana e nonsolo per quella della politica sanitaria: ilconcetto di «comprensorio», inteso comeuna estensione territoriale, dentro la qualepossano essere forniti al cittadino tutti iservizi essenziali di base. Concetto di compren-sorio, che prescinde dalle divisioni politico am-ministrative attuali, che non corrispondonopiù alla realtà sociale di oggi. I Comuni ita-liani in origine erano effettivamente deicomprensori; essi sono sorti proprio in quan-to assicuravano la difesa e i servizi di basead una certa comunità. Poi, nella evoluzio-ne storica, alcuni di essi si sono ridotti aniente, altri sono diventati immensi o si sonosfiancati sotto la pressione delle esigenzeeconomiche e sociali. A mio avviso, questoconcerto di comprensorio deve rinascere, e,una volta affermata la necessità di decen-trare lo Stato a livello regionale, questi com-prensori debbono configurarsi all’internodelle Regioni, nel quadro del programmadi sviluppo regionale.Abbiamo detto che, in prima approssima-zione, i comprensori dovrebbero compren-dere circa 50.000 abitanti; è un criterio mol-to approssimativo, perché purtroppo ci sa-ranno comprensori inevitabilmente più pic-coli, che la comunità dovrà sostenere, per-ché possano vivere, e ci sono, per contro,
280
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali
zone a popolazione addensata, dove i com-prensori potranno essere notevolmente piùampi. Comunque, dal concetto di compren-sorio nasce la prospettiva di un servizio sani-tario nazionale gestito a livello comprensoriale:nasce l’unità sanitaria locale, intesa come cir-coscrizione territoriale (e in un certo sensopolitico-amministrativa) dei servizi sanitari.Personalmente sono convinto che le stesse esi-genze poste dal servizio sanitario si riproporrannoper le attività assistenziali e sociali non legateal servizio sanitario; e, prima o poi, anche per leattività educative, dato che noi siamo unodei pochi Paesi in cui l’educazione è accen-trata a livello nazionale. Ad ogni modo, inprospettiva, il comprensorio, se è valido,deve essere valido per gli altri servizi comeper quello sanitario.
La gestionePer la gestione dell’U.S.L., la prospettiva cheha maggiori adesioni è quella di una strut-tura di tipo consorziale, perlomeno dove ilcomprensorio interessi più Comuni. Per icomprensori che sono più piccoli di una cir-coscrizione comunale (grandi Comuni) dob-biamo attendere che si delinei meglio l’ar-ticolazione amministrativa dei grandi Co-muni, perché ovviamente un Comune di 2o 3 milioni di abitanti non può formare uncomprensorio.Nella maggioranza dei casi, avremo unastruttura consorziale del comprensorio. In talcaso, chi dovrebbe gestire queste unità sani-tarie locali? Evidentemente c’è una dupliceesigenza: da una parte debbono essere rap-presentati nella gestione di questi consor-zi i Comuni e gli altri Enti locali istituziona-li presenti nel comprensorio, come l’ospeda-le di base. Però, noi vorremmo che ci fosseanche una rappresentanza diretta della popo-lazione, non mediata attraverso alle struttu-
re comunali e degli altri Enti locali. E po-tremmo immaginare abbastanza facilmen-te, visto che si tratta di territori ristretti, unapartecipazione di elementi eletti direttamentedalla popolazione. Se immaginiamo un’uni-tà sanitaria locale di 50.000 abitanti, divisain una decina di condotte (che noi chiamia-mo «distretti»), per ognuno di questi distret-ti ci dovrebbe essere un rappresentante elet-to direttamente dalla popolazione, che par-tecipi alla gestione insieme ai rappresentantidegli Enti consorziati.Indubbiamente è necessario che l’unità sanita-ria locale abbia soltanto due interlocutori: unoa monte, la popolazione, e uno a valle, la Regio-ne. Non ci devono essere diaframmi, né amonte, né a valle, tra l’U.S.L. e questi in-terlocutori. Altrimenti ritroveremmo nelnuovo sistema gli stessi difetti che lamen-tiamo oggi nel vecchio, vale a dire la pole-mica fra utente ed Ente gestore; l’utente deveessere il gestore del suo servizio e se è ilgestore del suo servizio sarà indotto a pro-grammare il suo servizio nella maniera piùredditizia, date le condizioni locali e le di-sponibilità economiche a disposizione.
Rischio di erroriProspettate così le cose, quali sono i peri-coli contro i quali, secondo me, bisogna lot-tare? Alcuni pericoli sono ormai superati allivello culturale, ma non sono scomparsi deltutto al livello operativo. Per esempio; latendenza all’accentramento nazionale; ci sonoancora di quelli che pensano ad un serviziosanitario nazionale gestito come un enor-me Ente, una specie di INAM generale pertutta la popolazione italiana; e si vedonogià nella fantasia i palazzoni e i burocrati,che dovranno gestirlo.E non è solo lo Stato che ci minaccia, ciminaccia anche la Regione, la quale, secon-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
281Alessandro Seppilli
do alcuni, dovrebbe gestire direttamente leunità sanitarie locali; e infine ci sono le Pro-vince che cercano spazio per la loro soprav-vivenza, e dicono perché non la Provincia?Quelli che hanno esperienza di consorzi pro-vinciali, sanno quanto poco democratichesiano le gestioni dei consorzi provinciali,dove è assolutamente impossibile la parte-cipazione diretta della popolazione.Altro pericolo: la dispersione di quello chenoi cerchiamo di unificare, attraverso la per-sistenza di strutture verticali settoriali. Tuttele strutture verticali esistenti cercano di so-pravvivere e trovano anche alcuni consensi;ora, deve essere ben chiaro che tutto quelloche le strutture verticali hanno creato noilo dobbiamo utilizzare: ha detto molto benel’amico Bruni che «le strutture dell’ONMI,che fino ad oggi hanno operato nell’ONMI,domani opereranno nelle unità sanitarie lo-cali». E lo stesso discorso vale per le strut-ture degli istituti mutualistici e degli altriEnti che hanno operato fin qui, ma questonon vuol dire la conservazione delle gerar-chie verticali.Infine c’è ancora un terzo pericolo: la ten-denza a negare la responsabilizzazione della cit-tadinanza, della popolazione. Si capisce cheresponsabilizzare la popolazione comportadei rischi, perché la popolazione non è stataabituata, fino ad oggi, a gestire queste cose,ma è solo cosi che si procede nella demo-crazia; ed io credo che si proceda molto piùrapidamente responsabilizzando, che «tute-lando», come facciamo noi in Italia, per cuianche gli amministratori comunali, a co-minciare dal sindaco di Roma e di Milano,sono tutti sotto tutela, tutti necessariamentecontrollati da un’altra testa, che non è af-fatto detto che sia più perfetta o più com-pleta della loro.Questi i pericoli; e poi ci sono le resistenze.
Le resistenze, anzitutto da parte di quantihanno interesse che non si cambi nulla. Sicapisce che se c’è qualcuno che nel sistema,a qualunque titolo, guadagna un paio di mi-lioni al mese, questi non ha interesse che sicambi niente; e quindi, anche in perfettabuona fede, resiste.Un’altra resistenza è costituita dalla impre-parazione della popolazione, degli utenti,che abituati dall’impostazione paternalisti-ca a ricevere dall’alto, non percepiscono l’im-portanza dell’autogestione, alla quale ci siprepara solo attraverso un processo educa-tivo di maturazione politica.Una terza resistenza è stata accennata an-che da alcuni che hanno parlato prima dime: è la resistenza corporativa delle cate-gorie che, attraverso le lotte sindacali, sisono assicurate certe posizioni, che riten-gono valide e che temono possano esseremenomate dalla riforma, che porta tutti icittadini allo stesso livello.Infine, ci sono i «fantasmi»: oltre alle resi-stenze ed ai pericoli, ci sono i fantasmi. Ilfantasma della «impiegatizzazione» del me-dico, che ha riempito i discorsi, nelle com-missioni a cui abbiamo partecipato, di quelliche parlavano in difesa della «libera profes-sione». Questa impiegatizzazione del me-dico è un fantasma; perché nelle prospetti-ve del servizio sanitario nazionale i rappor-ti giuridici dei medici sono esattamentequelli che vigono attualmente. Se voglia-mo chiamare «impiegati» gli ufficiali sani-tari ed i medici dell’Ufficio di Igiene, que-sti saranno impiegati domani come lo era-no ieri; se chiamiamo «impiegatizzazione»il rapporto che lega il medico condotto alsuo Comune, quello sussisterà certamenteanche domani.Tutti quelli che hanno avuto familiarità conqualche medico condotto operante in un pic-
282
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Tavola Rotonda sulle Unità Sanitarie Locali
colo centro, sanno che il medico condottonon si sente «impiegato» e svolge un’attivi-tà professionale altrettanto libera quantoquella degli altri colleghi.Un altro fantasma è quello della «burocra-tizzazione» delle prestazioni. Se c’è una or-ganizzazione burocratizzata delle prestazioniè proprio questa nostra, in cui, per avere laprestazione, bisogna prima dimostrare chisei, di chi sei figlio, che mestiere fai, quan-te marche hai pagato, di che malattia seimalato. Mi sembra chiaro che un servizioche riconosce: il diritto alla prestazione, peril solo fatto di essere al mondo, è il menoburocratizzato che si possa immaginare.Terzo fantasma: quello dei « costi insostenibi-li». Ora, è chiaro che il «diritto alla salute»è un diritto tendenziale, non è un dirittoassoluto, filosofico. E’ chiaro che, se dicia-mo «tutti hanno diritto a quello che la scien-za offre», non intendiamo con questo affer-mare che tutti hanno diritto ad essere ope-rati, anche di ernia, da Valdoni; è chiaro chevi saranno sempre dei limiti all’esercizio deldiritto, limiti imposti dalle possibilità tec-niche, sociali, economiche, che la colletti-vità offre.All’interno di queste possibilità, ci sono del-le scelte da fare, c’è una programmazione,che sarà fatta a livello nazionale, a livelloregionale, a livello delle unità sanitarie lo-cali. E quindi è chiaro che se volessimo por-tare le prestazioni a livelli insostenibili dal-la collettività esse sarebbero insostenibili inqualunque sistema; perciò dovremo propor-zionarle alle nostre possibilità.
Gli strumentiInfine, per concludere, quali sono, secondome, gli strumenti essenziali necessari perpoter realizzare tutto ciò.Occorrono anzitutto le Regioni; perché sen-
za le Regioni non si può programmare unservizio di questo tipo; occorrono i pianiregionali di sviluppo e quindi anche i pianicomprensoriali. A tutt’oggi, abbiamo già delleRegioni funzionanti ed abbiamo già delleRegioni che hanno fatto i piani comprenso-riali: quelle sono pronte.Occorre la riforma tributaria; ma possiamoanche immaginare che, in attesa della rifor-ma tributaria, si possa, attraverso un fondonazionale sanitario, sostenere in via tempo-ranea la spesa necessaria. Bruni dice «per unanno potremmo fare delle unità sanitarie in-complete»; io direi che, se è questione di unanno, é meglio aspettare e poi farle com-plete quest’altr’anno. Perché, diciamoci laverità, non c’è nulla di più pericoloso, inItalia, del provvisorio, della creazione distrutture che, una volta create, poi per sman-tellarle ci vuole il bene di Dio. Perciò, lagradualità necessaria, realizziamola attraver-so una programmazione di questa graduali-tà. Cominciamo a nazionalizzare le presta-zioni ospedaliere, cominciamo a naziona-lizzare le prestazioni ambulatoriali; poi, sesarà necessario, potremo aspettare ancorasei mesi, dopo di ché faremo le unità sani-tarie locali «globali».
Il personaleAd ogni modo, non facciamoci illusioni: leRegioni hanno due anni per poter legifera-re; per questi due anni, potremo anche aspet-tare la creazione delle unità sanitarie locali.Però, c’è il discorso che faceva Mazzotti: ilpersonale necessario dove lo andiamo a pren-dere? Questo è un discorso molto lungo,che richiederebbe per sé tutta una tavola ro-tonda. Perché ci sono problemi di formazio-ne di personale nuovo, a cominciare dai pro-blemi della riforma universitaria. Ci sono iproblemi della utilizzazione del personale
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
283Alessandro Seppilli
attualmente esistente, a cominciare dal per-sonale direttivo delle U.S.L. Personalmenteritengo che la direzione delle U.S.L. dovrà es-sere collegiale, poiché in essa convergono com-petenze molto diverse. Per esempio: diri-gente dei servizi preventivi (l’attuale uffi-ciale sanitario); dirigente dei servizi medicidi base (l’attuale dirigente dei servizi mu-tualistici); dirigente dei servizi ospedalieri(direttore sanitario dell’ospedale di base);dirigente dei servizi infermieristici; dirigentedei servizi sociali; dirigente dei servizi far-maceutici; dirigente dei servizi veterinari.
La direzione collegiale dovrà, poi, eleggereun direttore che la rappresenti e svolga lemansioni esecutive. E poi c’è il grossissimoproblema del personale sanitario così dettoausiliario, del personale «non medico»; e quibisogna operare, operare d’urgenza, non conil sistema all’italiana, che se mancano inge-gneri nominiamo ingegneri i capimastri ecosì non abbiamo né ingegneri né capima-stri, bensì con un sistema di reale qualifica-zione di questa categoria. Ma, ripeto, è unlungo discorso che richiederebbe un’altratavola rotonda.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 284-289
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
1.E veniamo al protagonista dell’opera, al qua-le tutta la riforma è dedicata: al cittadino,utente e gestore ad un tempo del servizio.Personalmente, io ritengo che nessun pro-gramma di riforma sanitaria meriterebbeseria attenzione se non si proponesse, in pri-missimo luogo, di superare l’attuale rappor-to inevitabilmente polemico fra chi forni-sce o assicura le prestazioni e chi le utilizza.Siamo partiti dal presupposto che scopo dellamedicina è la difesa della salute, di tutti edi ciascuno: perciò i soggetti del sistemanon possono essere che i cittadini, oggi trop-po spesso considerati, invece, come ogget-to passivo della società consumistica anchein questo settore vitale. Sono essi che deb-
La popolazione: soggetto del sistema*The people: subject of the system
Alessandro Seppilli
* Pubblicato, pp. 32-41 nel volume Significato di una riforma, di Alessandro Seppilli - Maurizio Mori - MariaAntonia Modolo (curatori), Il Pensiero Scientifico editore, 1972, pp. 210; e su “L’Educazione Sanitaria”, vol.XVI, fasc. 2-3 aprile-settembre 1971, pp. 161-177.
bono consapevolmente richiedere le presta-zioni di cui hanno bisogno e che il serviziodeve loro assicurare. Sono essi che debbonoconsapevolmente operare le scelte inevita-bili tra ciò che è utile o necessario e ciò cheè inutile o superfluo o addirittura dannoso.Per tali scelte debbono essere assistiti daitecnici. come in ogni altro caso in cui lascelta abbia un contenuto tecnico; ma deb-bono essere loro i soggetti della scelta e nonlimitarsi a subire passivamente le sceltedecisionali operate da altri.Questa responsabilizzazione dei cittadini nel-la gestione del servizio è la condizione inelu-dibile, a mio avviso, perché non si ripropon-ga nel servizio stesso l’eterna polemica tracittadino e servizio, che pesa come coltre di
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
285Alessandro Seppilli
piombo su tutti i nostri servizi pubblici. È lapremessa di una gestione veramente demo-cratica e non delegata del servizio sanitarionazionale; è insomma l’essenza stessa dellademocrazia, in questo come in ogni altroaspetto della vita sociale.
2.Questo problema, però, deve essere risoltoalla radice, a livello delle cellule elementaridel servizio, vale a dire a livello dei distret-ti. Non sembra contestabile che la parteci-pazione dei cittadini è tanto maggiore perquanto minore è l’ambito in cui essa si rea-lizza; una partecipazione diretta è possibilesoltanto in un ambito abbastanza ristretto,perché tutti possano rendersi conto dei pro-blemi ed esprimere a ragion veduta la pro-pria opinione in merito alla loro soluzione.È questo appunto l’ambito del distretto.Perciò è necessario che in ogni distretto sicostituisca un Comitato sanitario di distretto,che promuova le riunioni e prepari le pro-poste da sottoporre ai cittadini dello stesso.Ma, data la natura dei problemi, questo pre-suppone a sua volta che la popolazione siainformata ed aggiornata sui problemi dellasalute; che cioè si faccia nel distretto operacontinua, capillare ed approfondita, di edu-cazione sanitaria, onde preparare i cittadinia scelte consapevoli, non improvvisate e nonsuggestionate da pressioni pubblicitarie o dialtro genere. Il che comporta la soluzionedi un problema di fondo: quello appuntodella educazione sanitaria della popolazione,di chi la debba fare e di come debba esserefatta, con tutte le implicanze che da questiquesiti derivano.
3.L’educazione sanitaria è stata definita «quel-la categoria dell’educazione che focalizza la
salute e la sua problematica» (Seppilli, 1966).Come tutta l’educazione essa si propone diassistere l’uomo nella formazione della suapersonalità, aiutandolo a prepararsi a sceltecomportamentali consapevoli, nell’interes-se proprio e della società in cui vive.La «coscienza sanitaria», che l’educazione sa-nitaria si sforza di promuovere (e che puòconsiderarsi un aspetto della coscienza civi-le), rappresenta per l’appunto la raggiuntamaturità dell’individuo in tale campo e lasua capacità di operare scelte coerenti e con-sapevoli nell’interesse della propria salute edi quella dei suoi simili.Poiché la salute è un bene che sta a cuore atutti, potrebbe sembrare che basti una cor-retta informazione per indurre dei compor-tamenti positivi nei confronti della salute;purtroppo, però, non è così, e tutta l’espe-rienza di questi ultimi anni, in fatto di edu-cazione sanitaria, stà a documentarlo. Se cosìnon fosse non ci sarebbe più alcun medicofumatore!In effetti, le nostre scelte comportamentalidipendono dalla scala dei valori che strutturae motiva i nostri atteggiamenti e che dipen-de a sua volta in larga misura dagli atteggia-menti degli altri componenti il gruppo (o igruppi) di cui facciamo parte. Non basta certoche una donna sia informata dell’utilità diuna visita ginecologica durante la gravidan-za, perché vi faccia ricorso, e non basta nep-pure che ne sia convinta. A parte le difficoltàdi ordine materiale (disponibilità di tempo,distanza) ed economico (costo della visita edeventualmente dei mezzi di trasporto), se isuoi familiari (il marito, la suocera, i genito-ri) e le sue amiche più intime sono convintiche un tale comportamento è disdicevole osconveniente (e quindi la donna sa che ne sa-rebbe severamente censurata), tutti gli argo-menti a favore della visita hanno serie pro-
286
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La popolazione: soggetto del sistema
babilità di essere vanificati. Perché, nella scaladei valori di quella donna, probabilmente laricerca del consenso del suo gruppo sociale èpiù fortemente motivata della cura del pro-prio corpo.Da ciò deriva la necessità che l’educazionesanitaria venga rivolta, più che al singolo,al gruppo sociale; o quanto meno cerchinella convinzione di gruppo il supporto allaconvinzione del singolo.
4.Inoltre l’educazione sanitaria non è facile nep-pure come semplice messaggio informativo.Dobbiamo tener presente, infatti che ciascunindividuo, fin dalla nascita, ha cercato di ri-solvere, bene o male, i problemi della suasalute in parte per istinto, in parte valendosidella esperienza propria e del consiglio deisuoi simili. Per cui, l’informazione in questocampo non cala in un «vaso vuoto», ma simescola e reagisce col contenuto del vaso;con risultati difficilmente prevedibili. Moltevolte l’informazione è in contrasto, perlome-no apparente, con l’esperienza (ricordate ilsonetto di Renato Fucini sulla vaccinazioneantivaiolosa!); altre volte è in contrasto conabitudini inveterate o quanto meno tende arompere un equilibrio faticosamente raggiun-to e da tempo consolidato. Si pensi alla diffi-coltà di ottenere delle modifiche sostanzialinelle abitudini alimentari, nella scelta dei cibi,nella distribuzione dei pasti.Se poi si esamina il messaggio in se stesso esi studiano i canali dell’informazione, le cosesi fanno ancora più complesse.Noi possiamo servirci di due modalità fon-damentali di comunicazione: la comunica-zione bidirezionale, interpersonale; e quellaattraverso i mezzi di comunicazione dimassa. Ovviamente, l’efficacia individualedella prima è decisamente superiore, per-
ché ci permette di instaurare un dialogo e,per mezzo di esso, chiarire i dubbi, supera-re certe resistenze, suscitare la partecipa-zione attiva di chi ci ascolta al problema.Ancor più del colloquio individuale, nell’edu-cazione sanitaria si dimostra particolarmen-te efficace la discussione di gruppo, nellaquale più facilmente emergono certe diffi-denze e resistenze e la maturazione dell’at-teggiamento positivo si struttura e si con-solida nella solidarietà dei componenti ilgruppo. Queste modalità, però, richiedonomolto tempo e soprattutto molto persona-le adeguatamente preparato, raramente di-sponibile; per cui non ci si può sottrarre al-l’altra alternativa, quella dei mezzi di co-municazione di massa.Questi, infatti, ci permettono di raggiun-gere contemporaneamente un gran numerodi individui e di sostenere il nostro messag-gio con la suggestione propria di questimezzi (stampa, cinema, radio, TV). Tutta-via, qui sorgono altri problemi. Il messag-gio informativo è tanto più efficace perquanto più è specifico, cioè adatto a chi loriceve; dilatando il numero dei destinatari,inevitabilmente tale specificità viene sacrifi-cata. Chi ha esperienza di TV sa come sicerchi di comporre queste due esigenze an-titetiche, con una serie di accorgimenti cir-ca il linguaggio, la scelta del canale, del-l’ora di trasmissione, del modo di presenta-re le cose e così via. Non è qui il caso dientrare in dettagli su questo tema. Ma viho accennato, per inciso, per rilevare comegli interventi di educazione sanitaria pon-gano una serie di problemi, che vanno at-tentamente studiati e risolti, con l’ausiliodi chi si intende di queste cose, e che nonpossono essere oggetto di improvvisazione,fondata sulla presunzione di «conoscere» l’ar-gomento dell’intervento.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
287Alessandro Seppilli
5.Naturalmente, anche l’educazione sanitaria– come ogni altro aspetto dell’educazione– trova la sua sede naturale e primaria nellascuola, di ogni ordine e grado. Da noi, pur-troppo, in tale sede essa è stata fino a ieri (epotremmo dire fino ad oggi) completamentetrascurata. In nessun paese civile questa ca-renza è così totale come in Italia. Nellenostre scuole si imparano tante cose (dellacui utilità non è qui il luogo di discutere),ma si possono raggiungere i più alti gradidella istruzione senza sapere nulla del no-stro corpo, delle sue esigenze, delle causeinnumerevoli che attentano in mille modialla nostra salute fisica e psichica, e quindidel modo di difenderci da esse.E’ questo il primo impegno dell’educazionesanitaria, quello di preparare degli insegnan-ti che sappiano educare anche sanitariamentele nuove generazioni. Noi abbiamo affron-tato questo problema con una serie di ini-ziative e soprattutto con gli annuali «Corsiestivi di educazione sanitaria» (ai quali han-no partecipato numerosissimi insegnantielementari e medi) e con alcuni Convegniin cui si sono dibattuti alcuni temi specifici,come il ruolo dell’insegnante elementare, ladivisione dei compiti fra i diversi insegnantinella scuola media dell’obbligo e la parte spet-tante ai medici ed in particolare al serviziomedico-scolastico in questo compito essen-ziale per la formazione di una coscienza. sa-nitaria nella popolazione.Senza entrare in particolari, emerge dallaesperienza mondiale in questo campo che –trattandosi della difesa della salute – l’inizia-tiva e la prima responsabilità ricadono fatal-mente anche qui sulle strutture del serviziosanitario, che debbano fornire al corpo do-cente i necessari contenuti (e molto spessoanche gli orientamenti metodologici speci-
fici ed i sussidi didattici adatti allo scopo).Inoltre, è chiaro che la scuola non basta; siaperché i risultati dell’intervento scolastico sipotranno rilevare soltanto dopo diversi anni,sia perché gli stessi scolari sono oggi investi-ti da un gran numero di informazioni extra-scolastiche, spesso più incisive e penetrantidi quelle scolastiche, specie ad opera deimezzi di comunicazione di massa.
6.Da tutto ciò deriva la necessità che i servizisanitari siano organizzati anche sotto il profilodell’educazione sanitaria. E, come in tutti glialtri settori del servizio, una tale organizza-zione, per essere efficiente, deve prevederediversi livelli, dal centro alla periferia.A livello centrale – come già è stato fatto intutti i paesi più progrediti nella organizza-zione dei servizi sanitari – occorre un orga-no che affianchi e si integri con gli altri orga-ni centrali del servizio; occorre cioè un Isti-tuto Nazionale per l’Educazione Sanitaria.Tale Istituto dovrebbe avere il compito di:- assicurare gli scambi internazionali ed in-
terregionali di informazione, di materia-le e di personale;
- allestire e curare il continuo aggiornamen-to di un Centro di documentazione (conBiblioteca, Archivio e Schedario biblio-grafico) a disposizione di tutti gli opera-tori in educazione sanitaria;
- contribuire alla preparazione del piano sa-nitario nazionale (in tutte le sue fasi) edalla valutazione del fabbisogno effettivodi servizi sanitari (anche a mezzo di op-portuni sondaggi per il tramite delle UnitàSanitarie Locali);
- curare la preparazione del piano di svi-luppo dell’educazione sanitaria nel quadrodel piano sanitario nazionale, assicuran-done il necessario collegamento con i piani
288
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La popolazione: soggetto del sistema
di sviluppo dell’educazione permanente;- predisporre degli schemi orientativi per i
programmi regionali e per gli interventia livello locale, sempre nel campo del-l’educazione sanitaria;
- predisporre i criteri di valutazione dellaefficacia degli interventi educativi (anchea mezzo di indagini campionarie e di espe-rimenti comparativi);
- curare la realizzazione di campagne na-zionali di educazione sanitaria, valendosidei mezzi di comunicazione di massa edin particolar modo della RAI-TV;
- produrre materiale educativo, stampato,fotografico o registrato (con particolareriguardo alla produzione di films e filmi-ne), di «sketch» radio-televisivi;
- produrre, per iniziativa propria o su com-missione del S.S.N. ai diversi livelli, ma-teriale educativo vario, sia a scopo speri-mentale che operativo, nonché esprimerepareri – su richiesta degli Enti interessati– su materiale predisposto da terzi;
- preparare il personale specializzato per idiversi livelli, curando o promuovendol’organizzazione di corsi para-universitariper la formazione degli educatori sanitarie predisponendo programmi e sussidi di-dattici per corsi di breve durata da svol-gersi a livello regionale;
- curare l’organizzazione di brevi corsi diorientamento e specializzazione per ope-ratori sanitari, di convegni e dibattiti e dialtre manifestazioni culturali, sempre nelcampo dell’educazione sanitaria;
- infine svolgere opera di consulenza e spe-rimentazione nell’interesse del S.S.N. edello sviluppo scientifico e metodologicodell’educazione sanitaria.
Detto Istituto dovrebbe affiancarsi, comesi è detto, agli altri Istituti centrali che sioccupano di problemi sanitari e stabilire con
questi stretti rapporti di collaborazione. Allostato, il principale di essi è l’Istituto Supe-riore di Sanità, ma funzioni non meno im-portanti dovrebbe svolgere l’Istituto Regi-na Elena per la lotta contro i tumori e l’Isti-tuto dell’ENPI di Monteporzio Catone peri problemi dell’Igiene del lavoro. Altri sene potrebbero aggiungere, al centro delS.S.N., quali organi tecnici del Ministerodella Sanità ed a disposizione di tutto ilS.S.N., ai suoi diversi livelli, come di fattogià avviene in altri Paesi dove esiste un Ser-vizio Sanitario Nazionale.
7.A livello regionale l’educazione sanitaria devetrovare la sua collocazione nella direzionesanitaria del Governo regionale, al qualespetta la programmazione e l’organizzazio-ne unitaria di tutti i servizi sanitari dellaRegione, articolati nelle U.S.L.A questo livello, coerentemente alle fun-zioni affidate dalla Costituzione all’istitutoregionale, anche l’educazione sanitaria devesvolgere essenzialmente una funzione me-todologica, programmatica e normativa, esolo eccezionalmente operativa. Alla regio-ne dovranno giungere alcune indicazionidallo Stato e dal programma nazionale e inesse dovranno confluire le esigenze di baseraccolte dalle U.S.L. Dalla Regione, poi,verranno a queste ultime le linee generalidell’azione, l’assistenza tecnica ed il mate-riale educativo, per gli interventi sulla po-polazione nel suo complesso o su gruppiparticolari di cittadini o di lavoratori.Infine, alla Regione spetteranno compiti diricerca (su temi particolari di livello regio-nale), di formazione ed aggiornamento delpersonale, medico e non medico, che deveoperare nelle U.S.L., e di allestimento dimateriale educativo adatto alle necessità dei
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
289Alessandro Seppilli
servizi delle U.S.L. della Regione.
8.Dove, però, si concreteranno – salvo casieccezionali – gli interventi di educazionesanitaria sarà a livello locale, vale a dire nel-l’U.S.L, centro operativo di tutte le attivitàsanitarie di base. E’ qui che l’educazione sa-nitaria – intesa come intervento capillare,continuo, globale e integrato nel servizio sani-tario – diviene la premessa e l’alimento diun servizio sanitario efficace e rispondentea quei principi che hanno ispirato la crea-zione del S.S.N. nel nostro Paese.Capillarità, continuità, globalità, integrazio-ne significano presenza costante dell’educa-zione sanitaria in tutte le prestazioni sani-tarie, siano esse preventive, curative o ria-bilitative, siano esse domiciliari o ambula-toriali oppure ospedaliere, siano esse offer-te da personale medico o infermieristico otecnico o di assistenza sociale. È necessarioche il cittadino, il lavoratore, sano o mala-to che sia, senta la sua parte di responsabili-tà nella difesa della sua salute, si renda con-
to di ciò che vien fatto per lui e di ciò cheavviene in lui, assuma il suo ruolo in colla-borazione con chi si occupa del suo caso econtribuisca, cosi, alla sua soluzione. È que-sta la «coscienza sanitaria» di cui si parlavaall’inizio di questo capitolo ed è questa – èbene ripeterlo – la chiave di volta del S.S.N.Senza questo collegamento intimo del Ser-vizio con la popolazione non si avrà mai unservizio sanitario moderno e democratico enon sarà mai possibile una reale difesa dellasalute, individuale e collettiva. Perché ladifesa della salute comporta scelte politi-che, alle quali tutta la popolazione deve es-sere interessata, e perché un atteggiamentoautoritario da parte degli operatori sanitarie di acquiescenza passiva da parte dei citta-dini non consentono la rivalutazione dell’uo-mo, come soggetto del sistema, e la subor-dinazione della stessa nostra società alle sueesigenze primarie.È a questo livello che si rovescia l’imposta-zione del problema; è a questo livello che lariforma sanitaria e la creazione del S.S.N.assumono il loro vero significato.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 290-294
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Da un po’ di tempo il termine “educazionesanitaria” sembra scomparso dal lessico del-la sanità. Promozione della salute, healthliteracy, social marketing, ecc. risuonanomolto più frequentemente nelle narrazio-ni che riguardano l’empowerment per lasalute delle persone e delle comunità. Po-trebbe sembrare perciò meramente rievo-cativo il riproporre una riflessione sull’edu-cazione sanitaria tanto più che questo con-tributo fa parte della monografia che Si-stema Salute dedica ai sessanta anni divita di un’istituzione, il Centro Sperimen-tale per la Promozione della Salute e l’Edu-cazione Sanitaria, che l’educazione sanita-ria ha contribuito a “lanciare” nel nostroPaese negli anni ’50 e a sostenere per de-cenni nel contesto della sanità pubblica enon solo.
Riflessioni sull’educazione sanitaria. Esiste ancora l’educa-zione sanitaria?Reflections on health education. There is still health education?
Giancarlo PocettaMD PhD, Medico di Sanità Pubblica,Ricercatore in Igiene, Dipartimento di Medicina Sperimen-tale, Università degli Studi di Perugia
Vorrei invece vedere con questo breve con-tributo se sia possibile oggi andare oltre lasemplice rievocazione/celebrazione e cer-care piste che permettano di rilanciare erimotivare un discorso sull’educazione sa-nitaria oggi.Nel corso di questa discussione, farò rife-rimento specifico al settore della scuolache, soprattutto nel momento in cui nelnostro Paese si annuncia una poderosa ri-forma verso quella che si è definita “scuolabuona”, meriterà più di un approfondimen-to nell’immediato futuro in vista di darecorpo a quel legame inscindibile e chemutuamente si rafforza tra scuola “buona”e scuola “sana”.Un vantaggio insito nell’avere una lungastoria alle spalle, e l’educazione sanitariacome disciplina ha certamente questo re-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
291Giancarlo Pocetta
quisito, è quello di poter contare su un ap-parato di definizioni cospicuo e, nell’insie-me capace di rendere le molte sfumaturecon le quali – negli anni – è stato esplici-tato il senso del fare educazione sanitaria.Ed infatti, solo per citare definizioni para-digmatiche, nel 1970 l’OrganizzazioneMondiale della Sanità così si esprimeva:“Lo scopo dell’educazione sanitaria è di aiuta-re le popolazioni ad acquisire la salute attra-verso il proprio comportamento e i propri sforzi;l’educazione sanitaria si fonda dunque in pri-mo luogo sull’interesse che i singoli manifestanoper il miglioramento della loro condizione divita e mira a far loro percepire tanto come in-dividui, che in quanto membri di una fami-glia, di una collettività, di uno Stato, che iprogressi della salute derivano dalla loro re-sponsabilità personale”. Più o meno nellostesso periodo, Alessandro Seppilli affer-mava: “l’Educazione sanitaria è un processodi comunicazione inter-personale, diretto a for-nire le informazioni necessarie per un esame cri-tico dei problemi della salute ed a responsabi-lizzare gli individui e i gruppi sociali nellescelte che hanno effetti sulla salute fisica e psi-chica dei singoli e della collettività”. Infine,giungiamo alla definizione offerta e “san-tificata” dall’Organizzazione Mondiale del-la Sanità nel celeberrimo Glossario (1998)per il quale “educazione sanitaria” è: “l’in-sieme delle opportunità di apprendimento con-sapevolmente costruite, che comprendono alcune for-me di comunicazione finalizzate a migliorare l’al-fabetizzazione alla salute, ivi compreso l’aumen-to delle conoscenze e a sviluppare life skills checontribuiscano alla salute del singolo e della co-munità” (traduzione a cura di DORS).E’ molto utile leggere anche la nota espli-cativa che il Glossario aggiunge alla defi-nizione e dove l’educazione sanitaria è resavia via come: “opportunità di apprendimen-
to”, “forma di comunicazione” informativa manon solo, processo “che favorisce la motiva-zione e l’autoefficacia”, processo che sia ingrado di mostrare “la fattibilità politica e lepossibilità organizzative … per orientare i fat-tori determinanti della salute di carattere so-cioeconomico e ambientale”. Molte altre defi-nizioni si sono aggiunte nel tempo a carat-tere più operativo ma senza modificare inmodo sostanziale gli elementi che abbia-mo richiamato.La lettura di queste definizioni aiuta a in-dividuare le molte sfaccettature che com-pongono la visione dell’educazione sanita-ria che è giunta fino ad oggi. In aggiunta,in questo tentativo di dire cosa è l’educa-zione sanitaria è rilevante richiamare l’ul-tima parte della nota che il Glossario faseguire alla definizione dove si dice “Inpassato, il termine educazione alla salute è statoutilizzato per indicare una gamma di inter-venti più ampia, che comprendeva la mobilita-zione sociale e l’advocacy, Questi metodi sonoora ricompresi nel termine promozione della sa-lute e viene qui proposta una definizione piùristretta di educazione alla salute, proprio persottolineare la distinzione”.Questa parte è per me decisiva per com-prendere luci e ombre che hanno caratte-rizzato l’azione di educazione sanitaria ne-gli ultimi anni nel nostro Paese, dove si èmanifestata proprio la difficoltà a distin-guere i due livelli di intervento, quello pro-mozionale quello educativo, difficoltà cheha generato molta confusione tra gli ope-ratori provocando di fatto una sovrapposi-zione tra i due approcci che solo da poco sista superando.
Un esempio paradigmatico: educazione – salute– scuola1
Il contesto scuola propone un racconto piut-
292
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Riflessioni sull’educazione sanitaria. Esiste ancora l’educazione sanitaria?
tosto chiaro di come sia avvenuta una transi-zione, nello specifico nella cosiddetta forma-zione scolastica alla salute, da un approccio“educativo” ad uno “promozionale” e di comead un certo punto si sia determinato un cortocircuito tra educazione sanitaria e promozio-ne della salute che ha di fatto cancellato il pri-mo termine dal discorso dell’empowermentper la salute. L’inizio del racconto può esserecollocato senz’altro nei primi anni ’90 quandoviene promulgata la cosiddetta legge “anti-droga” che assegna alla scuola compiti di: “Pro-mozione e coordinamento, a livello nazionale, delleattività di educazione ed informazione”.All’inizio di questo percorso, la scuola si rap-presenta come utile, ma pressoché neutro,recipiente delle attività proposte da servizisanitari territoriali e da professionisti nonsanitari (psicologi, sociologi, educatori), for-nendo il palcoscenico per ospitare esperti deidiversi temi legati alla salute: la droga e ledipendenze e poi tutta una serie di compor-tamenti a rischio. Il risultato è stato una pa-tologia dell’educazione sanitaria nella scuo-la, la cosiddetta “progettite”: una miriadepressoché incontrollabile di iniziative fram-mentate ma, ciò che più conta, slegate dalcontesto educativo in cui venivano agite:approcci prevalentemente di tipo informati-vo e calati dall’alto, senza alcuna attenzioneai bisogni e alle domande dei destinatari(alunni, studenti), eterogenei e spesso improv-visati nelle opzioni educative, frammenta-rietà ed episodicità dei temi proposti, man-canza quasi completa di un orientamentoprogettuale e valutativo organico e sistema-tico. Ad un certo punto si manifesta una re-azione da parte delle istituzioni scolastiche e
degli insegnanti; la scuola reagisce a questaespropriazione di una parte del ruolo educa-tivo e di tempi e spazi che le appartengono ecerca di riappropriarsene ponendosi come in-terlocutore alla pari con il sistema sanitario,cercando modalità di “governo” dell’offerta dieducazione sanitaria, riuscendoci peraltro soloparzialmente, interrogandosi sui bisogni deipropri utenti e rimettendo in discussione ilproprio ruolo. E’ il momento dei docenti re-ferenti, figura interna alla scuola che ha segui-to un appropriato percorso formativo, i qualidiventano pivot di una programmazione diIstituto non più centrata sulla prevenzione deldanno e del rischio ma sul benessere dell’alun-no/studente e progressivamente di tutto ilcontesto organizzativo della scuola; ma soprat-tutto viene fatto ricadere nella programma-zione per l’educazione alla salute il know howpedagogico proprio della scuola. Si apre cosìla strada al nuovo approccio nella formazionescolastica alla salute, l’approccio che deriva di-rettamente dalla strategia della Promozionedella Salute lanciata nel 1986 dall’Organizza-zione Mondiale della Sanità, ovvero: HealthPromoting School – la scuola che promuove sa-lute. In concreto, la scuola si orienta verso lapromozione negli allievi di una autopercezio-ne positiva, il che si traduce nel fornire ai suoi“utenti” un contesto favorevole (in senso or-ganizzativo e educativo) allo sviluppo di unarappresentazione positiva della persona (“sana,intelligente, gentile, capace di affrontare lesituazioni, capace di fare sacrifici senza dispe-rarsi, senza deprimersi, senza irritarsi, capacedi stare in situazione, di tenere la situazione”.Health Promoting School diventa, dunque,l’orientamento che guida l’approccio forma-
1 Questa parte sintetizza un ragionamento più ampio svolto per la redazione del capitolo “La formazione allasalute nella scuola e la formazione dei formatori” che l’autore ha scritto per il volume edito da FrancescoCalamo Specchia “Manuale critico di sanità pubblica” di prossima uscita
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
293Giancarlo Pocetta
tivo della scuola alla salute. Alla base di que-sta strategia possiamo rintracciare fondamen-talmente l’affermarsi di una visione olisticae salutogenica della salute non più circoscrittaad un’azione centrata solo sulle life-skill in-dividuali del ragazzo.Progressivamente si affermano tre paradig-mi che connoteranno l’ethos particolare del-l’Istituzione scolastica riguardo al suo ruoloper la salute:1. La scuola come membro vitale del conte-
sto sociale contribuisce a realizzare queldiritto alla salute richiamato dall’art. 32della Costituzione Italiana;
2. La scuola come istituzione radicata nellacomunità realizza quell’indirizzo secondoil quale la salute deve far parte di tutte lepolitiche pubbliche di un territorio (sco-lastiche appunto, del lavoro, dell’ambien-te, etc.): Health in All Policies;
3. La scuola, come comunità educante, assu-me che alla radice della salute vi è il “buonfunzionamento” dell’essere umano integra-to nel suo ambiente.
Si apre una fase ulteriore nel percorso dellaformazione scolastica alla salute dove si sta-bilisce che il benessere e la salute nella scuo-la dipendono dalle politiche educative e sco-lastiche, dall’organizzazione scolastica, dallosviluppo dei curricoli, dall’impostazione pe-dagogica e didattica in tutto l’iter scolastico.In questa visione, pertanto, per promuoverela salute le scuole “non hanno bisogno di corsidi educazione sanitaria focalizzati su questo oquel comportamento né di insegnanti specialistima di riorientare la propria organizzazione, lescelte pedagogico-didattiche allo sviluppo delle ca-pacità che favoriscono il “buon funzionamento”dei ragazzi”. L’azione formativa che tieneconto del buon funzionamento dell’essereumano affronterà tre aree di sviluppo dellapersona: la capacità di ragionamento prati-
co, la capacità di rapportarsi/relazionarsi. Laconoscenza dell’anatomia e fisiologia uma-na. E’ la fase più matura del percorso dellaformazione scolastica alla salute, quella chevede la scuola come luogo di “produzionedella salute”.
In conclusione: tre spunti per ri-par-lare di educazione sanitariaL’esempio della scuola mostra la transizionedal vecchio approccio di educazione sanita-ria ad un approccio maturo di promozionedella salute comprensivo di una dimensioneeducativa. La mia opinione è che questo tra-guardo non lo si sta raggiungendo ma chepiuttosto stiamo attraversando un momen-to di confusione nel quale tante azioni di tiposquisitamente educativo vengono etichetta-te come “promozione della salute” perdendole caratteristiche che, per rimanere nell’esem-pio che abbiamo ora utilizzato, definivanouna scuola come health promoting.Allora che senso ha parlare, oggi, di educa-zione sanitaria?Tre punti mi sento di proporre per aprire,così come vuole la redazione di SistemaSalute, il dibattito.
1. In una società frammentata, liquida, glo-balizzata, vi è il rischio di perdere di vista lapersona a scapito di una collettività indistin-ta. Abbiamo trascorso, o forse vi siamo an-cora dentro, un tempo in cui il “globale” era(è?) il valore. Avvertiamo invece sempre dipiù la necessità di ritornare non all’indivi-duale – contrapposto al globale – ma allapersona. In questo vi è un richiamo ad unadimensione poco praticata, che è quella dellaresponsabilità personale, anche rispetto allapropria salute. In questo, ripensare i processidi salute in un’ottica (auto)educativa, di cre-scita personale è da rinforzare, qualche volta
294
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Riflessioni sull’educazione sanitaria. Esiste ancora l’educazione sanitaria?
anche riscoprire.
2.Il secondo punto è legato al primo ma spo-sta l’attenzione al di fuori della persona. A mioavviso occorre richiamare l’attenzione sul le-game tra educazione e salute, concentrandol’attenzione su una responsabilità “altra” nellacostruzione di opportunità di formazione allasalute. Pur se scegliere riguardo alla salute èinevitabilmente prima di tutto una responsa-bilità individuale, l’apprendimento sotteso aquesta formazione non è una responsabilitàsolo individuale ma il contesto sociale è chia-mato a fornire luoghi e situazioni di appren-dimento in cui le persone possano formarsi inuna prospettiva di long-life learning.
3. Infine, potremmo chiederci: il sistema sa-nitario ha una responsabilità educativa rispet-to alla salute? Probabilmente questo è il pun-to più difficile da affrontare. Se da una partenon vi è dubbio che il sistema della sanitàpubblica istituzionale (esempio: i servizi diprevenzione della ASL) hanno un ruolo diadvocacy e di mentoring rispetto agli altri
sistemi che guidano e orientano la vita so-ciale – compreso il sistema dell’istruzione –, tuttavia è altrettanto vero che c’è sempreuna dimensione relazionale tra un sanitario eil cittadino nella quale si gioca un compo-nente educativa. Nel primo caso – advocacy,mentoring – si tratta di produrre un processodi maturazione dei sistemi non sanitari versoun’assunzione di responsabilità verso la salutedei cittadini, nell’altro caso si tratta di istitu-ire un processo di maturazione del cittadinoverso la propria salute in una direzione “poli-tica” e che può essere qualche volta “eversiva”rispetto allo status quo (si pensi alle “lotte” oalle “conquiste” per la salute compiute peresempio in ambito lavorativo).La recente manifestazione nazionale “Guada-gnare Salute” (Orvieto, ottobre 2014), ha mo-strato con fisica evidenza quanto sia avanzatoil discorso sulla promozione della salute nelnostro Paese. Interrogarci sulla dimensioneeducativa contribuirà a dare senso agli sforziche tanti operatori e istituzioni compiono ognigiorno per: “aumentare il controllo delle personesui determinanti della propria salute”.
BIBLIOGRAFIA1. Glossario OMS della Promozione della Salute, World
Health Organization, Ginevra, traduzione a curadel Centro Regionale di Documentazione per laPromozione della Salute, DoRS, 2012
2. Testo unico delle leggi in materia di disciplina de-gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio-ne, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza” (DPR 309/90)
3. http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/ (ultimo accesso 15/11/2014)
4. Corradini L Il lavoro scolastico: organizzazione emetodi promotori di benessere, La Salute Umana
2003;183-184-185-186:18-225. http://ec.europa.eu/health/health_policies/policy/
index_it.htm (ultimo accesso 15/11/2014)6. Markham WA, Aveyard P. Una nuova teoria di scuola
promotrice di salute basata sul funzionamento del-l’essere umano, l’organizzazione scolastica, la pra-tica pedagogica, Educazione Sanitaria e Promozio-ne della Salute 2005; 3:181-201
7. Beatini P, Beltrano A.Scuola Produttrice di Salute: unmodello organizzativo per la Regione Umbria, LaSalute Umana 2009;217-218: 33-45
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 295-307
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute: il servizio sanitario nazionale traprevenzione, cura e saluteOn the side of health: the National Health Service between prevention, care andhealth
Fulvio Forinomedico di sanità pubblica, presidente di Dedalo 97
Tanto tempo faQuando una scuola fa scuolaEra il 1975 quando m’iscrivevo alla Scuoladi Specializzazione in Igiene e Medicina Pre-ventiva dell’Università di Perugia diretta dalprofessor Alessandro Seppilli. Per me, gio-vane medico romano, appena laureato, fucome sbarcare su Marte. Tutto era ben orga-nizzato, l’ambiente accogliente, tutti eranogentili e disponibili. Sapevo che la scuola erainnovativa e molto impegnativa. Infatti, cosainconsueta per quei tempi, al primo annoprevedeva una frequenza obbligatoria di tregiorni alla settimana e gli anni successivi ri-petuti stage. Materie come igiene, microbio-logia, statistica, medicina del lavoro o legi-slazione sanitaria, erano proposte con un ta-
glio interdisciplinare. Mentre lo studio delletradizionali materie dell’igiene ci impegna-va fortemente, i corsi d’antropologia cultu-rale, sociologia, psicologia dei piccoli grup-pi, programmazione sanitaria, management,educazione sanitaria introducevano noi spe-cializzandi nel mondo, a noi sconosciuto,delle scienze umanistiche e sociali. Appren-devamo a spaziare dalla prevenzione alla di-rezione sanitaria degli ospedali, dalla comu-nicazione ai modelli di malattia, dal rappor-to con il paziente agli screening, dalla mi-crobiologia ai fattori di rischio per la salute,dall’empatia alla futuribile funzione delle Usle del distretto.Noi specializzandi avevamo idee poco orga-nizzate circa la medicina preventiva, la pre-
296
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
mise d’apprendere a rendere porosi i confinidel nostro sapere. Senza diventare psicologi,antropologi o sociologi avevamo scoperto cheera possibile fecondare le nostre conoscenzebiomediche con quelle delle scienze umani-stiche e sociali per poi servircene sul campo.Avevamo nelle nostre mani la chiave che aprela porta dell’interdisciplinarietà e del “lavo-rare insieme”.Molti ritengono che le persone di scienzavadano giudicate per quello che pensano eteorizzano più che per quello che fanno. An-tesignano è sinonimo di precursore, pionie-re, guida, maestro, capo, animatore e, damoltissimi anni, penso che il professor Sep-pilli sia stato un antesignano e non solo perquello che pensava e diceva, ma per la con-cezione che aveva dell’uomo, della salute,della medicina e della sanità pubblica che sirispecchiava nel suo “modo d’essere mae-stro”, nell’impostazione che diede alla Scuo-la di Specializzazione d’Igiene, e al CentroSperimentale per l’Educazione Sanitaria.Spesso penso che ricordo con entusiasmo glianni passati a Perugia perché erano gli anniin cui ero giovane e pieno di energie e cu-riosità. Poi, però, ripenso a quanto, a queitempi, l’università fosse un mondo chiuso,centrato su un insegnamento omologato,quanto spegnesse ogni apertura al futuro eogni tensione all’innovazione. Mi confermoallora nell’idea che la Scuola di Specializza-zione in Igiene e Medicina Preventiva e ilCentro Sperimentale d’Educazione Sanita-ria furono, per me, per noi specializzandi,una formidabile palestra formativa. Com-prendo perché per moltissimi anni ho avu-to difficoltà a intendermi con il mondo de-gli igienisti. Solo dopo molto tempo hocapito che avevo appreso a stare dalla partedella salute e che avevano fatto di me un“igienista anomalo”.
venzione, l’educazione sanitaria che ci ven-nero proposte nell’ambito d’una riflessionesullo sviluppo della società, sul modello del-le malattie cronico - degenerative e sul lorocollegamento con l’ambiente, i determinan-ti di salute e i fattori di rischio. Avevo appe-na lasciato un’università autoritaria, estra-niante e, incredibilmente, mi ritrovai a “es-sere ammesso” ai seminari dei “Professori”che spaziavano dalla plastiche impiegate perl’imbottigliamento dell’acque minerali allestrategie comunicative in educazione sani-taria, dallo smaltimento dei rifiuti alla pro-gettazione di ospedali organizzati per inten-sità delle cure, dalle vaccinazioni al vissutodi malattia, dalla leadership alla medicinasociale.Al terzo anno di specializzazione mi venneproposto di fare esperienza sul campo e tennidei corsi di pronto soccorso per gruppi d’ope-rai dell’Enel e degli incontri d’educazione sa-nitaria in centri d’educazione popolare del-l’allora Ministero della Pubblica Istruzione.Con altri specializzandi partecipai come ani-matore a diversi Corsi Estivi di EducazioneSanitaria scoprendo, come “costruire” unalezione partecipata, cos’è un role playng,come comunicare in gruppo di lavoro.L’Istituto d’Igiene era organizzato come unaéquipe interdisciplinare in cui ognuno avevaun suo ruolo e il Centro Sperimentale perl’Educazione Sanitaria era un vero e propriolaboratorio d’idee. Così, apprendevamo moltodai libri, ma ancor più da come era organiz-zata l’attività di Seppilli e dei suoi collabora-tori, dal modo di funzionare dell’istituto edella Scuola di Specializzazione d’Igiene, dal-la spinta alla creatività e all’innovazione checaratterizzava il Centro Sperimentale perl’Educazione Sanitaria. L’aver potuto seguireun piano di studi che forniva conoscenze dibase proprie di “materie” umanistiche ci per-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
297Fulvio Forino
L’anomalia SeppilliNel 1948, l’OMS definì la salute come “unostato di completo benessere fisico, mentalee sociale e non la semplice assenza di ma-lattia o d’infermità”. A sua volta, fin dal1966, il prof. Alessandro Seppilli elaborò unasua definizione secondo la quale “la salutenon è una condizione statica d’equilibrio perfet-to; al contrario, essa consiste in uno sforzo conti-nuo di adattamento alle mutevoli condizioniambientali. La salute è una condizione di ar-monico equilibrio funzionale, fisico e psichico,dell’individuo integrato dinamicamente nel suoambiente naturale e sociale”.In questa definizione sta tutta la sua “ano-malia”. Se, infatti, entrambi le definizionispostano l’attenzione dalla malattia alla sa-lute, quella di Seppilli ha il carattere di unvero e proprio nuovo paradigma dissonan-te, “anomalo”, appunto, rispetto al pensie-ro “normale”. È paradigmatica nel sensoproprio della parola. Nasce, infatti, comeipotesi di ricerca, teorica e pratica, che, sullabase di riscontri positivi, è riconosciutacome valida e come modello di riferimentoda una comunità scientifica e professionale.Anticipa una visione complessa e sistemicadella vita, della società, dell’uomo, dellasalute e della malattia che oggi, a distanzadi tanti anni, è di grande attualità. Pone afondamento della sanità pubblica la difesa ela promozione della salute “di ciascuno e ditutti” intesa come strategia volta a integra-re la prevenzione, l’educazione alla salute,la medicina preventiva e quella delle cure edell’assistenza.
Una definizioneNella sua definizione, Seppilli esclude che lasalute sia “una condizione statica d’equilibrioperfetto”, uno “stato di perfetto benessere” econ ciò la possibilità che sia una conquista
data una volta per sempre.Esclude ogni visione meccanicistica e ridu-zionista e la possibilità che una persona pos-sa essere compresa, curata, presa in cura, scin-dendo le sue molteplici dimensioni, fram-mentandola in organi e apparati, riducendo-la alla sua biologia e alla sua malattia rivela-ta da sintomi e segni. La complessità e mul-tidimensionalità sono caratteristiche propriedell’uomo. Le possiamo riassumere nelle tredimensioni fondamentali biologica, psico-logica e sociale che, per praticità, possiamostudiare separatamente, ma che non possia-mo scindere quando siamo a curare un pa-ziente a prenderci cura d’una persona. “Ilmodo d’essere” dell’una dimensione, infatti,influenza, ricorsivamente, quello dell’altre.Sono tra loro interdipendenti e in un equili-brio instabile, dinamico e mutevole, dalla cuistoria emerge la condizione di salute/malat-tia di ogni ciascuno e la sua stessa identità esingolarità, colta nella sua irripetibile indi-vidualità.Nel collegare la multidimensionalità dellepersone e della salute all’ambiente naturale esociale, Seppilli preannuncia la necessità d’in-tegrare il paradigma bio medico e quello bio-psico-sociale che oggi, in medicina e nell’assi-stenza, rappresenta un nodo ancora da scio-gliere. Esclude che l’uomo possa essere assi-milato a una macchina biologica. Ha chiaris-simo che ogni essere vivente è un’unitaria re-altà sistemica e che “la salute è la salute deltutto [...] e [...] che l’equilibrio funzionale d’ogniindividuo è direttamente collegato alla salute fisicae alla salute mentale, che non sono altro che duefacce di dello stesso prisma, e che l’una dipende stret-tamente dall’altra e non può esserne isolata”.Nella sua definizione di salute, Seppilli ci ri-vela che l’uomo è un essere complesso, unsistema aperto, adattativo e che la fatica delvivere sta in “uno sforzo continuo di adatta-
298
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
mento alle mutevoli condizioni ambientali” e nellanecessità/possibilità di procurarci dall’am-biente, e d’utilizzare al meglio, le risorse ne-cessarie al nostro sviluppo e benessere. L’uo-mo non è una monade in se compiuta e indi-pendente dall’ambiente. Al contrario ciascu-no vive immerso in un ambiente, in un con-testo, che può essergli più o meno favorevo-le, con il quale coevolve e stabilisce una re-lazione che non è solo di dipendenza ma ècostitutiva della sua stessa identità, del suoessere e benessere, della sua condizione disalute/malattia.Nella visione di Seppilli, gli individui con-corrono incessantemente a trasformare l’am-biente che a sua volta agisce su di loro inun’incessante dinamica ricorsiva di recipro-co influenzamento. Si rivela, così, il para-dosso delle malattie cronico degenerative chesta tutto nel rapporto di causalità circolareche lega uomo e società, salute e ambiente.Infatti, le cause di molte delle malattie cro-niche che affliggono l’uomo nei paesi occi-dentali sono largamente riconducibili al tipodi società che l’uomo stesso ha generato. Seabbiamo creato condizioni di vita favorevolialla salute, largamente diffuse, abbiamo,però, paradossalmente, dato vita a contrad-dizioni sociali che “s’incarnano” negli indivi-dui” sotto forma di malattia.Non c’é alternativa a una visione in cui daun lato la “tutela della salute” rientra trai compiti fondamentali dello Stato, e dal-l’altra gli individui e le comunità localisono chiamati a scelte e comportamentiresponsabili. Per Seppilli, infatti, era asso-lutamente chiaro che le malattie cronicodegenerative non riconoscono solo causenaturali o genetiche, ma sono, quasi sem-pre, “connaturate” da un lato a comporta-menti individuali e collettivi e dall’altra ascelte e politiche di sviluppo, non solo in-
dustriale, del nostro paese e a potenti econsolidati interessi. Basta pensare che lepiù comuni malattie, come cancro, diabe-te, malattie cardiovascolari e respiratorie,sono riconducibili a un intreccio di fattoricausali e di rischio tra i quali vi sono, alivello individuale, fumo di sigaretta, usod’alcool, mancanza d’attività fisica, errateabitudini alimentari e, a livello di società,rischi da lavoro, ritmi di vita stressanti,inquinamento dell’aria, produzione indu-striale di alimenti, pressione al consumodi bevande e di alcoolici, […] bassi livellidi reddito e d’istruzione direttamente col-legati alla scarsa capacità d’accedere ai ser-vizi sanitari [...] Esemplificativo di que-st’intreccio di cause e concause, fattori dirischio e determinanti di salute è il casodell’obesità e del sovrappeso. Secondo datidel 2010, forniti del Ministero della Salu-te, in Italia, il 22,9% dei bambini delleterza classe primaria, di 8-9 anni di età, èin sovrappeso e l’11,1% in condizioni diobesità e si stima che obesità e sovrappe-so siano determinanti nell’insorgenza del44% dei casi di diabete tipo 2, del 23% deicasi di cardiopatia ischemica e fino al 41%di alcuni tumori.Seppilli fu tra i primi ad avere la luciditàd’insistere sull’idea che la prevenzione puògiocare un ruolo in termini di sostenibilitàdel SSN. Non siamo, infatti, riducibili allanostra biologia, al nostro “destino” gene-tico e “la difesa della salute di tutti e di cia-scuno” non è solo un “fondamentale dirittodell’individuo”. È un “interesse della col-lettività”, un bene comune, è non solo unobbiettivo per ogni individuo e per ognicomunità, ma anche un mezzo, una risor-sa che permette di condurre una vita pro-duttiva e socialmente utile sotto il profilopersonale, culturale e economico.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
299Fulvio Forino
La crisi sistemica del SSNLa frantumazione del SSNNel suo articolo del 1969 Seppilli esprimevauna visione unitaria del SSN secondo la qualela sanità andava gestita a livello locale mentrelo Stato aveva la difesa della salute come “suocompito primario, come per l’istruzione, l’eserciziodella giustizia o la difesa dei confini”.Negli anni, le Regioni hanno ottenuto unasempre più ampia autonomia che in sanitàha fatto venir meno un significativo coordi-namento centrale. Per decenni, hanno adot-tato politiche e modelli organizzativi moltodiversi, così che, oggi, siamo di fronte allafrantumazione del SSN in 21 Servizi Sanita-ri Regionali. Pochi esempi sono illuminanti.I sistemi informatici e informativi delle di-verse regioni hanno caratteristiche che nonpermetto loro di dialogare e, salvo alcuneeccezioni, di generare informazioni naziona-li. In alcune regioni si erogano farmaci chealtre non dispensano; vi sono macroscopichedifferenze che riguardano non solo i tempi diattesa e l’accessibilità dei cittadini alle pre-stazioni ma anche l’applicazione dei livelliessenziali d’assistenza e l’erogazione di alcu-ne tipologie di prestazioni. Permangono di-storsioni e differenze tra le regioni in termi-ni di dotazione di posti letto ospedalieri, distrutture intermedie di riabilitazione e di lun-godegenza, di residenze sanitarie assistite, dihospice. Variano da regione a regione gli stan-dard per l’accreditamento delle strutture sa-nitarie, il livello d’integrazione tra servizi esanitari e sociali, il sostegno dato alla fami-glie di disabili, così come la consistenza ecapillarità dell’assistenza domiciliare.Sappiamo che in ogni sistema socialmentecostruito gli equilibri vanno ristabiliti decen-trando al massimo le decisioni e le soluzionida adottare, ma sappiamo anche che ognidecentramento presuppone la possibilità per
il “centro” di riprendere il “controllo” dellasituazione. Senza immaginare ritorni a unimproponibile centralismo, possiamo ritenereche l’elusione dei più elementari principi dibilanciamento dei poteri tra diversi livelliistituzionali sia una delle cause della frantu-mazione del SSN e del mancato controllodella spesa che ha portato ben dieci regioniad essere commissariate nel 2012. È neces-sario abbandonare la difesa ad oltranza del-l’autonomia regionale e riequilibrare il ripar-to costituzionale delle competenze tra lo Sta-to e le Regioni in funzione dell’universalitàdel SSN e di una tensione all’equità volta aassicurare ai cittadini di ogni regione gli stessilivelli essenziali d’assistenza.Dovremmo riflettere sul fatto che il proble-ma della sostenibilità del SSN non ha unasoluzione unica, né tanto meno semplice. Vaperseguita adottando una strategia dell’inte-grazione dei servizi sanitari regionali e, al lorointerno delle aziende della sanità, ridimen-sionando una visione meramente aziendali-stica della sanità e affermando la missionedel SSN che consiste non solo nell’assicuraredei sistemi di cure, ma anche nello stare “dallaparte della salute”.
La complessità della salute, delle persone,dei pazientiSecondo Seppilli, “la salute è un fatto unita-rio... è una condizione d’equilibrio di tutto l’or-ganismo di tutte le sue parti e la difesa della sa-lute deve essere unitaria e deve tener conto di tuttele componenti, interne e esterne, di ordine fisico,psichico e sociale” [...] “la malattia di una parteè sempre la malattia del tutto […] Non si posso-no separare rigorosamente le malattie del corpo daquelle dello spirito, perché in effetti lo spirito non èaltro che un attributo del corpo”.Aveva chiaro che confrontarsi con la salute,con le persone e i pazienti, implica la consa-
300
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
pevolezza della loro complessità. Fare salutesignifica intervenire per “modificare durevol-mente e consapevolmente i comportamenti degli in-dividui” e contemporaneamente agire sul loro“ambiente naturale e sociale”, sul contesto incui essi vivono ovvero sull’insieme delle re-lazioni, condizioni e fatti che portano al ve-rificarsi di determinati comportamenti o si-tuazioni. Infatti, “la nostra salute dipende inlarga misura dalla nostra posizione nell’assettodella società e dai rapporti interpersonali che in-tercorrono tra noi e i nostri simili”. Nella suavisione, curare una persona è altro dal curareun organo o una malattia. Un paziente è unapersona in cui si verifica un “groviglio” ine-stricabile di patologie e di situazioni e pro-blemi psicologici, affettivi, sociali, familia-ri, culturali, ambientali, a loro volta così tantotra loro “intrecciati” da rendere la singolapatologia o il singolo problema un’astrazio-ne che non è possibile curare o risolvere estra-endola dagli altri. Il prof. Seppilli praticavaun approccio interdisciplinare, sistemico aiproblemi che affrontava che riproponeva nellasua concezione di educazione sanitaria e dicura delle persone la cui multidimensionali-tà e complessità impongono ai professionistidella sanità di possedere competenze non solobio mediche, ma anche quelle competenzesociali, psicologiche e umanistiche che, sot-tese dal paradigma bio-psico-sociale, sononecessarie per sostenere una persona e/o unacomunità nella promozione della propria sa-lute o un paziente nell’aderire a stili di vitacorretti o terapie impegnative.
Cronicità e complessità dei pazientiSeppilli, poneva una particolare attenzioneai dati epidemiologici intuendo che, comepoi sarebbe accaduto, in pochi anni, le pa-tologie cronico degenerative sarebbero dive-nute predominanti. Uno studio del 2005,
compiuto negli Usa sugli utenti di Medica-re, tutti ultra sessantacinquenni, rilevava cheil 50% di essi assume ogni giorno più di 5diversi farmaci, il 48% di essi sono pazienticronici, complessi in quanto hanno almenotre delle patologie più frequenti, mentre il21% ne presenta almeno 5. Oggi, nel nostropaese, l’Istat rileva che, in persone con etàsuperiore ai 14 anni, i disturbi psichici e com-portamentali e le malattie dell’apparato oste-omuscolare, del sistema circolatorio, respi-ratorio e digerente sono, in media, associatiad altre 4 o 5 patologie.Oggi, siamo di fronte a “un’epidemia” dipazienti cronici, polipatologici, e perciò com-plessi, che possono essere, ma non necessa-riamente sono, pazienti anziani, fragili, disa-bili, critici o ad alto assorbimento di risorse,genericamente “difficili” o “complicati”.Sono pazienti sempre portatori d’una pato-logia complessa che emerge, come tale, “dal-l’intreccio” di più patologie di cui sono por-tatori. In quanto tali, sono, per definizione,esclusi dai trials clinici. Sono EBM orfani edifficilmente “protocollabili” così che si apreuna contraddizione di difficile soluzione trala loro gestione e il ricorso a linee guida, pro-tocolli e percorsi clinico assistenziali.Dovremmo riflettere sul fatto che nella pra-tica medica e assistenziale, un paziente com-plesso non può essere gestito sommando piùconsulenze, più diagnosi, più linee guida, piùprotocolli, più prestazioni professionali, piùfarmaci, più prescrizioni terapeutiche, ali-mentari e comportamentali. La sua gestionerichiede più professionisti e/o specialisti che,interagendo sistematicamente tra loro, indi-viduino, sulla base dei massimi livelli possi-bili di accordo e certezza, una strategia e ledecisioni, le azioni prioritarie e le figure pro-fessionali da mettere in campo per raggiun-gere, in un determinato tempo, un insieme
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
301Fulvio Forino
condiviso d’obiettivi che coinvolgano, ognivolta che sia necessario e possibile, il pa-ziente stesso e i suoi familiari e caregiver.
I pericoli nella specializzazione“La progressiva specializzazione […] ha fram-mentato gli interventi: per cui ci troviamodi fronte alla necessità di ricomporli in qual-che maniera, perché l’individuo è pur sem-pre un tutt’uno e non c’è alterazione dellasalute che non si rifletta su tutto l’organi-smo” […] “Questa concezione contrasta conla prassi degli ultimi decenni, tutta concen-trata nella cura delle malattie, affidata a unnumero sempre crescente di “specialisti” sem-pre più specializzati, nessuno dei quali puòavere una visione panoramica del soggettonel suo complesso e nelle sue interazioni conl’ambiente naturale e sociale”.Già nel 1969 Seppilli individuava i pericoliinsiti nel processo di specializzazione, sem-pre più accelerato, che riteneva inevitabile econseguente al dilatarsi delle conoscenze edella tecnologia. La specializzazione, infatti,se ha comportato il vantaggio della diversi-ficazione della conoscenza, delle funzioni edei compiti, ha, però, generato il paradossodella “fragilità” del sapere specialistico. In-fatti, più le sue conoscenze sono “specializ-zate” meno lo specialista sa del “curare iltutto” e del “prendersi cura della persona”.Infatti, di fronte alle persone e a quadri pato-logici complessi, deve saper valutare e inte-grare una moltitudine di dati, informazionie variabili, non solo biomedici, ma anchesociali, economici, affettivi e psicologici traloro intrecciati e inseparabili. Si trova, così,a dipendere, a livello biomedico, da altri spe-cialisti e, a livello e dell’assistenza e delleproblematiche psicologiche e sociali, da altriprofessionisti.Dai lontani anni settanta la medicina ha ri-
sposta alla crescente complessità delle pato-logie dilatando il ricorso alle consulenze,ovvero a un metodo, che, nato in ospedale eesportato nella realtà dei servizi poliambula-toriali e territoriali, mostra oggi tutti i suoilimiti ed è tra le cause di rallentamenti, ri-dondanze, errori di comunicazioni e incer-tezza circa le responsabilità, le decisioni daprendere e le azioni da mettere in campo.Nel tempo l’organizzazione delle aziendedella sanità s’è complicata e al suo internostrutture e servizi specializzati hanno diffi-coltà a dialogare e a interconnettersi. Anco-ra oggi in sanità, domina una cultura del sa-pere identificato con la sola competenza tec-nica, mentre ai professionisti, e tanto più ailoro “direttori”, sono richieste oggi le capa-cità di lavorare in squadra e d’empatia pro-fessionale nel rapportarsi con i pazienti e conaltri operatori.Dovremmo riflettere sulla lezione di Seppil-li e dei suoi collaboratori i quali, in un mon-do universitario che non preparava in alcunmodo a “lavorare insieme”, improntavanoall’interdisciplinarietà l’attività dell’Istitutoe della Scuola di Specializzazione d’Igiene e,più che mai, quella del Centro Sperimentaleper l’Educazione Sanitaria di Perugia. Do-vremmo riflettere sulla necessità d’adottarein sanità un approccio sistemico che porti alsuperamento della “frammentazione specia-listica” dei pazienti e delle cure in funzionedell’unitarietà e continuità dell’assistenza.Dovremmo ripensare profondamente l’orga-nizzazione delle aziende della sanità che osta-cola la stessa proposizione di forme di lavoroinnovative, orizzontali, basate sulla collabo-razione tra strutture e/o servizi e professio-nisti diversi che mettono in discussione inte-ressi consolidati e una cultura aziendalisticaverticistica.
302
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
Organizzazioni verticaliSeppilli metteva in guardia da “un altro peri-colo, quello della dispersione che noi cerchiamo diunificare attraverso la persistenza di struttureverticali settoriali […] che cercano di sopravvi-vere e trovano alcuni consensi.”Da tempo, ormai, un numero crescente diprofessionisti avverte una “solitudine profes-sionale” vissuta come disagio, come difficol-tà a “lavorare insieme”, a “fare sistema”, chevanifica i loro sforzi per migliorare l’assisten-za. A questa difficoltà si è tentato di rispon-dere utilizzando la stessa logica che l’ha ge-nerata. Così, mentre l’efficienza e l’efficaciadelle prestazioni dipendono sempre più dalcoordinamento di più professionisti e/o uni-tà operative, oltre che, evidentemente, dalleloro capacità individuali, la gestione delleaziende della sanità si concentra sulle perfor-mance dei singoli, professionisti e/o servizi.Fa riferimento all’ingegneria organizzativa,all’efficientismo aziendalistico, al controllodi gestione, con il risultato di complicare l’or-ganizzazione e di dilatare la burocrazia. Pre-vale ancora una concezione sostanzialmentemeccanicistica delle aziende della sanità chenon pone sufficiente attenzione alle relazionid’interdipendenza e di reciproco influenza-mento che intercorrono tra i loro compo-nenti, servizi e/o singoli professionisti. Leaziende della sanità sono strutture rigide, es-senzialmente verticali, a canne d’organo. Alloro interno si pongono ostacoli all’innova-zione e all’integrazione organizzativa. Quantile abitano sono stati poco preparati, e sonopoco disposti, a “lavorare insieme”. Il mana-gement quasi sempre investe poco tempo epoche risorse per promuovere modalità or-ganizzative orizzontali, flessibili, adattativeche valorizzino le specifiche competenze deisingoli elevandole a complementarietà or-ganizzata. Non incentiva la capacità degli
operatori di muoversi tra regole date e occa-sioni che si pongono, per sfruttare la possibi-lità di dare vita a equipe, reti e gruppi dilavoro interdisciplinari, per “autorganizzare”il loro “lavorare insieme” fondato su stima efiducia tra colleghi e sul perseguimento diobiettivi riconosciuti come propri dall’azien-da d’appartenenza. Dovremmo riflettere sulperché della “persistenza di strutture verticalisettoriali […] che cercano di sopravvivere e tro-vano alcuni consensi” e su quante risorse e quan-to tempo saranno necessari per ridurre le ver-ticalità, abbattere confini e per realizzare mo-dalità organizzative basate sulla capacità de-gli operatori di fare sistema.
Il ruolo del medico di famigliaSecondo diverse stime, nel nostro paese visono 250.000 “casi” di diabete di tipo uno,3.000.000 di diabete di tipo due, 1.500.000di bronchite cronica ostruttiva, 300.000 diartrite reumatoide. I pazienti in dialisi sono250.000, i parkinsoniani più di 220.000, icardiopatici complessivamente 750.000. Lepersone sopravvissute a una diagnosi di tu-more sono circa 2.250.000 e oltre 900.000quelle sopravvissute a un episodio di ictuscerebrale. Le persone affette d’Alzheimer epre-Alzheimer sono circa 600.00 e gli adole-scenti con disturbi pervasivi dello sviluppocirca 300.000 … . Studi dei medici di fami-glia, servizi territoriali, strutture intermediee ospedali, sono affollati da pazienti cronici,da “malati per sempre” che esprimono nuovibisogni e diritti di salute, che chiedono dinon essere solo “oggetto” d’assistenza, maanche di essere considerati persone partecipidella gestione delle cure e del raggiungimen-to e mantenimento del migliore stato, perloro possibile, di salute e benessere.Ancora una volta Seppilli anticipa di moltoil futuro. “Il medico personale deve restare il cen-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
303Fulvio Forino
tro di riferimento di tutti gli interventi che vengo-no fatti sul suo assistito, anche quando egli sitrova a ricorrere alla collaborazione di specialistiper atti diagnostici e terapeutici che egli non èin grado di assumere in proprio” […] “Ciò cifa sentire da una parte il bisogno di una ria-bilitazione del medico di famiglia, che si assu-ma la responsabilità dell’individuo continua-tivamente, e, dall’altra, la necessità di un co-ordinamento di quegli interventi specialistici,che, inevitabilmente, dovranno completare l’ope-ra del medico personale”.Delinea con grande lucidità la situazione at-tuale per cui, in medicina e nell’assistenza,qualità e appropriatezza dipendono sempremeno dalle capacità dei singoli e sempre piùda “sistemi di servizi e di professionisti” cheintegrano competenze e attività di più pro-fessionisti coordinati tra loro e con un casemanager. La figura del case manager, conce-pibile nel 1969 solo da pochi, è ormai conso-lidata in molti servizi territoriali d’assisten-za domiciliare, di psichiatria, di riabilitazio-ne in età evolutiva, di medicina delle dipen-denze […] e non potrà non riguardare, in unprossimo futuro, il ruolo degli internisti odei geriatri in quegli ospedali che si vannoriorganizzando in funzione della complessitàassistenziale e dell’intensità delle cure, o ilruolo del medico di famiglia che chiamato aoperare in “case della salute” concepite perintegrare la sua attività con quella di specia-listi e infermieri al fine di ricomporre la fran-tumazione dell’assistenza territoriale e d’as-sicurare le prestazioni richieste in un deter-minato bacino d’utenza.Oggi tutti concordano sul fatto che, comeSeppilli immaginava, il medico di famigliadebba sviluppare le competenze necessariealle sue funzioni, proprie del case manager,d’accompagnamento delle persone nel loropercorso di vita e di responsabile delle cure
che, nella gestione di particolari situazioni epazienti, implicano la capacità di coordina-re più specialisti e/o professionisti.In questo senso un segnale ci viene dallaMedicina di Famiglia che ha sottratto, findalla loro nascita, le proprie scuole di forma-zione all’egemonia dell’insegnamento univer-sitario. Queste scuole sono orientate a forni-re un insegnamento che integri le compe-tenze cliniche con le competenze proprie delparadigma sistemico bio-psico-sociale. Pre-parano i futuri medici di famiglia, oggi dimedicina d’iniziativa, oltre che a curare lemalattie, a lavorare disponendo di pochi datibiomedici, a contestualizzare il paziente, autilizzare la sua narrazione e il suo vissuto dimalattia. Sono orientate a fornire le capacitànecessarie a “lavorare insieme” a rapportarsicon pazienti anziani, cronici, complessi con-siderati come persone verso le quali svolgereun ruolo di counseling per orientarli, respon-sabilizzarli e sostenerli nell’assumere un ruoloattivo e scelte consapevoli.La scelta della medicina di famiglia ci do-vrebbe far riflettere sul fatto che ancora oggi,come mezzo secolo fa, il medico esce dallenostre università ottimisticamente meccani-cista e riduzionista, convinto che tutta lamedicina consista nel porre diagnosi e nel-l’assegnare terapie e inevitabilmente votatoa specializzarsi.Il professor Seppilli citava spesso il motto“che si legge in Plauto. Nemo sati sapit” che cifa riflettere sul fatto che l’insegnamento uni-versitario, tutt’oggi centrato sulla medicinaclinica e tecnologica, dovrebbe fornire ai fu-turi professionisti della sanità, non solo me-dici, almeno la consapevolezza del limite im-plicito nelle conoscenze proprie di ogni pro-fessione o specializzazione e, almeno, gli stru-menti critici per comprendere che sempremeno in medicina si vince da soli e che è
304
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
necessario sapersi “connettere” soprattuttoquando ci si trova di fronte a un “intreccio”di più patologie e di situazioni e problemipsicologici, affettivi, sociali, familiari, cul-turali come avviene nella gestione di quei“casi unici” quali sono i “pazienti reali”, po-lipatologici, fragili, complessi e poco “pro-tocollabili”.
Salute e sostenibilità del SSNLo sperpero di risorse pubbliche e la crisi deivaloriSecondo il documento della Camera dei De-putati, XVII, n. 4, del 2014, “l’illegalità e lacorruzione rappresentano all’incirca il 5-6 percento della spesa sanitaria (circa 5-6 miliardidi euro); si tratta di un fenomeno preoccu-pante che non solo incide sull’efficienza e sul-l’equità dei servizi, ma che mina alla radiceil rapporto di fiducia tra istituzioni e i citta-dini”. A fronte di casi di sana gestione, unamiriade di casi d’invadenza della politica e diclientelismo hanno minato i valori su cui sifonda un servizio pubblico. Sono noti i ripe-tuti casi in cui “la politica” è arrivata a con-trollare e alterare le normali procedure ri-guardanti nomine, assunzioni, carriere, ap-palti, forniture, accreditamenti di struttureprivate […] Il SSN e le aziende della sanitàsono stati pervasi da valori negativi e antiso-ciali, spesso fortemente autoreferenziali, chehanno avuto effetti devastanti sul clima in-terno, sulla motivazione e sul senso di re-sponsabilità dei professionisti. Disaffezioneal lavoro, infedeltà all’azienda, inefficienza,sprechi e errori, deresponsabilizzazione deglioperatori sono largamente riconducibili allamancanza di fiducia e stima verso ammini-stratori e manager “poco credibili”, se noncompromessi sul piano etico e, spesso, an-che tecnicamente inadeguati.Sottrarre illecitamente risorse alla sanità si-
gnifica “rubare salute” e non possiamo nonriflettere su quanto sia ormai inevitabile unradicale ridimensionamento della politicanella gestione della sanità e rivendicare conforza, pretendere, amministratori e managerche abbiano non solo una competenza tecni-ca, ma soprattutto una credibilità etica sor-retta dalla capacità di proporre come valorela salute e come bene comune, per i cittadinie per quanti vi operano, il SSN e le aziendedella sanità che lo compongono.
Il fantasma dei costi insostenibiliDiscutere di sostenibilità del SSN significaconsiderarlo un sistema, vasto, complesso emolto articolato. Il suo funzionamento coin-volge legislatori e governanti del nostro pae-se, migliaia di amministratori e manager,migliaia e migliaia di imprenditori e forni-tori, centinaia di migliaia d’operatori maanche, e soprattutto, direttamente e indiret-tamente, milioni di cittadini in quanto pa-zienti “per sempre” e i loro familiari e deci-ne di milioni di cittadini “utenti occasiona-li”, che un travisato modernismo ha trasfor-mato in clienti estraniandoli come tali daiproblemi che si pongono in sanità.In una logica ancora troppo “mutualistica”,per soddisfare i “propri clienti”, le aziendedella sanità sono concepite come macchineper produrre prestazioni. La loro gestione siconcentra sull’efficienza tesa a incrementareun’offerta di prestazioni che, paradossalmen-te, ha l’effetto di dilatarne la domanda chespesso è alimentata da interessi di terzi, dapratiche inappropriate e da comportamentideresponsabilizzati dei “clienti”. Come in altripaesi occidentali, anche in Italia la crisi eco-nomica ha determinato un abbassamentodella soglia di sostenibilità del SSN a cui s’ècercato di far fronte mettendo in atto politi-che di razionamento e di risparmio, tagli ai
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
305Fulvio Forino
finanziamenti e maggiori controlli della spe-sa delle aziende e dell’efficienza dei servizidella sanità. Queste misure non sembranoperò efficaci contro ciò che Seppilli definivacome “il fantasma dei costi insostenibili”. Egli,senza mai mettere minimamente in discus-sione la conquista di una sanità pubblica cheassicuri i cittadini dal rischio di malattia, giàallora aveva chiaro che “il diritto alla salute èun diritto tendenziale, non è un diritto assoluto,filosofico” e che “se volessimo portare le prestazio-ni a livelli insostenibili dalla collettività, esse sa-rebbero insostenibili in qualsiasi sistema”.
AppropriatezzaPochi dati sono sufficienti a farci compren-dere che la sostenibilità del SSN e del suocarattere dipende certamente dal contrastoall’illegalità e alla corruzione, ma anche, enon marginalmente, dall’impegno volto acontenere l’inappropriatezza delle prestazio-ni erogate e quell’insieme di spinte e interes-si che ne alimentano la domanda. Secondodiverse stima, nel 2012, risulterebbe inap-propriato il 40% delle medicazioni avanza-te, il 25% delle indagini d’imaging, il 15%delle giornate di ricovero e, complessivamen-te, il 30% della spesa sanitaria sarebbe statodestinato all’erogazione di prestazioni inap-propriate, se non nocive. Secondo uno studiopiù recente, su 2.500 prestazioni, supportateda evidenze scientifiche, solo il 46% risulte-rebbe sicuramente utile e mentre il 4% sa-rebbe stato dannoso.L’appropriatezza è una combinazione di effi-cienza, efficacia e corretta indicazione, foca-lizza l’attenzione sui benefici delle prestazio-ni per l’utenza, esprime la tensione a conte-nere sprechi ed errori e a dare concretezzaalla qualità. In un SSN “intossicato” da me-dicina difensiva, interessi economici, spre-chi, ridondanze, errori, efficientismo […]
“fare appropriatezza” spesso consiste nel “faremeno per fare meglio”. Manager credibili,che comprendano quanto l’appropriatezzadipenda dai comportamenti responsabilidegli operatori sanitari, dovrebbero proporlaloro come valore impegnandoli professional-mente e moralmente. L’etica dell’appropria-tezza, infatti, si fonda su libertà professiona-le, rapporto fiduciario e beneficiario per ilpaziente, operare secondo scienza e coscien-za, agire con perizia, prudenza e diligenza[…] sono valori deontologici condivisi datutte le professioni sociali e sanitarie. Dopodecenni passati alla ricerca d’una efficienzasganciata da valori e a discutere di come “ri-sparmiare”, dovremmo occuparci non solodi quanto si spende e si lavora, ma anche, dicome si spende e si lavora e, soprattutto, percosa si lavora.Potremmo allora chiederci se la sostenibilitàdel SSN non stia anche nella capacità del SSNdi generare salute. Se non richieda che si adot-ti una strategia tesa a fare delle aziende dellasanità contesti nei quali i professionisti si ren-dano responsabili d’una continua “ricercadella massima appropriatezza possibile inte-sa come capacità d’utilizzare in modo effi-ciente le risorse disponibili per assicurare pre-stazioni efficaci e supportate da una correttaindicazione, ovvero capaci di rispondere alladomanda di salute espressa e inespressa, in-dividuale, familiare e sociale”.Nella visione di Seppilli, però, tutto ciò nonsarebbe stato sufficiente. Mentre pensava alla“popolazione protagonista del sistema”, avverti-va l’asimmetria del rapporto medico pazien-te e la necessità d’una tenace e diffusa azioned’educazione sanitaria, rivolta prima di tut-to alle giovani generazioni. Ricollegava lasostenibilità del SSN alla sua capacità di con-tribuire, con determinazione, alla prevenzionedelle malattie croniche e al suo impegno nel
306
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Dalla parte della salute
promuovere una diffusa coscienza sanitaria ea un’alleanza tra professionisti e cittadini fon-date su valori condivisi e su comportamentireciprocamente e consapevolmente respon-sabili. Riteneva, infatti, che “i cittadini, oggi,troppo spesso considerati come oggetto passivo dellasocietà consumistica, debbono richiedere le presta-zioni di cui hanno bisogno e che il SSN deve loroassicurare. Sono essi che debbono operare le scelteinevitabili tra ciò che è utile e ciò che è inutile osuperfluo o addirittura dannoso […] assistitidai tecnici […] ma debbono essere loro i soggettidella scelta e non limitarsi a subire passivamentele scelte decisionali operate da altri”.
Il pericolo della separazione cure preven-zioneNel 1969, nell’ambito d’una tavola rotonda,Seppilli affermava che: “scopo dei servizi sani-tari è la difesa della salute, non la protezioneeconomica dal rischio di malattia com’ è posta dalleassicurazioni sociali”. Poi, in poche battute,sintetizzava i cambiamenti intervenuti inmedicina nei decenni precedenti durante iquali “la lotta alle malattie infettive aveva por-tato alla nascita di una specie di specializzazionedella profilassi e staccato, in gran parte, l’attivi-tà preventiva, che tradizionalmente era legata aquella del medico generico, da quella che è l’atti-vità terapeutica”[…] “L’impostazione mutuali-stica, poi, della protezione dal rischio di malat-tia, conquistata a poco a poco per la pressione del-le categorie meglio organizzate dei lavoratori, haulteriormente dissociato le due cose; per cui oggitroviamo una gran massa di medici che di pre-venzione non si preoccupa quasi affatto”.Seppilli esprimeva l’idea che investire in pre-venzione significhi per i cittadini guadagna-re salute e per la società contenere i danni e icosti crescenti generati dalle malattie croni-che. Con estrema chiarezza metteva in evi-denza il pericolo di quella dissociazione tra
cura delle malattie, prevenzione e promo-zione della salute, che oggi è del tutto evi-dente. Riteneva che la prevenzione vada “por-tata a livello clinico, cioè a livello del rapportoindividuale medico paziente” cioè là dov’è mag-giormente possibile proporre, con efficacia,ai cittadini d’adottare stili di vita sani, di re-sponsabilizzarsi nella gestione della loro con-dizione di salute/malattia, di sottrarsi a ac-certamenti inutili, se non dannosi.A distanza di tanti anni, dovremmo riflette-re sul fatto che nelle aziende della sanità moltiritengono che l’educazione sanitaria e la pre-venzione delle malattie non siano tra le loropriorità. Spesso destinano risorse residuali allapromozione della salute, sottovalutano l’uti-lità di potenziare quelle competenze chemettano in grado le organizzazioni, le co-munità e le persone di utilizzare in modoappropriato i servizi sanitari e di migliorarel’ambiente di vita e di lavoro e la qualità del-la vita.Dovremmo pensare a un ridimensionamen-to del mito dell’aziendalismo e immaginaredelle aziende sanitarie locali capaci di curaree di stare “dalla parte della salute”; di assicu-rare prestazioni diagnostiche e terapeutichema anche di suscitare l’energia di quella “po-polazione protagonista del sistema” che, perSeppilli, non è un’astrazione ma l’insieme diindividui, organizzazioni, comunità, associa-zioni di pazienti, volontariato, scuole, istan-ze culturali, imprese, […] che al livello lo-cale possono contribuire a costruire social-mente la salute di ciascuno e di tutti come“bene comune” […] ma il tema dei beni co-muni, socialmente costruiti da comunità at-tivamente coinvolte nella loro gestione inquanto interessate ai vantaggi che da essiderivano, è un tema di grande attualità che,largamente anticipato dal professor Seppilli,merita una trattazione a parte.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
307Fulvio Forino
Un’ultima riflessioneAl termine di queste righe mi vengono inmente una metafora e un pensiero. La me-tafora propone di pensare che i professioni-sta della sanità siano degli scienziati del XVIIsecolo. In quel secolo il sapere scientificoacquistò una profondità e una circolazionemai conosciute in occidente. Matematica,geometria, fisica, astronomia fecero grandiprogressi. Ciò nonostante se a uno scienzia-to avessero chiesto: “come funziona l’uni-verso?“; avrebbe risposto che la terra è alcentro dell’universo; che il sole, la luna, ipianeti le ruotano intorno; che sotto i suoipiedi nulla si muove e che la terra è ferma;che gli oggetti cadono sempre sulla verti-cale del punto di rilascio. Tutto ciò era perlui “normale” e sarebbe stato difficile con-vincerlo del contrario. Newton nacque nel-lo stesso anno in cui moriva Galilei e dallascoperta di Copernico passarono quasi due
secoli prima che la scienza guardasse il cie-lo con nuovi occhi. Mi viene allora da pen-sare che spesso scienziati come Seppilli par-lano agli uomini del futuro. Le loro idee ri-mangono in attesa d’affermarsi e dobbiamosaper aspettare che i tempi maturino. Lascienza e la medicina sono ancora monopo-lio di meccanicismo, riduzionismo, sempli-ficazione. È inutile tirare l’erba per farla cre-scere e, anche se dagli anni in cui ho inizia-to la mia narrazione sembra passato moltotempo, ci vorranno ancora molto tempo el’impegno di molti prima che venga colta eraccolta la fecondità del pensiero del prof.Seppilli, della sua scuola e di quanti altri,nel mondo della medicina e nel tempo, han-no contribuito a sviluppare un’innovativavisione anticipatrice dell’approccio sistemi-co alla salute, alla malattia, ai pazienti, allaprevenzione e alle cure e alla loro organiz-zazione con occhi nuovi.
TESTI CONSULTATITutte le citazioni in corsivo tra virgolette sono trattedai tre articoli del Prof. Alessandro Seppilli riportatinel presente volume e da: Seppilli A. Conoscere laRiforma sanitaria: dalla cura delle malattie alla difesadella salute: riforma o rivoluzione? Roma:Edizioni del-le Autonomie; 1982.Alfieri R. Le idee che nocciono alla salute e alla sanitàMilano: Franco Angeli editore; 2007.Florita M. O. L’intreccio, neuroscienze , clinica e teo-ria dei sistemi dinamici complessi. Milano: Franco An-geli editore; 2011Forino F. L’approccio sistemico alle decisioni manage-riali: una storia. In: Decisioni e scelte in contesticomplessi,Padova: Casa Editrice Dott. Milani; 2013Forino F. La medicina le medicine.Keiron2004;12,,gennaio.Gembillo G, Anselmo A. Filosofia della complessità.
Firenze: Casa Editrice Le Lettere; 2013Pecere GP, Munari F, Loik F, Casini M, La ComplessitàOrganizzativa della Continuità delle Cure: l’ Approc-cio attraverso le Regole Semplici. In:Dedalo: gestire isistemi complessi in sanità”, 2003, Volume I, N° 1Seppilli A, Mori M, Modolo MA. Significato di unariforma. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore; 1972
SITI CONSULTATIwww.camera.itwww.salute.gov.itwww.istat.itwww.iss.itwww.retededalo.itwww.sirnm.orgwww.wikipedia.orgwww.treccani.it
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 308-315
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
“Siamo partiti dal presupposto che scopodella medicina è la difesa della salute, ditutti e di ciascuno: perciò i soggetti del si-stema non possono essere che i cittadini,oggi troppo spesso considerati invece comeoggetto passivo della società consumisticaanche in questo settore vitale. […] Questaresponsabilizzazione dei cittadini nella ge-stione dei servizi… è insomma l’essenzastessa della democrazia…” (1).Questo è quanto scriveva oltre quarant’an-ni fa Alessandro Seppilli intravvedendo quel-lo che avrebbe dovuto essere il funziona-mento di un Servizio Sanitario Nazionale(SSN) basato sui principi di “rispetto delladignità e della libertà della persona uma-na… eguaglianza dei cittadini nei confrontidel servizio… garantendo la partecipazionedei cittadini” (2).Con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione delconcetto e delle pratiche di “partecipazionedei cittadini” a livello nazionale e interna-
Salute e partecipazione della comunità.Una questione politicaHealth and community partecipation. A political issue
Angelo Stefanini, Chiara BodiniCentro di salute internazionale, Università di Bologna
zionale, questo articolo ripercorre brevemen-te la storia, il dibattito e le problematicheemerse negli ultimi decenni intorno al temadel coinvolgimento della popolazione nellaprogrammazione e gestione dei servizi pub-blici, arrivando a contestualizzare la situa-zione odierna e le sfide che essa pone allasocietà tutta.
Partecipazione come processo poli-ticoUn progressivo disincanto sul futuro delSSN così come concepito dai suoi padri fon-datori ha fatto seguito al disegno, attuatocon i DDLL 502/92 e 517/93, di fondare lasanità sulle leggi del mercato e della con-correnza. Appare sempre più evidente cheorgani di potere non eletti come le aziendesanitarie non godono della legittimazionenecessaria per prendere decisioni critiche cheriguardano la salute di tutti di fronte, peresempio, alla scelta tra servizi ospedalieri e
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
309Angelo Stefanini, Chiara Bodini
servizi territoriali o di come allocare risor-se limitate. Le problematiche coinvolte intali decisioni sono di natura sostanzialmen-te non tecnica ma politica e richiedono giu-dizi non soltanto professionali ma anche esoprattutto di valore.Se il settore sanitario soffre di un vuoto de-mocratico, il governo locale è però soventeesso stesso colpevole di incapacità di legge-re i bisogni della comunità e di tendenzemonopolistiche, autoritarie e burocratiche.È necessario quindi che la legittimità poli-tica che gli proviene dall’elettorato sia raf-forzata da una varietà di altre misure voltea renderlo più sensibile verso gli utenti delservizio e i cittadini, anche attraverso unloro maggiore coinvolgimento. D’altra partel’effettivo rapporto esistente tra il pubblicoe il processo decisionale in sanità (ma nonsolo) è in pratica inesistente. Di là dal mo-mento del voto alle elezioni politiche oamministrative, sono in concreto assenti leoccasioni in cui i cittadini che non accetta-no il supino ruolo di sudditi cui accennaSeppilli possono far valere il potere dellaloro voce, di protesta o di persuasione. Alivello locale insomma esiste il bisogno diun processo decisionale informato e di unmaggiore protagonismo del pubblico nelledecisioni che lo riguardano.La partecipazione della popolazione nellescelte che concernono la sua salute è quindiessenzialmente un concetto politico. Ilmodo in cui una comunità “partecipa” di-pende ovviamente dal contesto sociale, eco-nomico e politico di cui essa fa parte e daivalori culturali e sociali che esprime. Inol-tre, parlare di partecipazione significa che èla comunità, e non un governo, non un’isti-tuzione formale né un gruppo professiona-le, che ha il controllo sulle risorse e il pote-re di decidere come usarle. Dovrebbe esse-
re chiara quindi la distinzione tra i concettiespressi dai due verbi “partecipare” e “con-tribuire”, dove il primo indica che il con-trollo è in mano alla comunità mentre ilsecondo significa che attori esterni, in ge-nere il governo – comunale, regionale, na-zionale – ma sempre più anche altri nuoviprotagonisti sovranazionali non governati-vi e al di fuori del controllo democratico,creano attività a cui forniscono risorse invi-tando poi la popolazione a contribuire sen-za tuttavia che essa ne abbia alcun control-lo. La politica, una “buona” politica, costi-tuisce un approccio irrinunciabile alla crea-zione delle condizioni che possono favorirela salute. Come dire che per migliorare lasalute della popolazione è necessario miglio-rare la salute della politica (3).
Alma Ata e il ruolo della comunitàParallelamente al percorso che in Italia por-tava alla nascita del SSN, a livello interna-zionale cresceva il dibattito ed emergevanole esperienze che avrebbero condotto nelsettembre 1978 alla Conferenza di Alma Atae alla Dichiarazione sulla Primary HealthCare (PHC), praticamente contemporaneadella Legge 833. Entrambe, Dichiarazionee L. 833, rappresentano indubbiamente, an-che se a due livelli diversi, un momentocritico nella interpretazione dei valori, deiprincipi e delle strategie che hanno caratte-rizzato la storia della salute e dei sistemisanitari a livello internazionale. La progres-siva rivalutazione anche in Europa e nelNord America della PHC come filosofia estrategia per la promozione della salute, untempo ritenuta rilevante esclusivamente peri Paesi più poveri, è dovuta non soltantoalla presa di coscienza della inadeguatezzadell’approccio ospedalo-centrico, ma anchealla necessità di una solida strategia sociale
310
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Salute e partecipazione della comunità. Una questione politica
che porti a un cambiamento. È proprio al-l’interno dell’organizzazione sociale, infat-ti, che vanno ricercati i determinanti piùpotenti della salute e dunque è agendo su diessi che ci si possono attendere concreti van-taggi di salute.La Dichiarazione di Alma Ata era nata an-che grazie alle esperienze innovative di comele varie comunità in varie parti del mondoaffrontavano e gestivano con successo la lorosalute. Un elemento comune a tutte questebuone pratiche, documentate in una storicapubblicazione (4), era rappresentato da unaspetto della salute fino ad allora negletto:il potenziale e la necessità di avere comuni-tà che definiscono esse stesse i propri biso-gni di salute e su di essi agiscono. Il puntocentrale identificato dalle due agenzie delleNazioni Unite promotrici della Conferenzadi Alma Ata, Organizzazione Mondiale del-la Sanità (OMS) e UNICEF, non fu tanto dilamentare che le comunità nelle varie partidel mondo non fossero mai state coinvoltenella tutela della propria salute (cosa evi-dentemente non vera), ma di articolare uf-ficialmente la necessità di riconoscere e va-lorizzare tale coinvolgimento. In realtà, ilprincipio della PHC contenuto nella dichia-razione di Alma Ata sfidava molti dei con-cetti fondamentali di salute e assistenzamedica che avevano dominato le politichesanitarie dei precedenti decenni. Tra i puntiqualificanti di questo principio era l’affer-mazione che la responsabilità della saluterisiede nei singoli individui, nelle comunitàe nei governi.Continuando con l’analogia tra il contestoitaliano e quello internazionale, se in Italiatrascorsero quasi quindici anni prima di unarisposta “neo-liberista” nei confronti dell’uto-pia “socialisteggiante” di un SSN guidatodalla politica, alla contro-offensiva globale
del potente “complesso medico-industria-le” bastarono pochi mesi. Con la propostadi una selective PHC, pubblicata da una trale più prestigiose riviste mediche (5), veni-vano demoliti i principi di una comprehensivePHC espressi dalla Dichiarazione e così rias-sumibili:1. La salute è essenzialmente una questio-
ne politica;2. La medicina occidentale non è l’unica a
offrire cure efficaci;3. I professionisti creati da tale sistema non
sono gli unici in grado di dare risposteai problemi di salute delle comunità;
4. La salute non può essere isolata dalle al-tre politiche per lo sviluppo di una co-munità;
5. Le tecnologie più sofisticate non forni-scono necessariamente le cure migliori;
6. La decentralizzazione e la regionalizza-zione della programmazione e delle isti-tuzioni sanitarie sono maggiormente ingrado di rispondere ai problemi locali disalute.
Insomma, il messaggio contenuto nella com-prehensive PHC è che la salute è una condi-zione umana che non può essere miglioratasoltanto dall’offerta di servizi. Il suo mi-glioramento è anche e soprattutto respon-sabilità degli individui, delle comunità e deigoverni.
Dalla retorica alla realtàNell’accettare la PHC come politica di go-verno, tutti gli Stati membri dell’OMS ave-vano riconosciuto l’importanza di coinvol-gere i beneficiari dei servizi e dei program-mi, ossia la popolazione, nella loro proget-tazione e realizzazione. Le ragioni di questaaccettazione riguardavano in primo luogol’efficacia dei servizi sanitari: i servizi for-niti sono sotto utilizzati e male utilizzati,
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
311Angelo Stefanini, Chiara Bodini
perché le persone per le quali sono stati pro-gettati non sono coinvolte nella loro pro-grammazione e gestione. Una seconda ra-gione era di carattere economico. Esistono,infatti, in tutte le comunità risorse finan-ziarie, materiali e umane che potrebbero edovrebbero essere mobilitate per migliora-re le condizioni ambientali e sanitarie loca-li. Un ulteriore argomento per abbracciarela causa della PHC era ancor più sostanzia-le: la salute delle persone è soprattutto ilrisultato di come esse organizzano il pro-prio contesto sociale e gestiscono la propriavita. Non è soltanto il risultato di inter-venti medici. Gli Stati infine si trovano adaffrontare una questione centrale per la pro-pria sopravvivenza e benessere: la sfida del-la democrazia e della giustizia sociale. Tut-te le persone, infatti, specialmente i poverie gli svantaggiati, hanno il diritto e il dove-re di essere coinvolti nelle decisioni che ri-guardano la loro vita quotidiana.Tuttavia, l’adesione formale a questa stra-tegia ha raramente soddisfatto le aspettati-ve in termini di impatto sulla salute. SusanRifkin sostiene che la ragione di questo fal-limento è stata l’adozione entusiastica di unparadigma che vede la partecipazione dellacomunità come una bacchetta magica perrisolvere sia i problemi di salute sia quellidi potere politico (6). Per questo motivo ènecessario utilizzare una diversa prospetti-va che interpreti la partecipazione come un“processo di apprendimento iterativo checonsente l’adozione di un approccio piùeclettico” (7) e, di conseguenza, di aspetta-tive più realistiche.Sotteso al cosiddetto ‘approccio partecipa-tivo’ – ovvero all’utilizzo della partecipa-zione come strumento di programmazionee attuazione di politiche, servizi, interven-ti, azioni – vi è infatti non tanto un metodo
quanto un preciso statuto ontologico edepistemologico. Dall’etimo latino (pars,parte, e capere, prendere), partecipare signi-fica prendere parte a, o di, qualcosa. Rispon-dere alla domanda del ‘che cosa’ implica ri-flettere su chi è il soggetto che fa partecipa-re/che partecipa, che cosa è conoscenza (ciòche chiamiamo ‘realtà’) e come si arriva adessa. Dal punto di vista ontologico, l’im-plicazione riguarda lo statuto dell’Altro,visto e rispettato nella sua alterità e noncome un complemento dell’io (per identitào opposizione), come avviene nell’approc-cio dialettico. Accettare realmente l’alteri-tà, svincolandola da una definizione stabili-ta unilateralmente a priori (o rispetto a un‘a priori’ che è il soggetto che definisce), èpresupposto fondante per una reale possibi-lità di dialogo e di relazioni mutualmentesignificative (8). Dal punto di vista episte-mologico, la partecipazione poggia sull’ideache la conoscenza non è costruita da indivi-dui isolati nella loro propria soggettività,ma nelle relazioni che le persone intessono,e di/da cui sono intessute. La complessitàdella relazione intersoggettiva è il terrenoin cui avviene la co-costruzione del signifi-cato e della conoscenza. Solo ponendo larelazione come fondamento e fonte di co-noscenza è possibile costruire un contestorealmente partecipativo (9).Oltre dieci anni dopo le osservazioni soprariportate, sempre Susan Rifkin (10) offre treragioni della grande difficoltà costantementedescritta in letteratura di integrare la par-tecipazione della comunità nei programmidi salute. La prima riguarda il predominiodel paradigma bio-medico che continua acostituire nella maggioranza dei casi lo stru-mento principale di programmazione, conconseguente concezione della partecipazio-ne della comunità come semplice interven-
312
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Salute e partecipazione della comunità. Una questione politica
to tecnico. La seconda ragione concerne lamancanza di un’analisi approfondita dellapercezione e del punto di vista dei membridella comunità e, laddove esistono, degliagenti/operatori sanitari di comunità. Infi-ne, un altro motivo di difficoltà è la pro-pensione a utilizzare un quadro concettualeche limita l’indagine a ciò che funziona, alperché e al come funziona, e non prende inconsiderazione gli insuccessi. Alla base diqueste difficoltà si affacciano però più pro-fonde dinamiche di potere che devono esse-re chiamate in causa e analizzate.
Empowerment e dirittiLe diverse interpretazioni del significatodella partecipazione della comunità solle-vano la domanda se essa sia un mezzo op-pure un fine in se stessa, e ne interroganoquindi il ruolo e la collocazione nel proces-so politico di programmazione e sviluppodella salute e della vita della comunità. Daqui nasce anche la necessità di definire chia-ramente che cosa si intenda per “partecipa-zione” e per “comunità”. Su questi due si-gnificati si è svolto negli ultimi decenni unvasto dibattito.De Vos et al. (12) hanno esteso l’analisi sto-rica del dibattito accademico sulla parteci-pazione anche al concetto di empowerment ealle implicazioni derivanti da un approccioalla salute basato sui diritti umani. Parten-do ancora una volta dalla constatazione che:“Trentuno anni dopo Alma Ata, una rivisi-tazione delle politiche globali ha evidenzia-to che, di tutti i principi fondamentali dellaDichiarazione, il principio che ha in parti-colare mancato di prendere radice è quellodella partecipazione comunitaria”, gli au-tori argomentano come le diverse fasi nel-l’evoluzione dei concetti di partecipazione,empowerment e diritto alla salute hanno ag-
giunto importanti novità alla discussione.Tre sono gli aspetti cruciali che emergonodalla loro analisi: (a) l’importanza che vie-ne ad assumere la classe sociale quando sianalizzano gli elementi essenziali della par-tecipazione comunitaria; (b) il ruolo centrale(e ovvio, si potrebbe dire) del “potere” evi-denziato nel dibattito sull’empowerment, e (3)il ruolo dello Stato legato ai concetti di cit-tadino come “titolare dei diritti” e di Statocome “portatore dei doveri” in un approc-cio basato sul diritto alla salute. Il concettodi salute come “prodotto dell’empowermentdelle persone” viene proposto per descrive-re il significato fondamentale della parteci-pazione e della responsabilizzazione da unpunto di vista dei diritti umani e, in questomodo, elaborare strategie comuni. Se i grup-pi e le classi emarginate si organizzano,possono influenzare i rapporti di potere efare pressione sullo Stato affinché agisca.Questa pressione dal basso attraverso l’or-ganizzazione popolare può svolgere un ruo-lo essenziale nel garantire politiche gover-native adeguate per affrontare le disugua-glianze e affermare il diritto alla salute.Una tale prospettiva richiama il panoramaitaliano degli anni ’70 e in particolare, as-sieme ad altri pionieri come AlessandroSeppilli e Giovanni Berlinguer, la figura el’opera di Giulio A. Maccacaro, allora di-rettore dell’Istituto di Biometria e Statisti-ca Medica dell’Università statale di Mila-no. Denunciando la “medicalizzazione del-la politica”, ossia una “medicina [che è] sem-pre meno un sistema assistenziale e semprepiù un sistema gestionale”, Maccacaro rile-vava come “tutto si risolve in ultima anali-si in un aumento di capacità del capitale agestire medicalmente la società, magari fin-gendo di gestire socialmente la medicina”(13). La “politicizzazione della medicina”,
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
313Angelo Stefanini, Chiara Bodini
al contrario, significa che la tutela della sa-lute e la lotta alla malattia non possono nonavvenire che “attraverso l’attrito delle for-ze sociali che si confrontano” e a opera deiloro soggetti storici. È in tale contesto dicontinua lotta per la salute che Maccacarovedeva il ruolo della partecipazione denun-ciando come, nonostante la Costituzioneitaliana (art. 3, secondo comma) ponga “l’ef-fettiva partecipazione di tutti i lavoratoriall’organizzazione politica, economica e so-ciale del Paese” tra i compiti fondamentalidelle Repubblica, “né la teoria né la prassidi tale partecipazione si sono alzate dal pia-no dell’attività, nemmeno in quella ipotesidi sanità riformata che declama la parteci-pazione come carattere essenziale delle sueunità di base” (14). Riconoscendo “l’intrin-seca solidarietà tra il problema della ‘salu-te’ e quello della ‘partecipazione’” (15),Maccacaro contrapponeva la nozione di“malattia come perdita di partecipazione”del sociologo Talcott Parsons (16) al suomodello concettuale di “perdita di parteci-pazione come sostanza di malattia”. In par-ticolare, identificava come nemici della par-tecipazione l’autorità, l’efficienza e la prov-videnzialità. L’autorità che rifiuta Macca-caro è quella che “indossati i panni dellacompetenza, separatasi nella tecnica, costi-tuitasi come corporazione, legittimatasicome ordine - si pone di fatto quale esecu-trice dei comandi di un potere che la sovra-sta e che, pagatala con ruoli e privilegi, nefa lo strumento più insidioso ed efficace delcontrollo sociale nelle forme della medica-lizzazione”. L’efficienza è nemica della par-tecipazione quando diventa “domanda delpotere costituito” (17), avvalendosi dellavoluta e perpetrata confusione con l’effica-cia e tra la funzione dell’istituzione sanita-ria, ossia la tutela della salute, e il suo fun-
zionamento, ridotto a ottimizzazione di sestessa anziché all’adempimento di tale fun-zione. Per “provvidenzialità”, infine, Mac-cacaro intende il “paternalismo”, ossia “quelmodo di mettersi in rapporto con la realtàche prescinde dal suo ascolto; quell’attitu-dine a disporre risposte preformate che pre-scindono dalla formazione delle domande;quell’interpretazione del mandato ammini-strativo che infine determina una richiestacui si consente soltanto di conformarsi al-l’offerta” (18).
Partecipazione e salute globaleUn altro importante spartiacque nella sto-ria moderna del concetto e della pratica dellapartecipazione popolare per la salute è statala Dichiarazione del Millennio delle Nazio-ni Unite, firmata nel settembre del 2000.Nonostante il percorso modestamente par-tecipato che ha portato alla loro identifica-zione, i Millennium Development Goals (19)hanno segnato un cambiamento paradigma-tico nel modo in cui i policy-maker affronta-no i miglioramenti di salute. Tale cambia-mento si è incentrato sul riconoscimentoche la salute migliora grazie a fattori socia-li e ambientali, e non solo attraverso inter-venti tecnici bio-medici e modelli econo-mici. Mentre il predominio degli operatorisanitari qualificati nelle scienze mediche èrimasto intatto, è cresciuta la domanda diattenzione nei confronti dei determinantisociali della salute e dei bisogni ed esigenzedei beneficiari dell’assistenza sanitaria. Duedocumenti pubblicati nel 2008 dall’OMSsono indicativi di questo cambiamento. Ilprimo è il World Health Report dal titolo“Primary Health Care: ora più che mai” (20)che, se pur timidamente, promuove il ri-torno ai valori e alla visione della Dichiara-zione di Alma Ata. Il secondo è il rapporto
314
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Salute e partecipazione della comunità. Una questione politica
della Commissione OMS sui determinantisociali della salute (21), istituita nel 2005 ecomposta da una vasta gamma di espertiprovenienti da una varietà di discipline ePaesi. Il rapporto documenta con forza lastretta relazione tra stato di salute e deter-minanti sociali quali il reddito, l’istruzio-ne, il tipo di lavoro, l’accesso alla assistenzasanitaria, la capacità dei popoli di compierescelte e il buon governo.Non sarebbe corretto sostenere che questidocumenti hanno prodotto un consenso ge-nerale su come migliora la salute. Quelloche hanno fatto, però, è stimolare un’arenaper un ulteriore dibattito su questi temi. Atitolo di esempio, il terzo simposio globalesulla ricerca nei sistemi sanitari, svoltosirecentemente a Cape Town, ha avuto cometema portante gli approcci ‘centrati sullapersona’. In tale contesto, l’egemonia del-l’ideologia di mercato è stata presentatacome fondamentale ostacolo per qualunquetentativo di riportare realmente le persone,e dunque i bisogni (o determinanti) sociali,al centro dei sistemi di salute. La logicaconseguenza è la necessità di agire su levedi potere per controvertire l’attuale(dis)equilibrio, che non consente l’emerge-re di alternative soprattutto a livello istitu-zionale. A questo proposito, è stato chia-mato in causa in maniera esplicita il ruolodei movimenti sociali, e l’importanza dicontemplarne le potenzialità e i meccani-smi d’azione a livello di ricerca, di analisipolitica e di pianificazione delle politiche.Solo la mobilitazione sociale può infatti rap-presentare la forza necessaria a orientarerealmente le politiche di salute verso le per-sone. Si torna così alla necessità primaria dicostruire potere politico, ed è chiaro che ciònon può avvenire in un convegno di espertiné a livello dei ‘piani alti’ della governance
globale, bensì là dove le tanto citate ‘perso-ne’ sono naturalmente al centro, ovvero neiloro contesti di vita e di lavoro.
Il contesto italianoSecondo Luca Negrogno e Riccardo Ierna,autori di un contributo sul bloglavoroculturale.org, la questione della par-tecipazione nello scenario italiano “va col-locata in un problema molto più generale,che investe oggi tutti i servizi sociali e sa-nitari. Si tratta della crisi dello stato socia-le tradizionale, una crisi che oggi prende laforma di due imperativi: controllare la spe-sa e rendere più efficaci gli interventi” (22).Coinvolgere la comunità diviene dunqueanche una necessità di fronte alla crescentecarenza di risorse e all’inadeguatezza del-l’offerta rispetto a bisogni sempre più com-plessi (si pensi all’incremento delle patolo-gie croniche e alla necessità di muovere ra-pidamente verso una territorializzazione deiservizi in un sistema ancora largamenteospedalo-centrico, nella struttura come nellacultura organizzativa). Prendendo come casodi studio il coinvolgimento di utenti e fa-miliari esperti nei servizi di salute mentale,Negrogno e Ierna evidenziano il rischio chele pratiche di partecipazione messe in attocostruiscano forme di “cittadinanza dimi-nuita”, in cui il cittadino è partecipe solo inquanto utente o familiare e in cambio di unadeguamento alla cultura e all’organizzazio-ne del servizio: “per essere “utenti esperti”l’identità di utente deve essere accettata,anzi, deve diventare un’identità totalizzan-te: solo attraverso di essa si può accedere aduna forma positiva di cittadinanza, ad unposto dignitoso nel mondo. La responsabi-lità di cambiare è dei singoli, le personepossono migliorare il servizio “lavorandocidentro”, e soccorrendo alla carenza di risor-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
315Angelo Stefanini, Chiara Bodini
se pubbliche” (23). Nella situazione descrit-ta, ciò che viene chiamato “partecipazione”è di fatto un processo gestito attraverso ilfiltro delle etichette e in un rapporto indi-vidualizzato con l’utenza, il cui oggetto èdefinito dalla diagnosi e dall’intervento tec-nico al netto di possibili conflitti.I concetti di partecipazione ed empowermentrimandano però a ben altre relazioni, in cuii cittadini hanno la facoltà di intervenire neilivelli tanto programmatori quanto gestio-nali dei servizi, in un’accezione non setto-rializzata e predefinita ma di negoziazione
ampia sulle priorità di allocazione delle ri-sorse e di intervento. Riprendendo l’analisifatta a livello internazionale, è verosimileche tale cambiamento di prospettiva e pra-tiche non possa provenire “dall’alto”, adopera di decisori o programmatori per quan-to “illuminati”. Per immaginare nuove ereali forme di partecipazione è dunque ne-cessario pensare a una crescita del poterecontrattuale collettivo dei cittadini, all’in-terno di una riconfigurazione dello spaziopubblico in spazio nuovamente, e profon-damente, politico.
BIBLIOGRAFIA1. Seppilli A. La popolazione: soggetto del sistema.
L’Educazione Sanitaria 1971; XVI(2-3):159-167.2. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”. Titolo 1, Capo 1, 1.3. Stefanini A. Politiche di salute e salute della politi-
ca. Qualità Equità 2000;19: 74-82.4. Newell,K. W. Health by the people. Geneva,
Switzerland:WHO; 1975.5. Walsh J A, Warren KS. Selective primary health
care: an interim strategy for disease control indeveloping countries. The New England journal ofmedicine 1979; 301(18): 967-974.
6. Rifkin SB.Paradigms lost: toward a newunderstanding of community participation in healthprogrammes. Acta tropica 1996; 61(2): 79-92.
6 Ibid, p. 79.7. Montero M. Participation in Participatory Action
Research. Annual Review of Critical Psychology,2000; 2:131-143.
8. Genat B. Building emergent situated knowledgesin participatory action research. Action Research,2009; 7(1):101-115.
9. Ibid, p. 79.10.Rifkin SB. Lessons from community participation
in health programmes: a review of the post Alma-Ata experience. International Health 2009; 1(1):31-36.
11.De Vos P, De Ceukelaire W, Malaise G, Pérez D,Lefèvre P, Van der Stuyft P. Health through people’sempowerment: a rights-based approach to
participation. Health and human rights, 2009; pp.23-35.
12.Maccacaro GA. Classe e Salute. In: Per una medi-cina da rinnovare. Scritti 1966-1976. Milano:Feltrinelli, p. 445.
13.Maccacaro GA. L’Unità Sanitaria Locale come Si-stema, in Per una medicina da rinnovare. Scritti1966-1976. Milano: Feltrinelli, p.383.
14.Ibid, p. 385.15.Parsons T. Il sistema sociale, trad. it. Italiana Mila-
no: Ed. di Comunità; 1981.16.Maccacaro GA. Medicina Democratica, movimen-
to di lotta per la salute. In: Per una medicina darinnovare. Scritti 1966-1976. Milano: Feltrinelli,p. 467.
17.Ibid, p. 468.18.World Health Organization. Millennium
development goals. Geneva:WHO; 2008.19.Van Lerberghe W. The world health report 2008:
primary health care: now more than ever.Geneva:WHO; 2008.
20.Commission on Social Determinants of Health.Closing the gap in a generation: health equitythrough action on the social determinants of health:final report of the commission on social determinantsof health; 2008.
21.Negrogno L, Ierna R. (2014). L’inclusione èterapeutica? http://www.lavoroculturale.org/que-stione-inclusione/
22. Ibid.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 316-352
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Altri contributi
La promozione della salute attraverso i Social Media: unasfida per la sanità del futuro.Health promotion through Social Media: a challenge for healthcare in the future.
Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, RobertaSiliquiniDipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Università degli studi di Torino
Parole chiave: e-Health, mobile Health, promozione della salute, digital divide
RIASSUNTOObiettivi: il presente lavoro si pone l’obiettivo di valutare potenzialità e rischi dei Social Media nella condivisionedi iniziative di promozione della salute attraverso l’esposizione di iniziative condotte a livello nazionale einternazionale.Metodi: attraverso una revisione delle linee guida nazionali in materia di e-Health, delle testimonianzefornite dalla letteratura scientifica internazionale reperibile su Pubmed e della letteratura grigia rintracciabileattraverso i motori di ricerca generici è stata condotta un’analisi dello strumento dei Social Media periniziative di ambito sanitario.Risultati: lo studio dell’applicabilità del Web e di smartphones e tablets per la ricerca di informazionisanitarie, per la gestione delle patologie croniche e per la pratica quotidiana da parte dei clinici è materiapropria dei filoni di ricerca noti come e-Health e mobile health (m-Health). Con il progredire dell’evoluzio-ne tecnologica e in particolar modo di Internet e della penetrazione di nuovi dispositivi utilizzabili a finisanitari nella popolazione generale e nel mondo lavorativo è necessario che i professionisti sanitari ne
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
317Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
conoscano usi e potenziali rischi. Se è vero che le potenzialità di successo delle campagne di promozionedella salute possono essere notevoli, a destare preoccupazione sono soprattutto i rischi di un uso sconside-rato del Web quali l’insorgenza di diseguaglianze di accesso e di salute (nota come digital divide), la privacydei dati e la difficoltà di verificare l’evidenza scientifica dei contenuti delle pagine Web e delle applicazioniper smartphones e tablets.
Key words: e-Health, mobile Health, health promotion, digital divide
S U M M A RYAims: the present paper aims to assess potentialities and risks of social media in sharing initiatives topromote health through the exhibition of national and international experiences.Methods: through a review of national guidelines on e-Health, of evidences provided by the internationalscientific literature available on PubMed, and of gray literature retrievable through general search engines,we conducted an analysis of the role of social media as tool to carry out public health initiatives.Results: the study of applicability of Internet, smartphones and tablets to search for health information forthe management of chronic diseases and for daily practice by clinicians is a main topic of new research areasknown as e-health and mobile health (m-Health). With the progress of technology evolution and especiallyof internet and with the penetration of new devices that can be used for health purposes both in the generalpopulation and in the working world, it is necessary that health professionals are thoroughly familiar withtheir uses and potential risks. Considerable success can be reached by health promotion campaigns designedthrough Social Media, however particular concern derives from the risks of an irresponsible use of the Web,such as the occurrence of digital divide and health inequalities, the data privacy and the difficulties inverifying the scientific evidence of health information retrievable through these tools.
La comunicazione nell’era dell’e-HealthCon il progredire dell’evoluzione tecnolo-gica e la sempre maggiore penetrazione dinuovi dispositivi volti a facilitare le attivi-tà di vita quotidiana e professionali, è di-ventata sempre più cogente per gli opera-tori sanitari la necessità di conoscere e sa-per utilizzare tali strumenti in ambito sani-tario (1). Per indicare l’applicazione all’areamedica e all’area dell’assistenza sanitariadell’Information and Communication Tech-nology (ICT) viene utilizzato il termine e-Health. Rientra in questo settore di ricercal’area di intersezione tra l’informatica me-dica e la sanità pubblica, il cui obiettivo èmigliorare l’assistenza sanitaria a livello lo-cale, regionale e internazionale. L’e-Healthnacque con l’esigenza di identificare l’auto-
mazione dei processi per la trasmissione,l’archiviazione e il reperimento dei dati sa-nitari dal punto di vista amministrativo,formativo e ovviamente clinico (2).L’e-Health si esplicita in diverse branche distudio e di applicazione a seconda degli uten-ti, dei destinatari e delle tecnologie messein campo. Rientrano infatti nel campod’azione dell’e-Health il ricorso al Web peril reperimento di informazioni sanitarie daparte dei professionisti e della popolazione,la telemedicina, strumenti quali il fascicoloelettronico e la cartella clinica elettronica,le applicazioni in ambito sanitario dei nuo-vi Social Media e la m-Health (mobile he-alth). Al fine di orientare gli sforzi di pro-mozione, implementazione e gestione del-le tecnologie proprie dell’e-Health, il Mi-nistero della Salute ha pubblicato il 23 No-
318
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione della salute attraverso i Social Media: una sfida per la sanità del futuro
vembre 2011 il documento “The Nationale-Health Information Strategy” in cui fo-calizza l’attenzione su cinque aree definitecome prioritarie: le prenotazioni online, ilfascicolo sanitario elettronico, i certificatidi malattia online, l’e-prescribing e la tele-medicina (3). Se molto è stato fatto per ar-monizzare le soluzioni di e-Health da unpunto di vista delle gestione dei dati am-ministrativi e clinici e della dematerializ-zazione e digitalizzazione dei processi, an-cora molto c’è da fare per controllare il fe-nomeno nell’ambito dell’e-searching, del-l’acquisto di farmaci online, della comuni-cazione via Web e della mobile health.Un primo passo per promuovere la culturadella comunicazione in tema di salute viaWeb venne tuttavia effettuato nell’anno pre-cedente, il 2010, con la diffusione delle “Li-nee Guida per la comunicazione on line intema di tutela e promozione della salute”,ad opera del Ministero della Salute in colla-borazione con la Sapienza Università diRoma (4). All’interno del documento ven-gono individuate quali raccomandazioni,utili ad incrementare l’efficacia della comu-nicazione online in ambito di promozionedella salute, la traslazione sulle piattaformedei Social Media delle strategie di marke-ting sociale già in uso attraverso i canalicomunicativi tradizionali, la predisposizio-ne di blog e canali su Facebook e Twitterper favorire il coinvolgimento del paziente/cittadino, la predisposizione di canali mul-timediali video e l’attivazione di forum perla comunicazione con classificazione degliargomenti attraverso hashtag.L’importanza di una corretta (per forma econtenuti) ed efficace comunicazione è sta-ta evidenziata da due studi multicentricicondotti dal Dipartimento di Scienze dellaSanità Pubblica e Pediatriche in otto città
Italiane. In tali studi si riporta come gliutenti di Internet che cercano informazionisanitarie sul Web siano superiori alla metàdegli utenti Web in generale, con picchi trale donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni(78.8%) ed in particolar modo tra le donnein stato di gravidanza (98%) (5-8).
Il ruolo del Web 2.0 e dei Social MediaIl Web 2.0 è quella parte del Web alla qualechiunque può liberamente accedere attra-verso l’impiego di un software gratuito alfine di condividere informazioni e collabo-rare per creare nuova conoscenza e nel qua-le gli utenti siano al tempo stesso produt-tori e fruitori delle informazioni (9). Glistrumenti del Web 2.0 comprendono innan-zitutto i Social Media ma anche ulteriorimezzi di diffusione di informazioni qualiBlog, feed RSS, Podcast e Social book-marking. Sicuramente però i Social Media,spesso noti anche come Social Network,sono lo strumento principe per raggiungereil maggior numero di persone nel più brevetempo possibile. I Social Media infatti con-sentono l’aggregazione di persone che han-no interessi in comune e la creazione di veree proprie community online. La diffusionee condivisione di informazioni attraversoquesti legami sociali virtuali è favorita dal-l’offerta di strumenti che promuovono laconnessione e la relazione in Internet comeimmagini, fotografie, video e gruppi di di-scussione. L’utilità di questi metodi di co-municazione, soprattutto in ambito sanita-rio, viene rinforzata dalla possibilità di de-cidere il grado di condivisione dei proprifiles e documenti (utile nel selezionare grup-pi-target), dall’esistenza di sistemi di ratinge dalla possibilità di fornire giudizi e com-menti e infine dalla funzione di “tagging”che consente la diffusione e il reperimento
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
319Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
di informazioni di qualsivoglia formatomediante il ricorso a parole-chiave (10).Sono ormai numerose le società e le orga-nizzazioni scientifiche approdate sui princi-pali Social Network, quali Facebook e Twit-ter per promuovere le proprie attività asso-ciative, diffondere notizie e documenti direcente fattura. Di pari passo, ma per lo piùconfinata alla realtà anglosassone, è rileva-bile una forte attenzione alla comunicazio-ne attraverso i Social Media da parte distrutture ospedaliere e territoriali. In Ita-lia, le esperienze in questo settore sono po-che e concentrate maggiormente al Centro-Nord, come testimoniato dal rapporto Os-servasalute 2013 realizzato dall’Osservato-rio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Ita-liane dell’Università Cattolica di Roma (11).Appena il 34% delle Asl in Italia utilizzaalmeno un canale web 2.0 per comunicarecon il cittadino, afferma il rapporto Osser-vasalute. Guardando nel dettaglio, è l’Emi-lia-Romagna che fa registrare il dato piùconvincente, con il 73% delle Asl che uti-lizza almeno un canale web 2.0 come Face-book o Twitter per la comunicazione con icittadini. Nel Nord-Ovest spicca la Lom-bardia (47%), seguita da Piemonte (23%) eLiguria (20%). Al Centro i servizi social peril contatto con gli utenti sono in media inuna Asl su due: così nelle Marche (50%),nell’Umbria (42%), mentre la Toscana è al25%. Ma molto dipende anche dal numerodi strutture territoriali. Al Sud la connes-sione con i cittadini è meno “stretta”. Benel’Abruzzo (50%), poi Campania (43%) e Si-cilia (33%), mentre l’utilizzo dei canali web2.0 per la comunicazione con il cittadinorisulta del tutto assente in Molise, Basilica-ta, Calabria. Il canale di comunicazionemaggiormente utilizzato è Youtube, la piat-taforma multimediale di Google, che risul-
ta essere il mezzo preferito dalle Asl. Sonoinfatti 49 su 143 le aziende che lo utilizzan-do, mentre Twitter viene usato solo da 22aziende e Facebook da 20. Non hanno presopiede invece i blog, presenti con qualchesporadica esperienza solo in tre Regioni:Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna. Se sianalizza il dato di ospedali, Irccs e presidi,la quota di strutture che comunicano me-diante Social Media si attesta intorno al44%. Nuovamente l’Emilia-Romagna di-mostra di essere all’avanguardia nel settorecon l’83% delle strutture. Lombardia (41%ma con il numero più elevato, 54, di strut-ture di ricovero), Lazio (63%), Puglia (57%),Toscana e Basilicata (50%) riportano an-ch’esse valori positivi.
I Social Media per la promozionedella saluteIl ruolo dei Social Media nell’educazione allasalute e nella promozione della salute è sta-to indagato in numerosi studi in letteratu-ra. Le possibilità offerte da questi strumen-ti sono svariate, come testimonia l’estremavarietà di esperienze descritte a livello in-ternazionale. Uno studio canadese di Struike colleghi mostra ad esempio come i siti diSocial Networking come Facebook possa-no essere inclusi in programmi di promo-zione della salute come nel caso di inter-venti volti ad incoraggiare la cessazionedell’abitudine al fumo di tabacco (12).L’esempio riportato dagli autori è quello di“Crash the Crave”, un intervento rivolto agiovani adulti di età compresa tra i 19 e i29 anni. In tale intervento la cessazione delfumo è stata promossa mediante post diincoraggiamenti, gruppi di supporto, pro-mozione del supporto sociale, diffusione diinformazioni sanitarie ed esposizione dellestrategie di marketing delle industrie del
320
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione della salute attraverso i Social Media: una sfida per la sanità del futuro
tabacco. Un altro studio cross-sectional,condotto da Duke e colleghi, ha invece esa-minato i livelli di attività sui Social Mediae i contenuti dei Tobacco Control Programsnegli Stati Uniti (13). In tale studio vieneriportato come il 60% di questi program-mi utilizzi i Social Media per il raggiungi-mento dei propri obiettivi, ed in particolarmodo Facebook (60%), YouTube (40%) eTwitter (36%). Gli autori stessi riconosco-no però come le più frequenti attività suiSocial Media siano focalizzate sulla disse-minazione di informazioni più che sulle in-terazioni con gli utenti e come questi pro-grammi dovrebbero aumentare la parteci-pazione e la comunicazione reciproca con ifumatori per migliorare il servizio offerto.Un altro lavoro di Merchant e colleghi haindagato le potenzialità di Facebook nelcontribuire ad interventi volti a favorire lariduzione del peso in studenti del college(14). In un trial randomizzato controllatosono stati proposti a circa 400 studenti delcollege con problemi di sovrappeso o obe-sità dei contenuti attraverso Facebook ed èstato visto come questo strumento possaessere utile se associato ad un “health coa-ch” online disponibile alle interazioni congli utenti. Tuttavia, la pagina Facebook cre-ata per lo studio ha riportato una forte va-riabilità nelle risposte e un declino dellapartecipazione con il passare del tempo daparte degli utenti. La comunicazione e lapromozione della salute attraverso i siti diSocial Networking possono veicolare con-tenuti personalizzati per ogni target dellecampagne di promozione. La possibilità pergli utenti di generare contenuti, inoltre,accresce e massimizza la partecipazione de-gli utenti. Tuttavia, come riportato da Syrede colleghi a proposito di un’iniziativa di pro-mozione della salute nell’ambito delle ma-
lattie sessualmente trasmissibili, è fonda-mentale mantenere costante l’impegno conbanner e pubblicizzazioni dell’iniziativa perevitare che la risposta da parte della popo-lazione target si riduca con il trascorrere deltempo (15).Le iniziative di prevenzione e promozionedella salute attraverso i Social Media co-minciano a prendere piede anche in Italia.Tra le esperienze italiane da citare in questocontesto, sicuramente va ricordata ad esem-pio la diffusione di video volti a incoraggia-re l’attività fisica e la cessazione dell’abitu-dine al fumo di tabacco proposti dal canaleYouTube del Ministero della Salute (16,17).Parimenti utili sembrano essere le iniziati-ve proposte su Facebook per incentivarecorrette abitudini alimentari, un incremen-to dell’attività fisica, l’adozione di compor-tamenti salutari e la riduzione di compor-tamenti a rischio o per pubblicizzare eventiaventi quale obiettivo la diffusione e il coin-volgimento della popolazione in iniziativedi promozione della salute. Anche Twitter,attraverso il ricorso agli hashtag, può vei-colare informazioni e notizie e incrementa-re il dibattito su tematiche proprie del set-tore sanitario raccogliendo opinioni e puntidi vista sia dei professionisti sanitari che deicittadini. Infine anche le società scientifi-che, come la Società Italiana di Igiene,Medicina Preventiva e Sanità Pubblica(S.It.I.) e la European Public Health Asso-ciation (EUPHA), sono sbarcate su Face-book e Twitter per coinvolgere nel modopiù inclusivo possibile i propri soci di tuttele età (18,19).
La salute in tasca: la mobile health(m-Health)M-Health è un’abbreviazione per “mobilehealth”, un termine utilizzato per la pratica
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
321Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
della medicina e della sanità pubblica sup-porta da dispositivi mobili/portatili. È con-siderata una branca dell’e-Health, in forteespansione in diretta correlazione con la cre-scente introduzione sul mercato di apparec-chiature portatili per la comunicazione.L’uso più comune del termine m-Health èproprio in riferimento all’utilizzo di dispo-sitivi di comunicazione portatili, come itelefoni cellulari, i tablets e i personal digi-tal assistant (PDA) per offerta/fruizione diservizi sanitari, ricerca di informazioni sul-la salute e per influenzare gli stati emotivi(20). Al di là delle possibilità intrinseche diquesti strumenti per la diffusione di infor-mazioni (telefonia, sms, connessione inter-net, connessione bluetooth), smartphones etablets offrono la possibilità di ampliare leproprie potenzialità mediante il downloaddi software opzionali, denominati “Appli-cazioni” o “Apps” con specificità e caratte-ristiche funzionali molto diverse tra loro aseconda dello scopo per i quali sono statiprogettati. Tali applicazioni possono preve-dere contenuti relativi ai più svariati ambi-ti della vita quotidiana e tra questi ovvia-mente anche la salute (21). Le applicazioniin ambito sanitario presenti nei principalistore online di applicazioni sono ormai mi-gliaia e si prevede che 500 milioni circa dipazienti e cittadini ne faranno uso entro l’an-no 2015. Emerge chiaramente come smar-tphone e tablets posseggano tutte le carat-teristiche e le potenzialità necessarie pertrasformare, nei prossimi anni, il rapportotra professionisti della salute e pazienti (22).Infatti sono già disponibili in letteraturanumerosi studi che si occupano di descrive-re e valutare i molteplici utilizzi di questidispositivi in campo medico e, in partico-lare, che tipo di supporto possono fornire inambito clinico-diagnostico ma anche pre-
ventivo e di educazione sanitaria (23-25).Se gli smartphones si diffondono a macchiad’olio, altrettanto si può dire delle applica-zioni. Numerosi esempi vengono riportatidi applicazioni utilizzate per la gestione dipatologie cronico-degenerative, ed in par-ticolare del diabete, per la condivisione diinformazioni in ambito preventivo (es.: ma-lattie sessualmente trasmissibili ed in par-ticolar modo HIV), per la diagnostica e/ol’autodiagnosi, per la ricerca di informazio-ni sanitarie da parte di professionisti e dipazienti, per ricevere consigli sulla dieta osupporto durante l’attività fisica o ancoraper reclutare pazienti in studi e sperimen-tazioni (26-33).
Salute e Internet, i pericoli in agguatoLa diffusione di informazioni attraverso ilWeb e il ricorso a dispositivi portatili per lagestione e l’autogestione delle problemati-che relative allo stato di salute offre sicura-mente notevoli vantaggi in ambito comu-nicativo e sicuramente rappresenta il futu-ro per la Sanità Pubblica. Tuttavia, una se-rie di rischi collegati a questo fenomenodevono essere tenuti in forte considerazio-ne e controllati dai professionisti sanitari.Un primo rischio, infatti, è legato alla pos-sibile insorgenza di scarsa equità e disegua-glianze di salute per differenti possibilità diaccesso a queste tecnologie e alla rete, fe-nomeno noto come “Digital Divide”. IlDigital Divide può essere legato a ostacolidi diversa natura nell’accesso alla rete (34-37). Una prima fonte di Digital Divide èlegata all’età anagrafica. Viene riportato,infatti, come in Italia il digital divide, perquanto riguarda gli over 65, sia notevolmen-te presente. Solo il 21,1 per cento di questacategoria ha accesso alla rete (38). E men-tre il 66,1% degli under 30 usa telefoni
322
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione della salute attraverso i Social Media: una sfida per la sanità del futuro
smartphone e il 75,6% dei giovani italianiè iscritto a Facebook, solo il 6.8% degli over65 possiede uno smartphone e solo il 9,2%ha un account sui Social Media. Il DigitalDivide può essere invece dovuto a motividi natura geografica. È noto infatti comel’accesso a Internet sia molto differente aseconda sia dei continenti che delle nazioniche si prendono in considerazione, sia nel-l’ambito della stessa nazione a seconda chela sede di residenza/lavoro sia collocata inuna città o in un ambiente rurale. Il DigitalDivide può essere legato anche allo statussocio-economico. Questi dispositivi e laconnessione internet hanno un costo, spes-so molto rilevante, che può essere un deter-rente al loro utilizzo in tempi di crisi eco-nomica soprattutto tra i soggetti e le fami-glie con problemi finanziari e dovuti a dif-ficoltà di trovare occupazione. Non menoimportanti inoltre sono le differenze di ac-cesso associabili alle competenze informa-tiche, intese come l’insieme delle compe-tenze necessarie per operare con il compu-ter e la rete, cercare e selezionare informa-zioni presenti in essa e usare tali informa-zioni per raggiungere i propri obiettivi.Secondo rischio, particolarmente sentitodagli utenti di queste tecnologie, è riferibi-le ai possibili dubbi sulla trasparenza dei datie sulla privacy (39-41). La trasmissione didati sanitari sul Web fa insorgere in nume-rosi pazienti la preoccupazione che questidati non siano protetti da garanzie di riser-vatezza come avviene (o si auspica avven-ga) con l’archiviazione dei dati in via carta-cea. Questa percezione del rischio, tutta-via, spesso non è di importanza tale dal di-stogliere le persone dall’uso di questi stru-menti.Non meno importante è il problema dellaveridicità e dell’evidenza scientifica dei con-
tenuti delle pagine Web e delle applicazioniin ambito sanitario. Se è vero infatti cheInternet ed in particolar modo il Web 2.0ha spalancato le porte della conoscenza ereso fruibili all’intera popolazione informa-zioni e nozioni una volta confinati negli stu-di dei medici, e altrettanto vero che la pos-sibilità di caricare contenuti da parte dichiunque senza alcuna forma di controllopuò portare alla diffusione di informazioniincomplete o errate (42-43). Ne sono untipico esempio le pagine Web gestite daimovimenti antivaccinali, che veicolanomessaggi e contenuti scollegati da qualsiasiforma di evidenza scientifica, facendo levasugli stati emotivi attraverso anedotti dicomplicanze attribuite ai vaccini ma nonconfermate da evidenze scientifiche (44).Infine, fonte di preoccupazione per i profes-sionisti di sanità pubblica è la possibile in-fluenza che le informazioni reperite sul Webpossono avere sui comportamenti in ambi-to di scelte sanitarie della popolazione. Ilpericolo che tali informazioni modifichinola compliance dei pazienti alle terapie o in-ducano i cittadini a scavalcare i consigli delmedico, affidandosi totalmente al Web perla scelta dei farmaci da assumere e talvoltaanche l’acquisto di tali farmaci in negozionline non certificati, è infatti stato studia-to e dimostrato in precedenti studi multi-centrici e revisioni scientifiche condotte dalDipartimento di Scienze della Sanità Pub-blica e Pediatriche dell’Università degli Stu-di di Torino (5-7,45).In conclusione, vantaggi e rischi sono i duepiatti della bilancia di un fenomeno in con-tinua evoluzione, che non può e non deveessere trascurato dai professionisti sanitari,pena una loro prossima e sempre più rile-vante emarginazione dal processo diagno-stico e terapeutico del paziente. A tal fine,
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
323Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
va ripensata e rimodulata la relazione me-dico-paziente e soprattutto il ruolo del me-dico. Infatti, diventa necessario per il me-dico l’acquisizione di skills per poter svol-gere un ruolo di filtro delle informazioni
presenti sul Web. Solo così, il medico delfuturo starà al passo con l’inarrestabile cam-mino delle nuove tecnologie informatichein sanità.
BIBLIOGRAFIA1. Giacometti M1, Gualano MR, Bert F, Siliquini R.
Public health accessible to all: use of smartphonesin the context of healthcare in Italy. Ig Sanita Pubbl.2013 Mar-Apr;69(2):249-59.
2. Eysenbach G. What is e-health? J Med InternetRes. 2001 Apr-Jun;3(2):E20.
3. Ministry of Health. The National eHealthInformation Strategy - National Context, state ofimplementation and best practices. Roma, 2011.Disponibile al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1653_allegato.pdf (ultimo ac-cesso 25/07/2014)
4. Ministero della Salute, Sapienza Università diRoma. Linee guida per la comunicazione online intema di tutela e promozione della salute. Roma,2010. Disponibile al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1473_allegato.pdf (ul-timo accesso 25/07/2014)
5. Siliquini R, Ceruti M, Lovato E, Bert F, Bruno S, DeVito E, Liguori G, Manzoli L, Messina G, MinnitiD, La Torre G. Surfing the internet for healthinformation: an italian survey on use and populationchoices. BMC Med Inform Decis Mak. 2011 Apr7;11:21.
6. Lovato E, Bert F, Bruno S, Ceruti M, De Vito E, LaTorre G, Liguori G, Manzoli L, Messina G, MinnitiD, Siliquini R; Collaborative Group. Role of theWeb on behaviors and health choices in six Italiancities: results of a multicenter study. Ann Ig. 2011Jul-Aug;23(4):283-94.
7. Bert F, Gualano MR, Brusaferro S, De Vito E, deWaure C, La Torre G, Manzoli L, Messina G, TodrosT, Torregrossa MV, Siliquini R. Pregnancy e-health:a multicenter Italian cross-sectional study onInternet use and decision-making among pregnantwomen. J Epidemiol Community Health. 2013 Dec1;67(12):1013-8.
8. Siliquini R, Saulle R, Rabacchi G, Bert F, MassimiA, Bulzomì V, Boccia A, La Torre G. Validation of aweb-based questionnaire for pregnant women toassess utilization of internet: survey among an Italiansample. Ann Ig. 2012 Sep-Oct;24(5):397-405.
9. O’Reilly T. What Is Web 2.0. O’Reilly Network,30 settembre 2005. Disponibile al link: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (ul-timo accesso 25/07/2014)
10.Santoro E. Web 2.0 e Social Media in Medicina. IlPensiero Scientifico Editore, 2011, 2° edizione.
11.Silenzi A, Falvo R, Campanella P, Lazzari A, Paren-te P, Favaretti C. Assetto Istituzionale-Organizzativo: Web 2.0 e salute. In: Osservatorionazionale sulla salute nelle regioni italiane. Rap-porto Osservasalute 2013. Università Cattolica delSacro Cuore di Roma.
12.Struik LL, Baskerville NB. The role of facebook incrush the crave, a mobile- and social media-basedsmoking cessation intervention: qualitativeframework analysis of posts. J Med Internet Res.2014 Jul 11;16(7):e170.
13.Duke JC, Hansen H, Kim AE, Curry L, Allen J.The use of social media by state tobacco controlprograms to promote smoking cessation: a cross-sectional study. J Med Internet Res. 2014 Jul10;16(7):e169.
14.Merchant G1, Weibel N, Patrick K, Fowler JH,Norman GJ, Gupta A, Servetas C, Calfas K, RasteK, Pina L, Donohue M, Griswold WG, Marshall S.Click “like” to change your behavior: a mixedmethods study of college students’ exposure to andengagement with Facebook content designed forweight loss. J Med Internet Res. 2014 Jun24;16(6):e158.
15.Syred J, Naidoo C, Woodhall SC, Baraitser P. Wouldyou tell everyone this? Facebook conversations ashealth promotion interventions. J Med Internet Res.
324
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione della salute attraverso i Social Media: una sfida per la sanità del futuro
2014 Apr 11;16(4):e108.16.Ministero della Salute. La campagna per la promo-
zione dell’attività fisica (11.03.13). Disponibile suYouTube al link: http://www.youtube.com/watch?v=kjSjcAofyO8
17.Ministero della Salute. Io non fumerò mai! Lo spotdella campagna 2010 contro il tabagismo. Dispo-nibile su YouTube al link: http://www.youtube.com/watch?v=Sh7F7yBtbw4&list=TLH7MTCE3zQRiXX-PknhrVI0Vi3SrA8S62
18.Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva eSanità Pubblica (S.It.I.). Account Facebook: https://www.facebook.com/pages/SItI-Societ%C3%A0-Italiana-di-Igiene-Medicina-Preventiva-e-S a n i t % C 3 % A 0 - P u b b l i c a /716780378385798?fref=ts
19.European Public Health Association (EUPHA).Account Facebook: www.facebook.com/pages/Eupha-European-Public-Health-Association/196843717014707?fref=ts
20.Istepanian R, Jovanov E, Zhang YT. Introductionto the special section on M-Health: beyond seamlessmobility and global wireless health-careconnectivity. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2004,8(4):405-14.
21.Burdette SD, Herchline TE, Oehler R. Surfing theweb: practicing medicine in a technological age:using smartphones in clinical practice. Clin InfectDis. 2008 Jul 1;47(1):117-22.
22.Boulos MN, Wheeler S, Tavares C, Jones R. Howsmartphones are changing the face of mobile andparticipatory healthcare: an overview, with examplefrom eCAALYX. Biomed Eng Online. 2011 Apr5;10:24.
23.Lindquist AM, Johansson PE, Petersson GI,Saveman B-I, Nilsson GC. The use of the PersonalDigital Assistant (PDA) among personnel andstudents in health care: a review. Journal of MedicalInternet Research 2008, 10:e31.
24.Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. The uses ofthe iPhone for surgeons. Surgeon. 2011 Feb;9(1):44-8.
25.Sarasohn-Kahn J. How smartphones are changinghealth care for consumers and providers. Oakland,CA: California HealthCare Foundation; 2010. Di-sponibile al link: http://www.chcf.org/publications/2010/04/howsmartphones-are-changing-health-carefor consumers-and-providers. (Ultimo accesso
25/07/2014)26.Handel MJ. mHealth (mobile health)-using Apps
for health and wellness. Explore (NY)2001;7(4):256-61.27.Albrecht JA, Larvick C, Litchfield RE, Weishaar C.
Leftovers and other food safety information foriPhone/iPad application (“smartphone” technology).J Nutr Educ Behav. 2012;44(5):469-71.
28.Carter MC, Burley VJ, Nykjaer C, Cade JE: ‘MyMeal Mate’ (MMM) validation of the diet measurescaptured on a smartphone application to facilitateweight loss. Br J Nutr. 2012;3:1-8.
29.West JH, Hall PC, Hanson CL, Barnes MD, Giraud-Carrier C, Barrett J.There’s an app for that: contentanalysis of paid health and fitness apps. J MedInternet Res. 2012;14(3):e72.
30.Stephens J, Allen J. Mobile Phone Interventions toIncrease Physical Activity and Reduce Weight: ASystematic Review. J Cardiovasc Nurs2013;28(4):320-9.
31.Boyer EW, Fletcher R, Fay RJ, Smelson D, ZiedonisD, Picard RW. Preliminary efforts directed towardthe detection of craving of illicit substances: theiHeal project. J Med Toxicol. 2012;8(1):5-9.
32.Abroms LC, Padmanabhan N, Thaweethai L,Phillips T. iPhone apps for smoking cessation: acontent analysis. Am J Prev Med. 2011;40(3):279-85.
33.Ramanathan N, Swendeman D, Comulada WS,Estrin D, Rotheram-Borus MJ. Identifyingpreferences for mobile health applications for self-monitoring and self-management: Focus groupfindings from HIV-positive persons and youngmothers. Int J Med Inform 2013;82(4):e38-46.
34.Liff S, Shepherd A. An Evolving Gender DigitalDivide? Internet Issue Brief no 2. 2004 Oxford:Oxford Internet Institute.
35.Aqii SV, Moghaddam AI. Bridging the digital divi-de: the role of librarians and informationprofessionals in the third millennium. ElectronicLibrary 2008;26(2):226-37.
36.Roy S, Ghose S. Internet adoption as a two-stagetransition: converting internet non-users to internetusers and to online buyers. Int J Market Res2006;48(3):321-49.
37.Livingstone S. Balancing opportunities and risks inteenagers’ use of the Internet: the role of onlineskills and internet self-efficacy. New Media Soc
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
325Fabrizio Bert, Maria Rosaria Gualano, Giacomo Scaioli, Stefano Passi, Roberta Siliquini
2009;12(2):309-29.38.CENSIS-UCSI. L’evoluzione digitale della specie.
11° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione,2013.
39.Huesch MD. Privacy threats when seeking onlinehealth information. JAMA Intern Med. 2013 Oct28;173(19):1838-9.
40.Vodicka E, Mejilla R, Leveille SG, Ralston JD, DarerJD, Delbanco T, Walker J, Elmore JG. Onlineaccess to doctors’ notes: patient concerns aboutprivacy. J Med Internet Res. 2013 Sep26;15(9):e208.
41.Boulos MN, Brewer AC, Karimkhani C, Buller DB,Dellavalle RP. Mobile medical and health apps:state of the art, concerns, regulatory control andcertification. Online J Public Health Inform. 2014Feb 5;5(3):229.
42.Cooper CP, Gelb CA, Vaughn AN, Smuland J,
Hughes AG, Hawkins NA. Directing the publicto evidence-based online content. J Am Med InformAssoc. 2014 Jul 22. pii: amiajnl-2014-002701.
43.Giménez-Pérez G1, Caixàs A, Giménez-Palop O,González-Clemente JM, Mauricio D. Disseminationof ‘patient-oriented evidence that matters’ on theInternet: the case of Type 2 diabetes treatment.Diabet Med. 2005 Jun;22(6):688-92.
44.Poscia A, Santoro A, Collamati A, Giannetti G, deBelvis AG, Ricciardi W, Moscato U. Availabilityand quality of vaccines information on the Web: asystematic review and implication in Public Health.Ann Ig. 2012 Mar-Apr;24(2):113-21.
45.Bert F, Galis V, Passi S, Gualano MR, Siliquini R.Differences existing between USA and Europe inopioids purchase on Internet: an interpretativereview. Journal of Substance Use 2014 Early online:1-8.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 326-339
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti del-le diseguaglianze nell’accessoThe promotion of mammographic screening: aspects of inequalities in the access
Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
Gabriele CavazzaDirettore del Distretto di committenza e garanzia AUSL Bologna
Aldo TrottaSociologo, Distretto di committenza e garanzia AUSL Bologna
Parole chiave: screening mammografico, disequità nell’accesso, fattori socio-economici, condizioni di conte-sto, estensione della partecipazione.
RIASSUNTOObiettivi: analisi di alcune caratteristiche che la partecipazione ai programmi di prevenzione oncologica alseno assume nella realtà di Bologna, quale presupposto fondamentale per pianificare e realizzare iniziativevolte a contrastare le disparità nell’accesso ampliando i livelli di copertura dello screening mammografico.Metodologia: concentrando l’analisi in particolare sull’indicatore del rapporto di non-adesione, a partire dalquadro generale vengono brevemente descritte e commentate le variazioni dei livelli di partecipazione alloscreening in relazione ad alcune variabili socio-economiche, indicative della condizione materiale di vitadelle donne. Il confronto tra i due quartieri cittadini con i livelli più elevati e più bassi di partecipazione,l’analisi dell’impatto che le medesime variabili socio-economiche hanno in tali realtà territoriali e l’esame deirapporti di non-adesione delle donne delle dieci nazionalità con i livelli maggiori offrono lo spunto per unariflessione interessante.Risultati: dallo studio sono emersi un significativo divario nell’accesso allo screening tra italiane e straniere,un livello di partecipazione più basso nella classe d’età 55-59 anni, tra le donne sole e, in generale, con unacondizione di vita svantaggiata, nonché una peculiare polarizzazione territoriale indipendente dai livellisocio-economici delle diverse aree della città.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
327Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
IntroduzioneIl cancro della mammella è una delle princi-pali forme tumorali che colpiscono la popo-lazione femminile. L’insorgenza di questapatologia, che talora per essere affrontata ne-cessita di interventi terapeutici invasivi, puòtuttavia essere efficacemente contrastata conla prevenzione e la diagnosi precoce. Per taleragione, da alcuni anni si procede alla pro-mozione e alla attivazione di un programmadi screening, la cui efficacia preventiva è or-mai largamente comprovata da numeroseanalisi e riconosciuta dalla comunità scienti-fica internazionale. Secondo uno studio re-cente, la diminuzione di circa il 45% della
Key word: mammographic screening, inequalities on the access, socio-economics factors, context conditions,extension of the participation.
S U M M A RYObjectives: analysis of some characteristics that the participation to the programs oncological prevention ofthe breast assumes in reality of Bologna, as a fundamental precondition to plan and to realize someinitiatives aimed at opposing the inequalities in the access exstending the coverage levels of mammographicscreening.Method: focusing the analysis particularly on the indicator of non-adherence ratio, starting from the generalpicture the changes of the levels of the participation to the screening are briefly described and commentedin relation to some socio-economic variables, indicative of material condition of women’s life. The comparisonbetween the two discricts of the city which have the highest and the lowest participation, the analysis of theimpact that these socio-economic variables have in the same territorial realities and the examination of non-adherence ratios of women of the ten nationalities with the higher levels offer the opportunity for aninteresting reflection.Results: the study reveals a significant gap between the access to the screening of the italian women and theone of foreign women, a lower level of participation in the age 55-59 years, among lonely women and, ingeneral, among women with a disadvantaged condition of life, as well as a particular territorial polarizationindependent of socio-economic levels of the different areas of the city.
mortalità osservata per tumore alla mam-mella, che si è verificata negli ultimi 2-3decenni nei Paesi occidentali, compresa l’Ita-lia, può essere stata effetto di tali program-mi pubblici, oltre che dei controlli mammo-grafici periodici che le donne eseguono spon-taneamente1.Grazie dunque alle scelte di politica sanita-ria, i risultati ottenuti negli ultimi anni sonoindubbiamente positivi. Ciò nondimeno, esebbene il livello di copertura e di partecipa-zione della popolazione agli screening siaconsiderato alquanto soddisfacente, gli spazie le possibilità per ulteriori miglioramentirestano tuttora ampi. Non a caso il Piano
1 Lo studio di Barry D. et al, Effect of screening and adjuvant terapy on mortality from breast cancer, NewEngland Journal of Medicine, 2005; 27; 353(17): 1784-92, è citato in Screening oncologici. Raccomandazio-ni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro dellamammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto, (a cura di) Ministero della Salute,Direzione Generale della Prevenzione, Roma; 2006, p. 38.
328
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
Nazionale per la Prevenzione 2010-2012 rac-comanda di potenziare i programmi di scre-ening organizzati e di promuovere il coin-volgimento dei soggetti fragili, che per ra-gioni diverse non aderiscono2.D’altro canto, studi nazionali ed internazio-nali rivelano l’esistenza di considerevoli di-seguaglianze nell’accesso a tali iniziative: es-sendo correlati allo status socio-economico,i livelli di adesione sono significativamenteinferiori tra le minoranze etniche e gli im-migrati, e tra coloro che hanno difficoltà eco-nomiche, livelli reddituali bassi e gradi discolarizzazione non elevati. Secondo il siste-ma di sorveglianza Passi, ad esempio, la mi-nore adesione delle donne straniere allo scre-ening per la prevenzione del cancro al seno –così come a quello per la cervice uterina – haun nesso con una maggiore disinformazionespecifica in merito alle azioni e ai test di pre-venzione oncologica: rispetto alle donne ita-liane, le cittadine provenienti da altri Paesidichiarano di ricevere, sia da parte delle strut-ture e degli operatori sanitari che dai proprimedici di base, meno informazioni e consi-gli sui programmi di screening e sull’impor-tanza che la partecipazione ad essi riveste perla loro salute. Naturalmente, anche i deter-minanti sociali della salute, e in particolarmodo il grado d’istruzione e lo status econo-mico delle donne, risultano significativamen-te associati con l’adesione, soprattutto per loscreening mammografico e per quello del-l’utero3. Già largamente dimostrata dagli stu-di epidemiologici e sociologici, trova dun-que conferma la relazione tra condizioni so-
cio-economiche e stato di salute delle perso-ne, di cui senza dubbio l’adesione consapevo-le alle iniziative di carattere preventivo rap-presenta un aspetto di grande rilievo.La promozione degli screening non può indefinitiva prescindere dall’analisi di quei fat-tori sociali, economici e ambientali che inci-dono sui livelli di compliance alle strategie diprevenzione oncologica. Pertanto, cercandodi evidenziare alcune caratteristiche che ladiseguaglianza nell’accesso allo screening as-sume nella realtà di Bologna, l’articolo si ponequale contributo alla conoscenza del fenome-no, a sua volta presupposto ineludibile perdelineare e tradurre in pratica interventi dicontrasto degli svantaggi legati alle condi-zioni materiali di vita e alle conseguenti di-sparità in materia di salute.
PremessaLe elaborazioni si basano su una coorte di32.700 cittadine di età compresa tra 50 e 74anni, di cui 24.517 aderenti al programma e8.153 mai aderenti, vale a dire donne che, puressendo in età di screening e sebbene invitate(in alcuni casi anche più volte), non hannomai effettuato una mammografia. La coorteè il prodotto della estrapolazione dalla popo-lazione bersaglio nel round di screening delleresidenti a Bologna dal 20.8.2010 al 20.8.2012e del record linkage con i database del Co-mune, operazione quest’ultima finalizzata adottenere informazioni di carattere sociale,demografico ed economico, e che per en-trambe le categorie di donne ha dato risulta-ti superiori al 95%4. Per una valutazione pru-
2 Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, p. 36.3 PASSI, Disuguaglianze sociali e salute. Rapporto nazionale 2007-2009, scaricabile da sito di Epicentro,all’indirizzo http://www.epicentro.iss.it/passi/disuguaglianze07-09.asp4 La popolazione bersaglio di partenza era composta da 81.726 donne di età compresa tra 45 e 74 anni, di cuia) 32.166 aderenti; b) 8.523 mai aderenti; c) 4.491 mai invitate e pertanto non aderenti e 4) 36.564 inserite
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
329Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
dente del quadro d’insieme, in particolare perquanto riguarda il rapporto tra variabili so-cio-economiche e livello di partecipazioneallo screening, si devono tenere in conside-razione gli indubbi limiti oggettivi di alcunedelle informazioni ottenute con il record linka-ge: i dati reddituali, ad esempio, non sonopienamente realistici a causa di una quota dievasione e di elusione, dell’esistenza di red-diti non soggetti a tassazione fiscale (ad esem-pio l’indennità di accompagnamento) e diredditi tassati alla fonte, quali le rendite fi-nanziarie; si tratta peraltro di dati che per-mettono di valutare solo una dimensione dellacondizione economica personale o familiare,in quanto privi di informazioni dettagliatesul patrimonio mobiliare e immobiliare5.
Quadro generaleIl rapporto di non-adesione (mai aderenti/maiaderenti + aderenti x 100) su cui prevalente-mente si concentra l’analisi, è risultato parial 25%. Disaggregando però i dati in basealla cittadinanza emergono con immediatez-za significative disparità: il valore registratotra le nate in altri Paesi è infatti più del dop-pio rispetto a quello delle nate in Italia:52,8% rispetto al 23,3%6. Il picco dell’in-dicatore si presenta nella classe d’età 55-59anni con il 32,7%, mentre più bassi e relati-vamente analoghi tra essi sono i valori dei
rapporti di non-adesione delle altre fasce d’età.Analizzando i dati in relazione allo stato ci-vile, è emerso che sono le nubili a far regi-strare il livello di non-adesione più alto,39,4%, seguite dalle vedove e divorziate conil 26,2% e dalle coniugate con il 21,5%. Ladistribuzione dei valori in base allo stato ci-vile e alla cittadinanza ha tuttavia fatto emer-gere uno scenario leggermente differente:mentre per le italiane i valori più alti di man-cata adesione allo screening si hanno tra lenubili (34,9) e quelli più bassi tra le coniuga-te (20,8), per le cittadine straniere la com-pliance più bassa si riscontra tra le divorziatee le vedove (66,1%) – sebbene in questo casoil dato è stato calcolato su valori assoluti re-lativamente limitati – e quella più alta tra ledonne sposate (50,3). In definitiva, indipen-dentemente dalla cittadinanza, sono le spo-sate ad esprimere una maggiore sensibilità epiù elevati tassi di adesione ai programmiper la prevenzione del cancro al seno. Que-sto aspetto trova conferma anche dall’analisidei dati disaggregati per tipologia familiare.
Non-adesione e condizione socio-economicaA partire dalla suddivisione del reddito incinque classi, è stato sottoposto ad analisi ilrapporto tra questa variabile economica e illivello di non-partecipazione allo screening.
in una eterogenea categoria altro, comprensiva delle non-elegibili, delle donne cha avevano inviato un rifiutoscritto, di quelle in follow-up per cancro al seno, delle escluse dalla chiamata in quanto in possesso di un testmammografico recente e documentato, ecc….: l’impossibilità di distinguere le differenti tipologie ha resoopportuna la loro esclusione. L’analisi riguarda pertanto esclusivamente le prime due categorie: a) aderenti eb) mai aderenti. Per rendere omogenei i due sottogruppi, dal gruppo delle prime sono state inoltre escluse ledonne di età compresa tra 45 e 49 anni, in quanto nel sottogruppo delle mai aderenti non erano presenti donneresidenti della medesima classe d’età.5 AA.VV., I redditi 2010 dichiarati dalle cittadine e dai cittadini di Bologna. Alcune disuguaglianze fragenerazioni, generi, nazionalità e territori, a cura del Dipartimento programmazione del Comune di Bologna,Novembre 2012.6 È bene far notare che i rapporti di adesione (aderenti/aderenti + mai aderenti x 100) sono conseguenti,pertanto quello generale è pari al 75%, quello delle italiane è 76,7% e delle straniere è pari al 47,2%.
330
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
Sono le donne delle fasce di reddito più bassee più alte ad aderire meno allo screening,mentre una partecipazione maggiore si regi-stra nelle classi reddituali intermedie. Le duecurve di distribuzione (italiane e straniere)
assumono infatti una caratterizzazione ad U,con i valori più alti che si posizionano rispet-tivamente nella parte bassa e nella parte altadella scala (Fig. 1).Ad ogni modo, indipendentemente dall’am-
Fig. 1 - Rapporti di non-adesione per classi di reddito
30,4
20,817,6
23,237,6
58,2
40,8
27,5
20
54,5
0
10
20
30
40
50
60
70
fino a 7.500 da 7.501 a15.000
da 15.001 a30.000
da 30.001 a50.000
oltre 50.000
Italiane Straniere
piezza delle classi, è ragionevole supporre chei livelli più elevati di non-partecipazione alloscreening delle donne delle classi di redditopiù basse e di quelle con condizioni econo-miche più vantaggiose abbiano ragioni es-senzialmente differenti. È presumibile, cioè,che le donne con una condizione più agiatafacciano un maggiore ricorso al settore pri-vato per eseguire il test mammografico. Sa-rebbero pertanto le cittadine in condizionieconomiche più svantaggiate, e in modo piùrilevante quelle nate all’estero, a sottoporsicon minore assiduità al test di screening on-cologico. Considerando la cittadinanza, in-fatti, si evince che le differenze più ampie tra
straniere e italiane si presentano soprattuttonelle due classi di reddito più basse – in par-ticolare in quella da 0 a 7.500 euro con il58,2 % delle prime a fronte del 30,4% dellenate in Italia –, mentre nella fascia redditua-le centrale il divario tende ad assottigliarsi.Si direbbe, dunque, che il miglioramento del-la posizione economica contribuisca in qual-che modo a ridimensionare la differente par-tecipazione al programma di prevenzione chesi registra in relazione alla cittadinanza.Considerando un’altra variabile indicativa delladimensione economica e quindi delle condi-zioni generali di vita, vale a dire la situazioneabitativa7, è emerso che le donne che vivono
7 La variabile condizione abitativa è stata disaggregata in tre categorie: 1) affitto pubblico; 2) casa di proprietàdella famiglia; 3) altra condizione (quest’ultima include situazioni eterogenee quali l’affitto privato, l’usufrutto,il comodato d’uso, la proprietà di altri, parenti o meno)
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
331Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
in un alloggio con un affitto pubblico a canonecalmierato (condizione ipoteticamente indi-cativa di una situazione individuale e/o fami-liare di svantaggio sociale) fanno registrare unlivello di non-partecipazione superiore (36%)rispetto alle donne con un’altra condizioneabitativa (31%) e, soprattutto, rispetto a quelleche vivono in un’abitazione di proprietà(20,4%). Tali differenze trovano pieno riscon-tro sia tra le italiane che tra le cittadine dialtra nazionalità, sebbene i valori delle primesiano marcatamente inferiori.Valutando insieme entrambe le variabili (red-dito e condizione abitativa) e focalizzandol’analisi sulle donne con un livello economi-co basso (per semplicità sono state accorpatein un’unica classe, fino a 15 mila euro, le duefasce di reddito inferiori), è emerso che, aparità di condizione abitativa, la posizionereddituale incide negativamente sull’adesio-ne al programma di screening mammografi-co: sia tra le cittadine straniere che tra le ita-liane, il rapporto di non-adesione aumenta,sebbene leggermente, per tutte e tre le con-dizioni abitative prese in considerazione: trale straniere di classe di reddito fino a 15 milaeuro e con una condizione abitativa in affittopubblico, ad esempio, il valore raggiunge il60,6%; il dato delle italiane è il 36,7%.Approfondendo ulteriormente l’analisi e pren-dendo in esame le principali tipologie fami-liari delle donne8, si evince che sono le sposatea presentare i valori più bassi di non-adesio-ne (20,8%) e quindi a segnalare una maggio-re partecipazione allo screening, a fronte delledonne sole (30,4%). Questa differenza non sipresenta tra le straniere, dove i valori delle
due tipologie familiari aggregate che abbia-mo considerato sono sostanzialmente simili(51,9% le sposate e 52,4% le donne sole).A parziale conclusione dell’analisi relativa alrapporto tra il livello di partecipazione alloscreening e i fattori di natura socio-econo-mica, sono state analizzate la variazioni delvalore dell’indicatore prendendo in esamecontemporaneamente le tre variabili (reddito,tipologia familiare e condizione abitativa)che, nel loro complesso, concorrono a quali-ficare la condizione materiale di vita. Per in-terpretare correttamente i risultati di questaelaborazione, è importante ribadire che ilrapporto di non-adesione totale (indipenden-temente dalla cittadinanza delle donne e dal-le variabili) è pari al 25%. È da questo datoche occorre partire per avere un’immaginepiù precisa dell’impatto che le dimensionisocio-economiche hanno sulla partecipazio-ne all’iniziativa di prevenzione del tumore alseno. Come mostra il grafico seguente, vie-ne convalidato un aspetto già evidenziato: ilvalore del rapporto di non-adesione appenaricordato cambia in relazione alla diversa clas-se di reddito, ovvero diminuisce nelle fascereddituali intermedie e aumenta nella classedi reddito più bassa e in quella oltre i 50 milaeuro (Fig. 2).In quest’ultima fascia reddituale il dato pas-sa dal 25% al ben più rilevante 37,7%, regi-strando un aumento decisamente significati-vo che, come abbiamo già ipotizzato, po-trebbe essere almeno in parte spiegato da unmaggiore ricorso al settore privato. Ma èimportante notare che, valutando al contem-po anche la condizione abitativa non proprie-
8 Otto le tipologie familiari prese in considerazione: 1) Donna sola; 2) Madre con figli; 3) Madre con figli ealtri conviventi; 4) In convivenza; 5) Sposata; 6) Sposata con figli; 7) Sposata con altri conviventi; 8) Sposatacon figli e altri conviventi. Le prime tre tipologie, che in generale sembrano rinviare ad una condizione dimaggiore svantaggio sociale, sono state aggregate in un’unica categoria che abbiamo indicato con “Donnesole”, mentre le restanti tipologie in una classe che abbiamo indicato come “Sposate”.
332
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
taria e la tipologia familiare svantaggiata(donne sole), per questa classe di reddito illivello di non-partecipazione rimane sostan-zialmente stabile: il rapporto di non-adesio-ne aumenta infatti solo di 2,4 punti percen-tuali, passando da 37,7% al 40,1%, a riprovadel fatto che tra le persone che vivono in unacondizione economica agiata, queste due va-riabili non incidono più di tanto sulla mag-giore o minore partecipazione allo screening.Variazioni ben più rilevanti si registrano in-vece per le classi di reddito più basse, segna-lando un effetto di rinforzo reciproco tra quelledimensioni che nel loro insieme contribui-scono a delineare una condizione socialmen-te disagiata. Nella fascia reddituale più bas-sa, ad esempio, il rapporto di non-adesioneaumenta dal 25% complessivo (calcolato cioèindipendentemente da qualsiasi variabile equindi anche dal reddito) al 34,7%, per poipassare al 42% tra le coloro che vivono inun’abitazione non di proprietà e al 52,1% tra
le donne sole (vedi nota 8). In questo caso, l’in-cremento complessivo che si registra è di oltre17 punti percentuali, rispetto ai 2,4 della fa-scia di reddito più alta.In definitiva, i livelli di compliance a questaimportante iniziativa di prevenzione onco-logica sembrano denotare una generale situa-zione di diseguaglianza sociale. Essa rinviaad alcune di quelle numerose variabili che laletteratura sociologica descrive quali deter-minanti dello stato di salute, e su cui occor-rerebbe pertanto volgere lo sguardo e con-centrare l’impegno per ampliare i livelli dirispondenza e di copertura.
Non-adesione per quartieri e perzone della città: una polarizzazioneparticolareOsservando la distribuzione dei rapporti dinon-adesione allo screening nei diversi quar-tieri della città è possibile aggiungere, ad in-tegrazione del quadro finora delineato, un
Fig. 2 - Rapporti di non-adesione per classi di reddito/condizione abitativa/tipologia familiare
34,7
42
52,1
22,127,5
34,5
17,721,5
25,1 23,228,4
31,337,7
40,5 40,1
0
10
20
30
40
50
60
da 0 a 7.500 da 7.501 a15.000
da 15.001 a30.000
da 30.001 a50.000
> di 50.000
Reddito
Reddito + casa non di proprietà
Reddito + casa non di proprietà + tip. fam. "donne sole"
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
333Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
altro piccolo tassello. La scala di valori (Fig.3) oscilla dal 35,1% di S. Stefano (quartierecon un reddito imponibile medio tra i più
Fig. 3 - Rapporti di non-adesione per quartiere
elevati della città) al 17,7% del quartiere Reno(realtà con il reddito tra i più bassi), con unadifferenza tra i due pari quasi al doppio.
35,1
29,9 28,8
24,5 23,3 21,8 21,619,5
17,7
25
0
10
20
30
40
S. Stef
ano
S. Vital
e
Sarago
zzaPorto
S. Donat
oNavi
leSav
ena
Borgo Paniga
leReno
Totale
Relativamente differente (e con valori piùelevati) è la distribuzione territoriale dellanon-adesione delle cittadine nate all’estero.Ciò potrebbe essere dovuto sia ad una diver-sa distribuzione nei quartieri della città dellostatus sociale delle straniere, che al minoregrado di integrazione nel tessuto socio-cul-turale delle singole realtà di quartiere di co-loro che sono arrivate da poco tempo.Disaggregando ulteriormente i dati in basealle zone della città emerge una rappresenta-zione ancora più dettagliata, che tuttaviaconferma pienamente il profilo già emerso:le zone del centro storico cittadino e la zonacollinare fanno registrare i rapporti di non-adesione più alti, a differenza delle zone pe-riferiche nelle quali si riscontrano i valori più
bassi. Si manifesta cioè una polarizzazioneterritoriale del tutto particolare, ovvero as-solutamente non coincidente con i livelli disviluppo socio-economico e con gli indici dideprivazione, anzi in decisa controtendenzarispetto ad essi. In altri termini, è nei quar-tieri e nelle zone delle città con i livelli red-dituali più elevati9 che si registrano parados-salmente i valori più alti di mancata adesio-ne al test mammografico. Come spiegazio-ne parziale di tale fenomeno, siamo portatinuovamente a pensare all’ipotesi di un pro-babile maggiore ricorso al settore privato daparte di donne (in particolare delle italiane)che vivono nelle zone più ricche della città.Tuttavia, l’esame dell’impatto della variabi-le reddito sui livelli di partecipazione al pro-
9 AA.VV., I redditi 2010 dichiarati, op. cit., pp- 29-39.
334
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
gramma di prevenzione nei quartieri S. Ste-fano e Reno (rispettivamente con il rapportodi non-adesione più elevato e quello più bas-so) mostra che differenze sostanziali nellediverse fasce di reddito si mantengono. Ciòconsente di ipotizzare una sorta di “effetto
Fig. 4 - Rapporti di non-adesione per fasce di reddito
quartiere” sul livello di adesione, effetto chepotrebbe avere la sua spiegazione nella di-versa distribuzione del “capitale sociale”,maggiormente sviluppato nei quartieri concaratteristiche più “popolari” (Fig. 4).
45,1
34,3
26,229,6
43,2
28,7
14,711,7
15,3
25,6
0
10
20
30
40
50
da 0 a 7.500 da 7.501 a15.000
da 15.001 a30.000
da 30.001 a50.000
> 50.000
S. Stefano Reno
Tale effetto sembra interagire con le condi-zioni socio-economiche delle donne, e in par-ticolar modo con la tipologia familiare (“don-ne sole”). Nella fascia reddituale più bassa,ad esempio, l’indicatore del quartiere di S.Stefano cresce fino al 56,1% tra le donne cheinoltre hanno una condizione abitativa nonproprietaria10 e che vivono sole, con o senzafigli e altri conviventi. Tenendo presente,come abbiamo già visto, che qui il valore delrapporto di non-adesione complessivo è ri-sultato pari al 35,1%, si ottiene un’immagi-ne ancora più esaustiva dell’impatto che le
variabili prese in esame hanno sul grado dirispondenza all’iniziativa pubblica di preven-zione. Analoga, per certi versi, è la dinamicache si presenta nel quartiere Reno, che vedecrescere il valore della mancata adesione inmaniera ancora più consistente: tra le donnein condizioni di maggiore svantaggio socio-economico il dato della non-adesione è quasitriplicato: dal 17,7% complessivo al 49,3%(Fig. 5).
È interessante quindi notare che nei quartierimessi a confronto i livelli di non-partecipa-
10 Per un’opportuna semplificazione metodologica, in questo caso la variabile “condizione abitativa” è statadisaggregata solamente in due categorie: 1) casa di proprietà della famiglia; 2) casa in affitto pubblico o altracondizione abitativa.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
335Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
zione all’iniziativa di diagnosi precoce onco-logica tendono quasi a livellarsi nelle donnein condizioni più svantaggiate. In altri ter-mini, il divario iniziale (come abbiamo vi-sto, 35,1% vs 17,7%) si ridimensiona forte-mente attestandosi al 56,1% nel quartiere S.Stefano e al 49,3% nel quartiere Reno. Si trat-ta di un’ulteriore conferma dell’importanzache assume la condizione materiale di vita,in maniera più marcata tra le donne “sole”, edell’effetto che essa ha sui livelli di adesioneallo screening. In definitiva, si evidenzia lacoesistenza tra l’impatto dei fattori socio-economici e l’“effetto quartiere”.
Non-adesione e cittadinanza stranie-ra: un approfondimentoIn conclusione, ci sembra opportuno richia-mare l’attenzione sulle dieci nazionalità chehanno fatto registrare i valori assoluti e per-centuali di non-adesione più alti. In tal modo,si dovrebbe ottenere un’immagine più obiet-tiva della mancata partecipazione al program-
ma di prevenzione oncologica da parte dellecittadine straniere. Le donne che non si sonomai sottoposte al test di screening, prove-nienti dai dieci Paesi elencati nel grafico se-guente (fig. 6), rappresentano oltre i tre quartidella popolazione delle mai aderenti stranie-re. Considerate nell’insieme fanno registrareun rapporto di non-adesione, pari al 53,9%,che non si discosta in maniera significativadal valore complessivo di tutte le donne stra-niere. E tuttavia, disaggregando i dati persingole nazionalità (sebbene l’analisi si basisu valori assoluti alquanto limitati) è emersoche le cinesi, così come le eritree e le maroc-chine, hanno livelli di non-partecipazionedecisamente elevati, più del doppio rispettoalle donne delle nazionalità che si posiziona-no in fondo alla scala.
Al fine di attenuare l’effetto distorcente do-vuto alla limitatezza dei dati, sono state esa-minate congiuntamente le dieci nazionalità,con l’intento di valutare se, analogamente a
Fig. 5 - Rapporti di non-adesione totali e per variabili socio-economiche
25
34,7
42
51,1
35,1
45,151,1
56,1
17,7
28,7
35,1
49,3
0
10
20
30
40
50
60
Città Quartiere S. Stefano Quartiere Reno
Non-adesione totale Reddito 0-7.500 euro Reddito 0-7.500 euro e condiz. abit. non di proprietà Reddito 0-7.500 euro, condiz. abit. non di proprietà, "donne sole"
336
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
quanto riscontrato e più volte segnalato, illivello complessivo di non-partecipazioneallo screening tra le donne provenienti daquesti Paesi cresce ulteriormente in condi-zioni di svantaggio socio-economico. Pren-dendo dunque in esame le medesime varia-bili, è emerso che il valore del rapporto dinon-adesione tra le cittadine di queste diecinazionalità subisce un incremento, sebbenenon particolarmente rilevante, passando dal53,9% complessivo al 57% tra coloro chehanno un livello reddituale basso (fino a 7.500euro), una condizione abitativa non proprie-taria e una tipologia familiare svantaggiata.È stato infine calcolato il valore dell’indica-tore tra le italiane con identiche condizionisocio-economiche, riscontrando che il diva-rio iniziale tra straniere e italiane (come ab-biamo visto, 52,8% a fronte del 23,3%) siattenua in maniera significativa: se il rappor-to di non-adesione delle donne provenientidalle dieci nazionalità esaminate si attesta al57%, quello delle nate in Italia raggiunge il47,5%. In definitiva, anche in questo caso
gli aspetti indicativi del tenore generale divita risultano talmente rilevanti da ridimen-sionare la differenza iniziale relativa alla va-riabile della cittadinanza, così come quellaregistrata tra il quartiere S. Stefano e il quar-tiere Reno.
ConclusioniVolendo ricapitolare e sintetizzare gli aspettiprincipali dell’analisi, si è rilevato che:1. esiste una significativa disparità nell’acces-
so al programma di prevenzione oncologi-ca tra le donne con cittadinanza straniera ele italiane: il rapporto di non-adesione del-le prime è oltre il doppio di quello fattoregistrare dalle nate in Italia;
2. il livello di partecipazione è minore nellafascia d’età compresa tra 55 e 59 anni e, inmerito allo stato civile, tra le nubili rispet-to alle coniugate;
3. le donne con livelli di reddito bassi e quellecon una condizione economica particolar-mente agiata, per ragioni plausibilmente di-verse, fanno registrare valori di non-ade-
Fig. 6 - Rapporti di non-adesione per Paese di provenienza
89,5
72,7 72,567,3 63,9
53,9 53,647,7
43,435,8
52,8
0
20
40
60
80
100
Cina
Eritrea
Marocco
Sri Lanka
Filippine
Albania
Polonia
Ucraina
Romania
Moldavia
Totale s
tranier
e
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
337Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
sione maggiori rispetto a coloro che appar-tengono alle classi di reddito intermedie;
4. la condizione abitativa non proprietaria ela tipologia familiare svantaggiata (donnesole, con o senza figli e/o altri conviventi)accentuano l’effetto della variabile reddi-to, sia tra le nate in altri Paesi che tra leitaliane: nel loro insieme queste tre varia-bili socio-economiche fanno aumentare ilgrado di non-partecipazione allo screening;
5. si presenta una polarizzazione territorialein netta controtendenza rispetto ai livellidi sviluppo socio-economico: nelle zone enei quartieri cittadini più ricchi si regi-strano livelli di non-partecipazione mag-giori. La differenza si mantiene in tutte leclassi di reddito e ciò fa presumere la pre-senza di un “effetto quartiere” derivanteda fattori specifici delle diverse aree dellacittà. Tale influenza, peraltro, si dimostrapiù rilevante per le classi sociali interme-die: ciò presumibilmente è dovuto al fat-to che sono le cittadine residenti stabil-mente e con condizioni socio-economicheintermedie a manifestare un più alto li-vello di integrazione e di partecipazionealla vita sociale dei rispettivi quartieri, fi-nendo per condividerne la cultura e gli stilidi vita;
6. la rilevanza delle tre dimensioni rappre-sentative (nella nostra analisi) dello statussociale è tale che le diseguaglianze nell’ac-cesso allo screening presenti nei diversiquartieri tendono a livellarsi in alto. Nel-le donne con una condizione più sfavore-vole si registra, cioè, un significativo au-mento della non-adesione anche nelle re-altà territoriali più virtuose (quartiereReno) e quindi, come abbiamo visto, un
avvicinamento ai valori dei quartieri conuna più bassa partecipazione allo screening(quartiere S. Stefano). Quest’ultima dina-mica si verifica anche in riferimento allacittadinanza: nelle donne con una posizio-ne sociale svantaggiata il divario tra ita-liane e straniere tende a restringersi, conil livello di non-adesione delle prime chesi avvicina in maniera decisa a quello del-le donne nate in altri Paesi del mondo.
In sostanza, sulla partecipazione consapevo-le alle iniziative di carattere preventivo agi-scono sia i fattori socio-economici individualiche quelli “ambientali” propri della zona diresidenza. Emerge, di conseguenza, l’esigen-za di avviare azioni rivolte alle donne in si-tuazioni disagiate, ma al contempo a consi-derare anche l’opportunità di individuare in-terventi che si concentrino maggiormente suquei quartieri e zone della città in cui i livellidi non-adesione delle donne con uno statussocio-economico intermedio risultano esse-re più elevati.In conclusione, al di là dell’ambito della cit-tà di Bologna, ci sembra evidente che qualsi-asi prospettiva di ampliamento dei livelli dicopertura e dunque di miglioramento del-l’efficacia dei programmi di prevenzione ediagnosi precoce oncologica debba esserestrettamente intrecciata con la più comples-sa problematica delle disparità sociali e, inprimis, con il gigantesco tema delle «dise-guaglianze nella salute e nell’assistenza sani-taria che – come osserva Gavino Maciocco– si sono terribilmente dilatate negli ultimi20 anni, rappresentando uno dei più graviscandali del nostro tempo»11.In altri termini, se si vogliono compiere pas-si avanti in direzione dell’uguaglianza nel fon-
11 AA VV, A caro prezzo. Le diseguaglianze nella salute, 2° Rapporto dell’Osservatorio italiano sulla saluteglobale, Edizioni Ets, Pisa, 2006, p. 7.
338
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
La promozione dello screening mammografico: aspetti delle diseguaglianze nell’accesso
damentale diritto alla salute, via via semprepiù compromesso dalle turbolenze e dallecontraddizioni dei processi di globalizzazio-ne e, da qualche anno, da una lacerante crisieconomica che sta travolgendo in manieradrammatica le condizioni di vita di ampisettori della popolazione, è necessario con-trastare le disparità nell’accesso agli scree-ning. Occorre cioè focalizzare lo sguardo egli sforzi verso fasce sociali e singoli cittadi-ni che, a causa delle loro generali condizionidi disagio economico e culturale, aderisconomeno a programmi di prevenzione oncolo-gica, offerti tra l’altro gratuitamente, e chedi conseguenza non traggono beneficio dalleopportunità della diagnosi precoce, che con-sente di evitare trattamenti chirurgici taloradevastanti e spesso di salvare la vita.D’altro canto, è utile ricordare che negli ul-timi decenni, a fronte dei successi in terminidi riduzione della mortalità per neoplasia alseno, si è registrato un costante aumento dellafrequenza delle diagnosi di tumore al seno12,almeno in parte dovuto ai programmi di dia-gnosi precoce tramite lo screening. Bisognaperciò mettere in campo un supplemento diattenzione e di impegno in direzione dellapromozione dell’equità, a favore di soggettie fasce sociali maggiormente esposte alle in-temperie degli attuali scenari, allo scopo diarginare quella polarizzazione sociale che negliultimi tempi si è progressivamente accen-
tuata e che si manifesta in tutta la sua gravi-tà anche nel diritto fondamentale alla salute.Il recente richiamo (riportato nell’introdu-zione) del Piano Nazionale della Prevenzio-ne 2010-2012 ad ampliare i programmi discreening e, soprattutto, a coinvolgere i «sog-getti fragili» che non vi aderiscono, giungeevidentemente dalla consapevolezza del ri-tardo nell’applicazione di strategie di lottaalle disuguaglianze nell’accesso e dalla neces-sità di azioni coordinate volte all’inclusionedegli immigrati nei programmi di preven-zione oncologica. Tale ritardo tuttavia nondeve indurre all’inerzia: evidenze scientifichedimostrano che strategie di reclutamentoattivo (lettere, telefonate, invio di materialeinformativo...) dei soggetti appartenenti afasce sociali deboli risultano particolarmen-te efficaci per aumentare il grado di parteci-pazione13. Si tratta, in definitiva, di definiree tradurre in pratica, coerentemente con lespecificità dei rispettivi contesti, interventie programmi pubblici per innalzare i livellidi adesione di coloro che per ragioni econo-miche, sociali e culturali eludono la preven-zione. I decisori politici non dovrebbero la-sciarsi scoraggiare dal quadro generale di crisieconomica: oltre che sul piano sociale e sani-tario, gli effetti delle iniziative di contrastoe la conseguente riduzione delle disparità siripercuoterebbero positivamente anche sulpiano dello sviluppo economico.
12 Chiaradia G. et al, Il bisogno di cura nel carcinoma mammario: epidemiologia, diagnosi, stadiazione e screening,in Italian Journal of Pubblic Health, Year 7, vol. 6, Number 1, Suppl. 1, 2009, pp. 5-10.13 Giorgi Rossi P., et al., Health Technology assessment. Metodi per aumentare la partecipazione ai programmidi screening oncologici. EpidemiolPrev 2012; 36 (1) suppl 1: 1-104. Gli autori indicano una serie di possibiliiniziative per incrementare l’adesione delle fasce sociali svantaggiate e meno partecipative: ad esempio, 1)interventi mirati ai singoli soggetti, ovvero inviti e solleciti tramite lettera o telefonate a coloro che non hannoprecedentemente aderito; 2) campagne di informazione e di educazione sanitaria per la popolazione generale;3) introduzione di nuovi test di più facile esecuzione che potrebbero essere effettuati anche autonomamente;4) iniziative di formazione rivolte al personale sanitario; 5) miglioramento dell’organizzazione dell’esecuzionedei test di screening, ad esempio con la rimozione di barriere economiche e etniche tramite la presenza diprovider e l’offerta dei test con strutture mobili, e con appuntamenti flessibili.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
339Gabriele Cavazza, Aldo Trotta
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI1. Ministero della Salute, Direzione Generale della
Prevenzione (a cura di), Screening oncologici. Rac-comandazioni per la pianificazione e l’esecuzionedegli screening di popolazione per la prevenzionedel cancro della mammella, del cancro della cerviceuterina e del cancro del colon retto, Roma; 2006.
2. Dipartimento programmazione del Comune di Bo-logna (a cura di), I redditi 2010 dichiarati dallecittadine e dai cittadini di Bologna. Alcunedisuguaglianze fra generazioni, generi, nazionalitàe territori, Bologna; Novembre 2012.
3. Ministero della sanità, Centro nazionale per la pre-venzione e il controllo delle malattie infettive (acura di), Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, disponibile on line: http://www.ccm-network.it/Pnp_2010-2012
4. PASSI, Disuguaglianze sociali e salute. Rapportonazionale 2007-2009, scaricabile da sito diEpicentro, all’indirizzo http://www.epicentro.iss.it/passi/disuguaglianze07-09.asp
5. AA VV, A caro prezzo. Le diseguaglianze nellasalute, 2° Rapporto dell’Osservatorio italiano sullasalute globale. Pisa: Edizioni Ets; 2006.
6. Direzione Generale Sanità e politiche sociali Re-gione Emilia-Romagna (a cura di), I programmi discreening oncologici, report 2009, Bologna; gen-naio 2012.
7. Osservatorio nazionale screening (a cura di), I pro-grammi di screening in Italia 2011, Pavona (Roma);dicembre 2011.
8. Chiaradia G. et al., Il bisogno di cura nel carcinomamammario: epidemiologia, diagnosi, stadiazione escreening. Italian Journal of Pubblic Health 2009:7 (6), 1, Suppl. 1, 2009.
9. Istat (a cura di), Rapporto annuale 2012. La situa-zione del Paese, Rubbettino print; Soveria Mannelli(Cz); maggio 2012.
10.Giorgi Rossi P. et al., Metodi per aumentare lapartecipazione ai programmi di screening oncologici,Epidemiologia & Prevenzione 2012; suppl. 1, gen-naio-febbraio.
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 340-351
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezionisessualmente trasmissibili: la peer education inInAdolescenza-Guadagnare SalutePeer education for prevention of sexually transmitted infections: the experience of“Gaining Health in Adolescence” national programme
Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, Antonella Ermacora, GiusyFamiglietti, Claudia Ratti
Marta DottiDipartimento di culture, politica e società, Università Studi di Torino,
Mauro CroceS.S. Educazione Sanitaria, ASL VCO, Verbano Cusio Ossola
Rosanna D’AmbrosioSSD Epidemiologia, Dipartimento di Prevenzione, ASL TO 1
Antonella Ermacora, Giusy FamigliettiEclectica, Torino
Claudia RattiAssociazione Contorno Viola, Verbania
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
341Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
ObiettiviIn questo testo si presentano i risultati diun lavoro di valutazione del funzionamentodi un’esperienza di peer-education sul temadelle infezioni sessualmente trasmissibili(IST).L’esperienza è maturata all’interno del pro-gramma nazionale Guadagnare Salute InAdolescenza che, nella sua linea “sessuali-tà”, è stato attivato in: Sicilia, Marche,Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Sar-degna, Puglia, Liguria, Valle d’Aosta, Vene-to, Molise, Trentino, Calabria e Piemonteed ha visto coinvolti circa 870 peer educa-tor e circa 10.000 ragazzi come destinatari
Parole chiave: peer education, infezioni sessualmente trasmissibili, prevenzione, valutazione, adolescenti.
RIASSUNTOObiettivi: nell’articolo vengono presentati i risultati di un’attività di valutazione sviluppata nell’ambito delprogetto nazionale InAdolescenza-Guadagnare Salute sul tema delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili.Metodologia: l’attività di valutazione ha coinvolto sia gli studenti, tramite la compilazione di due questionaripre e post intervento, sia i peer educators e gli insegnanti che hanno partecipato a dei focus group.Risultati: punto di forza del progetto è stato quello di lavorare su un coinvolgimento attivo da parte di tuttii soggetti interessati: formatori, peer educators e insegnanti, in modo da sviluppare un lavoro che fosse ilpiù possibile integrato con le stesse attività scolastiche.
Keywords: peer education, sexually transmitted infections, prevention, evaluation, teenagers.
S U M M A RYObjectives: the article describes the results of the evaluation within the national project “Gaining Health inAdolescence” on the topic of Sexually Transmitted Infections.Method: the evaluation plan involved both the students, who filled two questionnaires, one before and oneafter the peer intervention in their class, and peer educators and teachers, who participated to the focusgroups.Results: the main strength of the project was the active involvement of all stakeholders: educators, peereducators and teachers, so that a work as integrated as possible with the same school activities could bedeveloped.
finali dell’attività di peer education.Il percorso sviluppato nel biennio 2010-2012 ha previsto diverse tappe, tra le qualiquella della valutazione su cui si concentraquesto articolo.A partire dall’attività di un gruppo di lavo-ro nazionale in cui si sono messi a confron-to i diversi modelli di peer education speri-mentata nel nostro paese, si è definito unoschema unico da proporre e sperimentarein tutte le realtà regionali aderenti al pro-gramma.Si è quindi proposto di sviluppare un pro-getto di peer education esportabile e legge-ro, efficace, economico e di semplice ado-
342
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ...
zione che potesse offrire a tutti i soggetticoinvolti (operatori, insegnanti e studenti)una metodologia di lavoro basata non solosu esperienze attive da anni, ma che fosseanche adottabile e adattabile in contesti dif-ferenti con una road map sperimentata eattenta alla razionalizzazione delle risorseimpiegate (1).L’impostazione metodologica prevede l’in-terazione tra adulti e ragazzi, distinguen-done nettamente i ruoli. I primi promuo-vono gli aspetti informativi e creano le con-dizioni ottimali per l’intervento dei secon-di – i peer educators – che agiscono sullasocializzazione del gruppo classe con la fi-nalità di promuovere e attivare tra i coeta-nei una riflessione, una condivisione e unacoscientizzazione intorno a questioni impor-tanti che riguardano le scelte in tema di sa-lute/rischio.La formazione dei peer educator, secondoquesta proposta metodologica, è orientatanon solo a fornire loro le conoscenze ade-guate sul tema delle IST, ma a enfatizzare illoro ruolo quali facilitatori di processi conun’attenzione sugli aspetti emotivi ed espe-rienziali.La scelta del tema da trattare quale attiva-tore dei processi di partecipazione è stataquella delle infezioni sessualmente trasmis-sibili (2).Ci sono alcuni elementi che caratterizzanoquesta esperienza e la distinguono da pro-getti simili. Per prima cosa è da sottolinea-re la dimensione nazionale del progetto, cheha permesso di applicare in quasi tutte leRegioni italiane uno stesso modello di peereducation su una stessa tematica. In secon-do luogo questo progetto è stato accompa-gnato dalla elaborazione e dall’attuazione diun piano di valutazione che ha permesso, inmodo pressoché inedito, di dare conto, al-
meno in parte, del funzionamento, sia diprocesso che di esito, della peer education.E’ possibile individuare e riassumere quelliche sono gli obiettivi generali e specifici delprogetto:Obiettivi generali- costruire una programma unitario di in-
terventi di prevenzione delle Infezioni Ses-sualmente trasmissibili rivolti agli adole-scenti su tutto il territorio nazionale;
- promuovere strategie di prevenzione e dipromozione della salute in adolescenzaefficaci e che rispondano a criteri di buo-na pratica (peer education).
Obiettivi Specifici- costituire gruppi di coordinamento o equi-
pe di lavoro a livello regionale;- favorire la partecipazione attiva dei gio-
vani nelle azioni di prevenzione delleI.S.T.;
- formare i peer sui rischi connessi all’at-tuazione di comportamenti rischiosi e fa-vorire lo sviluppo delle abilità personali;
- ideare e produrre messaggi di promozio-ne della salute con gli adolescenti;
- progettare e realizzare “iniziative tra pari”;- formare gli insegnanti;- valutare il processo e i risultati di proget-
to.
MetodiIl panorama italiano rispetto alla peer edu-cation presenta un quadro complesso, sia dalpunto di vista teorico che dal punto di vistapratico. Per questo motivo, il coordinamen-to di Guadagnare Salute In Adolescenza, haritenuto necessario costruire un quadro te-orico di riferimento cercando di definirecaratteristiche e peculiarità dei diversi mo-delli di educazione tra pari che si sono affer-mati nel tempo e che si connotano per fasioperative e metodologiche tra loro in parte
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
343Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
diverse (3).I differenti modelli (puro, misto, empowe-red) hanno trovato sede e sviluppo lungo lanostra penisola declinandosi nei territorisulla base delle caratteristiche culturali, so-ciali ed economiche dei contesti.Il gruppo di coordinamento ha raccolto lecaratteristiche dei modelli maggiormentediffusi sul territorio nazionale, analizzandoe ricercando le aree di forza e di migliora-mento delle singole esperienze, con l’obiet-tivo di proporre un programma unitario diinterventi basati sulla peer education rivol-ti agli adolescenti su tutto il territorio na-zionale.In particolare sono state analizzate le espe-rienze di alcune regioni in cui diversi dipar-timenti sanitari da anni investono nella spe-rimentazione di questa metodologia di pre-venzione.La tipologia di peer education proposta InA-dolescenza, si può considerare più vicina almodello “Social capital peer education orien-ted”, modello che lavora nell’obiettivo diattivare e sostenere un processo, un insie-me di azioni verso la generazione del lega-me sociale quale risorsa e vincolo per l’in-dividuo, per la comunità” (4). Il progettoprevedeva alcune tappe indispensabili perrendere la sperimentazione nazionale il piùuniforme possibile: la costituzione di ungruppo di coordinamento a livello territo-riale, il coinvolgimento delle scuole e degliinsegnanti, la formazione insegnanti, l’in-dividuazione dei peer educator attraverso laloro autocandidatura, la formazione dei peereducator, attraverso la metodologia e glistrumenti di didattica attiva (circa 8 incon-tri), la progettazione e realizzazione in classedell’intervento tra pari, l’intervento di “rin-
forzo” da parte dell’insegnante a seguitodell’intervento tra pari1.Pur dedicandoci in questa sede alla parte divalutazione del progetto, è importante de-finire quali sono stati gli attori coinvolti equale formazione abbiano essi ricevuto.Questo dal momento che proprio la sceltametodologica alla base del progetto ha de-finito anche la scelta dei soggetti da coin-volgere in fase di valutazione, ossia i peer,gli insegnanti e i ragazzi delle classi di rica-duta.Il progetto ha previsto, infatti, un processoformativo specifico per i peer e un coinvol-gimento attivo degli insegnanti, equilibra-to e mirato. Obiettivo del percorso era nonsolo trasferire a insegnanti e studenti le in-formazioni fondamentali sui contenuti datrasmettere, ma anche fornire ai peer edu-cator gli strumenti essenziali per la condu-zione del gruppo classe durante gli inter-venti.La formazione sul metodo è probabilmentela discriminante principale per la buona riu-scita dei processi di peer education: questacondiziona, infatti, l’acquisizione di abilitàe competenze necessarie per la gestione de-gli interventi nelle classi e la realizzazionedi uno scambio comunicativo efficace trapeer educator e studenti. Una buona forma-zione e un buon intervento nelle classi fa-voriscono l’interiorizzazione dei contenutie l’elaborazione emozionale da parte dellaclasse, in un contesto in cui i peer educatorguidano e favoriscono la discussione e ilconfronto tra pari.Seguendo questa impostazione metodolo-gica la valutazione si è concentrata su duemacro aree: il funzionamento materiale delprogetto nelle sue diverse fasi (dal recluta-
1 per maggiori informazioni http://www.inadolescenza.it/blog_sessualita/
344
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ...
mento all’intervento dei peer educators) ela sua efficacia.Ovviamente la valutazione dell’efficacia delprogetto è stata testata in modo parziale.Date le contingenze del progetto stesso (del-la durata di 2 anni), è stato possibile soloverificare la sua efficacia a breve termine esolo nel campo delle conoscenze puntualiacquisite, che non corrispondono per forzaal cambiamento dei comportamenti messiin atto.Soprattutto nel campo dell’attività sessua-le, infatti, diversi sono i fattori che entranoin gioco nel momento in cui si attuano del-le scelte e si mettono in atto comportamentispecifici, tra questi le conoscenze acquisitegiocano un ruolo spesso minimo, mentre laparte emotiva ha un ruolo preponderante.La valutazione delle conoscenze acquisiterappresenta comunque un primo elementodi possibile valutazione dell’esperienza e delsuo funzionamento.Si è ritenuto importante però, concentrarel’attenzione anche sulle dinamiche più or-ganizzative e di funzionamento pratico delprogetto (come esso si sia inserito nella scuo-la, le criticità e i punti di forza rilevati dastudenti e docenti) poiché questo è stato ri-tenuto un elemento fondamentale anche intermini di efficacia del progetto.Le dinamiche organizzative costituiscono,infatti, un elemento che può essere di gran-de forza o di grande debolezza nel garantireun’effettiva efficacia di un progetto di que-sto tipo. I contenuti, anche se perfettamen-te costruiti, hanno bisogno di essere tra-smessi e di essere contestualmente accolti eaccettati, e questo è possibile solo se l’in-tervento è costruito anche in modo mate-rialmente funzionale al contesto (in questocaso quello scolastico).Valore aggiunto di questa valutazione è il
fatto che essa presenta uno spaccato inte-ressante di quello che è il profilo delle co-noscenze (in generale) degli adolescenti ita-liani sia sulle IST sia sul funzionamento deiservizi pubblici a loro dedicati come adesempio il consultorio, aggiungendo un pic-colo tassello alla nostra conoscenza di que-sto mondo.
StrumentiGli strumenti utilizzati per valutare il pro-getto in tutti i suoi vari aspetti sono statidiversi. In questo articolo ci soffermeremoin particolare sulla valutazione che i desti-natari intermedi e finali hanno dato del-l’esperienza, per fare questo faremo riferi-mento a due degli strumenti utilizzati: iquestionari, che sono stati somministrati airagazzi delle classi in cui venivano effettua-ti gli interventi (un questionario ex-antesomministrato qualche giorno prima del-l’intervento dei peer e un questionario ex-post nei giorni successivi) e dei focus groupcon gli insegnanti e con i peer educators chehanno realizzato il progetto.I questionari pre intervento pervenuti e ana-lizzati sono 4637, mentre quelli post sono4151 (non tutte le regioni che hanno parte-cipato alla valutazione sono riuscite a man-dare in tempo i database relativi a tutti iquestionari).Sono stati effettuati 27 focus group con in-segnanti e peer educators di 6 regioni ita-liane (Piemonte, Veneto, Val d’Aosta, Emi-lia Romagna, Campania e Abruzzo).
RisultatiNella tab.1 è possibile avere un quadro d’in-sieme del campione che ha compilato i que-stionari pre e post.Considerando i dati in termini assoluti (siapre che post intervento), emerge come l’au-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
345Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
mentare dell’età, anche se si tratta di 2-3anni, fa la differenza per ciò che riguarda laconoscenza dei servizi, la consapevolezza cheanche il primo rapporto può determinareuna gravidanza e che il coito interrotto nonprotegge dalle IST.Tutte queste conoscenze aumentano infattinotevolmente passando dai 15 ai 16 e con ilsuperamento dei 17 anni.La stessa variabile sembra invece avere mi-nor peso quando si affronta il tema dellatrasmissione delle IST: il bacio per la tra-smissione dell’HIV o l’uso protettivo delpreservativo.Va, inoltre, considerata la percentuale dicoloro che risponde “non so”, percentualeche, in alcuni casi, come ad esempio la “pro-tezione del coito interrotto” nella trasmis-sione delle IST, raggiunge il 50%; così comeraggiunge il 25% per la domanda se sia ne-cessario il consenso dei genitori per la pre-scrizione della pillola contraccettiva a unaminorenne. Se, come nella “trasmissionedell’HIV con il bacio”, sommiamo “vero”e “non so”, si raggiunge una percentuale pari
al 30%.Come appare chiaro dai grafici presentati(grafici 1 e 2), le conoscenze specifiche sullepatologie che si possono contrarre con i rap-porti sessuali e le conoscenze sui metodicontraccettivi sono un mondo per buonaparte sconosciuto e questo diventa perico-loso per persone che hanno di sé la perce-zione di essere adulti, tanto da poter avereuna vita sessualmente attiva.Questi dati sembrano confermare la sceltadi intervenire nelle seconde classi delle scuo-le secondarie di secondo grado, è una buonascelta perché le conoscenze di base sono piut-tosto scarse e, poiché tra i 15 e i 16 annimolti adolescenti hanno le loro prime espe-rienze sessuali, un’informazione correttasulle patologie, sulle modalità di trasmis-sione, ma anche su ciò che i servizi territo-riali possono offrire, diventa un supportoimportante per vivere la propria sessualitàin modo sereno e sicuro.Concentrandosi invece sull’effetto dell’inter-vento dei peer possiamo fare alcune consi-derazioni, e in particolare: dai grafici (gra-fici 1 e 2) emerge come le conoscenze au-mentano, in particolare per quanto riguar-da le malattie, più particolare la situazionerispetto ai metodi anticoncezionali che ve-dono invece diminuire il numero di perso-ne che cita quelli più “classici” (condom epillola) laddove invece crescono anello, ce-rotto e spirale. Tendenza questa che potreb-be essere spiegata con una generale predi-sposizione a nominare nel questionario soloi metodi “nuovi” di cui si era venuto a co-noscenza nel corso dell’intervento dei peer.Anche per quanto riguarda le altre cono-scenze considerate, pur potendo notare an-cora una differenza per età, la percentualedi conoscenza del consultorio passa dal 48al l’80%, così come aumenta di 10 punti
Tabella 1- Descrizione del campione pre e post inter-vento
Tipo scuola PRE POST Istituto professionale 22,1 23,8 Istituto tecnico 25,8 23,7 Liceo 52,1 52,5 Età 15 anni 36,7 54,5 16 anni 43,2 31,2 17 anni 15,9 10,3 Più di 17 anni 4,2 4,0 Sesso Maschi 56,9 57,0 Femmine 43,1 43,0
346
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ...
3910
2958
470 340 189399
1546
2035
919744 649 604
109487
47
1227
3045
2000
0500
10001500200025003000350040004500
CondomPillo
la
Anello IUD
Cerotto
Coito In
terro
tto
Pillola del g
iorno dopo
Diaframma
Meto
di Natu
rali
pre
post
186
1404
255
1102
3756
897 896
1380
818 792
415 501
115 57 1071868
241290547455409
1749
1090
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
HIVAID
S
EPATITE
HERPES
SIFILI
DE
GONORREA
CLAM
IDIA
CANDIDA
CONDILOM
IHPV
MONONUCLE
OSI
INFE
ZIONI
TBC
pre
post
Grafico 1 - Malattie conosciute pre e post intervento
Grafico 2 - Metodi anticoncezionali conosciuti pre e post intervento
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
347Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
percentuali, raggiungendo il 90-92% in ognifascia di età considerata, la risposta “vero”alla domanda se “la gravidanza si può veri-ficare al primo rapporto sessuale”. La per-centuale di chi dichiara che il preservativoè il modo per proteggersi dalle IST sale dal50 al 65%; sale poi di 30 punti percentuali,dal 36 al 66% la risposta “vero” all’affer-mazione che “il coito interrotto non pro-tegge dalle IST”.Del 15% aumenta il numero di chi sa che ilpreservativo ha una data di scadenza e un20% in più dichiara che per andare dal gi-necologo del consultorio non è necessarial’impegnativa del MMG.Volendo fare un confronto tra maschi e fem-mine rispetto ai temi sopra discussi, pur seentrambi i generi mostrano un aumentodelle percentuali nelle risposte corrette e ingenerale quindi un aumento della conoscenzadel tema a seguito dell’intervento, per leragazze lo scarto tra i questionari pre e postè maggiore.Per quanto concerne il gradimento dell’espe-
rienza (grafici 3 e 4) i risultati sembranoessere positivi: soltanto l’8% ha trovato pocoutile l’intervento dei peer, il 32% abbastan-za utile, mentre il 40% lo giudica moltoutile e il restante 20% utilissimo.Su quanto sia stato interessante il 19% loritiene poco interessante, il 27% abbastan-za, il 34% molto e il 19 moltissimo, con-fermando un apprezzamento da parte deidestinatari finali dell’esperienza.Volendo valutare però l’esperienza nel suocomplesso, è necessario integrare i dati re-lativi al gradimento con quanto emerge daifocus group.Sia i peer educators, sia gli insegnanti con-cordano nel valutare positivamente l’utiliz-zo della peer education applicata a un pro-getto di prevenzione delle Infezioni sessual-mente trasmissibili. In generale viene at-tribuita alla comunicazione tra pari una ca-pacità maggiore di raccogliere l’attenzionedei ragazzi e di una maggiore efficacia delmessaggio. Nelle classi dove è stato effet-tuato l’intervento tra pari, nonostante alcu-
Grafico 3 - Gradimento dell’intervento: Hai trovato l’intervento utile?
348
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ...
ne eccezioni, la risposta è sempre stata po-sitiva ed è stato riportato un buon livello diinteresse sia nei confronti dell’iniziativa ingenerale, sia rispetto al tema trattato, siarispetto all’efficacia dei peer.La parola chiave per descrivere le dinami-che di diffusione e recepimento delle infor-mazioni tra gli adolescenti pare essere “pas-saparola”. La principale fonte di informa-zione degli adolescenti rispetto alle IST èdata dalla comunicazioni con il gruppo dipari e la possibilità che i peer hanno di inse-rirsi in questo flusso informativo informalefa sì che il tipo di comunicazione da loroavviata sia particolarmente efficace. Anchese non mancano espressioni in favore dellapresenza, a latere dell’intervento dei peer,di una voce “esperta”, che deve essere ne-cessariamente quella di un adulto (insegnan-te/esperto).Dal punto di vista dell’organizzazione pra-tica del progetto, non mancano alcune vocicritiche, in generale si considera positiva lariuscita dello stesso, ma vengono spesso fattiemergere elementi di disorganizzazione,
spesso attribuiti alle tempistiche o all’orga-nizzazione scolastica, ma ugualmente spes-so considerati parte integrante della dimen-sione di sperimentazione del progetto.I ragazzi stessi, sono i primi a considerarela novità del progetto un elemento di pos-sibile criticità. In alcuni casi attribuisconoalcune delle difficoltà incontrate nel corsodello sviluppo del progetto, al fatto di ave-re preso parte a un’esperienza pilota nellascuola di appartenenza, il cui funzionamen-to e la cui efficacia necessitano di tempoper poter essere riconosciute e quindi ac-cettate in un mondo così complesso comequello scolastico.Quello che emerge come elemento fonda-mentale per la buona riuscita del lavoro al-l’interno della scuola, è la possibilità di fareriferimento a un sostegno da parte della di-rigenza. Si tratta di un elemento che è sicu-ramente stato enfatizzato in modo partico-lare dagli insegnanti, ma rispetto al qualeanche i ragazzi dimostrano di avere svilup-pato una particolare sensibilità.Spesso la mancanza di sostegno e di parte-
Grafico 4 - Interesse per l’intervento: Hai trovato l’intervento interessante?
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
349Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
cipazione da parte della dirigenza viene at-tribuita a scarsa conoscenza del metodo edu-cativo e dunque si tende a esprimere unmoderato ottimismo rispetto alle possibi-lità che tale esperienza possa avere un esitomigliore nelle edizioni successive, una vol-ta che ne sia stato riconosciuto il valore eche siano di conseguenza stati eliminati al-cuni pregiudizi e resistenze.Un tema molto discusso è stato quello del-l’età considerata la migliore per trattare iltema della “sessualità”, in generale racco-glie più consenso la posizione che vorrebbeun intervento anticipato, rivolto quindi aragazzi di prima, se non addirittura all’ulti-mo anno delle scuole medie. In questo casosarebbe da valutare l’approccio migliore peril target in questione considerando le carat-teristiche specifiche dell’età e dell’argomen-to trattato.Non mancano comunque le voci di chi pensache i ragazzi in seconda non siano ancorapronti per affrontare un discorso legato allasessualità o che comunque sarebbe meglioestendere l’intervento anche alle classi deiragazzi più grandi.Il tema dell’età più opportuna per affronta-re il tema delle IST (e di tutti quegli aspettidella vita a esso correlati) è di certo emersocome il più controverso, il rapido evolversidelle abitudini, la delicatezza e l’importan-za del tema impongono un’attenzione par-ticolare, ma l’accoglienza che il progetto haricevuto in termini di gradimento generaledell’esperienza ci porta a pensare che in ognicaso l’azione sviluppata abbia avuto la suautilità.La variabile che emerge come determinan-te all’interno di questo discorso è quella delgenere, in particolare da parte degli inse-gnanti, ma a volte anche durante gli incon-tri con i peer, si sottolinea con forza la di-
versità che intercorre tra ragazzi e ragazzeper quanto riguarda lo sviluppo sia fisicoche mentale in questo fase della vita.Per quanto riguarda la percezione circa leconoscenze diffuse e i comportamenti mes-si in pratica dagli adolescenti rispetto allasalute sessuale, il quadro che viene presen-tato descrive degli adolescenti che non sonoa conoscenza di molti degli aspetti fonda-mentali legati alla salute sessuale.L’opinione raccolta nei focus group è infatticoncorde nel dichiarare che i ragazzi sonoscarsamente informati sulle infezioni ses-sualmente trasmissibili, sia per quanto ri-guarda la loro esistenza e diffusione, sia suimeccanismi di contagio, sia sulle possibilistrategie di diagnosi e terapia.Non solo gli insegnanti, ma anche i peersono piuttosto scettici quando si tratta diriflettere sugli effetti concreti che il pro-getto potrebbe avere, soprattutto per quan-to riguarda i comportamenti.Se, come abbiamo già detto, il fatto di uti-lizzare i peer consente effettivamente di rac-cogliere una maggiore attenzione e dunquedi aumentare il livello della conoscenza,resta evidente per tutti che l’intervento trapari, soprattutto se unica azione sul tema,non si traduce necessariamente in compor-tamenti più responsabili.In particolare sono diffuse tra i peer educa-tors considerazioni che attribuiscono le scel-te dei comportamenti da adottare nel cam-po sessuale (ma non solo) più al carattere,all’indole personale e all’influenza del grup-po di pari, che non alle conoscenze.Quello che appare invece essere un giudizioincontrovertibilmente positivo è quello re-lativo all’efficacia del progetto sui peer edu-cators.Gli insegnanti in particolare sono assoluta-mente concordi nel giudicare molto positi-
350
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Un progetto nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ...
vo l’effetto che la partecipazione al proget-to ha avuto sui ragazzi che vi sono stati coin-volti in prima persona. Questo giudizio vieneespresso per quanto riguarda diversi aspettidella vita dei ragazzi e non si limita a con-siderare le loro conoscenze e le loro attitu-dini nel campo della salute sessuale. In ge-nerale gli insegnanti descrivono la parteci-pazione ai gruppi di peer education comeun elemento importante per favorire tuttoil processo di crescita e di responsabilizza-zione dei ragazzi che vi prendono parte, egli effetti di tale processo si riverberanonecessariamente su tutti gli aspetti della lorovita, in alcuni casi anche al miglioramentodel comportamento scolastico.
ConclusioniSe lavorare in rete è un “valore aggiunto”,certamente i tre anni di lavoro che abbia-mo alle spalle sono stati, per noi del gruppodi coordinamento, ma anche per tutti quel-li che hanno partecipato al progetto, annifaticosi ma molto ricchi di conoscenze, re-lazioni, risultati.Ognuno di noi è stato portatore di un pezzodi conoscenza e di esperienza che, cosa nonsempre facile, siamo riusciti a rendere pa-trimonio comune: oggi siamo in grado diparlare uno stesso linguaggio e di avere ri-ferimenti metodologici e culturali condivi-si. Chi ha partecipato a questo percorso hasaputo mediare tra le sue posizioni e quelledegli altri, tra le esigenze del proprio terri-torio e la possibilità di adattare le azioni aun quadro di riferimento nazionale. Proba-bilmente ciascuno ha dovuto fare qualchepasso indietro, ma tutti insieme abbiamofatto molti passi avanti.
La rete di relazioni che si è creata in questotempo ci fa orientare molto meglio nelmondo non sempre ben definito della “pro-mozione della salute” e questo vale non sol-tanto per la linea d’azione della “Prevenzio-ne delle IST” ma per tutti i progetti pro-mossi da “Guadagnare salute InAdolescen-za”. Per la prima volta in Italia è stato pos-sibile conoscere e far propri i progetti dieccellenza che in più campi sono stati svi-luppati da alcuni gruppi di lavoro in variluoghi del territorio nazionale. Lo sforzo acui tutti, anche se in misura diversa e condiversi ruoli, hanno partecipato è stato quel-lo di rendere esportabili questi progetti fa-cendone quindi un “programma nazionale”.I risultati sono stati molti: dalla condivi-sione delle metodologie alla realizzazionedi momenti formativi per operatori, dallaconduzione dei progetti locali alla valuta-zione. Forse, anche se può sembrare troppoottimistico, possiamo cominciare a parlaredi un “linguaggio comune” nel campo dellapromozione degli stili di vita sani tra gliadolescenti.Una buona prova del raggiungimento diquest’ultimo risultato è riscontrabile nelfatto che, nonostante nel frattempo il pro-gramma “Guadagnare Salute negli Adole-scenti” si sia concluso, sono numerose lerealtà in cui si è deciso di continuare a por-tare avanti il lavoro iniziato. In molte scuoledi diverse regioni, si è lavorato perché ilprogetto venisse inserito nell’attività scola-stica, per fare tesoro di quanto imparato econdiviso e per capitalizzare un capitaleumano e sociale notevole sviluppatosi neltempo.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
351Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, et alii
BIBLIOGRAFIA
1. Antonietti V, Croce M. From Peer Education toPeer Development. A Critical Analysis of 10years of Peer Education, European Journal ofSchool Psychology 2007; 3 (2):293-316.
2. Croce M, Cristini F, Gnemmi A, Scacchi L., Peereducation e prevenzione dell’Aids: più responsa-bilità verso la propria salute. Psicologia di Co-munità 2010;IV: 99-112.
3. Pellai A, Rinaldin C, Tamborini E. Educazionetra pari. Manuale teorico-pratico di empoweredpeer education. Trento: Centro Studi Erickson;2002.
4. Croce M.,Vassura M.l puer digitalis e il senexeducandi”, In (a cura di) Ottolini G., Verso unapeer education 2.0. Animazione Sociale/Supple-menti, 2011:19-29.
Sistema Salute, 58, 1, 2014: pp. 352
RECENSIONI
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Stefano Orazi (a cura), Angelo Celli. Nasci-ta di una scienza della politica sanitaria, Sa-pienza Università editrice, Roma 2014, pp.163, euro 20,00.
A vent’anni della prima volta, Stefano Orazi, Auto-re di una bella biografia (edita da Bulzoni per contodella Fondazione Angelo Celli per una cultura dellasalute creata da Seppilli in onore del grande scienzia-to di Cagli) ha curato l’edizione di un nuovo volumesu Angelo Celli, per la collana Maestri della Sapien-za, pubblicato dall’ateneo romano.Questo nuovo volume è in qualche modo il prose-guimento dell’altro, rappresentando un importanteapprofondimento della vita del Celli scienziato, poli-tico, educatore, marito affettuoso, realizzato da di-versi autori che analizzano veri momenti ed aspettinell’ attività di professore nell’Ateneo romano. Met-tendo in maggiore evidenza elementi non semprenoti della sua vita ed evidenziando ancora meglio legrandi doti e le importanti realizzazioni.Ma il libro va ben oltre, approfondendo molti aspettidella vita dell’intero periodo che vide il Celli profes-sore a Roma, mettendo in evidenza la grande intel-ligenza e volontà in altri campi, oltre quello accade-mico. La prima parte affronta l’aspetto centrale dellavita di professore, la sua grande importanza nell’ in-trodurre scientificità sperimentale nell’istituto di igie-ne a Roma e la dura lotta fattagli dai colleghi dellascuola romana di malariologia, la contemporaneaazione di parlamentare con quella di professore.
Ma poi viene fuori un ritratto a tutto campo chemostra un Celli enciclopedico, versato in molti altricampi, nell’editoria e nell’arte. Che rafforza, anche seforse era già abbastanza noto, l’ importante contri-buto al benessere delle popolazioni, dei lavoratori,oltre quello della lotta antimalarica, evidenziandoallora, come ancor oggi, il ruolo negativo degli inte-ressi commerciali ed economici, delle lotte di potererispetto al bene comune della salute di tutti.Un capitolo importante è quello dedicato alla mogliedi Celli, Anna Fraentzel, alla quale riconosce l’ampiomerito di essere stata si una collaboratrice assidua delmarito ma anche portatrice di un suo importantecontributo, accanto al grande impegno nel sociale,assieme ad altre donne importanti, anche dopo lascomparsa del marito. In quegli anni in cui il ruolodella donna veniva ricondotto a quello di sposa emadre, semplice procreatrice custode del focolare,attorno alla Fraentzel operava a Roma un gruppo diantesignane, portatrici di valori e significati moder-nissimi sul ruolo della donna nella società.Insomma una bella lettura, illustrata da una riccaiconografia, che riporta all’attenzione non solo il gran-de scienziato ma soprattutto un modo di fare scienzae cultura, impegno politico e sociale di cui si avverteun indispensabile bisogno.Il volume è stato presentato a Perugia in occasionedella Mostra dedicata ai sessanta anni del Centro Spe-rimentale per la Promozione della Salute e l’Educa-zione Sanitaria.
Lamberto Briziarelli
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 353-356
SCHEDE
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Aime M., Etnografia del quotidiano. Unosguardo antropologico sull‘Italia che cambia,Elèuthera, 2014, pp.190, euro 15,00.
Seguendo la strada di alcuni altri antropologi cultu-rali, l’autore esce dai tradizionali schemi della ricercaantropologica e dopo una lunga storia di studi sullastregoneria, di ampio girovagare per il mondo, siavventura ad esplorare il suo paese natale, per “co-mune decenza”, come egli stesso dice nell’introdu-zione; per portare un “piccolo e modesto apportoalla comprensione della società in cui si vive quoti-dianamente”. E lo fa studiando diversi contesti dallaparata del 2 giugno al doppio binario (nel sensostretto del termine) delle ferrovie italiane, dalla sto-ria della TAV alla limitazione della responsabilità,all’apparire di nuovi tribalismi, ai fenomeni di san-guinario terrorismo tra machete e smartphone, adun’analisi dei mercati finanziari paragonati a vere eproprie stregonerie; completa il quadro un capitoloche prende spunto dalla distruzione dei Budda daparte dei talebani, per un ragionamento sul significa-to dell’arte, il suo rapporto con gli umani, il ruolo delmezzi di comunicazione di massa. Uscendo dal ruoloastratto del ricercatore-osservatore asettico, entra nelvivo del sociale, si sporca le mani in maniera moltoimpegnata, dandoci una visione originale della no-stra odierna società, rifiutando tutti gli stereotipi chei mezzi di comunicazione di massa ci propinano.Certo molte delle sue posizioni possono non esserecondivise ma senza dubbio egli porta un contributonotevole nel senso appena detto. Demistificando luo-ghi comuni, facili esemplificazioni, immagini acco-
modate per soddisfare il grosso pubblico. E in talmodo denuncia il calo della democrazia ed il suosnaturamento, l’aumentare della distanza tra le clas-si, tutto quello che non c’è e ci dovrebbe essere percreare responsabilità. Durissimo il giudizio sui partitie gruppi politici, responsabili della presenza di un“nuovo tribalismo”.Ogni capitolo è accompagnato da ricche notebibliografiche, che ben documentano i suoi ragiona-menti.Lo consigliamo vivamente ai nostri lettori, non soloperché tocca temi caldi, trattati spesso in questa no-stra rivista e segna indirizzi da noi condivisi ma so-prattutto perché egli si impegna nel tracciare i linea-menti di una sorta di antropologia politica, alla quale– questo egli non lo dice – dovrebbero probabilmen-te dedicare maggiore attenzione tutti gli studiosi deifenomeni sociali, a cominciare dagli antropologi.Anche se spesso sembra parlare soprattutto ai politi-ci, ai reggitori.
L.B.
Ferruccio Giacanelli, Nascita del movimentoantimanicomiale umbro, Fondazione Angelo Celliper una Cultura della Salute, Perugia, 2014, pp. 238(SMAS, Studi e Materiali di Antropologia della Sa-lute - Quaderni della Fondazione Angelo Celli), euro10,00.
Nella nuova collana SMAS è uscito il primo volumedi Per una storia della riforma psichiatria in Umbria:
354
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Schede
un’eccellente ricostruzione, dall’interno, di come sisviluppò il grosso movimento dell’antipsichiatriaumbra, per la voce di uno che vi partecipò in primapersona. L’editing è stato curato da Carla Nocentini,Francesco Scotti e Tullio Seppilli.Ferruccio Giacanelli, con una prosa di facile e bellalettura, con il suo stile di persona gentile e bene edu-cata quale l’ho conosciuto ed apprezzato, ripercorrel’intero cammino sin dai suoi primordi, essendonestato uno degli artifici dai primi anni sessanta ad oltreil 1970, quando si trasferì a Parma, chiamato a diri-gere l’ospedale psichiatrico di quella provincia.Senza indulgere in esaltazioni agiografiche o affer-mazioni estremizzanti, come è spesso avvenuto daparte di molti che hanno parlato su quei tempi e suimovimenti che hanno prodotto grandi trasforma-zioni nel nostro paese, descrive con grande maestriala complessità dell’azione condotta in Umbria, la suaspecificità ed originalità anche rispetto alla primigeniaimpostazione basagliana, cui comunque i riformato-ri umbri si ispirarono e furono molto vicini, anchecon frequentazioni personali dello psichiatra che ope-rava a Gorizia. Descrive senza apologismi il granderuolo dei soggetti che ne furono principali responsa-bili, in primis Rasimelli e Sediari e con altrettantaprecisione, senza acrimonia, le pregresse condizionidi direzione e di lavoro dell’ospedale psichiatricoperugino, contro cui si levò la giusta ribellione.Viene messa in evidenza con molto chiarezza lacoralità che a Perugia si creò attorno al movimentodei medici e degli altri operatori del manicomio, inparticolare l’azione dei politici dell’Amministrazio-ne provinciale ma anche il supporto di quasi tutta lacomunità, con veramente poche opposizioni, tra cuisi sottolinea quella dei parenti e delle famiglie, evi-dente residuo della mentalità emarginatoria dei ma-lati che disturbavano la quiete domestica o che impe-divano il realizzarsi di altri progetti.Insomma un’ importante rilettura di qui tempi, mol-to opportuna per quelli che corriamo, a segnalare lanecessità di ritrovare momenti di confronto e di uni-tario sentire per risolvere i problemi altrettanto graviche affliggono non solo la sanità ma l’intero com-plesso sociale.
Peccato che l’analisi di Giacanelli si arresti alla metàdegli anni settanta, perché sarebbe stato bello cono-scere il suo giudizio sul seguito della riforma e sugliulteriori sviluppi della psichiatria umbra, di cui sipossono avere alcune piccole osservazioni in scrittirecenti che vengono molto opportunamenteriproposti in una ricca appendice, che rende onore aicuratori non solo per la completezza ma per l’onestaintellettuale così dimostrata.
L.B.
AA.VV., Global Health Watch 4 Un rapporto alter-nativo sulla salute nel mondo, London, Zed Books2014.
Il Global Health Watch (GHW) è ampiamente rico-nosciuto come la voce più autorevole per un discorsoalternativo sulla salute. Il rapporto integra analisi ri-gorose, proposte alternative e storie di lotte e cam-biamento, presentando argomentazioni per agire peruna trasformazione radicale del modo in cui affron-tiamo le azioni e le politiche in salute. Il GHW èpensato per mettere in discussione le attuali politichee proporre alternative.Pubblicato da Zed Books, il GHW4 è un lavorocollettivo di attivisti e accademici di tutto il mondoed è stato coordinato da: People’s Health Movement,Asociacion Latino-americana de Medicina Social,Health Action International, Third World Networke Medact.Un appello a movimenti, organizzazioni della socie-tà civile e a tutte le persone impegnate per il dirittoalla salute affinché diffondano le evidenze e le analisipresenti nel GHW4, valutando anche la possibilitàdi organizzare presentazioni a livello locale.
ContenutiSezione A: L’architettura politico-economica globaleCrisi sanitarie della globalizzazione neoliberista –Politiche fiscali in Europa – Lotte sociali in AmericaLatina – Dopo la Primavera Araba.Sezione B: Sistemi sanitari, sfide e dibattiti attuali
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
355Lamberto Briziarelli, Riccardo Casadei, Edvige Mancinelli
Copertura sanitaria universale: casi di studio da Re-gno Unito, Messico, Brasile, Sudafrica e Tunisia –Ritorno degli operatori sanitari di comunità – Crisidella salute materna e riproduttiva – Crisi della forzalavoro in salute globale – Dispositivi medici nelmercato globale.Sezione C: Oltre l’assistenza sanitariaProtezione sociale – Malattie non trasmissibili –Nutrizione e sovranità alimentare – Violenza di ge-nere – Igiene ambientale su base comunitaria – In-dustrie estrattive.Sezione D: OsservatorioRiforma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità– ONG nell’erogazione di servizi – Influenza delsettore privato sulle politiche di sanità pubblica –Accordi TRIPS – Epidemia di colera ad Haiti – Ini-ziativa dell’International Finance Corporation sullasalute in Africa – Trial clinici offshore.Sezione E: Resistenza, azioni e cambiamentoCambiamenti sociali e salute in Bolivia, El Salvadore Venezuela – Colombia e Perù: resistenza alle rifor-me neoliberiste – Lotte per la salute in Europa –Miniere distruttive in Grecia – Campagna per il di-ritto al cibo in India – Australia: servizi sanitari con-trollati dalle comunità aborigene.Per saperne di più o visionare i precedenti Rapportivisitare il sito www.ghwatch.org o scrivere [email protected] acquistare il GHW4 visitare: http://zedbooks.co.uk/node/1 7814 oppurewww.ghwatch.org/ghw4
R.C.
Leandro Z. A., Teresa F. et al., SkeletalMuscle PGC-1á1 Modulates Kynurenine Me-tabolism and Mediates Resilience to Stress-In-duced Depression, Cell, Volume 159, Issue1, pp. 33-45, 25 september 2014
Come l’attività fisica protegge dalla depressione. Eccola scoperta di un gruppo di ricercatori svedesi in me-rito ad uno dei meccanismi fondamentali attraverso
i quali l’esercizio corporeo costituisce un fattore pro-tettivo – se non addirittura assurge alla dignità dielemento terapeutico- nei confronti della depressio-ne da stress. Stante la pandemia dei disturbi psichia-trici a livello planetario e della depressione in primis,molto resta da chiarire, a livello neurobiologico, cir-ca la loro patogenesi. Ebbene, il presente studio neha individuato un tassello fondamentale relativamentealla depressione rilevando come l’esercizio fisico in-crementi, da parte del muscolo scheletrico, la produ-zione di PGC-1á1, una proteina capace di ampliarela produzione di aminotransferasi chinurenina, enzimaa sua volta responsabile della conversione dellachinurenina in acido chinurenico. Ora la chinurenina,catabolita del triptofano, aumenta in varie condi-zioni (gravidanza, infezioni, neoplasie etc) stress com-preso e agisce a diversi livelli, dal sistema immunitario(ad es. a detrimento dell’attività delle cellule NK) aquello nervoso dove, attraversando la barriera emato-encefalica, entrerebbe nell’eziologia della depressio-ne. Ebbene, la sua trasformazione in acidochinurenico, incapace di superare la barriera emato-encefalica stessa, arresta il processo. Ecco come unmuscolo attivo, con meccanismo indiretto, filtra so-stanze neurotossiche e blocca processi depressogeni.Le case farmaceutiche già si stanno attivando perrinvenire un principio attivo antidepressivo ad azio-ne muscolare piuttosto che neuronale laddove, per lasanità pubblica, gli esiti di un simile lavoro rappre-sentano un ulteriore passo in avanti nella confermadel portato degli stili di vita sani nella promozionedella salute mentale.
E.M.
Ammerman S., Marijuana, Adolesc MedState Art Rev. 2014 Apr;25(1):70-88Battistella G, Fornari E, Annoni JM et al.,Long-term effects of cannabis on brain struc-ture, Neuropsychopharmacology, 2014Aug; 39(9)
Due studi focalizzati sulle conseguenze biomediche
356
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Schede
Le schede sono state redatte da:Lamberto Briziarelli, Riccardo Casadei,
Edvige Mancinelli
e psicosociali dell’uso voluttuario di marijuana conparticolare riguardo all’età evolutiva.Il primo affronta la questione sottolineando come,per il mondo scientifico, l’abuso di cannabis in epocapediatrica costituisca una preoccupazione costantedate le ricadute fisiche, psicologiche, cognitive e glialtri effetti collaterali presenti e futuri del fenomeno.Si ribadisce peraltro come le alterazioni su sviluppo,struttura e funzioni cerebrali si estrinsechino conmodalità a tutt’oggi non del tutto chiarite e si pro-spettano possibili strategie per la soluzione del pro-blema. Da segnalare, nondimeno, che, degli effettimarginalizzanti da fumo quotidiano di marijuanaprima dei 17 anni, si è occupata una metanalisi, pub-blicata in The Lancet Psychiatry nel 2014, operata sutre studi longitudinali che hanno arruolato più di3.700 persone. Metanalisi che, dopo aver incrociatola frequenza d’uso di cannabis in adolescenza con ibassi valori di sette parametri evolutivi fino all’età di30 anni – abbandono scolastico, mancatoottenimento di una laurea, frequenza di depressione,rischio di tentato suicidio, di abuso di sostanze illeci-te e grado di dipendenza dall’assistenza sociosanitarianazionale- previa eliminazione di fattori confondentiquali stato socio-economico e presenza di malattiementali, giunge alla positività dell’associazione.Il secondo lavoro menzionato analizza le modificazioniorganiche cerebrali indotte da esposizione cronica alla
cannabis premettendo che i risultati dei vari studisinora condotti sulla neuro-tossicità dose-dipendentedel principale componente psicoattivo della cannabisa carico di regioni cerebrali ricche di recettori CB1dei cannabinoidi sono contraddittori. Lo studioosservazionale selezionato indaga le alterazioni dellasostanza grigia in un gruppo di fumatori regolari dimarijuana vs un gruppo di fumatori occasionali appa-iati per gli anni di consumo di cannabis giungendo allaconclusione che l’uso regolare di marijuana si associa ariduzione del volume della materia grigia in alcunearee (corteccia temporale mediale, polo temporale,giro paraippocampale, insula e corteccia orbitofrontale)ricche di recettori cannabinoidi CB1 e funzionalmenteconnesse all’elaborazione motivazionale, emozionaleed affettiva. Modificazioni inoltre correlate alla fre-quenza del consumo nei 3 mesi precedenti l’inclusio-ne nello studio e, dato saliente per i professionistidella promozione della salute, all’età di esordio delricorso alla droga, elemento che influenza altresìl’estensione di simili alterazioni.
E.M.
DOCUMENTI
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 357-366
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Oltre la crisi sistemica del Servizio Sanitario Nazionale:immaginare il futuro
a cura di Fulvio Forino, presidente di Dedalo 97
Presentazione Questo documento nasce dalla rielaborazionedi una serie di laboratori promossi dall’Associazio-ne Dedalo 97 che si sono conclusi con unaConsensus Conference tenuta a Roma il 7 giugno2014 che ha messo in evidenza la solitudineprofessionale che, avvertita dai partecipanti come difficoltà a “lavorare insieme”, rispecchia ladifficoltà esistente nel Servizio Sanitario Nazionale(SSN) a “fare sistema”. Propone una letturasistemica di queste difficoltà e alcuni suggerimentitesi ad attivare delle dinamiche che favoriscanoun’evoluzione in senso sistemico del nostro SSNche si vuole rimanga uno dei migliori al mondo. Hanno partecipato alla Consensus Conference, inqualità di relatori o moderatori dei lavori: FrancoBifulco, Roberto Corsi, Rosanna Di Natale, FulvioForino, Pasquale Granata, Stefano Fortinguerra,Mauro Goletti, Stefano Ivis, Maurizio Musolino,Stefano Pompili, Stefano Tardivo, GianfrancoTarsitani.
Un approccio sistemicoLe organizzazioni sanitarie sono sistemi complessiL’idea centrale dell’approccio sistemico è che, anchein sanità, la rete sia la configurazione di base comunea tutte le organizzazioni siano esse un’équipe,un’azienda o un servizio sanitario regionale o il Servi-zio Sanitario Nazionale (SSN). La vitalità di ogniorganizzazione, come quella di ogni vivente, dipen-de dalla capacità/possibilità di procurarsi dall’ambien-te le risorse necessarie al suo funzionamento mante-nendo un grado d’integrazione tra i propri compo-nenti che, collegati tra loro da una “ragnatela” dirapporti, formali e informali, ne fanno un tutto coeso,un sistema complesso adattativo (Sca). L’integrazio-ne organizzativa è frutto della varietà, specializzazionee complementarietà di più soggetti che danno luogoa funzioni e attività che nessun di essi potrebbe svol-gere da solo. Complementarietà e integrazione com-portano, però, e sempre, interdipendenza. In uno Sca,infatti, il comportamento d’uno o più dei suoi com-ponenti può influenzare quello di altri componentie/o del sistema nel suo insieme così che, se non gesti-
358
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Documenti
te, possono ostacolarne le attività e il funzionamen-to. Tutto ciò è particolarmente evidente nelle azien-de della sanità. La verticalità della loro organizzazio-ne, articolata in unità specializzate e in attività indi-pendenti, contrasta, infatti, con la crescente com-plessità di pazienti e patologie complessi che richie-dono interventi di più servizi e operatori tra lorocoordinati.Le aziende della sanità sono sistemi complessi forma-ti da molti, moltissimi sottosistemi e componentispecializzati, unità organizzative e individui, i qualicon i loro comportamenti condizionano la qualità el’appropriatezza delle prestazioni erogate che inclu-dono le prestazioni di più soggetti e dipendono dallaprofessionalità di una pluralità di operatori. L’unitàelementare della complessità delle aziende della sani-tà è il singolo professionista che, sia pure all’internodi regole, ha libertà di agire così che esse, anche sehanno un loro centro decisionale, funzionano inbase a interazioni informali tra numerosi sotto centridi controllo e tra i singoli professionisti. Sono siste-mi aperti indissolubilmente connessi a sistemi socia-li, economici, culturali, politici che costituiscono illoro contesto con il quale coevolvono e dal qualericevono, e verso il quale inviano, forti e continuiinput evolutivi.
InterdipendenzaIl SSN, i Servizi Sanitari Regionali (SSR) e le aziendedella sanità sono sistemi socialmente costruiti e laloro complessità interna è in costante aumento a cau-sa del crescente numero di pazienti complessi che,portatori d’una mutata domanda di salute, attendo-no nuove risposte da un SSN prigioniero dei suoimiti. I miti sono racconti che inventiamo per conso-lare noi stessi e oggi l’efficientismo, l’ingegneriaorganizzativa, la razionalità aziendalistica, il mana-ger che risolve tutto sono i miti che alimentano unaconcezione della sanità e della medicina che ha com-plicato l’organizzazione delle aziende della sanità eha portato alla frantumazione delle cure e, di conse-guenza, dei pazienti. Oggi, mentre sappiamo che l’ef-ficienza non dipende tanto dalle performance di unasingola unità o di un singolo professionista ma so-
prattutto dalla capacità di fare sinergia, assistiamo arallentamenti, ridondanze, disfunzioni largamentedovuti alla mancata organizzazione nelle aziende dellasanità delle interdipendenze e delle relazioni tra di-versi settori e professioni. L’approccio sistemico sug-gerisce di guardare alle relazioni che intercorrono trai componenti di un sistema piuttosto che all’efficien-za dei singoli. Suggerisce di gestire l’interdipendenzeindividuando le complementarietà e organizzandolein forme di lavoro interdisciplinari e interprofessionaliadattative e flessibili che, a tutti i livelli, richiedonouna riorganizzazione sistemica del SSN che, inevita-bilmente, mette in discussione un consolidato stori-co di cultura e d’interessi materiali generando fortiresistenze. Ciò nonostante assistiamo allasperimentazione e al consolidarsi di nuove formeorganizzative dell’assistenza sanitaria orientate allacooperazione, all’interdisciplinarietà e all’interprofes-sionalità che fanno intravedere un’evoluzione in sen-so sistemico del SSN e dell’assistenza.
Indizi di futuroI segnali deboli sono indizi di futuro spesso pocopercepibili in quanto sovrastati da rumori di fondo.Son spesso sottovalutati in quanto considerati isola-tamente l’uno dagli altri, ma, se collegati tra loro,rivelano possibili scenari futuri. I diversi seminarihanno messo a fuoco dei segnali deboli che, registratida chi opera nella profondità dei servizi, nel loro in-sieme, indicano che in più realtà locali si assiste al-l’elaborazione e al diffondersi di nuove formeorganizzative orizzontali e improntate all’integrazionedi operatori e servizi.
- Le Case della salute o Utap, dotate di tecnologiedi base, sono concepite come strutture all’inter-no delle quali medici di famiglia, specialisti einfermieri integrano le loro attività perricomporre la frantumazione dell’assistenza ter-ritoriale e per assicurare le prestazioni richiestein un determinato bacino d’utenza.
- Gli ospedali organizzati per intensità di cure sonoarticolati in “sottosistemi” e integrano più com-petenze specialistiche in unità di degenza defini-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
359Documenti
te in funzione della complessità dell’assistenza edell’intensità cure.
- Le unità operative ospedaliere “ibride”, qualineuro- riabilitazione, orto-geriatria, cardio -ria-bilitazione, integrano nel loro organico più spe-cialisti con competenze complementari nellagestione di determinati pazienti.
- Il lavoro in équipe è alla base del funzionamentodi molti servizi, soprattutto territoriali, che sen-tono l’esigenza di sostenere la loro capacità di“lavorare insieme” e ricorrono a pratiche quali igruppi balint, la supervisione, il team building, ilaboratori di autoapprendimento.
- Le reti territoriali spontanee autogestite “con-nettono” sempre più operatori e/o servizi che,sulla base di stima e fiducia reciproci, anche al dilà di ruoli o procedure, collaborano ottenendomaggiore efficienza e efficacia nella risoluzionedi problemi clinici e assistenziali.
- Reti e Gruppi interdisciplinari ospedalieri, spes-so informali, includono specialisti diversi chefanno sinergia nella gestione di casi di neoplasiamammaria, di politrauma, di diabete, di cardio-vasculopatie, ecc.
- Il Case manager collega in rete équipe territo-riali “disperse” con il paziente e i suoi care giversè una figura, quasi sempre impersonata da infer-mieri esperti, che in molti casi ha una suaformalizzazione e un ruolo ben definiti.
- Le scuole di formazione della Medicina di Fami-glia si sono sottratte all’egemonia dell’universi-tà e forniscono competenze cliniche integratecon le competenze, proprie del paradigmasistemico bio - psico - sociale, necessarie a in-staurare rapporti empatici con altri professioni-sti e con il paziente e alla gestione della personae non solo della malattia.
- L’appropriatezza è all’attenzione di sempre piùoperatori che, consapevoli del loro ruolo ai fini
della sostenibilità del SSN, stanno riflettendo suquanto esso “sia intossicato” da prestazioni e pre-scrizioni inappropriate, se non dannose, e stannoelaborando “dal basso” una cultura del “fare menoper fare meglio”.
- La medicina personalizzata è tesa alla formula-zione di diagnosi e piani terapeutici personalizzatiin base al profilo di espressione genica, peculiarein ciascun paziente, integrato con dati e infor-mazioni cliniche e con la storia della malattiainscritta in quella sociale, biologica e psicologi-ca della persona.
- Le unità di degenza a conduzione infermieristicae gli ambulatori infermieristici danno buona pro-va di sé quando operano in rete con i medici difamiglia e inseriscono attività di educazione epromozione della salute nelle piani di trattamen-to dei pazienti.
Questo insieme di segnali deboli depone per unaricerca di soluzioni organizzative orizzontali e perun cambiamento di prospettiva radicale in cui as-sume un carattere strategico la capacità di far co-municare, d’integrare e coordinare più professio-nisti, più servizi, e “più medicine” in funzione dellacomplessità dei pazienti e delle cure.
Cronicità e polipatologiaSecondo diverse stime, in Italia gli over sessantacinquesono oltre il 20 % della popolazione. Considerandoalcune delle malattie più comuni, 250.000 sarebberoi “casi” di diabete di tipo uno, 3.000.000 quelli didiabete di tipo II e 1.500.000 quelli di bronchite cro-nica ostruttiva mentre le persone sopravvissute a uninfarto cardiaco sarebbero 2.000.000 e i sopravvissu-ti a un episodio di ictus cerebrale 900.000.
Patologie complesseSecondo uno studio compiuto negli Stati Uniti nel2005 sugli utenti di Medicare, tutti ultrasessantacinquenni, il 50% di essi assumeva più di 5diversi farmaci al giorno, il 48% aveva almeno tredelle patologie più frequenti, mentre il 21% ne presen-
360
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Documenti
tava almeno 5 e applicando le linee guida più accredi-tate ad una ipotetica paziente 79enne con osteoporosi,artrosi, diabete di tipo II, BPCO e ipertensione, emer-geva la necessità di somministrare 12 farmaci in 19diverse somministrazioni, applicare 18 “attenzioni ali-mentari”, 7 “attenzioni comportamentali”.Lo studio evidenzia i limiti del concetto di comorbilitàche presuppone la possibilità di separare più malattiecompresenti in uno stesso paziente per gestirleseparatamente e indipendentemente l’una dall’altre.I partecipanti ai laboratori di Dedalo 97 hanno pie-namente condiviso il concetto di patologia comples-sa che supera e ingloba quello di comorbilità. Nellaloro esperienza quando in uno stesso paziente coesi-stono più malattie, tanto più se sistemiche, esse siintrecciano facendo emergere una patologia com-plessa che è più della loro somma, che è una nuovaentità, e che, in quanto “caso” unico, risponde alogiche sue, non s’incontra nei testi universitari e nonè possibile gestire sommando più consulenze, più dia-gnosi, più linee guida, più protocolli, più prestazioniprofessionali, più farmaci, più prescrizioniterapeutiche, alimentari e comportamentali.
Pazienti complessiStudi dei medici di famiglia, ospedali, servizi territo-riali, strutture intermedie, sono affollati da pazienticronici, polipatologici, fragili, da “malati per sem-pre”. Sono pazienti cronici, complessi, spesso anzia-ni, che possono essere, ma non necessariamente sono,pazienti fragili, disabili, critici o ad alto assorbimen-to di risorse, o, genericamente, “difficili” o “compli-cati”. Presentano sempre una patologia complessagenerata dall’intreccio di più malattie e, in quantopolipatologici sono esclusi dai trias clinici e, di con-seguenza, sono EBM orfani e difficilmente“protocollabili”. Sono i pazienti reali che s’incontra-no nell’esercizio quotidiano d’ogni professione sani-taria e che rivelano una palese contraddizione, didifficile soluzione, tra la loro gestione e il ricorso alinee guida, protocolli e percorsi clinico assistenziali.La loro gestione richiede un “team di cura”, anche adassetto variabile e di durata limitata nel tempo, com-posto da più specialisti e/o professionisti che, sulla
base di stima e fiducia reciproci e dei massimi livellipossibili di accordo e certezza, interagiscano sistema-ticamente tra loro per individuare una strategia e ledecisioni, le azioni e le figure professionali da mette-re in campo includendo nelle cure, ogni volta che sianecessario e possibile, il paziente stesso e i suoi fami-liari e caregiver.
Le cure e la complessità della personaI partecipanti ai laboratori di Dedalo 97 hanno sot-tolineato che la gestione d’un paziente cronico, fra-gile, complesso, li pone sempre di fronte a unapersona in cui più patologie s’intrecciano tra loro econ situazioni e problemi psicologici, affettivi, so-ciali, familiari, culturali così che la singola patolo-gia o il singolo problema divengono astrazioni chenon è possibile curare o risolvere estraendoli daglialtri. Gestire un paziente complesso implica così ilpossesso non solo di competenze bio mediche, maanche di quelle competenze sociali, psicologiche eumanistiche che, sottese dal paradigma bio-psico-sociale, mettono in grado gli operatori di sostenerlanell’adottare nuovi stili di vita, nell’aderire a terapieimpegnative, nel riconsiderare e cogestire la pro-pria situazione familiare e sociale. In questo sensova letta l’esperienza delle scuole di formazione dellaMedicina di Famiglia che si sono sapute sottrarreall’insegnamento universitario di una medicina sem-pre più frantumata e che si sono orientate a forniredelle competenze cliniche integrate con quelle com-petenze, proprie del paradigma sistemico bio-psico-sociale, necessarie, oltre che a curare la malattia, arapportarsi e con il paziente come persona e conaltri professionisti.
Il paradosso della specializzazioneIn medicina, come in altre scienze e professioni, il dila-tarsi della tecnologia e del sapere ha portato allaspecializzazione che se ha una sua ragion d’essere nelladiversificazione del sapere, delle funzioni e dei compitidà luogo, però, a un paradosso. Infatti più profonda èla conoscenza specialistica, più diventa “fragile” il sa-pere dello specialista che posto di fronte a pazienti epatologie complesse si trova a dipendere da altri spe-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
361Documenti
cialisti. Si evidenziano così i limiti del modelloorganizzativo basato sulla consulenza che, nato, e tut-t’ora largamente praticato in ospedale, genera tempimorti, possibili errori di comunicazioni e incertezzacirca le responsabilità e le decisioni da prendere. Difatto le patologie complesse, in ospedale come nelterritorio, pongono il singolo medico nella situazionedi dover considerare molti dati e variabili, non solobiologici, ma anche sociali e psicologici, che per essereinterpretati e utilizzati richiedono, non delle consulen-ze, ma una collaborazione sistematica e non episodica,tra più specialisti e/o professioni. Infatti, se l’integra-zione senza specializzazione non ha senso, alti livelli dispecializzazione senza integrazione produconoridondanze, burocratizzazione dei rapporti professio-nali, rallentamenti, difficoltà a comunicare e a colla-borare.
Quattro direttrici evolutiveOggi, senza considerare le medicine complementari,in sanità possiamo evidenziare delle direttricievolutive fondamentali.L’igiene e la medicina preventiva utilizzanometodologie e interventi, rivolti sia al singolo chealle comunità, al fine di prevenire le malattie e dipromuovere favorevoli condizioni di vita, di lavoroe l’assunzione di adeguati stili di vita personali.La medicina ospedaliera è la “medicina clinica” che,per molti versi, da molti è ancora considerata la veramedicina. Domina nell’insegnamento universitario,si basa sulla specializzazione, utilizza metodologieconsolidate in una secolare esperienza. Registra con-tinui successi sempre più legati alla tecnologia, ma,centrata sulla diagnosi e cura delle malattie, fatica agestire i pazienti come persone.La medicina di famiglia, erede della medicinamutualistica, sta elaborando nuove strategie di inter-vento e d’ approccio al paziente caratterizzate da unforte grado di originalità rispetto alla medicinaospedaliera. Le sue funzioni fondamentali sono quel-le di “porta d’accesso” alle prestazioni e di presa incarico delle persone, sane e malate, basata su unapproccio bio-psico-sociale che implica il possesso diabilità professionali di tipo comunicativo - relazionale
e non solo biomedico.La “medicina del territorio” comprendono l’assisten-za domiciliare, la psichiatria, la riabilitazione, la me-dicina delle dipendenze, la neuropsichiatria dell’etàevolutiva, la geriatria, i consultori e le strutture inter-medie. È un variegato insieme di medicine, tuttenate e funzionanti sulla base di équipe interdisciplinari,che spaziano dalla prevenzione alla promozione dellasalute e dalla cura alla riabilitazione. La loro esperien-za è recente e le loro metodologie, pur se presentanouna grande varietà, presentano alcuni elementi fon-damentali comuni quali:- il lavoro in équipe interdisciplinari- la valutazione multidisciplinare/multidimensionale- la prospettiva riabilitativa- la diagnosi longitudinale nel tempo- la presa in carico del paziente e dei suoi familiari
come soggetti attivi- il programma o progetto terapeutico, assistenzia-
le, riabilitativo- la definizione di obiettivi periodicamente rivalutati- l’effettuazione di prestazioni integrate ma erogate
in modo autonomo da più professionisti
Una medicina, più medicineNon si tratta più di discutere d’ospedale e territorio.Va superato il luogo comune della contrapposizionetra ospedale e territorio pericolosamente semplifica-torio e, ormai, ampiamente abusato. In poco più dimezzo secolo siamo passati, in successione semprepiù rapida, dalle malattie acute alle malattie croni-che, alle sindromi, alla comorbilità, alle patologie e aipazienti complessi, ai pazienti fragili. Oggi tutte que-ste tipologie, o modelli, di malattia convivono cosìcome convivono più approcci al paziente e piùmetodologie d’intervento. Anche la medicina, cosìcome accade per altre scienze e discipline, non è piùun corpo monolitico di saperi ma un sistema artico-lato di paradigmi, saperi, metodologie di campo cheevolve continuamente. È un sistema animato da unadinamica che ha generato “servizi” assai diversi al-l’interno dei quali operano decine e decine di specia-listi e ben 21 professioni fortemente strutturate alloro interno per competenze, ruoli e funzioni. Così
362
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Documenti
oggi la medicina è contemporaneamente una e “piùmedicine”. Ciascuna di esse opera in contesti diversiquali l’ospedale, lo studio del medico di famiglia, ildomicilio del paziente, le strutture intermedie, le re-sidenze sanitarie assistite, i servizi territoriali. Hannotutte in comune delle conoscenze di base ma ciascu-na tratta pazienti diversi, o uno stesso paziente in fasidiverse di malattia; utilizza diversi approcci al pa-ziente e proprie metodologie; ha sviluppato un suolinguaggio; hanno difficoltà a comunicare e a com-prendersi l’una con le altre, a fare sistema.
Quando la soluzione è un problemaA questa difficoltà si è tentato di rispondere utilizzan-do la stessa logica che l’ha generata. E, mentre inter-venti e prestazioni in sanità dipendono sempre più dalcoordinamento di più professionisti e/o unità operati-ve, il management delle aziende della sanità si è con-centrato sull’efficienza e sulle performance dei singoli,professionisti e/o servizi senza porre la dovuta atten-zione a quelle relazioni d’interdipendenza che condi-zionano l’attività dei servizi e di quanti vi operano. Ilaboratori tenuti da Dedalo 97 hanno registrato unaconcezione delle aziende, che, ancora sostanzialmentemeccanicistica e verticistica, ha alimentato un’inge-gneria organizzativa sempre più sofisticata, unefficientismo aziendalistico e un controllo di gestionesempre più esasperati che hanno progressivamentecomplicato il funzionamento dei servizi e dilatato l’in-vadenza della burocrazia. Questa concezione rigidadelle aziende della sanità, abitate da professionisti pocopreparati, e di conseguenza poco disposti, a “lavorareinsieme”, ostacola, in molte realtà regionali e locali,l’innovazione e l’integrazione delle attività e delle curee la promozione di modalità organizzative orizzontali,flessibili, adattative così come lo sviluppo della capaci-tà degli operatori di “lavorare insieme” in team di cura,équipe, reti e gruppi operativi interdisciplinari einterprofessionali. In sanità la cultura organizzativa faancora fondamentalmente riferimento al modelloospedaliero basato su strutture a canne d’organo, sullaverticalità del sapere specialistico direttamente colle-gato allo sviluppo delle carriere. Ancora oggi le azien-de della sanità sono organizzate per compiti e per ge-
rarchie. Sono articolate in settori e unità specializzatiche si vivono come entità autonome, che tendono aisolarsi e a perseguire obiettivi propri e, per molti versi,poco coerenti da quelli dell’azienda. Si produce cosìun’ autoreferenzialità difficile da gestire e da superarein una situazione in cui la pressione esercitata dallacomplessità delle patologie e dei pazienti richiede ilcoordinamento di più attività e competenze in funzio-ne di programmi e d’obiettivi assistenziali.
Fare sistemaSconfondersiQuelle sanitarie sono organizzazioni polilogiche, inquanto rispondono a più logiche. Sono dotate di un’in-telligenza molecolare, fortemente distribuita. Han-no molteplici identità che è necessario riconoscere esconfondere uscendo da una concezione semplifi-catrice della medicina intesa come unitaria realtàindifferenziata. L’integrazione è figlia della varietà,delle differenze e della stima e fiducia reciproca. Peraprirsi alla prospettiva della cooperazione è necessa-rio affermare e sottolineare le differenze. Ciò, però,non avviene. Permane una concezione gerarchizzatadei saperi che pone al vertice del sapere la medicinaospedaliera. È difficile che le medicine del territorio,la medicina di famiglia e quella preventiva venganoriconosciute, non come specializzazioni della medi-cina clinica ma come organici sistemi di sapere cia-scuno dotato di suoi originali caratteri distintivi eemergente da una dinamica di differenziazione. Inquesta prospettiva un’azienda della sanità è un siste-ma poco coeso formato da più sottosistemi. Ciascu-no di essi ha una sua cultura e chiede di essere consi-derato come una realtà specifica e di essere gestitocon modalità, logiche, linguaggi e strumenti assaidifferenziati. Basta pensare, ad esempio, a quanto siadifficile, ma necessario, per il management utilizzaremodalità e logiche diverse nel definire obiettivi diefficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, rispetti-vamente per una degenza o un laboratorio ospedalieri,per una riabilitazione dell’età evolutiva, per unconsultorio, per un servizio veterinario o per i medicidi famiglia di un distretto sanitario.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
363Documenti
Lavorare insiemeLavorare in insieme non significa affiancare ma in-trecciare più saperi generando un sapere e una capaci-tà di decidere e d’agire che nessuna individualità pos-siede. Ciò richiede ai professionisti capacità di comu-nicare e di lavorare in équipe e in reti al cui interno ilruolo del case manager sarà sempre più importanteper assicurare appropriatezza e continuità dell’assi-stenza. L’assunto secondo il quale non c’è mai solouna parte da curare, ma sempre una persona da pren-dere in considerazione implica interdisciplinarietà einterprofessionalità così come un paziente comples-so implica non solo puntuali atti di cura individuali econsequenziali uno all’altro, ma strategia per adatta-re indagini e cure al paziente, per inventare soluzioniche prendano in considerazione oltre alla dimensionebiologica, quelle psicologica, sociale, culturale, fami-liare del paziente. Da molti anni più studi hannodimostrato che in sanità l’équipe interdisciplinarimostrano una maggiore efficienza delle prestazionidei loro componenti e una significativa riduzione deicosti. Nonostante ciò, ci sono forti resistenze a ripen-sare in senso orizzontale e cooperativo la configura-zione delle aziende della sanità al cui interno servizi eoperatori, che hanno ruoli e funzioni diverse, fatica-no a integrarsi e coordinarsi. Questa difficoltà vapresa in considerazione nella prospettiva di unariorganizzazione, ormai irrimandabile, delle aziendedella sanità e il livello politico, il management, leprofessioni, e le loro rappresentanze, dovrebbero ri-flettere sulla necessità di rivedere profondamente lenorme e la contrattualistica vigenti per aprire la stra-da a strategie che portino una riconfigurazionesistemica delle aziende stesse.
Reti professionaliUna rete è un insieme di professionisti, servizi e agenzieanche esterni, i cui componenti, organizzati su basenon gerarchica e sulla base di stima e fiducia recipro-ci, perseguono l’obiettivo di erogare in modo siste-matico prestazioni multi professionali che rappre-sentano il mandato e l’interesse comune. Le reti pro-fessionali connettono parti e dimensioni diverse diun’azienda della sanità, organizzano le interdipen-
denze generatrici d’inefficienza elevandole acomplementarietà. Nascono da più operatori checooperano indipendentemente dalla loro posizionenell’organigramma. Una rete non si installa, si ali-menta. Va rifornita d’energia sotto forma di investi-menti di pensiero e organizzativi e la sua creazione emanutenzione richiedono:- Una chiarezza di mandato e finalità- Una sua sponsorizzazione da parte del vertice
aziendale e delle unità coinvolte- Un suo riconoscimento formale teso a favorire un
clima di stima e fiducia tra i suoi componenti- La creazione d’una struttura, anche minima, in gra-
do di tenere i contatti, gestire agende, tempi eappuntamenti
- Responsabilizzare un hub che alimenti la rete etenga aperti i canali di comunicazione tra i suoicomponenti.
Ricomporre cure e prevenzioneMentre molti ritengono ancora che promozione del-la salute e prevenzione non rientrino tra le prioritàdella sanità, è ormai universalmente assodato che lagran parte delle malattie cronico degenerative piùcomuni non riconoscono solo cause naturali, biologi-che o genetiche. Basta pensare che tumori, diabete,malattie cardiovascolari e respiratorie, sono causateda un intreccio di molti fattori tra i quali, a livelloindividuale, fumo di sigaretta, uso d’alcool, mancan-za d’attività fisica, errate abitudini alimentari e, alivello di società, rischi da lavoro, ritmi di vita stres-santi, inquinamento dell’aria, produzione industrialedi alimenti, pressione al consumo di bevande e dialcoolici, … bassi livelli di reddito e d’istruzione e dicapacità d’ accedere ai servizi sanitari …. A distanzadi tanti anni dalla riforma sanitaria del 1978, è beneriaffermare che lo scopo del SSN è la difesa dellasalute e non solo protezione economica dal rischio dimalattia e che la sostenibilità del SSN sta tanto nellasua efficienza quanto nella sua capacità di generaresalute. Nel tempo s’è approfondita una dissociazionetra il sistema delle cure e la prevenzione. Oggi lapromozione della salute è divenuto un settore specia-listico in cui operano le più diverse figure di esperti. Il
364
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Documenti
risultato è che oggi la maggioranza dei medici e deiprofessionisti ritiene di non doversi occupare affattodi prevenzione mentre, al contrario, la stessa andreb-be portata a livello del rapporto individuale con ilpaziente, là dov’è possibile proporre con più effica-cia la responsabilizzazione degli individui nella ge-stione della loro salute/malattia e l’adozione di stili divita sani e di comportamenti responsabili e utili alsottrarsi a accertamenti e cure inutili, se non danno-si. Senza mettere in discussione risultati e conquistedella medicina curativa, dovremmo immaginare chele aziende della sanità non siano solo capaci di pro-durre prestazioni, ma anche di stare “dalla parte dellasalute”, di suscitare quell’energia di quella “popola-zione protagonista del sistema” che, al di làd’idealizzazioni e astrazioni, è un patrimonio indovatonegli individui, nelle loro comunità e rappresentan-ze, in associazioni di pazienti, nel volontariato, inscuole, istanze culturali, imprese, …. che al livellolocale possono contribuire a costruire socialmente lasalute di ciascuno e di tutti come “bene comune”eun SSN sostenibile.
Fare appropriatezzaSe il risparmio consiste in razionamenti e tagli dellerisorse, l’appropriatezza è la razionalizzazione del loroimpiego. L’appropriatezza, infatti, è una combina-zione d’efficienza, efficacia e corretta indicazione, inequilibrio tra loro. Dipende largamente dallaresponsabilizzazione dei professionisti. Ha il signifi-cato d’utilizzare al meglio, e in modo efficiente, lerisorse disponibili allo scopo d’assicurare prestazioniefficaci, supportate da una corretta indicazioni, ac-cettabili per l’utenza e capaci di rispondere alla do-manda di salute espressa e inespressa, individuale,familiare e sociale.Secondo dati del 2012, risulterebbero inappropriatoil 40 % delle medicazioni avanzate, il 25 % delleindagini d’imaging, il 15 % delle giornate di ricoveroe, complessivamente, il 30 % della spesa sanitariasarebbe destinata all’erogazione di prestazioniinappropriate, se non nocive.Sono dati impressionanti secondo i quali circa 30miliardi del finanziamento del SSN sarebbero spesi
inutilmente. Ancora una volta la soluzione è il pro-blema. Infatti, ormai da anni l’attenzione di tutti èconcentrata sulla scarsità di risorse, sul risparmio esull’efficienza, mentre dovrebbe soffermarsi sull’ideache se la sostenibilità del SSN dipende anche dall’ef-ficienza, non c’è efficienza senza efficacia e correttaindicazione. Secondo una logica ancora troppomutualistica e di soddisfazione del “cliente”, le azien-de della sanità sono concepite come macchine perprodurre prestazioni e la loro gestione è tesa a incre-mentare un’offerta che, paradossalmente, ha l’effet-to di dilatarne la domanda in una paradossale sinergiacon interessi di terzi, di pratiche inappropriate e dicomportamenti deresponsabilizzati dei professioni-sti e dei “clienti”. Al contrario, in una sanità intossi-cata da medicina difensiva, interessi economici,efficientismo …. l’appropriatezza va posta come“fare di meno per fare meglio”. Andrebbe propostacome metro di valutazione delle attività svolte e comevalore per gli operatori. L’etica dell’appropriatezza,infatti, si fonda su libertà professionale, rapportofiduciario e beneficiario per il paziente, sull’operaresecondo scienza e coscienza, agire con perizia, pru-denza e diligenza, tutti valori deontologici tutti con-divisi da tutte le professioni sanitarie e coerenti conuna riflessione a tutto campo, e a tutti i livelli, sucome si spende e su come si lavora, e non solo suquanto si spende e su quanto si lavora.La formazione al passato. L’università dovrebbepreparare al futuro ma oggi, come mezzo secolo fa, ilmedico esce dalle nostre università ottimisticamentemeccanicista e riduzionista. Convinto che l’unicamedicina sia quella clinica, appresa all’università epraticata in ospedale, ritiene che il medico basti a sestesso e che dal suo decidere e agire dipenda, sempree comunque, l’agire di ogni altra professionalità. Se,giustamente, è preparato dall’università a decidere eagire rapidamente, così come richiesto in particolarenell’urgenza, è impreparato a “lavorare insieme” nel-l’ambito di équipe interdisciplinari e interprofes-sionali. Inserito in organizzazioni verticali apprendepoi a “lavorare accanto”, in parallelo secondo la logi-ca della consulenza. Fortemente orientato ad utiliz-zare la tecnologia, è impreparato a gestire la com-
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
365Documenti
plessità delle patologie, dei pazienti e delle persone equelle situazioni che richiedono di standardizzare maanche di personalizzare le cure, di contestualizzare ilpaziente e le patologie di cui è portatore, d’utilizzarele narrazioni del paziente e le valutazioniepidemiologiche per posizionare gli accertamenti infunzione degli esiti possibili probabili, mai certi.
Attrattori L’Educazione Continua in Medicina è stato, ed è, unpotente attrattore che ha indotto nei professionistinuovi comportamenti e che ha portato le aziendedella sanità, i servizi, gli staff e le agenzie della for-mazione a riconfigurare come sistema l’insieme di-sperso delle attività riguardanti l’aggiornamento pro-fessionale. La cronicità e la complessità delle patologiee dei pazienti sono potenti attrattori che sempre più,e inevitabilmente, stanno inducendo il SSN a dotarsidi servizi assai diversificati. Fermo restando che ènecessario valutare l’efficacia delle nuove formeorganizzative oggi emergenti, tutto depone per unaricerca di soluzioni organizzative comunque orizzon-tali, tutte riconducibili a una prospettiva sistemica,basate sull’integrazione di più settori, unità operati-ve e/o professionisti, in équipe, team e in reti. Il siste-ma delle cure è di fronte a un cambiamento di pro-spettiva radicale che deve far riflettere il livello poli-tico e il management della sanità sulla necessità dirivedere profondamente le norme e la contrat-tualistica vigenti in funzione di avviare delle dinami-che di cambiamento che favoriscano l’assunzionegeneralizzata di nuove modalità sistemiche di fun-zionamento dei servizi sanitari.
Affermare valori per contrastare la corruzioneSe la crisi economica e i ripetuti tagli al suo finanzia-mento hanno messo in difficoltà il SSN, il degradodella politica e dell’etica pubblica ne stanno minandola stessa sopravvivenza. Secondo il documento dellaCamera dei Deputati, XVII, n. 4 del 2014, “l’illega-lità e la corruzione rappresentano all’incirca il 5-6 percento della spesa sanitaria (circa 5-6 miliardi di euro);si tratta di un fenomeno preoccupante che non soloincide sull’efficienza e sull’equità dei servizi, ma che
mina alla radice il rapporto di fiducia tra istituzioni ei cittadini”. Una miriade di casi d’invadenza dellapolitica e di clientelismo hanno deprivato il SSN deivalori su cui si fonda un servizio pubblico. Sono notii ripetuti casi in cui “la politica” è arrivata a control-lare e alterare le normali procedure riguardanti no-mine, assunzioni, carriere, appalti, forniture. Valorinegativi e antisociali hanno pervaso le aziende dellasanità con effetti devastanti sul clima interno, sullamotivazione e sul senso di responsabilità e sulla fidu-cia di quanti in esse operano verso amministratori emanager spesso poco credibili, compromessi e inade-guati. Sottrarre illecitamente risorse alla sanità signi-fica rubare salute e è ormai inevitabile un radicaleridimensionamento della politica nella gestione dellasanità. È ineludibile la rivendicazione di porre allaguida delle aziende della sanità amministratori cheabbiano non solo una competenza tecnica e, soprat-tutto, una credibilità etica sorretta dalla capacità diproporre come valore e come beni comuni la preven-zione e la cura delle malattie, la salute e il SSN e leaziende della sanità che lo compongono.
Dieci suggerimenti dell’approcciosistemicoNel SSN sono evidenti inarrestabili dinamiche dicambiamento in senso sistemico. A esse si contrap-pongono interessi materiali fatti di carriere e di van-taggi acquisiti, intrecciati con rendite di posizione,con interessi locali, politici e sindacali, che trovanoriscontro in norme, contratti e assetti organizzativi...Sappiamo, però, che il contesto paese è importante,che un sistema coevolve sempre con il suo contestoche l’orienta verso un futuro non del tutto prevedibilee che è inutile e dannoso tentare d’ignorare o evitarela complessità. Non tutte le soluzioni sono nel SSN.Con la complessità si può solo dialogare e l’approcciosistemico non fornisce ricette o programmi. Aiutasolo a immaginare il futuro. Sta a noi accogliere isuoi suggerimenti.1. Senza valori ogni servizio pubblico è destinato
a perire; è necessario pretendere manager eti-camente credibili e competenti
2. La finalità del SSN è produrre salute e la pro-
366
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Documenti
L’Associazione Dedalo 97 riconosce i principi dellacomplessità e le metodologie dell’approccio sistemicoquali strumenti per contribuire allo sviluppo delServizio Sanitario Nazionale e delle organizzazionisanitarie, al miglioramento degli interventi sociali esanitari e all’umanizzazione e all’appropriatezzadelle cure.Promuove lo sviluppo professionale e personale dei proprisoci. Realizza attività di aggiornamento e di scambiotra pari di conoscenze e di esperienze tra i propri soci e,più in generale, tra i professionisti del settore sociale esanitario e tra i quanti ritengono che l’approcciosistemico rappresenti uno strumento decisivo percontribuire a una più avanzata comprensionedell’essere umano e delle società.Riunisce quanti, nella prospettiva di un’etica diservizio, sono interessati:- alla promozione e al mantenimento della salute
delle persone e delle comunità intesa come benecomune;
- allo sviluppo di metodologie e pratiche, manageria-li, gestionali, professionali tese al miglioramentodell’organizzazione, dell’appropriatezza, dellaqualità, dell’umanizzazione delle attività e dellecure e delle prestazioni del settore sociale esanitario;
- alla realizzazione e partecipazione a studi,ricerche e esperienze basate su metodologie etecniche proprie dell’approccio sistemico chefavoriscano un rapporto positivo tra i professionisti etra essi e quanti si rivolgono ai servizi sociali esanitari;
- alla divulgazione e diffusione dell’approcciosistemico, in generale nella società, e più inparticolare tra gli operatori sociali e sanitari e traquanti hanno responsabilità direzionali egestionali all’interno delle diverse organizzazionisociali e sanitarie;
- alla promozione di iniziative, quali gruppi dilavoro e reti interdisciplinari e interprofessionali,anche in collaborazione con altre entità scientifi-che e culturali, al fine di realizzare quanto aipunti precedenti.
mozione della salute è un valore fondante ilSSN; va ricomposta la separazione tra cura eprevenzione
3. Pazienti e organizzazioni della sanità sono si-stemi complessi; vanno trattati come tali e laloro gestione richiede un approccio sistemico
4. La pressione della complessità dei pazienti èsempre maggiore; una profonda riconfigura-zione sistemica e orizzontale delle aziende del-la sanità è irrimandabile
5. In medicina spesso fare meno è fare meglio;qualità e appropriatezza delle prestazioni vaproposta come valore ai professionisti
6. Curare spesso non basta; per prenderci curadelle persone dobbiamo integrare il paradigmabiomedico e quello bio-psico-sociale
7. Nella complessità dei pazienti e delle personenon tutto è riconducibile all’evidenza; l’espe-rienza è importante
8. La specializzazione senza integrazione produ-ce sprechi, ridondanze, lentezze; perricomporre la frammentazione dei pazienti edelle cure vanno adottate delle strategie d’in-tegrazione.
NOTIZIARIOINFORMAZIONI
Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 367-371
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Perugia, 7-19 novembre 2014Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia,(Via G. Oberdan 54, Perugia)Centro Sperimentale per la Promozione dellasalute e l’Educazione Sanitaria dell’Universi-tà degli Studi di Perugia.CULTURA È SALUTE La Salute Pubblica aPerugia e in Umbria, attraverso i 60 anni delCentro Sperimentale per l’Educazione Sanita-ria dell’Università di Perugia. Concetti e im-magini per promuovere Salute in Italia e nelmondo.
Dal 7 al 19 novembre si è tenuta a Perugia, in ViaOberdan, nella ex chiesa di Santa Maria della Miseri-cordia la mostra intitolata CULTURA È SALUTELa Salute Pubblica a Perugia e in Umbria, attraversoi 60 anni del Centro Sperimentale per l’EducazioneSanitaria dell’Università di Perugia. Concetti e im-magini per promuovere Salute in Italia e nel mondo.E’ stata promossa per celebrare il sessantesimo com-pleanno di una prestigiosa istituzione dell’Ateneoperugino, creata da Alessandro Seppilli, Direttoredell’Istituto di Igiene e Sindaco della città assieme almedico provinciale Carlo Sganga, nel lontano 1954.Nata come istituzione volontaria e privatistica, fu inseguito assorbita dall’Università degli Studi di Perugia,il cui Rettore, Giuseppe Ermini era stato nominato
Dedichiamo in questo numero il notiziario della rivista alla Mostra CULTURA È SALUTEcurata dal rinnovato Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione sanitaria,un’opera che ha coagulato le energie di nuovi e vecchi ricercatori e collaboratori. Non solo un’esposi-
zione significativa di storie, immagini, concetti, avvenimenti, ma luogo di confronto, dibattito esviluppi di nuovi indirizzi concettuali ed operativi attraverso una articolata serie di iniziative,
alle quali hanno partecipato esperti nazionali e internazionali.Un grande impegno che ha coinvolto i cittadini di Perugia.
Presidente sin dall’inizio. Oggi è parte del Diparti-mento di Medicina sperimentale dell’Ateneo e nelsuo Statuto Regione, Provincia e Comune di Perugiafigurano come partner.Il suo scopo fondamentale fu, alla nascita, quello dicontribuire al progetto di costruzione della salute dellapopolazione, appena uscita dalla tragedia della secon-da guerra mondiale, facendo proprie le raccomanda-zioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cheaveva contribuito alla istituzione del Centro stesso.Per 60 anni il Centro Sperimentale per l’Educa-zione Sanitaria dell’Università degli Studi diPerugia ha lavorato sviluppando ricerche e forma-zione professionale, producendo modelli teorici edoperativi in sanità pubblica, prevenzione, educazionee promozione della salute. Creando una sorta di labo-ratorio di idee e pratiche dove professionisti, studentie cittadini possano contribuire con i propri saperi e leproprie esperienze a dare concretezza al diritto allasalute sancito dall’art. 32 della Costituzione italia-na: “La Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell’individuo e interesse della collettività”.Nell’intento di contribuire alla creazione di una cul-tura della salute i cui fondamenti sono il benesseredella persona in un sano ambiente, naturale e costru-ito, in un contesto sociale favorevole, con servizi sa-nitari centrati sul cittadino, nello sviluppo di coscien-za collettiva e nella partecipazione attiva e responsa-bile della cittadinanza.
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
368 Notiziario
La mostra ha ripercorso il lungo cammino del Centroattraverso la presentazione di alcune delle numeroseattività, articolandosi in quattro sezioni:- Origini e principi: viene esposta la filosofia del
Centro, il suo ruolo nazionale e internazionale nelcampo della sanità pubblica, programmazione edorganizzazione sanitaria, promozione della saluteed educazione sanitaria. Seppilli ed i suoi collabo-ratori figurarono tra i pianificatori e realizzatoridella riforma sanitaria istitutiva del Servizio Sani-tario, a livello nazionale e regionale.
- Ricerca e sperimentazione: sono riportati esem-pi dei concetti e modelli elaborati, sperimentati edisseminati. Tra i più innovativi quelli relativi al-l’educazione sanitaria, ad ambienti di lavoro pro-motori di salute, alla scuola produttrice di salute.Di grande rilevanza gli studi sull’ambiente natura-le e costruito, sugli stili di vita, sulle disuguaglianzein salute e i determinanti socio-economici, sullatutela della salute materno-infantile.
- Formazione e comunicazione: il Centro ha de-stinato da sempre gran parte delle sue risorse per laformazione dei professionisti della salute, nella sa-nità, nella scuola, nel sociale, attraverso corsi uni-versitari, di formazione continua, seminari per lacomunità.
- Partecipazione e futuro: sono presentate le nuo-ve attività, i progetti in costruzione, le più recentiiniziative formative, gli ultimi numeri delle riviste.
Collocato nel quadro di un’importante rete di collabo-razione internazionale, il Centro ha esposto anche unarassegna di manifesti originali, di sua proprietà, prove-nienti da tutte le parti del mondo, dal dopoguerra allafine del novecento, finalizzati a sensibilizzare la popo-lazione sui diversi temi di salute. Un patrimonio scien-tifico culturale e, non da ultimo, storico-artistico cui siaccompagna la presentazione di un’importante colle-zione di oltre 6.000 diapositive realizzate nei primianni del novecento dal prof. Casagrandi, maestro diSeppilli, sempre sui temi dell’Igiene e della salute dellepopolazioni.Sono stati esposti modelli e strumenti di informazionerealizzati nella lunga collaborazione con il SENDES(Servizio di documentazione in educazione sanitaria)dell’Assessorato alla Sanità della Regione dell’Umbria,
cooperazione oggi interamente ripresa, dopo qualcheanno di interruzione, con il trasferimento presso il cen-tro di personale regionale.La mostra, adottando i principi della filosofia delCentro, ha accompagnato il visitatore invitandolo adesprimere la propria opinione intorno al tema dellasalute, con un percorso interattivo e multimediale.Collegati alla Mostra sono stati realizzati eventi im-portanti e diversificati, tutti nella logica dell’immutatofine di promuovere una cultura della salute tra pro-fessionisti e popolazione, che elenchiamo.
Perugia, 7 Novembre 2014 ore 17.30Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia(Via G. Oberdan, 54)INAUGURAZIONE DELLA MOSTRASono intervenuti:Catiuscia Marini - Presidente Regione UmbriaFranco Moriconi - Magnifico Rettore Università de-gli Studi di PerugiaMaria Teresa Severini - Assessore alla cultura, al turi-smo e all’università, Comune di PerugiaVincenzo Nicola Talesa - Direttore Dipartimento diMedicina Sperimentale, Università degli Studi diPerugiaLamberto Briziarelli - Centro Sperimentale per laPromozione della Salute e l’Educazione sanitariaMaria Antonia Modolo - Centro Sperimentale per laPromozione della Salute e l’Educazione sanitariaHa coordinato: Federico Fioravanti - Giornalista
Perugia 9 novembre 2014 ore 17.30Hotel La Rosetta (Piazza Italia)MEETING SCIENTIFIC COMMITTEE OFTHE EXPERIMENTAL CENTER FORHEALTH PROMOTION AND EDUCATION(CESPES) UNIVERSITY OF PERUGIASono intervenutiLamberto BriziarelliPaolo ContuEmilio DucaBengt LindströmMaria Antonia ModoloCarlo SignorelliVincenzo Talesa
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Informazioni 369
Lenneke VaandragerFilippo BauleoPaola BeatiniGiuseppe MasanottiLiliana MinelliGiancarlo PocettaProgramChair Lamberto BriziarelliIntroduction Lamberto BriziarelliSItI Greetings Carlo SignorelliPresentation of the Center (Mission and Aims)Giancarlo PocettaOngoing initiatives Giuseppe MasanottiCenter Journals Filippo Bauleo, Maria AntoniaModoloFuture Steps Open discussion
Perugia 10 novembre 2014 ore 8.30Sala Comunale Sant’Anna, (Viale Roma)CONVEGNO NAZIONALEDeveloping Competencies and Standards forHealth Promotion in Europe (Comp - HP)ProgrammaPresentazione e coordinamento a cura di:Giancarlo PocettaDeveloping Competencies and Standards forHealth Promotion in Europe - The CompHPProject Marie Claude Lamarre - International Unionfor Health Promotion and Education (IUHPE)Nuove competenze e standards per la Promo-zione della Salute nei Servizi Sanitari Paolo Contu- Università degli Studi di CagliariTAVOLA ROTONDA
Sviluppo delle competenze professionali in promo-zione della salute: paritre dai bisogniGiuliana Bodini - ASNASAntonio Chiarenza - ASL Reggio EmiliaClaudio Tortone - DoRS PiemonteMarco Cristofori - USL Umbria2 TerniStefania Polvani - ASL FirenzeDiscussioneConclusioniMariadonata Giaimo - Servizio Prevenzione, sanitàveterinaria e sicurezza alimentare, Regione UmbriaPerugia 12 novembre 2014 ore 16.30
Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia(Via G. Oberdan, 54)PRESENTAZIONE DEL LIBRO
COMUNICAZIONE PROFONDA IN SANITÀdi Francesco Calamo Specchia, Maggioli editoreInterventi:Francesco Calamo Specchia - Autore, Università Cat-tolica Sacro Cuore di RomaLino Conti - Dipartimento di Filosofia, Scienze So-ciali, Umane e della Formazione, Università degliStudi di PerugiaCoordinatore:Giancarlo Pocetta - Centro Sperimentale per la Pro-mozione della Salute e l’Educazione sanitaria,Dipartimento di Medicina Sperimentale, Universitàdegli Studi di Perugia
Perugia 14 novembre 2014 ore 11.00Sala Comunale Sant’Anna (Viale Roma)PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SALUTE SENZA CONFINI di Paolo Vineis,Codice EdizioniInterventi:Edi Cicchi - Assessore al Comune di PerugiaPaolo Vineis - Autore Imperial College di LondraAngelo Stefanini - Centro di Salute Internazionale(CSI), Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica,Università di BolognaCoordinatore:Liliana Minelli - Centro Sperimentale per la Pro-mozione della Salute e l’Educazione sanitaria, Dipar-timento di Medicina Sperimentale, Università degliStudi di Perugia
Perugia 15 novembre 2014 ore 16.30Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia(Via G. Oberdan, 54)“ARTE È SALUTE”, a cura del gruppo Culturadel Forum Regionale Giovani umbriIl Forum riunisce oltre 70 associazioni giovanili cherappresentano 40.000 giovani umbri per un unicogrande obiettivo: trasformare Perugia in una capitaleaperta, giovane e dinamica. Un’esperienza cresciutadal basso che poi si è trasformata in un esperimentodi partecipazione e cittadinanza attiva, molto più
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
370 Notiziario
ampio a livello regionale. Lo Statuto si ispira ai principieuropei della rappresentanza giovanile e della parteci-pazione alla vita locale e regionale, promossi dal forumEuropeo dei Giovani (European Youth Forum) e dalForum Nazionale dei Giovani (Fng).ProgrammaPresentazione evento a cura del Gruppo Cultura delForum Regionale Giovani Umbria e iniziodell’estemporanea pittorica sul tema a cura di TizianoTardo (Il Circolo delle menti)Benvenuto musicale a cura del Gruppo giovani del-l’Associazione ASSIOMIConferenza Storico-Artistica “La salute nell’artedalla contemporaneità alla modernità”, un percorsoa ritroso dalle più recenti testimonianze artistiche finoai primi del Quattrocento a cura di Michela Morelli(Ekphrasis), Eva Morelli (Il Circolo delle Menti), Fran-cesca Fortunati (I Bracceschi)Intramezzo musicale, a cura del gruppo giovanidell’Associazione ASSIOMIPerformance di danza, a cura di Azione CattolicaItaliana (Ballerine: Vania Tosi, Virginia Segazzi,Carolina Berardi, Lavinia Ambrosi; Coreografa: AnnaMakarova)Presentazione dell’opera del pittore Tiziano TardoPerformance di danza, a cura di Dance Gallery(Ballerine: Daria Menichetti, Francesca Masala, SaraMaurizi, Licia Brunori, Marta Vinti; Musica: An-drea Rellini; Coreografa: Rita Petrone)Aperitivo “salutare”
Perugia 17 novembre 2014 ore 17.00Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia(Via Oberdan, 54)PRESENTAZIONE DEL LIBRO ANGELO CELLIa cura di Stefano Orazi, Sapienza Università EditriceInterventi:Gaetano Maria Fara - Università la Sapienza di RomaTullio Seppilli - Presidente della Fondazione AngeloCelli per una cultura della salute (Perugia) e della So-cietà italiana di antropologia medica (SIAM)Coordinatore:Lamberto Briziarelli - Centro Sperimentale per la Pro-mozione della Salute e l’Educazione sanitaria,Università degli Studi di Perugia
Perugia18 novembre 2014 ore 17.00Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia(Via G. Oberdan, 54)PRESENTAZIONE DEL 4° RAPPORTOGLOBAL HEALTH WATCH, REDATTO DALPEOPLE HEALTH MOVEMENTInterventiElisa Cennamo, Medici Senza Camice, RomaMarianna Parisotto, Centro Salute Internazionale,Università di BolognaMassimiliano Minelli, Dipartimento di Filosofia,Scienze sociali, Umane e della Formazione, Univer-sità degli Studi di PerugiaCoordinatoreRiccardo Casadei, Centro Sperimentale per la Pro-mozione della Salute e l’Educazione Sanitaria del-l’Università degli Studi di Perugia
COMITATO ORGANIZZATORE DELLAMOSTRAPresidente Onorario - Maria Antonia Modolo Pro-fessoressa di Igiene dell’Università degli Studi diPerugia, già Direttrice del CSES e Senatrice dellaRepubblica, Medaglia d’Oro del Presidente dellaRepubblica per la Cultura 2003Presidente - Lamberto Briziarelli Professore di Igie-ne dell’Università degli Studi di Perugia, per moltianni Direttore del CSESVicepresidente - Rossana Pasquini Professore di Igie-ne dell’Università degli Studi di Perugia e CeSPESComponentiGiuseppe Angeli - Dipartimento Medicina Sperimen-tale, Università degli Studi di Perugia e CeSPESGrazia Battista - Dipartimento Medicina Sperimen-tale, Università degli Studi di Perugia e CeSPESRiccardo Casadei - Specialista in Igiene e MedicinaPreventiva, Università degli Studi di Perugia eCeSPESFrancesca Fortunati - Dottoranda di ricerca in Storiadell’Arte, Dipartimento di lettere-lingue e letteratu-re antiche e moderne, Università degli Studi di Perugia,Responsabile Gruppo Cultura Forum Regionale Gio-vani UmbriaMarta Fressoia - Dottoressa in legge presso l’AlmaMater Studiorum Università di Bologna
Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2014
Informazioni 371
Osvaldo Fressoia - Esperto di documentazione earchiviazione del CeSPESGiuseppe Michele Masanotti - Docente di Igiene ge-nerale ed applicata, Dipartimento Medicina Speri-mentale dell’Università degli Studi di Perugia eCeSPESGiancarlo Pocetta - Docente di Igiene generale edapplicata, Dipartimento Medicina Sperimentale del-l’Università degli Studi di Perugia e CeSPESSegreteria ScientificaFilippo Bauleo - Direttore di Sistema Salute. La Rivi-sta italiana di educazione sanitaria e promozione del-la salute del CeSPESPaola Beatini - Dottore di Ricerca in EducazioneSanitaria, Dipartimento Medicina Sperimentale del-l’Università degli Studi di Perugia e CeSPESSegreteria Organizzativa - Alberto Antognelli, Se-gretario del CeSPES, Dipartimento Medicina Spe-rimentale dell’Università degli Studi di Perugia
CENTRO SPERIMENTALE PER LA PROMO-ZIONE DELLA SALUTE E L’EDUCAZIONESANITARIA (CeSPES)Comitato ScientificoMargaret Barry - Professor of Health Promotionand Public Health dell’Università Nazionale d’Irlan-da (NUI) a Galway, e Head of World HealthOrganization Collaborating, National University ofIreland, GalwayLamberto Briziarelli - Professore di Igiene dell’Univer-sità di Perugia, per molti anni Direttore del CentroSperimentale di Educazione Sanitaria (CSES)Paolo Contu - Professore di Igiene dell’Università di
Cagliari, vicepresidente International Union forHealth Promotion and Education (IUHPE)Emilio Duca - Direttore regionale Salute e CoesioneSociale della Regione UmbriaBengt Lindström - Professor in Health Promotion,NHV and Buskerud University College, Norway,Department of Social Work and Health Science eChair IUHPE Global Working Group onSalutogenesis.Maria Antonia Modolo - Professoressa di Igiene del-l’Università di Perugia, già Direttrice del CSES eSenatrice della Repubblica, Medaglia d’Oro del Pre-sidente della Repubblica per la Cultura 2003Walter Ricciardi - Professore di Igiene dell’Universi-tà Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Commissariostraordinario dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS),Presidente dell’European Public Health Association(EUPHA)Vincenzo Nicola Talesa - Direttore del Dipartimentodi Medicina Sperimentale dell’Università degli Studidi PerugiaLenneke Vaandrager - Professor at the ChairgroupHealth and Society of Wageningen University eCoordinator of the EuropeanTraining Consortium inPublic Health and Health Promotion (ETC-PHHP)GiuntaGiuseppe Angeli, Riccardo Casadei, GiuseppeMasanotti, Giancarlo PocettaCoordinatriceLiliana Minelli - Docente di Igiene generale ed appli-cata, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Uni-versità degli Studi di Perugia e CeSPES
L’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool nasce nel marzo 1991 con l’intento diraccogliere e mettere a disposizione della comunità scientifica e della collettività naziona-le informazioni e scientificamente attendibili sulle modalità di consumo di bevande alco-liche e sulle relative problematiche nella popolazione giovanile italiana.In questi anni la missione dell’Osservatorio è stata quella di promuovere ricerche, in un’otticadi integrazione interdisciplinare finalizzata ad ottenere una visione globale del fenomeno.A partire da un approccio bio-psico-sociale delle problematiche alcool correlate, l’Osser-vatorio ha voluto integrare ed allargare la dimensione ”sanitaria” del problema approfon-dendo gli aspetti psicosociali ed antropologico-culturali dei comportamenti individuali ecollettivi, compresi gli aspetti economici e quelli politico-legislativi.Ispirandosi ai principi dell’“alcologia sociale” che, specie a livello europeo, trova semprepiù consensi, l’Osservatorio ha esercitato un ruolo primario nell’identificare strategie diprevenzione dell’eccedenza efficaci e consapevoli delle differenze culturali e comporta-mentali.La crescente attenzione per le problematiche alcool correlate ha posto l’esigenza di strut-turare maggiormente l’Osservatorio dal punto di vista organizzativo, ampliando il nume-ro dei suoi partner.I mutamenti delle realtà giovanili e la crescente globalizzazione hanno inoltre reso neces-sario un allargamento delle tematiche ai comportamenti alimentari e agli stili di vita deigiovani ed un rafforzamento del network europeo, per garantire la realizzazione di ricerchecomparate e l’elaborazione di strategie di prevenzione adattabili in diversi paesi.In questa ottica una sempre maggiore enfasi verrà posta sulla promozione di collaborazio-ni internazionali che permetteranno il confronto e lo scambio di esperienze e la collabora-zione reciproca fra strutture ed esperti ai massimi livelli.
ObiettiviNel fornire aggiornate informazioni sul comportamento connesso al bere della popolazio-ne l’Osservatorio vuole essere:- Uno strumento per operatori e policy makers del settore- Un’affidabile fonte di interpretazione sul consumo d’alcool e politiche sociali- Un’agenzia permanente di valutazione e monitoraggio dei fenomeni delle misure pre-
ventiveIl complesso di queste attività è finalizzato alla promozione di un consumo d’alcool re-
sponsabile. In quanto laboratorio di riflessione sulle fenomenologie di consumo legateall’alcool, l’Osservatorio si pone in particolare i seguenti obiettivi:
- Fornire in modo permanente dati ed informazioni aggiornate sui comportamenti degliitaliani nei confronti del bere
- Promuovere fra le varie fasce e categorie della popolazione italiana un comportamentoresponsabile nei confronti dell’alcool
- Contribuire a prevenire i consumi smodati, gli eccessi e l’insieme dei comportamenti arischio legati all’assunzione di alcool
- Contribuire a sviluppare e definire politiche alcol correlate più efficaci, attraverso unamaggiore attenzione alle caratteristiche regionali delle comunità locali di auto regolarsi
Presidente onorario: Umberto VERONESI
Presidente: Giancarlo TRENTINI
Vice-Presidenti: Michele CONTEL, Amedeo COTTINO
Presidente del laboratorio scientifico: Enrico TEMPESTA