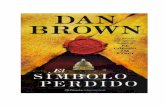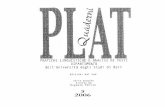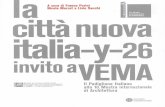Il segno a V e l'origine del simbolo di Tanit
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il segno a V e l'origine del simbolo di Tanit
31
Segni geometrici Capitolo III
I Segni a “V” e il simbolo di Tanit
Tra i motivi geometrici che decorano i manufat-ti preistorici, un posto di rilievo lo occupa sicu-ramente lo Chevron. Per la Gimbutas il simbo-lo è il risultato della reiterazione del segni a V, emblema “della Dea Uccello sin dal Paleolitico Superiore, derivato da un triangolo (triangolo pubico, vulva)... Uno dei segni principali nelle iscrizioni sacre dell’Europa antica”1.Anche se incline ad ipotizzare una diversa origi-ne dello Chevron e dei segni a “V” che lo com-pongono, non per questo intendo negare la va-lidità dell’ipotesi interpretativa della Gimbutas. Nel processo di formazione dei simboli può ac-cadere che uno stesso segno richiami idee che, per quanto possano sembrare diverse tra loro, hanno invece una loro coerenza interna. Come cercherò di evidenziare più avanti, alcune im-magini comunemente ritenute stilizzate, sono, probabilmente, il risultato di un “assemblag-gio” di segni il cui esito finale appare come una figura “stilizzata” ma, in realtà, si tratta di un compromesso stilistico frutto di una sommato-ria che, nei limiti del possibile, riesce a conser-vare anche un richiamo alle forme originarie. Si verifica in sostanza quella fusione che, sul piano concettuale, l’antropologo G. Durand definì iso-morfismi2 e cioè la somma di due o più concetti che si cristallizzano su una terza immagine che li evoca entrambi. In un’altra occasione3 ho ipotizzato che la lo-
1 M. Gimbutas 1990, p. 325. 2 G. Durand , 1972. 3 D. Orgiu, 1997.
Fig. 3.2 Statuina femminile con becco d’uccel-lo e ali al posto delle braccia che rimandano alla crescente lunare. Elementi che rivelano l’aspet-to uranico della divinità. Indossa una collana a Chevron. Cultura di Lengyel, Moravia, inizio del V millennio a. C. figure da Gimbutas
Fig. 3.1 Manufatto in terracotta antropomorfo a forma di violino interamente decorato con mo-tivi geometrici. Anatolia inizi del II millennio a.C.
32
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
sanga rappresentasse sia il ciclo della Luna, sia l’immagine della vulva (la losanga come vulva è un’interpretazione di C. Henze, condivisa anche dalla Gimbutas). Il simbolo, in altre parole mi sembrava composto da due segni a “vu”: uno dritto (V) simbolo del triangolo pu-bico e uno capovolto (Ʌ) simbolo del tempo che andavano a formare un rombo che ricorda, appunto, una vulva “stilizzata”. Oggi, a distanza di quindici anni, ritengo più verosimile che entrambi i segni che compongono la losanga derivano dall’osservazione dei moti lunari. La relazione che si stabilì tra la losanga e la vulva ha la sua spiegazione nel fatto che tutto ruota attorno al simbolismo lunare e, come spiega Eliade, la Luna è insieme reggitrice del Tempo e padrona della Fertilità Cosmica. Riassumo brevemente le ragioni per cui ritengo che entrambi i segni a “V” facciano riferimento al ciclo del Sole e della Luna, o se voglia-mo, alla ciclicità del Tempo. Se proviamo ad immaginare in che modo l’uomo del neolitico avrebbe potuto rappresentare graficamente un fenomeno che, col trascorrere del tempo, tende a crescere (così come cresce l’altezza e l’ampiezza degli archi che descrivono il Sole e la Luna), giunge all’apice (l’arco più grande, il punto più alto) e inizia a decrescere fino a giungere al punto più basso (l’arco più piccolo) per poi riprendere, immutabilmente, il suo cammino, ci accorgiamo che non sono molti i segni che riescono a riprodurre l’evento con semplicità e immediatezza. Il modo più naturale è sicuramente quello di disegnare archi concentrici a immagine e somiglianza di quelli che gli astri tracciano in cielo durante il loro percorso quotidiano (e forse non è un caso che nelle decorazioni preistoriche il motivo ad archi concentrici o che si susseguono sia così frequente). Se poi ipotizziamo che il no-stro uomo neolitico immaginasse una “traversata sottoterra” degli astri speculare rispetto al tracciato osservato in cielo, allora avrebbe potuto disegnare o una spirale o degli anelli concentrici. Un secondo segno altrettanto idoneo per rappresentare il movimento apparente della Luna e del Sole è, appunto, quello del segno a V dritto o capovolto Ʌ. Il simbolo, in entrambi i versi, si presta bene a raffigurare l’idea interiorizzata di un fenomeno che nasce,
cresce, raggiunge il suo apogeo per poi diminuire in un eterno salire e scende-re. Le figure geometriche che adornano manufatti e monumenti preistorici sono simboli quasi sempre riconducibili in maniera diretta a fenomeni naturali. Il segno a Ʌ è in pratica il tracciato del ciclo lunare o solare riprodotto su un grafico cartesiano ma, ovviamente, nella preistoria non ragionavano con ascisse e ordinate. Ma allora da dove arriva il suggerimento del segno? La risposta si trova forse in quella che è stata l’oraco-lo silenzioso dell’umanità: la Luna. È il cammino del nostro satellite che ha un andamento a zig-zag tra le stelle a ca-
Fig. 3.3 Vaso in terracotta con decorazione a zig-zag.
33
Segni geometrici Capitolo III
vallo dell’Eclittica simile al modo di procedere del serpente4 (fig. 3.7) da cui deriva proba-bilmente quel primo suggerimento che unirà la Luna al serpente e quindi alla Grande Dea. Inoltre, la Luna nel suo cammino incrocia l’Equatore Celeste ogni 14 giorni circa disegnan-do in tal modo in cielo una enorme onda sinusoidale situata a cavallo dell’Equatore. Questi fenomeni apparenti i popoli preistorici li riproducevano probabilmente a guisa di un segno a V dritto o capovolto. La posizione che assume il segno dipende dal punto di partenza che si utilizza: se si inizia dal lunistizio inferiore (il punto più basso) nascerà un segno capovolto, se invece iniziamo dal lunistizio superiore (il punto più alto) il segno risulterà dritto (fig. 3.7). Questa è, a mio avviso, una delle origini dei segni a V che si ritrovano nelle decora-zioni ed è inoltre possibile che il segno, nato come grafema del ciclo lunare, sia stato poi utilizzato per rappresentare qualsiasi fenomeno che presentasse un andamento ciclico, in primis quello solare.
4 Cfr. Brennan 1994.
Fig. 3.7 Osservando il movimento della Luna tra le stelle (si tenga presente che la Luna durante la notte si muove tra le stelle ad una velocità di circa 32’ all’ora. Cioè, in un’ora percorre uno spazio di poco superiore al suo diametro apparente che è di circa 30’) si può facilmente notare che il suo cammino non è lineare ma procede a zig-zag a cavallo dell’Eclittica e dell’Equatore Celeste. La Luna, in un anno, traccia poco più di tredici onde sinusoidali o segni a Ʌ ruotando attorno alla cupola celeste entro una fascia ben delimitata. Non è difficile trovare esempi di tale immagine nelle decorazioni dei manufatti preistorici.
34
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
Un giro completo della Luna e del Sole sul-la fascia dello zodiaco corrisponde ad un intero ciclo per i due astri. Per realizzarlo la Luna impiega poco più di 27 giorni e il Sole un anno; periodo, quest’ultimo, neces-sario anche alla natura per rinnovarsi. Cre-do sia importante tenere presente queste considerazioni poiché da questi fenomeni, e dalla rotazione quotidiana degli astri, si origina l’idea stessa del tempo circolare e il “tempo-lunare” non solo gira in cerchio ma procede pure a zig-zag.Tuttavia, pur sostenendo che il segno a V fu utilizzato per rappresentare il ciclo della Luna e del Sole, non escludo che possa con-tenere anche altri significati, né ritengo che ogni segno triangolare debba essere sempre e in ogni caso ricondotto alla nozione di ci-clo. Ritornando alla losanga, si può ora avan-zare l’ipotesi che essa sia composta dall’u-nione di due segni a V uno dritto e l’altro rovesciato, entrambi raffigurazioni del ci-clo della Luna. Ciò che ne scaturisce è un nuovo segno grafico, il rombo o losanga, che ha la capacità di ricordare sia una vulva in una forma “stilizzata”, sia il ciclo della Luna diviso in quattro fasi (più avanti al cap.VIII vedremo che anche il segno a cles-sidra, appunto formato da due triangoli uni-ti al vertice, ha probabilmente avuto origine dall’osservazione del ciclo della Luna). At-tribuendo il significato di ciclo ai segni a V che compongono sia lo Chevron sia le linee a zig-zag delle decorazioni, se ne ricavano due diverse immagini del tempo. Mentre le linee a zig-zag restituiscono un’idea di ripe-tizione, di cicli che si susseguono, lo Che-vron invece, essendo formato da una serie di cicli inseriti uno dentro l’altro, trasmette un’idea di un qualcosa che si auto-rinnova:
Fig. 3.5 I tripodi sono manufatti legati al culto della Dea Luna (Graves 1963). In questo splendido esem-plare in trachite proveniente dall’insediamento prei-storico Su Cungiau de is Fundamentas, Simaxis, la decorazione si limita a uno zig-zag che corre lungo tutta la facciata a rappresentare probabilmente il percorso in cielo della Luna.
Fig. 3.6 In alto, planimetria della tomba ipogeica di Enas de Cannuja, Bessude con il sof-fitto “strutturato” con sette travetti per falda. A destra particolare del pi-lastro della tomba decorato con lo Chevron.
35
Segni geometrici Capitolo III
In questo manufatto antropomorfo a “fia-schetto” dell’età del bronzo bulgaro, la deco-razione è formata essenzialmente da spirali contrapposte associate al segno a Ʌ. Sul da-vanti una spirale è collocata all’interno di un segno a Ʌ che ricorda lo schema della stele rinvenuta nel pozzo sacro di S. Antine di Ge-noni (fig. 3.16a). Sul retro, invece, le spirali sono poste ai lati di un segno a Ʌ similmente alla stele di M. d’Accoddi (fig. 3.17 e 3.18). Gli schemi sono molto simili, eppure le figu-
re distano tra loro per spazi e tempi incolmabili. Ciò è forse dovuto al fatto che questi simboli sono sug-geriti dalla natura ed essa, in buona parte del pianeta, si comporta allo stesso modo. Nella parte bassa del manufatto sono presenti tre archi con prolungamenti serpentini a indicare, forse, l’acqua “contenuta” nel “fiasco”. Stesso segno serpentino è presente sul collo del “contenitore” da cui “fuoriesce” l’acqua. Spirale, acqua, segno a Ʌ, contenitore e numero 3 sono tutti elementi legati alla Luna che, in questo manufatto, si trovano riuniti.
Fig. 3.4 Un triangolo aperto simile ad una “vu” dritta o capovolta fu il segno più utilizzato per rappre-sentare il tempo ciclico. Esso trae origine principalmente dall’osservazione della Luna che si sposta tra le stelle con un andamento sinusoidale. Ma il motivo del suo successo risiede anche nella capacità che ha il segno di immortalare il concetto di ciclicità e di opposizione duale. Il segno a Ʌ è l’equivalente simbolico della doppia spirale, della “spira di serpente” e della bipenne ma col vantaggio di essere più facilmente ri-producibile motivo per cui fu utilizzato anche come grafema dell’unità di misura del tempo. Il segno della Dea Tanit si compone, a mio avviso, dal “corpo” a triangolo quale rappresentazione del ciclo siderale della Luna mentre nella parte alta è il ciclo della lunazione ad essere raffigurato. Sull’ipotesi che il plenilunio e il novilunio si possano rappresentare attraverso un cerchio grande e uno piccolo (cfr. Gimbutas, 1990, p. 294).
36
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
il Ciclo che genera il nuovo Ciclo, concetto che richiama l’idea della partenogenesi e della luna-zione: “Secondo un inno babilonese a Sin, la luna è «un frutto che cresce da sé”5. La Luna rinasce dalla propria sostanza, in virtù del proprio destino (Eliade 1976). Nel complesso sepolcrale ipogei-co di Bessude, Enas de Cannuia, tomba IV, uno Chevron si trova scolpito su uno dei due pilastri della cella principale (fig. 3.6) su cui poggia una simbolica trave di spina che a sua volta regge set-te travetti per falda. Essendo i pilastri puramente simbolici, i segni su di essi incisi sono a maggior ragione carichi di significato. Se con l’incisione dello Chevron si voleva in qualche modo creare una similitudine simbolica tra la funzione del pi-lastro e quella dello Chevron, i costruttori di que-sta tomba forse intendevano il Tempo (quindi la Luna) quale «elemento portante» della vita che si rinnova, concetto quest’ultimo, espresso nella riproduzione del tetto a due falde che, come si ve-drà più avanti, potrebbe rappresentare l’anno con le due macro stagioni contrapposte.La Gimbutas scrive che “il segno grafico che ren-de nel modo più diretto il triangolo pubico è la V. Questa formulazione e il suo riconoscimento sono universali e immediati. È tuttavia stupefa-cente quanto presto questo segno “stenografico” si sia cristallizzato per diventare, nel corso dei millenni, il segno specifico della Dea Uccello”6. Riprodurre la Dea nelle sembianze di un volatile, o con qualche suo attributo, rivela l’aspetto ura-nico della Dea; essa “volava” in cielo come gli uccelli e il segno a V che spesso l’accompagna è, probabilmente, il simbolo del ciclo siderale del-la Luna. Il circuito Dea-Luna-uccello-triangolo è riscontrabile anche nelle scene riprodotte sulle steli cartaginesi (fig.3.8a 3.16b) dove i simboli si trovano spesso riuniti. Nella Sardegna preistorica, la Dea Luna nelle sembianze di uccello è forse rappresentata dalle colombelle che compaiono nei manufatti della cultura post-nuragica, in partico-
4 M. Eliade, 1976, p. 1865 M. Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, 1990, p. 3
Fig. 3.8 Stele votiva cartaginese con due tor-torelle dal collare collocate ai lati di una mano destra simbolo della Vita. Sotto, la Dea Tanit con il classico corpo a triangolo, immagine del tempo ciclico e della Luna stessa. La Dea ha nelle mani (o forse in sostituzione delle mani) due falci lunari contrapposte e una testa rotonda composta da due cerchi concentrici che fanno pensare al novilunio e al plenilunio. Le «mani» e la testa nell’insieme formano in tal modo il ciclo della lunazione. Anche la posizione delle due tortorelle (situate sopra uno zig-zag luna-re), rimanda alla lunazione con i corpi degli uccelli che rappresentano i due quarti di Luna contrapposti a schema bipenne.
Fig. 3.9 Tortorella dal collare. Il colore e la sa-goma del corpo dell’uccello rimandano al semi disco lunare.
37
Segni geometrici Capitolo III
lare nelle barchette-lucerne che, come vedremo, appartengono alla simbolo-gia lunare. Gli uccelli riprodotti nelle steli cartaginesi sembrerebbero torto-relle dal collare (fig. 3.9), un animale dal corpo a mezza luna e spesso anche dal colore lunare. Il fatto, poi, che il più delle volte gli uccelli si presentino in coppia rafforza l’ipotesi che si tratti di un rimando ai due quarti di Luna che assumono una posizione con-trapposta allo stesso modo di come vengono solitamente rappresentati gli uccelli nelle steli. La mano destra posta tra le due colombelle, è quella della Dea-Tanit-luna. È la mano buo-na, quella creatrice, la corrispondente della crescente. È posta ritta a indica-re la forza vitale che per natura tende verso l’alto contrariamente alla forza distruttiva e la morte che tende verso il basso. Questo gesto della mano alza-ta che è divenuto un diffusissimo se-gno di saluto, ha conservato invariato
Fig. 3.10a Tramonto del Sole all’equino-zio visto dalla finestrella centrale del nu-raghe S. Millanu. Si consideri che i due pertugi hanno una profondità di circa 145 cm e una sezione di 35x35. Sono in pratica delle mire che possono inquadrare solo un ristretto spazio di orizzonte. Sul punto in cui tramonta il Sole permangono le rovine del Nuraghe Margini situato sul ciglio del-la Giara di Gesturi
Fig. 3.10b Tramonto del Sole sul Monte S. Antine visto dalla finestrella più alta del nuraghe S. Millanu. Sul piccolo altipiano sono presenti diverse situazioni archeolo-giche tra cui il nuraghe omonimo situato sull’estrema destra. Invece in direzione in cui vediamo tramontare il Sole giace un pozzo sacro profondo 39 metri che ha re-stituito numerosissimi reperti.
Fig. 3.11 L’interno della torre centrale del nuraghe S. Mil-lanu con le tre finestrelle poste a diversa altezza. É difficile immaginare una funzione pratica di questi pertugi. Troppo piccoli e male esposti per poter essere considerati dei lucer-nai e non credo possano trattarsi neppure dei fori delle travi di appoggio di una ipotetica rampa esterna, poiché solo due di essi potrebbero ospitare una trave, pertanto insufficienti a sostenere una rampa. Inoltre sarebbe davvero una singo-lare coincidenza che le due travi (e il nuraghe) risultassero casualmente allineate col solstizio e con l’equinozio e, in aggiunta, sui punti dell’orizzonte su cui calano gli astri sia-no presenti costruzioni nuragiche.
38
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
fino ai nostri giorni il significato originario che ritengo sia, appunto, quello di «forza vitale», quindi salute, in ultima analisi, Vita.Tornando ai segni triangolari, sono dell’opinione che conservino in sé il duplice significato sia di triangolo pubico sia di tempo ciclico e che nell’iconografia antica, la seconda accezio-ne, prevalga largamente sulla prima.Vediamo altre situazioni a supporto di quanto vado proponendo sul significato e genesi del segno “triangolare”. Nella torre centrale del nuraghe Santu Millanu situato nel territorio di Nuragus sono presenti tre finestrelle poste a diversa altezza e sfalsate tra loro. Quella più in alto è orientata verso il tramonto del Sole al solstizio d’estate (vedi fig. 3.10b), quella centrale verso il tramonto all’equinozio (fig. 3.10a). La terza finestrella invece è di confor-mazione diversa dalle altre due, più stretta e, se osservata dall’esterno, sembra direzionarsi verso il basso sbucando nella parte alta della nicchia collocata sulla sinistra per chi entra nel nuraghe. Purtroppo, il crollo delle parti alte della tholos impedisce la sua misurazione o l’os-servazione diretta del Sole. Tuttavia, sebbene sarebbe stato utile verificare l’orientamento della terza finestrella, non è comunque indispensabile al fine di capire come può nascere un
Figura astratta femminile in osso decorata con una serie di segni a Ʌ e una losanga sul ventre. Cultura Epigravettiana, Romania; 8000 a.C. circa.Anche in questo caso le forme triangolari pur trovandosi in prossimità della vulva sono “stranamente” rovesciate e fanno da soste-gno ad una losanga decorata internamente con linee orizzontali ad indicare forse l’ac-qua amniotica.Acqua, losanga e segni triangolari dritti e capovolti sono qui riuniti in un complesso simbolico che tratta probabilmente il legame tra la Luna e la fecondità.
figura da Gimbutas
Fig. 3.16a Stele rinvenuta nel pozzo sacro di S. Antine di Genoni. Anche in questa stele similmente a quella di M. d’Accoddi si trovano associati il segno a “Ʌ” e la spirale, simboli dei cicli lunari.
39
Segni geometrici Capitolo III
simbolo. Ad una foto scattata all’interno del nuraghe (fig. 3.11) ho aggiunto una linea obliqua che congiunge le finestrelle per evidenziare come nella mente dei costruttori fosse associata alla fase ascendente del Sole un’idea di crescita in altezza e, ovviamente, di spostamento verso destra. Si consideri che per realizzare l’allineamento era sufficiente sfalsare le finestrelle di circa trenta gradi, ma non era necessario situarle ad altezze diverse. I mastri costruttori avrebbero potuto tranquillamente, e forse anche più agevolmente, collocarle sullo stesso filare invece le hanno sistemate quasi a formare una scala. Le finestrelle del S. Millanu possono suggerirci, quindi, che una linea obliqua inclinata ver-so destra può contenere, concettualmente, l’idea della fase ascendente, di crescita del Sole e della Luna pertanto equiparabile, secondo quanto detto finora, alla spirale che si apre in senso orario e al quarto di Luna crescente; tutti e tre sono simboli che rappresentano la fase creativa. Ovviamente per rappresentare l’intero ciclo del Sole o della Luna deve seguire ad
Fig. 3,16b La Dea Tanit è una divinità notoriamente legata alla Luna e alle prerogative lunari. Anche in queste incise su delle steli puniche sembra abbastanza evidente che la Dea abbia in “mano” (o più probabilmente in sostituzione delle mani a indicare il doppio potere della Dea) le due falci lunari della crescente (la sua “mano destra”) e della calante contrapposte a schema bipenne. Il segno sem-brerebbe composto in definitiva dalle rappresentazioni di due cicli lunari: nella parte alta costituita dalla testa e dalle mani si riproduce le fasi della lunazione e nella parte bassa con la forma triangolare del corpo, è il cilco siderale ad essere raffigurato. figure tratte da: www.commons.wikimedia.org
40
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
una prima linea ascendente una seconda discendente che, a rigor di logica, la si deve in-tendere sovrapposta alla prima. Fu, invece, riprodotta anche in maniera contrapposta - così come accadde per la spirale - sia per evidenziare le due fasi che si oppongono, sia perché l’identificazione dei segni a Ʌ col Ciclo era suggerito o confermato anche dal cammino a zig-zag della Luna in cielo dove l’astro traccia un “segno a Ʌ” ogni mese siderale. Infine và considerato che il futuro, anche in una concezione del tempo ciclico, è proiettato in avanti. Nell’incisione riprodotta sopra il portello della celletta d’ingresso della tomba ipogeica di Corongiu a Pimentel (fig. 3.12 e 3.13), la parte centrale della raffigurazione è composta da uno zig-zag su cui poggia il piede di una doppia spirale contrapposta. In alto a destra un altro segno, una seconda doppia spirale e, sul finire dello zig-zag, degli anelli concentrici. Una prima considerazione che si può fare è che, in questo caso, la doppia spirale non può essere ricondotta alle corna dell’ariete perché ha le spire che si attorcigliano verso l’interno. Ciò dimostra che il simbolo non deriva dalla riproduzione delle corna dell’ariete, ma ha un valore proprio e sono casomai gli animali ad acquistare sacralità quando sono in possesso di questo attributo e non viceversa. Nel disegno si può inoltre notare che lo zig-zag è composto da una serie di 9 e ½ segni a Ʌ. Ora, se interpretiamo i segni quale immagine del trian-
Vaso finemente decorato con diversi simboli tra cui tre zig-zag posti inclinati a destra e formati ognuno da 9 e ½ segni a Ʌ. Cucuteni A2, Moldavia; 4500 a.C.
Fig. 3.14 Segni a V nella Tomba delle Spirali della necropoli di Montessu, Villaperuccio.
41
Segni geometrici Capitolo III
golo pubico, diventa difficile capire la ragione per cui lasciarono un “triangolo pubico” a metà. Se, invece, attribuiamo al segno il significato di ciclo, in questo caso della lunazione, non solo scompa-iono le anomalie, ma spunta anche una gradita sorpresa. Nove lunazioni e mez-zo è, infatti, il tempo di gestazione della donna 29,5x9,5=280,25= 40 settimane, perciò è probabile che il pannello tratti temi legati alla rigenerazione e alla ri-nascita del defunto. Nella Tomba del-le Spirali della necropoli di Montessu, i segni a Ʌ si trovano su due registri: il primo (fig.3.14) è composto da sette segni dritti mentre nel secondo i segni
sembrerebbero rovesciati e di diverso tipo rispetto ai primi tant’è che fa pensare che non si tratti dello stesso segno. Di seguito vedremo che il numero sette è riconducibile al concetto
Fig. 3.12 Celletta d’ingresso della tomba ipogeica di Corongiu, Pimentel (CA).
Fig. 3.13 Riproduzione del disegno inciso nella tomba di Corongiu. disegno da Tanda
42
Donatello Orgiu La Dea Bipenne
di creazione, di rinnovo della Natura e pertanto - secondo l’interpretazione che propongo - è possibile che anche i sette segni a V della tomba indichino il rinnovo, in questo caso, forse, della “vita” del defunto. Gran parte dei segni che adornano le tombe ipogeiche del neolitico sardo sono riconducibili alla simbologia lunare. La doppia spirale del “pannello” della tomba di Corongiu, ad esempio, è più comprensibile se riferita al percorso lunare, piuttosto che a quello solare essendo, appunto, la Luna legata alle nascite e alle rinascite. Il fatto poi che il suo prolun-gamento si unisca materialmente come un cordone ombelicale allo zig-zag, può voler dire che sussisteva un legame tra la Luna e la gestazione. Si riteneva probabilmente che la Luna fosse influente sulla fecondità e avrebbe contribuito alla rigenerazione del defunto.Il segno a Ʌ è forse l’elemento più presente nell’iconografia della Sardegna preistorica e ogni volta che lo si incontra non è difficile avvicinarlo al simbolismo lunare. Prendiamo ad esempio le due steli rinvenute una a Monte d’Accoddi (fig. 3.17 e 3.18) e l’altra nel pozzo sacro di S. Antine di Genoni (fig. 3.16a). Esse sono separate da una distanza temporale di oltre mille anni eppure hanno tanto in comune. La prima, ritenuta comunemente la testa di una Dea, ha due spi-rali al posto degli occhi e un segno a Ʌ come naso. Se l’ipotesi ricostruttiva è veritiera, le due spirali col segno triangolare risultano, per quanto detto in precedenza, l’unione dei due simboli del ciclo della Luna (siderale e draconico) elegantemente trasformati nell’immagine astratta di un volto umano. Il segno è concettualmente molto vicino a quello della Dea Tanit (formato dall’unione del ciclo sinodico e siderale), ma sul piano artistico credo che l’opera sarda sia no-tevolmente superiore. Nella seconda stele, invece, compare un triangolo su cui è inscritta una spirale. In entrambe si trova quindi una forma triangolare col vertice in alto associata alla spirale e in quella del pozzo di S. Antine il legame è evidentemente anche con l’acqua e di conseguenza con la Luna.
Fig.3.17 Stele rinvenuta a M. d’Accoddi. Fig. 3.18 Ipotesi ricostruttiva della stele. disegno da Contu