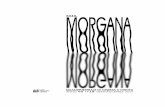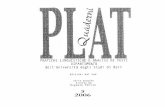Cartesio. Segno e linguaggio
Transcript of Cartesio. Segno e linguaggio
SommarioDaniele Gambarara. Il sogno di Cartesio
Claudia Stancati. Cartesio: segno e linguaggioIl linguaggio in CartesioLa terminologia scientificaUn modello linguistico della conoscenza della natura: il cifrarioUn modello semiotico della percezioneIl significato filosofico del paragone col linguaggioIl linguaggio come "testimone" della menteCartesio nella storiografia filosofica e linguisticaUna mappa dei testi
Antologia di testi
Tavola delle abbreviazioni
T 1 Manoscritto 1619-21T 2 Regole per la guida dell'ingegno 1627-8T 3 Lettera VI a *** 1628T 4 Lettera X a Mersenne 8 ottobre 1629T 5 Lettera XV a Mersenne 20 novembre 1629T 6 Lettera a Mersenne 18 dicembre 1629T 7 Lettera a Mersenne gennaio 1630T 8 Lettera a Mersenne 4 marzo 1630T 9 Il mondo o trattato della luce 1633T 10 L'uomo 1633T 11 Discorso sul metodo 1637T 12 Diottrica 1637T 13 Lettera CXIII a Rénéri per Pollot aprile-maggio 1638T 14 Lettera CLXXIV a Mersenne 16 ottobre 1639T 15 Lettera CXCIX a Mersenne 30 luglio 1640T 16 Lettera CCXXXVI a Mersenne per Hobbes 21 aprile 1641T 17 Lettera CCXXXIX a Regius maggio 1641T 18 Lettera CCXLV a Mersenne luglio 1641T 19 Lettera CCXLVIII a Mersenne 22 luglio 1641T 20 Meditazioni sulla filosofia prima 1641T 21 Obiezioni di alcuni dotti uomini contro le precedenti Meditazioni 1647T 22 I principi della filosofia 1647
2
T 23 Lettera CCCLXVII a Mesland 9 febbraio 1645T 24 Lettera CDXVIII a*** 1645 o 46T 25 Lettera CDXL al Marchese di Newcastle 23 novembre 1646T 26 Lettera CDLXVIII a Chanut 1 febbraio 1647T 27 Colloquio con Burman aprile 1648T 28 Le passioni dell'anima 1649T 29a Lettera DXXXI di More a Cartesio 11 dicembre 1648T 29b Lettera DXXXVII a Henry More 5 febbraio 1649T 29c Lettera DXLIV di More a Cartesio 5 marzo 1649T 30 La ricerca della verità mediante il lume naturale
Bibliografia
Indice dei nomi
3
CARTESIO: SEGNO E LINGUAGGIO
Il linguaggio in Cartesio
Il pensiero di Cartesio è stato oggetto di un appassionatodibattito scientifico e filosofico fin dal momento dellapubblicazione delle sue opere maggiori. Egli fu consideratonel suo secolo l'ispiratore sia di posizioni filosoficheortodosse o addirittura apologetiche, come l'occasionalismo,sia di un sistema metafisico, come quello di Spinoza, ritenutoassai pericoloso per ogni religione e fu guardato conreverente ma "distante" ammirazione dai protagonistidell'Illuminismo1.Anche in seguito l'interpretazione del suo pensiero si èvariamente composta con l'orientamento teorico di chi lo haaffrontato, mettendone in ombra, di volta in volta, alcuniaspetti come appunto è accaduto per la centralità dellanozione di segno o l'uso specificamente teoretico del modellodel linguaggio. In effetti, benchè l'attenzione filosofica versoil linguaggio sia un tratto costante di tutta la vicendaintellettuale di Cartesio, tale caratteristica è rimasta quasidel tutto "sommersa", fino alla pubblicazione, nel 1966,dell'opera Linguistica cartesiana di Noam Chomsky, in cui il celebrelinguista americano fa risalire a Cartesio un'impostazione delproblema dei rapporti tra mente e linguaggio che gli sembraanticipatrice di problemi e soluzioni propri del nostrosecolo. Certamente, come si può constatare scorrendo le paginedella bibliografia, la proposta interpretativa di Chomsky hamolti limiti sul piano della filologia cartesiana e risultaanacronistica sul piano della storia delle idee linguistichein senso stretto, ma è proprio in seguito "all'errore memorabile" (JOLY 1977) di Chomsky, cheil pensiero di Cartesio si è trovato al centro non solo deldibattito sulla storia delle dottrine linguistiche, ma anchedelle discussioni che si sono svolte in un altro dei settorinodali della ricerca contemporanea: quello della filosofia
1Spallanzani, Mariafranca (1990), Immagini di Descartes nell'Enciclopedia, Bologna, Il Mulino.
4
della mente. I testi presentati in questa antologia sono passidelle opere e lettere da cui risalta l'interesse di Cartesioper il linguaggio, così come sono dedicate specificamente allinguaggio le voci della bibliografia, tuttavia, comecercheremo di chiarire brevemente, gli aspetti connessi a talediscussione sono necessariamente molteplici e l'aspetto piùpropriamente linguistico non può che essere il punto dipartenza per affrontare questioni filosofiche più ampie.L'idea di lingua che Cartesio fa sua, e che condivide conaltri filosofi dell'epoca, tanto empiristi quantorazionalisti, è incentrata sull'arbitrarietà del segno e/osulla convenzionalità del linguaggio e nasce dalla convinzioneche la ragione è precedente e in gran parte indipendente dallinguaggio; anche se nel XVII secolo sopravviveva ancoralargamente nella cultura europea una concezione magico-ermetica del linguaggio come simbolo, secondo la quale laconnessione tra segno e referente è fondata su una qualcheforma di somiglianza, un'idea che Cartesio pare aver condivisoin gioventù ma non si preoccupa nemmeno di confutare nelle sueopere più mature2.Per quanto riguarda la sua idea di lingua, Cartesio laillustra nella citatissima lettera a Mersenne in cui discuteun progetto di lingua universale e in cui rivolge, tral'altro, la sua attenzione anche al tema del rapporto tralessico e grammatica (L. Mer. 20 11 1629 T 5). Possedere illessico di una lingua non è sufficiente, è la grammatica lachiave del codice linguistico, dei nessi associativi, dellemolteplici regole d'uso che possono trasformare un elenco divoci lessicali in una lingua. Ma poiché le regole grammaticali
2Delle opere giovanili di Descartes non ci è rimasto quasi nulla e i frammenti chepossediamo sono filtrati da Leibniz e da Adrien Baillet suo primo biografo (Vie deMonsieur Des-Cartes, 1691, trad. it. Milano, Adelphi, 1996); per i rapporti con il pensierorinascimentale in questi primi scritti v. Bortolotti, Arrigo (1983), Saggi sulla formazionedel pensiero di Descartes, Firenze, Olschki. Sull'evoluzione della nozione di segno e diarbitrarietà e sui rapporti tra queste concezioni e quelle magico-ermetiche dellinguaggio durante il Rinascimento, si veda Demonet, Marie-Luce (1992), Les voix du signes.Nature et origines du langage à la Renaissance (1480-1580), Paris-Genève, Champion-Slatkine, lavoroinformatissimo ma che si inserisce in quella corrente di studi che tende retrodatare lanascita del concetto di arbitrarieta semiotica. Al confronto sottolinea le differenzetra arbitrarietà antica e moderna e concezioni saussuriane: Gambarara, Daniele (1995)"The Convention of Geneva. History of linguistic ideas and history of communicativepractices", in: L. Formigari-D. Gambarara edd., Historical Roots of Linguistic Theories, Amsterdam-Philadelphia, 279-94.
5
si formano con l'uso e senza obbedire ad un piano razionale,spesso sono determinate da ragioni di pura eufonia e non sonofinalizzate alla traduzione del pensiero in parole. L'idealesarebbe una lingua senza grammatica, o meglio retta da unagrammatica puramente logica, che traducesse l'ordine naturaledei pensieri in parole o in caratteri grafici, senza lamediazione di regole convenzionali.Cartesio non si dedica allo studio sistematico delle lingue edelle loro strutture. Quello che gli interessa è il meccanismogenerale del significare, convinto com'è che poco conta lamolteplicità delle forme verbali rispetto all'unicità eall'univocità delle regole del pensare che finiscono percoincidere con le regole più profonde del significare.Se dunque Cartesio, come appare anche dalla lettera a Mersenneche abbiamo ricordato, non intende in alcun modo sovvertire lapreminenza del pensiero sul linguaggio (DASCAL 1996) qualesenso ha oggi tornare a riconsiderare il linguaggio nellafilosofia cartesiana? Forse perchè, come ancora recentementeha ripetuto Chomsky (CHOMSKY 1993, 35-36), i problemi postinel XVII secolo, tra gli altri anche da Cartesio, non sonoancora stati risolti, nonostante i notevoli progressi dellalinguistica e delle neuroscienze? O perché è ancora veroquello che ha scritto Joly (1986) che, per quanto riguarda illinguaggio e i segni, la filosofia cartesiana attende ancorauna valutazione complessiva?3
A mio avviso, non è nelle idee specificamente linguistiche diCartesio che può ritrovarsi per noi l'interesse ad unarilettura, bensì nel complesso intreccio tra la nozione disegno, l'immagine del linguaggio e della scrittura e i luoghiteorici più importanti della sua filosofia, un intreccio cherisulta tanto forte da connotare complessivamente l'ideacartesiana della mente. Il primo di questi luoghi è senz'altro3
"Descartes' approach to language has never been investigated thoroughly and it hasgiven rise to conflicting interpretations. According to most commentators, Chomsky'sessay (1966) offers a distorted view of Cartesian linguistics (e. g., Salmon 1969,Aarsleff 1970, 1971; Joly 1977) Descartes' contribution to the development of semioticand linguistic analysis has to be reevaluated" JOLY 1986 185) ("L'atteggiamento diDescartes nei confronti del linguaggio non è stato mai indagato in modo completo e hadato luogo a interpretazioni contrastanti. Secondo molti commentatori (per es. Salmon1969, Aarsleff 1970, 1971; Joly 1977) il saggio di Chomsky (1966) offre una visionedistorta della linguistica cartesiana pertanto il contributo di Descartes allo sviluppodell'analisi semiotica e linguistica dovrebbe essere riconsiderato").
6
l'interesse per il rinnovamento e la messa a punto dellaterminologia scientifica e filosofica (§ 2.2), il secondoquello dell'utilizzazione di un modello semiotico dellaconoscenza fisica e della percezione (§§ 2.3 e 2.4), il terzoquello per cui la relazione tra parola e significato èl'immagine più rispondente a illustrare uno dei nodifondamentali del suo pensiero: il rapporto tra l'anima e ilcorpo (§ 2.5), infine il linguaggio, in quanto segnodistintivo dell'uomo dall'animale-macchina, assurge al ruolofondamentale di unico testimone della mente (§ 2.6).
La terminologia scientifica
Per Cartesio, come per molti altri filosofi dell'epoca, illinguaggio, compreso il linguaggio comune, anche quando noncerca di nascondere il pensiero come negli oracoli, può esseredi ostacolo alla comprensione e alla chiarezza, poiché sipresenta come originariamente dotato di grande vaghezzasemantica, e spetta all'uso di insegnarci a restringernel'indeterminatezza (L. Cha. 1 2 1647 T 22; III Obj. AT IX). Inquesto senso egli ritiene che un'opera di chiarificazione dellinguaggio e di definizione accurata dei termini utilizzatisia essenziale per ogni esercizio scientifico. Come apparesoprattutto dalle numerose notazioni presenti nellacorrispondenza, Cartesio è attentissimo ai significati delleparole e in particolare alle loro accezioni filosofiche4. Sonocentrate sulle questioni terminologiche, che egli consideradeterminanti per l'argomentazione filosofica, anche leobiezioni scambiate con Hobbes e Gassendi sulle Meditazionimetafisiche. Alle osservazioni di Hobbes Cartesio ribatte che"fintanto che questo filosofo non vuol convenire con me sulsignificato delle parole, non può che avanzare obiezioniinconsistenti " (III Obj. AT IX, 143); a Gassendi eglirimprovera di fondare le sue critiche su un "cavillo",
4
La L. a *** 3 1638 AT II, 34-47 (T 13) parla di langue de philosophe, ma le osservazioni diquesto tipo sono numerose anche nelle opere; v. per es.: Regulae XIV AT X 438-52 (T 2);L. Mor. 13 7 1638; Méd. Mét. VI AT IX, 61 e sgg. dove distingue le possibili accezionidel termine natura; Princ. Ph. I § 51 AT IX, 46-7.
7
sull'abuso delle parole (V Obj AT IX, 205) sull'equivocità deitermini (ivi, 207).Le questioni del linguaggio e della terminologia scientificaallora in formazione (MORTUREUX 1973) sono al centro deldibattito anche nello scambio di lettere che Cartesio ebbe conMorin, e che è particolarmente illuminante per la suacollocazione rispetto alla cultura scientifica del tempo. Sitratta di una lunga e approfondita discussione dei principi edei metodi della fisica cartesiana, dei rapporti traesperienza e ipotesi, dell'atteggiamento di Cartesio neiconfronti della Scolastica. Scrive Cartesio: "c'è una grandedifferenza tra provare e spiegare. Al che aggiungo che si puòusare il termine dimostrare per esprimere l'una e l'altra(cosa), per lo meno se lo si prende nell'accezione comune enon nel significato particolare che vi annettono i Filosofi"(L. Mor. 13 7 1638 AT II, 197-98). A Cartesio Morin rispondeproprio rivendicando il valore del lessico filosoficoscolastico; infatti, se la Scolastica si è occupata poco dellaverità delle cose, osserva Morin, ha tuttavia fissato, in modoegregio, il dizionario "dei termini di cui bisogna servirsiper trattare le cose" (L. di Mor. a C 22 2 1638, AT I, 541).Nonostante quanto afferma Brunot5, Cartesio ritiene che lacostruzione di un linguaggio scientifico debba essere unodegli esiti necessari del suo percorso intellettuale. Inparticolare si dedica alla riforma della notazione algebrica,considerando il simbolismo matematico come un linguaggio incui la parola diventa segno puramente razionale e tantoappropriato alle idee da poterle sostituire (PALA 1990,LOJACONO 1996). Nel 1619 Cartesio adotta ancora la notazionedi Clavius, poi, tra il 1628 e il 1637, tra le Regole e laGeometria, egli elabora e perfeziona la notazione algebrica checi è oggi familiare (Regulae XVI, 305 T 2).
5Nella sua Histoire de la langue française des origines à nos jours, Brunot scrive: "Lorsque Descartesrésolut de parler de philosophie et de science dans la langue de son pays plutôt quedans celle de ses précepteurs (Disc. Méth.,VI; L. Mor. 22 2 1638) il semblait qu'il dûtposer du même coup le problème de la constitution d'un vocabulaire scientifiquefrançais. Il n'en fût rien cependant (...) ni le maître, ni les disciple, ni ses émulesne s'intéressèrent vraiment à cette question, ou, plutôt ils se la posèrent d'unemanière telle que le lexique n'en pouvait être profondément modifié", Ferdinand Brunot1930, 1966-722, VI, I, 25.
8
La nozione di segno trova applicazione nella notazione logico-matematica, nell'Algebra, nella Geometria e nella Mathesisuniversalis (Regulae X, 267 T 2) e anche nella fisica.
Un modello linguistico della conoscenza della natura: il cifrario
Molto si è scritto sulla centralità della nozione di segnonella filosofia di alcuni celebri contemporanei di Cartesio,quali Hobbes e Gassendi6. Uno stimolo a riconsiderare lanozione di segno in Cartesio, e con essa i suoi apporti allateoria linguistica, è venuto invece solo relativamente direcente da quegli studiosi che, in differenti contesti, hannomesso in rilievo il ruolo che questa nozione ha tanto nellafisica, che nella teoria della percezione (PALA 1990, CAVAILLÉ1991, SÉRIS 1995). Per questi interpreti la fisica cartesianasi presenta come una semiotica poiché si propone di studiare'oggetti' (e regole) non accessibili (o non immediatamenteaccessibili), per mezzo di 'segni' comunemente accessibili(PALA 1990, 158). La condizione per quest'uso dei segni è cheessi presentino, con gli oggetti indagati, analogie ecorrispondenze tali da da poterne fornire un'adeguatarappresentazione, analogie e corrispondenze regolate però nondalla somiglianza bensì dalla dissimiglianza edall'anamorfosi, ossia da quella "deformazione" prospetticache consente una visione corretta solo quando ci si ponga daun determinato punto di vista7.La ricerca cartesiana è improntata a un'idea della scienzacome ordine razionale. Infatti, fin dallo scritto noto comeCogitationes privatae (1619 circa), Cartesio sostiene che un ordinescientifico tale "che le immagini si formano in una reciprocadipendenza" (Cog. Priv. AT X 230, OF I, 204) può innanzitutto6
Nella filosofia di Gassendi appare assai più ampio il ruolo dei segni naturali ed inHobbes, grazie anche all'interesse per le questioni politiche, il ruolo dei segni èegualmente assai esteso e la loro classificazione assai ben delineata. V. Bloch,Olivier (1980), La philosophie de Gassendi, La Haye, M. Nijoff,e Zarka, Yves Charles, (1992)"Principes de la sémiologie de Hobbes", in Hobbes e Spinoza. Scienza e politica. Atti del ConvegnoInternazionale Urbino 14-17 ottobre 1988, a c. di Daniela Bostrenghi, Intr. di E. Giancotti,Napoli, Bibliopolis, 313-352; si veda inoltre GUENANCIA 1990.7
MARION 1973, 1981; CHEVALLEY DE BUZON 1979; BEYSSADE 1981; BONICALZI 1987, 1990 A;CAVAILLÉ 1991; JUDOVITZ 1996. Cfr. Baltrusaitis, Jurgis (1955), Anamorphoses, Paris;trad. it. Anamorfosi o Thaumaturgus opticus,, Milano, Adelphi, 1978.
9
aiutare la memoria (ROSSI 1960). Inoltre, come emerge consempre maggiore evidenza dalle sue opere successive, l'ordinedella conoscenza è istituito artificialmente e ricostruitoipoteticamente (Méd. Mét. I AT IX, 15), specialmente in queicampi del sapere che, come fisica, medicina e astronomia,hanno un minor grado di certezza. Come nella lettera a Moringià citata, nel Mondo il progetto epistemologico di Cartesio èdescritto in questi termini: "Il mio progetto non consistetanto nello spiegare, come loro fanno, le cose che sonoeffettivamente nel vero mondo, ma soltanto di immaginarne unoa piacere in cui non vi sia nulla che le menti più rozze nonsiano in misura di concepire e che possa tuttavia esserecreato esattamente come lo avrò immaginato" (Mon. AT XI, 36,OF I, 147)8.È un profondo intreccio di ragioni epistemologiche e dipresupposti metafisici che conduce Cartesio all'uso delmodello della decodificazione di un cifrario per spiegare laconoscenza della natura in testi che vanno dalle Regole per laguida dell'ingegno (1628), (T 2) fino ai Principi della filosofia (Prin.Ph. IV §205 T 22). L'uomo, unico in tutto il creato, partecipadella capacità di utilizzare e decifrare più sistemisimbolici, e può attraverso la ragione e l'esperienza tentaredi impadronirsi del codice della natura.Ai cifrari Cartesio si dedica in realtà anche per utilizzarlipersonalmente. In una lettera del settembre 1646 allaprincipessa palatina Elisabetta (AT IV, 485-94), in unposcritto per noi perduto, suggerisce l'uso di un cifrario,come veniamo a sapere dalla risposta di Elisabetta: "Hoesaminato il cifrario che mi avete mandato, e lo trovo assaibuono, ma troppo prolisso per scrivere un testo lungo; e se sidovessero scrivere solo poche parole, se ne troverebbefacilmente il senso mediante la quantità delle lettere.Sarebbe meglio creare una chiave di parole con l'alfabeto, epoi trovare un segno distintivo tra i numeri che sostituisconole lettere e (le lettere) che sostituiscono le parole " (L. diEli. a C. 10 10 1646 AT IV 519-24, 524).Ma non si tratta di un semplice divertissement. Della centralitàe dell'importanza del concetto di 'cifrario' in Cartesio e8
Si veda in proposito anche L. Mer. 10 5 1632 AT I, L. Mes. 16 5 1645 AT IV.
10
della sua connessione col tema delle verità eterne, nonpossiamo dubitare. Su questo tema torna infatti, discutendocon Lamy, uno degli interpreti più acuti del tema delle veritàeterne in Cartesio: Antoine Arnauld: "Descartes ha paragonatoil mondo creato da Dio ad una lettera scritta con un cifrario.Vedere le diverse opere nelle loro idee eterne equivarrebbeconoscere le opere grazie alla rivelazione del cifrario. Ma èproprio ciò che si guardato bene dall'attribuirsi"9. Che questasia una chiave di lettura possibile e fondata, è dimostratodal fatto che su questi due punti verte la revisione delcartesianesimo operata da Spinoza, fino ad eliminare ognilibertà dai decreti divini e ogni traccia di semiosi dallaconoscenza, per instaurare in entrambi il regno assoluto dellanecessità10. La teoria arbitrarista delle verità eterne miraproprio in Cartesio al ripudio della teorie scolastiche e loguida alla teoria semiologica della percezione e a dare"centralità e valore paradigmatico" al linguaggio e agli altrisistemi di segni umani (CAVAILLÉ 1991, 77). Tuttavia egliutilizza questa centralità in quei gradi e in quei settoridella conoscenza in cui opera "la puissance de jujer" che è lafacolta di istituire connessioni . Si tratta di una facoltàche può ingannarci, il che non avviene invece là dove entranoin gioco le verità analitiche, assolutamente evidenti.Per ciò che riguarda questo tipo di verità, cioè le veritàdella logica che sono a fondamento del sapere matematico,Cartesio dice che la loro necessità non eccede i limitidell'intelletto umano (L. Mer. 6 e 27 5 1630 AT I) e nelleMeditazioni metafisiche aggiunge a questo riguardo che "tramite ilsolo intelletto non affermo e nego alcuna cosa, ma concepisco9
Arnauld, Antoine (1693), Règles du bon sens pour bien jujer des écrits polémiques dans des matières descience, appliquées a une dispute entre deux théologiens touchant cette question métaphysique: si nous ne pouvonsvoir les vérités nécessaires et immuables que dans la vérité souveraine et incréée?, in Oeuvres, Paris etLausanne, 1775-1783, 43 voll., t. XL, 153-260, 165-166. Cfr. PÉCHARMAN 1995.
10Landucci, Sergio (1992), "Sulle 'verita eterne' in Spinoza, in Hobbes e Spinoza. Scienza epolitica. Atti del Convegno Internazionale Urbino 14-17 ottobre 1988, cit., 23-51, Id., (1986), La teodiceanell'eta cartesiana, Napoli, Bibliopolis. Una discussione d'insieme ormai "classica " deirapporti tra Spinoza e Descartes è quella di Lachièze-Réy, Pierre (1950), Les originescartésiennes du Dieu de Spinoza, Paris, Vrin, ma si veda anche: Scribano, Maria Emanuela,(1988), Da Descartes a Spinoza. Percorsi della teologia razionale nel Seicento, Milano, Franco Angeli. SuSpinoza e il linguaggio si veda Bove, Laurent (1991), "La théorie du langage chezSpinoza", L'enseignement philosophique, 41, n. 4 mars-av., 16-33.
11
solamente le idee delle cose che posso affermare o negare"(Méd. Mét. IV AT IX, 45). Del resto il concetto di verità èespresso da Cartesio in una lettera a Mersenne del 16 ottobre1639 in questi termini: "Così si può spiegare quid nominis acoloro che non capiscono la lingua e dire che questa parolaVerità in senso proprio denota la conformità del pensiero conl'oggetto, ma che quando la si attribuisce alle cose che sonofuori del pensiero, significa soltanto che le cose possonoessere oggetto di pensieri veri, sia nostri sia di Dio, ma nonsi può dare alcuna definizione di tipo logico che aiuti acomprenderne la natura" (L. Mer. 16 10 1639 T 14).
Un modello semiotico della percezione
In Cartesio, l'intreccio tra il radicale dualismo dellesostanze e l'arbitrarismo delle verità fondamentali estende ilcampo dell'attività semiotica a tutto ciò che è fuori dalpensiero, cioè oltre che alla fisica anche alla percezionesensibile, poiché "non v'è nulla che sia interamente in nostropotere se non i nostri pensieri" (L. a *** 3 1638, AT II, 34,OF I, 584 T 13).È possibile così istituire una corrispondenza tra due sistemisemiotici: le leggi naturali volute da Dio e i segni arbitraridi istituzione umana, ed è in questo senso che è presente inCartesio la nozione anche se non il termine di 'codice'11.Cartesio effettivamente intende l'arbitrarietà del segnolinguistico come la rappresentazione più adeguata dei rapportitra la mente e la natura ed estende per questa vial'arbitrarietà al cuore dell'atto percettivo. In particolarenelle VI Obiezioni e risposte alle Meditazioni metafisiche Cartesioillustra tre momenti della conoscenza sensibile: nel primo siha l'atto materiale del sentire tramite il movimento delleparticelle, il secondo è quello in cui gli oggetti suscitanole nostre impressioni, ed è un momento che gia dipendedall'unione delle due sostanze e come tale comporta un
11LEFÈVRE 1958; BEYSSADE 1981; 1995; MARION 1981, 252-56. Ho potuto constatare che èfrequente questo meccanismo, che Marion descrive a proposito della nozione di codice inDescartes, anche per la nozione di convenzione v. Stancati, Claudia (1996), "L'idée etle mot de 'convention': connaissance, langage et politique dans la culture française duXVIIIème siècle", in Studies on Voltaire and the eighteenth century, Transactions of the nineth InternationalCongress on the Enlightenment, 346-48, Oxford, Voltaire Foundation, 378-81.
12
rapporto arbitrario, il terzo momento, il giudizio, è quelloin cui si operano delle connessioni ma si può essere ingannati(VI Obj. OF I, 872, AT IX, 237). Nel secondo momento,destinato a mettere in rapporto l'uomo col mondo degli oggettinaturali, le percezioni sensibili si presentano come "segniconvenuti, anche se l'istituzione di queste "convenzioni" nonsta nelle stipulazioni umane ma nella volonta di Dio che hastabilito leggi per la natura come un re per il suo regno (L.Mer. 15 4 1630 AT I).I meccanismi della percezione sensibile sono spiegati daCartesio sempre grazie all'esempio della scrittura o dellaparola, in cui l'associazione arbitraria di due elementidiversi dà tuttavia luogo all'unità del segno e del suosignificato, nelle Meteore (1644) come nella Diottrica (Diot. IV,T 11), poichè all'anima che sente attraverso i nervi, infatti,non è necessaria la somiglianza, la contemplazione di immaginiche siano riproduzioni fedeli delle cose. I testi in cui siriflette questa concezione "semiotica" si snodano lungo tuttala riflessione di Cartesio. Notissimo è il passo che apre IlMondo o trattato della luce (1633) in cui si parla del rapporto trala natura e la percezione della luce come di un rapportoassolutamente arbitrario, analogo a quello tra il suono e ilsignificato delle parole, istituito per convenzione, poichènon c'è alcuna somiglianza tra le cose percepite e isentimenti che esse suscitano poichè è la natura che hastabilito certi segni. Nei Principi della filosofia (1644), adesempio, quando ci avverte come cadiamo in errore giudicandodelle cose sensibili secondo il sentimento della somiglianza(Prin. Ph. AT VIII, I §§ 68, 69, 33-34 , OF II, 97-98),Cartesio utilizza il paragone con la scrittura: "Si prova poiche la natura della nostra mente è tale che, solo per il fattoche nel corpo si producono certi movimenti, essa può essercondotta ad ogni sorta di pensieri (che non riportano in alcunmodo immagini di questi moti) e, specialmente, a quei pensiericonfusi che son detti sensi o sensazioni. Vediamo infatti chele parole, sia pronunciate sia soltanto scritte, eccitanonelle nostre anime ogni sorta di pensieri ed emozioni. Sullostesso foglio di carta, con la stessa penna ed il medesimoinchiostro, basta che la punta della penna sia condotta in uncerto modo sulla carta, perché vengano tracciate lettere che
13
provocheranno nell'animo del lettore pensieri di battaglie, ditempeste, di furie e passioni di indignazione e di tristezza.Qualora invece la penna sia mossa in altro modo pressochésimile, essa farà sorgere pensieri affatto diversi, ditranquillità, di pace, di piacevolezza e passioni del tuttoopposte a quelle precedenti, di amore e di letizia." (Prin.Ph. IV § 197, vedi per intero in T 22). Convenzionali,infatti, sono per Cartesio anche i rapporti tra le passioni ei loro segni naturali, tra i quali c'è connessione ma nonsomiglianza, come nella lingua tra parola e significato12.
Il significato filosofico del paragone col linguaggio
L'abbandono della relazione di somiglianza tra gli oggetti e iloro concetti, la frattura incolmabile tra sensazione emovimento corporeo si vale dell'analogia con il linguaggioperchè nella complessa articolazione della sua filosofiaCartesio affida al linguaggio una parte di grande rilievo:esso costituisce infatti, insieme al pensiero, uno dei duepoli entro quali può venire riconosciuta e definita l'essenzadella natura umana. Oltre che ad illustrare una visione assaicomplessa ed elaborata della sensibilità, il linguaggio apparenei luoghi centrali del pensiero cartesiano come un modellodestinato a spiegare il rapporto mente-corpo in quantorapporto arbitrario, di denominazione estrinseca. Il modellolinguistico è assunto da Cartesio in senso filosofico e nonretorico: non si tratta una semplice similitudine o di unaimmagine letteraria.Soprattutto negli ultimi anni della sua vita Cartesio ha modo,discutendo con Arnauld e scrivendo ad Elisabetta, di tornarepiù volte a chiarire una delle sue posizioni più controverse:in che modo le due res siano nell'uomo in una unionesostanziale. Scrive Cartesio nella Sesta meditazione:"Attraverso queste sensazioni di dolore, di fame, di sete ecc.la natura mi insegna anche che non solo sto all'interno delmio corpo come un nocchiero entro la sua nave, ma che sonocosì strettamente congiunto e quasi confuso con esso da
12
L. Cha. 1 2 1647 T 26; Ame art XLI AT XI, 368; L. Eli. 5 1646 AT IV, BONICALZI 1990 B eC.
14
costituire un tutto con tale corpo. Infatti, in caso diverso,quando il mio corpo è ferito, io, che non sono altro che cosapensante, non avvertirei per questo dolore alcuno, mapercepirei con il puro intelletto questa lesione proprio comeil nocchiero si rende conto con la vista se la nave ha subitoqualche danno; quando poi il corpo abbisogna di cibo o dibevande lo avvertirei con chiarezza senza provare quelleconfuse sensazioni della fame e della sete. Infatti questesensazioni di fame, di sete, di dolore ecc. non sono altro checerti confusi modi di pensare che provengono dall'unione edalla quasi mescolanza della mente con il corpo" (AT VII, 81,OF I, 726-27 T20)13.Se egli, in innumerevoli luoghi della sua opera, ha conchiarezza distinto ciò che appartiene alla res extensa, cioètutti quegli attributi come la grandezza, la figura, ilmovimento, la posizione e la divisibilità, da ciò cheappartiene alla res cogitans, al pensiero, è vero anche che lasua nozione di pensiero è così ampia da includere tutti i modidella percezione intellettuale e del volere tipici dell'essereumano14. Ma tutte le sensazioni, le passioni e le emozioni sonoriconducibili a quella che nelle lettere alla pricipessaElisabetta diventa una terza nozione primitiva, non una terzares, ma un composto con proprie specificità. "Innanzitutto notodunque una gran differenza tra queste tre specie di nozioni,in quanto l'anima non si concepisce che attraversol'intelletto puro; il corpo, cioè l'estensione le figure e imovimenti, possono anch'essi conoscersi attraverso il solointelletto, ma assai meglio attraverso l'intelletto aiutatodalla immaginazione e, infine, le cose che appartengonoall'unione dell'anima e del corpo solo oscuramente siconoscono mediante il solo intelletto o anche attraversol'intelletto aiutato dall'immaginazione, mentre si colgono congran chiarezza attraverso i sensi" (L. Eli. 28 6 1643, AT III,691-92, OF II, 44-45). Si tratta tuttavia di una nozione di
13
Per le posizioni degli interpreti recenti si vedano ad esempio RYLE 1949, COTTINGHAM1978, CANTELLI 1991, 1992, 199614
V. per es. Princ. Ph. I, 48.
15
cui avverte tutte le difficoltà, infatti il filosofo proseguescrivendo alla principessa: "non mi pare infatti che la menteumana sia capace di concepire ben distintamente e nello stessotempo la distinzione tra l'anima ed il corpo e la loro unione,perché per questo occorre concepirli come una cosa sola e,nello stesso tempo, come due, il che è contraddittorio" (L.Eli. 28 6 1643, AT III, 693, OF II, 46) . Ed è a questoproposito che ancora una volta il linguaggio, ossia l'unionenella parola tra il suono e il significato, torna come esempiodell'unione sostanziale corpo-anima: "nell'uomo il corpo staall'anima come nel linguaggio il segno sta al significato"(CANTELLI 1992, 136).Il rapporto tra il nome e la cosa riappare come esempio inun'altra prospettiva che è quella della lettera a Mesland del9 febbraio 1645. Qui Cartesio parla del rapporto tra nome erealtà a proposito delle entità geometriche e del corpo diCristo nell'Eucarestia. Il rapporto che c'è tra nome e cosa èlo stesso che c'è tra l'anima e il corpo, c'è una permanenzadell'identità che è data dall'anima e che ci fa consideraresempre la stessa una persona benché il passare del tempo e lanatura stessa dei processi fisiologici ci assicurino che nonresta identica una sola particella di materia. E' come per unfiume che si chiama sempre Loira anche se l'acqua scorre. Sitratta di una "identità o somiglianza di dimensioni".L'abitudine di definire con lo stesso appellativo le cose chenon sono uguali a se stesse se non per "l'estensione","l'aspetto esteriore" o "l'uso" è quello che Cartesio chiama"l'uso del linguaggio", codificato dai dizionari (L. Mes. 9 21645 T 19)15.
Il linguaggio come "testimone" della mente
Cartesio considera la coscienza come il tratto distintivodella realtà mentale e introduce una nuova nozione di pensieroe di mente includendovi una serie di fenomeni chetradizionalmente venivano attribuiti all'anima animale. Questocomporta il rifiuto della separazione tra intelletto e
15 Su questa lettera e sulle questioni in essa trattata si veda Armogathe, Jean-Robert(1977), Theologia cartesiana, La Haye, M. Nijhoff.
16
sensibilità poiché anche le sensazioni, essendo atticoscienti, implicano una qualche forma di attivitàintellettiva. E' vero che in tutte le definizioni, peraltroassai ampie, che Cartesio da dell'essere pensante non dice maiche esso oltre ad essere 'una cosa che sente, che vuole, chedubita, che concepisce, che afferma e che nega ecc.', è anche'una cosa che parla', benché questo sia implicito nel fatto diaffermare o negare16. Ciò si deve probabilmente al fatto chel'espressione e il pensiero sono radicalmente differenti,l'una appartiene alla macchina corporea, l'altro allo spirito,ed è alla frontiera delle due sostanze che si situa illinguaggio. D'altronde, poiché il legame tra l'anima e ilcorpo è stato stabilito da Dio, esiste tra pensiero elinguaggio una equivalenza per istituzione che approda ad unaequivalenza reale, e possiamo dedurre che non c'è pensierosenza linguaggio, ma soprattutto non c'è conoscenza senzaattività simbolica.L'atto fisico del parlare può essere imitato da un automa o daun animale ammaestrato17; quella che è la funzione originaledell'uomo, che non può essere imitata dagli animali èl'istituzione e l'uso di segni arbitrari, la funzione delsignificare. Essa permette all'uomo non solo di comunicare, diistituire regole, ma anche di decifrare il codice delle legginecessarie e immutabili della natura istituite arbitrariamenteda Dio con un atto di assoluta e insondabile libertà.Per Cartesio il linguaggio e l'uso dei segni testimonianol'esistenza del pensiero e sono indissolubilmente legati allibero arbitrio, ma appartengono alla macchina corporea. Laconcezione cartesiana del linguaggio non è riconducibile nè alnominalismo puro di Hobbes, nè alla concezione del linguaggiodi Montaigne e Charron cui egli fa esplicito riferimento nellalettera al Marchese di Newcastle (T 26). Oltre che nel Discorsosul metodo, nella corrispondenza con con il Marchese diNewcastle e con Henry More (T 26 e 29), il tema del linguaggioanimale compare in una lettera indirizzata a Cartesio daqualcuno appartenente alla cerchia di Pollot (S. P. à *** pour16L. Mer. bis 27 4 1637 AT I, 362; L a *** 3 1638 T 13; Corps AT XI, 224-5; III Méd.Mét. AT IX, 27.17
L. Mer. 20 11 1629 T 5; L. a *** 3 1638 T 13; L. Mer. 30 7 1640 AT III, 121; L. M. New.23 11 1646 T 25; L. H. M. 5 2 1649 T 28; BONICALZI 1987.
17
D AT I, 511-17) databile al febbraio 1638. Il corrispondentericorda a Cartesio, in riferimento proprio al Discours, etraendo alcuni argomenti da Aristotele, che "l'esperienza cimostra che le bestie fanno capire le loro affezioni e passionicon il loro tipo di linguaggio, e che con molti segnimanifestano la collera, il timore, l'amore, il lororincrescimento di aver male operato" (514). Quando Cartesioparla della parola come strumento primario per distinguerel'uomo dalle macchine e per rivelargli l'esistenza di altrementi ha di mira un problema fondamentale: si tratta didistinguere l'uomo dalle bestie nel momento in cui ilmaterialismo e lo scetticismo insidiavano pericolosamente ilprimato dell'uomo nel regno della natura18. Replicando tantoalle argomentazioni scettiche che a quelle di impiantoaristotelico, Cartesio si serve del linguaggio per ricollocarel'uomo al centro dell'universo ed assicurarlo della presenzadei suoi simili e della creatività della mente, costruisce sulmodello del linguaggio la conoscenza "ipotetica" del mondofisico, sottolinea, tramite l'uso della nozione di segno, laprofonda continuità tra naturale e artificiale (Prin. Ph. IV §203 AT IX, 321-22).Che il linguaggio non sia esplicitamente menzionato daCartesio come necessario al pensiero non significa che eglinon li ritenga strettamente connessi. Il linguaggio ètestimone del pensiero, entrambi rappresentano le cose ma inmodo diverso. Il pensiero le rappresenta immediatamente,mentre il linguaggio tramite segni esteriori pubblicamentecondivisi. Certo l'idea cartesiana del pensiero non richiedeuna comunità linguistica ma presuppone una comunità di esseriraziocinanti. Come è stato correttamente rilevato da tutti glistudiosi, la creatività che è espressa dall'atto linguistico,la stessa pertinenza pragmatica, sono in realtà frutto dellacreatività del pensiero come attività retta dalle leggi dellalogica, eppure, attraverso una sorta di test di Turing,Cartesio fa del linguaggio l'unica attestazione pubblicadell'esistenza del pensiero e dell'anima, poichè possiedecaratteristiche che ne dimostrano l'irriducibilità ad una
18
Stupisce perciò l'ironia di TRABANT (1994) 1996, 25.
18
dimensione meccanica. E' il linguaggio il fatto centrale chepermette una ricostruzione argomentativa dell'esistenza dellealtre menti. Attraverso un vero e proprio language-userstest19,Cartesio ripercorre la strada intrapresa da Agostino nelDe Trinitate senza fare uso, però, del ragionamento analogico,cioè di quel ragionamento che conclude a partire dallasomiglianza degli oggetti su cui ragiona.
Cartesio nella storiografia filosofica e linguistica
La mia impressione è che proprio per le ragioni che abbiamofin qui presentato la valutazione più accurata delle nozionidi segno e del ruolo del linguaggio in Cartesio sia statacompiuta in questi ultimi anni in un ambito diverso da quellodella storia delle teorie linguistiche, in quei testi cheabbiamo citato e che indicano la presenza di un forte modellosemiotico nella fisica cartesiana. A questa lineainterpretativa si richiama, oltre a Pala (1990) e Cavaillé(1991 A) anche Francesca Bonicalzi sottolineando il ruolo delconcetto di ordine e di modelli semiotici nella concezionedella scientifica di Cartesio. Attraverso un criterio dicertezza fondato sulla dissimiglianza percettiva, Cartesio"libera una teoria del segno come materiale da decifrare,teoria che ha il suo modello nel linguaggio e il suo esito piùradicale nella scrittura algebrica della Geometria." (BONICALZI1990 A, 123).Altri interpreti tuttavia hanno affermato addirittura lasomiglianza di molti testi cartesiani con quelli di Saussure20.Ma occorre sottolineare che la distinzione cartesiana non èinterna al segno, separa la parola dal concetto della cosa edalla cosa medesima, sottolinea la doppia frattura tralinguaggio e pensiero e tra pensiero e realtà. Cartesio mettein luce la funzione referenziale del segno linguistico ed èquesta funzione che intende come arbitraria. La cosa da cui laparola differisce è il referente di cui il pensiero si fa,attraverso la dissimiglianza, una "idea". Il segno è dunque19CHOMSKY 1966, 1993, VAN DE PITTE 1975, MATTHEWS 1986, SÉRIS 199520
I testi sono: L. Cha. 1 2 1647 T 26; Entr. Bur. T 27; L. Mer. 18 12 1629 T 6; Diot. T12; III Obj. AT IX, 139 T 21; Prin. Ph. I § 74 e IV § 197 T 22; Ame art. 50 T 28, 369;gli interpreti: LEFÈVRE 1958; MARION 1973, 1981 con alcuni dubbi; ROMANOWSKI 1974.
19
per Cartesio solo un segnale, il linguaggio non è un sistema,una totalità definita in sè, ma solo uno strumento per ibisogni della comprensione. Il senso non è contenuto nei segnibensì nello spirito che li manipola e che resta indipendentedalla funzione linguistica (CAVAILLÉ 1991 A, 75-83).Inoltre, la Grammatica e la Logica di Port Royal, inizialmenteappiattite sulla nozione di "linguistica cartesiana"dall'interpretazione chomskiana, sono state sottoposte adun'analisi dettagliata che che le ha relativamente allontanatedall'orbita cartesiana per metterne in rilievo i rapporti conla tarda Scolastica21. Da ciò consegue, a nostro avviso, lanecessità di rivalutare la nozione di segno in Cartesioall'interno dell'intero complesso della sua riflessionefilosofica e scientifica, fortemente connotata dalla polemicaanti-scolastica, per poterne meglio apprezzare l'originalità.Una operazione questa che permette di riconsiderare inun'altra ottica, più generalmente filosofica e nonesclusivamente legata a temi linguistici, gli stessi rapportitra Cartesio e alcuni dei portorealisti.Nella storiografia linguistica momento centrale degli studi èCHOMSKY 1966, tuttavia in quegli stessi anni LEFÈVRE 1958, DEMAURO 1965 e FOUCAULT 1966 avevano gia indicato in Cartesio lapresenza di importanti osservazioni sul linguaggio.Le voci bibliografiche relative al linguaggio e ai temiconnessi negli anni immediatamente successivi allapubblicazione dell'opera di Chomsky sono abbastanza numerose,ma molte di esse sono dedicate a Chomsky e alla discussionedel termine 'cartesiano' nell'accezione chomskyana, piuttostoche al problema del linguaggio in Cartesio. In questediscussioni spesso le opere di Cartesio non vengono affattocitate o viene citato un numero assai limitato di passi,spesso sempre gli stessi. Si indagano i rapporti di Port Royalcon Cartesio, ci si occupa piuttosto di cartesiani comeCordemoy, Lamy o La Forge22. Uno degli interventi più precisi e
21
La bibliografia sui rapporti tra Descartes e il pensiero scolastico è sterminata . Levoci più pertinenti della bibliografia qui riportata sono: VAN DE PITTE 1975; MARION1976, 1981; MATTHEWS 1986; NORMORE 1986.
22Tra gli altri: DONZÉ 1967; ROSIELLO 1967; ZIMMER 1968; SALMON 1969; AARSLEFF 1970;BRACKEN 1970, 1984.
20
pertinenti, quello di Keith Percival, conclude addiritturache: "Contrariamente agli altri grandi filosofi del XVIIsecolo Cartesio era relativamente disinteressato allinguaggio" (PERCIVAL 1972, 144). Al contrario, come abbiamocercato di mostrare, Cartesio è sì poco interessato allostudio concreto delle lingue, ma mantiene verso linguaggio esegno un'attenzione filosofica costante.E' nell'ambito della filosofia della mente e della fertilecorrente di storia delle teorie linguistiche, cui Chomsky hail merito indiscusso di aver dato inizio, che si sono, anostro parere, create le premesse per una valutazione errata oparziale dell'atteggiamento di Cartesio riguardo allinguaggio.Il problema è che alla valutazione del pensiero di Cartesio sisono sovrapposti elementi "estranei" e interessicontemporanei. In ambito di storia delle teorie linguistiche,come ho accennato, ha finito col prevalere la polemica conChomsky e la tendenza ad affermare che può esserci unaautentica teoria del segno solo nell'ambito dell'empirismo23.Del resto, la proposta chomskiana è stata considerata, ancheda coloro che l'hanno accettata, più uno stimolo intelligentee provocatorio che il frutto una ricerca documentata erigorosa24.Altre letture delle sparse osservazioni "linguistiche" diCartesio hanno puntato a ridurre la differenza sul pianoepistemologico tra empirismo e razionalismo in questa epoca25
fino a raccogliere sotto l'etichetta comune di "età dellarappresentazione", e intorno alla centralità della nozione disegno, le posizioni filosofiche più disparate (FOUCAULT 1966).In ambito di filosofia della mente la presenza di una corrente"cartesiana" contemporanea (ALANEN 1992, GOLA 1995) di"internalisti", funzionalisti e cognitivisti (che va daHusserl a Brentano, da Searle a Fodor ecc.) le cui visionicoincidono solo in parte con quanto ha detto Cartesio (ALANEN1992, 19-21) ha creato una situazione per cui il suo pensiero23
ROSIELLO 1967, AARSLEFF 1982, THOMAS 1984.24
ZIMMER 1968, CHOUILLET 1972, SIMONE, 1995, TANIGAWA 1995.25
ROSSI 1960, 1968, 1979, CHOUILLET 1972, REY 1973-76, DOMINICY 1992, DROIXHE 1996.
21
si è trovato ad essere attaccato come bersaglio polemico eindiretto o ad esser valutato in un ambito ristretto oparziale26. Tuttavia in questo dibattito pro o contro una certaimmagine di Cartesio, che coincide in sostanza con quello sulmind-body problem, il linguaggio ha avuto un posto alquantomodesto.L'attenzione di quella che potremmo definire la lettura"analitica" di Cartesio si è appuntata principalmente sugliaspetti logici e in particolare sul cogito27 e sulla presenza inCartesio di una concezione proposizionale del pensiero(VENDLER 1972). Il ruolo del linguagggio nel pensierocartesiano è stato comunque meglio valorizzato in questaottica, tanto che c'è stato poi, chi, come Anthony Kenny(KENNY 1973), ha ritenuto che nel caso del cogito Cartesio abbiaaddirittura ragionato secondo il modello: 1) io capisco lafrase che sto pronunciando; 2) chiunque capisce unaproposizione capisce tutto il linguaggio; 3) quindi capiscotutto il linguaggio. Tuttavia anche in questo gruppo diletture cartesiane si considera un errore da parte di Chomskyl'aver asserito l'esistenza in Cartesio di una specificitàdella facoltà di linguaggio (BOUVERESSE 1983).Una rivalutazione del ruolo del linguaggio in Cartesio si èavuta recentemente in ambito di studi sull'argomentazione28. SeCartesio tende alla costruzione consapevole di un linguaggiomatematico di pura denotazione, è anche vero che egli passagradatamente dalla diffidenza alla ricerca di un modello dicomunicazione filosofica nuovo. Egli approda così ad unapadronanza totale del discorso, inteso non solo come strumentopersuasivo, ma come vera e propria struttura agomentativa easse portante della costruzione di una certezza filosofica e
26
RYLE 1949; Fodor, J. A. (1983), The modularity of Mind: an Essay on Faculty Psychology, Cambridge(Mass.), MIT Press, trad. it., La mente modulare. Saggio di psicologia delle facoltàL, Bologna, IlMulino, 1988. Lakoff, G. (1987), Women, Fire and Dangerous Things. What Categories reveal about Mind,Chicago, The University of Chicago Press; Edelman, G. M. (1992), Bright Air. Brillant Fire. Onthe Matter of the Mind, Basic Book, New York, trad. it., Sulla materia della mente, Milano,Adelphi, 1993; Damasio, Antonio R. (1994), Descartes'Error, trad. it., L'errore di Cartesio,Milano, Adelphi, 1995.
27HINTIKKA 1962, KATZ 1986, 1990, CHANDLER 1987.28
CAHNÉ 1974, 1980, ROMANOWSKI 1974, BORDRON 1987, COSSUTTA 1996, MAINGUÉNEAU 1996.
22
scientifica, come dimostra in particolare la struttura delleMeditazioni metafisiche. Del resto la sua ricerca della clarté nellostile potè giovarsi delle raccomandazioni di uomini come JeanLouis Guez de Balzac, Du Perron, Pierre de Deimier (LOJACONO1996, 545).Una menzione infine meritano gli studi che, a partire daquello celebre di Couturat e Leau29, considerano Cartesio comeuno degli autori dediti alla ricerca della "lingua perfetta" esottolineano la sua attenzione alla dimensione utopica dellinguaggio. Egli tenderebbe, in questa ottica, alla ricercadella trasparenza assoluta del segno linguistico, alla mathesisuniversalis30, al controllo assoluto del pensiero sul linguaggio.La ricognizione bibliografica che ho condotto ha avuto cometermine di riferimento principale proprio la pubblicazione diCartesian Linguistics di Chomsky, tuttavia per i motivi che hoesposto, mi è sembrato necessario arretrare, in qualche caso,la ricerca bibliografica.
Una mappa dei testi
Le ragioni fin qui addotte spingono a ripercorrere ancora unavolta le sparse osservazioni di Cartesio sul linguaggio, e acercare la nozione di segno e l'uso del modello linguistico edella scrittura, nei testi in cui egli parla di arbitrarietàdella percezione, e descrive alcuni momenti della conoscenza.La rassegna di testi qui presentata non ha certo la pretesa diessere esaustiva, ma solo quella di rendere ancora piùplausibile una lettura di Cartesio che metta in rapportoaspetti linguistici e aspetti epistemologici.Quella che segue vuol essere una piccola mappa dei temitrattati nei testi proposti.Mathesis universalis:Regola IV (T 2)La scienza come ordine:Regola VII è utilizzato l'esempio dell'anagramma (T 2)29
COUTURAT-LEAU 1903; ROSSI 1960, 1968, 1979; PELLEREY 1992; ECO 1993, 1996; BONO 1995.30
Crapulli, Giovanni (1969), Mathesis Universalis, genesi di un'idea nel XV secolo, Roma, Edizionidell'Ateneo.
23
Regola X (T 2)La critica dell'uso comune del linguaggio:Regola XIII (T 2)Terminologia scientifica e filosofica:Regola III (T 2)Regola XIV (T 2) gli usi del linguaggio in rapporto allaconsiderazione scientificaRegola XVI (T 2) sulla simbologia matematicaL. Mer. 16 10 1639 sul termine 'verità'L. a Regius maggio 1641 (T 17) sul termine 'anima'La lingua universale:L. Mer. 20 11 1629 (T 4)Origine del linguaggio, usi retorici, varietà delle lingue:L. a *** 1628 (T 3)L. a Mer. 4 marzo 1630 (T 8)Entr. Bur. (T 30)Il funzionamento della lingua è trattato in:L. Mer. 20 11 1629L. a Rén. marzo 1638 (T 13)L. Mer. 22 7 1641 (T 19)Il rapporto tra le parole e le cose:Regola XIV (T 2) gli usi del linguaggio in rapporto agli entimatematici e geometriciMon. Cap. I (T 6)Prin. Ph. I 74 (T 22)L. Mes. 9 2 1645 (T 23)La semioticità della percezione:Mon. Cap. I (T 9)H. (T 10)Diot. I (T 12)Diot. II (T 12)Diot. VI (T 12)Sesta Méd. Mét. (T 20)Prin. Ph. I 66, 67 IV 197 204 (T 22)L. Cha. 1 2 1647 (T 26)Entr. Bur. (T 27)L'anamorfosi:Diot. II (T 12)Il cifrario:Regola X (T 2)
24
Prin. Ph. IV 205 (T 22)Natura della mente:H. (T 10)L. a Rén. marzo 1638 (T 13)L. a Regius maggio 1641 (T 17)L. Mer. luglio 1641 (T 18)Seconda Méd. Mét. (T 20)Sesta Méd. Mét. (T 20)III Obj. (T 21)IV Obj. (T 21)V Obj. (T 21)Prin. Ph. IV 197 204 (T 22)Entr. Bur. (T 27)Il riconoscimento delle altre menti:Seconda Méd. Mét. (T 20)Il rapporto le parole e il pensiero:L. Mer. per Hobbes 21 4 1641 (T 16)Seconda Méd. Mét. (T 20)III Obj. (T 21)L. a *** 1645 o 1646 (T 24)Ame 44 (T 28)Il rapporto tra il corpo e l'anima:Seconda Méd. Mét. (T 20)Sesta Méd. Mét. (T 20)IV Obj. (T 21)Entr. Bur. (T 27)L'esempio del linguaggio:Mon. (T 6)Entr. Bur. (T 27)Ame 50 (T 28)L'esempio della scrittura:Manoscritto 1619-21 (T 1)Regola XII (T 2)Diot. II (T 12)Prin. Ph. IV 197 204 (T 22)Entr. Bur. (T 27)Ame 50 (T 28)L'esempio degli enigmi:Regola VII e XIII (T 2)Gli automi:
25
L. Mer. 8 10 1629 (T 4)H. (T 10)Dis. méth. (T 11)L. a Rén. marzo 1638 (T 13)Sesta Méd. Mét. (T 20) è utilizzato il paragone con l'orologioGli animali macchina anche in rapporto al linguaggio:Regola XII (T 2)Dis. méth. (T 11)L. a Rén. marzo 1638 (T 13)L. Mer. 30 7 1640 (T 15)IV Obj. (T 21)V Obj. (T 21)L. M. New 23 11 1646 (T 25)Lettere tra C e H. M.1648-1649 (T 29)
26
I testi di C. sono stati indicati da queste abbreviazioni,seguite dall'indicazione del volume e delle paginenell'edizione delle Oeuvres de Descartes, Charles Adam e AntoineTannery edd., 13 voll., Paris, 1897-1913, nouv. prés. Vrin-C.N.R.S., 1964-74, rist. in 11 voll. 1996 (citate come AT) oeventualmente dal numero d'ordine con cui figuranonell'antologia. A questa edizione ci siamo attenuti, per lopiù, per quanto riguarda l'attribuzione e la datazione.Ame = Le passioni dell'anima 1649.Cog. Priv. = Cogitationes privatae.Com. Mus. = Breve trattato di musica 1650.Corps = Il corpo umano 1648.Diot. = Diottrica 1637.Dis. Méth. = Discorso sul metodo 1637.Entr. Bur. = Colloquio con Burman 1648.Géom. = Geometria 1637.H. = L'uomo 1633.Méd. Mét. = Meditazioni della filosofia prima 1641.Mét. = Meteore 1637.Mon. = Il mondo o trattato della luce1633.Notae = Osservazioni su un certo manifesto1648.Obj. = Obiezioni e Risposte 1647.Olym. = Olympica 1620.Préam = Preamboli 1619.Princ. Phi. = Principi della filosofia 1644.Regulae = Regole per la guida dell'ingegno 1628.Vérité = La ricerca della verità s. d.Le lettere sono individuate dal corrispondente secondo le sigleseguenti, e dalla data:L. Cha. = Chanut;L. Cler. = Clerselier;L. Eli.= Elisabeth;L. H. M. = Henry More;L. Mer. = Mersenne;L. Mes. = Mesland;L. M. New. = Marchese di NewcastleL. Mor. = Morin;L. Reg = RegiusL. Rén. = Rénéri;
27
Le opere secondarie citate nella bibliografia sono individuatidal nome dell'autore e dalla data.Ho utilizzato la traduzione di Ettore Lojacono delle Opere filosofiche,2 voll., Torino, UTET 1994 per i testi n 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13,15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29b e 30 e per il testo 12alle Opere scientifiche, II vol., Torino, UTET, 1983; per il testo 17,Lettera CCXXXIX a Regius (AT III, 369-70), la traduzione italianaè tratta da da René Descartes - Henricus Regius, Il carteggio. Le polemiche,Roberto Bordoli ed., Napoli Cronopio, 1997. Nei casi in cui latraduzione è condotta sul testo latino anzichè sul testo francese,più esteso, (testi 20, 21 e 22), ho riprodotto alcune delle noteesplicative del professor Lojacono. Ringrazio vivamente la casaeditrice UTET per avermi concesso di riprodurre i testi esoprattutto il professor Lojacono, cui ho sottoposto questolavoro, e dei cui consigli mi sono avvalsa traendolidall'importante premessa all'edizione delle Opere filosofiche, percondurre la traduzione degli altri testi antologizzati.
28
Testi1. Manoscritto 1619-21 (AT X, 204).
Si tratta di un frammento manoscritto ritrovato tra gli scritti diC.consegnati a Clerselier (v. T. 2). Gli originali sono perduti e ciòche possediamo ci è giunto o attraverso le copie fattene da Leibnizoppure, ed è il caso di questo scritto, attraverso la Vita di Cartesiopubblicata da Baillet nel 1691.
Così come non possiamo scrivere parole in cui si trovi altro chenon siano le lettere dell'alfabeto, né comporre una frase che nonsia composta dalle parole che si trovano nel dizionario, nellostesso modo non possiamo <scrivere> un libro <che non si componga>di frasi che si trovano in altri <libri>, pertanto se ciò che avròdetto sarà così coerente e argomentato, che una <cosa> scaturirànecessariamente dall'altra, ciò proverà che io non ho mutuatofrasi da altri più di quanto io ho tratto le parole daldizionario.
29
2. Regole per la guida dell'ingegno 1627-28 OF I (AT X, III, 368-69; IV, 373-74; 377-79; VII, 391-92; X, 414-15; XIII, 433-35; XIV, 439-40; XVI, 442-49, 454-56,458).
Redatto con tutta probabilità tra il 1627 e il 1628, il manoscrittolatino delle Regole per la guida dell'ingegno (Regulae ad directionem ingenii) furitrovato dopo la morte di C. tra gli scritti inviati a Parigi da Chanuta Claude Clerselier, traduttore di opere cartesiane e amico delfilosofo. L'opera fu letta e utilizzata, tra gli altri, dagli autoridella Logica di Port Royal, Antoine Arnauld e Pierre Nicole, e daLeibniz. Tradotta in olandese e pubblicata nel 1684, l'opera vide laluce in latino nel 1701, mentre la prima traduzione francese è del 1826.Il manoscritto cartesiano è incompiuto, si ferma all'enunciazione delleregole XIX, XX e XXI. Si tratta di una indagine che è già centrata sullanatura della mente e sui caratteri della conoscenza: la certezza el'evidenza, l'ordine, l'intuizione e la deduzione, e sul grande progettodella Mathesis Universalis.L'edizione critica delle Regulae è a c. di G. Crapulli, La Haye, 1966.Esiste un Index des 'Regulae ad directionem ingenii' de René Descartes, J. R.Armogathe, J.-L. Marion, G. Crapulli edd., Roma, Edizionidell'Ateneo,1976.Cit. in: CHOMSKY 1966, FOUCAULT 1966, CHOUILLET 1972, JOLY 1986, SÉRIS1995.
Dalla REGOLA III
(241) (...) enumeriamo qui tutti gli atti del nostro intelletto,attraverso i quali possiamo giungere alla conoscenza delle cosesenza tema di errore: due soltanto gli atti ammessi, l'intuito ela deduzione.Per intuito non intendo la mutevole attestazione dei sensi né ilgiudizio fallace di un'immaginazione che non sa comporre, bensì laconcezione di una mente pura ed attenta, <concezione> così facilee così distinta che non resti proprio alcun dubbio intorno a ciòche comprendiamo; ossia, che è poi la stessa cosa, la concezionesicura di una mente pura e attenta che nasce dal solo lume dellaragione e che, in quanto più semplice, è più certa della stessadeduzione, la quale tuttavia, come abbiamo notato sopra, non puòesser fatta male dall'uomo. Così ognuno può intuire con la menteche egli esiste, che pensa, che il triangolo è delimitato soltantoda tre linee, che la sfera è delimitata da una sola superficie ecose del genere, le quali sono molto più numerose (242) di quantocreda la maggior parte degli uomini, giacché non si degnano divolgere la mente a cose tanto facili.
30
Ad evitare però che qualcuno sia eventualmente turbato dal nuovouso della parola intuito e delle altre che allo stesso modo inseguito dovrò necessariamente rimuovere dal loro significatocomune, in generale faccio qui presente che non penso affatto almodo in cui questi termini, in questi ultimi tempi, sono statiadoperati nelle scuole, perché sarebbe cosa difficilissimaservirsi dei medesimi nomi e nutrire opinioni del tutto diverse;per quel che mi riguarda faccio dunque attenzione soltanto alsignificato che le singole parole hanno nella lingua Latina,affinché, in mancanza di parole proprie, riduca al mio significatoquelle che mi sembrano le più adatte.
Dalla REGOLA IV
(...) La mente umana possiede infatti un non so che di divino incui sono stati gettati i primi semi di pensieri utili, in modo chespesso, per quanto trascurati (245) e soffocati da studi contrari,producono spontaneamente frutti.Esperimentiamo ciò nelle scienze più facili, l'Aritmetica e laGeometria: infatti osserviamo che gli antichi Geometri hanno usatouna specie di analisi che estendevano alla soluzione di tutti iproblemi, sebbene, gelosi, non l'abbiano fatta conoscere aiposteri. Ormai fiorisce un certo genere di Aritmetica che èchiamato Algebra, per operare con i numeri ciò che gli antichifacevano con le figure. Queste due <scienze> non sono niente altroche frutti spontanei, nati dai principi di questo metodo che sononaturalmente in noi; non mi meraviglio che <tali frutti> fino adoggi siano maturati intorno agli oggetti semplicissimi di questearti più felicemente che nelle altre, nelle quali maggioriostacoli di solito li soffocano, dove però, tuttavia, se coltivaticon grandissima cura, potranno senza dubbio giungere a maturazioneperfetta.È ciò che ho incominciato a fare specialmente in questo trattato;infatti non terrei in gran conto queste regole, se fosserosufficienti a risolvere soltanto quei problemi di scarso valorecoi quali i Calcolatori e i Geometri sono soliti giocare in modoozioso; infatti in tal modo crederei di non aver fatto cheoccuparmi di cose futili, forse con maggior sottigliezza deglialtri. Sebbene mi appresti qui a dire molte cose intorno allefigure e ai numeri, non potendosi richiedere esempi così evidentiné così certi da alcun'altra scienza, tuttavia chiunque avràconsiderato attentamente il mio intendimento comprenderàfacilmente che qui non penso affatto alla Matematica comune, ma
31
espongo un'altra disciplina, di cui essi sono l'involucro più chele parti. Questa disciplina infatti deve contenere i primirudimenti della ragione umana e deve estendersi per ricavare laverità da qualsivoglia oggetto; e, per parlare francamente, sonopersuaso che questa sia più importante di ogni altra cognizionetramandataci dai nostri simili, in quanto è l'origine di tutte lealtre. Ho detto involucro, non perché voglia mascherare econfondere questa dottrina per sottrarla all'uomo comune, mapiuttosto perché voglio vestirla e adornarla in modo che possaessere più atta all'ingegno umano.(il passo seguente è da molti ritenuto un primissimo appunto)(247) (...) Poiché questi pensieri mi hanno distolto dai particolari studi di Aritmeticae di Geometria e mi han condotto verso una ricerca generale della Mathesis, mi sonochiesto prima di tutto che cosa la (248) gente intenda esattamente con questa parola eper qual ragione vengano considerate parti della Matematica, non solo le scienze giàindicate, ma anche l'Astronomia, la Musica, l'Ottica, la Meccanica e molte altre. Inproposito non è sufficiente considerare l'origine della parola; infatti; poiché il nomeMathesis significa semplicemente la stessa cosa che disciplina, <tutte le altre>potrebbero esser chiamate Matematiche con pari diritto della stessa Geometria.D'altronde vediamo però che non c'è quasi nessuno, sol che abbia varcato la prima sogliadella scuola, che non distingua facilmente, tra le cose che si presentano, ciò cheappartiene alla Mathesis e ciò che appartiene ad altre discipline. A chi infine haconsiderato ciò con maggior attenzione, è parso che solo tutte le cose in cui si puòesaminare un certo ordine o misura, si riferiscono alla Mathesis né ha importanza setale misura sia da cercarsi nei numeri, nelle figure, negli astri, nei suoni o in qualsiasialtro oggetto; ci deve esser pertanto una certa scienza generale che spieghi tutto ciò chepuò esser richiesto intorno all'ordine ed alla misura senza riferirla ad una specialemateria, e questa deve essere chiamata Mathesis universale, non con parola adottata,ma con una antica e già accettata dall'uso, giacché contiene in sé tutto ciò per cui le altrescienze sono definite anche parti della Matematica.(...)Conscio però della mia pochezza, ho deciso di osservare con costanza, nella ricerca dellaconoscenza delle cose, un ordine tale che, muovendomi sempre dalle più semplici e piùfacili, non mi spinga mai verso altre fin tanto che non mi sembri che nelle prime (249)non mi resti null'altro da cercare ulteriormente; perciò, per quanto mi e stato possibile,ho coltivato fino ad oggi questa Mathesis universale in modo che penso ormai di potertrattare, senza prematuro zelo, le scienze un po' più elevate. Prima però di passare adaltro, tenterò di riunire e di mettere in ordine quanto ho trovato più degno di nota neimiei studi precedenti, sia per poterlo agevolmente ritrovare in questo libretto, se l'uso lorichiederà, quando, col crescere degli anni, diminuisce la memoria, sia per liberarne sinda ora la memoria e poter liberamente rivolgere l'animo ad altre cose.
Dalla REGOLA VII
32
(257) Ho aggiunto anche che l'enumerazione deve esser ordinata: dauna parte perché non c'è alcun rimedio più efficace, contro idifetti già elencati, che osservare tutte le cose con ordine;dall'altra perché spesso accade che se le singole cose, che siriferiscono all'argomento proposto, dovessero esser esaminate unaper volta, non sarebbe sufficiente la vita di un uomo, o perchésono troppo numerose o perché le medesime cose si presenterebberoda ricercarsi più volte. Se le disponiamo tutte nell'ordinemigliore in modo che siano ridotte il più possibile in classideterminate, sarà sufficiente vedere con esattezza una sola diqueste o qualcosa di ciascuna o alcune piuttosto che altre o, perlo meno, non percorreremo mai niente due volte inutilmente; il cheè di così grande aiuto che spesso, grazie ad un ordine benstabilito, si portano a termine in breve tempo e con agevolelavoro molte cose che, a prima vista, sembravano immense.D'altra parte questo ordine delle cose da enumerare dipendedall'arbitrio di ciascuno e può spesso variare; pertanto, pertrovarlo con maggiore acutezza, occorre ricordare ciò che è statodetto nella quinta proposizione. Tra gli artifici meno importantidell'uomo, ce ne sono anche molti per la cui ricerca il metodoconsiste interamente in questa disposizione dell'ordine. Così, sesi (258) vuol fare il miglior anagramma trasponendo le lettere diun nome qualsiasi, non è necessario passare dalle cose più facilialle più difficili. né distinguere le assolute dalle relative, chénon è qui il luogo per tali distinzioni, ma, per esaminare letrasposizioni delle lettere, basterà proporsi un ordine tale danon ritornare mai due volte sulle stesse e che, ad esempio, illoro numero sia così distribuito in classi determinate in modo cheappaia subito in quali c'è maggiore speranza di trovare ciò che sicerca: così, infatti, il lavoro spesso non sarà lungo ma soltantopuerile.
Dalla REGOLA X
(267) Poiché però non tutti son dotati di ingegni così portati pernatura ad indagare le cose con le proprie forze, questaproposizione insegna che non ci si deve occupare subito di cosedifficilissime ed ardue, ma che prima bisogna sciogliere ledifficoltà delle arti meno importanti e più semplici e soprattuttodi quelle nelle quali maggiormente regna l'ordine, come quelledegli artigiani che tessono le tele e i tappeti o delle donne chericamano o intrecciano. In infiniti modi i fili in orditi diversi,
33
così come tutti i giochi di numeri e tutto ciò che appartieneall'Aritmetica, e simili: è stupefacente quanto tutte queste coseesercitino l'ingegno, purché non mutuiamo dagli altri la loroscoperta, ma da noi stessi. Infatti, poiché in esse nulla rimaneocculto e sono tutte alla portata nostra mente umana, esse cipresentano in modo molto distinto ordini molteplici, tutti diversitra loro e tuttavia regolari, nella cui rigorosa osservazioneconsiste quasi tutta la sagacia umana.
Per questo abbiamo raccomandato che occorre cercare tali cosecon metodo, che in quelle meno importanti consiste di solitosoltanto nella costante osservazione dell'ordine, sia che esistanella cosa stessa, sia che lo si sia sottilmente escogitato <conil pensiero>: così, se vogliamo leggere una scrittura occultata dacaratteri sconosciuti, nessun ordine certo vi appare, ma ne (268)fingeremo uno, sia per esaminare tutte le congetture che sipossono fare sui singoli segni o sulle parole o su ogni frase, siaanche per disporle in modo che, mediante l'enumerazione, si vengaa conoscere tutto ciò che se ne può dedurre Si deve stare attentisoprattutto a non perdere tempo ad indovinare simili cose a caso esenza arte; perché, anche se spesso è possibile trovarle senza diessa e talvolta dai fortunati perfino più rapidamente che colmetodo, tuttavia esse offuscherebbero il lume dell'ingegno e loabituerebbero talmente a sciocche puerilità che, in seguito, essodarebbe importanza sempre alla superficie delle cose senza poterpenetrare più a fondo Per non cadere, tuttavia, nell'errore dicoloro che occupano il pensiero soltanto in cose serie ed assaielevate, delle quali dopo molti sforzi non acquistano che unascienza confusa. pur desiderandone una profonda, bisogna dunqueche ci esercitiamo dapprima in quelle più facili, ma con metodo,allo scopo di abituarci a penetrare sempre per strade aperte econosciute, come giocando, nell'intima verità delle cose; inquesto modo infatti sentiremo che in seguito, grado a grado e intempo minore di quanto si possa sperare, anche noi possiamodedurre da principi evidenti, con uguale facilità, molteproposizioni in apparenza assai difficili e complicate.Alcuni forse si meraviglieranno che in questo luogo, overicerchiamo come renderci più atti a dedurre le verità le unedalle altre, tralasciamo tutti i precetti dei Dialettici, coiquali essi credono di dirigere la ragione umana, prescrivendocerte forme di ragionamento che concludono in modo così necessarioche la ragione che vi si affida - quand'anche si distraesse inqualche modo dalla considerazione attenta ed evidente della stessainferenza - potrebbe tuttavia, in virtù della forma, concludere
34
talvolta alcunché di certo: ci accorgiamo, infatti, che spesso laverità si sottrae a questi vincoli, mentre proprio chi se n'èservito ne resta a volte impigliato. Questo non accade così difrequente agli altri; sappiamo invero per esperienza che di solitotutti i più sottili sofismi non ingannano quasi mai chi si servedella schietta ragione, ma soltanto i Sofisti stessi.Di conseguenza noi, che stiamo qui soprattutto attenti a che lanostra ragione non si distragga mentre esaminiamo la verità diqualcosa, respingiamo queste forme come contrarie al nostroproposito e cerchiamo piuttosto tutti gli aiuti che posson far sìche il nostro pensiero resti attento, come si dimostrerà inseguito. Affinché appaia però ancor più evidente che quel modo diragionare non contribuisce assolutamente alla conoscenza dellaverità, si deve osservare che i Dialettici non possono formaresecondo <le regole> dell'arte alcun sillogismo che porti al vero,se non abbiano avuto prima la materia dello stesso, cioè se nonabbiano conosciuto anteriormente la stessa verità che in essoviene dedotta. Appare chiaro da ciò che essi stessi, con taleforma, non conoscono niente di nuovo e che pertanto la comuneDialettica è del tutto inutile a chi desideri ricercare la veritàdelle cose, ma può soltanto giovare, a volte, ad esporre piùfacilmente agli altri le ragioni già conosciute, e perciòdev'essere trasferita dalla Filosofia alla Retorica.
Dalla REGOLA XII
(274) In secondo luogo si deve pensare che, mentre il sensoesterno è mosso da un oggetto, la figura che esso riceve è portataa certa altra parte del corpo, chiamata senso comune, nel medesimoistante e senza il passaggio reale di alcun ente da un luogo ad unaltro; precisamente allo stesso modo in cui ora, mentre scrivo,comprendo che, nell'istante stesso in cui i singoli caratterivengono tracciati sulla carta, non soltanto si muove la parteinferiore della penna, ma non può prodursi in essa alcunmovimento, per minimo che sia, senza che nello stesso tempo siaricevuto anche da tutta la penna; e che tutte queste varietà dimovimenti sono descritte nell'aria anche dalla parte superioredella penna, benché non pensi che alcunché di reale si trasferiscada un estremo all'altro. Chi può credere, infatti, che vi siaminore connessione tra le parti del corpo umano che tra le partidi una penna? E che cosa di più semplice può escogitarsi peresprimere questo?
35
In terzo luogo si deve pensare che il senso comune adempiaanche la funzione di sigillo per imprimere nella fantasia onell'immaginazione, come in una cera, le medesime figure o ideeche provengono pure e senza corpo dai sensi esterni; e che questafantasia sia una vera parte del corpo e di tale grandezza che lesue diverse parti possano assumere più figure distinte fra loro emantenerle di solito abbastanza a lungo: allora è identica aquella che è chiamata memoria.
In quarto luogo si deve pensare che la forza motrice o glistessi nervi traggano la loro origine dal cervello, nel quale hasede la fantasia che li muove in modi diversi, come il sensoesterno muove il senso comune o come la parte inferiore muovetutta la penna. Questo esempio mostra pure come la fantasia possaesser causa di molti movimenti nei nervi, anche se essa noncontenga in sé configurate le immagini di questi movimenti, maalcune altre da cui essi possono derivare; neppure tutta la pennasi muove infatti come la sua parte inferiore; ma anzi, nella suaparte maggiore, sembra piuttosto spostarsi con movimento del tuttodiverso e contrario. Da queste cose si può comprendere comepossano prodursi tutti i movimenti degli altri animali, anche senon si ammetta in essi assolutamente alcuna conoscenza delle cose,ma soltanto una fantasia puramente corporea, e inoltre come (275)avvengano in noi stessi tutte quelle operazioni che compiamo senzaalcun intervento della ragione.
Dalla REGOLA XIII
(287) Diciamo che le cose sono cercate <muovendo> dalle paroletutte le volte che la difficoltà sta solo nell'oscurità deldiscorso; ed a questo si riportano non solo tutti gli enigmi,quale quello della Sfinge intorno all'animale che dapprima è unquadrupede, poi un bipede e alla fine diventa un tripede;parimenti quello dei pescatori che stavano sulla riva, forniti diami e di canne, per prendere pesci e dicevano di non aver piùquelli che avevano presi, ma di aver invece quelli che non avevanoancora potuto prendere, ecc.; ma oltre a ciò, nella maggior partedelle cose di cui disputano i dotti, la questione verte quasisempre sul nome. Non c'è bisogno di pensare così male dei maggioriingegni, da giudicare che concepiscano male le cose stesse tuttele volte che le spiegano con parole non abbastanza adatte: adesempio, se talvolta chiamano luogo la superficie del corpo ambiente, inverità non concepiscono una cosa falsa, ma abusano soltanto delnome di luogo che, nell'uso comune, significa quella natura semplice
36
e di per sé nota, per la quale si dice che una cosa è qui o là,natura che consiste nel (288) suo insieme in una certa relazionedella cosa che si dice esser in un luogo con le parti detto spazioesterno, alcuni, vedendo però che il nome di luogo era stato presodalla superficie ambiente, l'hanno impropriamente definita il doveintrinseco e così di tutto il resto. Tali questioni di nome ricorronocon tanta frequenza che, se tra i Filosofi si convenisse sempresul significato delle parole, quasi tutte le loro controversieverrebbero eliminate. Si cercano le cause dagli effetti tutte le volte che cerchiamo diuna cosa se sia o che cosa sia [...]Del resto, considerato che quando ci è proposta qualche questioneda risolvere spesso non ci accorgiamo subito di quale genere sia,né se si cerchino le cose dalle parole o le cause dagli effetti,ecc., mi pare inutile parlare ancora di queste cose inparticolare. Sarà più breve e più comodo, infatti, seguire insiemecon ordine tutto quel che si deve fare per risolvere qualunquedifficoltà; per questo, data una qualsiasi questione, dobbiamosforzarci prima di tutto di comprendere distintamente ciò che sicerca.Molto spesso infatti, alcuni procedono così in fretta nell'esamedelle proposizioni che applicano alla soluzione di esse un ingegnodistratto, prima di aver considerato da quali segniriconoscerebbero la cosa cercata, se per caso si imbattessero inessa: non meno inetti di un ragazzo che, mandato dal padrone,fosse così desideroso di ubbidire, da affrettarsi a correre primaancora di aver ricevuto le istruzioni e senza sapere dove glifosse comandato di andare.Invero in ogni questione, sebbene debba esserci qualcosa diignoto, perché altrimenti si ricercherebbe invano, occorretuttavia che questo sia indicato con condizioni precise, così dideterminarci totalmente a cercare una cosa piuttosto che un'altra,Queste sono le condizioni al cui esame diciamo che dobbiamoapplicarci fin da principio il che avverrà se rivolgeremol'acutezza della mente ad intuirle distintamente una per una,cercando con diligenza fino a che punto l'incognita che cerchiamosia delimitata da ognuna di esse, l'ingegno umano, infatti, èsolito ingannarsi (289) al riguardo in due modi: o assumendo, perdeterminare la questione, qualcosa di più vasto di quanto sia datoo, al contrario, tralasciando alcunché.Si deve fare attenzione a non supporre dati in numero maggiore ominore di quanti <effettivamente> sono: specialmente negli enigmie nelle altre domande escogitate artificiosamente per imbrogliare
37
gli ingegni, ma, a volte, anche in altre questioni quando perrisolverle, sembra si supponga quasi certo qualcosa di cui ci hapersuaso non una ragione sicura, ma un'antica opinione. Adesempio, nell'enigma della Sfinge, non si deve stimare che il nomepiede significhi soltanto veri piedi di animali ma si deve anchevedere se possa essere applicato ad altre cose determinate come difatto avviene, ossia alle mani del bambino o al bastone deivecchi, perché l'uno e gli altri se ne servono per camminare quasicome piedi. Parimenti in quello dei pescatori si deve tareattenzione che il pensiero dei pesci non abbia occupato la nostramente al punto da distoglierla dal riconoscere quegli animali chei poveri spesso portano con sé senza volerlo e che buttano viaquando li hanno presi.
Dalla REGOLA XIV
(291) Senza dubbio tutti questi enti già noti, quali l'estensione,la figura, il movimento e altri simili, che qui è inutileenumerare, sono conosciuti mediante una medesima idea in oggettidiversi, né immaginiamo la figura di una corona in modo diverso,sia essa d'argento o d'oro; e questa idea comune è trasferita daun oggetto a un altro non diversamente che mediante un sempliceconfronto, per il quale affermiamo che ciò che si cerca è, secondo(292) questo o quello, simile o identico o uguale a qualche<termine> dato; sicché in ogni ragionamento conosciamo conprecisione la verità soltanto per paragone. Ad esempio, in questocaso: ogni A è B, ogni B è C, dunque ogni A è C; si paragonano ciòche si cerca e ciò che è dato, ossia A e C, in quanto l'uno el'altro sono B, ecc. Poiché, come abbiamo già spesso ricordato, leforme del sillogismo non aiutano in nulla a percepire la veritàdelle cose, il lettore sarà avvantaggiato se, dopo averle messecompletamente da parte, comprenderà che proprio ogni cognizionenon acquisita per semplice e puro intuito di una cosa isolata, siottiene per raffronto di due o più cose tra loro. Senza dubbioquasi tutta l'industria della ragione umana consiste nel prepararequesta operazione; quando infatti essa è aperta e semplice, nonc'è bisogno di nessun aiuto dell'arte, ma del lume della solanatura per intuire la verità che si acquisisce in virtù <dellaragione>.Si deve osservare che i paragoni sono detti semplici e aperti soloogni volta che ciò che si cerca e ciò che è dato partecipano inmodo uguale di una certa natura; tutti gli altri paragoni, invece,hanno bisogno di preparazione per il solo fatto che tale natura
38
comune non si trova in modo uguale nell'una e nell'altra cosa, masecondo qualche altra relazione o proporzione in cui essa èimplicata; la parte principale dell'operosità umana consistesoltanto nel ridurre queste proporzioni a tal punto che appaiachiaramente l'uguaglianza tra la cosa cercata e quella che siconosce.(...) (294) Per estensione intendiamo ogni cosa che ha lunghezza,larghezza e profondità, non indagando se si tratti di un verocorpo o soltanto di uno spazio; né sembra che abbia bisogno di unamaggiore spiegazione, in quanto nulla assolutamente è piùfacilmente percepito dalla nostra immaginazione. Tuttavia, poichéi dotti si valgono spesso di così acute distinzioni da dissipareil lume naturale e trovare l'oscurità anche nelle cose che nonsono mai ignorate dalla gente di campagna, si deve ricordar loroche per estensione non viene qui designato qualcosa di distinto eseparato dallo stesso oggetto, e che in generale non riconosciamoenti filosofici di tal fatta che non cadono effettivamente sottol'immaginazione. Invero, anche se qualcuno potrà convincersi, adesempio, che riducendo a niente ciò che vi è di esteso nellanatura non è tuttavia contraddittorio che la stessa estensioneesista per sé sola, non si varrà tuttavia per tale concettodell'idea di corpo, ma soltanto di un intelletto che giudica male;il che egli stesso confesserà, se rifletterà attentamente a quellamedesima immagine dell'estensione che si sforzerà di formare conla propria immaginazione: si accorgerà infatti di non percepirlaprivata di ogni oggetto, ma di immaginarla in modo del tuttodiverso da come la giudica; sì che quegli enti astratti (checchél'intelletto creda della verità della cosa) non si formanotuttavia mai nella fantasia separati dagli oggetti.Poiché d'ora in poi non faremo in verità nulla, senza l'aiutodell'immaginazione, vale la pena distinguere con cautela per mezzodi quali idee sono da proporre al nostro intelletto i singolisignificati delle parole. Per questa ragione proponiamo chevengano prese in considerazione queste tre forme di espressione:l'estensione occupa luogo, il corpo ha estensione, l'estensione non è il corpo.La prima di queste mostra come l'estensione venga assunta per ciòche è esteso; infatti concepisco una cosa del tutto identica, sedico: l'estensione occupa luogo, e se dico: ciò che è esteso occupa luogo. Non perquesto, tuttavia, è preferibile, per evitare l'ambiguità, usarel'espressione ciò che è esteso: questa infatti non indicherebbe in modotanto distinto ciò che concepiamo, ossia che un oggetto occupi uncerto luogo perché è esteso, e qualcuno potrebbe interpretare chesoltanto ciò che è esteso è un oggetto (295) che occupa. luogo, esattamente come
39
se dicessi: ciò che è animato occupa luogo. E' per questa ragione cheabbiamo detto che qui ci saremmo occupati dell'estensione,piuttosto che di ciò che è esteso, anche se stimiamo che non sidebba concepire <l'estensione> se non come ciò che è esteso.Passiamo ora a queste parole: il corpo ha estensione, dove intendiamo cheestensione significa per certo qualcosa di diverso dal corpo; nonformiamo tuttavia nella nostra fantasia due idee distinte, l'unadel corpo e l'altra dell'estensione, ma una soltanto, ossia delcorpo esteso; per quanto riguarda la cosa è come se dicessi: ilcorpo è ciò che è esteso, o piuttosto, ciò che è esteso è ciò che è esteso. Il che èproprio di certi enti che esistono soltanto in un altro <essere>,né possono esser mai concepiti senza un oggetto; diversamenteaccade in quelli che si distinguono realmente dagli oggetti:infatti se, ad esempio, dicessi: Pietro ha ricchezze, l'idea di Pietro ècompletamente diversa da quella di ricchezza; parimenti sedicessi: Paolo è ricco, immaginerei una cosa del tutto diversa che sedicessi: il ricco è ricco. Non distinguendo tale diversità, parecchistimano in modo falso che l'estensione contenga qualcosa didistinto da ciò che è esteso, come le ricchezze di Paolo sono unacosa diversa da Paolo.Infine, se si dice: l'estensione non è il corpo, allora la parolaestensione viene assunta in un senso molto diverso da quelloprecedente; in questo significato nessuna idea particolarecorrisponde ad essa nella fantasia, ma questo enunciato èinteramente opera dell'intelletto puro, che solo ha la facoltà diseparare enti astratti di tal genere. La qual cosa è occasione dierrore per molti, i quali, non accorgendosi che l'estensione cosìassunta non può esser compresa dall'immaginazione, se larappresentano come una vera idea; e poiché tale idea comportanecessariamente il concetto di corpo, se affermano chel'estensione così concepita non è il corpo, restanoimprudentemente inviluppati in ciò, che la stessa cosa nello stesso temposia corpo e non corpo. È di grande importanza distinguere gli enunciati,in cui nomi di tal genere: estensione, figura, numero, superficie, linea, punto,unità, ecc., hanno un significato così delimitato da escluderequalcosa da cui invero non sono distinti, come quando si dice:l'estensione o la figura non è il corpo; il numero non è la cosa numerata; la superficie è illimite del corpo, la linea della superficie, il punto della linea; l'unità non è la quantità,ecc. Tutte queste proposizioni ed altre simili devono essereinteramente scartate dalla immaginazione, benché siano vere; pertale ragione nelle <pagine> che seguono non ce ne occuperemo.Si deve osservare con cura che in tutte le altre proposizioni incui questi nomi, sebbene conservino il medesimo significato e
40
nello stesso modo sian detti astratti dagli oggetti, non escludonotuttavia o negano nulla da cui non siano realmente distintipossiamo e dobbiamo far uso dell'aiuto della immaginazione, perchéallora, anche se l'intelletto si applica con precisione soltanto aciò che è indicato dalla parola, l'immaginazione deve tuttaviaformare la vera idea della cosa, affinché l'intelletto stessopossa volgersi, se a volte l'uso lo esiga, ad altre sue condizioninon espresse dalla parola e non giudichi mai imprudentemente cheesse siano state escluse. Così, se v'è una questione che riguardiil numero, immaginiamo qualche oggetto misurabile medianteparecchie unità e, per quanto l'intelletto al presente riflettasoltanto sulla molteplicità di quello, faremo tuttavia attenzioneche non giunga poi di lì ad una conclusione in cui si supponga chela cosa numerata sia stata esclusa dal nostro concetto, come fannocoloro che attribuiscono ai numeri stupefacenti misteri e puresciocchezze, cui certamente non darebbero così grande fiducia, senon concepissero il numero come distinto dalle cose numerate.Parimenti, se trattiamo della figura, stimiamo di trattaredell'oggetto esteso, concepito soltanto secondo questo modo, che èfigurato; se di un corpo, pensiamo di trattare dello stesso, comelungo, largo e profondo; se della superficie, concepiamo lo stessocome lungo e largo, omettendo la profondità, ma senza negarla; sedi una linea, soltanto come lungo; se di un punto, <concepiamolo>senza tener conto di null'altro, se non che esso è un ente.Per quanto svolga qui ampiamente tutte queste cose, gli ingegnidei mortali sono tuttavia così pieni di prevenzioni che temoancora che ben pochi siano abbastanza al riparo da ogni pericolodi errare a proposito di questa parte e trovino l'esposizione delmio pensiero troppo breve in questo lungo discorso; infatti lestesse arti dell'Aritmetica e della Geometria, sebbene siano lepiù certe di tutte, qui tuttavia ci ingannano: quale Calcolatorein realtà non stima che i suoi numeri non soltanto siano statiastratti da ogni oggetto mediante l'intelletto, ma che debbanoanche essere distinti veramente con l'immaginazione? QualeGeometra non altera l'evidenza del suo oggetto con principicontraddittori, quando ritiene che le linee siano prive dilarghezza e le superfici di profondità, che poi compone tuttaviale une dalle altre, senza accorgersi che la linea, dal cuiscorrimento concepisce il formarsi della superficie, è un verocorpo e che invece quella che manca di larghezza non è se non mododel corpo, ecc.? Ma per non soffermarci troppo a lungo nel passarein rivista tali cose, sarà più breve esporre in che modosupponiamo debba essere concepito il nostro oggetto per dimostrare
41
a suo proposito, nel modo più facile possibile, tutto quanto divero si trova nell'Aritmetica e nella Geometria.Qui ci occupiamo dunque dell'oggetto esteso, non considerando inesso assolutamente null'altro che la stessa estensione ed evitandovolutamente il termine quantità: certi Filosofi infatti sono cosìsottili che l'hanno distinta anche dall'estensione. Supponiamo poiche tutte le questioni siano state svolte fino al punto che non sichieda altro se non conoscere una certa estensione dal fatto chesi compari con qualche altra estensione conosciuta. Infatti,poiché non ci aspettiamo di conoscere qui alcun nuovo ente, maintendiamo soltanto ridurre le proporzioni, per quanto involuteesse siano, al punto da trovare quel che è ignoto uguale a ciò chesi conosce, è certo che tutte le differenze di proporzioni, qualiesistono in altri oggetti, si possono trovare anche tra due o piùestensioni; è sufficiente perciò al nostro scopo considerare nellaestensione stessa tutte quelle cose che possono esser di aiuto adesporre le differenze delle proporzioni che non si presentano senon nel numero di tre, ossia la dimensione, l'unità e la figura.Per dimensione non intendiamo nient'altro che il modo e ilrapporto secondo il quale si considera che qualche oggetto siamisurabile: in modo che non soltanto la lunghezza, la larghezza ela profondità sono dimensioni del corpo, ma anche la gravità è ladimensione secondo la quale gli oggetti vengono pesati, lavelocità la dimensione del movimento, e così altre infinite cosedel genere. La divisione stessa, infatti, in più parti uguali, chesia (298) reale o soltanto mentale, è propriamente la dimensionesecondo cui numeriamo le cose; e quel modo che costituisce ilnumero si dice in maniera appropriata che è specie delladimensione, anche se c'è qualche diversità nel significato delnome. Se infatti consideriamo le parti rispetto al tutto, allorasi dice che numeriamo; se invece riguardiamo il tutto come divisoin parti, allora misuriamo: ad esempio, misuriamo i secoli inanni, in giorni, in ore, in istanti; ma se numeriamo gli istanti,le ore, i giorni e gli anni, allora finiremo col riempire deisecoli.Da ciò risulta evidente che nello stesso oggetto le diversedimensioni possono essere infinite e che non aggiungono proprionulla alle cose misurate, ma sono intese nello stesso modo, siache abbiano un fondamento reale negli oggetti stessi, sia chesiano state escogitate dall'arbitrio della nostra mente. Infattila gravità del corpo è qualcosa di reale, come la velocità delmovimento o la divisione di un secolo in anni e in giorni; non èreale però la divisione del giorno in ore e istanti, ecc. Tutte
42
queste cose tuttavia sono nel medesimo modo, se le consideriamosoltanto in rapporto alla dimensione, come si deve fare qui enelle discipline Matematiche; infatti spetta piuttosto ai Fisiciesaminare se il loro fondamento sia reale.Questa considerazione porta gran luce alla Geometria, poiché inessa quasi tutti concepiscono a torto tre specie di quantità: lalinea, la superficie, il corpo. Già prima infatti è statoosservato che la linea e la superficie non sono nel concettoveramente distinte dal corpo o l'una dall'altra; invero, sevengono considerate semplicemente in quanto astratte per mezzodell'intelletto, allora le specie della quantità non sono diversepiù di quanto l'animale e l'essere vivente non siano nell'uomospecie diverse della sostanza. Si deve poi notare di passaggio chele tre dimensioni dei corpi, lunghezza, larghezza e profondità, sidifferenziano tra loro solo nel nome: infatti nulla vieta che, inqualche solido dato, si scelga una delle estensioni per lunghezza,l'altra per larghezza, ecc. Sebbene poi soltanto queste tredimensioni in ogni cosa estesa, in quanto semplicemente estesa,abbiano fondamento reale, qui tuttavia non le prendiamo in maggiorconsiderazione di infinite altre, che o sono forgiatedall'intelletto o hanno altri fondamenti nelle cose
(302) REGOLA XVIQuelle cose poi che non richiedono un attenzione presente della mente, anche senecessarie alla conclusione, è preferibile che vengano designate per mezzo di cifre moltobrevi piuttosto che per mezzo di figure intere: così infatti la memoria non potràingannarsi, né tuttavia il pensiero in tanto si distrarrà a trattenerle, mentre si applica adedurne altre.
Del resto, poiché abbiamo detto che, tra le innumerevolidimensioni che si possono dipingere nella nostra fantasia, nonbisogna, con un solo e medesimo atto intuitivo, sia della vista,sia della mente, contemplarne più di due differenti, è importanteritenere tutte le altre in modo che si presentino facilmente tuttele volte che l'uso lo esiga, fine cui sembra che la memoria siastata predisposta dalla Natura. Poiché però essa è spesso labile eperché non si sia costretti ad occupare una parte della nostraattenzione nel rinnovarla, quando siamo presi da altri pensieri,l'arte, molto a proposito ha inventato l'uso della scrittura;fiduciosi nel suo aiuto, non affideremo qui più nulla allamemoria, ma, abbandonando libera e intera la fantasia allepresenti idee, tracceremo sulla carta qualunque cosa dovrà esserricordata; e ciò mediante segni molto brevi, affinché, dopo aver
43
osservato (303) secondo la regola nona distintamente le singolecose, possiamo, secondo la undecima, percorrerle tutte con unmovimento molto veloce del pensiero e intuirne insieme il maggiornumero possibile.Tutto ciò che sarà pertanto da considerarsi come uno per lasoluzione di una difficoltà, lo indicheremo con un solo segno chesi può immaginare a piacere. Per facilità però ci serviremo deicaratteri a, b, c, ecc., per esprimere le grandezze già note, e A, B,ecc., per designare quelle ignote; spesso premetteremo aicaratteri le cifre dei numeri 2, 5, 4, ecc., allo scopo di rendereesplicita la molteplicità di quelle e di nuovo <altre ne>aggiungeremo per il numero dei rapporti che in esse si dovrannointendere: così se scriverò 2a3, sarà come se dicessi il doppiodella grandezza indicata con la lettera a contenente tre rapporti.Con tale accorgimento non solo compendieremo poi molte parole, ma- ciò che soprattutto importa - mostreremo i termini delladifficoltà così puri e nudi che, anche senza omettere nulla diutile, non vi si troverà mai nulla di superfluo e che occupiinvano la capacità dell'ingegno, quando la mente dovrà abbracciaremolte cose in una volta.Perché tutte queste cose siano più chiare, si deve osservare inprimo luogo che i Calcolatori sono soliti indicare le singolegrandezze mediante più unità o con qualche numero, mentre noi inquesto luogo facciamo astrazione dagli stessi numeri, comepoc'anzi dalle figure della Geometria o da qualunque altra cosa.Facciamo questo sia per evitare la noia di un lungo e superfluocalcolo, sia principalmente perché le parti dell'oggetto cheappartengono alla natura della difficoltà restino sempre distintee non vengano implicate in numeri inutili;(...) (305) In generale si deve pure osservare che non bisogna maiaffidare alla memoria nessuna di quelle cose che non richiedonouna costante attenzione, quando le possiamo fissare sulla carta,affinché un inutile ricordo non sottragga qualche parte dellanostra mente alla cognizione di un oggetto presente; si deve poiapprontare un indice in cui inserire i termini della questionecome saranno presentati la prima volta, poi in quale modo vengonoastratti e i segni con cui vengono designati affinché, dopo che lasoluzione sarà stata trovata con questi stessi segni, la siapplichi facilmente, senza alcun aiuto della memoria, all'oggettoparticolare di cui sarà questione; non si astrae infatti mai nullase non da qualcosa di meno generale, (...)
44
3. Lettera VI a *** 1628 OF I (AT I, 5-13, 7-10).
In questa lettera, diretta probabilmente a Jean Silhon, anche luiamico del celebre letterato Jean Louis Guez de Balzac, e destinataa difendere le Epistole di de Balzac, C. ha modo di distinguerel'uso del linguaggio nelle "prime incolte età", da quello dellaretorica politica e giudiziaria che considera, invece,completamente svincolato dal rapporto con la verità.
(347) All'illustrissimo Signor*** Giudizio su alcune Epistole del signor di Balzac 1628Signore illustrissimo,Qualunque sia l'intenzione con cui leggo queste Epistole, o peranalizzarle seriamente, o piuttosto per dilettarmi, è così grandeil piacere che mi procurano, che non solo non trovo nulla dariprendervi ma, tra cose tanto buone, non mi è neppure facilegiudicare quale lodare particolarmente. In esse si trova infattiquella purezza di elocuzione che, come la salute nel corpodell'uomo, è soprattutto da stimarsi ottima per il fatto che nonsi fa per nulla sentire. Vi si manifesta inoltre grazia edeleganza: come l'avvenenza di una donna compiutamente bella, chenon si esprime certo in questa o in quella parte, ma in taleaccordo e armonia di tutte, che nessuna sua parte potrebbedesignarsi come eminente tra le altre, perché non si deducaimperfezione per non buona proporzione delle altre parti.(348) Come però tra nei e difetti delle forme che di solitovediamo si distinguono facilmente singole parti della bellezza(alcune talvolta degne di così grande lode da permetterci distimare quanto maggiori sarebbero i meriti di una bellezza affattocompiuta posto che si desse), così, se volgo la mente a scritti dialtri autori, vi riscontro spesso un buon numero di pregi dieloquio che si distinguono da certi difetti cui sono commisti.Giacché ad essi anche qui non si risparmiano lodi, posso arguirein quanta maggiore considerazione debban esser tenuti lì doveappaiono affatto incontaminati. Infatti, se talvolta presso altriautori parole sceltissime, disposte in accurato ordine e fluentiin nobile stile, danno forse non scarsa soddisfazioneall'orecchio, per lo più, negli stessi casi, il modesto pensiero,disperso inoltre in vasti discorsi, non appaga gli ingegniscrupolosi. Al contrario, se espressioni densissime di significatoper la dovizia di nobili pensieri sono in vari casi apprezzatedalle menti più capaci, non è raro che risultino ad esse faticose
45
a causa di uno stile pesante e semioscuro: se poi qualcuno, traquesti estremi, si attiene al giusto mezzo e osserva con piùrigore le vere regole del discorso nell'esprimere cose semplici,risulta tanto austero da non essere in alcun modo prediletto dagliingegni raffinati. Infine se altri, ispirati da Muse piùaccomodanti, utilizzano motti pungenti o giochi di parole,mostrano quasi tutti di mal individuare la grazia del discorso onell'artificiosa maestà delle parole obsolete, o nel clamore delleespressioni straniere, o nella fievolezza di nuovi termini, o inridicoli equivoci, o in immagini poetiche, false argomentazioni efutili arguzie: tutte bagatelle che non posson piacere agli uominiseri più di quanto piaccian loro le sciocchezze degli istrioni ogli atti mimici delle scimmie.In queste Epistole invece la facondia dell'elegantissimo discorso,che sola basterebbe ad appagare il lettore, non stempera nésoffoca la forza delle argomentazioni, mentre la dignità dellemassime, che hanno sufficiente peso per sostenersi facilmente dasole, è lungi dall'esser sminuita dalla povertà dell'espressione.Gli altissimi pensieri della mente, che trascendono l'uomo dellastrada, sono molto accuratamente espressi con parole frequentisulla bocca degli uomini della Corte e legittimate da un nonrecente uso: da tanto felice accordo tra le cose e le parole sorgeuna (349) grazia semplice, diversa da quegli artifizi che disolito impressionano il volgo, come l'ingenuo colore di unabellissima fanciulla è diverso dal rosso e dal bianco dellevecchie pruriginose.Ecco quanto dovevo dire sull'elocuzione, che sarebbe quasi il solooggetto da considerare in questo genere di scritti, se queste letterenon si rivelassero di maggior gusto di quelle che solitamentes'inviano agli amici. Poiché però trattano assai spesso argomentidi non minore levatura di quelli che si trovano nelle arringhe chepronunciavano in pubblico gli antichi oratori, occorre che dicaqualcosa su questa eccellente scienza del persuadere, che disolito si richiede come complemento dell'eloquenza. Anche questaha avuto in altri i suoi meriti e i suoi difetti. Nelle prime edincolte età, prima ancora che nascessero i dissidi in questomondo, quando la lingua era l'espressione spontanea degli affettidi spiriti ingenui, si manifestava per così dire nei più altiingegni la forza divina dell'eloquenza, quale conseguenza dellasollecitudine per la verità e dell'abbondanza di buon senso: essaha tratto gli uomini rudi dalle selve, ha imposto le leggi,fondato le città, ha esercitato nello stesso tempo sia il poteredi persuadere che quello di regnare. Poco dopo però essa fu
46
corrotta nel mondo greco-romano per i dibattiti nei tribunali eper le frequenti concioni politiche: se ne era fatto un usoeccessivo. Essa passò infatti nelle mani di uomini volgari che,disperando di poter conquistare gli animi degli uditori in unleale confronto e con le sole forze della verità, ricorrevano asofismi e ad insidie fondate su vuote parole; con questi mezzi nondi rado riuscivano ad ingannare incauti uditori, ma non avevanoper questo maggior diritto gareggiare con chi li aveva precedutinell'arte dell'eloquenza quanto <ne avessero> i traditori <digareggiare> con ardimentosi soldati. Talvolta impiegavano - è vero- i loro colorati argomenti anche per patrocinare la verità; mahanno sempre posto il vanto maggiore della loro arte nel sostenerepessime cause e per questo li stimo miserabili: non sono infattimai potuti essere ottimi oratori se non apparendo pessimi uomini.
47
4. Lettera X a Mersenne 8 ottobre 1629 OF I (AT I, 22-32, 25).
(357) Stando al titolo mi pare che quel libro dei Cammei e dei(358) Talismani* non debba contenere che chimere. Nello stessomodo la testa parlante nasconde senza dubbio qualche impostura:dire infatti che bastano molle e tubicini per far recitare tuttoil Pater Noster, come accade per far cantare il gallo nell'Orologiodi Strasburgo, è cosa che non posso credere facilmente.
*Si tratta dell'opera: Curiositez inouyes sur la sculture talismanique des Persans,horoscopes des Patriarches et lectures des Estoilles di M. J. Gaffarel (Paris 1629),inviatagli da Mersenne.
48
5. Lettera XV a Mersenne 20 novembre 1629 OF I (AT I, 76-82).
Non possediamo la lettera di Mersenne cui C. risponde (cfr. nota in ATI, 572-3), ma Mersenne stesso lavorava ad un suo progetto di linguauniversale come risulta da una lettera non datata del 1636 o 37 cheaccompagna l'invio a Peiresc de l'Harmonie universelle. Da una lettera aGassendi del gennaio 1636 apprendiamo che discute questa volta ilprogetto di Jean le Maire, mentre quello che discute con C. è quello dides Valles (PELLEREY 1992, ECO 1993)La lettera (tranne la fine "non sperate...") fu copiata da Leibniz e sitrova in: Couturat, Louis (1903), Opuscules et fragments inédits extraits desmanuscrits de la Bibliothèque Royale de Hanovre, Paris, Alcan, réimp. (1961),Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, p. 28.L'argomentazione antiarbitrarista ritorna anche nelle lettere cheLeibniz scrive al filosofo e matematico Ehrenfried Walther vonTschirnaus (1651-1708) tra il 1679 e il 1684, discutendo a fondo ladottrina di C. e i progetti che Leibniz veniva elaborando intorno aduna possibile lingua universale. Scrive Leibniz, parlando del fatto cheaveva acquisito conoscenze di algebra: "Nel frattempo tuttavia, pocotempo dopo mi imbattei nella lettera in cui si parla di una sua certalingua filosofica, mediante la quale (se ben ricordo) anche uncontadino dovrebbe poter progredire nella ricerca della verità confacilita eguale a quella di un gran filosofo, e in cui si fanno altreasserzioni non dissimili ma che mi giungevano inaspettate. Ma iltermine 'lingua' mi fu / d'ostacolo alla comprensione." e infattiLeibniz ritiene di aver colto l'essenza del discorso cartesianoindividuando nell'algebra il "linguaggio" che C. cercava (Scritti di logica,trad. it. a c. di Francesco Barone, 2 voll., Bologna, Zanichelli,19681, 1992 ed. riv. e ampl., Roma-Bari, Laterza, vol. II- 440-53 cit.447-8).Cit in: CASSIRER 1923, MIGLIORINI 1929, DE MAURO 1965, LEFÈVRE 1965,ROSIELLO 1967, DROIXHE 1978, CAHNÉ 1980, MARION 1981, JOLY 1986,GENSINI 1991, PELLEREY 1992, ECO 1993, TRABANT 1994, ECO 1995, SÉRIS1995.
(358) DESCARTES A MERSENNEAmsterdam, 20 novembre 1629
Reverendo Padre,Questa proposta di una nuova lingua desta più ammirazione a primavista di quel che non appaia quando la si analizzi più da vicino:in tutte le lingue, infatti, null'altro v'è da apprendere se nonil significato delle parole e la grammatica.Per quanto riguarda il significato delle parole, l'autore di taleproposta non promette nulla di particolare: egli, infatti, nella
49
quarta proposizione scrive: “linguam illam interpretari dictionario”, ed èciò che un uomo un po' versato nello studio delle lingue può faresenza i suoi suggerimenti in tutte le lingue ordinarie. Sono certoche se ad Hardy si facesse avere un buon dizionario in cinese o inqualsiasi altra lingua e un libro scritto nella stessa, eglisarebbe in grado di farne emergere il senso.Ciò che vieta all'uomo comune di poterlo fare sta nelle difficoltàdella grammatica; mi par d'indovinare che qui stia tutto ilsegreto del vostro uomo. È cosa però assai semplice; posto infattiche si immagini una lingua dove non si dia che un modo diconiugare, declinare e costruire le parole, una lingua priva diforme difettive ed irregolari - tutti aspetti causati dallacorruzione dell'uso - e dove persino le flessioni dei nomi e deiverbi e la (359) costruzione si facciano per affissi, tuttispecificati nel dizionario e da apporsi prima o dopo i nomiprimitivi, non desterà meraviglia che gli ingegni comuniapprendano con l'aiuto del dizionario a comporre in essa in menodi sei ore, il che appunto è oggetto della prima proposizione.Per quanto riguarda la seconda <proposizione>, e cioè “Cognita haclingua, caeteras omnes, ut ejus dialectos, cognoscere”, non è posta che per lavalorizzazione della merce; non precisa infatti quanto temposarebbe necessario per conoscere le altre, ma soltanto chesarebbero da considerarsi come suoi dialetti: come dire che questalingua, non contenendo irregolarità grammaticali, sarebbe assuntacome primitiva. Occorre anche notare che nel suo dizionario eglipotrebbe utilizzare come nomi primitivi quelli in uso in tutte lelingue, come se fossero sinonimi. Così, per esempio, persignificare l'amore, potrebbe assumere aimer, amare, filein, ecc.; unFrancese, aggiungendo a aimer l'affisso che indica il sostantivo,otterrà amour, un Greco aggiungerà lo stesso a filein e così via.Su questa base la sesta proposizione appare assai facile daintendere: scripturam invenire, ecc. Utilizzando infatti nel dizionarioun solo segno che rinvii ad aimer, amare, filein, e a tutti i sinonimi,il libro che sarà scritto con quei caratteri potrà essereinterpretato da tutti quelli che saranno in possesso di queldizionario.Anche la quinta proposizione non sembra aver altro fine che quellodi lodare la sua mercanzia; come vedo, infatti, il termine arcanumin qualche proposizione, comincio ad averne cattiva opinione.Penso però che egli volesse semplicemente dire che, avendointensamente filosofato intorno alle grammatiche di tutte questelingue che cita, al fine di ridurre la sua, potrebbe insegnarlepiù facilmente dei maestri che di solito lo fanno. Rimane la terza
50
proposizione, che mi pare assolutamente un arcanum: sostenereinfatti che spiegherà i pensieri degli Antichi attraverso leparole che essi hanno utilizzato, assumendo ogni termine per (360)l'autentica definizione della cosa, è come dire, in effetti, cheridarà i pensieri degli Antichi, assumendo le loro parole in sensodiverso da quello che essi avevano loro attribuito, e tutto ciònon è accettabile; ma forse avrà voluto dire altra cosa.Ora questa idea di riformare la grammatica, o piuttosto dicostruirne una nuova che possa apprendersi in cinque o sei ore eche si possa rendere comune a tutte le lingue, potrebbe costituireinvenzione utile al pubblico, se tutti gli uomini si accordasseroper metterla in uso; prevedo però a questo proposito duedifficoltà.La prima sta nel non buon accostamento delle lettere checauserebbe spesso suoni sgradevoli ed insopportabili per l'udito;è infatti per evitare tale difetto che l'uso ha introdotto tuttala differenza delle inflessioni delle parole ed è impossibile cheil vostro autore abbia potuto porre rimedio a questo inconvenientecostruendo la sua grammatica universale per tante diverse nazioni;ciò infatti che è facile e piacevole nella nostra lingua è rude edinsopportabile per i Germani, e così di seguito. In tal modo tuttociò che sembra possibile è di evitare questo sgradevole incontrodelle sillabe in una o due lingue: la sua lingua, universale nonsarebbe dunque che ad uso di un paese. A noi però non puòinteressare apprendere una nuova lingua da parlarsi solo con iFrancesi.Il secondo inconveniente sta nella difficoltà d'apprendere leparole di questa lingua. E' vero, infatti, che se per i nomiprimitivi ciascuno si serve di quelli della propria lingua, lacosa non gli sarà particolarmente gravosa, ma è altresì vero chenon sarà inteso che dai suoi compatrioti se non per iscritto,quando chi lo vorrà intendere si darà la pena di cercare tutte leparole nel dizionario, cosa troppo noiosa per sperare che siaattuata. Se vuole che si apprendano nomi primitivi comuni a tuttele lingue, non troverà mai nessuno che voglia affrontare questafatica: sarebbe più facile far sì che tutti gli uomini siaccordassero ad apprendere la lingua latina o qualche altra traquelle oggi in uso, che non questa di cui non vi sono ancora operescritte, che potrebbero esser base di esercizio, né uomini che laconoscano, con i quali si potrebbe pervenire a parlarla.Tutta l'utilità dunque che può trarsi da questa invenzione sta(361) nella scrittura, cioè: se facesse stampare un grandizionario in tutte le lingue in cui volesse essere inteso e per
51
ogni nome primitivo ponesse caratteri comuni che rispondessero alsenso e non alle sillabe, come uno stesso carattere per aimer, amaree quelli che possedessero questo dizionario e conoscessero lagrammatica di questa lingua potrebbero, cercando tutti questicaratteri uno dopo l'altro, interpretare nel loro idioma quel chefosse scritto.Ciò tuttavia non sarebbe utile che per leggere misteri erivelazioni, per altre cose infatti occorrerebbe non aver quasinulla da fare per darsi la pena di cercare tutte le parole in undizionario; non mi sembra pertanto che questo progetto possaincontrare larga applicazione. Forse però m'inganno: ho volutocomunque comunicarvi tutte le congetture che mi pareva di poteravanzare su queste sei proposizioni che mi avete inviato; così,quando avrete visto l'invenzione, potrete dire se l'ho bendecifrata.A ciò d'altra parte potrebbe aggiungersi una scoperta relativa siaalla composizione dei nomi primitivi di tale lingua che ai lorocaratteri; essa permetterebbe di insegnarla in pochissimo tempomediante l'ordine che stabilirebbe tra tutti i pensieri cheabitano la nostra mente, proprio come ve n'è uno postonaturalmente tra i numeri. Come si può, infatti, apprendere in ungiorno a contare tutti i numeri sino all'infinito e a scriverli inuna lingua sconosciuta, numeri che costituiscono un'infinità dinomi diversi, lo stesso potrebbe farsi con tutte le altre parolenecessarie per esprimere tutte le altre cose che posson esserecolte dalla mente umana. Se si pervenisse a una tale scoperta,sono certo che questa lingua s'imporrebbe nel mondo: molta gente,infatti, utilizzerebbe volentieri cinque o sei giorni di tempo perpoter farsi intendere da tutti gli uomini.Non mi pare che il vostro autore vi abbia pensato, sia perché nonv'è nulla nelle sue proposizioni che ce lo possa far credere, siaperché l'invenzione di questa lingua dipende dalla vera Filosofia.È infatti impossibile enumerare in altro modo tutti i pensieridegli uomini, porli per ordine e anche distinguerli, in modo chesiano chiari e semplici, ciò che, a mio avviso, costituisce ilmaggior segreto che si possa possedere per acquistare la buonascienza. Se qualcuno avesse spiegato quali sono le idee semplici(362) che sono nell'immaginazione degli uomini e che costituisconoil loro pensiero, e ciò fosse da tutti accolto, allora osereisperare in una lingua universale, assai facile da apprendere,pronunciare, scrivere e - ciò che è di gran rilievo - tale daaiutare il giudizio, rappresentandogli le cose tanto distintamenteche non potrebbe quasi cadere in errore; all'opposto le parole di
52
cui disponiamo quasi non possiedono che significati confusi, cuila mente degli uomini si è da tempo assuefatta, e ciò fa sì chenon intenda quasi nulla perfettamente.Sono convinto che questa lingua sia possibile e che si possatrovare la scienza da cui dipende, per mezzo della quale icontadini potrebbero giudicar della verità delle cose meglio diquel che oggi non facciano i filosofi. Non sperate tuttavia divederla in atto: essa presuppone infatti grandi mutamentinell'ordine delle cose e occorrerebbe che tutto il mondo non fosseche un paradiso terrestre, il che non è opportuno proporre che peril paese dei romanzi.
53
6. Lettera XVI a Mersenne 18 dicembre 1629 (AT I, 82-104, 103).
La lettera concerne numerose questioni, il passo citato è relativo alladifferenza tra i suoni che esprimono direttamente una passione o unmoto del corpo, e le parole il cui significato è convenzionale e il cuisuono è diverso in tutte le lingue. Cit. in: DE MAURO 1965, DROIXHE1978, CAHNÉ 1980, CAVAILLÉ 1991, PELLEREY 1992.
In quanto al fatto che le parole esprimano naturalmente unsignificato, trovo la spiegazione valida per ciò che colpiscetalmente i nostri sensi che ci obbliga ad emettere un qualchesuono: come quando qualcuno ci batte, e ciò ci costringe agridare, se si fa qualche cosa di buffo a ridere, e i suoni emessigridando o ridendo sono simili in tutte le lingue. Ma quando vedoil cielo o la terra, questo non mi costringe a chiamarli in unmodo piuttosto che in un altro; e credo che sarebbe così anche seavessimo ancora la grazia originaria.
Le citazioni che seguono, tratte da due lettere del 1630, mostrano comeC. consideri l'uso il fattore determinante della produzione dellelingue, che non sono nate da alcun progetto razionale.
7. Lettera XVII a Mersenne gennaio 1630 (AT I, 105-15, 112).
Per ciò che riguarda l'uomo delle lingue, non vi sembri strano cheutilizzi il Persiano o altre lingue simili, principalmente perchénon fa ciò sul momento ma in due o tre giorni di tempo. Poiché,avendone apprese parecchie può certo decifrare qualcosa di tuttele altre che sono in uso, per lo meno se ha ingegno. Ma è ridicolodire che i Romani hanno derivato il nome di Dio da una parolaebraica e i Tedeschi da una araba: come se il popolo che hacomposto le lingue avesse voluto sottomettersi a similifantasticherie; ciò è tanto puerile, che mi meraviglio che ci siprenda la briga anche solo di ascoltarlo.
8. Lettera XIX a Mersenne 4 marzo 1630 (AT I, 124-27, 125).
Cit. in: DE MAURO 1965.
Dei bambini, che fossero allevati insieme, non imparerebbero aparlare da soli, eccetto forse per qualche parola cheinventeranno, ma che non sarebbero né migliori né più appropriate
54
delle nostre, che essendo state inventate in questo modo daprincipio, sono state da allora in poi quotidianamente corrette eaddolcite dall'uso, che in simili cose fa più di quanto nonfarebbe l'intelletto (di un uomo) d'ingegno.
55
9. Il mondo o trattato della luce 1633 Ia ed. 1664 OF I (AT XI, 3-6; 31-36).
In questo testo, che C.rinunciò a pubblicare in seguito alla notiziadella condanna di Galilei, il filosofo assume la "favola" come modello.Egli si propone, cioè, di costruire un modello meccanico del mondo e nedescrive la genesi dalla materia e dal movimento, secondo unanarrazione simmetrica del racconto biblico. L'opera, che dovevaproseguire col trattato De l'homme che ne avrebbe costituito il XVIIIIcapitolo, non ci restano oggi che i primi quindici capitoli pubblicatinel 1664 col titolo: Le monde ou Traité de la lumière.Su Mon. in generale si veda sub CAVAILLÉ 1991.Cit. in: DE MAURO 1965, RODIS LEWIS 1966, ROMANOWSKI 1974, JOLY 1986,CAVAILLÉ 1991, SÉRIS 1995.
CAPITOLO I: DELLA DIFFERENZA CHE SUSSISTE TRA LE NOSTRE SENSAZIONIE LE COSE CHE LE PRODUCONO
(397) Proponendomi qui di trattare della Luce, la prima cosa cheintendo ricordarvi è che può darsi differenza tra la sensazioneche ne abbiamo, l'idea cioè che per il tramite dei nostri occhi cene formiamo nella nostra immaginazione, e ciò che negli oggettiproduce in noi questa <stessa> sensazione, cioè quel che nellafiamma o nel Sole chiamiamo con il nome di Luce. Infatti, perquanto ciascuno sia di solito convinto che le idee che abbiamo nelnostro pensiero siano del tutto simili agli oggetti da cuiprocedono, non vedo tuttavia ragione alcuna che renda sicuri diciò, anzi noto parecchie esperienze che debbono portarci adubitarne.Sapete bene che le parole, pur non avendo alcuna somiglianza conle cose che significano, non mancano di farcele concepire e,spesso, senza che facciamo neppure attenzione al suono deivocaboli o alle loro sillabe; può così accadere che dopo averudito un discorso di cui abbiamo compreso assai bene il senso, nonpossiamo dire in che lingua sia stato pronunciato. Ora, se paroleche significano qualcosa solo per convenzione tra gli uominibastano per farci concepire cose con le quali non presentanosomiglianza alcuna, perché la Natura non avrebbe potuto stabilireanch'essa un certo segno che generi in noi la sensazione dellaLuce, anche se tale segno non possiede nulla in sé che sia similea questa sensazione? Non è proprio così che essa ha istituito il(398) riso e le lacrime per farci leggere la gioia e la tristezzasul volto degli uomini?
56
Forse direte che gli orecchi ci fanno però effettivamente udiresolo il suono delle parole e i nostri occhi <vedere> solol'atteggiamento di chi ride o piange e che, invece, è la menteche, serbato in sé il significato di quelle parole e diquell'atteggiamento, ce ne dà nello stesso tempo larappresentazione. A ciò potrei rispondere che nello stesso modo èla nostra mente che ci rappresenta l'idea della luce ogniqualvolta il nostro occhio è stimolato dall'azione che lasignifica. Senza perdere tempo però in discussioni, farò prima adaddurre un altro esempio. Pensate che anche quando non prestiamoattenzione al significato delle parole e udiamo soltanto il lorosuono, l'idea che di esso si forma nel nostro pensiero siaqualcosa di simile all'oggetto che ne è la causa? Un uomo apre labocca, muove la lingua, emette il fiato: in tutte queste azioninon vedo nulla che non sia ben diverso dall'idea del suono cheesse ci fanno immaginare. La maggior parte dei Filosofi affermache il suono non è altro che una certa vibrazione dell'aria chegiunge a colpire i nostri orecchi, così se il senso dell'uditorappresentasse al nostro pensiero la vera immagine del suooggetto, invece del suono dovrebbe farci concepire il movimentodelle parti dell'aria che in quel momento vibra contro i nostriorecchi. Poiché però non tutti vorranno forse credere a quantodicono i Filosofi, addurrò ancora un altro esempio.Di tutti i nostri sensi il tatto è stimato il meno ingannevole edil più certo: così, se vi mostro che il tatto stesso ci faconcepire molte idee che non assomigliano in alcun modo aglioggetti che le producono, penso che non dobbiate trovare strano seaffermo che anche la vista può fare altrettanto. Ora non v'ènessuno che ignori che le idee del solletico e del dolore, che siformano nel nostro pensiero in occasione del contatto con corpiesterni, non presentano somiglianza alcuna con questi. UnFanciullo che s'addormenta e sulle cui labbra si passi dolcementeuna piuma avvertirà il solletico: pensate che l'idea del solleticoche concepisce sia simile a qualche cosa che è in questa piuma? UnSoldato di cavalleria è reduce da uno scontro: nel divampare delcombattimento avrebbe potuto rimanere ferito senza accorgersene,ma ora (399) che comincia a quietarsi, avverte dolore e pensa diessere ferito; si chiama un Chirurgo, gli si tolgono le armi, losi visita e si trova infine che ciò che avvertiva non consistevache in una fibbia o in una correggia che si era infilata sotto learmi e lo premeva procurandogli fastidio. Se il suo tatto, nelfargli sentire questa correggia, gliene avesse anche impressa
57
l'immagine nel suo pensiero, non sarebbe stato necessario unChirurgo per avvertirlo di quel che sentiva.Ora non vedo ragione che ci obblighi a credere che ciò che è neglioggetti da cui deriva la sensazione della Luce sia simile a questasensazione più di quanto le azioni di una piuma e di una correggialo siano al solletico e al dolore. Non ho tuttavia riportatoquesti esempi per indurvi a credere assolutamente che altro è laLuce negli oggetti ed altro nei nostri occhi, ma solo perché losupponiate, cosicché, astenendovi dal preoccuparvi della<opinione> contraria, possiate ora esaminare meglio con me comeeffettivamente stiano le cose.
(415) CAPITOLO VI: DESCRIZIONE DI UN NUOVO MONDO E DELLE QUALITÀDELLA MATERIA DI CUI SI COMPONE
Permettete dunque per un certo tempo al vostro pensiero di uscireda questo Mondo per recarsi a vederne un altro del tutto nuovo chefarò nascere in sua presenza negli spazi immaginari. I Filosofi cidicono che tali spazi sono infiniti e debbono ben essere creduti,ché son essi stessi che li hanno costituiti. Al fine però chequesta infinità non ci sia d'ostacolo e d'impaccio, non tentiamodi pervenire sino al punto estremo, ma addentriamoci solo quantobasta perché si possano perdere di vista tutte le creature che Diogenerò cinque o sei mila anni fa; poi, dopo esserci fermati inqualche luogo determinato, supponiamo che Dio crei di nuovotutt'intorno a noi tanta materia che la nostra immaginazione,qualunque sia la parte verso cui può estendersi, non vi scorga piùalcun luogo che sia vuoto. Chi si trova in una nave in mezzo almare, benché questo non sia infinito, può estendere - pare - lapropria vista all'infinito; eppure al di là di quel che vede c'èancora altra acqua. Così, nonostante la nostra immaginazionesembri potersi estendere all'infinito e questa nuova materia nonsi supponga infinita, possiamo tuttavia supporre senza difficoltàche essa riempia spazi assai più vasti di tutti quelli che avremoimmaginato; tuttavia, perché in tutto ciò non vi sia nulla daridire, non concediamo alla nostra immaginazione di estendersitanto lontano quanto potrebbe, ma limitiamola a bella posta ad unospazio determinato che, per esempio, non superi la distanza cheintercorre tra la Terra e le principali stelle del Firmamento, esupponiamo che la materia che Dio avrà creato si estenda ben oltreda ogni parte, sino ad una distanza indefinita. Infatti è assaipiù verosimile e più in nostro potere porre limiti all'azione delnostro pensiero che non alle opere di Dio.
58
Ora, dacché ci prendiamo la libertà di immaginare questa materia anostra fantasia, attribuiamole, se vi aggrada, una natura tale chein essa non si trovi assolutamente cosa che ciascuno non possaconoscere tanto perfettamente quanto è possibile. A tal fine (416)supponiamo espressamente che non possegga né la forma della Terra,né del Fuoco, né dell'Aria, né alcun'altra più particolare comequella del legno, di una pietra o di un metallo, e neppure lequalità di essere calda o fredda, secca o umida, leggera o pesanteo di avere qualche gusto od odore o suono o colore o luce, o altrasimile <qualità> della cui natura si possa dire che vi sia qualchecosa che non sia conosciuta in modo evidente da tutti,Non pensiamo neppure d'altra parte che sia quella Materia primadei Filosofi, così bene spogliata di tutte le sue forme e qualità,che non vi è rimasta cosa che possa essere chiaramente intesa.Concepiamola invece come un vero corpo perfettamente solido cheriempia in modo uguale tutta la lunghezza, larghezze e profonditàdi questo grande spazio in mezzo al quale abbiamo fissato ilnostro pensiero: in modo che ciascuna delle sue parti occupisempre un luogo di questo spazio, tanto proporzionato, alla suagrandezza, che non potrebbe riempirne una maggiore ne rinserrarsiin una minore, né tollerare che, nel tempo in cui la occupa,qualcun'altra vi trovi posto.Aggiungiamo a ciò che tale materia può dividersi in tutte le partie secondo tutte le figure che possiamo immaginare e che ogni suaparte può ricevere in sé tutti i movimenti che possiamo pureconcepire. Supponiamo inoltre che Dio la suddivida effettivamentein parecchie parti, tali che le une siano più grandi e le altrepiù piccole, le une di una figura, le altre di un'altra, come cipiacerà fingerle. Non che per questo le separi l'una dall'altra inmodo che si dia vuoto tra esse: pensiamo che la sola distinzioneche vi faccia sussistere consista nella diversità dei movimentiche assegna loro, facendo in modo che dal primo istante della lorocreazione le une incomincino a muoversi da un lato, le altre da unaltro; le une più rapidamente, le altre più lentamente (o anche,se preferite, <che non si muovano> affatto), e che continuino poiil loro movimento secondo le leggi ordinarie della Natura. Dioinfatti ha così meravigliosamente stabilito queste Leggi che,anche se supponiamo che non crei nulla più di quel che ho detto eperfino che, in luogo di mettervi ordine e proporzione, compongail Caos più confuso e più ingarbugliato che i Poeti possanodescrivere, esse sarebbero sufficienti per far sì che le parti diquesto Caos si sbroglino da sole e si dispongano in così buon(417) ordine da acquistare la forma di un Mondo perfettissimo e
59
nel quale potranno vedersi non solo luce, ma anche tutte le altrecose, sia generali che particolari, che si vedono in questo veroMondo.Prima però ch'io spieghi ciò più a lungo, soffermatevi ancora unpo' a considerare questo Caos e notate che non contiene cosaalcuna che non conosciate così perfettamente da non poter neppurefingere di ignorarla. Quanto infatti alle qualità che vi ho poste,se vi avete fatto attenzione, non le ho supposte che come potevateimmaginarle. Quanto poi alla materia di cui l'ho composto, apparecome ciò che più semplicemente e più facilmente è conoscibilenelle creature inanimate: la sua idea è talmente compresa in tuttequelle che la nostra immaginazione può formare che doveteassolutamente concepirla, a meno che non immaginiate nulla.Tuttavia, poiché i Filosofi sono così sottili che riescono atrovare difficoltà nelle cose che agli altri uomini sembranochiarissime e poiché il ricordo della loro Materia prima, chesanno assai difficile da concepire, potrebbe allontanarli dallaconoscenza di quella di cui parlo, a questo punto debbo dir loroche, se non erro, tutta la difficoltà che incontrano nella<materia prima> viene solo dal fatto che la vogliono distingueredalla sua quantità e dalla sua estensione esterna, cioè da unaproprietà che le appartiene, quella cioè di occupare spazio. Inciò tuttavia voglio proprio che credano di aver ragione, giacchéil mio scopo non è di soffermarmi a contraddirli. Oltre a ciò nondebbono però trovare strano se io suppongo che la quantità dellamateria che ho descritta non differisca dalla sua sostanza più delnumero rispetto alle cose numerate e se concepisco la suaestensione o la proprietà che le è propria di occupare spazio noncome un accidente, ma come la sua vera Forma e la sua Essenza; nonpotrebbero infatti negare che in tal modo essa sia assai facile daconcepire. D'altra parte il mio progetto non consiste tanto nellospiegare, come loro fanno, le cose che sono effettivamente nelvero mondo, ma soltanto di immaginarne uno a piacere in cui non visia nulla che le menti più rozze non siano in misura di concepiree che possa tuttavia essere creato esattamente come lo avròimmaginato.
60
10. L'uomo 1633 (AT XI, 130-32).
XVIII capitolo de Le monde edito separatamente con questo titolo daClerselier nel 1664.L'edizione commentata di T. S. Hall è uscita a Cambridge (Mass.), 1972.
Ora man mano che questi spiriti entrano così nelle cavità delcervello, passano di là nei pori della sua sostanza, e da questipori nei nervi; dove a seconda che entrino, o anche solamente chetendano ad entrare, più o meno negli uni che negli altri, hanno laforza di cambiare la configurazione dei muscoli in cui questinervi sono inseriti, e mediante ciò di far muovere tutte lemembra. Così come potete aver visto che, nelle grotte e nellefontane che sono nei giardini dei nostri Re, la sola forza con cuil'acqua si muove uscendo dalla sua fonte, è sufficiente per farmuovere diverse macchine, e anche per far si che suonino qualchestrumento, o proferiscano qualche parola, a seconda della diversadisposizione dei tubi in cui scorre.E in verità si possono benissimo paragonare i nervi della macchinache vi descrivo, ai tubi dei meccanismi di quelle fontane; i suoimuscoli e i suoi tendini, agli altri diversi congegni e molle cheservono a farli muovere, i suoi spiriti animali, all'acqua che limette in movimento e di cui il cuore è la sorgente, e le cavitàdel cervello sono i serbatoi. Inoltre la respirazione e altresimili azioni che sono per essa naturali e ordinarie, e chedipendono dalla circolazione degli spiriti, sono come i movimentidi un orologio o di un mulino, che il corso ordinario dell'acquapuò rendere continui. Gli oggetti esterni che, con la loro solapresenza agiscono sui suoi organi di senso, e che in questo modola determinano a muoversi in molti modi diversi, a seconda delladisposizione delle parti del cervello, sono come degli estraneiche, entrando in qualche grotta di quelle fontane, causano lorostessi senza accorgersene i movimenti che si compiono in loropresenza: poiché non possono entrarvi se non camminando su certepiastrelle disposte in modo tale che, per esempio, se siavvicinano ad una Diana che si bagna la faranno nascondere tra lecanne; e se avanzano per inseguirla, faranno venire verso di loroun Nettuno che li minaccerà col suo tridente; o se vanno daqualche altra parte, ne faranno sbucare un mostro marino chevomiterà loro acqua in faccia; o cose simili secondo il capricciodegli Ingegneri che le hanno progettate. E infine quando l'animarazionale sarà in questa macchina, vi avrà la sua sede principale nel
61
cervello, e sarà lì come il fontaniere che deve essere neiserbatoi dove confluiscono tutti i tubi di queste macchine, quandovuol provocare o impedire, o cambiare in qualche modo i movimenti.
62
11. Discorso sul metodo 1637 OF I (AT VI, 55-60).
Il Discours de la méthode fu pubblicato anonimo a Leida nel 1637. Discorso enon Trattato, come C. stesso scrive a Mersenne, perché abbandona lapretesa di una trattazione complessiva e dettagliata del metodoscientifico quale aveva pensata per le Regulae in favore di unatrattazione di principi generalissimi, per di più nella forma dellanarrazione autobiografica. Nell'opera confluiscono alcune ricerchescientifiche condotte dall'autore, il quale nella parte VIesplicitamente rimanda ai tre saggi: Dioptrique, Météores e Géométrie checostituivano l'illustrazione del metodo e di cui il celebre Discours nonvoleva essere che un'ampia prefazione. L'edizione commentata è di E.Gilson, Paris, 1925, esiste un Index du 'Discours de la méthode' de René Descartes,P. A. Cahné ed., Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1977.Su Dis. Méth. in generale si veda sub MIWA 1988.Cit. in: OLGIATI 1937, ROSSI 1960, DE MAURO 1965, LEFÈVRE 1965, CHOMSKY1966, ROSIELLO 1967, MIEL 1969, CHOUILLET 1972, PERCIVAL 1972, DROIXHE1978, JOLY 1986, BONICALZI 1987, CANTELLI 1992, COTTINGHAM 1993,TRABANT 1994, SÉRIS 1995, TANIGAWA 1995, MAINGUENAU 1996.
(537) Quanto ora ho detto avevo assai particolarmente spiegato inun trattato che fino a poco tempo fa pensavo di pubblicare. Inseguito vi mostravo quale deve essere la struttura dei nervi e deimuscoli del corpo umano per fare in modo che gli spiriti animali,essendovi dentro, abbiano la forza di muovere le sue membra, comesi osserva nel caso delle teste appena mozzate, che continuano amuoversi e mordono la terra, nonostante non siano più animate;spiegavo poi quali sono i mutamenti che debbono verificarsi nelcervello perché si produca la veglia, il sonno e i sogni, e laluce, i suoni, gli odori, i sapori, il calore e ogni altra qualitàdegli oggetti esterni vi possano imprimere mediante idee diverse;e come la fame, la sete e le altre passioni interne vi possonoanch'esse inviare le loro idee; come debba intendersi il sensocomune, dove queste idee vengono accolte, e la memoria che leconserva, e la fantasia che può variamente mutarle e comporne dinuove e può, con lo stesso mezzo, distribuendo gli spiriti animalinei muscoli, far muovere le membra di questo corpo in tanti modidiversi, quanti sono i moti del nostro corpo, sia in rapporto aglioggetti che si presentano ai suoi sensi che in rapporto alle suepassioni interne, senza che la volontà le (538) conduca. Ciò nonsembrerà per nulla strano a chi - essendo a conoscenza di quantidiversi automi o macchine semoventi l'industria umana può costruire,usando anche pochissimi pezzi a confronto di quel gran numero diossa, muscoli, nervi, arterie vene e di tutte le altre parti che
63
si trovano nel corpo di ogni animale - considererà questo corpocome una macchina che, uscita dalle mani di Dio, èincomparabilmente meglio ordinata e ha in sé movimenti piùmeravigliosi di qualsiasi altra che possa essere inventata dagliuomini.Qui mi ero particolarmente soffermato a mostrare che se vi fosseromacchine siffatte, che avessero organi e aspetto di scimmia o diqualche altro animale senza ragione, non avremmo possibilitàalcuna per riconoscere la differenza di natura tra queste e queglianimali; mentre, se ve ne fossero di somiglianti al nostro corpo ecapaci di imitare le nostre azioni per quanto fosse moralmentepossibile, avremmo pur sempre a nostra disposizione due mezzicertissimi per riconoscere che non sarebbero veri uomini. Il primoconsiste nel fatto che questi non avrebbero mai l'uso dellaparola, né d'altri segni, per comporli come noi facciamo percomunicare agli altri il nostro pensiero; è infatti benconcepibile che una macchina sia fatta in modo da pronunciareparole, ed anzi che ne pronunci effettivamente qualcuna inoccasione di azioni esterne che producano qualche mutamento neisuoi organi, sia che, toccata in qualche punto, domandi ciò che lesi vuole dire, sia che, toccata in un altro, gridi che le si famale e altre simili cose, ma non che le coordini variamente, perrispondere al senso di tutto ciò che si dirà in sua presenza, cosìcome anche l'uomo più ebete può fare. Il secondo è questo: chetali macchine, anche se facessero molte cose bene come noi, eforse anche meglio, fallirebbero però inevitabilmente in altre, ilche rivelerebbe come esse non agiscano per conoscenza, ma soltantoper la disposizione dei loro organi. Infatti, mentre la ragione èuno strumento universale, che può servire in qualsiasi occasione,gli organi di queste macchine hanno bisogno di una certaparticolare disposizione in corrispondenza di ogni azioneparticolare: da ciò si deduce che è moralmente impossibile che inuna macchina ve ne siano tanti e così diversi da farla agire intutte le circostanze della vita così come ci fa agire la nostraragione.(539) Ora con questi due stessi mezzi, possiamo ancheconoscere la differenza tra gli uomini e le bestie. E' infattidavvero assai notevole che non vi siano uomini tanto ebeti estupidi, senza far eccezione neppure per gli insensati, che nonsappiano mettere insieme diverse parole in modo da comporre undiscorso che faccia capire il loro pensiero e che, al contrario,non vi sia nessun altro animale, per quanto perfetto e felicementenato che possa fare altrettanto. Ciò non accade perché questidifettino d'organi, giacché possiamo vedere che le gazze e i
64
pappagalli possono pure proferire qualche parola come facciamonoi, eppure non possono parlare come noi, mostrando cioè dipensare ciò che dicono, mentre gli uomini che, pur essendo natisordi e muti, son privi, come le bestie e talvolta anche di più,degli organi di cui gli altri si servono per parlare, son solitiinventare essi stessi alcuni segni con i quali si fanno intendereda quelli che, vivendo generalmente con loro, hanno modo diapprendere il loro linguaggio. Questo non attesta soltanto che lebestie son dotate di ragione in misura minore di noi, ma piuttostoche non ne hanno in modo assoluto. E' chiaro infatti che ce nevuol ben poca per saper parlare; e dal momento che si notanodifferenze tra gli animali di una stessa specie, come tra gliuomini, e che alcuni sono più facili da ammaestrare di altri, nonè credibile che una scimmia o un pappagallo, tra i più perfettidella loro specie, non uguaglino in ciò un fanciullo, anche tra ipiù stupidi, o almeno uno dalla mente alterata, se la loro animanon sia del tutto differente dalla nostra. E non dobbiamoconfondere le parole con i moti naturali, che testimoniano lepassioni e che possono essere imitati tanto da macchine quanto daanimali31; o pensare, come alcuni tra gli Antichi, che le bestieparlino, ma che noi non comprendiamo il loro (540) linguaggio:infatti, se ciò fosse vero, dato che esse hanno diversi organi checorrispondono ai nostri, potrebbero farsi intendere tanto da noiquanto dai loro simili. È pure assai notevole che, sebbene moltianimali in alcune loro azioni dimostrino più industria di noi,tuttavia non ne mostrano alcuna in molte altre: cosicché, ciò cheessi fanno meglio di noi non prova che hanno ingegno - ché in talcaso ne avrebbero più di noi e ci supererebbero in ogni attività-, ma piuttosto che essi non ne hanno affatto, e che è la Naturache agisce in loro, secondo la disposizione dei loro organi, cosìcome si osserva che un orologio, pur essendo solo composto diruote e di molle, conta le ore e misura il tempo più precisamentedi noi con tutta la nostra prudenza.Dopo tutto questo, avevo descritto l'anima razionale, e fattovedere che in nessun modo può derivare dalla potenza dellamateria, come le altre cose di cui avevo parlato, ma che deveessere creata appositamente; e avevo mostrato come non basti che31“Et on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignentles passions et peuvent être imités par des machines aussi. bien que par les animaux”.Nel testo latino a “parole” (loquela) è aggiunto un chiarimento e la frase “e chepossono essere imitati tanto da macchine quanto da animali” non è tradotta affatto:Notandumque est loquelam, signaque omnia quae ex hominum instituto cogitationes significant, plurimumdifferre a vocibus et signis naturalibus quibus corporei affectus indicantur” (nota E.Lojacono).
65
sia posta nel corpo umano, come un pilota nella sua nave, se nonforse per muovere le sue membra, ma che bisogna che sia congiuntae unita ad esso ancor più strettamente, perché, oltre a tuttoquesto, possa provare sentimenti ed appetiti simili ai nostri ecostituire in tal modo un vero uomo. Del resto, mi sono qui un po'dilungato a proposito dell'anima, perché è uno degli argomenti piùimportanti; infatti, dopo l'errore di quelli che negano Dio -errore che penso aver qui sopra confutato con sufficientiargomenti - non ve n'è altro che allontani di più gli uominideboli dal giusto cammino della virtù che immaginare che l'animadelle bestie sia di natura uguale alla nostra e che, diconseguenza, non dobbiamo temere nulla, né nulla sperare dopoquesta vita, come le mosche e le formiche; mentre, quando si saquanto esse differiscano, si comprendono molto meglio gliargomenti che provano che la nostra anima è di una naturainteramente indipendente dal corpo, e che quindi non è soggetta amorire con esso; poi, considerato che non si vedono altre causeche la distruggano, si è naturalmente portati a concludere cheessa è immortale.
66
12. Diottrica 1637 OS II (AT VI, I, 83; IV, 112-14; VI, 130, 137).
Terminato nel 1634, questo scritto fu pubblicato nel 1637 come primodegli scritti applicativi che seguono il Dis. Méth. Il testo erapensato come manuale per artigiani che volessero costruire telescopimigliori ma tratta rilevanti questioni scientifiche (legge dirifrazione) e di teoria della percezione.Cit. in: RODIS LEWIS 1966, JOLY 1986, CAVAILLÉ 1991, CANTELLI 1992,PÉCHARMAN 1995, TANAGAWA 1995.
Dal Discorso I(190) Non v'è bisogno che mi accinga ad esporre quale siaveramente la sua natura [della luce] ma stimo che due o treparagoni, che aiutino a concepirla nel modo che mi sembra piùagevole, mi basteranno per spiegarne tutte le proprietà chel'esperienza ci fa conoscere e per dedurre in seguito le altre chenon posson con uguale facilità venir osservate. In tal modo nonfaccio che imitar gli astronomi, che, pur muovendo da supposizioniquasi tutte false (191) o poco sicure, tuttavia, dato che questesi riferiscono a diverse osservazioni da essi fatte, non mancanodi trarne molte conseguenze verissime e certissime.Qualche volta, procedendo di notte, senza torcia, per luoghi unpo' malagevoli, vi sarà certamente accaduto, per saper dovemettere i piedi, di dovervi aiutare con un bastone: allora, (192)avrete potuto notare che percepivate, per l'interposizione diquesto bastone, i vari oggetti che vi circondavano e che potevateperfino distinguere se erano alberi, pietre, sabbia, acqua, erba,fango o altre cose di questo genere. È vero che questa specie disensazione, per chi non ne abbia lunga consuetudine, risulta unpo' confusa ed oscura, ma consideratela in quelli che, naticiechi, se ne son serviti per tutta la loro vita e in essi latroverete così perfetta ed esatta da poter quasi dire che vedonocon le mani o che il bastone che usano è l'organo di qualche sestosenso concesso loro al posto della vista.
Dal Discorso II (232) Oltre a ciò è necessario stare attenti a non supporre chel'anima, per sentire, abbia bisogno di contemplare immaginiinviate dagli oggetti fino al cervello, così come in generepensano i nostri Filosofi; o, almeno, bisogna concepire la naturadi queste immagini del tutto diversamente da come essi fanno.Infatti, non considerando nelle immagini nient'altro se non cheesse devono avere una certa somiglianza con gli oggetti che
67
rappresentano, questi Filosofi non possono poi dimostrarci comequelle possano formarsi da questi oggetti ed essere ricevute dagliorgani dei sensi esterni e trasmesse dai Nervi fino al cervello. Enon hanno avuto nessuna ragione di supporle, se non che, vedendoessi che da un quadro il nostro pensiero può esser facilmenteportato a concepire l'oggetto che vi è dipinto, sono stati indottia credere che esso dovesse esser portato, nello stesso modo, aconcepire gli oggetti che toccano i nostri sensi da alcune piccoleimmagini di essi che si formerebbero nella nostra testa: dobbiamoinvece pensare che, oltre alle immagini, molte altre cose possonostimolare il nostro pensiero come, per esempio, i segni e leparole, che in nessun modo assomigliano alle cose che significano.E se, per allontanarci il meno possibile dalle opinionicomunemente accolte, preferiamo (233) ammettere che gli oggettiche sentiamo inviino veramente le loro immagini fin dentro ilnostro cervello, dobbiamo notare che non v'è nessuna immagine chealmeno debba assomigliare in tutto e per tutto agli oggetti cherappresenta (in caso diverso non si darebbe, infatti, nessunadistinzione tra l'oggetto e la sua immagine), ma che è sufficienteche assomigli agli oggetti in poche cose e che spesso laperfezione di tali immagini dipende perfino dal fatto che nonassomigliano loro quanto potrebbero. Come vedete nelle stampe che,pur risultando da un po' d'inchiostro sparso qua e là sulla carta,ci rappresentano foreste, città, uomini e financo battaglie etempeste, anche se delle innumerevoli diverse qualità che esse cifanno immaginare in questi oggetti non ve n'è alcuna, se sieccettua la figura, cui propriamente rassomiglino. Talesomiglianza è poi anche assai imperfetta, giacché su unasuperficie completamente piana esse ci rappresentano, posti invario modo, corpi in rilievo e sul fondo e, secondo le regoledella prospettiva, spesso rappresentano meglio cerchi con ovali,che non con altri cerchi, e quadrati meglio con rombi che non conaltri quadrati, e così per ogni altra figura: in tal modo spesso,per essere più perfette come immagini e rappresentare meglio unoggetto, non debbono in alcun modo rassomigliargli. La stessa cosadobbiamo pertanto pensare delle immagini che si formano nel nostrocervello ed osservare che si tratta solo di renderci conto comepossano fornire all'anima il mezzo di sentire tutte le (234)diverse qualità degli oggetti cui si riferiscono, e non già disapere come possano essere simili a loro. Nello stesso modo quandoil cieco, di cui abbiamo sopra parlato, tocca col suo bastonealcuni corpi, è certo che questi non inviano fino a lui cosaalcuna, ma che, facendo muovere diversamente il suo bastone a
68
seconda delle diverse qualità che sono in loro, fanno muovere perciò stesso i nervi della sua mano e, in seguito, le parti delcervello onde questi nervi provengono. Ciò dà alla sua animal'occasione di sentire in questi corpi tante diverse qualità,quanto vari sono i movimenti che essi causano nel suo cervello.
Dal Discorso VI (252) Ora, anche se questa figura, passando in tal modo finoall'interno della nostra testa, conserva sempre qualchesomiglianza con gli oggetti da cui procede, non bisogna tuttaviaper nulla credere, come poc'anzi vi ho già abbastanza fattointendere, che sia per mezzo di tale somiglianza che essa facciain modo che noi li percepiamo, come se nel nostro cervello vifossero ancora altri occhi coi quali potessimo vederla, ma,piuttosto, che sono i movimenti da cui essa è composta che, agendoimmediatamente sulla nostra anima, in quanto unita al corpo, sonoistituiti dalla Natura per procurarle tali sensazioni.(259) La percezione della distanza non dipende più di quella dellacollocazione, da alcune immagini inviate dagli oggetti, maprincipalmente dalla configurazione del corpo dell'occhio; poiché,(260) come abbiamo detto, questa configurazione deve essere un po'diversa, per farci vedere ciò che ne è più distante, e man manoche la cambiamo per renderla proporzionale alla distanza deglioggetti, cambiamo anche una certa parte del nostro cervello, in unmodo che è istituito dalla Natura per far percepire alla nostraanima questa distanza: e questo ci accade comunemente senza che viriflettiamo; nello stesso modo in cui, quando stringiamo qualcosanella mano, la conformiamo alla grandezza e alla figura di questocorpo, e lo sentiamo per suo tramite, senza che sia necessario perfar ciò che pensiamo ai suoi movimenti.
69
13. Lettera CXIII marzo 1638 a *** OF I (a Rénéri per Pollot aprile-maggio 1638) (AT II, 34-47,36, 39-40, 46).
La lettera è diretta a Rénéri, amico di C.e professore nelle universitàolandesi, ed è destinata al piemontese Alfonso Pollot (o Pollotti)valoroso soldato, matematico, interessato a questioni scientifichediverse.Cit. in: BONICALZI 1987.
(584) Non mi pare affatto che sia una finzione ma una verità - enessuno deve in alcun modo negarla - il fatto che non v'è nullache sia interamente in nostro potere se non i nostri pensieri,(585) almeno se si assume, come lo faccio, il termine pensiero pertutte le operazioni dell'anima; in modo che non solo lemeditazioni e gli atti di volontà, ma anche le funzioni delvedere, dell'udire, del determinarsi <a compiere> un movimentopiuttosto che un altro ecc., in quanto dipendono da essa, sonopensieri. E nel linguaggio della filosofia non vi sono che le cosecomprese sotto questo termine che si attribuiscono propriamenteall'uomo.
(...) E' certo che la somiglianza che sussiste tra la maggiorparte delle azioni delle bestie e le nostre ci ha dato, findall'inizio della nostra vita, tante occasioni per giudicare chele bestie agiscono per un principio interiore simile a quello cheè in noi, cioè per mezzo di un'anima che è affetta da sensazioni epassioni come le nostre, che siamo tutti naturalmente condizionatida questa opinione. Qualunque ragione si possa poi invocare pernegarla, non (586) si potrebbe dire apertamente come stanno lecose, senza esporsi alla derisione dei fanciulli e della gente diingegno. Quelli però che intendono conoscere la verità debbonoinnanzi tutto diffidare delle opinioni da cui sono stati in talmodo condizionati fin dall'infanzia. Per sapere quel che se nedeve pensare, occorre, mi pare, considerare quale giudizio nedarebbe un uomo che avesse vissuto tutta la sua vita in qualcheluogo dove non avesse visto nessun altro animale all'infuoridell'uomo e dove, essendosi dato con grande ardore allo studiodelle arti meccaniche, avesse fabbricato o aiutato a fabbricareparecchi automi, di cui alcuni con figura umana, altri con quelladi un cavallo, altri di un cane ed altri ancora con quella di unuccello ecc., e che camminassero, mangiassero, respirassero,insomma che imitassero nella misura del possibile tutte le altreazioni degli animali con cui avessero qualche somiglianza, senzaomettere gli stessi segni che utilizziamo per manifestare le
70
nostre passioni, come gridare quando li si colpisce, fuggirequando si produce gran rumore attorno a loro, ecc., in modo chespesso <quest'uomo> si sarebbe trovato nell'impossibilità didistinguere tra i veri uomini e quelli che non ne avevano chel'aspetto: un uomo, cui l'esperienza avesse insegnato che perriconoscerli non vi sono che i due mezzi che ho spiegato allapagina 57 del mio Metodo32, di cui uno è che mai questi automi, senon per caso, rispondono con parole o con segni intorno a cose sucui li si interroga e l'altro che essi, per quanto i movimenti chefanno siano di frequente più regolari e più certi di quelli degliuomini più saggi, mancano tuttavia in parecchie cose chedovrebbero fare per imitarci, più di quanto non farebbero gliinsensati. Bisogna - dico - considerare che giudizio esprimerebbequest'uomo sugli animali che sono tra noi quando li vedesse,soprattutto se fosse imbevuto della conoscenza di Dio o, almeno,avesse notato quanto tutta la ingegnosità che usano gli uomininelle loro opere sia inferiore a quella che la natura fa apparirenella composizione delle piante: in quel che fa quando addensa inesse un'infinità di piccoli condotti, impercettibili alla vista,attraverso i quali fa salire poco a poco certi liquidi (587) che,giunti alla sommità dei rami, vi si mischiano, vi si congiungono evi si seccano in modo da formarvi foglie, fiori e frutti; così<quest'uomo> è giunto a credere fermamente che, se Dio o la naturaavessero formato automi che imitassero le nostre azioni, questi leimiterebbero assai meglio e sarebbero incomparabilmente e piùsagacemente prodotti di quelli che possono essere stati inventatidagli uomini. Ora non v'è alcun dubbio che quest'uomo, vedendo glianimali che sono tra noi e notando nelle loro azioni quelle duestesse cose che le differenziano dalle nostre e che sarebbeabituato a vedere nei suoi automi, giudicherebbe che in essi nonsi dà alcun sentire né autentica passione, quali sono in noi, mache si tratta soltanto di automi che, essendo prodotti dallanatura, sarebbero incomparabilmente più compiuti di quelli cheegli stesso avrebbe prima formato. Qui dunque resta solo daconsiderare se il giudizio ch'egli farebbe con conoscenza di causae non condizionato da falsa opinione, sia meno credibile di quelloche si è formato in noi dalla nostra infanzia e che poi abbiamoconservato per consuetudine, fondandolo solamente sullasomiglianza che sussiste tra alcune azioni esterne degli animali ele nostre, somiglianza che non è affatto sufficiente per provareché ve n'è una anche tra quelle interne.
32Qui in T 11, 538.
71
Per quanto riguarda l'ortografia, è vero che sta al tipografosalvaguardarla; da lui infatti non ho desiderato altro se non cheseguisse la consuetudine [...]- Non intendo del resto riformarel'ortografia Francese, né vorrei consigliare a chicchessia diimpararla in un libro stampato a Leida; la mia opinione però, sequi debbo dirla, è questa: credo che seguir esattamente lapronuncia renderebbe più facile agli stranieri l'apprendimentodella nostra lingua di quanto l'ambiguità di alcuni equivociprocuri difficoltà sia a noi che a loro, le lingue infatti sicostituiscono più parlando che scrivendo. Se nella pronuncia sidessero poi (588) equivoci che causassero frequenti ambiguità,l'uso, per evitarle, vi cambierebbe immediatamente qualcosa.
72
14. Lettera CLXXIV a Mersenne 16 ottobre 1639 (AT II, 587-99).
Parlando del libro De la Verité di Herbert di Cherbury inviatogli daMersenne, C. commenta:
(596-7) E, da un punto di vista generale, il libro segue unpercorso assai diverso da quello che io ho seguito. Esamina cosa èla Verità; e da parte mia non ne ho mai dubitato, poiché mi sembrauna nozione così trascendentalmente chiara, che è impossibileignorarla: infatti, abbiamo i mezzi per esaminare una bilanciaprima di servircene, ma non avremmo modo di sapere che cosa è laverità se non la conoscessimo per natura. Infatti quale ragioneavremmo di dare il nostro assenso a colui che ce l'insegnasse, senon sapessimo che è vera, cioè se non conoscessimo la verità? Cosìsi può spiegare quid nominis a coloro che non capiscono la lingua edire che questa parola Verità in senso proprio, denota laconformità del pensiero con l'oggetto, ma che quando la siattribuisce alle cose che sono fuori del pensiero, significasoltanto che le cose possono essere oggetto di pensieri veri, sianostri sia di Dio, ma non si può dare alcuna definizione di tipologico che aiuti a comprenderne la natura.
73
15. Lettera CXCIX a Mersenne 30 luglio 1640 OF I (AT III, 119-38, 119-21).
(605) Leida, 30 luglio 1640Mio Reverendo Padre,Inizierò a rispondervi <trattando> della lettera del SignorMeyssonnier, che, stando alla data, è la meno recente tra quelleche mi avete inviato. Gli assicuro tutta la mia devozione, che ètutto ciò che posso offrire in risposta ai suoi complimenti. (...)Per quanto riguarda le bestie, siamo così convinti per abitudineche esse sentano come noi, che ci è difficile distaccarci da taleopinione. Se fossimo però ugualmente abituati a vedere automi cheimitassero perfettamente tutte quelle nostre azioni che possonoimitare e quindi a non considerarli che come automi, nondubiteremmo in alcun modo che tutti gli animali senza ragionesiano pure automi, in quanto troveremmo che differiscono da noi intutte le stesse cose, come ho già scritto a pagina 56 del Metodo33.Nel mio Mondo ho poi spiegato minutamente come nel corpo deglianimali si trovino tutti gli organi che si richiedono un automaper imitare tra le nostre azioni tutte quelle che abbiamo incomune con le bestie.
33
Qui in T 11, 538.
74
16. Lettera CCXXXVI a Mersenne per Hobbes 21 aprile 1641 (AT III,353-357, 354-56).
In risposta a una lettera di Hobbes del 30 marzo 1641 (Lettera CCXXXIVAT III, 341 348, 342-43) indirizzatagli tramite Mersenne in cui Hobbesscrive, tra l'altro: (342) "In primo luogo si deve sapere che, cosìcome ogni uomo è o Pietro, o Socrate o un altro individuo, quantunquequesto termine uomo sia un termine comune (uno senza dubbio dellecinque parti del discorso che indica Porfirio nell'Isagoge) (343) cosìogni moto è questo o quel moto senza dubbio determinato dai termini aquo e ad quem. Così dunque Socrate e uomo non sono due uomini, né duecose, ma un uomo sotto due denominazioni (infatti quella cosa che èchiamata col nome di Socrate è la stessa cosa che è chiamata col nomeuomo), così il moto e il moto determinato sono un solo moto, e unastessa cosa sotto due nomi".
(354) Quanto a ciò che mi avete inviato da parte dell'Inglese(...) i suoi ultimi ragionamenti che mi mandate per iscritto sonocattivi come gli altri suoi che ho visto. Infatti, in primo luogo,ancorché l'Uomo e Socrate non siano due diversi supposita, tuttaviasi significa col nome di Socrate qualcosa di diverso da ciò che sidesigna col termine Uomo, (355) cioè le differenze individuali oparticolari. Allo stesso modo il movimento determinato non èdiverso dal movimento, ma nondimeno la determinazione è cosadiversa dal movimento.In secondo luogo, non è vero che la causa efficiente del movimentosia anche la causa efficiente della determinazione (...)In terzo luogo, usa una leggerissima sottigliezza, quando chiedese la determinazione si trovi nel movimento come in un soggetto;come se si trattasse in questo caso di sapere se il movimento èuna sostanza o un accidente: poiché non c'è alcun inconveniente oalcuna assurdità nel dire che un accidente è il soggetto d'unaltro accidente, come si dice che la quantità è il soggetto dialtri accidenti. E quando ho detto che il movimento era ladeterminazione del movimento, così come il corpo piano lo è delsuo piano o della sua superficie, non ho inteso con ciò fare unparagone tra il movimento e il corpo, come tra due sostanze, masoltanto come tra due cose (356) concrete, per mostrare che eranodifferenti da quelle che si potevano considerare in astratto.Infine è del tutto a sproposito che conclude che essendo cambiatauna determinazione, le altre debbono esserlo anche, poiché tuttequeste determinazioni non sono che un accidente sotto differentinomi. Se fosse così ne conseguirebbe dunque che, secondo lui,l'Uomo e Socrate non sono che una medesima cosa sotto due nomi
75
differenti; e pertanto, non una delle differenze individuali diSocrate potrebbe perire, per esempio la sua conoscenza dellafilosofia, senza che contemporaneamente non cessi di essere Uomo.
76
17 Lettera CCXXXIX a Regius maggio 1641 (AT III, 369-70).
Henry de Roy, professore di medicina teorica e botanica, fu tra iprimi e più entusiasti seguaci della filosofia cartesiana,tuttavia col tempo le divergenze fra i due divennero insanabili,specialmente sulla questione del rapporto dell'anima e del corpo,tanto che nel 1645 C. interruppe i rapporti con questo "discepoloinfedele".trad. it. da René Descartes Henricus Regius, Il carteggio. Le polemiche, RobertoBordoli ed., Napoli Cronopio, 1997,113-115.
(113) Endegeest, maggio 1641
Signore,tutta la nostra controversia sull'anima triplice è più di nomi che dicose. (114) Ma innanzi tutto, poiché ad un Cattolico Romano non èlecito affermare che l'anima nell'uomo è triplice e poiché temo imputi ame quel che poni nelle tue tesi, preferirei ti astenessi da questomodo di parlare.2. Anche se la forza vegetativa e quella sensitiva nei bruti sono atti primi,tuttavia il medesimo non vale nell'uomo, ché la mente è prima,almeno in dignità.3. Anche se le cose che convengono sotto qualche ragione generale,possono esser poste dai logici come parti di un medesimo genere,tuttavia qualsiasi ragione generale di questa sorta non è un verogenere; e non vi è buona divisione se non del vero genere in verespecie, e sebbene le parti debbano essere opposte e diverse,affinché vi sia buona divisione, esse non debbono troppo distarel'una dall'altra. Infatti se uno distingue, ad esempio, l'interocorpo umano in due parti, nella prima delle quali pone solo ilnaso e nell'altra tutte le restanti membra, questa divisionepeccherebbe come la tua, giacché le parti sono ineguali.4. Non ammetto che la forza vegetativa e quella sensitiva nei bruti meritinoil nome di anima, come lo merita la mente nell'uomo; ma così vuoleil volgo, poiché ignora che i bruti sono (115) privi di menteperciò il termine anima è equivoco rispetto all'uomo ed ai bruti.
77
18. Lettera CCXLV a Mersenne luglio 1641 OF I (AT III, 391).
Si tratta di una risposta alle obiezioni di Gassendi alle Méd. Mét.
(621) Se egli però ha concepito qualcosa di questi nomi, cosa dicui non è il caso di dubitare, ha saputo nello stesso tempo quelsi doveva intendere per le loro idee, giacché non si deveintendere altra cosa che quella stessa che ha compreso. Nonattribuisco infatti il nome di idee alle immagini dipinte nellafantasia, anzi non le chiamo con questo nome proprio perché sononella fantasia corporea; assegno invece in generale il nome diidea a tutto ciò che è nella nostra mente quando concepiamo unacosa, in qualsiasi modo la si concepisca.Temo però che egli sia di quelli che pensano di non potereconcepire una cosa quando non possono immaginarla, come se non sidesse in noi che questo solo modo di pensare e di concepire. Si èben reso conto che questa non era la mia opinione ed ha fattointendere che non era neppure la sua, poiché ha detto egli stessoche Dio non può essere concepito con l'immaginazione: Se Dio perònon è concepito mediante l'immaginazione, o non si concepiscenulla quando si parla di Dio (il che sarebbe indice di unospaventoso accecamento), o lo si concepisce in un altro modo:comunque però lo si concepisca, se ne ha l'idea giacché nonpotremmo esprimere nulla con le nostre parole quando intendiamoquel che diciamo, senza che per ciò stesso non sia certo cheabbiamo in noi l'idea della cosa che è significata dalle nostreparole.Se dunque vuole assumere il termine idea nel modo in cui ho assaiesplicitamente detto che io l'assumevo, senza sostarenell'equivoco di quelli che lo riducono alle sole immagini dellecose materiali che si formano nell'immaginazione, non avràdifficoltà a riconoscere che per idea di Dio non intendo altracosa se non ciò che tutti gli uomini intendono di solito quando neparlano e che è pure quello che egli stesso deve necessariamenteaver inteso; come avrebbe altrimenti potuto dire che Dio èinfinito ed incomprensibile e che non può essere rappresentatodalla nostra immaginazione? E come potrebbe affermare che questiattributi, e un'infinità d'altri che ci esprimono la suagrandezza, gli si (622) addicono, se non ne avesse l'idea? Ci sideve dunque trovar d'accordo sul fatto che possediamo l'idea diDio e che non è possibile ignorare quale essa sia né quel che sidebba intendere per essa; senza <tale idea> non potremmo infatticonoscere nulla di Dio. Si avrebbe un bel dire, per esempio, che
78
si crede che Dio è e che qualche attributo o qualche perfezione gliappartengono; sarebbe come non dire nulla, poiché a ciò noncorrisponderebbe alcun significato nella nostra mente, cosa chesarebbe la più empia e la più insolente del mondo.Per quanto riguarda l'Anima, le cose sono ancora più chiare. Essainfatti, come ho dimostrato, non è che una cosa che pensa è quindiimpossibile che si possa mai pensare a qualche cosa senza averenello stesso tempo l'idea della nostra Anima come una cosa capacedi pensare a tutto quel che si pensa. E' vero che una cosa di talnatura non potrebbe immaginarsi, cioè non potrebbe rappresentarsicon una immagine corporea. Non bisogna tuttavia stupirsene,giacché la nostra immaginazione non è atta che a rappresentarsicose che cadono sotto i sensi e, visto che la nostra Anima non hané colore, né odore, né sapore, né nessun'altra cosa cheappartenga al corpo, non è possibile immaginarsela o costruirneun'immagine. Tuttavia non è per questo meno concepibile: alcontrario, poiché è per essa che concepiamo le cose, essa è puredi per sé più concepibile di tutte le altre cose insieme.Dopo ciò sono costretto a dirvi che il vostro amico non ha affattocolto il senso <del mio discorso> quando, per far rilevare ladistinzione tra le idee che stanno nella fantasia e quelle chesono nella mente, dice che le prime si esprimono con nomi mentrequeste con proposizioni. Che si esprimano infatti con nomi o conproposizioni non è ciò che fa sì che esse appartengano alla menteo alla immaginazione; le une e le altre possono esprimersi inquesti due modi: è il modo di concepirle che fa la differenza;così, tutto ciò che concepiamo senza immagine è un'idea della puramente e tutto quel che concepiamo mediante immagine appartienealla immaginazione Poiché poi i limiti della nostra immaginazionesono assai brevi e ristretti, mentre la nostra mente quasi non nepossiede, vi sono poche cose, anche corporee, che possiamoimmaginare, anche se siamo capaci di concepirle. (623) Perfinol'insieme di quella scienza che potrebbe forse credersi la piùsoggetta alla nostra immaginazione poiché non considera chegrandezze, figure e movimenti, non è per nulla fondata sui suoifantasmi, ma soltanto sulle nozioni chiare e distinte della nostramente; ciò lo sanno bene tutti quelli che appena un po' l'abbianoapprofondita.Ma grazie a quale ragionamento ha potuto trarre dai miei scrittiche l'idea di Dio debba esprimersi con questa proposizione Dio esistee concludere quindi, come fa, che la principale ragione di cui miservo per provare la sua esistenza non è altro che una petizione diprincipio? Deve aver visto ben chiaro per cogliere quel che non ho
79
mai avuto l'intenzione di porvi e che mai m'era venuto alla menteprima che avessi ricevuto la sua lettera. Io ho tratto la provadell'esistenza di Dio dall'idea che trovo in me di un Esseresovranamente perfetto, che è il concetto che se ne ha comunemente.È pur vero che la semplice considerazione di un tal Essere ciporta così facilmente alla conoscenza della sua esistenza che èquasi la stessa cosa concepire Dio e concepire che esiste; Ciò nonimpedisce tuttavia che l'idea che abbiamo di Dio o di un esseresovranamente perfetto sia ben diversa da questa proposizione: Dioesiste e che possa servire di mezzo o di antecedente per provarel'altra.Nello stesso modo è certo che, dopo essere venuto a conoscenzadella natura della nostra Anima attraverso i gradi per i quali visono pervenuto ed aver così conosciuto che è una sostanzaspirituale, giacché vedo che tutti gli attributi che appartengonoalle sostanze spirituali le convengono non è stato necessarioesser gran Filosofo per concludere, come ho fatto, che essapertanto non è corporea; Occorre invece senza dubbio possedereun'intelligenza assai aperta e diversa da quella che appartienecomunemente agli uomini per vedere che una cosa non seguefacilmente l'altra e trovar vizioso questo ragionamento. E' ciòche lo prego di mostrarmi e che attendo di apprendere da luiquando vorrà darsi la pena di istruirmi. Quanto a me, non glirifiuterò le mie modeste chiarificazioni, se ne abbisogna e sepensa di agire con me in buona fede. Sono ecc.
80
19. Lettera CCXLVIII a Mersenne 22 luglio 1641 (AT III, 414-19, 417-18).
Cit. in: LEFÈVRE 1965, MARION 1981, TANAGAWA 1995.
Non capisco bene la domanda che mi fate, cioè se le nostre idee siesprimono con un semplice termine; poiché essendo le paroleinventate dagli uomini ci si può sempre servire di una sola o dimolte, per spiegare una stessa cosa.
81
20. Meditazioni sulla filosofia prima 1641, OF I (AT VIII, Méd. II 26-34; MédVI, 72-86).
Fin dal 1629 C. aveva avuto l'idea di precisare i temi della suametafisica, ma solo molto più tardi arriverà a comporre quest'opera cheaffronta i seguenti temi: le cose che possono essere "revocate indubbio", la natura della mente umana, Dio, il vero e il falso, l'essenzadelle cose materiali, la loro esistenza e la reale distinzione dellamente dal corpo. La prima edizione latina è del 1641, del 1642 quellafrancese poi ampliata e corretta nel 1647; la traduzione francese furivista da C.L'edizione critica, con indicizzazione automatizzata, frequenzelessicali e concordanza, è: 'Cogito 75', René Descartes Méditations métaphysiques,A. Robinet ed., Paris, 1976.Cit. in: OLGIATI 1937, VAN DE PITTE 1975, JOLY 1986, BORDRON 1987.La traduzione di E. Lojacono è condotta sull'edizione latina, in nota sono stateriportate alcune delle differenze di maggior rilievo che la traduzione francesepresenta.
Dalla Seconda MeditazioneDella natura della mente umana
(673) Che <accade> ora d'altra parte, quando suppongo che uningannatore potentissimo e - se mi è consentito dirlo - malvagioabbia messo in atto in ogni cosa tutto quello che è in suo potereper ingannarmi? Posso forse affermare di possedere, non fosse chein minima parte, qualcosa di quanto ho appena detto (674)appartenere alla natura del corpo? Fermo la mia attenzione, penso,ripenso, nulla mi si presenta alla mente; mi affatico invano apassare in rassegna le medesime cose. Che dire ora di quelle cheattribuivo all'anima? nutrirsi o camminare? Dal momento che non hopiù un corpo anche queste non sono che finzioni. Sentire? È chiaroche anche ciò non può darsi senza corpo e nel sonno ho avutol'impressione di percepire moltissime cose che poi mi sono accortodi non aver affatto sentito. Pensare? Ecco, ho trovato: è ilpensiero la sola cosa che non può essermi sottratta. Io sono, ioesisto, questo è certo. Quanto a lungo invero? Di certo per tuttoil tempo che penso; potrebbe infatti anche forse accadere che, seil pensiero si spegnesse in me, all'istante cessassi del tutto diessere. Ora non concedo nulla se non ciò che è necessariamentevero: sono dunque - ad essere esatti - soltanto una cosa pensante,cioè una mente o un'anima o un intelletto o una ragione, terminiil cui significato mi era prima ignoto. Sono dunque una cosa vera,
82
effettivamente esistente, ma quale cosa? L'ho detto, una cosapensante.Che altro? Lo immaginerò: non sono quel complesso di membra che sichiama corpo umano, né una qualche aria sottile diffusa tra questemembra, né un vento, né una fiamma, né un vapore, né un soffio eneppure qualsivoglia altra cosa possa immaginare: ho infattisupposto che tutte queste cose non esistono. Rimane quanto hoposto: nondimeno io sono qualcosa. Accade forse che queste stessecose, che suppongo che non esistano perché non le conosco, nonsiano tuttavia effettivamente diverse da quell'io che conosco? Nonne so nulla, né di questo intendo per ora disputare, perché possopronunciare giudizi solo su cose (675) che mi sono note. So diesistere e cerco <di sapere> chi sia quell'io che conosco. Ècertissimo che la nozione di questo essere così precisamenteassunto non dipende da quelle cose che ancora non so se esistano;da nessuna dunque di quelle che fingo con l'immaginazione. Questostesso termine fingo mi avverte del mio errore: fingerei infattiveramente se immaginassi di essere qualcosa, giacché immaginarenon è che contemplare la figura o l'immagine della cosa corporea.So già con certezza che io sono e, nello stesso tempo, chepotrebbe darsi che tutte queste immagini e, in generale,qualsivoglia cosa si riferisca alla natura del corpo, non sianoche sogni. Considerate queste cose, mi accorgo che dicendo:“immaginerò per conoscere più distintamente chi mai io sia”, nonsembrerei meno sciocco che se dicessi: “adesso invero sono desto epercepisco qualcosa di vero, ma, poiché non lo percepisco ancoracon sufficiente evidenza, mi sforzerò di addormentarmi per far sìche i sogni mi rappresentino questa stessa cosa con più evidenza everità”. Riconosco così che tra quelle cose che posso comprendereper mezzo dell'immaginazione non v'è nulla che appartenga a questosapere che ho di me stesso e che è necessario apporre gran curaper stornare la mente da siffatte cose, perché essa possapercepire con la massima distinzione la propria natura.Ma dunque, che cosa sono? Una cosa che pensa. E che è questa cosa?Invero una cosa che dubita, che intende, che afferma, che nega,che vuole, che non vuole, che immagina anche e che sente.Queste di certo non sono poche cose se tutte insieme miappartengono, Perché però non dovrebbero appartenermi? Non sonoforse io stesso che ora dubito quasi di tutto, che tuttaviaintendo alcunché, che affermo che solo questo è vero e nego ognialtra cosa, che miro a conoscerne parecchie, che non voglio essereingannato, che, anche contro il mio volere, immagino molte (676)cose e ne avverto pure molte come se pervenissero dai sensi? Che
83
cosa vi è di ciò che non sia tanto vero quanto è vero che io sono,anche se dormissi sempre e chi mi ha creato facesse quanto è insuo potere per beffarsi di me? V'è qualcosa che si distingue dalmio pensiero? V'è qualcosa che possa dirsi separato da me stesso?È infatti così manifesto che sono io a dubitare, ad intendere, avolere, che nulla viene alla mente per renderlo più evidente. Iosono però anche quella medesima entità che immagina: infatti,posto anche che accada, come ho supposto, che proprio nessunadelle cose immaginate sia vera, tuttavia la stessa forza diimmaginare esiste veramente e fa parte del mio pensiero. Infine,sono lo stesso che percepisce o che avverte le cose corporee comeattraverso i sensi, cioè vede ora la luce, ode il rumore, avverteil calore. Tutto ciò è falso, infatti dormo. Tuttavia è certo chemi pare di vedere, di udire, di avvertire calore. Ciò non puòessere falso, ché in ciò effettivamente consiste quel che in me sidice sentire; e questo, assunto così con precisione, altro non èche pensare.Da ciò comincio davvero a conoscere assai meglio chi io sia.Tuttavia mi pare ancora- non posso astenermi dal crederlo -che lecose corporee, le cui immagini si formano mediante il pensiero eche gli stessi sensi cercano di scoprire, siano conosciute moltopiù distintamente di questo non so che di me stesso che non cadesotto l'immaginazione, anche se, in effetti, è sorprendente ch'iocomprenda più distintamente le cose che avverto come dubbie,ignote ed estranee a me, di quel che è vero e noto, insomma di mestesso. Vedo bene però che cos'è: alla mia mente piace vagare edessa non tollera di essere costretta entro i limiti della verità.Sia pure: allentiamole ancora una volta le briglie con (677) granlarghezza, affinché, poco dopo tiratele opportunamente, essaaccetti più facilmente di esser guidata.Consideriamo quelle cose che per lo più crediamo conoscere piùdistintamente di tutte: cioè i corpi che tocchiamo e vediamo; nonperò i corpi in generale, ché queste percezioni generali risultanonormalmente assai più confuse, ma un corpo in particolare,Scegliamo ad esempio questo pezzo di cera: da pochissimo è statotratto dall'alveare, non ha ancora perso tutto il sapore del suomiele e conserva qualche traccia del profumo dei fiori dai quali èstato raccolto; il suo colore, la sua forma, la sua grandezza sonomanifesti; è duro, freddo, facile da toccare e, se si colpisce conun dito, emetterà un suono; gli son proprie insomma tutte quellequalità che sembrano richiedersi perché un corpo possa essereconosciuto nel modo più distinto possibile. Ecco però, mentreparlo, viene posto accanto al fuoco: i residui del sapore se ne
84
vanno, l'odore svanisce, muta il colore, si perde la forma aumentala grandezza, diviene liquido e caldo, a stento può toccarsi edora, se lo si tocca, non emetterà più suono. Resta ancora ilmedesimo pezzo di cera? Sì, bisogna ammetterlo: nessuno <lo> nega,nessuno pensa altrimenti. Che si trovava dunque in esso che siconosceva tanto distintamente? Nulla certo di quelle cose che mipervenivano attraverso i sensi; quanto infatti cadeva sotto ilgusto, l'odorato, la vista, il tatto o l'udito già è mutato:rimane la cera. Forse si trattava di ciò cui ora penso: la cerastessa non era cioè questo dolce sapore del miele, né la fragranzadei fiori, ne questo candore, né la forma, né il suono, ma uncorpo che poco fa mi appariva visibile sotto questi aspetti ed orasotto altri. Che è però precisamente quel che così immagino?Consideriamo con attenzione e, messo da parte tutto ciò che nonappartiene alla cera, vediamo che rimane: null'altro invero chealcunché di esteso, flessibile, mutevole. Che è ciò: flessibile,mutevole? Forse quel che immagino, cioè che questa cera può mutarela sua figura da rotonda in quadrata o da questa in triangolare?Assolutamente no; infatti mi rendo conto che essa è capace diinnumerevoli (678) cambiamenti di tal genere e la mia immaginazionenon può seguirne tanti: non è dunque mediante l'immaginazione chesi ricava questa comprensione. Che è esteso? Non è forse ignotaanche la sua stessa estensione? Aumenta infatti nella cera che siliquefa, è maggiore quando è bollente ed aumenta ancora quando ilcalore si fa più intenso; non esprimerei un corretto giudizio suquel che è la cera se non pensassi che, per quanto riguardal'estensione, essa ammette variazioni ancor più numerose di quelleche io sia mai andato immaginando. Non mi rimane dunque checoncedere che non posso in alcun modo immaginare che sia questacera, ma solo percepirlo con la mente; dico questa cera inparticolare, poiché per la cera in generale la cosa è più chiara.Che cosa è però questa cera che si può percepire solo con lamente?34 Certamente è la stessa che vedo, tocco, immagino, la stessainsomma che fin dall'inizio pensavo che fosse- D'altra parte lapercezione <di questa cera> - bisogna notarlo - non è e non è maistata una visione, un contatto, un'immaginazione, benché primacosì apparisse, ma un'analisi della sola mente, che può essereimperfetta e confusa, come era prima, oppure chiara e distinta,come appare ora, a seconda ch'io faccia maggiore o minore attenzionealle cose che la costituiscono.
34
Ed. 1647: i termini usati sono due "l'entendement ou l'esprit".
85
Mi stupisce frattanto <di costatare> quanto grande sial'inclinazione della mia mente all'errore: infatti, per quanto vadatacitamente considerando in me queste cose, senza pronunciareverbo, resto tuttavia invischiato nelle stesse parole e quasiingannato dall'uso stesso del linguaggio. Diciamo infatti divedere la stessa cera, se essa è là, e non di giudicare che essa èpresente per il colore e per la forma.. Da ciò concluderei subitoche la cera si conosce attraverso una visione dell'occhio e nonmediante un'analisi della sola mente se, per caso, non avessi giàosservato dalla (679) finestra <alcuni> uomini passare perlastrada, e, secondo la stessa consuetudine che me lo fa dire per lacera, dico di vedere <uomini>. Tuttavia che vedo, se non deicappelli e delle vesti sotto i quali potrebbero nascondersi degliautomi?35 Giudico però che sono uomini. In tal modo è solo mediantela facoltà di giudicare, che sta nella mia mente, che afferro quelche pensavo di vedere con i miei occhi.Chi mira però a innalzare il proprio sapere al di sopra di quellocomune, deve provar vergogna di aver tratto motivi di dubbio dalleforme del linguaggio inventate dal volgo; passiamo dunque oltre econsideriamo se percepivo più perfettamente e più evidentementequel che era la cera quando l'ho vista la prima volta ed hocreduto di conoscerla con lo stesso senso esterno o almeno, con ilsenso comune, come lo chiamano, cioè con la facoltàdell'immaginazione, O piuttosto ora, dopo che ho piùdiligentemente indagato da una parte che cosa essa sia edall'altra come possa essere conosciuta. Sarebbe certo sciocconutrire dubbi su un simile quesito. Che c'era infatti di distintonella prima percezione? Che cosa che un animale qualsiasi -sembrasse non poter avere? Quando, invero, distinguo la cera dalleforme esterne e, quasi l'avessi spogliata, la considero nuda,allora sì veramente, per quanto si possa ancora incontrare qualcheerrore nel mio giudizio, non mi è dato tuttavia percepirla se nonmediante la mente umana.Infine, che dire di questa stessa mente, cioè di me stesso? Fino aquesto momento infatti non ammetto che vi sia in me altro se nonuna mente. Che cosa - dico - sono io cui sembra di percepire tantodistintamente questa cera? Non conosco forse me stesso non solocon molto maggior verità e certezza, ma anche con ben maggioredistinzione ed evidenza? Infatti, se giudico che la cera esiste inquanto la vedo, è certo che, proprio per il fatto che la vedo,risulta con molta più evidenza che anche io esisto. (680) Può
35.Ed. 1647 "spettri o uomini che non son mossi che da molle".
86
accadere infatti che quel che vedo non sia veramente la cera; puòanche darsi che non abbia neppure occhi con cui vedere qualsiasicosa, ma non può assolutamente accadere che quando io vedo o -cosa che ormai non distinguo più - quando penso di vedere, iostesso, che penso, non sia qualcosa. Per simile motivo, se stimoche la cera è per il fatto che la tocco, risulterà di nuovo lamedesima cosa, cioè che io sono. Se per il fatto che la immagino oper qualsiasi altra causa, esattamente la medesima cosa. Leconsiderazioni che svolgo qui intorno alla cera possono peròapplicarsi a tutte le altre cose che stanno fuori di me. Inoltre,invero, se la percezione della cera è parsa più distinta dopo chemi è divenuta palese non soltanto per il tramite della vista e deltatto, ma anche per parecchie altre cause, con quanta maggiordistinzione - non posso non ammetterlo - dovrò ora conoscere mestesso, giacché tutte le ragioni che possono esser utili allapercezione della cera o di qualsivoglia altro corpo sono in gradodi provar ancor meglio la natura della mia mente. Sono inoltreperò così numerose le altre cose che si trovano nella stessamente, grazie alle quali è possibile conoscerla ancor piùdistintamente, che sembra che appena debbano essere enumeratequelle che emanano dal corpo verso di essa. Ecco infine chespontaneamente sono ritornato dove volevo; infatti, poiché mi èora noto che i corpi stessi non sono propriamente percepiti daisensi o dalla facoltà dell'immaginazione, ma dal solo intelletto,e che non sono percepiti perché li. tocchiamo o li vediamo, masolo perché li concepiamo mi è assolutamente manifesto che non v'ènulla che possa conoscere con maggior facilità ed evidenza dellamia mente. Giacché però non è possibile abbandonare cosìprontamente una consuetudine che sì fonda, su una antica opinione,appare opportuno che mi soffermi su tale punto, così da poterimprimere più profondamente nella mia memoria questa nuovaconoscenza, grazie ad una durevole meditazione.
87
Dalla Sesta MeditazioneDell'esistenza delle cose materiali e della reale distinzionedella mente dal corpo
(718) Mi rimane da esaminare se esistano cose materiali. Invero sogià almeno che, in quanto oggetto della pura Mathesis36, essepossono esistere poiché le concepisco chiaramente e distintamente.Non v'è dubbio infatti che Dio sia capace di produrre tutte quellecose che io sono in grado di concepire in questo modo e non ho maigiudicato che gli fosse impossibile di compiere qualche cosa, ameno non si trattasse di alcunché che non riuscivo a percepiredistintamente. Inoltre, dalla facoltà di immaginare che so peresperienza di utilizzare allorché mi applico a tali cosemateriali, sembra seguire che queste esistono: infatti, a chiconsideri più attentamente cosa sia l'immaginazione, essa apparenon essere altro che una certa applicazione della facoltàconoscitiva al corpo che le è intimamente presente e che,conseguentemente esiste.Affinché tutto ciò risulti manifesto, esamino innanzi tutto ladifferenza che sussiste tra l'immaginazione e la puraintellezione. Infatti, ad esempio, quando immagino un triangolo,non soltanto concepisco che è una figura compresa tra tre linee,ma nello stesso tempo vedo con l'acume della mente queste trelinee come presenti37, il che è propriamente quel che intendoimmaginare. Se voglio però pensare ad un chiliagono, in veritàconcepisco che si tratta di una figura formata da mille lati tantobene quanto <concepisco> che un triangolo è una figura che constadi tre <lati>, ma non immagino nello stesso modo quei mille latiné li (719) vedo come presenti. Per quanto poi - secondol'abitudine che ho di immaginare sempre alcunché ogni qualvoltapenso alle cose corporee - forse mi rappresenti confusamentequalche figura38, è tuttavia palese che non si tratta delchiliagono, poiché non differisce per nulla da quella che mirappresenterei se pensassi ad un miriagono o a qualsiasi altrafigura formata da molti lati - né gioverebbe in alcun modo perconoscere quelle proprietà che fanno sì che il chiliogonodifferisca dagli altri poligoni. Se si tratta invece di un
36
Ed. 1647: "in quanto le consideriamo come oggetto delle dimostrazioni della geometria".37
Ed. 1647 aggiunge: "grazie alla forza e all'applicazione interiore della mia mente".38
Ed. 1647 agggiunge: "accade che quando concepisco un chiliogono".
88
pentagono, è ben vero che posso concepirne la figura senzaricorrere all'immaginazione come nel caso del chiliagono, ma possoanche immaginarla fissando l'acume della mente sui suoi cinquelati e, insieme, sull'area che quelli racchiudono: mi rendo cosìchiaramente conto che per immaginare necessito di una peculiaretensione dell'animo che non mi serve per comprendere: è questainusitata tensione dell'animo che mostra con chiarezza ladifferenza tra l'immaginazione e la pura intellezione.Considero inoltre che questa potenza di immaginare che è in me, inquanto differisce dalla facoltà di comprendere, non è necessariaalla essenza di me stesso, cioè della mia mente; infatti, anche semi mancasse, rimarrei nondimeno - non v'è dubbio - quello stessoche sono ora: da ciò sembra seguire che essa dipenda da qualcosadi diverso da me. Così comprendo facilmente che, se esiste uncorpo cui la mia mente sia in tal modo congiunta da adoperarsi,per così dire, a ispezionarlo come e quando vuole, può darsi cheper questo mezzo immagini le cose corporee: cosicché questo mododi pensare differisce dalla pura intellezione per il solo fattoche la mente, quando intende, si volge in qualche modo verso disé, considerando alcune delle idee che ha in se stessa; quandoinvece immagina, si volge al (720) corpo e vi intuisce alcunchéconforme all'idea, sia che essa l'abbia concepita di per sé, siache l'abbia percepita per mezzo dei sensi. Concepisco - dico -facilmente che l'immaginazione possa prodursi in questo modo, postoperò che il corpo esista; e poiché non si dà modo altrettantoconveniente per spiegarla, presumo pertanto che probabilmente ilcorpo esista, ma solo probabilmente: infatti, per quanto esaminiaccuratamente tutte le cose, non vedo ancora tuttavia come potertrarre da questa idea distinta della natura corporea, che trovonella mia immaginazione, un argomento che porti a concluderenecessariamente che qualche corpo esiste.Oltre questa natura corporea, che è oggetto della pura Mathesis39,sono solito immaginare molte altre cose, cioè colori, suoni,sapori, dolore ed altre simili, ma nessuna con ugual distinzione;in quanto poi le percepisco meglio con i sensi dai quali sembrache siano pervenute alla immaginazione per mezzo della memoria, alfine di trattarne con maggior agio, <mi pare opportuno>considerare nello stesso tempo anche i sensi e ricercare se daquelle <idee> che percepisco attraverso quel modo di pensare chechiamo sensibilità, non possa trarre un qualche argomento sicuroper poter stimare che le cose corporee esistano.
39 Ed. 1647 il termine Mathesis è sostituito da 'Geometria'.
89
Innanzi tutto richiamerò qua alla mia memoria quali siano le coseche prima ho stimato vere in quanto percepite per mezzo dei sensie per quali cause le ho credute tali; poi esaminerò anche leragioni che successivamente me le hanno fatte revocare in dubbio e- infine - considererò quel che ora debba crederne.Così, prima di ogni altra cosa, mi son dunque reso conto che avevouna testa, delle mani, dei piedi, e altre membra di cui è compostoquesto corpo che consideravo come una parte di me o - forse -anche come tutto me stesso; ho poi anche avvertito che tale corposi situava tra molti altri corpi dai quali poteva ricevere diversivantaggi o danni; misura di tali vantaggi era un certo sentimentodi piacere e dei danni un sentimento di dolore. Oltre al dolore eal piacere, sentivo pure in me la fame, la sete ed (721) altrisimili appetiti, nonché certe inclinazioni corporee all'allegria,alla tristezza, all'ira, ed altre simili affezioni. Al di fuori,oltre all'estensione dei corpi, alle figure ed ai movimenti,avvertivo in essi anche la durezza, il calore ed altre qualità checadono sotto il tatto; poi anche luce, colori, odori, sapori esuoni, la cui varietà mi dava modo di distinguere gli uni daglialtri il cielo, la terra, i mari e tutti gli altri corpi. Non erapoi certo senza ragione che, considerando le idee di tutte questequalità che si offrivano al mio pensiero e che erano le sole chepropriamente ed immediatamente sentivo, stimavo di avvertire certecose affatto differenti dal mio pensiero, cioè dei corpi da cuitali idee derivavano; mi rendevo infatti conto per esperienza chequeste mi si presentavano senza che vi avessi consentito,cosicché, anche se lo volevo, non mi era possibile aver lasensazione di alcun oggetto, se questo non era presente all'organodel senso, né potevo non sentir<lo> quando era presente, In quantopoi le idee che percepivo per il tramite dei sensi erano assai piùvivaci e manifeste ed anche, a modo loro, più distinte di alcunedi quelle che io, prudente e consapevole40, immaginavo meditando oche sentivo impresse nella mia memoria, <mi> pareva che nonpotessero procedere da me stesso: solo dunque rimaneva cheprovenissero da certe altre cose. Non avendo alcuna conoscenza ditali cose da altra <fonte> che da queste stesse idee, solo potevavenirmi alla mente che <tali cose> fossero simili ad esse. Giacchépoi mi ricordavo pure che mi ero servito dei sensi prima che dellaragione e riconoscevo che le idee che formavo io stesso non eranocosì manifeste come quelle che percepivo con i sensi e che per lopiù erano composte da parti di queste <ultime>, mi convincevo
40
Ed. 1647 manca 'prudente e consapevole".
90
facilmente che non avevo assolutamente alcuna idea nell'intellettoche prima non avessi avuto nei sensi. Non era infatti senzaragione che stimavo che quel corpo, che per un certo particolarediritto chiamavo (722) mio, mi appartenesse più di qualsiasialtro: infatti non potevo mai separarmi da esso come dagli altri;in esso e per esso sentivo tutti gli appetiti e tutte le affezionie - infine - avvertivo il dolore e le sollecitazioni del piacerenelle sue parti e non in altre che son poste fuori di esso. Delmotivo però per cui da questo non ben definito sentimento didolore segua una certa tristezza dell'animo e dal senso delpiacere una certa gioia, oppure da quel certo prurito dellostomaco, che chiamo fame, sia sospinto ad assumere cibo edall'arsura della gola a bere e di altri <fenomeni> di tal fattanon davo certamente altra ragione se non che ho appreso tutto ciòdalla natura; infatti non si dà affinità alcuna (almeno ch'iocomprenda) tra questo prurito e la volontà di assumere cibo o trala sensazione della cosa che apporta dolore e il triste pensieroche deriva da tale sentire. Mi pareva poi di aver appreso dallanatura anche tutte le altre cose che stimavo intorno agli oggettidei sensi, giacché mi ero convinto che le cose stessero in talmodo prima ancora di aver soppesato alcuni argomenti con cuil'avrei provato.In seguito però molte esperienze poco a poco hanno fatto vacillaretutta la fede che avevo riposto nei sensi: infatti sia talvoltatorri, che da lontano erano apparse rotonde, da vicino apparivanoquadrate, sia statue grandissime poste sulle loro cime, viste daterra, non sembravano grandi; e mi accorgevo che i giudizi deisensi esterni erano erronei in altre innumerevoli cose di talgenere, e non soltanto dei sensi esterni, ma anche di quelliinterni: infatti che può esserci di più intimo del dolore? Eppuretalvolta ho sentito dire da persone cui era stato amputato unbraccio o una gamba che qualche volta sembrava loro di avvertire(723) ancora dolore in quella parte del corpo di cui erano privi:così anch'io credevo di non esser assolutamente certo di provaresofferenza in qualche parte del mio corpo, sebbene avvertissi inessa dolore. A questi ho da poco aggiunto due generalissimi motividi dubbio: il primo era che non ho mai creduto di avvertire dasveglio alcuna cosa che non possa talvolta stimare di avvertireanche quando dormo e, non pensando che quanto mi pare sentire nelsonno provenga da cose poste fuori di me, non vedevo per qualragione dovessi crederlo piuttosto di quelle cose che mi sembra diavvertire quando son desto; il secondo era che, non conoscendoancora, o - almeno - fingendo di non conoscere l'autore della mia
91
origine, non vedevo ostacoli a che la mia natura fosse tale da farsì che mi ingannassi anche in quelle cose che mi apparivanoverissime. Quanto agli argomenti che mi avevano prima convintodella verità delle cose sensibili, non trovavo particolaridifficoltà a confutarli. Infatti, poiché la natura sembravaspingermi verso molte cose che la ragione sconsigliava, nonpensavo accordar molta fiducia agli insegnamenti della natura.Sebbene poi le percezioni41 dei sensi non dipendessero dalla miavolontà, non stimavo per questo di dover concludere cheprocedessero da cose differenti da me, ché forse può trovarsi inme stesso qualche facoltà che, pur essendomi ancora ignota, leproduca.Ora però che comincio a conoscere meglio me stesso e l'autoredella mia origine, non stimo invero di dover ammettere alla ciecatutte quelle cose che mi pare percepire per mezzo dei sensi, maneppure di doverle revocare tutte in dubbio.Innanzi tutto, giacché so che tutte le cose che percepiscochiaramente e distintamente possono essere prodotte da Dio tali equali le intendo, è sufficiente che possa comprendere chiaramentee distintamente una cosa senza l'altra per esser certo che l'una èdiversa dall'altra, giacché, almeno da Dio, può essere (724) postaseparatamente; perché la si consideri diversa, non riveste poiimportanza la potenza per la quale questo avviene. Pertanto dalfatto stesso che so di esistere e che riconosco nel contempo chealla mia natura o alla mia essenza appartiene solo questo, cioèche sono una cosa pensante, concludo correttamente che la miaessenza consiste solo in ciò: che sono una cosa che pensa42.Nonostante poi forse (o piuttosto certamente, come dirò inseguito, abbia un corpo cui sono assai strettamente unito, vistoche tuttavia da un lato ho un'idea chiara e distinta di me stessoin quanto soltanto cosa pensante, inestesa, e, d'altro lato,un'idea distinta del corpo in quanto soltanto cosa estesa, che nonpensa affatto, è certo che io sono veramente distinto dal miocorpo e che posso esistere senza di esso.Inoltre trovo in me facoltà con certi speciali modi di pensare,quali ad esempio le facoltà di immaginare e di sentire, senza lequali posso concepire tutto me stesso chiaramente e distintamente,ma non viceversa quelle senza di me, cioè senza una sostanzaintelligente cui ineriscano: infatti nel loro concetto formale
41 Ed. 1647 il termine percezioni è tradotto con 'idee'.42
Ed. 1647 aggiunge: "o una sostanza dì cui tutta la natura o l'essenza è soltanto di pensare".
92
esse comprendono qualche intellezione grazie alla quale percepiscoche sono distinte da me come i modi dalla cosa.Riconosco anche certe altre facoltà, come quella di mutar diluogo, di assumere varie figure e simili che, come le precedenti,non possono essere concepite, né - quindi - esistere, senza una(725) qualche sostanza in cui si trovano: è manifesto però chequeste <facoltà>, posto che esistano, debbono trovarsi in unasostanza corporea, ossia estesa, e non in una sostanzaintelligente: infatti nel loro concetto chiaro e distinto ècompresa sì una qualche estensione, ma assolutamente nessunaintellezione. Per di più, si trova senza dubbio in me una certafacoltà passiva di sentire, cioè di ricevere e di conoscere leidee delle cose sensibili, ma non potrei utilizzarla in alcunmodo, se in me o in altro non esistesse anche una facoltà attivaper produrre o formare tali idee. Ora tale facoltà attiva non puòcertamente essere in me, in quanto non presuppone assolutamentealcuna intellezione, e tali idee si producono senza la miapartecipazione, anzi, spesso, anche contro la mia volontà: restadunque che sia in qualche sostanza diversa da me in cui, visto chetutta la realtà che è oggettivamente nelle idee prodotte da questafacoltà deve (come ho detto sopra) inerire o formalmente oeminentemente, o questa sostanza è corpo, cioè una naturacorporea, ove è contenuto formalmente tutto ciò che èobiettivamente nelle idee, oppure - non v'è dubbio - è Dio oqualche creatura più nobile del corpo, nella quale tutte le cosesono contenute eminentemente. Non essendo però Dio ingannatore, èdel tutto manifesto che non è lui ad inviarmi direttamente taliidee e che non lo fa neppure attraverso qualche creatura, nellaquale la loro realtà obiettiva sia contenuta non formalmente, masolo eminentemente. Infatti, poiché non mi ha concessoassolutamente alcuna facoltà per conoscere ciò, ma piuttosto unagrande inclinazione a credere che esse mi siano inviate dalle cosesensibili, non vedo in qual modo potrebbe comprendersi che <Dio>non è ingannatore, se tali idee procedessero da (726) alcunchédiverso dalle cose corporee. Dunque le cose corporee esistono.Tuttavia, forse, non tutte esistono esattamente quali lepercepisco con i sensi: questa percezione dei sensi, infatti, inmolte cose appare assai oscura e confusa; in esse però si troveràalmeno quanto percepisco chiaramente e distintamente, cioè tuttequelle cose che, considerate in generale, sono compresenell'oggetto della pura Mathesis43.
43 Ed. 1647 scrive invece di Mathesis: "Geometria speculativa".
93
Per quanto poi riguarda le altre che sono o soltanto particolari,come ad esempio che il sole sia di tal grandezza o di tal figuraecc., oppure concepite meno chiaramente, come la luce, il suono,il dolore e simili, sebbene siano assai dubbie ed incerte, il solofatto che Dio non è ingannatore e quindi non può accadere che sitrovi falsità nelle mie opinioni, senza che sia in me anchequalche facoltà concessa da Dio per correggerla, mi apre allaferma speranza di conseguire la verità anche su di esse. Di certotutte le cose che apprendo dalla natura contengono in sé alcunchédi vero: infatti per natura, considerata in generale, non intendoora null'altro che Dio stesso o il coordinamento44 delle cose createche Dio ha stabilito, mentre per la mia natura particolare nonintendo nient'altro che l'insieme di tutte quelle cose che Dio miha attribuito.Ora non v'è nulla che questa natura mi insegni più chiaramente delfatto che io ho un corpo che sta male quando avverto dolore, cheabbisogna di mangiare e di bere nel momento in cui soffro la fameo la sete e cose simili; non debbo dunque dubitare che in ciò visia alcunché di vero.Attraverso queste sensazioni di dolore, di fame, di sete ecc. lanatura mi insegna anche che non solo sto all'interno del mio corpocome un nocchiero entro la sua nave, ma che sono così (727)strettamente congiunto e quasi confuso con esso da costituire untutto con <tale corpo>. Infatti, in caso diverso, quando il miocorpo è ferito, io, che non sono altro che cosa pensante, nonavvertirei per questo dolore alcuno, ma percepirei con il purointelletto questa lesione proprio come il nocchiero si rende contocon la vista se la nave ha subito qualche danno; quando poi ilcorpo abbisogna di cibo o di bevande lo avvertirei con chiarezzasenza provare quelle confuse sensazioni della fame e della sete.Infatti queste sensazioni di fame, di sete, di dolore ecc. nonsono altro che certi confusi modi di pensare che provengonodall'unione e dalla quasi mescolanza della mente con il corpo.Oltre a ciò la natura mi insegna che intorno al mio corpo neesistono vari altri, tra i quali alcuni sono da ricercare, altrida fuggire. Poi, di certo, dal fatto che avverto assai diversicolori, suoni, odori, sapori, il calore, la durezza, e cosesimili, concludo negativamente che nei corpi da cui procedonoqueste differenti percezioni dei sensi esistono alcuni diversiaspetti che corrispondono ad esse anche se, forse, non simili aquelle; per il fatto poi che certune di queste percezioni mi
44
Ed. 1647 aggiunge: "oppure l'ordine e la disposizione".
94
risultano gradite ed altre sgradite, appare assolutamente certoche il mio corpo o, piuttosto, tutto me stesso, in quanto sonocomposto di corpo e di mente, può subire varie <azioni> favorevolio sfavorevoli dai corpi che l'attorniano.Vi sono però molte altre cose che non ho certamente appreso dallanatura, nonostante mi sembri che sia essa ad avermele insegnate,ma da una certa consuetudine di giudicare sconsideratamente ed èper questo che accade facilmente che siano false: per esempio cheogni spazio, ove non si dà assolutamente nulla che colpisca i mieisensi, sia vuoto, che in un corpo caldo vi sia qualcosa affattosimile all'idea del calore che è in me, che in un <corpo> bianco overde si trovi lo stesso bianco o lo stesso verde che sento, inuno amaro o dolce il medesimo sapore e così di (728) seguito; chegli astri, le torri e qualsivoglia altro corpo lontano abbiano lastessa dimensione e la stessa figura che mostrano ai miei sensi edaltre cose di tal fatta. Affinché però a questo proposito nonresti nulla che non concepisca abbastanza distintamente, debbodefinire con più cura quel che intendo propriamente quando dicoche la natura mi insegna qualcosa. Qui assumo infatti la naturasecondo un significato più angusto di quando <l'assumo> come ilcomplesso di tutto ciò che Dio mi ha concesso: in esso infattisono contenute molte cose che appartengono solo alla mente, comeche io percepisca che quel che è fatto non può esser non fatto, etutte le rimanenti cose che mi sono note grazie al lume naturale edi cui qui non si parla; molte cose anche che appartengono solo alcorpo, come che esso tenda verso il basso, e simili, di cui neppurtratto, ché <intendo farlo> per quelle sole che mi sono state dateda Dio, come ad un <essere che è> composto di mente e di corpo45.Questa natura mi insegna pertanto a rifuggire da quanto procurasenso di dolore e a ricercare quelle cose che apportano sensazionidi piacere ed altre di tal genere; oltre a questo non vedo peròche ci insegni come trarre da queste percezioni dei sensi, senzaprevia analisi dell'intelletto, conclusioni sulle cose che stannofuori di noi, giacché (729) conoscere la verità su di esse sembraappartenere solo alla mente e non al composto. Così, per quantouna stella non produca sul mio occhio più forte impressione di una
45 Ed. 1647 dice diversamente: "visto che questo ammucchiamento o questo insieme comprende molte cose che non appartengono che alla sola mente e di cui non intendo qua parlare, giacché tratto della natura, come ad esempio la nozione che ho di questa verità che ciò che una volta è stato fatto non può più non essere stato fatto e un infinità di altre simili che conosco grazie al lume naturale, senza l'aiuto del corpo; e che ne comprende anche parecchie altre che non appartengono che al solo corpo e non sono qui neppure comprese sotto il nome di natura: come la qualità che ha di essere pesante e parecchie altre simili su cui neppure mi soffermo, <giacché parlo> solo dellecose che Dio mi ha concesse in quanto sono composto di mente e di corpo".
95
tenue fiamma, in esso non si dà tuttavia propensione positiva oreale a credere che quella <stella> non abbia maggiori dimensioni,eppure è questo che senza ragione ho pensato fin dai miei primianni; per quanto poi avvicinandomi al fuoco avverta calore e, semi ci avvicino un po' troppo, anche dolore, non si dàassolutamente ragione alcuna che convinca che nel fuoco si troviqualcosa di simile a tale calore e neppure a quel dolore, masoltanto che in esso, qualunque cosa sia, v'è alcunché che producein noi tali sensazioni di calore o di dolore. Per quanto poi inuno spazio non vi sia nulla che muova i sensi, da ciò non segueche non vi sia in esso alcun corpo: mi accorgo però che in questie in moltissimi altri casi ho l'abitudine di pervertire l'ordinedella natura appunto perché utilizzo le percezioni dei sensi, chemi sono state propriamente date dalla natura soltanto per indicarealla mente quali cose siano di giovamento o di danno al compostodi cui essa è parte - fino a che sono abbastanza chiare e distinte- come sicure norme per discernere immediatamente quale sial'essenza dei corpi posti fuori di noi, su cui però esse non dannose non indizi assai oscuri e confusi.Già precedentemente ho sufficientemente indagato per qual ragioneaccada che, nonostante la bontà di Dio, i miei giudizi sianofalsi. A questo proposito si presenta una nuova difficoltà intornoa quelle cose che secondo l'insegnamento della natura dovreisfuggire o ricercare ed anche intorno a quel che riguarda lesensazioni interne nelle quali mi sembra aver colto errori: comequando qualcuno, ingannato dal gradito sapore di qualche (730)cibo, ingerisce il veleno che vi è stato nascosto46. E' vero peròche in tal caso la natura non lo spinge ad appetire che quel cheha sapore gradito e non il veleno che ignora assolutamente; da ciòsi può dunque solo concludere che questa natura non è onnisciente,il che non è stupefacente ché, essendo l'uomo una cosa limitata,non gli spetta altra <natura> se non di limitata perfezione.Non di rado ci inganniamo però anche a proposito di quelle cosecui siamo portati per natura, come i malati quando desideranobevande o cibi che poco dopo risulteranno loro nocivi. Qui sipotrà forse dire che quelli si ingannano perché la loro natura ècorrotta, ma ciò non sopprime la difficoltà, perché l'uomo malatonon è davvero meno creatura di Dio di quanto lo sia l'uomo sano e- conseguentemente - non sembra esser meno ripugnante che abbiaricevuto da Dio una natura fallace. Come un orologio composto di
46 Ed. 1647 dice diversamente: "come ad esempio il gusto gradevole di qualche vivanda nella quale abbiano mescolato veleno, può invitarmi ad ingerire tale veleno e così ingannarmi".
96
ruote e di contrappesi non osserva meno precisamente tutte leleggi di natura, quando è stato mal costruito e non indicacorrettamente l'ora, di quando risponde totalmente ai voti del suoartefice, così, se considero il corpo dell'uomo come una macchinacosì allestita e composta di ossa, di nervi, di muscoli, di vene,di sangue e di pelli che, anche se non vi esistesse mente alcuna,eseguirebbe nondimeno tutti quegli stessi movimenti che ora inesso non procedono da ordini della volontà e quindi neppure dallamente47, riconosco facilmente che <per tale corpo> sarebbeegualmente naturale, nel caso, per esempio, fosse malato diidropisia soffrire di quell'aridità di gola che di solito faavvertire (731) alla mente il senso della sete e lo porta anche adisporre i suoi nervi e le rimanenti parti in tale modo daingerire bevande e quindi aggravare la malattia, quanto gli ènaturale, allorché non è colpito da tale morbo, esser spinto dauna simile arsura della gola ad ingerire bevande a lui utili. Perquanto, se considero l'uso per il quale l'orologio è statoconcepito48, possa dire che, quando non indica esattamente le ore,deflette dalla sua natura e, allo stesso modo, se prendo inconsiderazione la macchina del corpo umano come predisposta49 aimoti che di solito si producono in essa, stimi che anche questa sidistacchi dalla propria natura, se la sua gola è secca quando berenon giova alla sua conservazione, riconosco tuttaviasufficientemente che quest'ultima accezione di natura differiscenotevolmente dall'altra: questa infatti non è che unadenominazione dipendente dal mio pensiero, che raffronta l'uomomalato e l'orologio mal fabbricato con l'idea dell'uomo sano edell'orologio perfettamente congegnato, ed estrinseca rispettoalle cose di cui si parla50; con l'altra intendo invece ciò chedavvero si trova nelle cose e che, conseguentemente, possiede unaqualche verità.Di certo, per quanto rispetto al corpo sofferente di idropisia siasoltanto una denominazione estrinseca dire che la sua natura ècorrotta perché ha la gola secca senza aver bisogno di bere,tuttavia, se si considera il composto, cioè la mente unita a talecorpo, non è mera denominazione, ma vero errore della natura ilfatto che abbia sete quando bere gli nuocerà; resta ora pertanto
47Ed. 1647 aggiunge: "ma soltanto dalla conformazione dei propri organi".48Ed. 1647 aggiunge: "dal suo artefice".49Ed. 1647 aggiunge: "da Dio".50Ed. 1647 dice diversamente: "e non indica niente che si ritrovi nelle cose di cui si parla".
97
(732) qui da esaminare come la bontà di Dio non impedisca che lanatura così intesa sia fallace.Innanzi tutto avverto qui che tra la mente e il corpo si dà unagrande differenza, in quanto il corpo per sua natura è sempredivisibile, mentre la mente è affatto indivisibile: infatti ècerto che quando considero quest'<ultima>, cioè me stesso comesoltanto cosa pensante, non posso distinguere parti in me, mentremi concepisco come una cosa del tutto unica ed integra; e sebbenetutta la mente sembri unita a tutto il corpo, tuttavia se unpiede, un braccio o qualsiasi altra parte del corpo vengonoamputati, non avverto per questo che qualcosa sia stato sottrattoalla mia mente e neppure le facoltà di volere, di sentire e diintendere possono dirsi parti di essa, giacché una ed identica èla mente che vuole, che sente, che intende51. Al contrario non v'ècosa corporea od estesa cui possa pensare, che con il pensiero nondivida facilmente in parti e, quindi, che non concepisca comedivisibile; se per altra via non lo sapessi ancora, questo solobasterebbe ad insegnarmi che la mente è del tutto diversa dalcorpo.Mi rendo poi conto che la mente non riceve immediatamente leimpressioni da tutte le parti del corpo, ma soltanto dal cervelloo forse soltanto da una sua piccolissima parte, cioè da quella incui si dice che risiede il senso comune; la quale, ogni qualvoltasi trova disposta nello stesso modo, mostra alla mente la stessacosa, anche se le altre parti del corpo nello stesso tempo possonoessere disposte in altri modi, come provato da innumerevoliesperienze che qui non v'è bisogno di riportare.
51Ed. 1647 dice diversamente: "perché la mente stessa si pone nella sua interezza a volere ed ugualmente nella sua interezza a sentire, a concepire ecc.".
98
21. Obiezioni di alcuni dotti uomini contro le precedenti Meditazioni 1647 OF I(AT VIII, 177-83; 227-31; 269-71; 355-56).
Il testo delle Méd. Mét. fu inviato tramite Mersenne a diversi illustrilettori che inviarono le loro obiezioni che con le risposte di C.accompagnarono l'edizione parigina dell'opera. Le prime obiezionifurono formulate dal teologo Johan de Kater (Caterus) difensore delpunto di vista scolastico; le seconde da Mersenne stesso, le terze daHobbes, le quarte di Arnauld, le quinte di Gassendi, le seste da alcuni"filosofi e geometri" e infine le settime dal gesuita Bourdin allievo epoi professore a La Flèche il collegio in cui C. era stato educato.Sulle Méd. Mét. e Obj. in generale si veda sub BEYSSADE 1994, MATHEWS1986 o NORMORE 1986.Cit. in: DE MAURO 1965, GILSON 1969, CAVAILLÉ 1991.(780) Terze obiezioni fatte da un celebre filosofo inglese TERZA OBIEZIONEDunque, che cos'è che si distingue dal mio pensiero? Che cos'è chesi possa dire separato da me stesso?Forse qualcuno risponderà a questa domanda: io stesso che penso sono distinto dal miopensiero; e sebbene non sia separato da me, il mio pensiero è però diverso da me, nellostesso modo in cui (come prima è stato detto) è distinta la danza dal danzante. Poiché seD C. dimostrerà che l'intelletto e colui che intende sono la medesima cosa, cadremo nellinguaggio degli Scolastici. L'intelletto intende, la vista vede, la volontà vuole e, per unaottima analogia, il passeggiare o, almeno, la facoltà di passeggiare, passeggerà. Le qualicose sono tutte oscure, improprie e assolutamente indegne dell'abituale perspicuità delSignor Des Cartes.
RISPOSTA
Non nego che io che penso sia distinto dal mio pensiero, come unacosa dal modo; ma quando chiedo che cos'è dunque che si distingue dal miopensiero, intendo ciò riguardo ai diversi modi di pensare làconsiderati e non riguardo alla mia sostanza; quando poi aggiungo:che c'è che si possa dire che sia separato da me stesso, intendo soltanto chetutti quei modi di pensare sono in me e non vedo che cosa didubbio o di oscuro qui si possa immaginare.
QUARTA OBIEZIONE
[...] C'è una grande differenza tra l'immaginare, cioè tra l'avere una qualche idea, econcepire con la mente, ovvero concludere ragionando che qualche cosa è o che qualchecosa esiste. Ma D. C. non ci ha spiegato in che differiscano [...] Ora, che diremmo noise per avventura il ragionamento non fosse null'altro che una congiunzione e una
99
concatenazione di nomi o di denominazioni per il (781) tramite di questa parola “è”? Daciò con la ragione non concludiamo assolutamente nulla sulla natura delle cose, ma sulle loro denominazioni [...].
RISPOSTA
Qui ho spiegato la differenza tra l'immaginazione e la concezionedella pura mente, come enumerando nell'esempio quali siano quellecose che immaginiamo nella cera e quali siano quelle checoncepiamo con la sola mente; ma anche in altre parti ho spiegatocome una sola e medesima cosa, ad esempio un pentagono, laintendiamo in un modo e la immaginiamo in un altro52. Nelragionamento però l'unione non è dei nomi, ma delle cosesignificate dai nomi; e mi meraviglio che a qualcuno possa venirein mente il contrario. Chi dubita infatti che un Francese e unTedesco possano ragionare in modo assolutamente identico sullestesse cose, pur concependo parole del tutto diverse? E questoFilosofo non si condanna forse da sé quando parla di convenzioniche abbiamo stabilito a nostro arbitrio sui significati delleparole? Infatti, se ammette che le parole significano qualcosa,perché non vuole che i nostri ragionamenti vertano su ciò chesignifica qualcosa, piuttosto che sulle sole parole? Certamentecon lo stesso diritto col quale conclude che la mente è movimento,potrebbe anche concludere che la terra è cielo o tutto quanto alui piacerà53.
52Il testo francese si diffonde sull'esempio del pentagono per stabilire la differenzatra immaginare e concepire (nota E. Lojacono).
53Il testo francese aggiunge un periodo per stabilire il rapporto tra il movimento e lamente (nota E. Lojacono).
100
QUINTA OBIEZIONEalla TERZA MEDITAZIONE: Su Dio
[...] Quando penso ad un uomo, mi raffiguro un'idea o un'immagine formata dallafigura e dal colore, di cui posso dubitare se sia o no una similitudine dell'uomo. Lo stessoquando penso al cielo. Quando penso ad una Chimera, mi raffiguro un'idea oun'immagine della quale posso dubitare se sia la similitudine di qualche animale che nonesiste, ma che potrebbe esistere, o che è o no (782) esistito in altri tempi. [...]Credendo che ci siano creature invisibili e immateriali; mentre di Dio, diamo il nome diAngelo ad una cosa creduta o supposta, sebbene tuttavia l'idea sotto la quale immaginoun Angelo sia composta di idee di cose visibili.Nello stesso modo per il venerabile nome di Dio non abbiamo alcuna immagine o idea;perché ci viene proibito di adorare Dio in una immagine, affinché non ci sembri diconcepire colui che è inconcepibile. [...]Ora, poiché da questa ipotesi, che abbiamol'idea di Dio nella nostra anima, D. C. procede alla prova di questo Teorema, che Dio (cioèil creatore sommamente potente e sapiente del mondo) esiste, sarebbe stato opportunoche egli avesse spiegato meglio quell'idea di Dio e, quindi, che ne avesse dedotto non solola sua esistenza, ma anche la creazione del mondo.
RISPOSTA
Col nome di idea egli vuole qui che s'intendano soltanto leimmagini delle cose materiali raffigurate nella fantasia corporea;ciò posto, gli è facile provare che non ci può essere alcuna ideapropria di un Angelo e di Dio. Io mostro però qua e là ovunque, maspecialmente in questo stesso passo, che assumo il nome di ideaper tutto ciò che è percepito immediatamente dalla mente, in modoche quando voglio e temo, in quanto percepisco insieme che voglioe temo, questa volizione e questo timore sono da me annoverati trale idee. Mi son servito di questo nome, perché era stato giàspesso usato dai Filosofi per significare le forme dellepercezioni della mente divina, anche se non riconosciamo in Dioalcuna fantasia; e non ne avevo alcuno più appropriato. [...l
SESTA OBIEZIONE
[...] Quando qualcuno vuole o teme, in verità ha l'immagine della cosa che teme edell'azione che vuole ma non è spiegato che cosa di più abbracci col pensiero chi vuole ochi teme. Sebbene invero il timore sia un pensiero, non vedo in qual modo possa esseraltro che il pensiero della cosa che si teme [...].
(783) RISPOSTA
101
È di per sé noto che altro è vedere un leone e nel contempotemerlo, altro è vederlo soltanto; e così altro è vedere un uomoche corre, altro è affermare che lo si vede, il che avviene senzaparola. E non riscontro qui nulla che richieda una risposta.
102
QUARTE OBIEZIONI
Si tratta delle obiezioni rivolte a C.da Antoine Arnauld, il passo faparte della risposta alle Quarte obiezioni sulla natura della mente umana.
(800) Né mi è contrario quanto ha aggiunto il Chiarissimo Uomo, chenon c'è da meravigliarsi se, mentre dal fatto che penso concludo che esisto, l'idea che inquesto modo formo mi rappresenta soltanto come una cosa che pensa, perché, nellostesso modo, quando esamino la natura del corpo, non trovo in essaproprio nulla che rimandi al pensiero. E per la distinzione tradue sostanze non si potrebbe avere alcun argomento più solido diquesto: a qualsiasi di esse guardiamo, non vi cogliamoassolutamente nulla che non sia diverso dall'altra.Non vedo neppure per quale ragione questo argomento provi troppo.Infatti non si può dire nulla meno di questo per dimostrare cheuna cosa si distingue realmente da un'altra: che può esserneseparata dalla potenza divina. E mi è sembrato di aver postoattenzione con sufficiente diligenza onde <evitare> che qualcuno,proprio per questo stimasse che l'uomo è soltanto un'anima che si serve delcorpo. Infatti nella stessa sesta Meditazione, nella quale hotrattato della distinzione della mente dal corpo, ho anche insiemeprovato che essa è essenzialmente unita a quello. [...]Né, infine, per il fatto che la facoltà di pensare è assopita nei fanciulli, eche neppure nei folli è spenta, ma solo turbata, si deve pensare che essasia così congiunta agli organi corporei da non poter esisteresenza di essi. Poiché dal fatto che sperimentiamo che tale<facoltà> è spesso impedita da questi <organi>, non segue innessun modo che sia prodotta da essi; il che non si può provareper mezzo di alcuna, sia pur minima, ragione. [...] Non rispondonulla alle cose che l'illustre Uomo ha aggiunto quisull'immortalità dell'anima, poiché non mi trovano contrario; ma,in quanto alle anime delle bestie, anche se non è questo il luogoper parlarne e, senza la trattazione di tutta la Fisica, non possodire molto di più intorno ad esse di quanto ho già spiegato nellaquinta parte della dissertazione sul Metodo, tuttavia, perché nontaccia del tutto, mi sembra principalmente doversi notare chenessun movimento può prodursi tanto nei corpi delle bestie (801)quanto nei nostri, se non sono totalmente presenti tutti gliorgani, o strumenti, per l'azione dei quali questi medesimimovimenti potrebbero esser prodotti anche in una macchina: cosìche neppure in noi stessi la mente muove immediatamente le membraesterne, ma dirige soltanto gli spiriti <animali>, che scorrononei muscoli dal cuore attraverso il cervello, e li determina acerti movimenti, poiché tali spiriti si adattano da sé con uguale
103
facilità a molte azioni diverse. Moltissimi movimenti cheavvengono in noi non dipendono però in alcun modo dalla mente: adesempio il battito del cuore, la digestione dei cibi, lanutrizione, la respirazione di chi dorme ed anche, in coloro chesono svegli, il camminare, il cantare e simili, quando avvengonosenza l'attenzione della mente. E quando coloro che cadonodall'alto mettono avanti le mani verso terra per difendersi latesta, non lo fanno certamente per alcun consiglio della ragione,ma soltanto perché la vista della imminente caduta arriva fino alcervello e fa passare gli spiriti animali nei nervi nel modonecessario a produrre questo movimento, anche senza lapartecipazione della mente e come in una macchina. E poichésperimentiamo in noi stessi, come una cosa certa, che è propriocosì, perché ci meravigliamo tanto se la luce riflessa dal corpo del lupo negliocchi della pecora ha la medesima forza per eccitare nella pecora ilmovimento della fuga?Ora, se vogliamo però far uso della ragione per riconoscere sealcuni movimenti delle bestie siano simili a quelli che sicompiono in noi per l'azione della mente o a quelli soltanto chenon dipendono che dall'influsso degli spiriti <animali> e dalladisposizione degli organi, si devono considerare le differenze chesi trovano tra essi, cioè quelle che ho spiegato nella quintaparte della Dissertazione sul Metodo, giacché non penso se netrovino altre; e allora apparirà facilmente che tutte le azionidelle bestie sono soltanto simili a quelle che, senza alcun aiutodella mente, avvengono in noi. Donde saremo costretti a concludereche non conosciamo proprio nessun principio del movimento nellebestie, all'infuori della sola disposizione degli organi e delcontinuo affluire degli spiriti <animali> prodotti dal calore delcuore che assottiglia il sangue. E nel contempo osserveremo chenulla ci ha offerto prima d'ora l'occasione per attribuirne loroaltro, ma soltanto che, non distinguendo quei due principi delmovimento, (802) vedendo che il primo, il quale dipende dai solispiriti <animali> e dagli organi, è tanto nelle bestie quanto innoi, abbiamo creduto sconsideratamente che anche l'altro, il qualesi trova nella mente o nel pensiero, fosse in esse. E certamente,quando ci siamo così persuasi di alcunché fin dalla giovinezza,anche se poi mediante argomenti è dimostrato falso, tuttavia non ècancellato facilmente dalla nostra opinione, a meno che nonprestiamo frequente e prolungata attenzione a questi argomenti.
104
QUINTE OBIEZIONI
Si tratta delle obiezioni rivolte a C.da Pierre Gassendi, inparticolare il testo qui riportato è rivolto contro la SecondaMeditazione.
(819) Vi domandavo poc'anzi un criterio col quale ci provaste di essere qualcosa didiverso, ma non credo che possiate portarne alcuno. Certamente addurreste operazionimolto più nobili di quelle che sono prodotte dalle bestie: ma come l'uomo, pur essendo ilpiù nobile degli animali, non si sottrae tuttavia dal numero degli animali così, anche sefoste riconosciuto come la più efficiente delle facoltà immaginative o delle Fantasie, non viescludereste pertanto dal loro numero. Poiché, che vi chiamiate particolarmente mente,questo nome può apparire di maggior dignità, ma non di diversa natura. Per provare chesiete di natura diversa (cioè, come pretendete, incorporea) dovreste eseguire una qualcheoperazione in modo diverso da come la eseguono le bestie, se non fuori dal cervello,almeno indipendentemente dal cervello: il che tuttavia non fate. Poiché, quando è turbatoil <cervello> è turbata anche <la vostra mente>, e così, quando esso è oppresso, èoppressa anche <la vostra mente>, e se le specie delle cose scompaiono dal cervello, nonne conservate traccia alcuna. Tutte le cose avvengono nelle bestie, voi dite,per impulso cieco degli spiriti <animali> e degli altri organi:nello stesso modo in cui si producono i movimenti nell'orologio oin un'altra macchina. Quantunque però ciò sia vero riguardo a tutte le altrefunzioni, come quella della nutrizione, del battito delle arterie, e simili, che si produconoanche nell'uomo allo stesso modo, si potrebbe forse affermare che le (820) azioni deisensi o quelle che si dicono le passioni dell'anima siano prodotte nelle bestie da unimpeto cieco, e non si producano in noi? [...]Le bestie dite voi; sono prive di ragione. <Si>, ma di una ragione umana enon di una loro; sì che non sembra si debbano dire aloga se non in confronto a noi o allanostra specie, benché d'altra parte il logos o la Ragione, sembra essere così generale dapoter esser loro attribuito come facoltà conoscitiva o senso interno. Dite che le<bestie> non ragionano. È vero, perché non ragionano in modo così perfetto e ditutte le cose come gli uomini, tuttavia ragionano e non sembra ci sia distinzione se nonsecondo il più e il meno. Dite che le bestie non parlano. Ma sebbene nonproducano Suoni umani cioè non sono uomini tuttavia producono loro propri suoni deiquali si servono come noi dei nostri.[...]
Dalla RISPOSTA
(839) Quando però aggiungete Che devo anche provare che le anime delle bestiesono incorporee e che il corpo grosso non contribuisce in nulla al pensiero, date provanon solo di non sapere a chi spetti provare, ma anche che cosa daciascuno debba esser provato; non stimo infatti né che le animedelle bestie siano incorporee, né che il corpo grossolano non
105
apporti nulla al pensiero, ma solo che una trattazione (840) diqueste cose non sia assolutamente da farsi in questo luogo.Voi trovate qui oscurità per il significato equivoco della parolaanima, ma l'ho chiarito a suo luogo con tanta cura, che miinfastidisce ripeterlo qui. Così dirò soltanto che i nomi sonostati per lo più imposti alle cose da persone ignoranti, e cheperciò non sempre in maniera abbastanza idonea corrispondono allecose; ma non è compito nostro cambiarli, dopo che sono statiaccolti dall'uso, soltanto possiamo correggere i loro significati,quando notiamo che non sono ben compresi dagli altri. Così, forseperché i primi uomini non distinsero in noi quel principio per ilquale ci nutriamo, cresciamo e senza pensarci compiamo tutte lealtre cose comuni a noi e alle bestie, da quello per il qualepensiamo, chiamarono con il solo nome di anima l'uno e l'altro;poi, avvertendo che il pensiero è distinto dalla nutrizione,dissero ciò che pensa mente e credettero che questa fosse la partepiù importante dell'anima. Io poi, avvertendo che il principio peril quale ci nutriamo si distingue in tutti i sensi da quello peril quale pensiamo, ho detto che il nome di anima è equivoco quandoviene assunto per l'uno e per l'altro principio; e che, affinchésia assunto particolarmente per l'atto primo o forma principaledell'uomo, si deve intendere soltanto del principio per il qualepensiamo; e più volte l'ho chiamato col nome di mente per evitarel'equivoco; considero infatti la mente non come una partedell'anima, ma come tutta l'anima che pensa.
106
22. I principi della filosofia 1647 OF II (AT VIII, I, LXVI, LXVII, 32-33; LXXIV,38; IV, CXCVII-CXCVIII, 320-21; CCIV-CCV, 327-28).
L'opera è stata scritta da C. per sostituire i vecchi manualiscolastici. La prima parte è dedicata ai principi generali dellaconoscenza, la seconda, la terza e la quarta parte sono dedicaterispettivamente ai principi delle cose materiali, al mondo visibile,alla terra. La prima edizione latina è del 1644, del 1647 la traduzionefrancese rivista da C.Sui Prin. Ph. si veda sub CANTELLI, LOJACONO 1996 A.
(96) LXVI Come le sensazioni, gli affetti e gli appetiti si conoscono chiaramente perquanto spesso giudichiamo male intorno ad essi.
Restano le sensazioni, gli affetti e gli appetiti, che pure sipossono certo percepire chiaramente, se ci guardiamo con cura dalgiudicare al loro riguardo alcunché di più di quanto precisamenteè contenuto nella nostra percezione e di cui siamo intimamentecoscienti. Ma è molto difficile osservare ciò, almeno riguardoalle sensazioni, poiché non c'è nessuno di noi che non abbiagiudicato fin dall'infanzia che tutto ciò che sentiva fosserocerte cose esistenti fuori della sua mente e del tutto simili allesue sensazioni, cioè alle percezioni che ne aveva, tanto chevedendo, per esempio, un colore, abbiamo stimato di vedere unacerta cosa posta fuori di noi e del tutto simile a quell'idea dicolore che in quel momento sperimentavamo in noi; e per laconsuetudine di (97) giudicare così ci pareva di veder ciò tantochiaramente e distintamente da considerarlo certo e indubitabile.
LXVII Nello stesso giudizio sul dolore noi spesso ci inganniamo.
Lo stesso accade esattamente con tutte le altre cose che sisentono, anche con il solletico e con il dolore. Per quantoinfatti queste cose non siano ritenute essere fuori di noi,tuttavia non si suole avvertirle come <esistenti> nella solamente, ovvero nella percezione nostra, ma nella mano o nel piede oin qualsiasi altra parte del nostro corpo. E non è davvero piùcerto, quando per esempio sentiamo il dolore come se fosse in unpiede, che esso sia qualcosa di esistente nel piede, fuori dellanostra mente, di quanto <sia certo>, quando vediamo la luce comese fosse nel Sole, che quella luce esista fuori di noi nel Sole;ma entrambe queste cose son pregiudizi della nostra prima età,come apparirà chiaro più avanti.
107
(101) LXXIV La quarta causa è che colleghiamo i nostri concetti a parole che nonrispondono esattamente alle cose.E infine, per l'uso del linguaggio, colleghiamo tutti i nostriconcetti a parole con le quali li esprimiamo, né li affidiamo allamemoria se non insieme con queste parole. E, ricordandoci poi piùfacilmente delle parole che delle cose, a stento talvolta abbiamoun concetto di qualche cosa tanto distinto da separarlo da ogniconcetto di parole; e i pensieri di quasi tutti gli uomini vertonopiù sulle parole che sulle cose, al punto che molto spesso essidanno l'assenso a parole non comprese, perché reputano di averlecapite una volta o di averle accolte da altri che le intendevanorettamente.
Cit. in: OLGIATI 1937, CAVAILLÉ 1991, BONICALZI 1996.
(381) CXCVII La mente è di tale natura che il solo movimento di un corpo puòprovocare in essa diverse sensazioni.
Si prova poi che la natura della nostra mente è tale che, solo peril fatto che nel corpo si producono certi movimenti, essa puòesser condotta ad ogni sorta di pensieri (che non riportano inalcun modo immagini di questi moti) e, specialmente, a queipensieri confusi che son detti sensi o sensazioni. Vediamo infatti(382) che le parole, sia pronunciate sia soltanto scritte,eccitano nelle nostre anime ogni sorta di pensieri ed emozioni.Sullo stesso foglio di carta, con la stessa penna ed il medesimoinchiostro, basta che la punta della penna sia condotta in uncerto modo sulla carta, perché vengano tracciate lettere cheprovocheranno nell'animo del lettore pensieri di battaglie, ditempeste, di furie e passioni di indignazione e di tristezza.Qualora invece la penna sia mossa in altro modo pressoché simile,essa farà sorgere pensieri affatto diversi, di tranquillità, dipace, di piacevolezza e passioni del tutto opposte <a quelleprecedenti>, di amore e di letizia. Si risponderà forse che lascrittura o la parola non eccitano immediatamente nell'animapassioni e immagini di cose diverse da se stesse, ma soltantodiverse <possibilità> di comprensione, in occasione delle qualil'anima stessa forma poi in sé le immagini delle varie cose54. Ma
54È questo un passo assai breve, ma di un certo rilievo, attinente alla concezionecartesiana del rapporto anima-corpo e ci stupisce che neppure Alquié abbia notato ladifferenza tra il testo latino, che - fra l'altro - utilizza l'espressione “occasione”,non ripresa - almeno alla lettera - dal testo francese corrispondente, che si presentain ben diversa forma e che pertanto riportiamo: “Qualcuno risponderà forse che la
108
che diremo della sensazione del dolore e del solletico? Una spadaè rivolta contro il nostro corpo e lo ferisce: solo da ciò segueun dolore, che non è certo meno diverso dal moto locale dellaspada o del corpo che è ferito, di quanto lo siano il colore o ilsuono o l'odore o il sapore. In quanto poi vediamo con chiarezzache la sensazione di dolore è provocata in noi dal solo fatto chealcune parti del nostro corpo sono localmente mosse dal contattocon qualche altro corpo, possiamo concludere che la nostra anima èdi tale natura che anche alcuni moti locali possono <portarla a>sentire le affezioni di tutti gli altri sensi.
Cit. in: MARION 1981, JOLY 1986, CAVAILLÉ 1991, CANTELLI 1992.
(383) CXCVIII Con i sensi percepiamo negli oggetti esterni soltanto figure, grandezzee movimenti;
Inoltre non percepiamo tra i nervi differenza alcuna da cui potergiudicare che dagli organi dei sensi esterni attraverso gli unipervenga al cervello qualcosa di diverso di quanto attraverso glialtri o che, assolutamente, vi pervenga altra cosa che non sia ilmoto locale degli stessi nervi. Vediamo poi che questo moto localenon solo produce la sensazione del solletico o del dolore ma anchedella luce e dei suoni. Infatti, se si colpisce qualcunonell'occhio, in modo che la vibrazione del colpo giunga sino allaretina, per ciò stesso egli vedrà parecchie scintille di lucelampeggiante, luce che non sussiste fuori del suo occhio. Ancora,se qualcuno ottura con un dito il proprio orecchio, udirà untremulo ronzio che sarà causato dal solo moto dell'aria racchiusain esso. Infine avvertiamo spesso che il calore od altre qualitàsensibili in quanto sono negli oggetti, e persino le forme dellecose meramente materiali, come ad esempio quella del fuoco, sonoprodotte dal moto locale di certi corpi ed esse stesse danno poiorigine ad altri moti locali in altri corpi. Comprendiamo ancheperfettamente in qual modo le varie dimensioni, figure e moti eparticelle di un corpo producano diversi moti locali in un altrocorpo, mentre non possiamo comprendere in alcun modo come lestesse cose (cioè le dimensioni, le figure ed i moti) possanoprodurre qualcosa d'altro, di natura totalmente differente da essiquali quelle forme sostanziali e qualità reali che moltisuppongono presenti nelle cose. Né <possiamo comprendere> poi come
scrittura e le parole rappresentano all'anima soltanto le figure delle lettere e i lorosuoni, per cui essa, che intende il significato di queste parole, eccita in sé leimmaginazioni e le passioni che vi si riferiscono” (nota E. Lojacono).
109
tali qualità o forme abbiano la forza di eccitare moti locali inaltri corpi. Stando così le cose, poiché sappiamo che la naturadella nostra anima è tale che i diversi moti locali bastanoprovocare in essa tutte le sensazioni e conosciamo per esperienzache tali diverse sensazioni sono effettivamente suscitate in essa,mentre non ci è mai dato percepire che qualcosa d'altro, a partetali moti, passi dagli organi dei sensi esterni al cervello, (384)occorre concludere senza riserve che neppure ci accorgiamo chequelle cose, che negli oggetti esterni indichiamo con i nomi diluce, colore, odore, sapore, suono, calore, freddo e di altrequalità tattili o persino di forme sostanziali, siano qualcosad'altro se non diverse disposizioni di tali oggetti, che fanno sìche possano muovere i nostri sensi in diversi modi.
(388) CCIV E' sufficiente che io abbia spiegato come le particelle impercettibilipossono essere, anche se forse esse non sono in tal modo.Per quanto forse in questo modo si intenda come tutte le cosenaturali siano potute accadere, tuttavia non per questo si deveconcludere che si siano realmente così costituite. Infatti, comeuno stesso artigiano può fabbricare due orologi che, sebbeneindichino ugualmente bene le ore e dall'esterno appaianoassolutamente simili, sono comunque costituiti all'interno da unsistema di ruote del tutto differente, cosi non vi è dubbio che ilsommo artefice delle cose abbia potuto costituire tutte quelle chevediamo in parecchi modi diversi. Che ciò sia effettivamente verolo ammetto ben volentieri e stimerò di aver compiuto unsufficiente lavoro, posto che le cose che ho scritto siano tali daaccordarsi accuratamente a tutti i fenomeni della natura. E ciòbasterà anche per le esigenze della vita, poiché la Medicina, laMeccanica e tutte le altre arti che possono compiersi per mezzodella Fisica hanno come loro fine solo quelle cose che sonopercettibili e che pertanto debbono essere comprese tra i fenomenidella natura55. E perché nessuno per caso si convinca che Aristoteleabbia compiuto o inteso compiere qualcosa di più ampio,<ricordiamo> che egli stesso testimonia espressamente nel primolibro delle sue Meteore, all'inizio del capitolo settimo, che, perquanto riguarda le cose che non sono manifeste ai sensi, stima di
55Più esplicito nella versione francese: “Crederò di aver fatto abbastanza se le causeche ho spiegato sono tali, che tutti gli effetti che esse possono produrre sono similia quelli che vediamo nel mondo, senza preoccuparmi se è per mezzo di esse o per mezzodi altre che essi sono prodotti” (trad. M. Garin) (nota E. Lojacono).
110
portare sufficienti ragioni e dimostrazioni, se solo mostra cheesse possono accadere in accordo con le spiegazioni che ne hadato.
Cit in: CHOMSKY 1966.
(389) CCV Tuttavia le cose che ho spiegato sembrano almeno moralmente certe.Tuttavia, affinché non si faccia qui alcun torto alla verità,occorre considerare che vi sono certe cose che sono stimatemoralmente certe, cioè quanto basta alle esigenze della vita,benché, in rapporto all'assoluta potenza di Dio, siano incerte.Come, per esempio, se qualcuno vuole leggere una lettera scrittasì in caratteri latini, ma non disposti secondo il giusto senso,e, congetturando che dovunque in essa v'è A debba leggersi B edove B debba leggersi C, e che così ogni lettera debba esseresostituita da quella immediatamente seguente, trova che in questomodo certe parole latine sono composte da esse, non dubiterà cheil vero senso di quella lettera sia contenuto in quelle parole,sebbene abbia raggiunto tale conoscenza solo per congettura epossa pure darsi che chi l'ha scritta non abbia posto in luogodelle vere lettere quelle immediatamente seguenti, ma alcunealtre, celando così in essa un altro significato: ciò infatti puòcosì difficilmente accadere da non sembrare credibile. Quelli peròche considereranno quante cose intorno al magnete, al fuoco e allafabbrica di tutto il Mondo sono state qui svolte da pochiprincipi, anche stimando che io li abbia assunti solo per caso esenza ragione, forse riconosceranno tuttavia che difficilmentesarebbe potuto accadere che tante cose fossero organicamenteconnesse, se fossero false.
111
23. Lettera CCCLXVII a Mesland 9 febbraio 1645 (AT IV, 161-72, 165-170).
La corrispondenza tra C. e il gesuita Mesland, uomo assai influenteche doveva favorire la diffusione della dottrina cartesiana neicollegi dell'ordine si svolse presumibilmente tra il 1644 e il 1646.Le lettere furono diffuse da Clerselier, editore della corrispondenzadi C., ma per la delicatezza dei temi trattati (la questione dellapresenza reale del corpo di Cristo nell'Eucarestia, oggetto dellecontroversie tra cattolici e protestanti) rimasero inedite e furonopubblicate solo nel 1811.
In quanto al modo in cui si può concepire che il corpo di GesùCristo è nel Santo Sacramento, credo che non sta a me spiegarlo,dopo aver appreso dal Concilio di Trento che è ea existendi ratione quamverbis exprimere vix possumus. Parole queste che ho citato appositamentealla fine della mia risposta alle Quarte Obiezioni, proprio peressere esentato dal doverne dire di più: aggiungi anche che, nonessendo Teologo di professione, avrei paura che le cose che potreiscrivere, fossero meno ben accette da me che da un altro.Tuttavia, dato che il Concilio non stabilisce che verbis exprimere nonpossumus , ma solamente che vix possumus; mi azzarderò qui, inconfidenza, a dirvi un modo che mi sembra assai comodo eutilissimo per evitare la calunnia degli eretici, che eccepisconoche noi crediamo a questo riguardo una cosa che è assolutamenteincomprensibile, e che implica contraddizione. Lo farò, se non vidispiace, a condizione che non me ne attribuirete la paternità nelcaso che la comunichiate ad altri; e anche che non la comunichiatea nessuno nel caso non la giudichiate conforme a quanto èstabilito dalla Chiesa. In primo luogo considero che cosa è ilcorpo di un uomo, e trovo che questa parola corpo è moltoequivoca; poiché quando parliamo di un corpo in generaleintendiamo una parte determinata della materia, e insieme dellaquantità di cui l'universo è composto, di modo che non potremmotogliere una porzione massima o minima di questa quantità, senzadover immediatamente constatare che il corpo è diminuito, e chenon è più intero; né cambiare alcuna particella di questa materia,senza pensare, di conseguenza, che il corpo non è più interamentelo stesso, o idem numero. Ma quando parliamo del corpo di un uomo,non intendiamo una parte determinata di materia, ma intendiamosolamente tutta la materia che è unita insieme con l'anima diquest'uomo; di modo che, benché questa materia cambi, e la suaquantità aumenti o diminuisca, crediamo sempre che si tratti dello
112
stesso corpo idem numero, fino a quando perdura l'unione sostanzialecon la stessa anima; e crediamo che questo corpo sia tutto intero,fino a quando ha in sé tutte le disposizioni necessarie perconservare questa unione. Infatti non c'è chi non creda che noiabbiamo gli stessi corpi che abbiamo avuto fin dalla nostrainfanzia, benché la loro quantità sia di molto accresciuta, e che,secondo l'opinione comune dei Medici, e senza dubbio secondo laverità, non ci sia più in loro nessuna parte di <quella> materiache vi si trovava allora, e anche che non abbiano più la stessafigura; di modo che essi non sono eadem numero, se non per il fattoche sono informati dalla stessa anima. Io, che ho esaminato lacircolazione del sangue e che credo che la nutrizione non avvengase non attraverso una continua espulsione di parti del nostrocorpo, che vengono scacciate dal loro posto da altre che vientrano, non penso che vi sia alcuna particella delle nostremembra, che resti per un solo istante la stessa numero, ancorché ilnostro corpo, in quanto corpo umano resti lo stesso numero, fintanto che è unito alla stessa anima. E anche in quel senso èindivisibile: infatti, se ad un uomo si amputa un braccio o unagamba, pensiamo certo che il suo corpo è diviso prendendo iltermine corpo nella prima accezione, ma nella seconda; e nonpensiamo che chi ha un braccio o una gamba amputati sia meno uomodi un altro. Infine, di qualunque materia si tratti, e diqualsivoglia quantità o figura essa possa essere, purché sia unitaalla stessa anima razionale, la consideriamo sempre come il corpodello stesso uomo, e per il corpo tutto intero, se non ha bisognodi essere accompagnata da altra materia per rimanere unita aquest'anima.Inoltre, io considero che, quando mangiamo del pane e beviamo delvino, dissolvendosi nel nostro stomaco, le particelle di questopane e di questo vino defluiscono in un attimo di là nelle nostrevene, e per il solo fatto che si mescolano col sangue, subisconouna transustanziazione naturale, e diventano parti del nostrocorpo; benché se avessimo la vista abbastanza acuta perdistinguerle dalle altre particelle del sangue vedremmo che sonoancora le stesse numero, che componevano prima il pane e il vino;di modo che, se non considerassimo l'unione che hanno con l'anima,potremmo chiamarle pane e vino come prima.Ora questa transustanziazione avviene senza miracolo: Ma,similmente, non vedo difficoltà a pensare che tutto il miracolodella transustanziazione che si compie nel Santo Sacramento,consista in ciò che in luogo del fatto che le particelle di quelpane e di quel vino avrebbero dovuto mescolarsi col sangue di Gesù
113
Cristo e disporvisi in certi modi particolari, affinché la suaanima le informasse naturalmente, essa le informa, senza <che> ciò<avvenga>, tramite la forza delle parole della Consacrazione; e inluogo del fatto che quest'anima di Gesù Cristo non potrebberimanere naturalmente unita con ciascuna di quelle particelle dipane e vino senza che esse fossero assemblate con parecchie altreche componessero gli organi del corpo umano necessari alla vita,essa resta unita in modo soprannaturale a ciascuna di esse,ancorché le si separi. In questo modo è facile comprendere come ilcorpo di Gesù Cristo non sia che una volta in tutta l'ostia quandonon è divisa, e nondimeno che è tutto intero in ciascuna delle sueparti, quando lo è (sott. divisa); perché tutta la materia, grandeo piccola che sia <la sua quantità>, che è informata <nel suo>insieme dalla stessa anima umana, è considerata come un corpoumano nella sua interezza.Questa spiegazione scandalizzerà senza dubbio in un primo momentocoloro che sono avvezzi a credere, che affinché il corpo di GesùCristo sia nell'eucarestia, bisogna che tutte le sue membra visiano con tutta la loro medesima quantità e figura, e la stessamateria numero di cui erano composte quando è asceso al Cielo. Masi sbarazzeranno agevolmente di queste difficoltà seconsidereranno che non c'è nulla di ciò che sia stabilito dallaChiesa; e che tutte le membra esterne, e la loro quantità emateria, non sono necessarie all'integrità del corpo umano, e nonsono in nulla utili e confacenti a questo sacramento, in cuil'anima di Gesù Cristo informa la materia dell'ostia, perché siaricevuta dagli uomini, e di unirsi a loro più strettamente; eparimenti ciò non diminuisce in nulla la venerazione di questosacramento. E infine si deve considerare che è impossibile, e chesembra manifestamente implicare contraddizione, che vi sianoquelle membra; giacché ciò che chiamiamo, per esempio, il braccioo la mano di un uomo, e ciò che ne ha l'aspetto esteriore, e lagrandezza e l'uso; di modo che, qualsiasi cosa si possa immaginarenell'ostia come il braccio o la mano di Gesù Cristo, è fareoltraggio a tutti i dizionari e cambiare interamente l'uso delleparole, il chiamarli braccio o mano, poiché non ne hal'estensione, né la configurazione, né l'uso. (...)E per la stessa ragione è impossibile attribuire al corpo di GesùCristo altra estensione o altra quantità che quella del pane:poiché queste parole estensione e quantità non sono stateinventate dagli uomini che per significare questa quantitàesteriore che si vede e si tocca. E quale che possa esserenell'ostia ciò che i Filosofi chiamano la quantità di un corpo,
114
che ha la dimensione che aveva Gesù Cristo allorché era nel mondocon la sua estensione interna, è senza dubbio tutt'altra cosa diciò che gli altri uomini hanno chiamato fin qui quantità oestensione.
115
24. Lettera CDXVIII a*** 1645 o 46 (AT IV, 348-50).
La lettera è indirizzata ad un corrispondente anonimo, forse Mesland oVatier, e ha per oggetto il rapporto tra pensiero e enti reali e inostri modi di designare idee ed oggetti.
Per ciò che concerne la distinzione tra essenza ed esistenza, nonmi ricordo dove ne avevo parlato; ma io distinguo tra modi propriamentedetti, e Attributi senza i quali le cose di cui sono attributi non possono essere; / ossia tra imodi delle cose stesse, e i modi di pensiero (Perdonatemi se qui cambio lingua,per cercare di esprimermi meglio). Così moto e figura sono detti in sensoproprio modi della sostanza corporea, poiché lo stesso corpo può esistere, ora con questafigura, ora con un'altra, ora in moto, ora in quiete, sebbene, al contrario, né questafigura, né questo movimento possano sussistere senza questo corpo. Così amore, odio,assenso, dubbio, ecc. sono modi veri nella mente; invece esistenza, durata, grandezza,numero e tutti gli universali, non mi sembra siano modi propriamente detti, così come inDio giustizia, misericordia, ecc. Ma sono detti Attributi in senso più ampio, ossia modi delpensiero, poiché comprendiamo certamente l'essenza di qualche cosa in modo diverso, sefacciamo astrazione dal fatto che esista, o non esista, o al contrario, se consideriamo lacosa stessa come esistente. Ma la cosa stessa senza la sua esistenza non può essere al difuori del nostro pensiero, e neppure la sua durata, o la sua grandezza ecc.. E così dicosenza dubbio la figura e gli altri modi simili, essere distinti propriamente in senso modaledalla sostanza di cui sono modi, ma vi è tra gli altri attributi una minore distinzione che,solo in senso lato usurpando il nome di modo, può esser chiamata Modale, così come l'hodefinita nella parte finale della mia risposta alle prime obiezioni, e se mai sarebbe megliodefinita come Formale. (...) Non mi sembra che ci sia altro in questa materia che generidifficoltà, se non il fatto che non distinguiamo abbastanza le cose che esistono fuori delnostro pensiero dalle idee delle cose, che esistono nel nostro pensiero. Così, quandopenso l'essenza del triangolo, e l'esistenza del medesimo triangolo, codesti due pensieri,in quanto sono pensieri, anche considerati obiettivamente differiscono in senso modale,assumendo il termine modo in senso rigoroso; ma così non è per il triangolo che esistefuori del pensiero, nel quale mi sembra chiaro, che l'essenza e l'esistenza non sono distintiin alcun modo; e lo stesso è per tutti gli universali; così, quando dico, Pietro è un uomo,senza dubbio l'idea che mi faccio di Pietro, differisce in senso modale da quella in cuipenso l'uomo, ma nello stesso Pietro l'essere uomo non è altro dall'essere Pietro ecc. Cosìdunque considero solo tre distinzioni: Reale, quale si trova tra due sostanze, Modale eFormale, ossia pensate dalla ragione; tre che tuttavia possono esser dette Reali, sevengono contrapposte alla distinzione della ragione Raziocinante, e in questo sensopotrebbe esser detto che l'essenza è distinta realmente dall'esistenza. Così pure, quandoper essenza intendiamo la cosa, in quanto è obiettivamente nell'intelletto, e per esistenza(intendiamo) tuttavia la cosa stessa, in quanto è fuori dell'intelletto, è chiaro che essa èdistinta realmente in due.
116
Così quasi tutte le controversie in Filosofia sorgono per il fattoche non ci si intende gli uni con gli altri.
117
25. Lettera CDXL al Marchese di Newcastle 23 novembre 1646 OF II(AT IV, 568-77, 573-76).
Il Marchese di Newcastle viaggiò a lungo in Europa e fu forse in casasua a Parigi che C., Gassendi e Hobbes si incontrarono sirappacificarono dopo le polemiche.Cit. in: DE MAURO 1965, LEFÈVRE 1965, RODIS LEWIS 1966, CHOUILLET 1972,PERCIVAL 1972, VAN DE PITTE 1975, DROIXHE 1978, BONICALZI 1987,CANTELLI 1992.
(451) Per quanto riguarda l'intelletto o il pensiero, cheMontaigne ed alcun altro attribuiscono alle bestie, non possocondividere la loro opinione. Non è che mi soffermi su quel che sidice, cioè che gli uomini esercitano un dominio assoluto su tuttigli altri animali, giacché ammetto che ve ne siano più forti dinoi e credo che possano essercene dotati di tale furbizia naturaleda poter ingannare gli uomini più astuti. Considero però che <lebestie> ci imitano o ci superano solo in quelle azioni che nonsono guidate dal nostro pensiero; accade spesso infatti checamminiamo o che ci nutriamo senza pensare affatto a quel chestiamo facendo, ed è a tal punto senza ricorrere alla nostraragione che respingiamo le cose che ci nuocciono e che cidifendiamo dai colpi che ci sono inferti che, anche sedeterminatamente non volessimo mettere le mani a difesa del nostrocapo quando stiamo cadendo, non potremmo evitarlo. Credo altresìche mangeremmo come le bestie senza averlo appreso, se non fossimodotati della facoltà di pensare; si dice anche che quelli checamminano dormendo attraversino talvolta fiumi a nuoto, doveannegherebbero se lo facessero da svegli. Per quanto riguarda imoti delle nostre passioni, (452) benché in noi siano uniti alpensiero, in quanto possediamo la possibilità di pensare, ètuttavia ben evidente che non ne dipendono - si producono infattispesso nostro malgrado - e, conseguentemente, che possono prodursinelle bestie, e perfino con maggior violenza di quanto non sidiano negli uomini, senza che se ne possa concludere che siandotate di pensiero.
Infine, nessuna nostra azione esteriore può render certo chila esamini che il nostro corpo non sia solamente una macchina chesi muove autonomamente, ma possieda in sé anche un'anima che nutrepensieri, eccetto le parole o altri segni inventati in rapporto adoggetti che si presentano, senza riferimento ad alcuna passione.Dico parole o altri segni, giacché i muti si servono dei segninello stesso modo in cui noi ci serviamo della voce e che questi
118
segni siano a proposito, per escludere la parola dei pappagallisenza escludere quella dei folli, che non manca di essereappropriata agli oggetti che si presentano, anche se non segue laragione; aggiungo che queste parole o segni non debbono dipendereda passione alcuna ed escludo così non solo i gridi di gioia o ditristezza e simili, ma anche tutto ciò che con artifizio puòessere insegnato alle bestie. Se si insegna infatti ad una gazza adire buongiorno alla sua padrona, quando la vede apparire, è soloperché la prolazione di questa parola è stata collegata conl'impulso di qualche passione, cioè ad un moto della speranza dimangiare, se la si è abituata a ricevere qualche ghiottoneria ogniqualvolta l'abbia pronunciata: in tal modo tutte le cose che sifanno fare ai cani, ai cavalli, alle scimmie, non sono che impulsidovuti al loro timore o alla loro speranza o alla loro gioia,sicché le possono fare senza alcun pensiero. Ora mi sembra davverocosa notevole che la parola, così definita, non convenga cheall'uomo. Infatti, benché Montaigne e Charron abbiano detto chev'è maggior differenza tra uomo e uomo che tra l'uomo e la bestia,non si è comunque mai data bestia tanto perfetta che abbia usatoqualche segno per fare intendere ad altri animali cose che nonavessero rapporto con le sue passioni, mentre non v'è uomo cosìimperfetto che non ne faccia uso, tanto che i sordomuti inventanosegni particolari con cui esprimere i loro pensieri. Ciò mi apparecome un validissimo argomento per provare che ciò che fa sì che lebestie non parlino come noi è che non posssiedono (453) alcunafacoltà di pensare e non la mancanza di organi <appropriati>. Nési può dire che parlino tra loro e che noi non le intendiamogiacché come i cani ed alcuni altri animali ci esprimono le loropassioni, così ci esprimerebbero anche i loro pensieri, se neavessero.
So bene che le bestie fanno parecchie cose meglio di noi, manon me ne stupisco, ché ciò serve solo a provare che agiscono pernatura e grazie a congegni, al pari di un orologio che dice l'orapiù precisamente di quanto il nostro giudizio ce la indichi. Senzadubbio anche le rondini, quando giungono a primavera, agisconocome un orologio; quel che fanno le api è della stessa natura, el'ordine che seguono le gru nel volo, nonché quello che osservanole scimmie quando si battono - posto che ne seguano uno - e,infine, l'istinto di seppellire i loro morti, non è più strano diquel che fanno i cani ed i gatti, quando grattano il terreno persotterrarvi i loro escrementi, benché poi non li sotterrino quasimai: il che mostra che lo fanno solo per istinto, senza pensarvi.Si può soltanto dire che, per quanto le bestie non compiano
119
nessuna azione che ci assicuri che pensano, tuttavia, per il fattoche gli organi dei loro corpi non sono molto diversi dai nostri,si può congetturare che vi sia qualche pensiero collegato con taliorgani, come avvertiamo in noi, benché il loro sia di gran lungameno perfetto. A ciò non ho risposta, se non che, se maipensassero come noi, avrebbero un'anima immortale come noi, il chenon è verosimile, giacché non vi è ragione di crederlo per alcunianimali e non per tutti gli altri, e se ne danno molti troppoimperfetti per poter accordare loro <l'immortalità>, come leostriche, le spugne ecc. Temo però di importunarvi con questidiscorsi, quando tutto il desiderio che ho è di assicurarvi chesono, ecc.
120
26. Lettera CDLXVIII a Chanut 1 febbraio 1647 OF II (AT IV, 600-17,603-604).
La lettera di Chanut a C. del 1 dicembre 1646 è la CDLXII (AT IV, 581-3).Cit. in: MARION 1981, JOLY 1986, CAVAILLÉ 1991, CANTELLI 1992.
(468) E non c'è da meravigliarsi che certi movimenti del cuoresiano così naturalmente connessi a certi pensieri con cui nonhanno somiglianza alcuna; la nostra anima infatti, essendo dinatura tale da poter essere congiunta al corpo, ha anche questaproprietà, che ogni suo pensiero può talmente associarsi conqualche movimento o con altre disposizioni di questo corpo che,quando le stesse disposizioni si trovano un'altra volta in lui,l'anima è indotta da esse ai medesimi pensieri: e, reciprocamentequando lo stesso pensiero ritorna, prepara il corpo a ricevere lastessa disposizione. Così, quando s'impara una lingua, siassociano le lettere o la pronuncia di certe parole, che sono cosemateriali, con i loro significati, che sono pensieri; di modo che,udendo di nuovo, in seguito, le stesse parole, si concepiscono lestesse cose; e quando si concepiscono le stesse cose ci sirammenta delle stesse parole.
121
27. Colloquio con Burman aprile 1648 OF II (Lettera DXIV AT V, 146-79,150-51; 162-63).
Si tratta della trascrizione in latino di una vera e propria"intervista" fatta a C. dallo studente ventenne François Burman, figliodi un ministro protestante. Oltre all'edizione critica pubblicata da C.Adam col titolo di Entretien avec Burman, Paris 19752 esiste l'edizioneannotata di J. M. Beyssade, Paris, PUF, 1981.Su Entr. Bur. in generale si veda sub BEYSSADE 1981.Cit. in: BEYSSADE 1981, CAVAILLÉ 1991, TANIGAWA 1995.
(539) [0] Anche se non si imprimono tracce nel cervello e non sidà quindi memoria corporea, c'è tuttavia una memoriaintellettuale, come senza dubbio nel caso degli angeli e delleanime separate, ed è per quella che la mente ricorderebbe i suoipensieri.[R] Non nego la memoria intellettuale, infatti essa ci è data.Quando, per esempio, ascoltando che la parola R-E-X significa ilsupremo potere, mando ciò a memoria e poi ripeto mnemonicamentequel significato, è certo che questo avviene grazie alla memoriaintellettuale, non essendovi tra quelle tre lettere e il lorosignificato alcuna affinità da cui trarlo, tuttavia, attraverso lamemoria intellettuale, ricordo che quelle lettere denotano talcosa. Questa memoria intellettuale è però piuttosto relativa agliuniversali che alle cose singole: per essa non possiamo quindiricordare tutti i nostri fatti particolari.
(555) se esiste un corpo cui la mia mente sia in tal modo congiunta da volgersi quasi aconsiderarlo quando e come vuole (VII, p. 73).
[0] Che significa considerarlo? Forse intendere? Se è così, perchéporre tale distinzione? Se non è così, allora la mente è più diuna cosa intelligente o pensante, e così prima di avere un corpoessa possiede la capacità di considerare il corpo; o <talecapacità> è il risultato nella mente della sua unione con ilcorpo?[R] E una speciale forma di pensare che si attua in questo modo:quando gli oggetti esterni agiscono sui miei sensi e vi (556)dipingono pertanto la loro idea o, piuttosto, la loro immagineallora si dice che la mente sente, allorché si volge a quelleimmagini che sono così raffigurate sulla ghiandola. Quando peròquelle immagini non sono dipinte sulla ghiandola dalle stesse coseesterne, ma è la mente che, in assenza di cose esterne,
122
rappresenta e le forma nel cervello, allora si tratta diimmaginazione. Così la differenza tra immaginazione e senso consistesolo in questo, che nel <senso> le immagini sono dipinte daglioggetti esterni, mentre essi sono presenti, <nell'immaginazione> invecesono raffigurate dalla mente, senza oggetti esterni, come afinestre chiuse. Da ciò risulta ora chiaramente come mai possoimmaginare un triangolo, un <pentagono> e figure simili, ma nonchiliagono, ecc. La mente infatti, potendo facilmente tracciarelinee nel cervello e formarne una figura, può allora facilmenteconsiderarle ed immaginare così il triangolo, il pentagono efigure simili. Dal fatto invece che in ugual modo non può, se nonconfusamente, condurre e dar forma nel cervello a mille piccolelinee, segue che non si immagina distintamente un chiliagono, masolo confusamente; e tutto procede in modo tale che moltodifficilmente possiamo immaginare anche un ettagono o un ottagono.L'autore, uomo dotato di immaginazione e che per poco tempo haesercitato il suo ingegno in questo campo, può immaginarliabbastanza distintamente, gli altri invece non possono <farlo>altrettanto bene. Da ciò risulta pure chiaramente il motivo percui possiamo vedere quelle piccole linee come se fossero presentie come sia necessaria una singolare tensione dell'animo perimmaginare e conoscere il corpo in tal modo. Ciò infatti appareevidente da quanto detto.
123
28. Le passioni dell'anima 1649 OF II (AT XI, I, XLIV 361-2; L 368-369).
L'opera riprende il progetto di una esposizione completa della suafilosofia che C. non aveva portato a termine nei Principia Philosophiae. Iltesto accompagna, inoltre, la riflessione sul tema dell'unionedell'anima col corpo che C. svolge negli anni della redazionedell'opera soprattutto nella discussione epistolare con Elisabetta,principessa palatina. C. vi distingue le strutture e le funzioni delcorpo dai pensieri, ossia le funzioni dell'anima, distinte in azioni epassioni. Sul testo in generale si veda BONICALZI 1990 C.Cit. in: MARION 1981, BONICALZI 1987, CAVAILLÉ 1991, CANTELLI 1992.
(619) ARTICOLO XLIVOgni volizione è naturalmente congiunta a qualche movimento della ghiandola; mamediante arte o per abitudine la si può congiungere ad altri. (...) (620) E quando, parlando, non pensiamo ad altro che alsenso di quello vogliamo dire, ciò fa che muoviamo la lingua e lelabbra molto più prontamente e molto meglio che se pensassimo dimuoverle in tutte le maniere richieste per proferire le stesseparole, in quanto l'abitudine che abbiamo acquisito imparando aparlare ha fatto sì che abbiamo congiunto l'azione dell'anima che,mediante la ghiandola, può muovere la lingua e le labbra, con ilsuono delle parole che seguono questi movimenti, piuttosto che coni movimenti stessi.
(624) ARTICOLO L
Non esiste un anima così debole che non possa, se ben guidata, acquistare un potereassoluto sulle sue passioni.
Qui è utile sapere che, come s'è già detto prima, sebbene ognimovimento della ghiandola sembri esser stato congiunto dalla naturaa ognuno dei nostri pensieri dall'inizio della nostra vita, si puòtuttavia congiungerli ad altri per mezzo dell'abitudine, comel'esperienza fa vedere nel caso delle parole, che eccitano nellaghiandola movimenti i quali, secondo l'ordine della natura, nonrappresentano all'anima che il suono di esse, quando sonopronunciate dalla voce, o la figura delle loro lettere, quando sonoscritte, e che, nondimeno, per l'abitudine che si è acquisitapensando a quel che esse significano, quando si è udito il lorosuono oppure si sono viste le loro lettere, fanno di solitoconcepire quel significato, piuttosto che la figura delle lorolettere o il suono delle loro sillabe. E' utile ancora sapere che,
124
sebbene i movimenti, tanto della ghiandola quanto degli spiriti edel cervello, che rappresentano all'anima alcuni oggetti, sianonaturalmente congiunti con quelli che eccitano in essa certepassioni, possono esserne separati per mezzo dell'abitudine econgiunti ad altri diversissimi; e anche che questa abitudine puòessere acquisita con una sola azione e non richiede affatto unlungo uso.
125
29a. Lettera DXXXI di More a C.11 dicembre 1648 (AT V, 235-50, 243-45, trad. nostra).29b. Lettera DXXXVII a Henry More 5 febbraio 1649 OF II, 717-18 (ATV, 267-79, 278-79).29c. Lettera DXLIV di More a C.5 marzo 1649 (AT V, 298-317, 311, trad.nostra).
Cit. in: DE MAURO 1965, LEFÈVRE 1965, RODIS LEWIS 1966, MIEL 1969,CHOUILLET 1972, PERCIVAL 1972, VAN DE PITTE 1975, DROIXHE 1978, JOLY1986, BONICALZI 1987, CANTELLI 1992, SÉRIS 1995.
La differenza tra uomini e animali rispetto al linguaggio è solo unodei punti trattati nella discussione tra i C.e il filosofo neoplatonicodi Cambridge Henry More.
a) Quanto al resto, il mio animo, da nessuna delle tue opinionidissente di più, per la sua infondatezza e inconsistenza, quantoda quella terribile e micidiale affermazione fatta nel Metodo,secondo la quale togli, o per meglio dire, strappi, a tutti ibruti la vita e la sensibilità. Infatti nemmeno concedi che essiabbiano in qualche modo la vita. A tal proposito non tanto diffidodella brillante acutezza del tuo ingegno, quanto piuttosto latemo, come farebbe chiunque abbia a cuore il destino deglianimali, e considero il tuo acume non solo sottile, ma ancheaffilato e crudele come una spada, perché, con un colpo solo, haosato privare della vita e spogliare della sensibilità tutti glianimali, trasformandoli in statue ed automi.
Ma consideriamo, ti prego, che cosa ci sia nei fatti che tispinga a pronunciarti così severamente contro gli animali. Nonpossono servirsi del linguaggio, e difendere la propria causapresso un giudice, e, cosa questa che aggrava il crimine, benchésiano sufficientemente forniti di organi per il linguaggio, come èchiaro dalle gazze e dai pappagalli, e perciò sono da condannarealla perdita della vita e del senso.
Ma in verità tuttavia come potrebbero le gazze e i pappagalliimitare i nostri suoni, se non avessero percepiti e inteso conl'udito ciò che diciamo? Ma non comprendono, dici, cosasignificano quei suoni che proferiscono per imitazione. Perché mainon dovrebbero comprendere sufficientemente ciò che vogliono, cioèil cibo, che con questo artificio, ricevono dai padroni? Hannocoscienza insomma di chiedere il cibo, poiché con tali suoni moltevolte ottengono la soddisfazione del loro desiderio. E quale scopoavrebbe, mi chiedo quella attenzione e quell'ascolto attento degli
126
uccelli canori, se non vi è in essi alcuna sensibilità eintenzionalità? Da dove deriverebbero l'astuzia e la sagacia dellevolpi e dei cani? Come potrebbero le parole minacciose placare lebelve feroci? Perché il cane affamato, che ha sottrattofurtivamente qualcosa, quasi consapevole della sua colpa sisottrae di soppiatto al castigo, e avanzando guardingo ediffidente, senza manifestare la propria gioia a nessuno che sitrovi sulla sua via, ma col muso ostile e chino in avanti continuaper la sua strada cauto e sospettoso, per non espiare la colpacommessa? Come possono accadere tali cose, senza unaconsapevolezza interiore di ciò che ha fatto? Questo gran numerodi storielle, con le quali molti tentano di dimostrare che laragione si trova (anche) negli animali, dimostra almeno, che essipossiedono sensibilità e memoria. Sarebbe troppo lungo narrare quitali storielle. Molte delle quali, lo so bene, sono del genere dicui non si può ignorare la forza di persuasione e la sottigliezzadimostrativa.
Ma vedo chiaramente cosa ti ha condotto a considerare glianimali come macchine: il modo con cui dimostri anche cosìl'immortalità delle nostre anime, cosa che, dal momento che sisuppone che il corpo non possa in alcun modo pensare, porta aconcludere che, dovunque ci sia pensiero, è necessaria la presenzadi una sostanza realmente distinta dal corpo, e per di piùimmortale. Da ciò consegue che se i bruti pensassero, avrebberoanch'essi una sostanza immortale.
Orbene, ti prego, uomo perspicacissimo, poiché da questadimostrazione consegue di necessità, che agli animali o sia toltoil senso o sia conferita l'immortalità, perché preferisciconsiderarli macchine inanimate, piuttosto che corpi resi attivida anime immortali?
127
Così risponde C:
b) OF II (717) Tuttavia, secondo me, il principale motivo che puòconvincerci che le bestie sono prive di ragione sta nel fatto che,sebbene tra quelle di una medesima specie - come accade anche tragli uomini - alcune siano più perfette di altre, come ad esempio(718) vediamo nei cavalli e nei cani, tra i quali alcuniapprendono assai meglio degli altri quel che si insegna loro, eper quanto tutte le bestie, ci facciano conoscere moltochiaramente con la voce o con altri movimenti del corpo i loroimpulsi naturali, come il timore, la fame e simili, non si èancora mai osservato che una bestia sia giunta a tal grado diperfezione da utilizzare un vero linguaggio, cioè da indicare conla voce o con segni qualche cosa che potesse riferirsi al solopensiero e non all'istinto naturale. La parola infatti è l'unicosegno certo del pensiero nascosto nel corpo e di essa si servonotutti gli uomini, anche i più stupidi e i più insensati, persinoquelli che son privi della lingua e dell'organo della voce, ma nonle bestie: essa dunque può essere assunta come la vera differenzatra gli uomini e i bruti. Per essere breve, ometto qui tutti glialtri argomenti che sottraggono il pensiero alle bestie. Vorreituttavia notare che parlo di pensiero, non di vita o di capacitàdi sentire; a nessuno infatti nego la vita che pongo nel solocalore del cuore, né gli nego la capacità di sentire in quantoquesta dipende dagli organi corpo. Così questa mia opinione nontanto è crudele verso le bestie quanto pia verso gli uomini chenon siano seguaci superstizioni dei Pitagorici, giacché li assolvedal sospetto di commettere un delitto ogni volta che si nutrono diun animale o lo uccidono.
More ritorna sul tema nel marzo 1649:
c) (311) Forse che i cani non annuiscono con la coda come noi conil capo? Forse che più spesso non mendicano il cibo dalla tavolacon piccoli guaiti? Anzi talvolta, con il rispetto di cui sonocapaci, toccano il padrone con la zampa, per ricordargli, conquesto segno garbato, la loro presenza, quasi egli si fossedimenticato di loro.
128
30. La ricerca della verità mediante il lume naturale il quale, nella sua purezza,senza valersi dell'aiuto della Religione né di quello della Filosofia, determina leopinioni che un onest'uomo deve avere in riferimento a tutto ciò che può esseroggetto del suo pensiero e penetra nei segreti delle scienze più curiose. OF, I (AT X,502-3).
La datazione di questo dialogo è molto discussa; si veda su questoLojacono OF I 316-18.
(323) EUDOSSO. Pensate piuttosto, Poliandro, che proprio voi netrarrete vantaggio perché non avete pregiudizi e mi sarà molto piùagevole portare dalla parte buona una persona neutrale che nonEpistemone, che si troverà spesso impegnato nel partito opposto.Per farvi però capire più chiaramente di che qualità sarà ladottrina che vi prometto, desidero che notiate la differenza chec'è tra le scienze e le semplici conoscenze che si acquistanosenza moto della ragione, come le lingue, la storia, la geografiae, in generale, tutto quello che dipende dalla sola esperienza.Sono infatti completamente d'accordo che la vita di un uomo nonbasterebbe per acquistare l'esperienza di tutte le cose che sonoal mondo; ma sono anche persuaso che sarebbe follia desiderarlo eche un onest'uomo non è obbligato a sapere il greco o il latinopiù della lingua svizzera o del basso bretone, né la storiadell'Impero più di quella del più piccolo Stato d'Europa, ma chedeve soltanto curarsi di impiegare il suo tempo in cose oneste eutili, e di caricare la sua memoria solo delle cose piùnecessarie. Delle scienze, che non sono altro che i giudizi certi,che fondiamo su qualche conoscenza precedente, alcune si ricavanoda cose comuni (324) e di cui tutti hanno sentito parlare altre daesperienze rare e rigorose. Confesso pure che sarebbe impossibileparlare in particolare di tutte queste ultime, giacché prima ditutto avremmo dovuto condurre ricerche su tutte le erbe e sullepietre che vengono dalle Indie, aver visto la Fenice e, in breve,non ignorare nulla di tutto ciò che vi è di più strano in natura.Crederò, tuttavia, di aver sufficientemente soddisfatto alla miapromessa se, mostrandovi le verità che si possono trarre dallecose comuni e conosciute da chiunque, vi renderò capaci di trovareda voi stessi tutte le altre, quando vi piacerà prendervi la penadi cercarle.
129
3. Bibliografia
3. 1. Premessa
Riportiamo in ordine cronologico le pubblicazioni dedicate altema della lingua e del segno in C. dal 1960 al 1998, conqualche accenno alle opere precedenti.Abbiamo utilizzato le bibliografie cartesiane disponibilicioè:Sebba, Gregor (1964), Bibliographia cartesiana. A critical Guide to Descartes' Literature 1880-1960,The Hague, M. Nijoff ;Kippe D. - Curley, E. M. - Harding, J. (1973), "Bibliography of Descartes'Literature", in: Caton, H., The Origin of Subjectivity, New Haven-London, 223-43;Gabbey, A.- Marion, Jean-Luc et alii (1983), "Descartes", chap. XIV in: A CriticalBibliography of French Literature, vol. III A, The Seventeenth Century Supplement, H. G. Halled., Syracuse University Press, 377-419;Chappel, Vera - Doney, Willis (1987), Twenty-five Years of Descartes' Scholarship, 1960-1984,New York, Garland;gli aggiornamenti annuali del Bulletin cartésien, pubblicato a partire dal 1971dall'équipe Descartes e dal C. N. R. S. negli Archives de philosophie; dal 1979indispensabile punto di riferimento, la rivista Studia Cartesiana, Amsterdam,Quadratures.
Abbiamo controllato dal 1960 i repertori bibliograficispecializzati:Bibliographie de la philosophie, Paris, Vrin;Bibliografia filosofica italiana, Milano, Marzorati;Répertoire bibliographique de la philosophie, Louvain, Peeters;The Philosopher's Index, Dodrecht, D. Reidel; Philosophical Books, Oxford, B. Blackwell;Bibliographie linguistique, Dodrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publisher;Linguistics and Language Behaviour Abstract, San Diego;MLA International Bibliography of books and Articles on the Modern Languages and Literatures, ed.Modern Language Association, New York, New York University Press.
In pubblicazioni italiane recenti si trovano ampie e accuratesezioni bibliografiche:Garin, Eugenio (1984), Vita e opere di Cartesio, Laterza; Roma-Bari, 207-33;Crapulli, Giovanni (1988), Introduzione a Descartes, 245-87, Roma-Bari;Spallanzani, Mariafranca (1990), Immagini di Descartes nell'Enciclopedia, Bologna, IlMulino, 205-22;René Descartes, Opere filosofiche curata da Ettore Lojacono (2 voll., Torino, UTET,1994).Per il 1996 c'è una accurata rassegna in:
130
Belgioioso, Giulia (1998), "L'année Descartes 1996. Un bilan historiographique",Nouvelles de la Republique des lettres, II, revu et augmenté, Napoli, Prismi.
Ci sono due dizionari cartesiani: Morris, John M. (1971),Descartes' Dictionary, New York, Philosophical Library e Cottingham,John (1993), A Descartes'Dictionary, Oxford, Blackwell.I testi di C citati nelle voci della bibliografia sono preceduti dalla sigla TC e sonoindividuati dalle abbreviazioni elencate nella nota ai testi.
131
Couturat, Louis - Leau, Léopold (1903), Histoire de la langueuniverselle, Paris, Hachette, 11-14. Il progettocartesiano di lingua filosofica si basa su trepresupposti: l'analogia di tutte le idee con lanozione di numero, la ricerca di idee semplici capacidi combinarsi tra loro, l'analogia di questecombinazioni, e quindi di ogni ragionamento colcalcolo. Le idee di C. sono state sviluppate dai suoisuccessori e da Leibniz stesso ma è a C. che dobbiamol'idea "d'une grammaire régulière et logique"applicabile a-posteriori alle radici delle linguestorico-naturali.
Croce, Benedetto (1905), La Critica, 428-33. Cita C. comeconvinto assertore di una lingua universale,aspirazione che, per Croce, nasce da un'errataconcezione del linguaggio come strumento convenzionaledi espressione del pensiero.
Gouhier, Henri (1926), La vocation de Malebranche, Paris, Vrin. InMon. (T 9) C. usa la metafora del linguaggio perrisolvere il problema del rapporto tra le due sostanze,esso viene ripreso dagli altri cartesiani a partire daCordemoy.
Sahlin, Gunvor (1928), César Chesneau du Marsais et son rôle dansl'évolution de la Grammaire générale, Paris. Le fonti dellaGrammaire e della Logique di Port Royal vengonoindividuate in una corrente razionalistica precedente aC..
Harnois, Guy (1929), Les théories du langage en France de 1660 a 1821,Paris, Les Belles Lettres. Sottolinea gli interessi deiportorealisti per i problemi concreti dell'insegnamentodelle lingue ma anche la loro dipendenza dall'ideacartesiana che pensiero e linguaggio esprimanol'unicità della ragione. E gli elementi delrazionalismo finiscono per essere dominanti anche inquelli che H. chiama "grammariens empiristes" comeCondillac.
Migliorini, Bruno (1929), "Una lettera di Cartesio e ilproblema della lingua internazionale", La cultura, n. 8,627-30. TC: L. Mers. 20 11 1629 T 5.
132
Brunot, Ferdinand (1930) (2ème éd.1966-72), Histoire de la languefrançaise des origines à nos jours, 13 t. Paris, Colin. C. e icartesiani non hanno dato acun contributo alla nascitadella terminologia scientifica (VI, I, 25).
Mouy, Paul (1934), Le développement de la physique cartésienne. 1646-1712,Paris, Vrin. Cordemoy utilizza le premesse"occasionaliste" cartesiane per applicarle allaquestione del linguaggio descrivendo le cose neitermini che saranno poi derisi da Molière. Gadrois nelTraité des passions paragona l'unione dell'anima e del corpoa quella che esiste per istituzione tra pensiero elinguaggio.
Olgiati, Francesco (1937), La filosofia di Descartes, Milano, Vita ePensiero. "Tutto ciò che C. ha scritto intorno allinguaggio non è se non un riflesso e un'applicazionedella sua metafisica" (551). C., dopo un'inizialeconsiderazione del linguaggio come costituito dasimboli, passa ad una diversa concezione secondo laquale il linguaggio per essere accettatofilosoficamente deve connettere cose e non nomi. TC:Princ.Phi. AT IX §59, § 74 T 22 - Med. Mét. II T 20 -Dis. Méth. V T 11.
Ryle, Gilbert (1949), The Concept of Mind, London, Hutchensons'University Library. Ed. it. di F. Rossi-Landi, Lo spiritocome comportamento, Torino, Einaudi, 1955. E' daimputarsi a C. "l'errore categoriale" del rappresentaremetaforicamente e del considerare come sostanzialmentediversi i fenomeni fisici e quelli mentali. E' il"dogma dello Spettro nella Macchina" che crea l'ideadell'accesso privilegiato ai contenuti della propriamente.
Vartanian, Aram (1953), Diderot and Descartes, Princeton, PrincetonUniversity Press; trad. it. Diderot e Descartes, Milano,Feltrinelli, 1956. L'importanza della teoriadell'animale-automa va valutata nel quadro dellosviluppo del materialismo dalla fisica di C., mentre laquestione del linguaggio degli animali si iscriverebbenel quadro della metafisica cartesiana e della difesadell'irriducibilità della res cogitans alla res extensa (188-217).
133
Wittgenstein, Ludwig (1953), Philosophische Untersuchungen, Oxford,Basil Blackwell. Trad. it. a c. di R. Piovesan e M.Trinchero, Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi. I §§ 244-45in cui W. nega la possibilità di un "linguaggioprivato" costituiscono una critica del cartesianesimo.
Lefèvre, Roger (1958), Le criticisme de Descartes, Paris. Accosta lateoria del segno in C. e Saussure (157).
Alquié, Ferdinand (1960), "Coscience et signes dans laphilosophie moderne et le cartésianisme", Polarité dusymbole, Etudes carmélitaines, 39, Bruges, 221-26.
Rossi, Paolo (1960), "La memoria artificiale come sezionedella logica in Cartesio", Rivista critica di storia della filosofia,XV, n.1, 44-9 e 55-62, poi in Clavis universalis (19601), ein G. Gori (1977) a c. di, Cartesio, Milano, ISEDI, 17-36.
Rossi, Paolo (1960 1a, 1983 rist. con mod.), Clavis universalis: Artidella memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Milano-Napoli, Riccardi, poi Bologna, Il Mulino. C. è undistruttore dell'aristotelismo linguistico (174). Tuttala tradizione lulliana porta all'idea dell'arborscientiarum, Bacone e C.sono accomunati dal rifiuto dellamnemotecnica che era ormai persa in giochi estenuanti ein simbologie magico-ermetiche.
Hintikka, Jaakko (1962), "'Cogito ergo sum': Inference orPerformance?", The Philosophical Review, LXXI, n. 1, genn.,3-32, poi riv. in Meta-Meditations: Studies in Descartes, A.Sesonske and N. Fleming edd., Belmont California,Wadworth Publishing Company, Inc., 1965, 50-76. Trad.it. "Cogito, ergo sum: Inferenza o operazione?", in G.Gori (1977), Cartesio, Milano, ISEDI, 143-77. Il celebreenunciato cartesiano privilegia cogitare tra tutti iverbi che esprimono i molteplici modi della naturapensante, perchè l'indubitabilità degli enunciati diquella forma può essere espressa solo da un verbo diintellezione.
Apel, Karl Otto (1963), Die Idee der Sprache in der Tradition DesHumanismus von Dante bis Vico, Bonn, H. Bouvier u. Co.Verlag. Trad. it. a c. L. Tosti e F. Castellani, L'idea dilingua nella tradizione dell'umanesimo da Dante a Vico, Bologna, IlMulino, 1975. Le riflessioni di C. sul linguaggio sono
134
collocate in una linea che afferma la precedenza delpensiero rispetto al linguaggio. Linea che parte daOckham e giunge fino a Locke ed è contrapposta a quellache approda a Vico e a Leibniz. In questa ottica ilpensiero è in rapporto diretto con le cose che intuisce,mentre il linguaggio è solo un contesto di nomi, e nonuna forma della realtà.
Gunderson, Keith (1964), "Descartes, La Mettrie, Language andMachines", Philosophy, 39, n. 149, 193-222.
Rodis Lewis, Geneviève (1964), "Le domaine propre de l'hommechez les cartésiens", Journal of History of Philosophy, 2, 157-88.
De Mauro, Tullio (1965 1a, 1989 3a), Introduzione alla semantica,Bari, Laterza. Lo scarso spazio che C. dedicherebbe allinguaggio è spiegato col fatto che le formelinguistiche hanno una parte secondarianell'organizzazione della vita mentale e cognitiva. TC:L. Mer. 20 11 e 18 12 1629 TT 5, 6 - L. Mer. 4 3 1630 T8 - Mon. T 9 - Dis.Méth. T 11 - III Obj. T 21 - Princ.Phi. AT IX, I § 10, § 74 T 22 - L. M. New. 23 11 1646 T25 - L. H. M. 5 2 1649 T 29.
Lefèvre, Roger (1965), La pensée de Descartes, Paris, Bordas, (119-23). Parola e industriosità sono associati da C., comefacoltà e strumento di progresso. La parola è unelemento materiale segno di un senso spesso confuso edequivoco. Quando la parola si meccanizza diventa vuotalogomachia retorica e perde ogni contatto col pensiero.TC: Olym. AT X, 217 - L a*** sur Balzac 1628 T 3- L.Mer. 20 11 1629 T 5 - L. Mer. 15 5 1630 AT I - Dis.Méth. I AT VI, 7 - L. Mer 8 10 1639 AT III - L. Mer. 71641T 18 AT III - II, V, VII Obj. AT IX T 21,- Princ.Phi. I § 74 T 22 - L. M. New. 23 11 1646 T 25 - L. H.M. 5 2 1649 T 29.
Chomsky, Noam (1966), Cartesian Linguistics, A Chapter in the History ofRationalist Thought, Harper and Row, New York. Trad. it. ac. di A. De Palma, Linguistica cartesiana, in: Id., Saggilinguistici, vol. III, Torino: Boringhieri, 1969.Illimitatezza dell'ambito, indipendenza da stimoli,pertinenza nel contesto: questi i caratteri del normaleuso creativo del linguaggio ritrovati in C. e che
135
portano allo sviluppo di tematiche presenti fino adHumboldt ed Herder. Struttura superficiale e strutturaprofonda è l'altro concetto "cartesiano", sviluppatopoi da Port Royal e ritenuto basilare per i successivisviluppi delle scienze del linguaggio. Il problema didistinguere l'uomo dalle macchine e dagli altri animaliposto con forza da C, secondo Chomsky non è risolto eneppure affrontato adeguatamente dai suoi contemporaneie dai successori. TC: Dis. Méth. VI T 11 - Princ. Phi.IV § 204 T 22 - Regulae XII T 2 - L. M. New. 23 11 1646T 25- L. H. M. 5 2 1649 T 29.
Foucault, Michel (Paul) (1966), Les mots et les choses. Trad. it. ac. E. Panaitescu, Le parole e le cose Milano, Rizzoli, 1967.Nel XVII secolo si rovescia il rapporto tra segnonaturale e segno convenzionale, solo quest'ultimo èsegno in senso pieno. Con C. inizia l'epoca in cui "illinguaggio si ritira di tra gli esseri per entrarenella sua età di trasparenza e di neutralità" (71 ed.it.). Il razionalismo classico non è definibile solo apartire dal meccanicismo e dalla matematizzazione dellanatura quanto piuttosto dal rapporto tra ordine emathesis che si estende a campi nuovi. TC: Regulae III,VI, VII, XIV T 2.
Rodis-Lewis, Geneviève (1966), "Langage humain et signesnaturels dans le cartésianisme", in: Actes du XIIIe Congrèsdes Sociétés de Philosophie de Langue française, Genève, Le langage,132-6 (pubblicata poi quale X capitolo di L'anthropologiecartésienne, 1990). Il problema del linguaggio in C. sicolloca alla confluenza di due temi: l'uomo sidistingue dall'animale grazie alla capacità di usaresegni convenzionali che manifestano l'universalitàdella ragione; d'altra parte il legame tra parole ecose è arbitrario come quello tra l'anima e il corpo otra la sensazione e l'azione della luce ecc. C'è in C.un duplice modo di intendere il rapporto tra segno esignificato. E' assolutamente arbitrario nel Mon. (T9), quando C. riflette sul progetto di una linguauniversale e rifiuta l'esistenza di una linguaadamitica (L. Mer 18 12 1629 T 6), e si inverte,secondo R. L. nella VI Méd. Mét. e Obj. (T 20, T 21)
136
quando C. si chiede perché i corpi in sè non siano taliquali appaiono ai nostri sensi. Altri: Ame AT XI § 138- L. M. New. 23 11 1646 T 25 - L. H. M. 5 2 1649 T 29 -Diot T 12 - H. AT XI, 160.
Donzé, Roland (1967, 1971 2a rev.), La grammaire générale etraisonnée de Port Royal, Berne, Francke. Ricorda l'opinionedi C. sull'imperfezione delle lingue naturali e ladisputa con Hobbes.
Mounin, George (1967), Histoire de la linguistique des origines au XXèmesiècle, Paris, PUF, trad. it. Milano, 1968. Estende a C.la ricerca dei precursori dell' arbitrarietà del segno,pur mettendo in guardia dall'illusione ottica diretrodatare certi concetti.
Robins, Robert Henry (1967 1a, 1979 2a, 1990 3a), A Short Historyof Linguistics, London, Longman. Trad. it. Storia dellalinguistica, Bologna, Il Mulino, 1971 1a, 1981 2a, 19923a. C. avrebbe indotto Mersenne ad interessarsi alproblema della lingua universale, offrendo, incontrapposizione ad Aristotele, la base filosofica sucui lavorarono i portorealisti.
Rosiello, Luigi (1967), Linguistica illuminista, Bologna, Il Mulino.La tradizione empirista sul linguaggio è più ricca einteressante di quella razionalistica (contro Chomsky).Il problema della lingua universale è squisitamenterazionalistico e C. rifiuta il progetto sottopostoglida Mersenne non solo per ragioni di semplice buonsenso,ma perché il progetto gli appare fondato su un metodoinduttivo che lo renderebbe assai simile alle linguenaturali. Port Royal assume il razionalismo cartesianocome base di una educazione nuova e non di una teoriaautonoma del linguaggio che non è possibile fondare suipresupposti cartesiani. Anche quella di Cordemoy è unametafisica del linguaggio e non una teoria linguistica.TC: L. Mer. 20 11 1629 T 5 - Dis. Méth. V T 11.
AA. VV, (1967-68) "Les problèmes du langage dans lecartésianisme", Bulletin de la Société française de philosophie, 91,1-38.
Rossi, Paolo (1968), "Linguisti d'oggi e filosofi delSeicento", Lingua e stile, 3, 1, 1-20. Poi in Aspetti dellarivoluzione scientifica, Napoli, Morano, 1971. Isolare le
137
concezioni linguistiche dal generale contestofilosofico e scientifico di un'epoca in cui nonesistevano le scienze del linguaggio è fuorviante.Polemico in particolare con De Mauro (1965).
Verburg, Pieter Adrianus (1968), "Ennoësis of language in XVIIcentury philosophy", Lingua, 21, 558-62. C. è inseritonella tradizione del razionalismo scientistacontrapposto ad una corrente di studi più attenti allarealtà fattuale del linguaggio.
Zimmer, Karl E., (1968), "Review of Cartesian Linguistics",International Journal of American Linguistics, 34, 290-300. Purapprezzando Chomsky (1966), Z. non ritiene che vi sianoreali elementi di novità nelle sporadiche riflessionidi C. sul linguaggio.
Crapulli, Giovanni-Giancotti Boscherini, Emilia (1969), Ricerchelessicali su opere di Descartes e di Spinoza, Roma, Edizionidell'Ateneo.
Gilson, Etienne, (1969), Linguistique et philosophie, Paris, Vrin.Chomsky (1966) sbaglia perché il dualismo cartesianocostituisce un arretramento rispetto alle posizionilinguistiche espresse da Aristotele specie nellaPolitica. Il dualismo mette in crisi la possibilitàstessa del linguaggio, per questo è necessaria unalingua universale che sia un alfabeto di nozionisemplici, simile più ad una notazione algebrica che aduna lingua. C. lascerebbe in eredità all'uomo macchinala possibilità di parlare "sans que son âme y soit pourrien". TC: III Obj. T 21.
Lakoff, Robin (1969), "Review of Herbert H. Brekle ed. (1966),Grammaire générale et raisonnée", Language, 45, 343-64. poicome La grammaire générale et raisonnée ou la Grammaire de PortRoyal, in: History of Linguistic Thought and contemporary Linguistics,H. Parret ed., Berlin- New York, De Gruyther, 1976,348-73. Le ricerche condotte a Port Royal sono piùlegate alle teorie di Sanctius che a C..
Miel, Jan (1969), "Pascal, Port Royal and CartesianLinguistics", Journal of History of Ideas, 30, 261-71. Rip. in:Language and the History of Thought, N. Struever ed.,Rochester, University of Rochester Press, 1995. Chomskytrascura che in Port Royal quanto appare cartesiano è
138
piuttosto agostiniano. Inoltre il mentalismo cheChomsky crede di fondare su C. è proprio quella ideameccanica della mente che C. attribuisce agli animali.TC: Dis. Méth. V T 11 - L. H. M. 5 2 1649 T 29.
Salmon, Vivian, (1969), "Review of Noam Chomsky CartesianLinguistics", Journal of Linguistics, 5, n. 1, 165-187. Sioppone a Chomsky.
Simone, Raffaele (1969), Introduzione, in: Grammatica e Logica diPort Royal, trad. it. a c. di R. Simone, Roma, UbaldiniAstrolabio. C. offre ai portorealisti lo sfondo di unaidentica struttura logica presente in tutti gli uominisu cui collocare le categorie dell'aristotelismolinguistico e un senso "agostiniano" (filtratoattraverso Pascal) dell'opposizione tra linguaggiointeriore profondo e linguaggio esteriore superficiale.
Aarsleff, Hans (1970), "The History of Linguistic andProfessor Chomsky", Language, 46, 570-85. Quello cheChomsky ha considerato come frutto delle teoriecartesiane è in realtà l'apporto fondamentale eoriginale dell'empirismo.
Bracken, Harry M. (1970), "Chomsky's Variations on a Theme byDescartes", Journal of the History of Philosophy, VIII, n. 2,181-2, poi in Mind and Language (1984). Recensione aChomsky (1966), parla di Cordemoy, Lamy, La Forge epochissimo di C..
Coseriu, Eugenio, (1970 1a, 1975 2a überarb. von G. Narr) DieGeschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zum Gegewart. EineÜbersicht Teil. I Von der Antike bis Leibniz, Tübingen. L'influssodi C. è in qualche modo presente alle origini dellasemiologia.
Robinet, André (1970), "Descartes à l'ordinateur", Etudesphilosophiques, n. 2, 219-33.
Uitti, Karl D. (1970), "Descartes and Port Royal in twoDiverse Retrospects", Romance Philology, 23, 75-83.Recensione a Chomsky (1966).
Aarsleff, Hans (1971), "Cartesian Linguistic: History orFantasy", Language Sciences, 1-12.
Verhar, J. W. M. (1971), Discussione di Chomsky (1966),Language Sciences, 14.
139
Bracken, Harry M. (1972), Discussione di Chomsky (1966) inrisp. a Verhar (1971), Language Sciences, 22.
Chouillet, Jacques (1915-1990) (1972),"Descartes et leproblème des origines des langues au XVIIIème siècle",Dix-huitième siècle, IV, 39-60. Chomsky ha parlatoimpropriamente di linguistica cartesiana poiché le ideedi cui parla sono espresse in un arco di tempo che vada Port Royal a Humboldt. "Cartesiano" è ciò che èdetto espressamente da C. medesimo e si pone ilproblema della sopravvivenza del cartesianesimolinguistico nel XVII secolo a partire 1) dal linguaggiocome unico segno distintivo tra uomo e animali omacchine, 2) dalla compatibilità del cartesianesimo conil tema delle origini. TC: Dis. Méth. V T 11 perdimostrare il punto 1 che è assolutamente specifico diC. L. H. M. 5 2 1649 T 29, L. M. New. 23 11 1646 T 25mostrano che C. utilizza il linguaggio comeattestazione sperimentale dell'esistenza degli altriesseri pensanti. Inoltre il Dis. Méth. II, I (AT VI) ele Notae (AT VIII), Méd. Mét. I (AT IX) e Regulae XIII(T 2) indicano che benché la parola e il pensiero sianoradicalmente differenti esiste tra loro una equivalenzaper istituzione che approda ad una equivalenza reale.Il linguaggio in cui la parola è puramente razionale etanto appropriata alle idee da poterle sostituire comenel discorso matematico o in quello metafisico (RegulaeXIV T 2, Méd. Mét. I AT IX, Princ. Phi. I § 51 AT IX)condurrebbe a poter derivare una grammatica dallalogica ma C.non compie questo passo anche se dalleRegulae sono deducibili alcuni principi che possonovalere tanto per l'una quanto per l'altra.
Dostert, L. (1972), "Descartes on Language", in: Studies inLinguistics in Honour of George L. Trager, M. E. Smith ed., TheHague, 44-9.
France, Peter (1972), Rhetoric and Thruth in France. Descartes to Diderot,Oxford Clarendon Press. Il modello tipicamenteargomentativo dell'opera di C. fa supporre una profondasapienza retorica. C., come poi di D'Alembert, sidomanda se il linguaggio ostacoli o aiuti lacomunicazione delle idee.
140
Henze, Donald F. (1972), "Descartes on the other minds",American Philosophical Quarterly, 6, 41-56. Discutendo leposizioni di Hintikka (1962) spiega il cogito alla lucedella filosofia del linguaggio contemporanea.
Joly, André (1972), "Cartésianisme et linguistiquecartésienne: mythe ou réalité", Beiträge zur RomanischePhilologie, 11, 86-94.
Percival, W. Keith, (1972), On the Non-existence of Cartesian Linguistics,in: Cartesian Studies, R. J. Butler ed., Oxford, BasilBlackwell, 137-145. Critica radicale di Chomsky (1966).C. ritiene che ci siano solo due tipi di sostanze e checiò che distingue gli esseri umani dalle altre sostanzeviventi è il pensiero che attesta la presenza diun'anima immortale e la cui presenza è rivelata propriodal linguaggio: argomento circolare. C. torna sullecaratteristiche del linguaggio affermando (Dis. Méth. VT 11) che: 1) le parole rivelano il pensiero, 2) veraloquela è altro rispetto ai cris naturels, 3) le parole usatenel discorso rivelano direttamente il pensiero, 4) leemissioni sono pertinenti. Questa quarta caratteristicaporta fuori dalla circolarità, si sarebbe tentati diidentificare questa caratteristica con la connessionelogica ed è una interpretazione coerente con altripassi del Dis. Méth. Inoltre nella L. M. New (T 25) C.chiarisce che la frase di risposta è appropriata perchécontiene più del semplice significato letterale diquella espressione. C'è dunque in C. il terzo criterioindividuato da Chomsky ma il concetto che Chomsky hadella mente è diverso da quello di C.. Le somiglianzetra l'appropriatezza nell'emissione e la creativitàindefinita sono solo superficiali, il discorsocartesiano ha il suo centro più che nel linguaggio, neltema degli animali-macchine e C. si limita a ripetereun luogo comune di Aristotele (Politica I, 2). Per P.,contrariamente a molti grandi filosofi dell'epoca, C."era relativamente poco interessato al linguaggio"(144). TC: L. H. M. 5 2 1649 T 29 - Dis. Méth. V T 11 -L. M. New. 23 11 1646 T 25.
Ricken, Ulrich (1972), "Zur erkenntnistheoretishen Wertung derSinne in der französischen Sprachdiscussion bis Locke",
141
in: Beiträge zur französischen Aufklärung und Spanischen LiteraturFestgabe für Werner Krauss zum 70 Geburstag, W. Bahner ed.,Berlin, 337-61.
Vendler, Zeno (1972), Res Cogitans: An Essay in Rational Psychology,Ithaca and London, Cornell University Press. V. ritieneche C. abbia una concezione essenzialmenteproposizionale del pensiero e perciò neghi illinguaggio agli animali.
Gusdorf, Georges (1973), L'avènement des sciences humaines au siècle desLumières, Paris, Payot. Una critica a Chomsky (1966).
Marion, Jean Luc (1973) "A' propos d'une sémantique de laméthode", Revue internationale de philosophie, 27, 103, 11-37.
Mortureux, M. F. (1973), "A' propos du vocabulairescientifique dans la deuxième moitiée du XVIIèmesiècle", Langage, 72-80.
Rey, Alain (1973-76), Théories du signe et du sens, 2 voll., Paris,Klinksieck.
Rosnerova, H. (1973), "Cogito on the Light of the Philosophyof Language", Studia Philosophia Christiana, 9, 123-51.
Voss, J. (1973), "Noam Chomsky et la linguistiquecartésienne", Revue philosophique de Louvain, 71, n. 11, 512-38. E' una storia del termine cartesiano in riferimentoall'uso chomskiano.
AA. VV. (1973), The History and Philosophy of Knowledge of Brain and itsFunctions, An Anglo-American Symposium, London July-15th/17th-1957, Amsterdam, B. M. Israël. Tra lequestioni di neurofisiologia trattate c'è anchel'origine del linguaggio e tra gli autori trattatianche C..
Borgmann, Albert (1974), The Philosophy of Language, Den Haag,Martinus Nijhoff. Sostiene la tesi che alcuni concetticentrali per la odierna filosofia del linguaggio sononati in epoca moderna e tra gli altri si occupa anchedi C..
Land, Stephen K. (1974), "The Cartesian Language Test andProfessor Chomsky", Linguistics, 122, 11-24.
Meisel, Jürgen M. (1974), "On the Possibility of Non-CartesianLinguistics", Linguistics, 122, 25-38.
Romanowski, Sylvie (1974), L'illusion chez Descartes. La structure dudiscours cartésien, Paris, Klincksieck. Dall'adozione
142
iniziale di una considerazione simbolica del linguaggiodi tipo tardo-rinascimentale, C. passa a una ricerca diun linguaggio matematico di pura denotazione che lospinge alla diffidenza verso il linguaggio naturale everso la poesia. Le opere sono analizzate secondo unalinea evolutiva che culmina nelle Méd. Mét. in cui sipassa dalla "méfiance du langage" alla "confiance versle discours" considerato autentico modo dicomunicazione e di fondazione di una filosofia fondatasull'argomentare. Il discorso, infatti, non è illinguaggio puro e semplice ma un'organizzazione invista di un ricettore. Interessante l'analogia tranatura e linguaggio che R. istituisce sulla base delleCog. Priv. e soprattutto del Mon. utilizzando lenozioni saussuriane di signifiant e signifié (69-70). TC:Cog. Priv. AT X - Mon. T 9.
Adams, R. M. (1975), "Where do our Ideas come from?- Descartesvs Locke" and a brief overview of Cartesian Linguistics byNoam Chomsky, in: Innate Ideas, S. P. Stich ed., Berkeley,University of California Press.
Dascal, Marcelo (1975), "Sign e pensamento segundo Leibniz,Hobbes, Locke e Descartes", Rivista Discurso, 6, 133-50.
Porset, Charles (1975), "Grammatista Philosophans. Lessciences du langage de Port Royal aux Idéologues (1660-1818). Bibliographie, in: J. Kristeva et alii, Latraversée des signes, Paris, Editions du Seuil, 11-96.
Yarvin, Herb (1975-77), "Language and cogito", Journal of CriticalAnalysis, 6, 109-18.
Van De Pitte, Frederick P. (1975), "Descartes on analogy andother minds, International Studies in Philosophy, VII, 89-110,rep. in: René Descartes critical Assessments, (1991) G. J. D.Moyal ed., 4 vols, Routldge, London, New York, vol.III, 343-62. La maggior parte dei commentatori haindicato nell'analogia il metodo con cui C. proverebbel'esistenza delle altre menti, in realtà egli nonavrebbe potuto farlo senza violare la sua stessadottrina epistemologica. Non avrebbe potuto applicarel'analogia che concerne cose solo parzialmenteconosciute alle altre menti, come la discussione tra icartesiani ha dimostrato è il linguaggio il fatto
143
centrale che permette una ricostruzione argomentativadelle altre menti. TC: Regulae T 2 - Méd. Mét. II T 20- L. M.New. 23 11 1646 T 25 - L. H. M. 5 2 1649 T 29.
Bakalar, H. Nicholas (1976), "The cartesian legacy toeighteenth century grammarians", modern Language Notes, 91/ 4 may, 698-721. Nel XVIII secolo l'eredità cartesianaera ancora viva negli studi sul linguaggio e nellafedeltà al razionalismo ed al metodo geometrico anchese era declinata l'influenza di C. in fisica e inmetafisica. Port Royal consegna la grande eredità diC. a Condillac e agli altri autori che riflettono sullinguaggio.
Di Caro, Alessandro (1976), "Nota su linguistica e filosofia.A proposito di Gilson, 'Linguistique et philosophie'(1969)", Studi urbinati, 1-2, 301-9. C. viene collocato inuna linea meccanicistica e algebrizzante di studio dellinguaggio che giunge fino a Condillac. Ilconvenzionalismo, l'eterogeneità tra parola e pensierosono le linee portanti della riflessione cartesiana sullinguaggio, ma è attraverso lo studio analitico dellinguaggio che passa per C. la possibilita di accderealle leggi del pensiero (lingua universale). C. dunqueantenato della linguistica ma anche della scissionenegativa tra semiotica e semantica.
Marion, Jean-Luc (1976), Sur l'ontologie grise de Descartes, Paris,Vrin. Mette in risalto l'uso della nozione di codicebenchè il termine non sia presente nell'accezionelinguistico-comunicativa.
Picardi, Eva (1976), "Note sulla logica di Port Royal", Lingua estile, XI, 347-91.Pierssens, Michel (1976), La tour de Babil. La fiction du signe, Paris,Minuit.Pochtar, Ricardo (1976), "El Examen de Ingenios y la
'linguistique cartésienne'", Revista latinoamericana defilosofia, 1976 (2), 179-85.
Villanueva, E. (1976), "A cerca de la tesis filosofica delpensamento en relacion con la tesis del linguaje deRenato Descartes", Dian, 22, 17-26.
144
Joly, André (1977), La linguistique cartésienne: un erreur mémorable, in:La grammaire générale des modistes aux idéologues, A. Joly - J.Stéfanini edd., Lille, Université de Lille.
Cahné, Pierre-Alain (1978), "Autour de la phrase deDescartes", Europe, n. 594, 59-72.
Cottingham, John, (1978), "A brute to the the brutes?Descartes' treatement of animals", Philosophy, 53, 551-9,poi in: René Descartes critical Assessments, (1991) G. J. D.Moyal ed., 4 vols, Routledge, London-New York, vol. IV,323-331. La posizione di C. riguardo agli animali non ècosì radicale come potrebbe apparire e mette inevidenza uno dei punti nevralgici della sua dottrina:il dualismo e lo statuto della sensibilità.
Dascal, Marcelo (1978), La sémiologie de Leibniz, Paris, AubierMontaigne. L'uso dei segni in C è legato alladescrizione del funzionamento della memoria ma C. nondà all'immaginazione un ruolo autonomo rispettoall'intelletto nella manipolazione dei segni.
Droixhe, Daniel (1978), La linguistique et l'appel a l'histoire (1600-1800),Genève, Droz. C sarebbe un logiciste cui sfugge ladimensione sociale e comunicativa del linguaggio. TC:L. Mer. 20 11 e 18 12 1629 TT 5, 6, Dis. Méth. V T 11 -L. M. New. 23 11 1646 T 25 - L. H. M. 5 2 1649 T 29.
Ricken, Ulrich (1978), Grammaire et philosophie au siècle des Lumières,Lille, Presses Universitaires.
Robinet, André (1978) Le langage a l'âge classique, Paris,Klincksieck. Analizzando le concezioni linguistiche traXVII e XVIII secolo individua due posizioni: quelladegli agostiniano-cartesiani, i quali consideranolettere e parole come convenzioni arbitrarieinessenziali all'esercizio del puro pensiero, e quelladi coloro che come Gassendi ritengono che non c'èpensiero senza linguaggio. Questa opposizione non èsempre netta e non costituisce il punto discriminantedelle diverse concezioni del linguaggio. C. èconsiderato il più radicale nella svalutazione dellinguaggio ordinario, infatti, presso gli stessiportorealisti la nozione di segno sarebbe piùsviluppata.
145
Wilson Dauler, Margaret (1978), Descartes, Routledge and KeganPaul, London-Henley and Boston. C. non sottopone aldubbio il significato delle parole e in ogni casoritiene che la competenza linguistica sia un fenomenotroppo complesso per essere spiegatomeccanicisticamente.
Bossong, G. (1979) "Über die zweifache Unendlichkeit derSprache. Descartes, Humboldt, Chomsky und das Problemder sprachlichen Kreativität", Zeitschrift für RomanischePhilologie, 95, 1-20.
Bouveresse, Jacques (1979), "La linguistique cartésienne:grandeur et décadence d'un mythe", Critique, 35, 420-28.Alle forzature chomskiane alla ricerca di un precusore atutti i costi, i suoi avvversari rispondono con lostudio prudente ed erudito che cerca di fare storia.
Buczynska Garewicz, H. (1979), "La teoria del segno e ildubbio cartesiano", Studia Filozoficzne, Varsavia, n. 4,113-25 (in polacco).
Chevalley de Buzon, Catherine (1979), "Rationalité del'anamorphose", Dix-septième siècle, 31, n. 124, 289-96.Sulla centralità della nozione di segno in una teoriapercettiva fondata sulla nozione di dissimiglianza.
Fattori, Marta e Bianchi, M. edd. (1979), Contribution a lasémanthèse de «ordre-ordo» chez Descartes, in: Ordo. Atti del IIColloquio Internazionale del Lessico Intellettuale Europeo, Roma,Ateneo e Bizzarri.
Piattelli-Palmarini, Massimo ed. (1979), Théories du langage,théories de l'apprentissage, Paris, 1979. Discute Chomsky(1966).
Cahné, Pierre-Alain (1980), Un autre Descartes. Le philosophe et sonlangage, Paris, Vrin. Sullo stile di C. e sull'uso e lasemantica di alcuni termini quali subtil, ordre ecc.,sulla sintassi, sull'uso del latino e del francese. C.accomuna le lingue storico-naturali al diritto: sitratta di un coacervo di assurdità derivate dall'uso,ma è meglio conservarle che innovare. TC: L. Mer. 20 11e 18 12 1629 TT 5, 6.
Giordano, Maria (1980), Cartesio epistemologo. La forma cartesiana dellascienza, Bari, Ecumenica Editrice. La correlazionecartesiana di monismo ontologico e metodologico porta
146
al riduzionismo verticale e alla perdita della funzionesimbolica del linguaggio. Nel quadro dell'eliminazionedi tutto quanto è soggettivo anche le fictions assumono unlinguaggio matematico. Nel Com. Mus. c'era un progettodi far corrispondere passioni e linguaggio, tuttaviaegli conserva l'idea che la verità si trovi nellapoesia e la certezza nella scienza. TC: Com. Mus., Cog.Priv., Olym., AT X.
Tagliagambe, Silvano, (1980), La mediazione linguistica. Il rapporto trapensiero e linguaggio da Leibniz ad Hegel, Milano, Feltrinelli.Il dibattito sei-settecentesco non si esaurisce nellaricerca della lingua universale. C'è consapevolezza delfatto che il linguaggio è il luogo della simulazioneoltre che della comunicazione, come dirà Jakobson.
Wokler, Robert (1980), "The ape debate in Enlightenmentantropology", Transactions of the fifth International Congress on theEnlightenment, Oxford, The Voltaire Foundation, III,1164-1175. Si sottolinea il ruolo determinante che ildibattito tra Chomsky (1966) e Aarsleff (1970) ha avutonell'avviare la conoscenza del pensiero linguistico delXVII e XVIII secolo.
Beyssade, Jean-Marie (1981), RSP ou Le monogramme de Descartes,suit: Descartes, René, L'entretien avec Burman, Paris, PUF,153-207. Il segno è considerato sempre da C. in uncurioso parallelismo tra il segno della scrittura e latraccia propria della memoria corporea. Nei testi incui C. elabora la sua teoria della percezione e lanozione di segno, c'è, da un lato, l'esigenza delladissimiglianza per opporsi alle specie intenzionalidella scolastica o ai simulacri dell'epicureismo,dall'altro, un minimo di similitudine viene conservatoattraverso la similitudine geometrica o la"corrispondenza regolata", linguistica. TC: Entr. Bur.T30.
Brissoni, A. (1981), "Descartes e Wittgenstein: epistemologiae linguaggio", Rivista d'Europa, 10, 46-52.
Drach, Margareth (1981), "The Creative Aspect of Chomsky's Useof the Notion of Creativity", The philosophical Review, XC,44-65.
147
Marion, Jean-Luc (1981 1a 1991 2a), Sur la théologie blanche deDescartes, Analogie, création des vérités éternelles et fondement,Paris, PUF. Interpretazione semiotica del pensiero diC. in particolare della fisica. Nel confronto conSaussure (252-56) il rapporto arbitrario tra segno esignificato di cui parla C. non va inteso come ilrapporto tra segno e referente intendendo i termininell'accezione moderna, bensì dando al termine'significato' una accezione per cui l'arbitrarietà ètutta interna al rapporto segnico poiché signifiant è perC. ciò che il segno può far concepire, sentire,immaginare. TC: Diot. IV, VI T 12, VII AT VI, 149 -Prin. Phi. IV § 197 T 22 - Ame T 28.- L. Mer. 22 7 1641T 19 - L. Mer. 20 11 1629 T 5, L. Cha. 1 2 1647 T 26.
Ricken, Ulrich (1981), "Interpretationen der Sprache alsArgument für und gegen den Dualismus. Descartes undseine sensualistischen Gegenspieler im 17 Jahrundert",Beiträge zur Romanische Philologie, 20, 29-49.
Aarsleff, Hans (1982), From Locke to Saussure. Essays on the History ofLinguistics and Intellectual History, Mineapolis, MinnesotaUniversity Press. Trad. it. Da Locke a Saussure, Bologna,Il Mulino, 1984, Introduzione di T. De Mauro conrisposta a Rossi (1968). Critica Chomsky e rivendica ilruolo dell'empirismo, mette a confronto Locke e C. enota come termini simili nascondano concezioni assaidifferenti.
Bouwsma, O. K. (1982), Toward a New Sensibility, Lincoln, Universityof Nebraska Press. Serie di saggi, molti dedicati aWittgenstein, in cui l'autore discute tra l'altro anchela filosofia di C. con una speciale attenzione allinguaggio filosofico.
Costabel, Pierre (1982), Démarches originales de Descartes savant,Paris, Vrin. Affronta, tra gli altri, anche il problemadel linguaggio e della terminologia della nuovascienza.
Reiss, T. J. (1982), The Discourse of Modernism, Ithaca-New York.Tassi, Aldo (1982), "Modernity as the transformation of truth
into meaning", International Philosophical Quarterly, 22, n. 3,185-93.
148
De Zilah, E. (1983), "Letero de Kartezio pri linguointernacia", Simpozio, 1, 11-16.
Pomian, K. (1983), "De l'animal comme être philosophique",Débat, 124-47.
Kenny, Anthony (1983),"The cartesian Spiral", Revue internationalede philosophie, n. 146, 247-256. C., avendo trascuratoAristotele, non si è posto il problema di distinguerela facoltà delle percezioni chiare e distinte da quellausata nelle conclusioni comparative da azioni remoteragionando secondo il modello: 1) io capisco la fraseche sto pronunciando; 2) chiunque capisce unaproposizione capisce tutto il linguaggio; 3) quindicapisco tutto il linguaggio, da ciò è scaturitol'errore chomskyanocirca l'esistenza in C. diun'autonoma facoltà linguistica.
Bouveresse, Jacques (1983), "Réponse a Anthony Kenny (1983)",Revue internationale de philosophie, n. 146, 257-64. La stradadella validazione delle certezze e dell'uscita daldubbio metafisico e psicologico passa in C. per laprova dell'esistenza di Dio e non c'è alcuninterrogativo sulla specificità della facoltà dellinguaggio.
Arduini, Stefano (1984), "La filologia dell'equivoco. Unainterpretazione della 'storia delle idee linguistiche'di N. A. Chomsky", Studi italiani di linguistica teorica e applicata,13, n. 2-3, 179-208.
Bracken, Harry M. (1984), Mind and Language. Essays on Descartes andChomsky, Dordrecht, Foris. Si discutono le teoriecartesiane sulla funzione del linguaggio accettando letesi chomskiane.
Buczynska Garewicz H. (1984), "Peirce's Idea of Sign andCartesian 'cogito'", in: Sign, System and Function, J. Pelcet alii edd., Belin, 37-47.
Derrida, Jacques (1984), "Languages and Institutions ofPhilosophic Semeiotic Inquiry", Recherches sémiotiques, 4,91-154.
Dienes, Otto (1984), "Descartes a francia nyelvfilozòfiaikritika tükrében", Magyar Nyelv, 80/2, 187-202. C.interpretato a partire dalla critica francese dellafilosofia del linguaggio contemporanea.
149
Dominicy, Marc (1984), La naissance de la grammaire moderne,Bruxelles, Mardaga.
Swiggers, Pierre ed. (1984), Grammaire et méthode au XVIIème siècle,Leuven, Peeters. Le grammatiche del XVII secolo sonointeressanti per lo sforzo di adeguare gli esiti dellaricerca cartesiana del metodo con la tradizionelinguistica precedente.
Thomas, Jean-Jacques (1984), "Descartes, langue, signe etrelecture chomskyenne", in Semiotica, Amsterdam-Berlin-New York. Mouton Publishers, vol. 51 1-3, SpecialIssue: The Classical Sign, 197-210. Da un punto di vistasemiolinguistico nel XVII secolo il pensare implicarassomiglianza mnemonica e dunque concettuale dielementi compresenti nell'operazione mentale. Questateoria del segno è nuova perché presuppone ladistinzione tra le verità divine e quelle di ordineumano: la semantica trova il suo fondamentonell'antropologia poiché la verità dei segni viene daun accordo interumano. Tanto l'approccio deduttivo chequello rappresentativo usano la nozione di segno, eproprio l'oscillazione tra empirismo e razionalismospiega l'oscillare tra uso e regola prescrittiva neglistudi sul linguaggio. Nell'analizzare questo quadrotanto Chomsky quanto i suoi critici compiono un erroreriducendo eccessivamente o accentuando troppo ladistanza tra le nozioni di segno di cui fanno usoempiristi e razionalisti. Il segno nella tradizionerazionalistica utilizza un modello dualistico,strettamente unito al pensiero esso ha tuttavia conl'idea un rapporto mediato. Nell'empirismo la costantearbitrarietà del segno fa sì che si tratti di unalogica semiotico-simbolica autonoma e non piùidealistica.
Yaguello, Marina (1984), Les fous du langage, Paris, Seuil.Pariente, Jean-Claude (1985), L'analyse du langage a Port Royal,
Paris, Minuit.Joly, André (1985), "Cartesian or Condillacian Linguistics",
Topoi, 4, 145-49. C. ha scritto assai poco sullinguaggio e tuttavia non si può negare la presenza diuna teoria semiotica in C. e la sua influenza sul
150
movimento della grammaire générale. É tuttavia scorrettal'analisi di Chomsky che, tra l'altro non si avvededell'originalità e dell'importanza di Condillac.
Joly, André (1986), Descartes, René, in: Encyclopedic Dictionary ofSemiotics, Research Center for Language and SemioticStudies, ed. by T. A. Sebeok, 3 vols, Berlin-New York-Amsterdam, Mouton-de Gruyter, vol. I, 183-85.Nonostante il carattere sparso e relativamente pocoesteso delle osservazioni di C. sul linguaggio e isegni ci sono gli elementi di una coerente teoriasemiotica. C. parte dall'arbitrarietà del segnolinguistico, e la relazione tra i tre termini,suoni/lettere-significato-cosa significata, anticipa iltriangolo semiotico di Odgen e Richards. C. estende leconsiderazioni che Prisciano e la Scolastica avevanoriservato ai segni linguistici anche a fenomeni nonlinguistici come la luce. Le parole sono "dualistiche"per natura poichè la loro funzione è di attirarel'attenzione sui concetti, in questo senso sono segni.C. affonda le sue radici nelle analisi della Scolasticae degli Stoici, la sua originalità (come poi quella diCordemoy e di Port Royal) sta nell'analisi del rapportotra suono e significato. Pur assegnando un ruolosubordinato al linguaggio nel senso materiale deltermine, C. non accetta il nominalismo e non è neppureun realista: si distingue così tanto da Hobbes che daLeibniz. Il suo mentalismo lo conduce alla ben notaposizione sul linguaggio degli animali. Il suointeresse per la lingua universale è guidato dall'ideache sia possibile porre ordine tra gli stessi pensieriper il progresso della conoscenza, il che lo condurràall'elaborazione di un simbolismo geometrico. TC: Mon.T 9 - Diot., IV AT VI - Princ. Phi. IV § 197 T 22 -Méd. Mét. II T 20 - II Obj. AT IX - Dis. Méth. V T 11 -Regulae XIV T 2 - Géom. AT VI - L. Mer. 20 11 1629 T 5- L. H. M. 5 2 1649 T 29 - L. Cha. 1 2 1647 T 26.
Katz, Jerrold J. (1986), Cogitations. A study of the Cogito in the relationto the Philosophy of Logic and Language and a study to them in relationto the Cogito, Oxford, Oxford University Press. Ilproblema della filosofia cartesiana è quello di
151
formulare in termini linguistici certe asserzioni,l'area linguistica permette di resistere al dubbio manon permette di raggiungere verità sintetiche poste aldi fuori dell'area semantica.
Kopania, Jerzy (1986), "La signification du mot selonDescartes", Studies in logic, grammar and rhetoric, J. Kopaniaed., Papers of Warsau Univ. Bialystok Branch n. 56,Humanities 11: Logic; Bialystok, 234, 31-42.
Matthews, Gareth B., (1986), "Descartes and the Problem ofOther Minds", in: Essays on Descartes' 'Meditations, RortyOksenberg, Amélie ed., Berkeley, University ofCalifornia Press, 141-51. Nell'ultima parte dellaseconda MM (T 20) C. affronta il problema delle altrementi che era stato del resto gia impostato da Agostinonel De Trinitate, C. non lo risolve mediante l'analogiabensì attraverso un language-users test.
Normore, Calvin (1986), "Meaning and Objective Being:Descartes and His Sources", in: Essays on Descartes''Meditations, Rorty Oksenberg, Amélie ed., Berkeley,University of California Press, 223-41. Il tentativocartesiano di spiegare come e perchè il pensiero possaoffrirci informazioni sugli oggetti ha a che fare tantocol problema del riferimento che con quello delsignificato. C. considera l'idea come un Giano bifrontecapace di riferirsi agli oggetti pur essendo a-priori,e questo gli permette di superare tanto l'olismo quantola teoria puramente referenziale, anche se le sue fontisono indubbiamente scolastiche.
Rooryck, Johan (1986), "Méthode, grammaire et théories dessignes au XVIIème siècle", Semiotica, 60, n. 3-4, 343-50.Rec. a Swiggers, Pierre ed. (1984), Grammaire et méthodeau XVIIème siècle, Leuven, Peeters. La teoria del segno diPort Royal è una teoria binaria e fondatasull'arbitrarietà e le grammatiche del XVII secolo sonointeressanti per losforzo di adeguare gli esiti dellaricerca cartesiana del metodo con la tradizionelinguistica precedente.
Barret, William (1987), Death of the soul. From Descartes to theComputer, Oxford-New York, Oxford University Press.
152
Trad. it. (1987), La morte dell'anima. Da Cartesio al computer,Bari, Laterza.
Bartlett, B. E. (1987), "The grammarian's contribution to thestudy of semantics Renaissance to Enlightenment", in:Speculative grammar, Universal Grammar and Philosophical Analysis ofLanguage, D. Buzzetti-M. Ferriani edd., Amsterdam,Benjamins, SiHoLS 42, 23-41.
Bonicalzi, Francesca, (1987), Il costruttore di automi. Descartes e leragioni dell'anima, Milano, Edizioni Universitarie Jaca.Un'ampia introduzione al tema dell'automa in C. in cuiil linguaggio risulta assai importante. Vi sonoraccolti numerosi testi fra cui: L. Mer. 27 5 1630 AT I- Dis. Méth. V T 11 - L. Rén. 4-5 1638 T 13 - L. Mer.30 7 1640 AT II - IV Obj.. AT IX, 177-79 - Princ. Phi.IV § 203 T 22 - L. M. New. 23 11 1646 T 25 - L. H.M. 52 1649 T 29 - Ame I 50 T 28.
Bordron, Jean-François (1987), Descartes, Paris, PUF. Analisidelle Méditations alla luce della semiotica perenuclearne il contenuto profondo. TC: Méd. Mét., I, ATIX, 14-18; II, 18-21; III, 28-41; V, 52-55.
Chandler, Hugh (1987), "Cartesian Semantics", Canadian Journal ofPhilosophy, 17, 63-69. La teoria della verità in C. èsemantica piuttosto che referenziale. L'a. chiama incausa Dummet e Putnam e centra l'analisi sull'utilizzodel dubbio radicale e della fiction del genioingannatore.
Kopania, Jerzy (1987), "La concezione del languaggio inDescartes", Ruch filozoficzny, 44, 3-4, 274-81 (inpolacco).
Pariente, Jean Claude (1987), "Problèmes logiques du Cogito",in: Le discours et sa méthode, N. Grimaldi-J.-L. Marion edd.,Paris, PUF, 229-69. Sul carattere metalinguisticodell'esposizione cartesiana del problema deglienunciati fondamentali, risposta a Hintikka (1962).
Burkhardt, Hans (1988), "Modalities in Language, Thought andReality in Leibniz, Descartes and Crusius",Synthèse, ,75, n. 2, 183-215.
Chomsky, Noam (1988), Language and Problems of Knowledge. The ManaguaLectures, Cambridge, Mass., The MIT Press. Trad. it. a c.di A. Moro, Linguaggio e problemi della conoscenza, Bologna, Il
153
Mulino, 1991. L'uso creativo del linguaggio individuatoda C. è ancora un problema.
Leiber, Justin (1988), " 'Cartesian' Linguistics?", Philosophia,18, 4, 309-346.Miwa, M. (1988), "Rhétorique et dialectique dans le Discours de la
méthode", in: Problématique et réception du Discours de la méthodeet des Essais, H. Méchoulan ed., Paris, Vrin, 47-55.
Rosiello, Luigi (1988), "Ancora sul cartesianesimolinguistico", in: Prospettive di storia della linguistica, L.Formigari-F. Lo Piparo edd., Roma, Editori Riuniti,127-34. La critica di Chomsky è ancora più radicale chein Rosiello (1967) perchè non solo non esiste unalinguistica cartesiana ma non esiste neppure il C. diChomsky, R. si rifà a VARTANIAN 1953.
Ross, George Mac Donald (1988), "Hobbes and Descartes on therelation between language and Consciousness", Synthèse,75, 217-29. Per Hobbes la ragione dipende dallinguaggio, per C. è il contrario. TC: Princ. Phi. I §§9, 60 - III Obj. T 21.
Thomson, Anne (1988), "L'homme-machine, mythe ou métaphore?",Dix-huitième siècle, 20, 367-76.
Drozdowicz, Z. (1989), "Le conventionnalisme dans laphilosophie française moderne", Uniwersytet Imienia AdamaMickeiwicza w Poznaniu Seria Filozofia i Logika, 148, 1-47.
Rossi, Paolo (1989), La scienza e la filosofia dei moderni, Torino:Bollati Boringhieri. C. è uno dei protagonisti deldibattito sulla lingua universale, anche nelletestimonianze dei suoi contemporanei.
Specht, E. K., Erichsen, N., Schttauf, K. (1989), "DieEmpfindungen des Anderen. Ein Disput zwischenCartesianer und Wittgensteinianer", Grazer PhilosophischeStudien; Wittgenstein in Focus, 33-34, 305-34. Differenze traC. e Wittgenstein sul linguaggio privato.
Boboc, A. (1990), "Cartésien et non-cartésien dans l'étudemoderne du langage. Modalités significatives de laprésence du Discours de la méthode dans la penséecontemporaine", Revue Roumaine des Sciences sociales. SèriePhilosophie et Logique. Logique, théorie du langage et praxiologie, 34,n. 1-2, 25-40. Partendo da Husserl e Chomsky, illustra
154
gli aspetti cartesiani degli studi di modellizzazionedella grammatica e della semantica.
Bonicalzi, Francesca (1990) A, L'ordine della certezza, Genova,Marietti. Sottolinea il ruolo del concetto di ordine edi modelli semiotici in C.. Attraverso un criterio dicertezza fondato sulla dissimiglianza percettiva C."libera una teoria del segno come materiale dadecifrare, teoria che ha il suo modello nel linguaggioe il suo esito più radicale nella scrittura algebricadella Géométrie" (123).
Bonicalzi, Francesca (1990) B, "Passioni come linguaggio.Introduzione alla lettura di Le passioni dell'anima diDescartes", Bollettino filosofico, Dipartimento di Filosofiadell'Universita della Calabria, 8, 105-30.
Bonicalzi, Francesca (1990) C, Passioni della scienza. Descartes e lanascita della psicologia, Milano, Jaca Book. Le passioni sonointese da C. come il linguaggio del corpo.
Canziani, Guido (1990), "'Histoire' autobiografica e 'fable'del mondo tra le 'Regulae' e il 'Discours'", in Atti delConvegno per il 350o anniversario della pubblicazione del Discours dela méthode e degli Essais, G. Belgioioso, G. Cimino, P.Costabel e G. Papuli edd., 2 voll., Roma, Istitutodell'Enciclopedia Italiana, 163-85. La fabula cartesianacome specchio letterario della scientificità.
Carr, Thomas M.jr. (1990), Descartes and the resilience of rhetoric.Varieties of Cartesian rhetorical theories, Carbondale, SouthernIllinois University Press. Analisi dei modelli retoriciin C. e nei cartesiani.
Cavaillé, Jean Pierre (1990), "Une histoire, un discours, desméditations; récit, éloquence et métaphysique dans le'Discours de la metode'", in Atti del Convegno per il 350oanniversario della pubblicazione del Discours de la méthode e degliEssais, G. Belgioioso, G. Cimino, P. Costabel e G.Papuli edd., 2 voll., Roma, Istituto dell'EnciclopediaItaliana, 185-201.
Guenancia, Pierre (1990), "Hobbes-Descartes le nom et lachose", in: Thomas Hobbes. Philosophie première, théorie de lascience et politique. Actes du Colloque tenu en Sorbonne et al'ENS Ulm les 30-31 mai et 1er juin 1988 sous la
155
direction de Yves Charles Zarka avec la collaborationde Jean Bernhardt, Introduction de Raimond Polin,Paris, Presses Universitaires de France, 67-79.
Katz, Jerrold (1990), "Descartes's cogito", in: Demonstratives,Palle Yourgrau ed., Oxford University Press, 154-181.Ripropone le tesi di Katz (1986).
Kopania, Jerzy (1990), "La concezione del languaggio inDescartes", Studia Semiotyczne, 16-17, 21-31, (inpolacco). Sui rapporti tra linguaggio e realtà in C..
Manjali, F. D. (1990), "What is cartesian in linguistics",International journal of Dravidian Llinguistics, 19, n. 1, 63-79. Laricostruzione di Chomsky è falsata dalla sua ignoranzafilosofica.
Pala, Alberto (1990), Descartes e lo sperimentalismo francese 1600-1650,Roma, Editori Riuniti. La fisica cartesiana è unasemiotica poichè si propone di "studiare 'oggetti' nonaccesibili o non immediatamente accessibili, per mezzodi 'segni' comunemente accessibili che presentino leanalogie idonee a fornire un'adeguata rappresentazionedegli oggetti indagati" (158).
Ricken, Ulrich (1990), "Von Descartes zu Locke und Leibniz:zur Ausgangskonstellation sprachphilosophischerEntwicklungen der Aufklärung", in Sprach Theorie undWeltanschauung ünder europeischen Aufklärung: zur Geschichte derSprachtheorien in des 18. Jahrunderts und ihrer europeischen Rezeptionnach der Französischen Revolution, U. Ricken- K. Herrmannedd., Berlin, Akademie, 11-37.
Rodis Lewis, Geneviève (1990), L'anthropologie cartésienne, Paris,PUF. I temi trattati sono relativi piuttosto al lorosviluppo nel cartesianesimo (Cordemoy, Lamy, La Forge).In ogni caso le caratteristiche della "linguisticacartesiana" sono individuate nella differenza tralinguaggio animale e linguaggio umano e nel legamearbitrario tra segno e significato sul modello di altrilegami metafisici quali quello anima-corpo e sensazione-oggetto.
Sencerz, S. (1990), "Descartes on Sensation and Animal Minds",Philosophical Papers, 19, n. 2, 119-41.
Simone, Raffaele (1990), Seicento e Settecento, in: Storia dellalinguistica, G. C. Lepschy ed., vol. II, Bologna, Il
156
Mulino, 313-387. Dà conto delle discussioni suscitateda Chomsky e indica come spunti cartesiani sullinguaggio: la trasparenza del segno linguisticorispetto alla ragione, l'interesse per una linguauniversale, la differenza tra linguaggio umano elinguaggio animale.
Bitbol-Esperies, A. (1991), "Le dualisme dans laCorrespondance entre Henry More et Descartes", in:Autour de Descartes. Le problème de l'âme et le dualisme, J. L.Vieillard- Baron ed., Paris, PUF.
Sullivan, John J. (1990), "Noham Chomsky and 'CartesianLinguistics' ",in: Psychology of Language and Thoutht. Essais onthe Theory and History of Psycholinguistics, Studies in AppliedPsycholinguistics, R. W. Rieber ed., New York, Plenum, 197-223.
Uitti, Karl D. (1990), "Cordemoy and 'Cartesian Linguistics'",in: Psychology of Language and Thoutht. Essais on the Theory andHistory of Psycholinguistics, Studies in Applied Psycholinguistics, R. W.Rieber ed., New York, Plenum, 53-76.
Cantelli, Gianfranco (1991), "Anima e corpo in Cartesio: uncaso di denominazione estrinseca", in: Filosofia e cultura perEugenio Garin, M. Ciliberto-C. Vasoli edd., 2 voll.,Roma, Editori Riuniti. Poi parzialmente rielaboratocome 2 capitolo di Cantelli (1992).
Cavaillé, Jean-Pierre, (1991) A, Descartes la fable du monde, Paris,Vrin. La dissimiglianza semiotica tra la sensazione eil suo oggetto fonda in C. la possibilità di utilizzarela favola come strategia retorica della vera scienza.C. sembra aver condiviso in gioventù la concezionemagico-ermetica del linguaggio come simbolo, che noncompare nelle sue opere più mature. C. non condivideneppure la dottrina tomista del segno come "aliquid proaliquo", la sua teoria delle verità eterne mira proprioal ripudio della centralità tomista del ragionamentoper analogia e lo guida alla teoria semiologica dellapercezione e a dare "place centrale et paradigmatique"al linguaggio e agli altri sistemi di segni umani (77).Il linguaggio si rapporta tanto alle cose che al sensoma quest'ultimo non è contenuto nei segni ma nello
157
spirito che li manipola e che resta indipendente dallafunzione linguistica.
Cavaillé, Jean Pierre (1991) B, "Les sens trompeurs. Usagecartésien d'un motif sceptique", Revue philosophique de laFrance er de l'Etranger,116, CLXXXI, 3-29. L'uso dell'ingannodei sensi trova la sua ragione nella teoriaepistemologica di C. non scettica ma legata allatematica della rappresentazione e della separazione delmentale dal sensibile.
Gensini, Stefano (1991), Il naturale e il simbolico. Saggio su Leibniz,Roma, Bulzoni. Pur riconoscendo il valore mnemotecnicodel segno C. non affronta il problema della mediazionelinguistica del pensiero, poichè esclude che il segnoabbia valore costitutivo rispetto alla conoscenza equesto lo differenzia da Leibniz. TC: L. Mer. 20 111629 T 5.
Gontier, Thierry (1991),"Les animaux-machines chez Descartes:modèle ou réalité?", Corpus, 16/17, L'âme des bêtes, 3-16.Sono i cartesiani del XVII e del XVIII secolo ad avercreato il mito della negazione radicale dell'animadelle bestie da parte di C., in realtà le posizioniappaiono spesso assai sfumate. Argomentazioniepistemologiche e teologiche si oppongonoall'attribuzione dell'anima alle bestie e il linguaggioresta il segno decisivo della differenza. TC: L. Mer. 810 1629 AT I - Dis. Méth. V T 11 - L. Rén. 4-5 1638 T13 - L. Mer. 30 7 1640 AT II - L. Mer. 30 8 1640 AT II- IV, VI Obj. T 21, L. M. New. 23 11 1646 T 25 - L. H.M. 5 2 1649 T 29.
Kopania, Jerzy (1991), "Descartes and Kant: Two DifferentConception of Language", Ruch Filozoficzny, 48, n. 1, 45-9,trad. ingl. in Signs of Humanity: Proceedings of the IVth CongressIASS 1989, Berlin, De Gruyther, 1992, 1525-9. Dalla tesiche l'oggetto della conoscenza è costruito nel processocognitivo scaturiscono in C. e Kant due differentivalutazioni sulla natura del linguaggio naturale esulla sua funzione cognitiva. Benché C. consideri illinguaggio uno strumento subordinato alle strutture delpensiero, tuttavia è uno strumento adeguato, fondandola necessità di instaurare una grammatica razionale e
158
quindi generale. TC: L. Mer. 20 11 1629 T 5 - Dis. Méth.V - III Obj. T 21 - L. H. M. 5 2 1649 T 29 - L. Mer. 71641 AT III 392-3 - L Cler. 12 1 1644 AT IX,1, 209-10 -L. Mer. 1 1630 T 7.
Lojacono, Ettore (1991), "Descartes e le culture barocche.Appunti su alcune recenti interpretazioni", Giornalecritico della filosofia italiana, VI serie, vol. XI, a. LXX(LXXXXII), fasc. 1, 1-14.
Shea, William R. (1991), The Magic of Numbers and Motion. The scientificCareer of René Descartes, Nantucket Massachussets, WatsonPublishing International. Trad. it. La magia dei numeri edel moto. René Descartes e la scienza del Seicento, Torino, BollatiBoringhieri, 1994. TC: L. Mer. 20 11 1629 T 5.
Alanen, Lilli (1992), "Thought-talk. Descartes and Sellars onintentionality", American Philosophical Quarterly, 29, n. 1,19-34. Quando si parla di C. e della sua concezione delpensiero e di una eventuale identificazione tra cogitatioe pensiero proposizionale si rischia sempre dimescolare l'immagine che di C. hanno dato alcunifilosofi della mente, con ciò che egli ha veramentedetto. C. non è "cartesiano" nel sensodell'internalismo, egli considera la coscienza come iltratto distintivo della realtà mentale e ha introdottouna nuova nozione del pensiero e della mente per cui'idea' e 'percezione' diventano termini usaticoestensivamente a 'pensiero'. C'è poi per C. un altrosegno certo e distintivo della presenza del pensiero,in certi contesti ne è l'unico segno e si tratta di unsegno "esterno": il linguaggio. Dati questi due criteriin che misura coincidono? La coscienza coincide con opresuppone la capacità di esprimersi attraverso il"discorso interiore"? Siamo consapevoli solo di ciò chepuò essere rappresentato attraverso una sorta dilinguaggio interno? Purtroppo C. non descrive laconnessione tra pensiero e linguaggio. L'ideacartesiana del pensiero non richiede una comunitàlinguistica ma presuppone una comunità di esseriraziocinanti.
Auroux, Sylvain (1992), L'Illuminismo francese e la tradizione logica diPort-Royal, Bologna, CLUEB.
159
Chomsky, Noam (1992), "On Nature, Use and Acquisition ofLanguage", in Thirty Years of Linguistic Evolution, M. Putz ed.,Philadelphia, Benjamins, 3-30.
Dominicy, Marc (1992), "Le programme scientifique de lagrammaire générale", in: Histoire des idées linguistiques, IIvol.: Le développement de la grammaire Occidentale, S. Aurouxed., Bruxelles, Mardaga. Fa il punto sulla discussionesuscitata da Chomsky (1966) e Foucault (1966), ma sioccupa più del cartesianesimo che di C..
Cantelli, Gianfranco (1992), La parola come similitudine dell'uomo, Unainterpretazione del rapporto mente corpo in Cartesio, Napoli,Morano. Il rapporto mente-corpo è interpretato come uncaso di denominazione estrinseca ossia come un rapportosemiotico, un legame arbitrario. Oggetto della fisicanon è l'esperienza sensibile ma quella ricostruibile inbase a concetti matematici e geometrici. La sua teoriadella sensibilità è analoga a quella deducibile dallafisica galileiana. Tra sensazione e movimento corporeosussiste una frattura incolmabile e proprio ricorrendoall'analogia con il linguaggio C. illustra il tiporelazione (100 e sgg.). In nessuna sua opera C. dedicaal linguaggio un'attenzione più che generica, evitandodi indagarne l'origine e la natura. Nessuna originalitàcontraddistingue le sue idee in proposito e la suaadesione alla dottrina tradizionale del linguaggio comeuna istituzione stabilita mediante convenzione dagliuomini si presenta senza alcuna riserva. Ciò tuttavianon toglie che nella complessa articolazione della suafilosofia C. affidi al linguaggio una parte di granderilievo: costituisce infatti, insieme al pensiero, unodei due poli entro quali può venire riconosciuta edefinita l'essenza della natura umana (135).TC: Dis. Méth. V T 11 - Diot. IV T 12 - Corps AT XI,224 - Princ. Phi. IV § 197 T 21 - L. M. New. 23 11 1646T 25 - L. Cha. 1-2 1647 T 26 - L. H. M. 5 2 1649 T 29 -Ame art 50 T 28.
Conant, James (1992), "The search for logical alien thought.Descartes, Kant, Frege and the 'Tractatus' ",Philosophical Topics, 20, 1, 115-80. Hilary Putnam Replay,374-77.
160
De Buzon, Frédéric (1992), "L'homme et le langage chezMontaigne et Descartes", Revue philosophique de la France et del'Etranger, 4, IV (oct.-déc.), 451-66. C. non accetta ilnominalismo e ritiene che il linguaggio sia prerogativasolo umana.
Pellerey, Roberto (1992), Le lingue perfette nel secolo dell'utopia, Roma-Bari: Laterza. Il pensiero linguistico di C. e il suoatteggiamento nei confronti della lingua perfetta sonoispirati a considerazioni pratiche (è un'idea utile madifficilmente attuabile, troppo macchinosa) e all'ideache la lingua universale debba avere una base"ontologica" nella vera filosofia: Sono perciònecessari un elenco di idee semplici, di universalisemantici e un repertorio delle idee composte di usocorrente per superare gli idoli del linguaggio (per P.si tratta di una critica del lingua analoga a quellabaconiana). Le lingue naturali sono strumentiimperfetti, tuttavia hanno una forma originaria e unacorruzione che deriva dall'uso. TC: L. Mer. 20 11 1629e 18 12 1629 TT 5, 6 - Princ. Phi., I §§ 7-45 AT IX §74 T 22.
Picardi, Eva, (1992), Linguaggio e analisi filosofica. Elementi di filosofia dellinguaggio, Bologna, Patron. L'idea di lingua cheaccomuna C. e Leibniz nasce dalla confluenza dielementi della tradizione empiristica e di quellarazionalistica del XVII secolo. La convenzionalità èuno degli elementi centrali delle riflessioni sullinguaggio di questi due autori, poiché sono convintiche la ragione abbia il proprio patrimonio di ideechiare e distinte, governate dagli atti mentali delconcepire, giudicare e ragionare e sia, quindi,trasparente a se stessa, l'invenzione delle linguenasce perciò dalla necessità di trovare uno strumentoper comunicare (19-21).
Proust, Joelle (1992), "L'esprit des bêtes", Revue Internationalede Philosophie, 46, 4 (183), 418-34. Polemizzando conMontaigne a proposito del linguaggio degli animali, C.identifica la razionalità con la competenzalinguistica. Gli studi recenti hanno confermato illegame tra uso composizionale dei segni e intelligenza
161
in senso generale, ma hanno anche evidenziato come siadubbio il legame tra la "ragione" e altri aspetti dellacompetenza linguistica, che sarebbero piuttostomodulari. Sul punto della mancanza negli animali di unlinguaggio interiore lo stato delle ricerche nonconsente una risposta netta.
Sievert Don, (1992), "Searle and Descartes. The connectionbetween thinking and speaking", Southwest PhilosophicalReview, 8, I, 137-144.
Aarsleff, Hans (1993), "Descartes and Augustine on Genesis,Language, and the Angels", in M. Dascal-E. Yakira edd.,Leibniz and Adam, University Publishing Projects Ltd, 169-195.
Auroux, Sylvain (1993), La logique des idées, Montréal-Paris,Bellarmin-Vrin. Nei secoli XVII e XVIII il concetto diidea serve sia nella teoria logica che in quellalinguistica, tuttavia l'evoluzione delle due disciplineprocede nel senso di una separazione. La teoria delleidee è un'antenata dell'algebra delle classi ma anchedella semantica lessicale. Attraverso Port Royal, ilproblema della definizione supera gli schemidell'aristotelismo grazie proprio al dualismocartesiano.
Chomsky, Noam (1993), Language and Thought, Wakefield RhodeIsland and London, Moyer Bell. I problemi del rapportotra mente, corpo e linguaggio posti nel XVII secolo inparticolare da C. non sono stati ancora risoltinonostante i progressi delle neuroscienze e dellescienze del linguaggio.
Eco, Umberto (1993), La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea,Roma-Bari: Laterza. Pochi tratti, stessa impostazioneche in Pellerey (1992). Il progetto discusso da C. eMersenne è quello di des Valles. TC: L. Mer. 20 11 1629T 5 - Princ. Phi., I § 48 AT IX.
Fichant, Michel (1993), "L'ingenium selon Descartes et lechiffre universel des Règles", Scepticisme et exégèse.Hommage a C. Perrot, ed. par B. Besnier, ENS FontenaySaint Cloud, 197-216. Nelle Regulae l'immaginazioneriveste un ruolo centrale poiché fornisce "traccecorporee" utili alla decodifica di un cifrario
162
universale, all'ingenium si apre il mondo delletraduzioni virtuali in cui si opera una selezionegrazie agli strumenti logici della matematica.
Gallotti, Cecilia (1993), "L'eta moderna", in: I filosofi e illinguaggio, U. Volli, C. Gallotti, S. Bulgari edd.,Bologna, Progetto Leonardo. Brevissimi cenni al temadella differenza uomo-animale ed alla lingua universalee del rapporto tra linguaggio e conoscenza.
Guenancia, Pierre (1993), "L'institution de la nature chezDescartes", in L'interpretazione nei secoli XVI e XVII, G.Canziani- I. C. Zarka edd., Milano, Franco Angeli, 319-77. La nozione di institution è presente in tutta l'operacartesiana ed è centrale per quella concezionesemiotica della teoria della percezione, dei fenomenifisici, delle passioni che permette a C. di pensare lanatura e le sue operazioni in un modo che è insiemespecifico e conforme alle esigenze di unarappresentazione intellegibile.
Guerini, L. (1993), "Occasionalismo e teoria dellacomunicazione in Cordemoy", Annali del Dipartimento di Filosofiadell'Universita di Firenze, IX, 63-80. Discutendo le teorielinguistiche di Cordemoy fa riferimento a Gouhier(1926) e Cantelli (1992).
Rudolph, K. (1993), "Descartes'Discourse", Philosophy today, 37,n. 1, 38-51. Insolubile tensione nell'epistemologia diC. tra l'evidenza intuitiva e il ruolo del metodo, deldiscorso, della fiction, del linguaggio.
Séris, Jean Pierre (1941-1995) (1993), "Language and Machinein the Philosophy of Descartes", in: Essays on thePhilosophy and Science of René Descartes, S. Voss ed., New York-Oxford. Saggio poi ampliato come 1 capitolo in Séris(1995).
Verbeek, Theo (1993), "Le contexte historique des Notae inprogramma quoddam", in Descartes et Regius autour de l'explicationde l'esprit humain. Colloque du Centre franco-neerlandais de recherchescartésiennes, T. Verbeek ed., Amsterdam, Rodopi, 1-33.
Bennet Johnathan (1993-94), "Mind and Brain in the 17thCentury", Philosophical Exchange, 24-25, 81-92.
Beyssade, Michelle, (1994), "Réponse a Lilli Alanen et a Raul Landim surla fausseté matérielle", in: Descartes. Objecter et répondre,
163
Actes du colloque "Objecter et répondre" organisé par le Centre d'étudescartésiennes a la Sorbonne et a l'Ecole normale supérieure du 3 au 6octobre 1992, a l'occasion du 350e anniversaire de la seconde édition desMeditationes, J.-M. Beyssade- J.-L. Marion et L. Lévyedd., Paris, PUF, 231-46. Nelle Méd. Mét. e nei Princ.Phi. il sentire è spiegato mediante la nozione disegno. Il sentimento rinvia a qualcosa fuori di noi, siriferisce a questo qualcosa senza rappresentarlo esenza esibirlo, lo designa e nient'altro.
Bineham, Jeffrey L. (1994), "Displacing Descartes:Philosophical Hermeneutics and Rhetorical Studies",Philosophy and Rhetorics, 27, n. 4, 300-12. Se si assume ilcartesianesimo come dualismo, il linguaggio non può cheessere considerato come strumento e ogni teoria dellacomunicazione presuppone una presa di posizione difronte a questo paradigma. Il paradigma retorico edermeneutico, di cui C è considerato un oppositore,ponendo l'accento sugli usi pratici del linguaggio,sfida il dualismo di C.
Gozzano, Simone (1994), "Mental Images and their Ontology",Epistemologia, 17, n. 2, 225-52. L'articolo analizza ilproblema del rapporto tra idee, immagini mentali elinguaggio riferendo al XVII secolo il dibattitocontemporaneo.
Trabant, Jürgen (1994), Neue Wissenshaft von alten Zeichen: VicosSematologie Suhrkamp, Frankfurt an Main; (1996), La scienzanuova dei segni antichi. La sematologia di Vico, ed. it. a c. D. DiCesare, Roma-Bari, Laterza. Chomsky ha avuto il meritodi dare alla linguistica un interesse ormai assai forteper la sua storia remota. T. ritiene che la concezionecartesiana della mente sia una versione radicalizzatadi una lettura tradizionale dell'aristotelismo per cuicognizione e comunicazione sono connesse solo in modolasco (23). Lo spirito, pensando il mondo delle cosecrea i concetti indipendentemente dal linguaggio, percomunicarli ad altri, possono essere designati permezzo di parole, in modo arbitrario. Alle lingue nonviene attribuito nessun particolare valore cognitivo eperciò il pensiero che "non è affatto legato a segni"(25) come in Locke, Leibniz, Vico, Condillac. Anche il
164
tema degli automi per T. viene introdotto per separaree non per integrare il corpo nel pensiero. Vico compieper primo questa integrazione per cui il pensiero èsemiosi (34), e così compie una "svolta linguistica"aggiungendo alle res cartesiane una vera e propria reslinguistica. TC: Dis. Méth. V T 11 - L. Mer. 20 11 1629 T6.
Beyssade, Jean Marie (1995), "Sensation et idée: le patronrude", in: Antoine Arnauld. Philosophie du langage et de laconnaissance, J.-C. Pariente ed., Paris, Vrin, 133-152.La teoria della percezione di Arnauld è messa aconfronto con quella di C. interpretata come "doublecodage".
Bono, James J. (1995), The word of God and the languages of man,Interpreting Nature in Early Modern Science andMedecine, 1: Ficino to Descartes, Madison, TheUniversity of Wisconsin Press. Nonostante lefondamentali differenze che oppongono la filosofia diBacone e quella di C., un aspetto comune sta nella loropolemica antiretorica, nel rifiuto del simbolismo edell'ermetismo e nel loro considerare la natura come unlibro scritto in "caratteri reali" o nella lingua dellamathesis universalis.
Bouvier, Alban (1995), L'argumentation philosophique. Etude de sociologiecognitive, Paris, PUF. Sulla base delle Méd. Mét B.avanza un'interpretazione dell'uso della metafora edell'analogia in C. in funzione non solo retorica maanche cognitiva chiamando in causa come esempio ilrapporto sincronia e diacronia e la nozione di linguain Saussure (50).
Duddy, Thomas (1995), "Privacy, Self-knowledge, and the InnerEye: The Cartesian Project Rivisited", History of EuropeanIdeas, 21, n. 4, 515-26. La tesi è che non ci sia in C.una teoria introspettiva della conoscenza e che la suaepistemologia non implichi una nozione di linguaggioprivato.
Eco, Umberto (1995), "Una parodia di linguistiche nonilluministiche", Lingua e stile, XXX, n. 1, dedicato aLuigi Rosiello, 47-62. Cita L. Mer. 20 11 1629 (T 4)per dare ragione a C. che si avvede del limite di tutti
165
i progetti di lingua universale che debbono approdare oad una enciclopedia o ad un limitato alfabeto di atomilogici.
Gola, Elisabetta (1995), "Le metafore e il problema mente-corpo cartesianesimo e anticartesianesimo nelle scienzecognitive contemporanee", in: Filosofia Scienza Storia. Studi inonore di Alberto Pala, A. Cadeddu ed., 295-320. C. vieneconsiderato uno dei padri della scienza cognitiva, inparticolare si sottolinea come il dualismo sia statoutilizzato come punto di partenza del funzionalismo.Anche nelle prime formulazioni dell'IntelligenzaArtificiale può essere ritrovata un'eco cartesiananell'idea che l'essenza del pensiero sia una ragionedisincarnata e meccanica indifferente rispetto allinguaggio.
Miers, Paul (1995), "Descartes and the Algebra of Soul",Modern Language Notes, 4 (110), 943-52.
Pécharman, Martine (1995), "La signification dans laphilosophie du langage d'Antoine Arnauld", in: AntoineArnauld. Philosophie du langage et de la connaissance, J.-C.Pariente ed., Paris, Vrin, 65-98. Analizzando la teoriadel segno e del significato in Arnauld nota come A.avrebbe correttamente interpretato la III Méd. Mét. diC.. Sono chiamati in causa il Mon. (T 9) e la Diot. VI(T 12) per chiarire il doppio rapporto diconvenzionalità che si instaura a partire dallesensazioni nel significare: "une institution naturellemise au service d'une institution humaine" (93).
Séris, Jean-Pierre (1995), Machine et langage a l'âge classique, Paris,Hachette. Il punto di partenza è l'errore compiuto daChomsky che non solo ha individuato come già pronte aquest'epoca soluzioni che anticipano le sue posizioniteoriche ma ha scelto per sostenerlo gli autori che S.considera più distanti dalla prospettiva chomskiana.Attraverso una sorta di test di Turing C. afferma cheil linguaggio è l'unica attestazione pubblicadell'esistenza del pensiero e dell'anima. S. mette inluce tutti quegli elementi per cui si potrebbe parlaredi una "semiotica cartesiana" ma tali elementi non sonoapplicati da C. proprio alla filosofia della parole e
166
delle langues, che restano invece ancorateall'impostazione tradizionale per cui il pensieroprecede il linguaggio e ne determina la strutturalogica, indipendentemente dalle caratteristicheconcrete dell'enunciazione linguistica. Questo spiega,forse, lo scarso interesse che C. manifesta per ilprogetto di lingua universale sottopostogli daMersenne; la sua attenzione è rivolta piuttosto al temadel rapporto tra lessico e grammatica. C'è un'analisidel pensiero linguistico di alcuni dei maggioriesponenti del cartesianesimo: Mersenne, Cordemoy, Lamye Malebranche. TC: Regulae T 2 - L. Mer. 20 11 1629 T 5- Mon. T 9 - H AT XI 120 -- Dis. Méth. T 11 - Princ.Phi. I AT X, 214-17-24, 365, 372 - L. H. M. 5 2 1649 T29 - L. Cler. 23 4 1649 - Ame art. VIII AT XI 33.
Simone, Raffaele (1995), "Purus historicus est asinus Quattromodi di fare storia della linguistica", Lingua e stile,XXX, n. 1, dedicato a Luigi Rosiello, 117-26. Torna inparticolare sul modo di utilizzare il passato da partedi Chomsky (1966) per propore un diverso atteggiamento:una storia "carica di teoria".
Tanigawa, Takako (1995), "Signe, idée, langage chez Descartes,Locke et Leibniz - l'arbitraire et le mental dans lesigne représenté", Fenestra, Linguistic Information from Japan,n. 1 The psyche in linguistics, Gakushu-in University Tokyo,23-29. Il punto di partenza di una definizione delsegno è per C. il dualismo poiché segno e linguaggiosono alla frontiera delle due sostanze. La primaconnotazione è l'indipendenza della parola rispetto alpensiero (III Obj. T 21 - L. Mer. 7 1641 T 18 - Mon. T9). Nella dissimiglianza tra parole e cose T. vedeanticipata la posizione di Saussure (Diot. IV T 12) eEntr. Bur. T 27). Sottolineando la differenza tra segnoe significato (L. a *** 4 1641 e L. Mer. 7 1641 T 18) Ccondivide le posizioni sulla lingua di un Vaugelas(Dis. Méth. I AT VI - Vérité T 30). Tuttavia quando C.elabora il suo algoritmo algebrico sembra che illivello sintattico esprima, piuttosto che indicaredall'esterno, il pensiero. C. sottopone anche le veritàmatematiche al dubbio metodico pur prendendole a
167
modello dell'evidenza. Chomsky ha saputo sottolinearecome il meccanicismo non sappia spiegarci né illinguaggio né la conoscenza delle altre menti, ma nonha fatto rilevare come la scelta metafisica di C. rendail linguaggio solo uno strumento della ragione innata.
Aarsleff, Hans (1996), "Herders Cartesian Ursprung vs CondillacExpressivist Essai", in: Philosophies and Sciences of Language,D. Gambarara-S. Gensini-A. Pennisi edd., Münster, NodusPublikationen, 175-89. Herder è visto come cartesianoperchè fautore di un discorso puramente interiore,silente e non sociale.
Avramides, Anita (1996), "Descartes and Other Minds", Theorema,16 (1), 27-46. Mette in relazione il Dis. Méth. V (T11) e la seconda Méd. Mét. (T 20) per mettere in luceil ruolo che, nella dimostrazione dell'esistenza dellealtre menti ha l'uso del linguaggio.
Bonicalzi Francesca (1996), "Sensi, infanzia e il sapere delcorpo", in: Descartes: Principia Philosophiae (1644-1994), Atti delConvegno per il 350o anniversario della pubblicazione dell'opera. Parigi,5-6 maggio 1994 Lecce 10-12 novembre 1994, J.-R. Armogathe-G.Belgioioso edd., Napoli, Vivarium, 53-66. L'infanziarappresenta per C. il momento in cui sensazione eimmaginazione dominano la nostra visione del mondo e ilpensiero non è ancora capace di raggiungere, attraversoil dubbio un sapere adeguato e rigoroso e un linguaggioche controlla pienamente il suo significato (T 22).
Buroker, Jill Vance (1996), "Arnauld on Judging and the Will",in: Interpreting Arnauld, E.J. Kremer ed., Toronto,University of Toronto Press. Dal punto di vista dellaprospettiva della moderna filosofia del linguaggio, leteorie di C. rivelano qualche punto di forza ma anchemolte debolezze.
Cantelli, Gianfranco (1996), "La terza nozione primitiva el'analisi dei sensi esterni e interni svolta neiPrincipia, IV, 188-199", in: Descartes: Principia Philosophiae(1644-1994), Atti del Convegno per il 350o anniversario dellapubblicazione dell'opera. Parigi, 5-6 maggio 1994 Lecce 10-12 novembre1994, J.-R. Armogathe-G. Belgioioso edd., Napoli,Vivarium, 67-104. L'unione dell'anima col corpo appare
168
in certi luoghi cartesiani quasi come una terza nozioneprimitiva accanto alla res cogitans ed alla res extensa maproprio là dove più si dovrebbe servire di questanozione C. si affanna a darne una dimostrazioneappellandosi, come altre volte aveva fatto, al modellodel linguaggio.
Cossutta, Frédéric ed. (1996), Descartes et l'argumentationphilosophique, Paris, PUF.
Dascal, Marcelo (1996), The Dispute on the primacy of thinking orspeaking, in: Sprachphilosophie, 2 Halbband, M. Dascal- D.Gerhardes- K. Lorenz- G. Meggle edd., Berlin-New York,De Gruyter, 1026-28. TC: Regulae VI, VII, X T 2.
Droixhe, Daniel (1996), "Adam ou Babel? Théorie du signe etlinguistique biblique de Descartes a Leibniz", in:Philosophies and Sciences of Language, D. Gambarara-S. Gensini-A. Pennisi edd., Münster, Nodus Publikationen, 121-34.Ricolloca la "linguistica cartesiana" all'interno dirapporti più complessi e sfumati tra razionalismo edempirismo emersi nella più recente storiografialinguistica ma non ci sono indicazioni specifiche suC..
Gomila Benejam, Antoni (1996), "La theoria de las ideas deDescartes", Theorema, 16 (1), 47-69. Cerca di superarele tradizionali interpretazioni della filosofia dellamente di C., condotte alla luce di categorie usate insenso spregiativo quali: dualismo, soggettivismo,individualismo, utilizzando la nozione di idea comesegno naturale e non come immagine incorporea. Perquesto vengono chiamate in causa non solo le Méd. Mét.ma anche le opere scientifiche.
Hintikka, Jaakko (1996), "Cogito, ergo quis est?", RevueInternationale de Philosophie, 50, 1 (195), 5-21. C'è unlegame essenziale tra il cogito e l'uso del pronome diprima persona, perchè non si può ricavare dal cogitoalcuna inferenza che concluda all'esistenza di unoggetto pubblico.
Ishiguro, Hidé (1996), "L'esprit cartésien et le problème dulangage", in: Actes du XXVIe Congrès de l' Association des Sociétés dePhilosophie de Langue Française: L'esprit cartésien, Célébration duquatrième Centenaire de la naissance de Descartes a Paris en Sorbonne
169
30 août - 3 sept. 1996. In preparazione presso le Presses del'Université de Paris-Sorbonne.
Judovitz, Dalia (1996), "La vision, la représentation et latechnologie chez Descartes", Revue internationale dephilosophie, vol. 50, n. 195, 1, 133-61. L'utilizzo daparte di C. di alcune analogie pittoriche neldescrivere i processi cognitivi dimostra come egliscelga questa rappresentazione del pensare proprio persottolineare il primato dell'anamorfosi rispetto allavisione e quindi la centralità dell'idea di segno.
Kearns, John T. (1996), Experience: A solution to a Problem Inherited fromDescartes, Albany, Suny Press. Una spiegazioneintenzionale dell'attività umana (compresa quellamentale e linguistica) è incompatibile con unaspiegazione meccanico-causale.
Lojacono, Ettore (1996) A, "Cenni sulle lingue di Descartes",in: Descartes: Principia Philosophiae (1644-1994), Atti del Convegno peril 350o anniversario della pubblicazione dell'opera. Parigi, 5-6 maggio1994 Lecce 10-12 novembre 1994, J.-R. Armogathe- G.Belgioioso edd., Napoli, Vivarium, 531-75. La prosa diC. in latino e in francese, i suoi rapporti con laretorica e la poetica del tempo, ma anche la suaattenzione alla dimensione utopica per cui egli"preferirebbe esprimersi in una lingua-segno o linguanumero" (540).
Lojacono, Ettore (1996) B, "Epistemologia, metodo eprocedimenti metodici nel pensiero di R. Descartes", inCartesio, Tra utopia e realtà. Il progetto metodico di Descartes dalleRegulae al Discours ai Principia, E. Lojacono-D. Massaroedd., Napoli, Loffredo, 161-233. Traduzione del Dis.Méth., ampia selezione di altri testi, lessico ebibliografia. Oltre a Dis. Méth. TC: Mon. AT XI 20 - L.Mor. 13 7 1638 AT II 198, 200-202.
Mainguenau, Dominique (1996), "Ethos et argumentationphilosophique. Le cas du Discours de la méthode", in: Descarteset l'argumentation philosophique, F. Cossutta, ed., Paris,PUF, 85-110. C non è direttamente "confronté à lalangue mais a l'intéraction des variétés langagières".Ogni filosofo costruisce un proprio code langagier, C.approda ad una sorta di hyperlangue di hypotaxe méthodique
170
de la pensée che si svolge nelle "longues chaînes deraisons" del Dis. Méth. (102-3).
Meyer, Michel (1996), "The Problematological Interpretation ofthe Cogito. Is there a Distintive Argumentative Structure in theMeditations?", Revue internationale de philosophie, vol. 50, n.195, 1, 23-49. Il linguaggio non è tra gli elementi cuiC. applica il dubbio.
Pradhan, R. C. (1996), "Descartes and Wittgenstein: TwoPhilosophical Models of Mind", Indian Philosophical Quarterly,23, n. 1-2, 119-40. C. e Wittgenstein condividono laconvinzione che la mente sia ontologicamente unelemento costitutivo della realtà, ma per C. la mente èindipendente dal mondo e dal linguaggio, mentre perWittgenstein c'è continuità tra mente, mondo elinguaggio.
Pauli, Evaldo, (1996), "Kartezio: Universala linvo", Simpozio,27, 43-44.Rodis-Lewis, Geneviève (1996), "L'âme et le corps chez
Descartes et ses successeurs: la naissance del'occasionalisme", Les études philosophiques, n. 3, oct.-déc., 437-52. Il problema dell'unione dell'anima colcorpo e la sua discussione tra i successori di C. farisaltare la centralità del linguaggio benchè nè C., nèCordemoy, abbiano tratto da ciò tutte le conseguenze.
Salmon, Vivian (1996), The Universal Language Problem, in:Sprachphilosophie, 2 Halbband, M. Dascal- D. Gerhardes- K.Lorenz- G. Meggle edd., Berlin-New York, De Gruyter,916-28. Discute la L. Mer. 20 11 1629 T 5.
Tanigawa, Takako (1996), "La raison ou l'argumentation chezDescartes selon un point de vue japonais", Il cannocchiale,n. 1-2, gennaio-agosto, 277-80. Anche per chi parla unalingua in cui il verbo essere o il pronome io sonointraducibili, C. appare come colui che ha reimpostatodalle fondamenta il pensiero tentando di tradurre nellinguaggio ordinario i principi del suo metodo e delsuo sistema.
Roberto Bordoli ed. (1997), René Descartes-Henricus Regius, Ilcarteggio. Le polemiche, Napoli Cronopio.
Devlin, Keith (1997), Goodbye, Descartes: The End of Logic and the Searchfor a New Cosmology of the Mind, New York, John Wiley & Sons;
171
trad. it. Addio Cartesio. La fine della logica e la ricerca di una nuovacosmologia della mente, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.Cartesio (assieme ai suoi contemporanei Galilei,Leibniz ecc.) ha fissato una volta per tutte la naturadell'indagine scientifica: oggettività, distacco,razionalità, indipendenza dal contesto. Si tratta di unparadigma attivo in Boole, Turing, Chomsky ed oltre,ma, secondo D., un nuovo paradigma emergente metterebbein crisi l'applicazione di queste caratteristicheall'indagine scientifica della percezione, dellinguaggio e della mente.
Dickson, William- J. (1997), "Descartes: Language and Method",Seventeenth Century French Sutudies, 19, 61-72.
Novack, Peter (1997), Mental Symbols. A Defense of the Classical Theory ofMind, Dordrecht/Boston/London, Kluwer AcademicPublishers. C. è stato uno dei primi a notare comel'uso delle parole sia indipendente dagli stimoli,anche se tale meccanismo può funzionarenell'acquisizione del linguaggio. TC: Dis. Méth. V T11.
Pala, Alberto (1997), Letture cartesiane, Milano, Franco Angeli. Ilrinnovamento del linguaggio della scolastica è unodegli snodi fondamentali del pensiero filosofico edella epistemologia di C..
Swiggers, Pierre (1997), Histoire de la pensée linguistique, Paris, PUF.Il concetto di 'metodo' è uno degli apporti scientificipiù rilevanti di C. anche sul piano linguistico, comedimostra l'uso che ne viene fatto nelle grammatiche apartire da quella di Port Royal.
Bonicalzi, Francesca (1998), A tempo e luogo. L'infanzia e l'inconscio inDescartes, Milano, Jaca Book. Il linguaggio è la chiavedi volta della definizione del pensiero cartesiano.
J.-R. Armogathe- G. Belgioioso, C. Vinti edd. (1999), Labiografia intellettuale di René Descartes attraverso la Correspondance,Atti del Convegno 'Descartes et l'Europe savante' Perugia, ottobre 1996,Napoli, Vivarium. Molti dei contributi presenti nelvolume offrono interessanti osservazioni sul lessicocartesiano così come emerge dalle lettere.
Armogathe, Jean-Robert (1999), "L'approche lexicologique enhistoire de la philosophie", in Il vocabolario della République
172
des lettres. Terminologia filosofica e storia della filosofia problemi dimetodo. Atti del convegno internazionale in memoriam di Paul Dibon,Napoli 17-18 maggio 1996, M. Fattori ed., Firenze, Olschki,57-68. Importanti precisazioni sul lessico e lascrittura filosofica di Cartesio che si costruisconoper differenza rispetto alla terminologia a suadisposizione.
173
Indice dei nomiUna I indica i testi citati nelle note dell'introduzione una Tquelli citati nelle note ai testi.Aarsleff, Hans 1970, 1971, 1982, 1993, 1996Adams, R. M. 1975Alanen, Lilli 1992Alquié, Ferdinand (1906-1985) 19501, 19914, 1960Apel, Karl Otto 1963Arduini, Stefano 1984Armogathe, Jean - Robert, 1999, ed., 1999Auroux, Sylvain 1979, 1992, 1993Avramides, Anita 1996Barret, William 1987Bartlett, B. E. 1987Bakalar, H. Nicholas 1976Belgioioso, Giulia ed. 1999Bennet Johnathan 1993-94Bitbol-Esperies, A. 1991Beyssade, Jean-Marie 1981, 1995Beyssade, Michelle 1994Bineham, Jeffrey L. 1994Boboc, A. 1990Bonicalzi, Francesca 1987, 1990 A, 1990 B, 1990 C, 1996, 1998.Bono, James J. 1995Bordron, Jean-François 1987Borgmann, Albert, 1974Bossong, G. 1979Bouvier, Alban 1995Bouveresse, Jacques 1979, 1983Bouwsma, O. K. 1982Bracken, Harry M. 1970, 1972, 1984Brissoni, A. 1981Brunot, Ferdinand 1966-72Buczynska Garewicz, H. 1979, 1984Burkhardt, Hans 1988Buroken, Jill Vance 1996Cahné, Pierre-Alain 1978, 1980Cantelli, Gianfranco 1991, 1992, 1996Canziani, Guido 1990Carr, Thomas M. 1990
174
Cavaillé, Jean-Pierre 1990, 1991 A, 1991 BChandler, Hugh 1987Chevalley de Buzon, Catherine 1979Chomsky, Noam 1966, 1988, 1992, 1993Chouillet, Jacques (1915-1990) 1972Cohen Rosenfield, Leonora 19401 19682 enl.Conant, James 1992Coseriu, Eugenio 19701, 19752Cossutta, Frédéric 1996Costabel, Pierre 1982Cottingham, John 1978Couturat, Louis (1868-1914) 1903Crapulli, Giovanni 1969Croce, Benedetto (1866-1952) 1905Dascal, Marcelo 1975, 1978, 1996De Buzon, Frédéric 1992Derrida, Jacques 1984Devlin, Keith 1997De Zilah, E. 1983Di Caro, Alessandro 1976Dickson, William J. 1997Dienes, Otto 1984De Mauro, Tullio 19651, 19893Dominicy, Marc 1984, 1992Donzé, Roland 1967, 19712 rev.Dostert, L. 1972Drach, Margareth 1981Droixhe, Daniel 1978, 1996Drozdowicz, Z. 1989Duddy, Thomas 1995Eco, Umberto 1993, 1995Fattori, Marta e Bianchi M. 1979Fichant, Michel 1993Foucault, Michel (Paul) (1926-84)1966France, Peter 1972Gallotti, Cecilia 1993Gensini, Stefano 1991Giancotti Boscherini, Emilia 1969Gilson, Etienne (1884-1978) 1969
175
Giordano, Maria 1980Gola, Elisabetta 1995Gontier, Thierry 1991Gomilla Benejam, Antoni, 1996Gozzano, Simone 1994Guenancia, Pierre 1990, 1993Guerini, L. 1993Gouhier, Henri 1926Gunderson, Keith 1964Gusdorf, Georges 1973Harnois, Guy 1929Henze Donald F. 1972Hintikka, Jaako, 1962 1996Ishiguro, Hidé 1996Israël, B. M. ed., 1974Joly, André 1972, 1977, 1985, 1986Judovitz, Dalia 1996Katz, Jerrold J. 1986, 1990Kenny, Anthony 1983Kearns, John T. 1996Kopania, Jerzy 1986, 1987, 1990, 1991Land, Stephen K. 1974Lakoff, Robin 1969Leau, Léopold (1868-1943) 1903Lefèvre, Roger 1958, 1965Leiber, Justin 1988Lojacono, Ettore 1991, 1996 A, 1996 BMainguenau, Dominique 1996Manjali, F. D. 1990Marion, Jean Luc 1973, 1976, 19811 19912Matthews, Gareth B. 1986Meisel, Jürgen M. 1974Meyer, Michel 1996Miel, Jan 1969Miers, Paul 1995Migliorini, Bruno (1896-1975) 1929Miwa, M. 1988Mortureux, M. F. 1973Mounin, George (1910-1993) 1967Mouy, Paul 1934
176
Normore, Calvin 1986Novack, Peter 1997Olgiati, Francesco (1886-1962) 1937Pala, Alberto 1990, 1997Pariente, Jean-Claude 1985, 1987Pauli, Evaldo 1996Pécharman, Martine 1995Pellerey, Roberto 1992Percival, W. Keith 1972Picardi, Eva 1976, 1992Piattelli-Palmarini, Massimo 1979Pierssens, Michel 1976Pochtar, Ricardo 1976Pomian, K. 1983Porset, Charles 1975Pradhan, R. C. 1996Proust, Joelle 1992Rey, Alain 1973-76Reiss, T. J. 1982Ricken, Ulrich 1972, 1978, 1981, 1990Robinet, André 1970, 1978Robins, Robert Henry 19671, 19792, 19903Rodis Lewis, Geneviève 1964, 1966, 1990, 1996Romanowski, Sylvie 1974Rooryck, Johan 1986Rosiello, Luigi (1930-93) 1967, 1988Rosnerova, H. 1973Ross, George Mac Donald 1988Rossi, Paolo 1960 poi 1977, 19601, 19832, 1968, 1989Rudolph, K. 1993Ryle, Gilbert (1900-1976) 1949Sahlin, Gunvor 1928Salmon, Vivian 1969, 1996Sencerz, S. 1990Séris, Jean Pierre (1941-1995) 1993, 1995Shea, William R. 1991Sievert Don 1992Simone, Raffaele 1969, 1990, 1995Specht, E. K., Erichsen, N., Schttauf, K. 1989
177
Sullivan, John J. 1990Swiggers, Pierre 1984, 1997Tanigawa, Takako 1995, 1996Thomas, Jean-Jacques 1984Thomson, Anne 1988Tagliagambe, Silvano 1980Tassi, Aldo 1982Trabant, Jürgen 1994Uitti, Karl D. 1970, 1990Van De Pitte, Frederick P. 1975Vartanian, Aram 1953Vendler, Zeno 1972Verbeek, Theo 1993Verburg, Pieter Adrianus (1905-89) 1968Verhar, J. W. M. 1971Villanueva, E. 1976Vinti, Carlo ed., 1999Voss, J. 1973Wilson Dauler, Margaret 1978Wokler, Robert 1980Yaguello, Marina 1984Yarvin, Herb 1975-77Zimmer, Karl E. 1968Wittgenstein, Ludwig 1953AA. VV., 1967-68
178
Armogathe, Jean- Robert 1976 T 2, 1977 IArnauld, Antoine 1693, 1775-1783 IBaillet, Adrien 1691 IBaltrusaitis, Jurgis 1955 trad. it. 1978 IBarone Francesco 19681, 1992 T 5Belgioioso, Giulia 1998 IBloch Olivier 1980 IBordoli, Roberto 1977 T 17Bortolotti, Arrigo 1983 IBove, Laurent 1991 ICahné, Pierre A. 1977 T 11Chappel, Vera 1987 ICouturat, Louis 1903 T 5Crapulli, Giovanni 1966 T Regulae, 1969 I, 1976 T 2, 1988 ICottingham, John 1993 ICurley, E. M., 1973 IDamasio, Antonio R. 1994, trad. it. 1995 IDemonet, Marie-Luce 1992 IDoney, Willis 1987 IEdelman, G. M. 1992, trad. it. 1993 IFodor, Jerry A. 1983, trad. it. 1988 IGabbey, A 1983 IGambarara, Daniele 1995 IGarin, Eugenio 1984 IGilson, Etienne 1925 T 11Hall S. 1972 T 10Harding, J., 1973 IKippe, D., 1973 ILachièze-Réy, Pierre 1950 ILakoff, G. 1987 ILanducci, Sergio 1986, 1992 ILeibniz, Gottfried Wilhelm 19681, 1992 T 5Lojacono, Ettore 1994 I,Marion, Jean-Luc, 1976 T 2, et alii 1983 IMorris, John M. 1971 IScribano, Maria Emanuela 1988 ISebba, Gregor 1964 ISpallanzani, Mariafranca 1990 I
179