Metafore vi(si)ve. I limiti del linguaggio figurato nel linguaggio figurativo
Filosofia del linguaggio Pragmatica cognitiva I meccanismi della comunicazione
Transcript of Filosofia del linguaggio Pragmatica cognitiva I meccanismi della comunicazione
Filosofia del linguaggioPragmatica cognitiva
I meccanismi della comunicazioneClaudia Bianchi
Capitolo 1 - L’eredità di Gricecomunicare significa esprimere intenzioni o stati mentali e , per chi ascolta, riconoscere intenzioni o stati mentali. In unmodello inferenziale come quello proposto da Grice, gli enunciati sono indizi forniti da chi parla sul messaggio cheintende comunicare. Il significato è una questione di riconoscimento di intenzioni.
I filosofi del linguaggio ordinarioimplicatura Frase Enunciato GRICE propone 3 idee guida Significato comeintenzionePrincipio di cooperazione e massime conversazionaliImplicatura
Capitolo 2 - Dopo Grice: una mappa - neo-griceani e post-griceaniNeo-griceriani e post-griceani: teorici della pertinenza, contestualisti, quasi-contestualisti. La riflessione di Grice è strettamentefilosofica. Il progetto neo-griceano appartiene piuttosto al campo della linguistica. La proposta post-griceana si caratterizza fortementein senso cognitivo.
Grice: esplicito e implicitoSemantica tradizionale: letteralismoNeo-griceani LEVINSON ed euristiche (QI M)
Capitolo 3 - La teoria della pertinenza (RT) - Post griceani Si occupa della prospettiva più innovativa: la teoria della pertinenza, per spiegare i processi di produzione e comprensione linguisticainserendoli in un resoconto plausibile non solo dal punto di vista teorico ma anche da quello empirico.
Sperber, WilsonLe aspettative che orientano i processi interpretativi: lapertinenza. Pertinenza e cognizionePrincipio cognitivo di pertinenzaPertinenza e comunicazione - Comunicazione e -referenzialePrincipio comunicativo di pertinenzaTre strategie interpretativeConcetti ad hoc: pragmatica lessicaleNARROWING BROADENINGProcessi di modulazione lessicale: inferenziali (si) o associativi(no perché RT rifiuta un po’)
Natura dei processi inferenziali : modularità Grice: letturadella mente Autismo e teoria della mente Un sotto-modulodedicato per la comunicazione
Capitolo 4 (dal capitolo 2) - I confini della pragmaticaLa contrapposizione fra i 2 modelli comunicativi conduce a riflettere sul ruolo svolto, nell’interpretazione delle nostre mosselinguistiche, rispettivamente dalla conoscenza del linguaggio.
Due modelli comunicativi: del codice – inferenziale1Minimalismo = letteralismo2Indicalismo3Prospettiva sincretica (eredi di Grice) o intermedia 4Contestualismo di Kent BACHObiezioni ai 4 punti
La pragmatica cognitiva è una disciplina empirica, che eredita imetodi della psicologia cognitiva; ma una disciplina che ha solideorigini filosofiche, dovuta in larga misura a GRICE.
Capitolo 1 - L’eredità di GriceLe teorie di Grice costituiscono un riferimento per filosofia dellinguaggio, e anche filosofia della mente, linguistica, analisidel discorso, semiotica, scienze cognitive. La sua opera puòessere situata all’origine del filone cognitivo in pragmatica.L’opera griceana è caratterizzata da:
ciò che un’espressione E significa; ciò che un parlante P dice esplicitamente usando
l’espressione E in una certa occasione; ciò che un parlante P lascia intendere implicitamente usando
l’espressione E in quella certa occasione.I filosofi del linguaggio ordinarioPur mantenendo l’idea della centralità dell’uso, GRICE afferma cheè necessario distinguere elementi dell’uso del linguaggio edelementi dovuti a fattori dell’interazione comunicativa. Nonbisogna però confondere enunciati inappropriati perché falsi.
Grice riconosce che sarebbe strano asserire X mi sembra rosso se nonci fossero dubbi sul colore di X.Fra sostenitori di una semantica formale (filosofi del linguaggioideale) e teorici dell’uso (filosofi del linguaggio ordinario),Grice si propone di riconciliare i 2 campi.Allora cruciale è la distinzione fra conseguenza logica eimplicatura, fra ciò che viene lasciato intendere implicitamentedall’uso.Frase = è per Grice un oggetto astratto con proprietà fonologiche,morfologiche, sintattiche e semantiche assegnate dalla grammaticadel linguaggio;Enunciato = è un oggetto concreto, localizzato nello spazio e neltempo, usato in uno scambio comunicativo. Nella comunicazione sono dunque coinvolte sia proprietàlinguistiche sia proprietà non linguistiche: il nucleo dellateoria griceana è mostrare come esse interagiscono. La riflessionecontemporanea sul linguaggio di GRICE propone 3 idee guida:1 Significato come
intenzioneLa comunicazione èespressione ericonoscimento diintenzioni, indiziofornitointenzionalmente.
2 Principio dicooperazione e
massimeconversazionali
L’enunciato soddisficerti standard (=informativo, sincero,pertinente e chiaro),l’aspettativa deldestinatario
3 ImplicaturaUn parlante comunica ciòche dice esplicitamente eciò che veicolaimplicitamente.Distinzione tra esplicitoe implicito.
1 Comunicare significa esprimere intenzioni o stati mentali. Quello che contaè il riconoscimento da parte di D dell’intenzione comunicativa di P. Siattribuisce a Grice un vero e proprio progetto riduzionista.Grice opera una distinzione tra:1.significato dell’espressione, essa viene usata in un certo modo. Quello chele parole significano è questione di quello che la gente intende con esse. Neitermini cioè di intenzioni, credenze, desideri. Supponiamo si dica: IL TRENO E’IN RITARDO, con un’altra espressione : SONO GIA’ LE 8 e 40, chi ascolta conoscel’orario di arrivo previsto del treno. Questo significa che gli utenti di unlinguaggio hanno procedure standard per usare enunciati. P non ha alcunasperanza di essere compreso a meno che non le renda accessibili a D. E’ quiche entrano in gioco le conoscenze condivise.
2.significato del parlante, è l’intenzione comunicative: P ha l’intenzione cheil proferimento di E produca un certo effetto in D grazie al riconoscimento diquesta stessa intenzione, viene dunque inteso nei termini di un’intenzioneespressa in modo manifesto. ES: DOMANI SARA’ BELLO: l’effetto che produce è chechi parla pensa che domani sarà bello. L’effetto produce una credenza piùdebole: la credenza che P vuole che D pensi che P creda che domani farà bello.In questo quadro, pertanto, le intenzioni comunicative hanno la caratteristicadi essere:a.orientate verso il destinatario;b.aperte cioè manifeste e trasparenti;c.riflessive, essere riconosciute dal destinatario. Il 1° livello comunicativo è l’intenzione che D riconosca che E è statoprodotto con intenzione (uomo esce in frac e passante ne deduce che va a unballo). Il 2° livello informativo è l’intenzione di produrre in D la credenza di P,usando E. L’informazione intenzionale non manifesta (indurre qualcuno a pensarequalcosa) è l’es: l’assassino che lascia il fazzoletto di un altro sulla scena affinchè la polizia sospettiun altro: qui è info intenzionale, non comunicazione, in quanto l’assassino non vuole che la propriaintenzione info venga riconosciuta dalla polizia.Alcune obiezioni poste da Grice che non sembrano valere per tutti gli scambi linguistici. Problemagenerale della riduzione del significato. Che il parlante abbia certe intenzioni non è:a) né a condizione necessaria; ci sono infatti casi in cui P non ha alcunaintenzione di indurre D a condividere certe credenze. In altri casi non sembracorretto dire che P vuole che D si formi di una certa credenza, perché Dpossiede già quella certa credenza.b) né condizione sufficiente per essere compreso a meno che non renda pubblichele proprie intenzioni.
2 L’uso del linguaggio è una forma di comportamento cooperativo razionale, lenostre conversazioni richiedono un livello elevato di coordinazione.Conversare è agire in collaborazione con qualcuno. La conversazione è alloraun’attività: RazionaleCollaborativa Finalizzata a uno scopo.P e D, condividono uno scopo minimale anche se “i loro scopi ultimi possononaturalmente essere indipendenti e persino in conflitto fra loro. Il principiodi cooperazione si declina in 4 gruppi di massime che prendono il nome di:QUANTITA’- (informativo):1.dà un contributo tanto informativo quanto richiesto;2.non dare più di quanto richiesto.QUALITA’ – (plausibile), l’aspettativa di essere sincero. Cerca di dare uncontributo che sia vero, e le 2 sottomassime:1-non dire ciò che credi essere falso2-non dire ciò per cui non hai prove adeguate.RELAZIONE – (pertinente)
MODO – (appropriato): evita ambiguità sii brevesii ordinato nell’esposizione-esprimiti in modo da facilitare la risposta appropriata.Grice: un comportamento sarà tanto più razionale quanto più si conforma aprincipio e massime, in cui concorrono interlocutori collaborativi e razionali,che condividono uno scopo comune, pur minimale, come quello di comprendere efarsi comprendere.Le diverse opzioni che ne scaturiscono:1.Un parlante può innanzitutto conformarsi al Principio di Cooperazione e allemassime, rispettarle tutte.2.P può violare una massima. La violazione più grave è la massima di Qualità,che rispecchia la nostra aspettativa che P comunichi solo informazioni cheritiene vere.3.Un parlante può anche uscire dal raggio d’azione di una massima, puòsospendere la collaborazione in modo esplicito (le mie labbra sono sigillate, nocomment) o in modo implicito. In questa categoria cadono giochi di parole,battute, barzellette. P potrebbe violare le massime e quindi si ha la prova chei parlanti sono consapevoli dell’esistenza di massime che regolano quantità,qualità, pertinenza e appropriatezza dell’informazione.4.Spesso può succedere che 2 massime entrino in conflitto, e P deve sceglieredi violarne una per non violarne un’altra.5. Il caso più interessante è quello in cui un parlante ‘si burla’ o sfruttauna massima: anche questi sono casi di violazione, aperta e manifesta.
3 Distinzione fra dire e implicare: spesso comunichiamo molto più di quantonon diciamo, esplicitamente o implicitamente. Grice chiama implicatureconversazionali ciò che non viene esplicitamente detto. Ciò che è detto per Grice è legato al significato convenzionale delle parole(l’enunciato) che ha proferito. Il livello di ciò che è detto è il livellovero-condizionale, valutabile come vero o falso.Ciò che P ha implicato proferendo E in quella occasione. Si suole distinguere 2 categorie di implicature:. standard: nel caso in cui P stia osservando le massime;. da sfruttamento: l’ipotesi che P stia violando intenzionalmente le massime.Le implicature sono inferenze non vero-condizionali. Per calcolareun’implicatura, dunque, D parte dal riconoscimento del significatodell’enunciato proferito da P, che ci si conformi al Principio di Cooperazionee alle massime e che le informazioni sono accessibili a P e D.Ancora tipi di implicature:a.convenzionali (ordinario, originale) - suggerisce che c’è una correlazione.Associate a determinate espressioni, come ‘ma’, ‘quindi’, ‘persino’, ‘nonancora’. -sono distaccabili: lo stesso contenuto può essere espresso in modo darimuovere l’inferenza. Ha le stesse condizioni di verità, ma non veicola lamedesima implicatura;
-non sono cancellabili: non è cioè possibile bloccare l’implicatura e vengonogenerate in tutti i contesti;-non sono calcolabili: sono colte intuitivamente da D;-non sono parte del significato delle espressioni, non modificano le condizionidi verità dell’enunciato.b.conversazionali:1.particolarizzate - Vengono generate solo in contesti particolariEs: Uno dice: Hai mai pensato di iscriverti al Partito Socialista? - E l’altro: No grazie, sono ricco di famiglia. Chi non sapesse molto dell’Italia di quei tempi potrebbe faticare ariconoscere l’implicatura veicolata. -Non sono distaccabili.-Sono cancellabili, esplicitamente o contestualmente.-Sono calcolabili, ma Grice non esclude che esse possano essere colteintuitivamente.2.generalizzate - dipendono dalle circostanze a) Non vengono generate in tutti i contesti.b) è cancellabile. La cancellazione può essere esplicita, come in HA UNAPPUNTAMENTO CON UNA DONNA STASERA: SUA MOGLIE. Semplice, chiara e ordinatanell’esposizione e che non si dica più del necessario.La critica di Grice porta anche a termini di ambiguità delle espressionicoinvolte.Marge si è sposata e ha avuto un bambino, ma non so in che ordine si sono prodotti i 2 eventi.L’implicatura di sequenza temporale viene generata anche in assenza di “e”, sec’è un segno di interpunzione. Marge si è sposata. Ha avuto un bambino.Implicature scalari. Fra le implicature generalizzate derivate dall’aspettativadel rispetto da parte di P della prima massima di Quantità.ALCUNI POLITICI SONO ONESTI, chi parla veicola implicitamente la proposizioneNON TUTTI I POLITICI SONO ONESTI. Le espressioni ‘tutti, la maggior parte, molti, alcuni, pochi’ sono poste suuna sorta di scala lessicale.Anche in questo caso si tratta di proposizioni in cui P invita D a derivare, apartire da ciò che P non ha detto.
Capitolo 2 - Dopo Grice: una mappa - neo-griceani e post-griceaniLe eredità da Grice trattano la distinzione fra esplicito (ciò cheè detto) e implicito (ciò che è implicato), messa in discussione.
GRICE filosofico Neo-griceani linguistico Post-griceani cognitivoIl progetto di Griceè strettamentefilosofico dellacomunicazione.
Levinson, Horn, Atlas inforte continuità con lateoria di Grice riguardoil Principio diCooperazione e massime
Teorici dellapertinenza (Sperber,Wilson, Carston) e vedeuna rottura netta con
Grice postulaprocessi inferenzialiper eliminareeventuali ambiguità.
conversazionali.Il progetto neo griceanoappartiene piuttosto alcampo della linguistica esi focalizza sugliaspetti stabili delsignificato.
il progetto di Griceriguardo il Principiodi Cooperazione emassimeconversazionali.-contestualisti(Recanati), -quasi contestualisti(Kent Bach).
Il punto di partenza è la distinzione griceana fra DIRE eIMPLICARE, esplicito e implicito.Semantica tradizionale: letteralismo (anche nel cap. 4).Le frasi di una lingua hanno condizioni di verità fisse. Quinditutti gli effetti sulle condizioni di verità devono esserericonducibili a elementi sintattici della frase.Il solo processo SEMANTICO (obbligatorio, che consentono dideterminare il livello della proposizione letteralmente espressada un enunciato) che i letteralisti ammettono è il processo disaturazione, innescato dalla presenza di particolari espressioni:indicali (IO, QUI, ORA), dimostrativi (QUESTO, QUELLO), pronomi(LUI; LEI), predicativi, tempi verbali.Ogni dipendenza contestuale deve essere riconducibile allapresenza di un deittico; in alcuni può essere attribuita allapresenza nella forma logica di una variabile nascosta.PIOVE: sarà vero se e solo se piove nel luogo a cui il parlanteintende riferirsi.NESSUNO MI AMA, c’è una variabile nascosta presente nella formalogica di NESSUNO RISPETTO AL DOMINIO X MI AMA.Nei processi pragmatici (facoltativi, che consentono diindividuare un livello di senso addizionale e implicito) abbiamoil processo di arricchimento libero in larga parte del linguaggionaturale.C’è DEL LATTE NEL FRIGO esprime una proposizione di per sé giàcompleta e valutabile.La determinazione del MODO o della FORMA in cui il latte è infrigo è un processo di arricchimento.
Poi i processi di transfert, che permettono di sostituireall’interpretazione letterale (la malattia) un’interpretazionemetonimica (il paziente affetto dalla malattia).E ancora le implicature conversazionali. Alla domanda PRENDIAMO UNCAFFE’, si risponda HO FATTO COLAZIONE. La prospettiva letteralista individua 3 livelli di senso:
1. significato convenzionale, che corrisponde a uno schema, adesso viene applicato il processo di saturazione che consentedi determinare la
2. proposizione espressa, una volta determinato il significatoletterale possono essere applicati i processi pragmatici diarricchimento e transfert, e vengono generate le implicatureconversazionali, viene cioè individuato il
3. senso implicito, ciò che è comunicato implicitamente dalparlante.
I neo-griceani oltre a condividire con Grice l’idea che lacomprensione sia parzialmente inferenziale che limita allacomunicazione implicita) pensano inferenze a livello esplicitodella comunicazione, di ‘ciò che è detto’. Secondo ATLAS, ‘ciò cheè detto’ è di solito meno informativo di ‘ciò che è comunicato’, edeve essere arricchito da inferenze conversazionali generalizzate.I neo-griceani ritengono che siano legittime 2 nozioni di ‘ciò cheè detto’:-una semantica -l’altra pragmatica.Allora 4 livelli di senso (vd prospettiva sincretica o intermedia cap. 4):
1. significato convenzionale (X MANGIA ALCUNI TIPI DI CARNE). Adesso si applica il processo di saturazione che permette diottenere la
2. proposizione minimale o ‘ciò che è detto’ in senso semantico.In seguito ottiene la
3. proposizione massimale o ‘ciò che è detto’ in sensopragmatico. Si deriva infine il
4. senso implicito.Secondo i neo-griceani le massime griceane sono inadeguate dalpunto di vista descrittivo ed esplicativo, dal momento che incerti casi non sono intuitivamente intese dal parlante.LEVINSON propone di sostituire le massime griceane con 3euristiche (Q I M) regolate da un preciso ordine di priorità:
Q>M>I per evitare conflitti. Quindi Q e M hanno la megliosull’euristica I. Esse permettono di arricchire il contenuto di unenunciato secondo direzioni standard. Le euristiche hanno 2prospettive ciascuna: la prospettiva orientata al parlante e laprospettiva orientata al destinatario. Abbiamo innanzitutto la:-Euristica Q orientata al parlante: “Non fornire enunciato più debole diquello permesso dalla conoscenza”;-Euristica Q orientata al destinatario: “Ciò che non è detto non èavvenuto” (1° mass di qual di Grice);-Euristica I orientata al parlante: “Produci l’info linguistica suff asoddisfare i tuoi scopi comunicativi”;-Euristica I orientata al destinatario: “Ciò che è detto in modo nonmarcato è una situazione stereotipica” (2° mass di Quanti (non dare un contributo piùinformativo di quanto richiesto); l’euristica I legittima l’interpretazionedi espressioni brevi e semplici.-Euristica M orientata al parlante: Indica una situazione anormale usandoespressioni marcate che contrastano con quelle che useresti per indicare lasituazione normale.-Euristica M orientata al destinatario: Ciò che è detto in modo marcatorappresenta una situazione anormale (massime di Modo: se P utilizza un’espressione
inconsueta è perché ha un buon motivo per farlo). ES.: HOMER HA CAUSATO L’ARRESTODELLA MACCHINA laddove potrebbe usare HOMER HA FERMATO LAMACCHINA. HORN propone 2 principi simmetrici (che rispecchiano alcunemassime di Grice):Principio Q, minimizzare lo sforzo del destinatario, “Fornisci uncontributo sufficiente, anzi dì quanto più puoi, pur nel rispettodi R”. Principio R, minimizzare lo sforzo del parlante, “Fornisci uncontributo necessario: non dire più di quanto devi. Da questoesempio: PUOI PASSARMI IL SALE? = non come domanda sulle capacitàmotorie dell’interlocutore, ma come richiesta (indiretta), ilprincipio R genera anche il fenomeno detto della ‘perfezione delcondizionale’.Riguardo la tendenza dei parlanti a “perfezionare un condizionale”(CP), sono state indicate 3 strategie possibili di trattamento:Connettivo SE, l’interpretazione condizionale (SE) el’interpretazione bicondizionale (SE E SOLO SE).
Le inferenze sono il risultato di osservazioni induttive su come vannotipicamente le cose in una certa società o comunità (contro la teoria griceanasulle letture temporali e causali della congiunzione): ABBIAMO CONSUMATO UNPASTO ABBONDANTE E SIAMO CADUTI IN UN SONNO PROFONDO.E come E DOPO e anche come E DI CONSEGUENZA sono, per Grice, GCI (implicatureconversazionali generalizzate), dunque sistematiche ma cancellabili. Anche ineo-griceani sottolineano il legame fra CP e le fallacie logiche: la fallaciadell’affermazione del conseguente e la fallacia della negazionedell’antecedente.SE LA STRADA è BAGNATA ALLORA PIOVELa pioggia è un condizionale sufficiente perché la strada sia bagnata, ma la strada potrebbe esserebagnata per altri motivi, perché hanno lavato le strade o innaffiato fiori. La motivazione di CP è:le strade non sono sempre bagnate perché ha piovuto, ma DI SOLITO lo sono. Il ragionamento èlogicamente fallace, ma in un’induzione pratica si tratta di un passo razionale. Come scrive HORN:stipulando che P è una condizione sufficiente per Q, suggeriamo implicitamente che P è anche unacondizione necessaria, altrimenti perché menzionarla?
Infine alcuni tipi di condizionale sottolineati da Austin, oltre acomune linguaggio come Ci sono dei biscotti nella credenza, se ne vuoi e Se haisete c’è della birra nel frigo, dal New York Times: Signore, se avete bisogno diqualcosa, sono Nick, risposta: E se non abbiamo bisogno di nulla, chi sei ?HORN cita: Un altro movimento e sparo. Ti sparo SE E SOLO SE fai unaltro movimento. Capitolo 3 - La teoria della pertinenza (RT) - Post griceani (sicaratterizza in senso cognitivo, processi mentali sotto flussolinguistico): Sperber, Wilson. Oggi la prospettiva più innovativa e completa sulla natura dellacomunicazione, che si lega a cognizione e architettura dellamente. Riconoscono che La comprensione è un processo di riconoscimento delleintenzioni comunicative del parlante (per via inferenziale); Il destinatario viene guidato nelprocesso di comprensione da certe aspettative.Per RT come per Grice, la comunicazione è produzione di indizi,indizio del senso che intende comunicare. Per quanto riguarda Estensione del modello inferenzialeGrice postula processiinferenziali solo per lacomunicazione implicita
Per RT invece anche il livelloesplicito è largamente sotto-determinato dal significato codificatoe integrato grazie a processipragmatici (posizione CONTESTUALISTA)
Gli atti comunicativi sono azioni apertamente intese ad attirarel’attenzione di D e veicolare un contenuto. Essi vengono prodottida un agente intenzionale che rende manifesta la propriaintenzione di fornire informazione pertinente.
Le aspettative che orientano i processi interpretativi: lapertinenza. Pertinenza e cognizione.Gli esseri umani sono in grado di costruire ed elaborarerappresentazioni di oggetti e di stati di cose. Di attribuire ailoro simili credenze, desideri, speranze, paure. La capacità dimetarappresentazione è alla base del senso comune. Dice SPERBER:siamo psicologi spontanei e la nostra mente ci permette di leggerela mente degli altri. La Teoria della mente: di cui si riconoscono la teoria dellasimulazione cioè mettersi nei panni dell’agente il cui comportamento è da simulare, e lateoria della teoria cioè ogni essere umano dispone di un corpus di conoscenze specifiche,funzionali all’attribuzione di stati mentali a se stesso e agli altri, di questa teoria abbiamola variante modularista secondo cui possediamo un modulo innato con fasi di sviluppo).Di conseguenza riusciamo a identificare intenzioni comunicativeall’interlocutore, quindi si tratta di una meta rappresentazione,che ci permette di fare previsioni sul comportamento del soggetto.L’esempio di SPERBER: S che scocca una freccia e uccide un cervo ne inferiamo che Savesse l’intenzione di uccidere il cervo. UN comportamento può non riuscire a produrrel’effetto inteso, e, dall’altro, produrre effetti non previsti o intesi. Comunque si consideranole circostanze.! Per i teorici della pertinenza la comunicazione è un effettosecondario della capacità di meta rappresentazione !In BART HA MAL DI DENTI abbiamo:caso 1: Bart vuole agire sul suo stato mentale di Margecaso 2: Marge gli vede portare una mano sulla guancia (non staancora comunicando la frase)caso 3: con aria dolorante vuole che Marge sappia e qui ècomunicazione verbale.SPERBER sottolinea i diversi livelli di metarappresentazione:-di 1° livello: avere un’intenzione informativa;-di 2° livello: riconoscere che qualcuno ha un’intenzioneinformativa;-di 3° livello: attribuire a qualcuno un’intenzione comunicativa.Gran parte dell’attività cognitiva degli esseri umani è impegnataa elaborare informazione. Gli esseri umani sono capaci dimonitorare una vasta gamma di stimoli, immagazzinare unasconfinata mole di dati e di concentrare l’elaborazione solo suuna quantità limitata di informazione.
Questo è il collo di bottiglia attenzionale: regolare e stabiliredelle priorità nel flusso dell’informazione. Cosa rendel’informazione degna di attenzione, SPERBER e WILSON fornisconouna risposta basata su:Principio cognitivo di pertinenza. La pertinenza è una proprietàdegli input dei processi cognitivi, siano essi stimoli esterni(proferimenti, azioni) o rappresentazioni interne (pensieri,ricordi, inferenze). ! Ogni elaborazione di uno stimolo ha un costo cognitivo (intermini di tempo, percezione); il costo si giustifica con glieffetti cognitivi ottenuti (modifiche della rappresentazione delmondo). Maggiori sono gli effetti cognitivi, maggiore sarà lapertinenza; maggiori sono i costi di elaborazione, minore sarà lapertinenza !Alcune critiche all’analisi proposta da RT:1° concentrarsi sugli effetti in termini informativi o cognitivi,senza considerare altri tipi di benefici, sociali, che sonocruciali nelle nostre interazioni comunicative.2° la difficoltà di misurare la pertinenza degli stimoli che RTcaratterizza in termini comparativi. Pertinenza e comunicazione - Il nostro sistema cognitivo si èsviluppato in modo tale che tende a collegare gli stimolipertinenti e attivare assunzioni pertinenti ed elaborare glistimoli nel modo più produttivo.RT riprende la distinzione griceana fra 2 livelli di intenzione:
a) Intenzione informativa b) Intenzionecomunicativa.
Naturalmente la comunicazione non verbale presenta dei limiti: innanzitutto è tipicamente piuttosto vaga, fraintesa; inoltre essa puòveicolare solo un insieme ristretto di significati. La comunicazione verbale permette una comunicazione infinitamente più ricca, esplicitae sfumata.
Principio comunicativo di pertinenza - Base del 2° principio dipertinenza - Un comportamento comunicativo suscita aspettativedi pertinenza ottimale, tanto da guidare D nel riconoscimentodell’intenzione comunicativa di P. La differenza con il Principio di Cooperazionee le massime griceane è netta.
I parlanti non possono violare il principio di pertinenza, nemmenovolendo, e non si può neppure dire che lo rispettino. La procedura dicomprensione sarà quella di seguire un percorso di minimo sforzo, Dsceglie l’interpretazione più accessibile. E poi di fermarsi
quando arriva a un’interpretazione che soddisfa le sue aspettativedi pertinenza. ES.: Si chiede “Possiamo confidare nel fatto che Lisa facciaquello che le abbiamo detto e difenda gli interessi del Dipartimento in Facoltà?” e larisposta “Lisa è un soldato!”. Una volta soddisfatte le sue aspettativedi pertinenza non prenede nemmeno in considerazione le altreimplicazioni.Un buon parlante non dice troppo. È più economico usare un pronomeE’ STATO LUI piuttosto che E’ STATO LUIGI.Tre strategie interpretativeÈ interessante il CASO DEL SILENZIO: -se supponiamo che egli voglia rispondere dobbiamo supporre chenon sia in grado di farlo; -se invece supponiamo che sia in grado di farlo, dobbiamo supporreche non voglia farlo. Per Grice, invece, il silenzio implica sempre che non è in grado di essere tanto informativo quantorichiesto (violando la Massima di Quantità.
1. In una strategia di ottimismo ingenuo, D assume che P siainsieme benevolo e competente. D assumerà pertanto chel’informazione veicolata da P sia abbastanza pertinente dameritare la sua attenzione.
2. Strategia di ottimismo prudente e assumere che P sia sìbenevolo, collaborativo, ma non necessariamente competente.
3. Strategia di comprensione sofisticata: D assumerà che Pvoglia sembrare competente e benevolo. Per RT la cooperazione non èessenziale alla comunicazione.
Ogni altra forma di arricchimento del contenuto di una frase è sì opera di processi inferenziali,che vanno però a costituire un ULTERIORE livello di senso pragmatico e non più semantico: il sensoIMPLICITO. Per quanto riguarda il livello esplicito, Grice può essere considerato a tutti gli
effetti un TEORICO DEL MODELLO DEL CODICE. RT si oppone con vigore al modello del codice. Integrareil modello del codice per eludere le obiezioni che si concentrano sugli aspetti figurati, estesi oimpliciti della comunicazione.
OBIEZIONI di RT alla revisione proposta da Grice:1ª obiezione – In una prospettiva griceana, un processoinferenziale sembra ammissibile solo se P e D condividono lepremesse dell’inferenza. 2ª obiezione – Non è necessario ipotizzare che P e D condividanoalcuna assunzione contestuale PRIMA del proferimento di E. Siparlerà non di condivisione, ma di COSTRUZIONE di un contestocondiviso.
3ª obiezione – In una prospettiva griceana, un processoinferenziale sembra garantito o giustificato solo se P e Dcondividono le premesse dell’inferenza.Esplicature e implicature al centro della RT - Per decodificareil significato linguistico, arricchirlo a livello esplicito ederivare l’eventuale senso implicito si considerano 3 processi:
a) Costruzione di ipotesi sul contenuto esplicito (che prende ilnome di esplicatura) attraverso processi di decodifica,determinazione dei riferimenti e arricchimento;
b) Costruzione di ipotesi (premesse implicitate);c) Costruzione di ipotesi sulle implicazioni (conclusioni
implicitate).Es: TI PIACE HOMER ? – Risposta: NON MI PIACCIONO I FANNULLONI =risposta indiretta e invita a derivare un’implicatura. Quando ilprocesso di recupero avviene ON –LINE, mentre cioè il proferimentoè ancora in corso, é in parallelo.Nella prospettiva pertinentista, l’interpretazione lessicalecomporta allora la costruzione, a partire dai concetti codificati,di concetti ad hoc o concetti occasionali, costruitespontaneamente da un soggetto per portare a termine uno scopoparticolare in una situazione particolare, un’occasione, ecostruite spontaneamente in quanto non sono immagazzinate nellamemoria a lungo termine ma vengono nell’occasione particolare. Unconcetto lessicale attiva proprietà che RT definisce logiche e cheprende il nome di pragmatica lessicale.La costruzione dei concetti ad hoc avviene grazie a 2 processicomplementari di NARROWING e BROADENING e avviene a livellodell’esplicito.NARROWING (restringimento) Una parola viene usata per veicolare unsenso più specifico rispetto a quello codificato. ES: A MOLTIFILOSOFI PIACE BERE viene generalmente interpretato come A MOLTIFILOSOFI PIACE BERE BEVANDE ALCOLICHE: il concetto lessicale BEREdeve essere ristretto alle bevande alcoliche.BROADENING viene usata per veicolare un senso (o concetto) più generale. QUESTO TAVOLO E’ RETTANGOLARE, si suppone lo sia approssimativamente. Esempi diusi “loose” (loosening - allargamento). Le metafore sonosempre frutto di broadening.LISA E’ UN CARRO ARMATO = che non guarda in faccia nessuno
HOMER E’ UN ELEFANTE = non ha tatto, è in sovrappeso.Nei casi di estensione categoriale il nome di una marca viene utilizzato perriferirsi a oggetti che condividono alcune proprietà rilevanti. Ne sono esempioenunciati come: HO BISOGNO DI UN’ASPIRINA = a un qualunque antidolorificoHO FINITO I KLEENEX = a un qualunque fazzoletto di carta.Ci sono infine i neologismi, come in inglese, dove è pratica frequente la creazione, a partire daun nome proprio o comune, del verbo corrispondente.
I 2 processi di narrowing e broadening vengono consideratisostanzialmente UN UNICO PROCESSO di rafforzamento o selezione dialcune informazioni.Livello esplicito –Per RT il livello esplicito è largamente sotto-determinato dal significato codificato linguisticamente: è laposizione contestualista.Per RT TUTTI i processi pragmatici, sia a livello esplicito, sia alivello implicito, sono inferenziali – prendono cioè come input uninsieme di premesse e producono come output una o più conclusioniderivabili logicamente o quanto meno GARANTITE dalle premesse,processi riconducibili a euristiche SPONTANEE, AUTOMATICHE eINCONSCE.Il resoconto pienamente inferenziale di RT distingue fra:
Processi primari (ASSOCIATIVI) implicati nella determinazionedell’esplicito; tratta di processi locali, inconsci, cheavvengono a livello sub-personale.
Processi secondari (INFERENZIALI) coinvolti nella derivazionedelle implicature; processo globale, conscio, esplicito, cheavviene a livello personale.
RT distingue inoltre fra implicature: - forti se D deve derivarla per rendere l’enunciato prodotto da
P compatibile con le proprie aspettative di pertinenza. - deboli se la sua generazione non è essenziale.
Per RT la comunicazione è un elemento di vaghezza. Ironia = fenomeno simile alla metafora. Riassumiamo i punti cardine dell’analisi pertinentista della comunicazione.
1. Che cosa innesca il processo di modulazione lessicale – è la ricerca della pertinenza.2. Che cosa determina la direzione della modulazione, e quali conclusioni – dal percorso di
minimo sforzo, mentre conclusioni tramite aggiustamento reciproco di esplicature, assunzionicontestuali e conclusioni implicate
3. Come procedono modulazione lessicale e derivazione di implicature – 4. Che cosa arresta il processo – fino a che le aspettative di pertinenza di D sono
soddisfatte.
Natura dei processi inferenziali : modularità Grice: letturadella mente – 3° punto di dissensoI bambini già a 2/3 anni sono in grado di produrre e interpretareatti linguistici (no lettura della mente però).Il comportamento è spiegato in termini di esperienze coscienti, stati intenzionali e agiredeliberato.
SPERBER: È poco plausibile che, per interpretare un qualunqueenunciato, D debba compiere complessi calcoli su ciò che P sa cheD sa che P sa, e così via. E nel caso di metafore e attilinguistici indiretti le inferenze dovrebbero comportare tempi dielaborazione più lunghi.Nei recenti sviluppi delle scienze cognitive si sta affermando unavisione sempre più modulare della mente. La mente/cervello è uninsieme di sottosistemi distinti che eseguono funzioni specifichegli uni indipendentemente dagli altri.Un modulo è un dispositivo della mente/cervello dotato di inputspecifici e limitati; autonomo. Autismo e teoria della mente - La correlazione fra teoria dellamente e capacità comunicative ha ricevuto interessanti confermedallo studio dell’autismo. Uno dei caratteri dell’autismo è lacecità alla mente degli altri, cioè l’incapacità di attribuirestati mentali agli altri. Testata con i test della falsa credenze:il test di Sally e Anna o il test degli Smarties.I soggetti autistici hanno infatti enormi difficoltà a comprenderele conversazioni più comuni, quando queste si discostano da un usoletterale: ironia, espressioni metaforiche.Gli studi mostrano dunque che la metafora richiede capacitàordinarie (1° ordine) di attribuzione di stati mentali, mentrel’ironia richiede capacità di attribuzione di stati mentali piùcomplesse, in particolare la capacità di attribuire agli altricredenze.Un sotto-modulo dedicato per la comunicazione - RT adotta unaprospettiva fodoriana. Secondo Fodor i sistemi cognitivi sono di 2tipi:
1. I sistemi di input, modulari;2. I sistemi centrali, non modulari.
Nella revisione più recente di RT, si è affermata una visione chenon distingue fra sistemi centrali e sistemi periferici, definita
modularità massiva, dove un modulo è definito dalla presenza dimeccanismi dedicati. Per RT la comprensione comporta un sotto-modulo del modulo di lettura della mente, una procedura basatasulla pertinenza e opera su stimoli ostensivi, con particolareattenzione agli enunciati. In definitiva il sistema, per deciderequali input elaborare, deve calcolare i benefici cognitivi diTUTTI gli stimoli. SPERBER prospetta una soluzione: il sistema nonha bisogno di effettuare veri calcoli, ma può utilizzareindicatori fisiologici di futuri effetti cognitivi. Il calcolodella pertinenza sarebbe allora un fenomeno cognitivo che avvieneattraverso meccanismi non cognitivi: meccanismi in grado di“INDOVINARE” quale sarà l’informazione più fruttuosa.
Capitolo 4 (dal capitolo 2) - I confini della pragmatica -dedicato ai temi della distinzione fra esplicito e implicito e a quellodell’interazione fra semantica e pragmatica. Due modelli comunicativi:
- il modello del codice – il parlante codifica il messaggio cheintende comunicare in un segnale che il destinatario devedecodificare. Rappresentante Grice.
- il modello inferenziale – il processo di codifica è solo unausilio al riconoscimento del significato del parlante.
I 2 modelli si distinguono anche per il diverso campo d’azione disemantica e pragmatica, che coincide con quella fra DIRE(esplicito) e IMPLICARE (implicito) e a quella, nella prospettivapertinentista fra DECODIFICA e INFERENZA. Vd cap.2Si individuano 4 posizioni teoriche: letteralismo, indicalismo, prospettivasincretica, contestualismo.1 Minimalismo = letteralismo dove il livello esplicito (ciò che èdetto) è in stretta relazione con ciò che compare nell’enunciato. Una volta individuato il livello esplicito, è possibiledeterminare un eventuale livello implicito.Il quadro letteralista traccia una distinzione fra processiobbligatori o SEMANTICI (saturazione) e processi facoltativi oPRAGMATICI (arricchimento, transfert e implicature), checonsentono di individuare un livello di senso addizionale eimplicito.Detta minimalismo perché tutti gli effetti devono essere
riconducibili a elementi sintattici della frase: indicali (io,qui, ora), dimostrativi (questo, quello), pronomi (lui, lei),tempi verbali.Essa individua 3 livelli di senso:
1. significato convenzionale a cui viene applicato il processodi saturazione che consente di determinare la
2. proposizione espressa o contenuto semantico. Determinato ilsignificato esplicito possono essere applicati i processipragmatici di arricchimento e transfert, e così vieneindividuato il
3. senso implicito.PIOVE = per i minimalisti si tratta di una proposizione completa,il cui contenuto semantico è una proposizione come C’E’ PIOGGIA oC’E’ UN’OCCORRENZA DI PIOGGIA: è vero se e solo se piove.2 Indicalismo - Ogni dipendenza dal contesto deve esserericonducibile alla presenza di un indicale, un dimostrativo, unpronome, o un ruolo d’argomento presente nella forma logica eOCCUPATO DA UNA VARIABILE NASCOSTA. L’indicalismo può essereconsiderato una variante più libera del letteralismo, secondo cuiil solo processo semantico è la saturazione dei deittici, opera diprocessi pragmatici che identificano il senso implicito.Primo, ci sono le espressioni indicali (io, tu, ora).Secondo ci sono espressioni dimostrativi (questo, quello).Terzo ci sono pronomi. Ogni dipendenza contestuale viene dunqueattribuita alla presenza di un deittico; in casi particolari puòessere ricondotta alla presenza di una variabile nascosta. Vieneper esempio postulata l’esistenza di un indicale nascosto inPIOVE.3 Prospettiva sincretica (eredi di Grice) o intermedia perché traela nozione minimale di CIO’ CHE E’ DETTO, mentre dalcontestualismo certi arricchimenti devono esserci. Il livellointermedio comprende tutte quelle interpretazioni standard o didefault generate dall’uso di una certa espressione che svolgono unruolo SISTEMATICO. Prevede 4 livelli di senso:
1. significato convenzionale (X E’ FRANCESE), si applica ilprocesso di saturazione e si ha
2. proposizione minimale o “ciò che è detto” in senso semantico(MArtine è francese). Si derivano le implicature e si ottiene
la3. proposizione massimale o “ciò che è detto” in senso
pragmatico (Martine è una francese); si derivano infine leimplicature particolarizzate e può essere identificato il
4. senso implicito (a MArtine piace mangiare bene).La prospettiva sincretica da un lato è cancellabile o rivedibile,dall’altro permette un maggior potere esplicativo.Per Bach proposizioni espanse non sono né esplicature néimplicature, ma impliciture, in quanto sono cancellabili. Bachrifiuta l’esplicatura perché sono cancellabili, e nulla diesplicito può essere cancellabile. SPERBER e WILSON fanno notareche anche referenti indicali sono cancellabili, eppurecontribuiscono al significato esplicito. Con Bach ben 5livelli di senso:
1. significato convenzionale (X E Y SI SONO SPOSATI TROPPOGIOVANI), il processo di SATURAZIONE per ottenere
2. CIO’ CHE E’ DETTO in senso meno che minimale (HOMER E MARGESI SONO SPOSATI TROPPO GIOVANI), il processo di COMPLETAMENTOper ottenere
3. CIO’ CHE E’ DETTO in senso minimale (HOMER E MARGE SI SONOSPOSATI TROPPO GIOVANI RISPETTO AGLI STANDARD DISPRINGFIELD), il processo di ESPANSIONE per ottenere
4. CIO’ CHE E’ DETTO in senso massimale o IMPLICITURA (HOMER EMARGE SI SONO SPOSATI L’UNO ALL’ALTRA TROPPO GIOVANI RISPETTOAGLI STANDARD DI SPRINGFIELD). Le implicatureparticolarizzate e si identifica il
5. Senso implicito (IL MATRIMONIO DI HOMER E MARGE E’ IN CRISI).4 Contestualismo di Kent BACHSe i letteralisti prevedono processi inferenziali solo per la comunicazione implicita, icontestualisti ritengono che processi inferenziali (pragmatici)debbano essere postulati anche per la comunicazione ESPLICITA.Secondo la prospettiva contestualista, il significato linguisticoè frammentario e incompleto: ogni frase esprime una proposizionecompleta solo grazie al contesto extralinguistico, elementi che,pur non corrispondendo ad alcun costituente sintattico dellafrase, entrano a far parte della sua interpretazione semantica.MARGE prima SI E’ SPOSATA E poi HA AVUTO UN BAMBINO = non èconsiderata un’implicatura, ma parte delle condizioni di verità
dell’enunciato.Ne segue che con la prospettiva contestualista viene adottata unanozione di condizioni di verità intuitive: la proposizioneespressa è la proposizione individuata dalle intuizioni vero-condizionali dei partecipanti allo scambio conversazionale.Comprendere un enunciato dichiarativo significa sapere quali statidi cose lo renderebbero vero. Alla base c’è l’idea di matrice griceana secondo laquale il significato è una questione di riconoscimento di intenzioni: DIRE è una varietàdi significato riconoscibile da parte dell’interlocutore. Questoil senso del PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’ proposto da RECANATI,secondo cui “ciò che è detto deve essere analizzato in conformità alle intuizionicondivise da chi comprende pienamente l’enunciato, tipicamente parlante eascoltatore”.Con la prospettiva contestuali sta si torna a uno schema cheprevede 3 livelli di senso, alla domanda ACQUA O VINO? Siproferisca NON BEVO PIU’. Avremo i seguenti livelli di senso:1. Significato convenzionale (X NON BEVE PIU’), cui vengonoapplicati IN PARALLELO i processi di saturazione, arricchimento etransfert. Si ottiene2.Proposizione espressa (HOMER NON BEVE PIU’ ALCOLOCI) ==proposizione in senso massimale, o esplicature dai teorici dellapertinenza.3. Senso implicito (HOMER DESIDERA BERE ACQUA A CENA).OBIEZIONI A:1.Letteralismo – minimalismo - Secondo il modello del codice, lagrammatica di una lingua assegna a ogni espressione linguistica unsignificato letterale, che è prioritario rispetto a quellofigurato. Su questo punto Grice porta argomenti a favore delmodello tradizionale: è la violazione manifesta di una massima aindicare che P si è allontanato dal significato letterale e incitaD a derivare una similitudine o metafora.C'è poi un'obiezione difficilmente superabile: le implicaturesembrano dipendere dalla proposizione ARRICCHITA e non da quellaminimale.Infine obiezioni sollevate sui tempi di lettura, tempi di reazionee movimenti oculari rispetto a enunciati letterali o metaforici.La teoria di Grice è impegnata a sostenere che i tempi dielaborazione degli enunciati metaforici sono più lunghi e i costi
cognitivi di elaborazione sono più alti rispetto ai tempi e aicosti di elaborazione di enunciati letterali. Predizione smentitada altri: i significati figurati vengono elaborati altrettantovelocemente di quelli letterali.2.Indicalismo - un ruolo importante il dibattito fra uncontestualista RECANATI e un indicalista come STANLEY e questoperchè STANLEY condivide con i contestualisti la centralitàdell'idea di condizioni di verità intuitive. A tal proposito PERRYparla di costituenti inarticolati: non sono né costituentiespliciti, né indicali nascosti, ma la cui omissione rendel'enunciato non valutabile. In altri termini X è un costituenteinarticolato se:1. X è un elemento fornito dal contesto alle condizioni di veritàdell'enunciato;2. X non è il valore semantico di alcun componente della formalogica dell'enunciato.Il verbo PIOVERE : l'istante è una variabile ESPRESSA dal tempoverbale, mentre il luogo è un costituente inarticolato di PIOVE.Nella prospettiva di PERRY istante corrisponde a una variabileesplicitata dal tempo verbale, e il luogo a una variabile fornitacontestualmente: in nessuno dei 2 casi si tratterà di unavariabile nascosta.STANLEY propone il TEST DEL VINCOLAMENTO, tesa a mostrare che nonesistono casi convincenti di costituenti inarticolati. Se in PIOVEil costituente per il luogo in cui piove fosse inarticolato, nondovrebbe essere possibile vincolarlo:(A) OGNI VOLTA CHE X ACCENDE UNA SIGARETTA, PIOVE. 2 possibiliinterpretazioni:Visto che STANLEY nega l'esistenza di una variabile NASCOSTA peril luogo, si può generare questa interpretazione: a. PER OGNI T IN CUI
JOHN ACCENDE UNA SIGARETTA, PIOVE A T NEL LUOGO DEL PROFERIMENTO DI (A).RECANATI critica il Test del Vincolamento perchè costringe aintrodurre variabili nascoste. HOMER HA FERMATO L'AUTO. I modi incui Homer ha fermato l'auto sono sì parte del nostro modo dicomprendere l'enunciato, ma solo come aspetti IMPLICITIdell'interpretazione, applichiamo la strategia del vincolamento, eintroduciamo un operatore che sembra vincolare l'elementocostituito dal Modo, In COMUNQUE ABBIA FATTO , HOMER HA FERMATO L'AUTO
/ IN UN MODO O NELL'ALTRO , HOMER HA FERMATO L'AUTO . Il MODOcostituirebbe allora una variabile nascosta.Criterio di Opzionalità - Recanati oppone a quella di Stanleyun'interpretazione alternativa di PIOVE, di costruire contesti diproferimento in cui non è necessario fissare alcun luogodeterminato per definire i costituenti inarticolati.3.Prospettiva sincretica o intermediaRispetto alla tradizione letteralista, i progetti neo-griceani hannol’indubbia attrattiva di combinare un punto di vista inferenziale sullacomunicazione con una visione del linguaggio influenzata dalla semanticaformale e dalla grammatica generativa.Tuttavia è possibile formulare argomenti decisivi contro la nozione diproposizione minimale che i neo-griceani mutuano dalla tradizioneletteralista. In considerazione 3 argomenti:1. Asimmetria diNARROWING e BROADENING Nella teoria della pertinenzacap.3
2. EMBEDDING TESTusato da CARSTON
3. Dati sperimentalisulle implicaturescalari
Obiezioni che riguardanol'architettura complessivadella prospettiva neo-griceana. Levinson trattai processi di NARROWING(restringimento) comeinferenze sistematiche ainterpretazionistereotipiche. Wilsonribatte che sembranoesserci diversi gradi ediverse direzioni diNARROWING, che quindiviene influenzato dafattori contestuali. Ilprocesso BROADENING vieneinterpretato da Levinsoncome un processo digenerazione diimplicature.
per verificare se un elementoè, o meno, parte dellecondizioni di verità di unenunciato. CARSTON mostra chesono proprio le esplicature, enon le proposizioni minimali,a cadere nella portata deglioperatori logici, il test siconfigura come un’obiezionealla nozione stessa diproposizione minimale.In SE LISA HA SPINTO BART E LUI SI E’ROTTO UNA GAMBA, ALLORA (= e diconseguenza, che fa partedelle condizioni di verità) LUIPUO’ FARLE CAUSA.Si tratterebbe per Levinson di“costruzioni intrusive “ incui “le condizioni di veritàvengono influenzate dalleimplicature di alcune sueparti costitutive”.
In ALCUNI ELEFANTI SONOMAMMIFERI, l’inferenzaNON TUTTI viene generataautomaticamente, poicancellata in quanto incontrasto con ilcontesto.A differenza dellateoria della pertinenzaqui il contesto svolgeun ruolo sempre piùrilevante. La rispostapiù rapida a ALCUNIELEFANTI SONO MAMMIFERI:la risposta FALSOrichiede tempi piùlunghi, mentre larisposta VERO è quellafornita più rapidamente.
4.ContestualismoCome sottolinea STANLEY, i teorici della pertinenza si limitatotalvolta a riformulare o addirittura a mascherare i problemi.La nozione di pertinenza è il nodo cruciale su cui si concentranomolte osservazioni critiche contro RT. Viene criticato il fatto
che sembra esserci sempre UN SOLO MODO di soddisfare il principiodi pertinenza. LISA E’ UN SOLDATO può avere un’interpretazionemetaforica che letterale. (le implicature generalizzate nonvengono attivate)Un altro nodo critico di RT è quello di presentarsi come unateoria empirica. Empiricamente solo se combinato a descrizioni diparticolari meccanismi cognitivi (percezione, memoria,categorizzazione); solo una volta fornita una talecaratterizzazione, infatti, può essere testata l’ipotesipertinentista. La tesi contestualista rischia di trasformarsi in una debolezza senon si riesce a porre vincoli ragionevoli all’appello ai processipragmatici. Il contestualismo tende a ridimensionare l’importanzafilosofica dei significati linguistici. I contestualisti silimitano a fornire un significato a OCCORRENZE di enunciati. Nesegue una perdita di potere esplicativo da parte della prospettivacontestualista, che deve rendere conto del maggior peso accordatoall’informazione contestuale (rispetto agli aspetti invarianti disintassi e semantica). Molto controversa è infine la nozione di inferenza utilizzatanella prospettiva contestualista.Per RT arricchimento del significato esplicito e derivazione delleimplicature sono considerati tutti processi automatici, spontanei,inconsci, impliciti – e malgrado ciò inferenziali.Secondo RECANATI un processo, per essere inferenziale, deve esseredisponibile alle intuizioni dei parlanti; i processi primari sonopertanto processi associati. Recanati si riferisce a enunciatocome: SONO VENUTI TUTTI i miei amici MI SONO LAVATO I DENTI questa seraGIULIETTA E’ come IL SOLE.
Carston argomenta che è possibile ribattere con enunciatiPERFETTAMENTE COERENTI QUANTO SCHERZOSI come:GIULIETTA E’ IL SOLE. PIENA DI ELIO E IDROGENO ? SONO VENUTI TUTTI. ANCHE BUSH ? ANCHE MADONNA?
Ne segue che non c’è motivo di tracciare una distinzione traprocessi primari (associativi) e secondari (inferenziali). I datisperimentali sembrano mostrare che i parlanti hanno intuizionisulla distinzione fra ciò che è detto e ciò che è implicato.Contro questi dati sono state sollevate molte perplessità: a voltei soggetti fanno rientrare in CIO’ CHE E’DETTO dal parlante
persino proposizioni che sono in realtà implicatureconversazionali.Sbisà distingue fra la concezione STRUMENTALE della teoria dellapertinenza, in cui la razionalità è un tratto universale in quantoparte del nostro corredo cognitivo, e la concezione ARGOMENTATIVAdi derivazione griceriana, secondo cui la razionalità si esprimenella pratica di motivare le nostre mosse.Anche la prospettiva CONTESTUALISTA presenta difficoltà e incoerenze, tanto daspingere Recanati a trarre un’insolita conclusione pessimistica: “Ladistinzione semantica/pragmatica evidenzia quelli che gli psicologi chiamanoEFFETTI DI PROTOTIPICALITA’.
EPILOGONelle scienze cognitive si è affermata una metafora dal sapore vagamenteparadossale: comunicare significa LEGGERE LA MENTE del nostrointerlocutore. Paul Grice, il 1° a proporre riduzione della nozione disignificato e intenzione o stato mentale: le frasi sono indizi delmessaggio inteso da chi parla. Non possiamo “leggere la loro mente”. Etuttavia possiamo riconoscere le loro intenzioni comunicative grazie aparole e gesti e argomento. Certo, a volte le parole non ci bastano e cicapita solo di coglierle, di attribuire stati mentali ai simili.All’interno della prospettiva cognitiva, RT rappresenta oggi una delleteorie più interessanti e significative, che ambisce a trovareapplicazioni negli ambiti più diversi. Però uno dei maggiori pregi dellaRT è il presentarsi come teoria empiricamente controllabile, dovel’interpretazione linguistica è un processo spontaneo, intuitivo,implicito, che si attua al di sotto del livello della coscienza.




























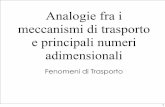







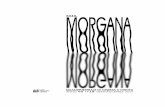

![[Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6337b6d5ce400ca6980922d3/intro-with-f-gambetti-from-parmenides-to-plato-an-overview-da-elea-ad-atene.jpg)






