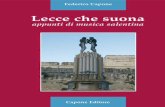Appunti sulla sintassi contrastiva nelle grammatiche italiane all’estero. Esempio polacco
La realtà, la semiosi, il linguaggio. Note e appunti per una ricerca
Transcript of La realtà, la semiosi, il linguaggio. Note e appunti per una ricerca
Comitato di consulenza scientifica
MARGARET ALLENEmeritus Professor, Gender Studies, University of Adelaide, South Australia
MONA BAKERUniversity of Manchester, Inghilterra
LISA BLOCK DE BEHARUniversidad de la República, Montevideo, Uruguay
PAUL COBLEYMetropolitan University, Londra, Inghilterra
WAYNE CRISTAUDOAssociate Professor in European Studies, University of Hong Kong, Cina
VINCENT COLAPIETROProfessor of Philosophy, Pennsylvania State University, USA
JOHN DEELYSt. Thomas University, Houston, USA
ANNE FREADMANProfessor of French, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia
NATHAN HOUSEREmeritus Professor of Philosophy and Senior Fellow,
Institute for American Thought, Indiana University, Indianapolis, USAVICKI KIRBY
Associate Professor, Sociology and AnthropologyThe University of New South Wales, Sydney, Australia
RICHARD L. LANIGANExecutive Director, International Communicology Institute, Washington, USA
CHRISTINA LJUNGBERGProfessor of English, University of Zurich, Zurich, Switzerland
FLOYD MERRELLProfessor of Foreign Language and Literature, Purdue University, West Lafayette,
Indiana, USAVALDEMIR MIOTELLO
Professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de S�o Carlos, BrasileWINFRIED NÖTH
Professor of Linguistics and Semiotics, University of Kassel, GermanyFRANK NUESSEL
University of Louisville, Kentucky, Stati UnitiMARGARET PETERS
Associate Professor in Organisational Communication and BehaviourDean: Research and Research Education, University of South Australia, Adelaide
LUCIA SANTAELLADirector, Post-graduate program in Technologies of Intelligence and Digital Design,
Full Professor, Post-Graduate program in Communication and Semiotics,Catholic University, Sao Paulo, Brasile
SILVANO PETROSINOUniversità Cattolica S. Cuore, Milano
ROLAND POSNERTechnische Universität Berlin, Germania
THOMAS SZASZState University of New York, Syracuse, Stati Uniti
EERO TARASTIUniversity of Helsinki, Finlandia
Filippo Silvestri, Julia PonzioSusan Petrilli, Augusto Ponzio
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------Tempo, corpo, scrittura----------------------------------------------------
ISBN 978-88-6760-017-5
2012 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l.73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.23043525038 Rovato (BS) • Via Cesare Cantù, 25 • Tel. 030.5310994
www.pensamultimedia.it • [email protected]
Sommario
----------------------------------------------------7 Introduzione
Augusto Ponzio
9 Filippo Silvestri La realtà, la semiosi, il linguaggio Note e appunti per una ricerca
9 Premessa12 1. Una filosofia prima15 2. Agire comunicando18 3. Scienza e narrazione20 4. Potere all’immaginazione22 5. La morte, la scrittura, le terapie25 6. Pensieri deboli28 7. Schemi immanenti32 8. Immagini trascendentali35 9. Espressioni e contenuti38 10. Strutture41 11. Il pensiero è una cosa in sé44 12. I motori della semiosi48 13. Presi al centro del vortice dell’Essere53 14. Somiglianze ed imitazioni56 Riferimenti bibliografici
63 Julia Ponzio Il genere sessuale come testo chimericoLa connessione fra nome proprio e differenza sessualenel pensiero di J. Derrida
63 1. Designazione e definizione64 2. Il nome proprio come traccia del corpo vivente di un testo66 3. Il nome in senso proprio e il nome proprio. 68 4. Lo Style come nome proprio del rapporto fra significanti 73 5. Déjà: il tempo dell’interpretazione78 6. Leggere l’invisibile: la favola della differenza sessuale84 Riferimenti bibliografici
5
85 Susan Petrilli Tempo di scrittura, tempo di vita nuova85 1. Tempo della scrittura letteraria e tempo reale87 2. “L’amour est plus fort de la mort”; ma la scrittura letteraria
lo è ancora di più90 3. Il tempo di Sylvie, a partire dal 183293 4. Giganti mostruosi sui trampoli del tempo95 5. Il romanzo di una vita nova come decostruzione dell’identità96 6. Tra una parola e un’altra, come la nebbia di un mattino98 7. Il cadere del tempo nella scrittura filmica 100 8. Il tempo vuoto102 9. Tempo dell’amore e tempo della scrittura106 10. Fuori tempo e fuori luogo , ovvero fuori identità110 Riferimenti bibliografici
113 Augusto Ponzio Il tempo e lo spazio nella scrittura letteraria113 I. Il cronotopo nell’opera di Bachtin113 1. Contestualizzazione del concetto bachtiniano di “cronotopo”
nell’opera di Bachtin123 2. Centralità del cronotopo per il carattere letterario del testo134 II. Lo spazio della parola. Le cimetière marin di Paul Valéry150 Riferimenti bibliografici
153 Indice di Plat. Quaderni di pratiche linguistiche e analisi di testi, Nuova serie, 2008-2010, Pensa MultiMedia
Premessa
Come è noto uno dei problemi fondamentali della semiotica con-temporanea è legato all’esigenza teoretica di scoprire il fantasmadella mente, evocandolo in luce, in una battaglia mai compiuta neiconfronti delle oscurità interiori del soggetto che parla. Detto al-trimenti e per essere più in chiaro, uno studio scientifico dell’uma-no che si voglia collocare su un gradino giusto di legittimazione,non può accettare un programma di studio filosofico, che induginelle secche di una anima-mente, di cui non si ha contezza imme-diata, evidente. In ultima analisi e per dare ragione di una svolta se-miotico-linguistica maturata non solo in seno alla filosofia del No-vecento, la “posa in primo piano” di un soggetto semiotico rispon-de ad un’esigenza epistemologica, quella di mettere le cose in chia-ro, chiamando la cosa in sé umana allo scoperto, non consentendolepiù ombre dietro le quali rifugiarsi per non mostrare i suoi lati an-tropologici, ora di nuovo in luce come necessari oggetti di un or-dine del discorso scientifico. Certamente e al di là di tutte quelleche possono essere le ragioni che dettano un’agenda delle esigenzescientifiche, non si può negare come insieme a tutto questo vada-no delle precise istanze economiche, finanziare, che fissano un mer-cato intorno a delle coordinate, perché la ricerca deve garantire deiriscontri tangibili, finanziari ed economici. Di qui il passaggio ver-so una messa allo scoperto delle vere intenzioni che accomunanogli umani, che sono denudati delle loro diversità-riservatezze, per-ché accomunati dai linguaggi che li parlano, li rivelano, li descrivo-no, secondo una messa a disposizione di dati, che offrono un utiletornaconto, calcolabile in ogni caso.
Per certi versi si compie una svolta linguistica nel momento in
9
La realtà, la semiosi, il linguaggio Note e appunti per una ricerca ----------------------------------------
Filippo Silvestri
cui si accetta un accordo sul “vero valore” di ciò che appare.Quanto si afferma come qualcosa che non conta è il fenomeno inragione della sua acclarata superficialità: ciò che appare restando insuperficie non è vero, non è attendibile. Così e per paradosso, mapoi fino ad un certo punto, si assume in una sorta di ribaltamen-to delle posizioni lo strato linguistico delle nostre parole comeuna superficie affidabile, da cui partire per scavare in direzione diun trascendentale comune. Se il linguaggio è ciò che si manifesta ap-parendo (apparentando), questo “apparire” è pur sempre qualcosache è comune, perché condiviso da una comunità, riconosciuto daun gruppo di parlanti come il proprio linguaggio. Muovendo daquesta condivisione senza sforzi soverchi (se non quelli legati al-l’imparare una lingua), si può iniziare lo scavo in direzione di unaprofondità ulteriore, un comune profondo condiviso questa voltaper ragioni biologiche. Quindi ed in una rapida sovrapposizionedi prospettive quel biologico che è naturale, si dice avere una pre-disposizione logica alla comprensione del mondo: è naturale, sia-mo esseri che pensano in modo logico e questa logica sostiene uncervello dotato di una disposizione naturale a parlare, mettendosoggetto e predicato in certe posizioni, per cui pur avendo pochimezzi, con quei pochi è in grado di generare correttamente l’edi-ficio complesso della sintassi, declinando e flettendo le varie for-me dell’essere semiotico, senza che nessuno debba insegnare nien-te a nessuno, salva fatta una buona esperienza del proprio ambien-te circostante. Per dirla con Chomsky, svuotando il linguaggio diogni contenuto sociologico e politico: «[…] se gli adulti dovesse-ro improvvisamente morire e i bambini dovessero in qualche mo-do sopravvivere, allora qualunque cosa essi si trovino a parlare sa-rebbe una lingua umana, anche se sarebbe una lingua che ora nonesiste» (Chomsky 2000; trad. it.: 111).
Dati tutti questi presupposti il programma epistemologico co-sì descritto punta al riconoscimento di un “in-sieme” per la co-munità antropomorfa, in nome di una identità che si vuole stabi-lire. Va da sé che a partire da quanto pattuito sul piano scientifico,ogni qualità-diversità-seconda non sarà presa in considerazione,non perché non se ne ammette l’esistenza, ma perché non inte-ressa, non risponde ad un utile. Se si vuole, quel che si consideradiverso, unico e differente non dispone nemmeno di superfici se-miotiche, che ne rivelino dei tratti distinguibili. Che sia ai limiti
Filippo Silvestri
10
della comunità, questo è possibile. Che non interessi ai fini dellericerche che si compiono e valgono altrettanti finanziamenti, èuna regola che non ha bisogno sempre di una spiegazione, che nedimostri il merito.
Alla luce di quanto argomentato in forma di introduzione al-le questioni che tratteremo, il compito di un discorso filosoficoche abbia margini plausibili di credibilità non è quello di cono-scere la realtà così com’è (impresa complicata, ai limiti del possi-bile), quanto piuttosto di prendere contezza della strutture e del-le dimensioni del trascendentale-umano-mente, unico campo diricerca per uno studio interessato alle coordinate di funzionamen-to di una societas da governare. Bisogna andare in profondità, sca-vando le ragioni archeologiche del nostro apparire linguisticocontemporaneo, ferma restando la sostanziale ambiguità della po-sta in palio teoretica che si misura con un fantasma dai modi sfug-genti. Di che materia è fatto il trascendentale-mentale? Quali for-me lo caratterizzano? E’ difficile stabilire se ci sono delle paterni-tà novecentesche, cui attribuire il momento aurorale in cui matu-ra una soluzione linguistico-trascendentale. Il Cassirer di Filosofiadelle forme simboliche insegna una strada semiotica, attribuendo allinguaggio la funzione di tramite per eccellenza del rapportoumano al mondo, all’essere delle cose, secondo un modo di inten-dere la relazione al contesto, all’ambiente, al mondo in forza diuna sintassi logico-pragmatica, storica ed effettuale delle intenzio-ni (Cassirer 1954-58 [1923]), dove l’intreccio-chiasma uomo-mon-do è fatto di parole, simboli, logiche sintagmatiche e paradigmati-che, salve fatte dimenticanze di vario tipo, che forse suggerirebbe-ro un modo di stare insieme della carne mondana, che non ha nul-la di linguistico, utile e determinabile in senso causale, finalistico(Merleau-Ponty 1964).
Ciò che a noi interessa sottolineare è il carattere problematicolegato ad uno sforzo che resta non ovvio se misurato con le solu-zioni che sono state proposte nella messa sul tavolo delle cartevincenti nel gioco-dibattito trascendentale. L’adozione di certecartine torna-sole linguistiche, quali inconvenienti sperimentalicomporta? Ricoprire il mondo di segni, realizzando un progettopan-semiotico, con la conseguente conquista delle strutture antro-pologiche portanti, riducendole alla loro manifestazione linguisti-ca, significa intanto spingere il privato fatto di ombre dentro il co-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
11
no pubblico acceso dalla luce semiotica, dove il suo modo dicomportarsi e intendere le cose risulta oggettivo, osservabile, con-diviso in una sorta di auto-denucia-confessione indotta o altri-menti estorta, magari con la promessa di un successo garantito dauna platea appassionata di vizi privati, che non hanno più nem-meno particolari pretese di riconoscimento in termini di pubbli-che virtù. In ogni caso il logos linguistico prende progressivamenteil posto di quello filosofico, mentre la teoresi cede il passo alla se-miotica, il tutto determinandosi su di un piano di maggiore o mi-nore credibilità delle discipline in ragione della loro caratura epi-stemologica, che può incontrare maggiori o minori riscontri a se-conda delle tendenze epocali che vanno per la maggiore secondole più accorte rilevazioni statistiche di gradimento.
1. Una filosofia prima
In ogni caso a seconda dei modi teoretici con cui si tratta il pro-blema, quanto discusso implica che il ruolo di una filosofia prima in-tesa in senso aristotelico possa essere interpretato a queste condi-zioni solo da una “filosofia del linguaggio” (Ponzio, Petrilli, Cale-fato 1994). Se non c’è accesso al mondo che non sia condiziona-to da una semiosi storicamente e socialmente determinata, alloraci si deve incamminare in direzione di una scienza della comuni-cazione e della significazione, comunque la si voglia intendere, an-che nella sua variante più accettabile perché dai modi fluidi e prag-matici, mentre vita e linguaggio vanno insieme, sebbene i due nonsi riducano mai l’uno all’altra (e viceversa), proprio in ragione del-la loro relazione in un rilancio delle istanze costitutive di senso,lontane da uno schema universalizzabile, che possa valere per tuttied in ogni momento (Apel 1973; Habermas 1981). I dubbi sulpunto, sulla sintesi indissolubile di pensiero, vita e linguaggio, re-stano iperbolici ed è lecito domarsi con Havelock: “Ogni pensie-ro logico qual è comunemente inteso non sarà un prodotto del-l’alfabetizzazione greca?” (Havelock 1988; trad. it.: 51)
A di là delle varianti sul tema, sulla relazione mente-linguaggioo ancora (e se si vuole) tra l’esperienza e la sua resa categoriale-lo-gica-linguistica, una delle prerogative epistemologiche che hannoincoraggiato una svolta linguistica è anch’essa ascrivibile ad una cir-
Filippo Silvestri
12
costanza meta-fisica, che fa perno sull’idea che il linguaggio sia insé caratterizzato da una certa trasparenza. Il passaggio dal segno alsignificato, dalla semiosi alle idee che la animano, è possibile in ra-gione di una disposizione strumentale del mezzo linguistico ad es-ser trapassato da parte a parte nello scorrimento intenzionale in di-rezione dei contenuti significativi che si vogliono dire-rappresenta-re. Il segno è una porta sempre aperta, una pellicola invisibile, qual-cosa che non opacizza la trasparenza significativa che lascia compa-rire. Nello svolgimento corretto della sua fenomenologia il segnodistoglie lo sguardo dell’interprete da sé, per guidarlo verso il ber-saglio ermeneutico inteso. Questo carattere visibile-invisibile lo fapensare-credere come assente. Certamente questa qualità (del se-gno) gli spetta in ragione di un’astrazione proto-tipica ed universa-le, tanto più sostenuta da una standardizzazione nei secoli dellastampa seriale, dove ogni segno perde il carattere eccezionale chegli spettava come trascrizione amanuense, come ancora prima gliapparteneva nella sua disposizione narratologica legata alla parola-corpo di chi racconta con la sua voce, tramandando il vivere insie-me delle comunità che ascoltavano riunite.
Nulla togliendo a questa caratteristica transeunte della semio-si, resta la sua sintesi inestricabile con la vita che rappresenta, percui l’esperienza delle cose umane è “segnata” perché continua-mente indirizzata sulle strade linguistiche che si decide di traccia-re, per cui si percorrono certi sentieri (anche interrotti) perché sidispone di certe mappe, mentre non si guarda la cosa stessa (diret-tamente), perché si è stabilita una dipendenza da certi occhiali lin-guistici, che fanno apparire le cose per come sono “vere”. La tra-sparenza che resta invisibile e che si pretende per i segni che siadoperano, è tuttavia segnata da uno spessore che fa pensare-ve-dere il mondo in certi modi che sono diversi da quelli dell’anal-fabeta, che non è “un incivile” perché conserva una relazione conil mondo che non fa passare attraverso una scrittura delle sue im-pressioni (Sini 2009). D’altra parte ammesse pure quelle pretesetrasparenze che si assegnano ai linguaggi, una certa materialità se-miotica, dando corpo ai segni, dipende dalla stratificazione stori-ca-etica-politica che contribuisce ad ispessire il loro deposito er-meneutico, governandolo in certe direzioni piuttosto che altre(Rossi-Landi), come ancora una certa materialità tutt’altro chetrasparente viene alla semiosi da una precisa istanza costitutiva del
La realtà, la semiosi, il linguaggio
13
senso legata alla “materia” di cui è fatto il segno, per cui il suo es-sere pietra, gesso, carta o elettricità ha un peso specifico determi-nante, se misurato con la qualità della vita di chi ne fa un uso stru-mentale utile alle sue auto-rappresentazioni, con tutti i tempi e glispazi che misurano la lunghezza, la larghezza, la località e la glo-balità dei movimenti possibili per il soggetto delle parole coinvol-to (McLuhan 1964).
Una questione resta aperta e non sembra ci siano margini peruna soluzione, ammesso ci sia bisogno di risolvere qualcosa, alme-no in questo caso. Che cosa hanno in-comune gli esseri umani,cosa li rendi umani (spesso troppo umani), cosa condividono real-mente al di là delle loro eccezioni, che fanno la singolarità di cia-scuno, laddove poi paradossalmente questa eccezionalità persona-le è il tratto comune che rende tutti differenti? Certamente pro-prio il passaggio dall’oralità alla scrittura implica una messa in-co-mune, un comune-non-materiale-condiviso-universale, un pen-siero-pensare comune, un modo della comunicazione-significa-zione, sulle cui fondamenta grammaticali ed alfabetiche si basa piùdi un senso-momento della giustizia come sistema di valori intor-no ai quali costruire uno stare insieme regolato da leggi. Ammes-so come decisivo da un punto di vista storico-antropologico que-sto passaggio dall’oralità alla scrittura, la tesi che andiamo soste-nendo è che proprio questo atto di tra-scrizione segni la nascita diun discorso sul trascendentale: la domanda che ha come oggetto l’es-sere universale umano inizia all’alba dell’epifania di una scritturagreco-occidentale-mediterranea, nel momento in cui le singolevoci che si alzano dal dibattito-non-dibattito-naturale si trovanotrascritte in un alfabeto che le accomuna nella determinazione delsenso delle cose che capitano. Tornerebbe così sul proscenio dellequestioni sperimentali ed epistemologiche, per altre ragioni saziedi metafisica, sebbene sempre pronte a nuovi soluzione meta-ta-phyka, una suggestione confermata per questo verso secondoquanto appena discusso ovvero che il trascendentale va cercato trale pieghe di un linguaggio, che divenuto scrittura astratta delle as-senze personali qualitative, è nuovo garante di un comune che va-le per tutti come parametro di giustizia e verità (Sini 2009). Loschema dell’umano e delle sue relazioni per parte sua è ovviamen-te immobile in ragione delle astrazioni che lo hanno reso possibi-le, in ragione delle continue sottrazioni di corpo, gestualità, voca-
Filippo Silvestri
14
lità, movimenti che lo contestualizzerebbero in una dimensionepre-categoriale, in cui vivrebbe delle variabili delle sue diverse ap-partenenze aperte. La sua dinamica solo virtuale gli deriva da uninserimento (sempre schematico) in una disposizione lineare pro-pria della scrittura, che lo fa “progredire” lungo un percorso uni-direzionale da sinistra a destra, collocandolo in un tempo anch’es-so lineare.
2. Agire comunicando
Spostare l’umano su un piano linguistico significa collocarlo in unordine di considerazioni pragmatiche, a sua volta legato all’utilizzodi uno strumento dialogico con tutti i significati storici e sociali,politici, che ogni comunità antropologicamente determinata impli-ca: l’umano diventa così una funzione strumentale, linguistica e se-miotica, dialogica, un mezzo rispetto a fini che sono nel governodelle tecniche della relazione e dell’unione, della sintesi. Rispetto aqueste riduzioni l’agire comunicativo su cui ragiona Habermas puòintercettare il mondo della vita, corrisponda questo mondo ai fatticon cui bisogna fare i conti, coincida diversamente con le personecon cui si condivide una parola, sia infine il mondo una società ar-ticolata in cui si è costretti ad una collocazione, secondo sintagmi eparadigmi semioticamente convenzionati che riflettono un’econo-mia dei rapporti che innerva di sé il linguaggio. Il punto che restada capire è fino a che punto un agire comunicativo garantisca di persé una soluzione etica (anche la cosa la si volesse intendere nei ter-mini di un telos realizzabile), un’etica della reale condivisione capa-ce di restare lontana da un agire strumentale per fini e mezzi. Co-municare significa dialogare realmente? Disponiamo davvero di unacontroprova semiotica, in grado di rivelare lo spessore effettivo del-lo stare insieme secondo un modo della relazione che sia vitale?D’altra parte, se vale una differenza corrispondente ad una plurali-tà di soggetti e non un solo trascendentale universale ed onnicom-prensivo, è difficile delegare ad un presunto agire finalizzato alla co-municazione una convergenza, che date quelle differenze è ai limi-ti del possibile, quando ancora non sia auspicabile. Non è qui nem-meno questione di forze centrifughe: la moltiplicazione della sog-gettività nelle infinite personalità divergenti è sempre ai limiti di
La realtà, la semiosi, il linguaggio
15
un’esplosione divaricante, secondo andamenti nomadici (Deleuze),rispetto ai quali è difficile fare valere un principio-comunicazioneche stringa tutti in una relazione, per di più etica. La frantumazio-ne del sociale nella moltiplicazione dei diversi soggetti del pensie-ro (senzienti e spesso “dissidenti” a vario titolo) va poi di pari pas-so con una contestuale automazione meccanica del “tipico socia-le”, con quanto ne consegue in termini di cattive abitudini utili algoverno della cosa pubblica, che conservano poca consapevolezzacritica del proprio fare-agire. A fronte di quanto detto, il potere se-miotico resta nelle mani di coloro che dispongono delle informa-zioni utili a far funzionare il cyborg sociale, mentre ciascuno è re-stituito al proprio sé, dove constata politicamente che questo se-Io,preso in una continua lotta per la sopravvivenza linguistica, è pocacosa (Lyotard 1979; Bauman 1999) se misurato con le forze che losovrastano.
Fatte queste considerazioni, l’organizzazione sociale si struttu-ra intorno ad una quota comunicativa come asse determinante lacostituzione dello stare insieme delle persone. Pertanto una teoriadell’agire comunicativo (Habermas 1981) ha il pregio di porre laquestione semiotico-trascendentale in senso normativo-giuridico,secondo modi pragmatici nel momento in cui frantuma il mon-do della semiosi nelle diverse regioni in cui si articola a secondadei giochi linguistici prevalenti che regolano gli spazi del sociale, as-sumendoli in ragione del loro variabile consistere. Le leggi sonodiverse e non sempre valgono per tutti, ma non si può negare co-me non ci sia spazio della ragione che non sia regolato, normato,normalizzato secondo precise istanze costitutive il senso della re-lazione dialogica-non-dialogica dell’essere al mondo degli uomi-ni. Non c’è atomo umano del dialogo universale, che non si muo-va seguendo regole che rispetta e che evade, assecondano fini percui dispone di certi mezzi, accettando soprattutto una certa feno-menologia di valori in cui crede, assumendoli in un modo chepuò essere più o meno critico. A fronte di queste possibili feno-menologie, resta inevitabile una parallela genealogia della morale,che non ha necessariamente un carattere linguistico mentre fa dasfondo rispetto all’analisi del verbale-non-verbale, con uno studiodei meccanismi che regolano le scelte. Salve fatte alcune convin-zioni internaliste-innattiste, con tutte le loro varianti “biologiche”del caso, Chomsky ricorda che:
Filippo Silvestri
16
Quando si discute di linguaggio e di uso del linguaggio vengonoregolarmente introdotti altri tipi di struttura condivisa: comunitàcon le loro lingue, lingue comuni nel contesto di una cultura piùampia ecc. Queste pratiche sono normali anche nel discorso ordi-nario. […] A questo proposito non si può parlare di scelta giusta osbagliata se facciamo astrazione da interessi che possono variare inogni modo immaginabile. Inoltre, non ci sono categorie naturali oidealizzazioni. Da questo punto di vista, “parlare la stessa lingua” èallo stesso livello di “essere vicino” o “assomigliare”. Un’osserva-zione ormai classica nei corsi introduttivi di linguistica è la battu-ta di Max Weinrich secondo cui una lingua è un dialetto con unesercito ed una marina, ma anche i dialetti sono nozioni non lin-guistiche, che possono essere formate in modi arbitrari, a secondadegli interessi e delle preoccupazioni in gioco. Fattori quali le con-quiste, le barriere naturali (oceani, montagne), la tv nazionale ecc.potranno anche produrre alcune illusioni a questo proposito, ma inrealtà non è ancora stata formulata alcuna nozione utile e coeren-te di “linguaggio comune”, né le prospettive al riguardo sembranoincoraggianti. Si dovrebbe pertanto diffidare di qualsiasi approccioallo studio del linguaggio che si basi su simili nozioni (Chomsky2000; trad. it.: 87).
A fronte di questa torsione politica del problema, l’emersionepubblico-semiotica del privato trascendentale non garantisce, si sa,una fondazione che sia logica e neutra, perché lo stesso linguag-gio comune non è garanzia di universalità. Assumiamo ad esem-pio un punto d’osservazione analitico, secondo la sua specificacurvatura pragmatica. Restando su una linea poco incline a solu-zioni epistemologiche nella considerazione del problema della ve-rità dei significati (Hacking 1975), è noto come Quine (1975) siaconvinto non ci sia possibilità di un’univoca relazione tra le paro-le e le cose, tra una proposizione ed il suo stato di cose, perchénon c’è un senso comune che faccia da punto di riferimento inquanto strutturato in modo logico e linguistico con crismi di uni-versalità. Le logiche che sottendono i linguaggi sono costruite al-la stregua di edifici progettati secondo uno stile olistico, mentre larealtà (se intesa come esperienza) resta ai margini, quasi al limitedi una serie di sistemi di forze naturali che si contrappongono aduna riduzione semiotica, una realtà da assumere per sfumature co-me fosse lo sfondo delle rappresentazioni recitate. Se si assumonoquesti presupposti semiotici da una parte e realistici dall’altra, il
La realtà, la semiosi, il linguaggio
17
problema linguistico si riduce ad un transumanza continua di tra-duzioni (laddove siano possibili), con il corredo di smussature chela cosa implica perché non si danno perfette corrispondenze sulpiano semantico. Il linguaggio così compreso coincide con unaserie di atti-comportamenti sostanziati e valorizzati in termini dipossibili competenze sostenute da una apparato linguistico orga-nizzato per giochi: la performatività degli enunciati è regolata danorme che possono essere descritte fenomenologicamente, ri-spondendo a più sistemi di corto-circuiti semiotici in cui si pos-sono o si devono dire-fare certe cose.
3. Scienza e narrazione
Presa così, la cosa in sé resta nella sua imperturbabile in-differenza,mentre il nodo delle rappresentazioni si dipana secondo fili diver-si, che possono avere un tenore narrativo ovvero si ispirano ad unaserie di matrice scientifica, secondo modi della legittimazione diun dire che ha le sue leggi, per cui si potrebbe avere sempre daobiettare sulla verità di quanto messo in scena. Se la rappresenta-zione delle cose sta simulando-emulando qualcosa che veramen-te-realmente accade, allora lo spettacolo-scientifico deve fornire alpubblico pagante prove resistenti alla confutazione-sperimenta-zione. Poi, una volta acquisita questa serie di riscontri, si può ac-cettare in senso divulgativo in favore dello stesso sapere scientifi-co una opportuna traduzione narrativa, con tutte le degenerazio-ni significative (narratologiche) che la cosa comporta, tuttavia uti-li per una condivisone che valga per la maggioranza, ferma restan-do la circostanza fondante che tutti i linguaggi con cui si vorràgiocare dovranno essere utilizzati secondo modi che testimoninola loro performativa efficacia, perché nel mondo postmodernoogni forma della rappresentazione deve dimostrarsi “potente” ov-vero strumentalmente-tecnologicamente efficace, utile perché di-sponibile per un suo possibile commercio (Lyotard 1979). Datiquesti presupposti performativi con il potenziale che ne consegue(potenza dell’agire comunicativo), nel quadro di una politica delgoverno dell’istruzione Lyotard vede in prospettiva quanto già al-lora, quando scriveva, appariva facile prevedere:
Filippo Silvestri
18
Se la nostra ipotesi generale è vera, si accrescerà la domanda diesperti, quadri superiori ed intermedi dei settori di punta indica-ti in apertura di questo studio, che rappresentano la posta in gio-co degli anni a venire: tutte le discipline che interessano una for-mazione “telematica” (informatici, cibernetici, linguisti, matema-tici, logici) si vedranno riconoscere la priorità in materia di inse-gnamento. Tanto più che la proliferazione di esperti di questo ge-nere dovrebbe accelerare i progressi della ricerca in altri settoridella conoscenza, come si è visto in relazione alla medicina e al-la biologia (Lyotard 1979; trad. it.: 88).
La rivoluzione industriale contemporanea porta con sé iltrionfo dei mezzi, con una discreta decadenza consapevole (in-consapevole) dei fini rispetto a quei mezzi, ammesso ce ne siano,di fini. Considerata la cosa in senso mass-mediatico questa supre-mazia dell’uso strumentale delle cose si avvalora nel ciclo che ca-ratterizza la moltiplicazione degli strumenti audio-video-televisi-vi, fin dentro la più recente configurazione cross-mediale (Jenkins2006). Se solo si considera la questione della fine della narrazioneteorizzata da Lyotard dal punto di vista cross-mediale dei compu-ter in rete e delle generazioni di tutto ciò che è “portatile”, le vi-cende semiotiche che dicono di un passaggio dalla narrazione al-la scrittura algebrica trovano un’ulteriore spiegazione dell’escala-tion evolutiva-involutiva, che segna la fine delle disponibilità ditempo e spazio per la narrazione. I nuovi modi della messa in sce-na del pensiero (cellulari, computer, i-pod, ecc.) innescano unmodo della comunicazione dialogica, che ha caratteristiche brevi,frammentate, veloci nell’esecuzione. Non c’è più il tempo e so-prattutto lo spazio per raccontare qualcosa, non solo perché nonc’è più nessuno disposto ad una lettura-ascolto prolungati, ma an-che in ragione di un’assenza tecnologica di spazio e tempo, assen-za che è parte costitutiva dei nuovi dispositivi informatico-comu-nicativi per come sono fatti materialmente.
Questa frammentazione del linguaggio, proiezione delle tec-nologie che lo rendono possibile, va insieme ad una più antica di-sarticolazione del sapere in una serie di scienze sempre più spe-cialistiche, ognuna segnata da una sua linguistica particolare, cir-costanza questa che porta a non ammettere un meta-linguaggiocapace di raccontarle tutte insieme. Dissolti in questa frammenta-zione, la potenza ed il potere del singolo (coinvolto nelle pseudo-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
19
socialità delle sue relazioni aperte) si realizzano passando attraver-so i nodi nevralgici del suo stare in rete, mai vittima di un digital-divide perché sempre elettrizzato dalle sue connessioni (McLuhan1964), che lo seguono ovunque controllandolo su una mappacontinua dei suoi mancati spostamenti, perché immobile nellarealizzazione delle sue semiosi di fronte alla console dei comandicross-mediali, che lo comandano, non mandandolo da nessunaparte (Manovich 2001). Preso nella frammentazione della comu-nicazione-chat e rapido nell’esecuzione significativa perché all’al-tezza della disponibilità degli sms che digita telefonando letteraper lettera, dedito alle fenomenologie linguistiche della moltipli-cazione dei codici morse che sa de-cifrare con elementare predispo-sizione ad un’aritmetica di cui non conosce gli algoritmi, l’uomonuovo non è solo un homo videns (Sartori 2008), ma è soprattuttoun articolato cyborg della comunicazione breve, che non implicalungaggini descrittive da raccogliere in narrazioni poco scientifi-che, che implicherebbero troppe pagine da sfogliare.
4. Potere all’immaginazione
Una tesi che corre parallela a quella della fine delle narrazioni è so-stenitrice di una fine dell’azione politica o di altra natura nel trion-fo globale della comunicazione, comunque la si voglia intendere,avendo tuttavia essa essenzialmente un carattere mass-mediatico, ra-diofonico e televisivo. Tutto ciò che avviene, in realtà “avviene” fi-no ad un certo punto o meglio, non è mai all’altezza della rappre-sentazione di massa in senso comunicativo che se ne dà (Perniola2009). L’evento come momento di svolta da intendere in terministorici, è il risultato di una creazione-eco nel governo dei registidella comunicazione. Qualcosa indubbiamente avviene (il MaggioParigino, la Rivoluzione Iraniana, la Caduta del Muro di Berlino, ilcrollo delle Torri Gemelle a New York) ed ha un carattere eccezio-nale. Il suo essere miracoloso e traumatico dipende, tuttavia, dal-l’eco che si produce attraverso le casse di risonanza di chi ne am-plifica la portata: il Maggio francese dura un mese, il suo caratteremiracoloso nei tempi del mito di chi lo alimenta, riprendendoloper immagini, suoni, secondo gli artifici disponibili della semiosi, fi-no a generare i traumi che ne conseguono nel corso del tempo per
Filippo Silvestri
20
chi crede nel miracolo (presunto e virtuale) e passa all’azione, dan-do corpo alla voragine aperta tra la realtà che resta da una parte el’immaginazione, che pretende di passare ad un’azione che dia con-cretezza a quelle aspettative miracolose, salvo in questo modo ge-nerare mostruosità di dimensioni pari in modo proporzionale alladistanza-divaricazione che passa tra l’immaginazione ai limiti dellesue prerogative virtuali e la realtà che continua ad avere tempi lun-ghi di gestazione, senza nulla togliere alla circostanza che la stessarealtà possa essere alla fine completamente aliena rispetto alle vi-cende umane e alle rappresentazioni che uno cerca di darle.
Sulla scia di queste divergenze reali ed immaginarie, nella sua-dente moltiplicazione delle rappresentazioni del sé, il terzo spiritodel capitalismo (Boltanski, Chiapello 1999; Perniola 2009) si inscri-ve in un culto estetico del sé, che si presume anarchico, che ha delbohemien e che fa valere il proprio agire deregolamentato comeistanza costitutiva del senso di un allontanamento da tutto ciò chesi dispone in modo strutturale, accorpante. Il potere dato all’im-maginazione è così preda dei meccanismi del mercato, che lo as-sorbe, ponendolo al servizio di precisi interessi finanziari. L’indi-viduo che si sottrae alla massa e ai processi di massificazione, di-viene un individualista che fa valere il suo genio, facendo merca-to delle sue immagini-immaginazioni: non che sia nelle sue di-sposizioni la cosa, ma la trasfigurazione che compie e che subisceè effetto della sua conversione al mercato, secondo le forme e neimodi in cui possono essere sfruttati “i creativi”. Ancora: non es-sendoci più una catena di montaggio, l’anarcoide libero di farequel che vuole, coincide con la figura imprenditoriale di avan-guardia di un capitalismo, che si pone esplicitamente fuori dalleregole. La metamorfosi descritta matura negli ultimi due decennieuro-americani del Novecento (Perniola 2009) collocandosi nel-le maglie larghe di una infrastruttura che è la rete tele-nautica, quidissolvendosi, mentre il soggetto delle intenzioni trascendentali(universali) a sua volta si liquefa in un mancato spazio-tempo, se-condo variabili fenomenologiche che non sono anarchiche, per-ché si vive piuttosto nell’impossibilità di una vera riconduzione adun soggetto pensante-morale, individualmente imputabile. La lot-ta per la liberazione del pensiero nell’immaginazione, nutrendosidi una comunicazione che non domina e che lo trascina in dire-zioni che non vuole, sembra capovolta nel corso del tempo secon-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
21
do una dinamica miracolosa prima e traumatica poi, risultando al-la fine in una fenomenologia che gli è completamente estranea, incui non c’è più una vera azione, un’agire seppur comunicativo se-condo verità, ma solo una sequela ininterrotta di performance, do-ve la riuscita di quello che uno eventualmente fa, finisce sempreper coincidere con lo spettacolo che il sé dà di sé, dove il succes-so è sancito dall’applauso di un pubblico che si crede sempre as-sistere allo spettacolo, finanche quando la cosa spettacolare do-vrebbe avere toni intellettuali.
5. La morte, la scrittura, le terapie
Dietro quanto detto, stanno certe scritture scomposte dal loro au-tore, tanto indipendenti da alimentare una “morte” che se non èdel soggetto, è una morte che si deve imputare ad una vita che sisposta fuori dai piani della rappresentazione. Il testo (inteso inmodo semiotico ampio) è tra l’essere e il nulla, inscritto in unorizzonte neutro: la parola letteraria non dice nulla, è una scrittu-ra che si produce per spostamenti mentre non dialoga, segnandole distanze delle posizioni tra gli interlocutori (Blanchot 1980).Nella ricerca di un senso chi scrive si affida alla costruzione diun’opera che gli restituisca delle risposte che possano risultargliconfortanti. Ma come in un atto creativo primordiale, questa mes-sa al mondo della rappresentazione del sé di sé, in quanto lottacontestuale alla morte singola e particolare, comporta la scompar-sa del soggetto della scrittura, soggetto che implode ritraendosinel momento in cui si articola-disarticola nella sua scrittura: ioche mi cercavo in quello che raccontavo, scopro il mio annulla-mento in una scrittura che mi trascende in ragione della sua neu-tralità (filosofica e trascendentale), scrittura destinata ad un’eman-cipazione secondo modi del senso che non hanno bisogno di meche pretendo specchiarmi, nel frangente in cui cerco (speculando)un’immagine del mio Io nelle rifrazioni di quello che scrivo,un’immagine che non mi travisi e che confermi il mio essere an-cora un uomo in vita (Kierkegaard 1839). Scrive Blanchot:
Scrivere significa non rinviare più al futuro la morte sempre giàpassata, ma accettare di subirla senza renderla presente e senza
Filippo Silvestri
22
rendersi presenti ad essa che, per quanto non sia stata provata, haavuto luogo, e riconoscerla nell’oblio che lascia dietro di sé […](Blanchot 1980).
L’opera conserva un carattere rivelatore, che le deriva dalla suacaratteristica scrittura, che coincide con un morire continuo, sen-za che la cosa possa essere una soluzione rispetto alla fine cui si èdestinati (la morte), mentre si dis-pone in senso comunicativo (perchi se ne accorge) nel rendere conto della nostra mortalità secon-do un’ontologia che non è disponibile. D’altra parte e in positivola scrittura, che non è ri-presa del sé, è dono per l’altro, laddovelei/lui abbia voglia di leggere:
[…] l’opera […] non è né compiuta né incompiuta: essa è [….] lasolitudine dell’opera ha come primo sfondo quest’assenza di esi-genza che non permette mai di dirla né compiuta né incompiuta[…] l’opera è solitaria: ciò non significa che essa rimanga incomu-nicabile, che il lettore le vanga a mancare (Blanchot 1955).
L’Orfeo di Blanchot (Blanchot 1955) è il simbolo di una ri-cerca delle profondità amate ed al tempo stesso della sconfitta-perdita che questa ricerca conclude: la pretesa di vedere Euridice(il sé, il proprio, l’amore, la resurrezione dell’impossibile) chiudeun viaggio ai limiti delle possibilità umane, viaggio che si compienelle dinamiche nullificanti di una scrittura, che volendo essere ri-cerca autocosciente, si concretizza in una perdita completa per chila scrive. In queste risultanze semiotiche devitalizzanti, su cui ra-giona Blanchot, tolte le differenze di genere letterario, risuonaun’eco molto lunga, lunga almeno tutta la distanza critica neiconfronti della scrittura che Platone sosteneva nel Fedro, dove al-l’oblio della memoria delle cose si associa la dimenticanza del sog-getto concreto, che in quanto vivente è fuori gioco nel momen-to in cui cerca una rappresentazione di sé che sia oggettivante.
L’oggettivazione de-soggettivizzante del sé personale nellosforzo auto-rappresentativo si innesta nell’orizzonte ampio (insenso metafisico) in cui si realizza il progetto epistemologico di unuomo senza qualità in grado di rendere conto in termini statisticidi un altrimenti evanescente, con tutto lo spreco nel rifiuto indif-ferenziato di quelle qualità soggettive, che fanno la personalità el’eccezione dell’umano, ma che non offrono riscontri statistici,
La realtà, la semiosi, il linguaggio
23
economici e scientifici rilevanti. Se la storia della filosofia è unaperdita di tempo metafisica, in cui ci si è fatti una serie di falsi pro-blemi, che avrebbero meritato un’analisi (dei dati) più attenta dalpunto di vista linguistico, la nuova ricerca praticata si offre comeuna terapia finalmente efficace, se non altro se misurata con il gra-do di semplificazione delle cose, che sembra garantire. Si sa d’al-tra parte come ogni medicina abbia le sue controindicazioni e lafine del romanticismo idealistico delle lunghe fenomenologienarrative è nel momento di ogni sua conclusione ancora e sem-pre una conta dei sommersi e dei salvati, degli inclusi, degli esclu-si, secondo un ordine del discorso, che vale sempre scavare fuori dal-le sue dissimulazioni apparenti, come ha provato a fare Foucault.Ammettendo tutti i benefit ragionevoli implicati in una svolta lin-guistica, totalizzare l’uomo nelle logiche (pure larghe) del suo par-lare comune è metafisicamente quantomeno operazione degna diqualche eccepire, come se l’umano non si raccogliesse anche inuna dimensione silenziosa del suo essere al mondo (non necessaria-mente poetico), mentre l’inespresso rimane la vera posta in gioco,come un non detto che corrisponde ad un telos mai compiuto perchi indaga l’essere delle cose umane (Habermas in Apel 1992).Ragionando su certi modi di “svoltare” che si pretendendo deci-sivi, Franca D’Agostini domanda:
[…] l’adozione di un “logos linguistico” porta realmente al difuori della metafisica, ovvero della filosofia tradizionale? Il prima-to riconosciuto al linguaggio costituisce un’opportunità positivaper il pensiero, oppure lo imprigiona più saldamente nel destinodella scienza e della tecnica, ultime incarnazioni del logos filoso-fico occidentale? Più in generale, che cosa comporta la sostitu-zione di una prospettiva linguistica alla prospettiva metafisica? Èun’autentica novità, un’autentica frattura nell’ontologia e nellametodologia tradizionali? (D’Agostini 1997: 156).
Oltre le nuove metafisiche della determinazione linguistica delsenso dell’orientamento nel mondo, si deve pure tenere conto chela mente, che si appoggia ad un cervello materiale, mostra alme-no secondo certe prospettive fotografiche di non essere attraver-sata da sole istanze costitutive di senso riducibili ad un piano lin-guistico e logico. Certa neurologia computazionale fa fenomeno-logia di cose che non hanno nulla da dire, né avanzano la pretesa
Filippo Silvestri
24
di farlo, semplicemente perché non sono dotate del dono della pa-rola. La divaricazione che si compie è sul piano epistemologico trauna psicologia dalle larghe prospettive di indagine ed una semio-tica-linguistica di nuovo regionalizzata se misurata con le sue pre-tese, secondo un modo del rimbalzo ermeneutico tra le due disci-pline (Dummett 1988), quasi nel rispetto di un margine dellecompetenze. Ammesso un loro mutuo soccorrersi, resta una certadivaricazione rispetto ai modi ontologici nel trattare le cose cheriguardano l’uomo, tra eccessi metodologici nel discutere il pro-blema del rapporto tra pensiero e linguaggio, quasi sempre sul li-mite di una tentazione mai sopita di ridurre il primo al secondo,se non altro per una certa comodità che ne consegue nel tratta-mento metafisico umano.
6. Pensieri deboli
D’altra parte a quale pensiero ci riferiamo? Forse e per davvero edal di là delle perplessità onomastiche che si possono avere in luo-go di quel battesimo, un pensiero debole, se non altro perché rifles-so della moltiplicazione dei linguaggi, posta la fine delle metafisi-che dell’uno, sancita a vario titolo e in tempi diversi da Nietzsche,Heidegger e dal Wittgenstein che gioca con i linguaggi. Rifacen-dosi al manifesto di questa debolezza, curato da Vattimo e Rovat-ti (Vattimo, Rovatti 1983) la resa nella denuncia di una mancanzadi forza, non significa un ritiro. Anzi, se certe pretese rivolte aduna totalità sono messe da parte perché insostenibili per le spalledi un soggetto che si è moltiplicato e non ha più interessi perun’impresa titanica del genere, la debolezza abbracciata è unosprofondamento nell’essere delle cose e del mondo come nellapropria carne, con uno sguardo oltre il passato monumentale, tra-dottoci dalle testimonianze. Il destino degli eventi descritto daHeidegger è l’insieme delle macerie lasciato giacere come reso(a)-conto di un passato, dove alcuni hanno vinto e molti hanno per-so, rimanendo travolti in questa sconfitta. Ma le tracce lasciate, trale macerie su cui si attarda lo sguardo contorto dell’angelo impe-gnato nel volo nuovo di Klee ricordato da Benjamin (Benjamin1955), mostrano oltre il non-essere-più non solo una serie di tra-gedie di cui avere pietas, ma anche l’insieme-non-insieme delle
La realtà, la semiosi, il linguaggio
25
possibilità che non realizzate si sono realizzate, mostrandosi perspezzoni monchi, tranciati via dall’ordine del discorso dell’impe-ro vincitore. Proprio questa frammentazione dell’essere va raccon-tata, alludendovi con una scrittura che non sia il Zarathustra nic-ciano ma il caleidoscopio delle infinite possibilità di Joyce e deisuoi Ulisse. Lo sminuzzamento del senso corrisponde all’esperien-za quotidiana che ci riguarda non appena smettiamo di guardareal mondo come se fosse lo specchio delle nostre pretese e ricono-sciamo oltre la nausea insopportabile di Sartre, che la vita non èsolo la noia che ci opprime, ma anche l’infinito nient’affatto sog-gettivo delle cose che per quanto inanimate siano, fanno tutte(non insieme) un rumore di fondo che non risponde a nessun or-dine (del discorso).
Per poter ascoltare questa moltiplicazione dei rumori bisognadecostruttivamente partire dalla consapevolezza che quello che ciammorba è la continua semplificazione categoriale alla quale cisottoponiamo volontariamente (passivamente), perché la relazionesociale, se vuol essere coronata da successo, impone una comuni-cazione semplice, che necessaria all’economia dei rapporti, non èsenza una serie importante di rinunce, cui si è costretti per anda-re a ballare in società. Un recupero di quella sensibilità attenta airumori e non solo ai suoni, operazione degna di molte “sospen-sioni”, passa da altrettante prese di coscienza non facili, comequella che dipenderebbe da una nuova relazione al proprio esserecyborg, cosa che implica un’assunzione critica della personale sen-sibilità mediata dalla relazione con le macchine, che fanno da fil-tro esperenziale nella relazione mondana, determinando in modomeccanico, sistematico e trans-umano il nostro sentire la vita(McLuhan 1964).
Assunta questa estetica, la sua evoluzione non semiologicacoincide con una grammatologia (Derrida 1968; Ferraris 1982) sen-za velleità ermeneutiche. La premessa da cui partire è l’assunzio-ne-consapevolezza del proprio essere in un cortocircuito semioti-co, che dipende dalla nostra voce che è il primo segno di una lal-lazione auto-riflettente, che coincide con la scoperta primordialedel possesso di un’anima che sente e che si sente mentre producedei suoni. La voce che passa attraverso la gola-bocca risuona inprima istanza nelle proprie orecchie e questo suono articolato te-stimonia in favore di una presenza autocosciente, la nostra (per
Filippo Silvestri
26
tutti). Questa prima immersione del senso nella semiotica dei se-gni che significano la propria auto-presenza-a-sé, rappresenta lavirata primordiale in direzione di una linea interpretativa del pro-prio essere semiotico al mondo (a tutto tondo), una svolta segna-ta dai segni che escono per suoni articolati dalla nostra res exsten-sa (Derrida 1967).
Data così per assodata questa traduzione pan-semiotica del pro-prio essere mondano (definita su un piano chiaramente intersog-gettivo), acquisita una certa esperienze delle cose nel corso del tem-po, si può scoprire come questa disposizione nel segno della rela-zione con il mondo significhi al tempo stesso l’infinita lontananzada ogni qui ed ora degli altri nel loro rispettivo scrivere, dire, par-lare. La circostanza si può apprezzare in ogni momento esistenzia-le, mentre si trova confermata sul piano intellettuale e letterario: ivuoti storici che separano le epoche della letteratura mondiale im-pediscono qualsiasi tipo di contemporaneità, per quanto uno la vo-glia recuperare facendo affidamento su una stessa familiarità con lelettere, che una volta scritte, dovrebbero poter essere condivise (Ga-damer 1972). Tutta questa circostanziata serie di ragioni (semioti-che) dovrebbero indurre ad una resa kantiana su tutta la linea se-condo un senso critico che non ci consente l’accesso all’an sich delnostro essere come degli altri e delle loro opere, restituendoci alcontempo (oltre le pretese chimeriche di una verità) ad una pre-di-sposizione naturale a restare negli ordini del discorso prevalenti,abitandoli con uno studio rigoroso dei segni e della loro funzionesignificante, forzandoli magari fuori dalla staticità semiotica che liimmobilizza, per trasformali in vettori di senso che siano in gradodi pescare in nuove aree della possibilità semantica, scovando segnicapaci di attivare aree non ancora calpestate dal senso comune. Il pro-getto da perseguire si realizzerebbe così completamente all’internodi un orizzonte linguistico, dentro le sue dinamiche, non mettendoil linguaggio che si usa continuamente di fronte ad un’esigenzaesplicativa veritiera, ma studiandolo nelle sue evoluzioni retoriche(e non solo), ferma restando la variabile rischiosa che questa ope-razione si possa tradurre in un avvitamento nella (della) follia, checresce su se stessa in un soliloquio che si fa forza della propria au-tarchica auto-comprensione.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
27
7. Schemi immanenti
Ribadita l’indipendenza dell’essere dalle sue possibili predicazio-ni, la moltiplicazione dei giochi linguistici studiata da Wittgen-stein rappresenta un perno teoretico invalicabile in senso pragma-tico-metafisico, per cui non ha senso cercare un logos universale,su cui fondare una pretesa democratica globale. Ogni isola lingui-stica e giocosa ha le sue regole e funziona per quel tanto che lacoinvolge in senso territoriale per coloro i quali conosco il mododi giocare, giocando quel gioco. Data questa moltiplicazione del-le aree di competenza, ne consegue una dissoluzione metalingui-stica con un tracollo conseguente di ogni soluzione totalizzante,insieme all’ennesima divaricazione tra un piano linguistico e se-miotico che si fa valere come plausibile in un arco ridotto di in-fluenza da una parte ed uno diversamente cognitivo e psicologi-co, che conserva ampi margini di indagine indipendente da pos-sibili costrizioni linguistiche, avanzando in aree del biologico-na-turale che possono essere davvero comuni. In ogni caso semioti-co o psicologico si tratta di ri-flettersi su se stessi ed ogni ri-fles-sione ha un pregio tutto analitico, che è quello di rivolgere l’at-tenzione ad uno studio immanente della mente. Questa imma-nenza è la vera chiave di volta (Tugendhat 1976): si parte dallacomplessità delle costruzioni logico-linguistiche per guadagnaregli elementi primi costitutivi il pensiero-linguaggio, procedendosenza preoccuparsi della sterilità implicata in ogni ri-piegamentosu se stessi secondo una tesi classica per cui ogni riflessione sareb-be inutile perché poco produttiva, perché solo esplicativa, perchéappunto ri-flessione, per cui kantianamente il predicato è conte-nuto nel soggetto e così procedendo non si andrebbe oltre il sog-getto srotolato secondo i suoi modi d’essere che non implicanorapporto alcuno con un diverso da sé.
Restando in una prospettiva semiotico-cogntiva è noto comesia quasi naturale ridurre l’oggetto dei propri studi ad una rappre-sentazione schematica-esplicativa. Andando per macrocategorie lastessa grammatica universale di Chomsky (1986) è in sintonia consoluzioni del genere, che si concretano in arborescenti disegni fat-ti di linee logiche e simboliche che riproducono gli andamenti(appunto ad albero) delle nostre famiglie linguistiche di apparte-nenza. Leggendo la questione in modo storico, mettendo la scrit-
Filippo Silvestri
28
tura al centro della svolta logo-centrica del pensiero occidentale,Sini guarda anche lui a schemi di questo tipo, leggendoli alla stre-gua di una soluzione lineare del problema della relazione con ilmondo come architrave della determinazione logica del logos, chevale così come unico canone ermeneutico di verità lungo quasitre millenni, con tutte le dimenticanze ritmiche e musicali cheuna diversa oralità conservava tra le sue maglie, animata a sua vol-ta da un pensiero capace di visioni plastiche avvolte nelle diverse so-luzioni semiotiche. Sini:
La verità intesa come corrispondenza del giudizio alla cosaavrebbe allora a suo fondamento il contenuto di una “costruzio-ne”: la costruzione di una realitas geometrica (aritmo-geometrica)fatta di punti astrattamente omogenei linearmenti disposti. Scrit-tura di realtà che vale universalmente e oggettivamente.La verità del giudizio è pertanto solo l’ultimo stadio di questa co-struzione. Il significato linearizzato del logos “si adegua” al carat-tere “logico” (“in sé”) delle cose. Beninteso delle cose preliminar-mente ridotte entro lo schema lineare della definizione, cioè ridot-te ai suoi elementi puntuali e geometrici. Ma tutto ciò il giudi-zio l’ha dimenticato, o, per dir meglio, non l’ha mai saputo. Essovige e detta legge su questa costruzione onto-logica che è il fon-damento invisibile del suo edificio logico (Sini 2009: 83).
La categoria schematica, in ragione delle sue istanze iconolo-giche e grafiche, non è da condannare se guardata da un punto divista metafisico. Per quanti limiti euristici le si possano imputare,essa risponde ad una semplificazione pragmatica della complessitàdelle cose, semplificazione che è una parte importante dei proces-si cognitivi in ragione del loro tendenziale sviluppo. Non che quisi debba recuperare tutto ed a tutti costi, ma ogni analitica dellesemplificazioni simboliche-aritmetiche, che scansa il piano dellacontinua ripetizione dell’intero ragionamento algebrico, rispondead un bisogno di traduzione del processo cognitivo in immagini-segni, per ottenere una mappa che consenta veloci discriminazio-ni categoriali nell’interpretazione del mondo. Il passaggio storica-mente lento dalle immagini e dalle icone ai simboli è stabilito daun salto fenomenologico, che Peirce ha descritto in un modo tal-mente chiaro da costituire con la sua teoria un punto di riferi-mento che vale ancora alla stregua di un irrinunciabile punto ar-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
29
gomentativo. Ma quanto intendiamo sostenere è qui una certacontinuità pragmatica, che va dalla disposizione al disegno delleicone fin dentro la scrittura retta dai sintagmi nominali e verbali.Con Sini (ma si veda allo stesso modo Kallir 1961, a cui Sini si ri-ferisce, il quale a sua volta parla di “stilizzazione”) la questione po-trebbe essere descritta nel modo seguente, con una ripresa ad in-crocio di alcuni momenti del Fedro di Platone con altri essenzialidella semiotica di Peirce:
In altri termini: la parola che analizza e che giudica (krinein) nonè la parola che nomina, che evoca, oppure che cha narra l’azioneo l’accompagna (“Via sulle navi, Achei!”; oppure “Via sulle navi,filosofi!”, come diceva Nietzsche). Questa parola analitica mirainvece a formare un’immagine o mimesis logica delle cose. L’im-magine è poi più propriamente un diagramma (come direbbePeirce), uno snodo di linee entro un grafico (entro un “foglio-mondo”, direbbe di nuovo Peirce); e questa letteralmente, è la de-finizione (Sini 2009: 23).
Se si assume il problema “linguaggio” in senso genetico distin-guendolo da quello linguistico delle lingue, il “linguaggio” è inprima battuta un congegno di modellazione specie specifico dell’uomo(Sebeok 1991). Rispetto al mondo della vita ed in ragione delle suecomplicazioni una parte importante del linguaggio rappresentaun “modello” in miniatura della complessità di quanto altrimentiè intreccio e chiasma. Certe grammatiche universali non sono (for-se) né più né meno che modelli (anche macroscopici in senso co-gnitivo) del funzionamento delle mente nel suo atteggiarsi logicoe linguistico nei confronti di se stessa, come del mondo con cuientra in relazione: da una parte tutta la disposizione innata carte-siana dei propri dispositivi come dotazione genetica, dall’altra lacircostanziata esperienza a seconda del tempo-luogo dove-quan-do si nasce e cresce. La grammatica generativa è secondo quest’ideauna proiezione schematica non del mondo com’è ma della men-te come è disposta-disponibile fin dall’inizio verso lo stesso mon-do, nuovo trascendentale biologico-cognitivo, essere-comune delgenere umano, nuovo schema logico della scrittura di come ci siimmagina siano tutti gli uomini. La lezione di Sebeok sui model-li e sugli schemi antropologici e mondani, che qui riproponiamo,vale prototipicamente alla stregua di una ripresa iconica di una
Filippo Silvestri
30
ipotesi sulla possibile origine del senso in un legame primordialecon un segno (iconico) che, caratterizzato da una consistente quo-ta fenomenologica di somiglianza, che spiega il suo funzionamen-to nel rapporto con il significato-referente, può degenerare (nelcorso del tempo) rispetto alla sua disposizione iconica-immagini-fica seguendo gli andamenti di una dialettica dell’astrazione sim-bolica, con tutti gli scarti dell’arbitrarietà che questi salti-passaggidalle icone ai simboli comportano. Sebeok:
Nei primi ominidi, il linguaggio non veniva usato per la comuni-cazione, ma per la “modellazione”, cioè per un’analisi raffinata delloro ambiente […] Tuttavia, la nostra specie alla fine riadattò il lin-guaggio in una serie di manifestazioni lineari, prima il parlato epoi gli altri mezzi, come la scrittura, che fioriscono come sistemisupplementari rispetto a quelli fondamentali e più antichi, con cuicomunica anche l’umano moderno (Sebeok 1991; trad. it.: 78).
Alcune considerazioni vogliamo aggiungere a quelle già fatte,non in un’ottica esaustiva ma in una prospettiva integrante, chedice dell’apertura del problema oltre ogni sua possibile soluzione.Il problema dell’elaborazione di uno schema, che possa avere del-le pretese strutturali e per certi versi strutturanti il discorso sul pia-no estetico e su quello semantico e cognitivo, sembra avere a chefare, come è ovvio, con un problema più generale di categorizza-zione. Che cosa fa di una categoria una categoria come tale capa-ce di riassumere dentro sé una fenomenologia significativa ed im-maginifica fatta di diversi esemplari? Una delle risposte plausibilipuò essere cercata dentro le maglie complicate di quanto viene al-trimenti discusso come “proto-tipo”. Si tratta di muoversi all’in-terno di un’area estetico-semantica, all’interno della quale è pos-sibile cercare una mappatura delle proprietà essenziali (e periferi-che) concorrenti ad individuare un certo gruppo di appartenen-za-condivisione. Queste proprietà essenziali possono avere un ca-rattere generale, quasi diremmo “primo” in senso aristotelico, co-me possono diversamente risultare dalla progressione realizzatanell’ambito di un complesso processo cognitivo, dove esse vannodefinendosi secondo incroci esperienziali più o meno complicati,comunque controllati nella determinazione delle relazioni sociali.Anche in questa seconda prospettiva la definizione di questi am-biti identitari della significazione e dell’interpretazione non è im-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
31
mediata e non è priva di una une serie di sfumature, che apranogli spazi della contraddizione, dell’ambiguità e dei sensi doppi etripli. Solo a considerare la cosa dal punto di vista della razza edella specie umana, lo stesso “umano” riesce a districarsi con dif-ficoltà dalle sue parentele vischiose con altre specie animali cherestano come fossero sul suo confine identitario ed ontologico,confondendo le categorie che aiuterebbero una sua definizione,individuazione. Del resto nella catena di incroci che vanno da unA ad un D, ammettendo che non c’è rapporto diretto da A a D,ma secondo una trafila mediata attraverso B e C, la loro assolutaestraneità è messa in crisi dalla linearità e circolarità dei rapporti,che regolano la continua migrazione da una campo animale e se-mantico ad un altro. Il meticciato della significazione è un feno-meno difficile da gestire con una netta separazione dei campi ca-tegoriali. Detto quanto si è detto, certe ipotesi da verificare speri-mentalmente restano e vengono ricordate così da Taylor (1995;trad. it.: 117), che nelle sue argomentazioni si appoggia nel caso aLangacker (1987), proprio ragionando di prototipi e schemi e gra-di della somiglianza, nel senso in cui abbiamo provato a discuter-ne noi nella prospettiva di un andare semantico e cognitivo, anco-ra estetico dal più concreto al massimamente astratto:
Un prototipo è un esempio tipico di una categoria, ed altri ele-menti vengono assimilati a quella categoria sulla base della per-cezione della loro somiglianza col prototipo; ci sono gradi di ap-partenenza basati su gradi di similarità. Uno schema, al contrario,è una caratterizzazione astratta che è pienamente compatibilecon tutti i membri della categoria che esso definisce (pertantol’appartenenza non è una questione di gradi); è una struttura in-tegrata che include l’insieme dei suoi membri, i quali sono atti-vità concettuali più specifiche e dettagliate che elaborano loschema in modi contrastanti (Langacker 1987: 371).
8. Immagini trascendentali
Così oltre le appartenenze di scuola (continentale, analitica) unostudio della fenomenologia delle icone, dei grafi e delle omologieche le sottendono in un confronto, può essere fondante, in alcunicasi decisivo, se capace di stare a cavallo trascendentale tra un’este-
Filippo Silvestri
32
tica dalle larghe vedute ed una semiotica che abbia anch’essa am-pi orizzonti nell’indagine che si prefigge. Certamente un punto diconvergenza si potrebbe realizzare se si cominciasse ad ammette-re che qualunque modello o schema di riferimento è tanto piùvalido-efficace quanto più “coglie nel segno”, se avvicinando ilsuo oggetto, si determina a partire da una sua costitutiva variabi-lità che tenga le fila aperte del discorso, sforzandosi in modo ab-duttivo nello studio di possibili omologie tra sé come metodo-studio e l’oggetto delle proprie indagini (Rossi Landi). Detto al-trimenti: mi propongo un’analisi ed a tal fine elaboro, a partire dalmateriale a disposizione, uno schema, un modello esplicativo, do-ve questo ultimo ha tanto più valore quanto più “assomiglia” al fe-nomeno, ai fenomeni che si propone di descrivere, salva fatta lasua distanza costitutiva dagli esempi che si propone di analizzare,salva fatta la sua flessibilità iconica e simbolica, considerato il pro-cesso descrittivo come mai completamente compiuto. Ovvero edancora e sulla stessa linea: ogni applicazione di un metodo deveavere di sé una consapevolezza metalinguistica, in modo tale chechi lo usa, sappia a quali varianti ermeneutiche si sta affidando,con le conseguenti scivolate autoriflessive che uno studio com-porta inevitabilmente. In una sorta di gioco al rimbalzo, guardoall’oggetto linguistico dei miei studi e mentre lo analizzo, pongocostantemente in questione il modello epistemologico che mi staguidano nelle analisi, nella misura in cui quello che cerco assomi-glia per certi aspetti proprio a me che faccio uso di un linguaggionel momento delle mie ricerche.
Tutto o quasi tutto si determinerebbe nell’intendere nel mo-do corretto due diversi ordini del discorso, che così proviamo ariassumere. Il linguaggio come capacità simbolica di rappresenta-re il sé ed il mondo nella loro relazione, sul doppio piano primasignificativo e poi comunicativo, quel linguaggio-lingua si fondasu un “trascendentale” aperto di per sé ad infinite interpretazionia seconda della prospettiva dalla quale lo si guarda. Per esplicitareil punto, non c’è logica formale che non abbia bisogno di una logi-ca trascendentale, non c’è linguistica e grammatica delle lingue sto-riche che non si fondi su una logica dei contenuti significativi, chea sua volta rimanda ad un rapporto con il mondo della vita ovverocon un common sense, a seconda del grado di profondità analiticache si vuole raggiungere. Ora, come intendere questa logica tra-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
33
scendentale fondante? Una risposta univoca (ovviamente) è im-possibile. Quelle che invece proponiamo sono due diverse varian-ti ipotetiche, lontane tra loro, riconducibili rispettivamente adHusserl e a Rossi Landi, due soluzioni divergenti-convergenti nelcomune sforzo cognitivo (e non solo) di rendere conto di alcunitramiti fondamentali della relazione con il sé e con il mondo. Almodo di un mero riferimento teoretico si sa come Husserl, lun-go larga parte della sua fenomenologia, si sia sforzato di descrive-re come tra la logica trascendentale, che regola l’esperienza senso-riale-percettiva delle cose e quella formale e categoriale, che restaa fondamento della logica dei contenuti significativi del giudizioapofantico, ci siano delle relazioni non solo omologiche ed ana-logiche, ma anche di tipo fondativo, il che giustifica una possibilerelazione altrimenti complessa tra le sfere percettive e logico-ca-tegoriali, nella definizione di un piano cognitivo comune.
Su un piano diverso Rossi Landi (Ponzio 2011) ragiona su untrascendentale semiotico, che chiama “parlare comune”, che si con-figurerebbe a metà strada tra la parola singolarmente presa nella suavalenza enunciativa ed il sistema totale della lingua, all’interno delquale quella singola parola ha vita e normale-normato svolgimen-to. Il parlare comune corrisponde così ad una serie di funzioni “co-muni” in una societas, che in forza del suo avere in comune qualco-sa da un punto di vista funzionale alle sue esigenze significative ecomunicative, sta “insieme” seguendo un possibile accordo erme-neutico, nonostante le differenze che la accomuna, differenziando-la al suo interno. Parlare in comune significa condividere una storiaed una politica, mentre resta escluso dai rapporti chi non è dispo-sto a dare ragione alle scelte che si fanno (comuni in comune), nonaccettando in questo consesso che certe ripetizioni espressive pos-sano anche essere stucchevoli iterazioni (per quanto necessarie albene comune), laddove è fisiologico che un corpo linguistico pog-gi i suoi piedi saldi su un piano che si è dimostrato solido per la suaesistenza-resistenza. Secondo uno stile che si ispira ad una lezione-modello kantiana ed andando oltre, Rossi Landi può scrivere di unlinguaggio che è “connesso con il pensiero” costituendo con lostesso un a priori, secondo un parlare da intendere come “attività aradice più fisiologica che storico-culturale” e pertanto “distinguibi-le dalle varie lingue naturali”, un parlare che è un “parlare comunecome insieme di tecniche umane spontanee relativamente costan-
Filippo Silvestri
34
ti”, ispirate da una “certa “ripetibilità di categorie, strutture, signifi-cati e rapporti significanti fondamentali, precedenti rispetto a qua-lunque costruzione volontaria in vista di fini delimitati” (Rossi-Landi 1961: 160-161). Se si guarda a quanto detto nella prospetti-va di un confronto teoretico, allora la logica trascendentale husserlia-na e il parlare comune di Rossi-Landi sono due varianti di un discor-so sul trascendentale, assunto in ragione delle sue valenze e funzio-ni pre-categoriali, pre-semiotiche. Prima che l’uomo parli, la suamente è in grado di dare un senso alla vita del pensiero che la ani-ma, tracciando coordinate che resteranno come solchi del suo esse-re al mondo, lungo i cui tracciati scorreranno le parole grammati-calmente organizzate, che scivoleranno via naturalmente predispo-ste, perché hanno trovato un terreno comune già dissodato in mo-do pre-categoriale-pre-semiotico.
9. Espressioni e contenuti
Senza scendere nei particolari delle posizioni discusse e riallac-ciandoci a quanto detto in precedenza a proposito di schemi emodelli, è come se alla luce delle posizioni segnalate, con valoridiversi, perché da una parte inscritte in una prospettiva cognitiva(Husserl) e dall’altra in una serie di ragionamenti di tipo politicoe sociale-economico (Rossi-Landi), comunque il discorso criticoe teoretico ogni volta si rianimasse in una sfida lanciata all’impos-sibile ricerca dell’essenza dell’umano. Non si può escludere apriori che nella mente si costruisca in progressione un fondamen-to pre-semiotico che sia alieno rispetto al successivo “parlare co-mune”. L’idea è che ci sia per tutti dentro la mente-cervello unastruttura estetica e cognitiva, plastica perché in continua evoluzio-ne, un governo-motore delle funzioni elementari, che svolge lesue funzioni prima che la varietà linguistica disegni popoli e ter-ritori, confini, amicizie e inimicizie, comprensioni ed incompren-sioni. Non è questione di forzare a tutti costi un confronto este-tico e semiotico, in un salto epistemologico sempre difficile dacompiere, in ragione di uno spazio vuoto che non è facile colma-re tra le due discipline, dove dalla parte dell’estetico regna sovra-na la costituzione del senso, mentre nei territori segnati dal lin-guaggio è in gioco una questione legata all’interpretazione delle
La realtà, la semiosi, il linguaggio
35
varianti del significato. Tuttavia, ribadite queste differenze cheemergono fenomenologiche, se guardate dal lato dell’oggetto distudio, si consideri in modo analogico il quadro messo insieme daHjelmslev (1943) per rendere conto della differenza tra espressionee contenuto. Seguendo una prospettiva descrittiva, che fa affida-mento su immagini dal tenore più o meno metaforico, si sa comeper Hjelmslev il fenomeno linguistico possa essere studiato allastregua di un dato complesso, disposto su due piani che sono in-trecciati. Le due fenomenologie corrispondono ad altrettante di-mensioni, nella cui prospettiva si ritaglia il “semiotico” nella suacomposizione: da una parte la materia fonetica assume certe for-me perché segmentata seguendo certe “linee”, come d’altra partela costituzione del significato dipende da certi ri-tagli, che fannola pertinenza in senso “astrattivo” di alcuni momenti ed altri pezzidell’organizzazione semantica del discorrere. Il doppio piano “te-stimonia” in direzione analogica di una materia, reale ed irreale,che si costituisce in ragione di un Ur-teil che porta alla costituzio-ne di modelli proto-tipici, un Ur-teil del senso trascendentale fo-netico e semantico, che consente i processi di identificazione edinterpretazione (per type e token) alla base dell’uso e della com-prensione di un linguaggio. Così se sul piano fonetico quest’idea-immagine proposta da Hjelmslev appare più chiaramente nel suoconcreto farsi, il discorso si complica in senso metafisico quandoci si sposta sul versante significativo, cercando corrispondenze delgenere. In questo campo i tagli e le pertinenze, i modelli che por-tano all’identificazione di un contenuto significativo sfumano,perché avvolti nell’area rarefatta che si respira a cavallo tra le di-verse regioni della semiosi considerate a partire dalle loro rispet-tive aree semantiche, fermo restando che i segni che attraversanoquesti spazi semiologici sono come ganci e reti, ami che pescanoad incrocio nelle astrazioni concettuose-significative, disegnandouna rete di relazioni più o meno evidente, più o meno visibile dalpunto di vista significativo. Dunque il piano dell’espressione vie-ne ri-tagliato per ottenere suoni e visioni, mentre in parallelo e se-condo modi propri (da considerare analogicamente) si disegnanomodelli sfumati di significato, contenuti dai segni che li aggancia-no per significarli in modo esplicito, per comunicarli in società.Queste operazioni di selezione semiotica e di costituzione-deter-minazione di pertinenze linguistiche plausibili, a seconda delle
Filippo Silvestri
36
grammatiche e delle prammatiche in uso nelle diverse comunità,queste operazioni trascendentali (dicevamo) possono essere de-scritte-ricostruite attraverso schemi analitici, grafo-logici, realiz-zando insomma dei disegni che sappiano rendere il senso delleomologie intuite, omologie che lasciano intendere certi percorsioriginari (trascendentali) del senso, salva fatta la variabilità intrin-seca degli stessi schemi, come parte promotrice la loro eventualeevoluzione-utilizzo, come ancora la loro completa implosione,come ancora ed infine la rivelazione di tutta la falsità che li con-traddistingueva e che non appariva come tale a fronte dei presun-ti successi euristici, che li continuavano a sorreggere.
In fondo qui non si tratta di sposare ad ogni costo un proget-to di indagine fondato su una ricerca di rapporti omologici ai li-miti della distorsione, nel disconoscimento delle differenze chevalgono su piani diversi e olistici, magari arrivando ogni volta adi-mostrare somiglianze che alla conta sperimentale si rivelanodelle forzature, con tutto il ritorno nichilistico che queste smen-tite possono comportare. Quanto proponiamo come base per unragionamento è solo una nuova analisi critica di un vecchio ada-gio, che è quello che ricorda che verità, metodo e discorso spes-so si somigliano, perché rispondono ognuno a modo suo ad unaserie determinata di percorsi interpretativi per lo più consuetudi-nari perché tipici (ovvero sulla via di una loro tipicizzazione), go-vernati dal common sense che regola a sua volta una comunità lin-guistica, che si raccoglie intorno alle sue fondazioni semiotiche,tagliando e ritagliando a seconda delle sue esigenze i pezzi d’aria,di carta ed inchiostro che le servono per mettere insieme gli stru-menti del suo comunicare. Il segno nel suo complesso è sottol’egida di una determinazione legislativa in ogni suo momento-motore, dal piano fonologico a quello semantico, fin dentro le tra-me iconologiche della sua determinazione referenziale-indicale.All’interno di questi presunti regimi democratici della significa-zione-comunicazione ogni devianza dal consueto funzionamentonon è ammessa, perché non è condivisibile e quando lo è, è am-messa e vale alla stregua di un miracolo-trauma, che sarà assorbi-to in un flusso comunicativo delle rappresentazioni dominanti, peressere trasformato secondo i canoni sensibili e sensuali che vannoper la maggiore, a seconda dei modi della tecnologia prevalente.L’agire comunicativo continua a non avere funzioni dialogiche, rin-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
37
corre poche verità, mentre non si veste quasi mai di valori etici,perché acquista significato anche nelle sue versioni avanguardistenella misura in cui queste sono assorbite dallo scambio delle mer-ci, nel commercio delle performance artistiche o d’altra natura, sia-no esse all’insegna delle rappresentazioni più verbali-verbose oappartengano diversamente ad una dimensione estetica poco lo-quace, nient’affatto incline alla comunicazione, muta nel suo sten-dersi in un non-senso che si rifiuta alla significazione.
10. Strutture
Rispetto al quadro delineato ci ripetiamo con Barthes (1964), percui ogni disposizione strutturale della ricerca deve prefiggersi co-me compito minimo-base un’analisi fenomenologica capace dielaborare un simulacro-schema-modello di mondo, che sia dota-to di uno o più sensi, che si riconoscano parte di una Weltan-schaung socialmente e storicamente determinata, risultando da unascomposizione, classificazione e ricomposizione del problemapreso in carico, rispetto al quale il modello-schema sperimentatosi propone come un’analisi-soluzione comunque problematica. Suquesto punto le istanze teoretiche di Barthes sono in chiaro: la di-sposizione alla scomposizione, ricomposizione ed enumerazionedegli elementi a disposizione nella costruzione di un simulacro-modello teorico di indagine coincide con quella che è la prassicomunemente intesa ovvero ancora in senso largo con l’esperien-za umana, in modo trasversale nel tempo, così oggi come alloranella Grecia delle prime invenzioni intellettuali. Da una parte unmetodo che viene elaborato, costruendolo a partire da una intela-iatura fatta di strutture analitiche capaci di una lettura fenomeno-logica; dall’altra un oggetto di studio a sua volta guardato in mo-do tale che appaia come già messo in posa per una sua fotografiastrutturale. Ciò che rimane ogni volta è una coincidenza-circola-re-strutturale di modo soggettivo d’analisi-studio e disposizioneoggettiva della cosa-uomo (studiata). Certamente intorno alle ca-pacità euristiche ed ermeneutiche di ogni modello-simulacro sigioca la quota epistemologica che gli si riconosce, dove il suo fun-zionamento spesso dipende dalla ristrettezza del campo di appli-cazione.
Filippo Silvestri
38
Con Deleuze (1969) si tratta poi di capire come questa strut-tura, soprattutto se intesa dal lato della “cosa” che si cerca di guar-dare-descrivere, sia un centro-luogo-non-luogo composto da for-ze positive, attive e dinamiche, raccolte in un insieme-non-insie-me organico-inorganico, che si costituisce disfacendosi ogni voltaanche (tra l’altro) in ragione di una serie dinamica di forze attivee reattive, che vivono muovendosi nei solchi tracciati dai flussi se-mantici più evidenti, che a loro volta alimentano alla stregua diun’istanza di fondo in ragione di un senso evidentemente pluri-mo e molteplice. Per Deleuze ogni struttura è una macchina ovve-ro con le sue parole prese da un saggio dedicato al “fenomeno-strutturalismo”, è «una molteplicità interna, un sistema di rappor-to multiplo non localizzabile tra elementi differenziali, che si in-carna in relazioni reali e termini attuali». La struttura è «[…] unacombinatoria di elementi formali che di per se stessi non hannoné forma, né significato, né rappresentazione, né contenuto, nérealtà data, né modello funzionale ipotetico, né intelleggibilitàdietro alle apparenze», per cui «il senso risulta sempre dalla com-binazione di elementi che non sono di per sé significanti», fino alpunto che si può dire «[…] che c’è, profondamente, un non-sen-so del senso da cui risulta il senso stesso» (Deleuze 1969). Gli ele-menti che concorrono alla costituzione di un senso non sono ele-menti ma forze e non sono unità di senso ma flussi di energia, chesolo nel momento della loro combinazione danno luogo a dellestrutture che possono apparire sensate e che tali sono nel momen-to in cui si offrono allo sguardo in un istante della loro combina-zione, quasi fermi nell’abbaglio fotografico che coglie un mo-mento del loro movimento. Del resto la stessa struttura è un in-sieme che emerge in ragione della combinazione dei suoi ele-menti e se misurato con una sua eventuale collocazione nello spa-zio-tempo è un fantasma sfuggente, la cui presenza si può intuiresolo se il “tutto” è preso nel suo complesso. E tuttavia, insieme conBarthes, non è possibile uscire dal gioco strutturale: è come se lanostra mente non avesse altre risorse logiche e grammaticali-ge-nerative, per cui i suoi occhi non vedono che un mondo che siregge in piedi per un senso, perché ha fondamenta strutturate chelo rendono solido e pertanto visibile. E’ forse questo il frutto diuna disposizione naturale e storica del rapporto con le cose sem-pre guidato dalle parole che lo presentano e lo descrivono?
La realtà, la semiosi, il linguaggio
39
La disposizione strutturale delle cose e degli uomini, il giocodel continuo rimando dei pezzi e dei momenti nel gioco semio-tico, non sempre e non necessariamente si determinano nel siste-ma del rimbalzo dal segno al significato ed ancora al referente, neldoppio modo, nel senso duplice del rimando dai segni ai significa-ti, dai segni-significati al mondo reale, come cosa alla quale si“guarda” quando si parla, si scrive, si comunica. La perfezione di unsistema, in ragione delle sue radici strutturali, può coincidere conl’intrinseca perfezione tipica di un “codice”, che perfettamente au-to-referenziale, è come sganciato da qualsiasi determinazione disenso. Che senso ha il gioco a cui giochiamo? Nessuno, se non ilpiacere estetico ed estatico di vedere all’opera una macchina per-fetta, perché tutti gli ingranaggi che la muovono, funzionano al-l’unisono, senza tuttavia che quel suono sia un segno, senza chequel meraviglioso ingranaggio che è un simulacro della realtà, ab-bia la ben che minima relazione con ciò che si vorrebbe, si preten-derebbe esso simulasse. Il lavoro produttivo fine a se stesso funzio-na senza essere funzionale alla creazione di una ricchezza, di unarisorsa che possa essere utile a qualcuno. La rappresentazione dellarealtà è una rappresentazione della rappresentazione, in un riman-do che va da significante a significante, senza che ci sia un passag-gio al significato, senza che tutta la produzione immaginaria abbiaun appiglio con la realtà, quasi tutto fosse in un ingorgo attraver-so il quale non passa il flusso della significazione, vuoto di senso edi significato, assenza di una relazione nel sistema olistico del con-tinuo rimando concentrico, dentro un sistema semiotico struttura-le-strutturato in pieno corto-circuito, privo di una relazione conun fuori. Termini s-terminati. Baudrillard negli anni settanta scrive-va di una reversibilità del sistema-struttura, un ri-baltarsi della strut-tura su se stessa, comunque la si voglia intendere, in un parallelo trasemiotica ed economia, che dimostra a distanza di quarant’anni,come le cose in sé non siamo molto cambiate:
La dimensione strutturale si autonomizza a esclusione della di-mensione referenziale, si istituisce sulla morte di quest’ultima. Fi-niti i referenziali di produzione, di significazione, d’affetto, di so-stanza, di storia, tutta questa equivalenza a contenuti “reali” chezavorrano ancora il segno d’una specie di carico utile, di gravità:la sua forma di equivalente rappresentativo. E’ l’altro stadio delvalore che la spazza via, quello della relatività totale, della com-
Filippo Silvestri
40
mutazione generale, combinatoria e simulazione. Simulazione,nel senso che tutti i segni si scambiano ormai tra loro senza scam-biarsi più con qualcosa di reale (e non si scambiano bene, non siscambiano perfettamente tra di loro che a condizione di non scam-biarsi più con qualcosa di reale). Emancipazione del segno: svin-colato da quell’esigenza “arcaica” che aveva di designare qualco-sa, esso diventa infine libero per un gioco strutturale, o combina-torio, secondo un’indifferenza e una indeterminazione totale, chesuccede alla precedente regola di equivalenza determinata. Me-desima operazione al livello della forza-lavoro e del processo pro-duttivo: l’annientamento di qualsiasi finalità dei contenuti di pro-duzione permette a questa di funzionare come un codice, e al se-gno monetario, per esempio, di evadere in una speculazione in-definita, al di fuori di qualsiasi riferimento a un reale di produ-zione o persino a un tallone aureo. La fluttuazione delle monetee dei segni, la fluttuazione dei “bisogni” e delle finalità della pro-duzione, la fluttuazione dello stesso lavoro – la commutabilità ditutti questi termini che si accompagna a una speculazione e aun’inflazione senza limiti (si è veramente nella libertà totale: disaf-fezione, disobbligazione, disincanto generale: è ancora una magia,una specie di obbligazione magica che teneva il segno incatena-to al reale; il capitale ha liberato i segni da questa “ingenuità” perabbandonarli alla circolazione pura) – tutto questo, né Saussurené Marx lo presentivano: essi sono ancora nell’età dell’oro d’unadialettica del segno e del reale, che è allo stesso tempo il periodo“classico” del capitale e del valore. La loro dialettica si è squarta-ta e il reale è morto sotto il colpo di questa autonomizzazionefantastica del valore. La determinazione è morta, l’indetermina-zione è sovrana. C’è stata una s-terminazione (nel senso letteraledel termine) dei reali di produzione, del reale di significazione(Baudrillard 1976; trad. it.: 18).
11. Il pensiero è una cosa in sé
In questa trama in continuo facimento-disfacimento i buchi ne-ri semiotici (inevitabili) si aprono in continuazione come risorsedi senso in una progressione semiotica nella conquista del territo-rio abitato dalle cose-uomini. La Bedeutung di Frege è il modosingolo della freccia significativa nel suo rivolgersi particolare allacosa delle sue rappresentazioni, è una nuova porzione guadagnataal quadro rappresentativo, all’interno del quale il processo della si-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
41
gnificazione si muove per passi brevi e lunghi che fanno i conticon un’impossibile colonizzazione dell’essere. Ogni oggetto deldiscorso è una frazione-momento, la parte di un mondo cultural-mente determinato. L’oggetto del mio discorso è sempre un tokendi un certo type (Eco 1975: 90-91), secondo la caratteristica deimodi della rappresentazione significativa, per cui la determinazio-ne del senso avviene in forza di una doppia articolazione della suadeterminazione oggettuale, generale e particolare. Alla fine resta allimite di ogni considerazione plausibile proprio quella dimensio-ne del pensiero “oltre la siepe” del linguaggio che lo parla (il pur-pot hjelmsleviano), secondo un ribaltamento fino ad un certopunto paradossale, per cui non c’è più una cosa in sé, ma un pen-siero in sé irraggiungibile, pur rappresentando esso stesso quellamateria di cui è fatta l’espressione come ancora il contenuto si-gnificativo in ragione dei tagli e ri-tagli trascendentali utili al suoorientamento. Il Putnam (1978) citato da Chomsky (2000), avreb-be scritto che il problema è che:
[…] se siamo realisti dobbiamo ammettere che non otterremomai un modello esplicativo dettagliato per il genere naturale “es-sere umano”», non per la «mera complessità» di tale modello maper il fatto che «siamo parzialmente opachi a noi stessi, nel sensoche non abbiamo la capacità di comprenderci l’un l’altro così co-me comprendiamo gli atomi dell’idrogeno». Si tratta, affermaPutnam, di un «fatto costitutivo degli esseri umani nel periodo at-tuale», anche se la situazione potrebbe essere diversa fra qualchecentinaio di anni (Chomsky 2000: 71).
La cosa in sé non è una cosa ma un purpot ovvero «un’entità ina-nalizzata definita solo dalla sue funzioni esterne» rispetto alla quale«ogni lingua traccia le sue particolari suddivisioni» come muoven-dosi all’interno di una «“massa di pensiero” amorfa», dando «rilie-vo in essa a fattori diversi in disposizioni diverse», ponendo «centridi gravità in luoghi diversi», dando «loro enfasi diverse» (Hjelmslev1943; trad. it.: 55-56). Così all’immanenza mentale delle istanze co-stitutive che ogni grammatico generativo riconosce come luogodella determinazione prima del senso, si affianca con Hjelmslev unmarcare quelle funzioni esterne della cosa-in-sé-purpot-pensiero-fantasma che resta invisibile, mentre si mostra per quel tanto che sisporge sul mondo nella sua relazione con lo stesso.
Filippo Silvestri
42
A questo punto è legittimo domandarsi in che misura abbiaancora senso ragionare intorno ad una cosa in sé, sia essa un esse-re-mondo che ci fronteggia o un altro-noi che abitiamo comemente o come corpo. Ad esser rigorosi, una possibile replica suo-nerebbe, secondo note che evocherebbero il senso dei limiti del-la prospettiva dalla quale guardiamo le cose, per cui bisogna ricor-darsi che l’indiscernibile è “fuori discussione” (e qui vale semprel’adagio del Wittgenstein del Tractatus, secondo il quale su ciò dicui non si può parlare, in certo modo si deve tacere), mentre que-sta assenza del senso corrisponde ad una materia che si offre sen-za alcuna ragione da dare, con tutta la durezza resistente che laconsolida. Resta vero che il mondo delle rappresentazioni assumeforme e contorni proprio appoggiandosi come una pellicola suquelle resistenze ontologiche dell’essere, quasi inguainando ilmondo, che appare trasparente, assumendo le fattezze di una fan-tasma a cui è stato gettato un lenzuolo addosso (Eco 1997): la tra-ma delle parole si stende come una continua lotta al non sensomortale delle cose, perseguendo una conquista significativa in cuisi disegna la trama di un dialogo che cerca accordi per sopravvi-vere a questa in-differenza ontologica che l’essere umano provavivendo il mondo. Oltre l’ineffabile e nel quadro di una riduzio-ne fenomenologica del problema a quello che può essere indaga-to, il linguaggio e le semiosi che lo attraversano è un parlare comu-ne con tutte le sue determinazioni storiche e le alienazioni che gliappartengono, secondo gli usi che lo regolano nei giochi del suomoltiplicarsi, in un rimando aperto o chiuso di senso, che puòavere determinazioni più o meno olistiche, a seconda dei gradi ditraducibilità con cui si offre per una sua manipolazione. Da unaparte resta il purpot-pensiero con i suoi caratteri-non-caratteri-in-alienabili, dall’altra il linguaggio, i linguaggi, le lingue, che cresco-no su se stessi in modo esponenziale seguendo le semiosi limitateed illimitate che li attraversano, vivificandoli. I sensi, i significati ditutti i segni sono inscritti nelle ruote semio-logiche in cui circo-lano, viaggiando di metafora in metafora per aree semantiche piùo meno familiari, fermo restando il continuo alternarsi di luci edombre in questa rotazione delle colture linguistiche, che consen-te la crescita degli orti e dei giardini popolati dalle parole.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
43
12. I motori della semiosi
Tutto sta a stabilire, nei limiti del possibile in una prospettiva didiscorso filosofica sul linguaggio, quali siano i confini entro i qua-li si gioca la partita semiologica, individuando i partecipanti alconfronto, nei ruoli dominanti che essi occupano, perché il pesopolitico che rappresentano e che posseggono è direttamente pro-porzionale alle quote scientifiche di rappresentanza politica cheottengono. Poi poco (o molto) conta decidere se il dominio del-la semiosi sia spostato sul versante significante o su quello signifi-cativo: con Barthes (Barthes 1973; 1978), almeno, appare chiarocome la questione sia di difficile soluzione, perché il motore ac-cesso (o spento) della semiosi può trovare fluidità per i suoi ingra-naggi una volta trainato da una forza che attraversa le parti espo-ste della semiosi (quelle che compongono il segno nella sua ma-terialità significante-perpecibile), dove in altre circostanze la spi-rale semiotica trae la spinta da una riserva di senso-significato pro-dotta dall’accavallamento continuo delle aree semantiche in cui ilpurpot semiologico esplode ed implode come lava che ribolle, ac-quisendo e perdendo modi e forme per una sua eventuale comu-nicazione-significazione, nella determinazione delle aree di in-fluenza che regolano l’impero dei segni. I segni possono rivelarsiin certi momenti della loro vita autentiche “mostruosità”, soprat-tutto quando concorrono all’ingorgo del flusso della significazio-ne: alcune aree del significato-contenuto si ossidano se assumonoconfigurazioni statiche o poco flessibili nel momento della lorointerpretazione. Preso atto che dal linguaggio non si può uscire,che non si fugge dalla dimensione verbale (quasi fosse un “verba-le” dai risvolti polizieschi), se non altro se si è impegnati in un’in-dagine di carattere meta-linguistico, la ri-vitalizzazione dei sensi,dei segni e dei significati resta a portata di mano, se spostata in unorizzonte letterario, dove le varianti sono con più favore accetta-te, realizzando così un ritorno ad una “scienza alla narrazione”, se-guendo nuovi ritmi che solo una oralità impossibile liberata dallascrittura potrebbe garantire. Chi ha dimestichezze con la scritturaletteraria, non si accontenta del vocabolario e del dizionario tra-dizionali e proprio studiando l’aspetto visibile del segno, lavora aduna metamorfosi dell’aspetto significante. Qui ritorna con Barthesl’idea che Joyce possa in certi casi più di Nietzsche, proprio sulla
Filippo Silvestri
44
linea indicata da Nietzsche di uno Über-Mensch semiotico, cheparla la stessa lingua da sempre parlata e detta, sapendole dare nuo-vi toni, pescando in nuove aree del senso e del significato, facen-do uso di lenze-ami-segni torti in forme diverse rispetto a quelleche si comprano al miglior prezzo sul mercato. Questo lavoro sul-l’aspetto evidente del segno implicherebbe un ritorno alla suamusicalità, quasi questa ripresa fosse capace di evocare nuove areeinesplorate (dimenticate) del purpot pensiero, atrofizzato su posi-zioni ovvie e abitudinarie (Marrone 2000: 32).
Quanto sembra costante alla luce di ogni possibile variantenella discussione del problema è una sintesi di visibile ed invisibi-le, segno e significato, corpo e spirito, sinoli di materia e formache muovono il divenire semiotico, dove insieme ad un elementofermo ed invariabile, utile all’identificazione del senso, si accom-pagna un diversificarsi della significazione, che produce gli sposta-menti di senso del caso, comportando le eventuali smentite che sidevono rispetto alle identità ermeneutiche acquisite, fino ai limi-ti di una spersonalizzazione della semiosi, per cui non solo si èdetti e parlati, ma si è anche trascinati, determinati e ri-semantiz-zati, continuamente, a seconda del punto-maelstrom del vortice si-gnificativo-comunicativo in cui ci si trova ad essere risucchiati(Coupland 2009). Coinvolti in questo turbine si può essere legge-ri o pesanti e questo stabilisce le possibilità di galleggiamento o diaffondo, mentre gli oggetti ruotano toccati da una grazia signifi-cativa che li vivifica e li sospinge fuori oltre la loro inerzia, per ri-lasciarli di nuovo sulle rive della ragione, una volta che la forza cheri-anima, li ha usati secondo uno scopo, per cui poi non ne ha piùbisogno. Scrive Barthes:
Nel codice vestimentario l’inerzia è lo statuto originario deglioggetti di cui la significazione è destinata ad impadronirsi: unagonna esiste senza significare, prima di significare; il senso che es-sa riceve è a un tempo abbagliante ed evanescente: la parola (delgiornale) coglie degli oggetti insignificanti, e, senza modificarne lamateria, li investe di senso, dà loro la vita di un segno; ma può an-che riprendersela, in maniera che il senso è come una grazia sce-sa sull’oggetto (Barthes 1967; trad. it.: 66-67).
Rispetto a quanto letto, la materia del contendere epistemolo-gico è delicata. Ragionare sul senso e sui significati delle cose
La realtà, la semiosi, il linguaggio
45
comporta muoversi al limite di un confine che si definisce in ma-niera molto lata tra estetica e semiotica, con un rischio costante,segnalato da Garroni, di uno sconfinamento riflessivo nel linguag-gio che si pretende descrittivo, ma che in modo speculare riman-da un’immagine, che è quella del sé che guarda e indaga, secondomodi che non vanno oltre l’orizzonte di un soggetto riflettente,che riflettendo, riflette se stesso in un’immagine di sé che è fattadi parole, le sue parole, senza uscire dal continuo rimbalzo di unafenomenologia che non è trascendente. La stessa semiotica comedisciplina, che ha dalla sua la pretesa (legittima sotto molti aspet-ti) di andare oltre la glottologia, la linguistica, la filologia, non èesente da problemi che condivide con altre scienze e che atten-gono allo strumento delle loro indagini, quel linguaggio verbale-non verbale, che nelle sue istanze costitute di senso, esse voglionoindagare e che resta come un velo epistemologico che lascia tra-sparire certi momenti-pezzi del senso, mentre ne nasconde inevi-tabilmente altri. Del resto ragionando sullo statuto semiotico, lecontaminazioni che si cercano nel rapporto con le altre discipli-ne, espongono la stessa semiotica (per partito preso) ad una me-scolanza di prospettive che può mettere in crisi il suo assetto di-sciplinare, con una difficoltà per lei di collocazione epistemolo-gica che se non le impedisce il dialogo, la lascia fluttuare attraver-so una serie di posizioni, che non sono sempre ben sorrette per-ché riconducibili ad una regola del procedere, che se non altro leconsentirebbe una certa continuità speculativa (salvo il fatto chequesta disposizione rappresenta per il semiotico il vantaggio di cuisi può far forte). Il problema descritto coincide con il progetto de-lineato da Greimas. Chi è interessato allo studio della semiosi, de-ve addentrarsi nei meandri della produzione-costituzione del sen-so. Ogni settore della realizzazione letteraria si rappresenta in ba-se ad una propria disposizione linguistica, mentre la vita del pen-siero attraversa questi campi del sapere, nutrendosi delle diverseglottologie, muovendosi in una continua “parafrasi” che fa da tra-mite nel passaggio d’aria da un campo del sapere all’altro. In que-sto leggere-ascoltare-dire-ridire le stesse cose si realizza in pro-gressione il senso di quanto appare e nella transizione continua trai territori dell’umano la semiotica come scienza deve avere l’in-telligenza di comprendere queste diverse trasformazioni-depositi,assumendo per sé un compito che ha uno spessore complicato ed
Filippo Silvestri
46
un’ambizione che si sono attribuite tradizionalmente alla filosofia(Greimas, Courtés 1979; Marrone 2000: 39).
Il trascendentale resta la posta in palio, metafisica ed epistemolo-gica, sempre dato ed ancora da venire, materia-senso formata edinforme con le sue logiche categoriali, le sue determinazioni lin-guistiche, le sue pozze semantiche, mentre si produce in un con-tinuo divenire vitale, avendo oltre le possibili linguistiche della suaconfigurazione a che fare con lo stare al mondo in modo estesico(alludiamo ad un’estetica che è quella del Kant della Critica del giu-dizio: Garroni 1981) ovvero su un primo piano di disposizioneontologica che non ha ancora implicazioni di carattere semiolo-gico perché determinato da una «unità liminare di senso nonesauribile mediante significati che invece sempre la presuppongo-no» (Garroni 1986: 263). Quanto abbiamo già sostenuto sullascorta delle nostre allusioni alle posizioni rispettivamente di Hus-serl e Rossi Landi, è così argomentato da Garroni:
Bisogna […] supporre che, prima delle rappresentazioni dei sin-goli e prima dei significati che le organizzano linguisticamente, cisia una comune condizione di senso, implicante un riferimentoal mondo, entro la quale i comunicanti già sono ed entro cui sol-tanto possono sorgere significati e concrete produzioni di senso(Garroni 1992: 252).
Spostandosi sul versante delle disponibilità rappresentative sucui “contare” (anche nel senso stretto del calcolo) quando voglia-mo descrivere, raccontare, analizzare, schematizzare quello che vi-viamo, va detto che in ogni caso nulla viene tolto al magma par-lante secondo profondità e superfici, che quando assume formeche sono in qualche modo visibili in ragione delle loro caratteri-stiche condivise, queste mostrino una strutturazione, una struttu-ra analizzabile, che testimonia in direzione di una coincidenza disuperficie e profondità, quasi la superficie fosse rivelativa di unaverità che non è necessariamente nascosta in un non si sa dove(Lacan 1966), mentre le emersioni dell’essere (umano-disumano-troppo-umano) si disegnano per disposizioni diagrammatiche, chepossono anche ingannare l’occhio, ma che alla fine come all’ini-zio sono lì e non possono essere negate alla stregua di un’ennesi-ma dimostrazione epifenomica di un arcano che ha bisogno dimistici contatti. Gli esempi che si offrono per un’analisi non sono
La realtà, la semiosi, il linguaggio
47
lontani dal prototipo che rappresentano, ammesso ce ne sia unoche tutti li sottenda. La lingua che si parla se non altro (e a tantoalludiamo quando parliamo di certe superfici) è questo manife-starsi strutturale ed epifenomenico, è questo essere lì così com’è ecome si mostra, modello continuo per se stessa e primo gradinonecessario da scalare per una sua analisi. Quali siano poi i rappor-ti tra una lingua e il suo pensiero, è cosa che resta sempre da son-dare. Con Hjelmslev (Caputo 2006: 59):
Possono lingua e pensiero essere un’unica cosa, vale a dire due fe-nomeni identici? […] Oppure lingua e pensiero sono comunquedue cose ben diverse che hanno semplicemente la particolarità dipoter avere un rapporto reciproco?Sembrerebbe essere opinione diffusa che lingua e pensiero sianodue cose completamente diverse, e questa affermazione può es-sere sostenuta da ragioni piuttosto valide. Innanzitutto, sappiamoche non è semplice trovare l’espressione linguistica del pensiero[…] Spesso non la si trova nemmeno, e ci si deve arrangiare conun’espressione linguistica incompleta [ricorrere a circonlocuzio-ni]. La lingua contiene inoltre stranezze che non corrispondonoal pensiero, o che rendono difficile e complicato esprimere ilpensiero, o che causano equivoci (Hjelmslev 1936; trad. it.: 12).
13. Presi al centro del vortice dell’Essere
Solo andando alla ricerca delle nostre cose in sé, disponendo deimezzi semiotici di cui sappiamo già gestire i modi del loro fun-zionamento, possiamo avvicinare quanto si mostra refrattario ri-spetto ad una sua sistemazione rappresentativa, nel mare apertodell’essere, mentre la semiosi delle nostre istanze cresce su se stes-sa, variando in modo spesso imprevedibile, come imprevedibili so-no gli interpreti che (diversi) possono intercettare questa continuaricerca costitutiva di un senso. De Mauro scrive di un lògos capa-ce di dilatarsi nella ricerca significativa verso «ciò che ancora nonha già trovato espressione in nuove e specifiche parole e nei rigo-rosi termini di qualche scienza», un lògos che ci consente di «lot-tare contro l’inesprimibile», avendo fiducia consapevole «nei mez-zi di cui già disponiamo» (De Mauro 2002: 98), senza disprezzar-li, sapendoli valorizzare, comprendendoli in ragione delle loro po-
Filippo Silvestri
48
tenzialità anche solo fenomeniche. In seguito e questa volta conSaussure il gioco delle immanenze e delle trascendenze (che vainsieme a questo affidarsi, sprofondando nella semiosi delle pro-prie parole) si rivelerà un gioco linguistico macroscopico che siregola al limite dell’incontro e dello scontro e nella fusione chepuò risultare dall’incrocio di sistemi semiotici confinanti-vicini,gioco che non consente una chiusura ermetica ed olistica dellegalassie semiologiche, che se si definiscono per opposizioni delleloro ragioni caratterizzanti, vivono degli incontri che le rendonopermeabili. Saussure:
Così per determinare che cosa vale un pezzo da cinque franchi,bisogna sapere: 1. che lo si può scambiare con una certa quantitàdi una cosa diversa, per esempio con del pane; 2. che lo si puòconfrontare con un valore similare del medesimo sistema, peresempio un pezzo da un franco, o con una moneta di un altro si-stema (un dollaro ecc.). Similmente, una parola può essere scam-biata con qualcosa di diverso: un’idea; inoltre può venire con-frontata con qualche cosa di egual natura: un’altra parola. Il suovalore non è dunque fissato fintantoché ci si limita a constatareche può esser “scambiata” con questo o quel concetto, vale a di-re che ha questa o quella significazione; occorre ancora confron-tarla con i valori similari, con le altre parole che le sono opponi-bili. Il suo contenuto non è veramente determinato che dal con-corso di ciò che esiste al di fuori (De Saussure 1916; trad. it.: 140).
La compartecipazione di “ciò che esiste al di fuori” è un chia-mare in causa l’altro oltre la definizione del mio campo di com-petenze, evocando un pensiero, un concetto, il pezzo di un altrogioco linguistico e non solo, a seconda delle assonanze e delleomologie, delle somiglianze e delle compatibilità, come ancoradell’assoluta estraneità che si interpone sui cammini rettilinei del-la significazione, costretta alle sue traduzioni-sostituzioni, il tuttonell’orizzonte sfumato-tracciato dalla scia di un fantasma, il comu-ne-non-comune, regola non regola dello stare insieme (in una con-traddizione ai limiti di una necessaria paralogia), secondo un dise-gno discontinuo e per tratteggi delle coordinate del senso nellesue diverse disposizioni-indisposizioni. La semiosi sembra così uninsieme mai definito di vortici che roteano nell’area-radura aper-ta dell’Essere abitata dal senso, dalle significazioni e dalle eventua-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
49
li comunicazioni. Ogni vortice della rappresentazione mulina at-traendo a seconda della sua forza centrifuga e centripeta ogni co-sa, persona, società, realtà lo dovesse attraversare, secondo unamoltiplicazione che non è calcolabile e che non garantiscel’emersione-emergenza di qualcosa che possa essere espressa peruna condivisione. Il mescolamento semiologico produce come ef-fetto una serie-non-serie di degenerazioni del senso, parti di unanormale (anomala) economia del pensiero e della relazione, se-condo semplificazioni e complicazioni, che dipendono a loro vol-ta da un sistema di regole semiotiche-linguistiche, che in alcunicasi si mostrano elastiche e quindi aperte ad intrusioni-sovverti-menti, mentre in altre circostanze marcano con decisione i loroconfini coincidenti con il sapere che li fonda, determinando undentro e un fuori la comunità linguistica dei parlanti e di coloroche ascoltano, con tutte le valorizzazioni, le discriminazioni, lealienazioni, le competenze, come ancora le sempre tarde coscien-ze critiche che fanno di tutto una fenomenologia, a loro voltacoinvolte in modi più o meno decisivi nel processo in atto ovve-ro ancora fermo nelle stasi del suo divenire evolutivo-involutivo.Circa certe durezze e resistenze opposte dai sistemi linguistici edai corrispettivi ordini del sapere, le posizioni di Quine erano giàmolto decise nel 1936, quando scriveva:
Ci sono asserzioni che decidiamo di abbandonare per ultime, seproprio dobbiamo farlo, nel corso del rappezzamento delle no-stre scienze al cospetto di nuove scoperte; e tra queste ce ne so-no alcune che non abbandoneremo mai, tanto sono fondamen-tali per l’intero nostro schema concettuale. Fra queste ultime de-vono essere annoverate le cosiddette verità logiche e matemati-che (Quine 1936; trad.it. 166).
Nel maelstrom della significazione e della comunicazione alcu-ne discriminanti verbali e non verbali aprono (oltre la loro diva-ricazione fenomenologica) uno spazio del senso che non appar-tiene loro e che resta a metà strada tra un dimensione che sembraavere a che fare con un vitale senso dell’orientamento, mentre siinscrive in una strada traversa che acquista rilevanza per una disci-plina estetica, che si rifiuta (in modo legittimo) ad un facile appa-rentamento con la semiotica del tutto riducibile a segno, comunquelo si voglia intendere quel segno. Garroni, che ragiona sull’origi-
Filippo Silvestri
50
ne-genesi della semiosi a partire “dall’intero organico” riconduci-bile alla macro categoria metafisica della “relazione” (da assumerein senso perciano e morrisiano), segnala come il problema delsenso non sia risolto da una scienza dei segni. Il senso delle cosepuò valere alla stregua di un “significato semiotico”, ma non sipossono misconoscere fenomenologie diverse che sono impernia-te intorno ad un “significato extra-semiotico” (ad esempio il«qualcosa in quanto qualcosa»), dove quest’ultimo non è tematiz-zabile «nel quadro di una teoria generale dei segni, dal momentoche qui possono essere in questione soltanto le significazioni chepuò avere il qualcosa in quanto segno e non appunto il qualcosain quanto qualcosa» (Garroni 1977: 23-24). Del resto per Garro-ni resta valido un programma trascendentale di ricerca, ambiziosoal punto da cercare un senso dell’umano poggiato su «più profon-de condizioni intellettuali di cui [il linguaggio verbale] è proie-zione e specificazione» (Garroni 1977: 35) secondo un’idea inqualche modo vicina alla modellazione primaria-specie-specifica-umana teorizzata da Sebeok come ancora a tutta la matrice tra-scendentale di certa ricerca che si muove oltre un orizzonte delladeterminazione semiotica del mondo.
Fuori da queste nuove definizioni di ambiti disciplinari, on-tologici e semiotici, la resa di fronte all’indicibile coincide con unapresa di coscienza della necessità di restare nel proprio, per guar-dare a quello che si ha, per come uno ne dispone, nel proprio diun linguaggio di cui cercare una fenomenologia capace di diri-mere, districando, i diversi fili intenzionali attivi e passivi della si-gnificazione-comunicazione. Forma, formazione, formalizzazionee formattazione, messe in fila nella nuova era mass-mediatica del-la cross-medialità stabiliscono canali di percorso e di refluo dellerelazioni alla stregua di dati che poggiano su fondamenta, che aloro volta sprofondano lungo assi storici, in imitazioni di tempiche hanno visto (testimoni) forme che possono assomigliare aquelle attuali, forme dell’essere-linguaggio che è stato un parlarecomune, che se recuperate con cura filologica per un confrontocon il contemporaneo, potrebbero rivelare come le posizioni chefanno valere la loro attualità sono molto meno avanguardiste diquanto non dicono ogni volta di essere, costringendo a nuove pe-dagogie, nuovi esoterismi delle loro forme e dei loro funziona-menti. In questi orizzonti analitici, bisogna disporsi con la consa-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
51
pevolezza che il linguaggio, comunque lo si voglia intendere, na-sce in funzione strumentale con il fine di dare una rappresenta-zione quanto meno credibile di quell’essere che gli resta muto difronte, imponendogli le sue forme, i suo modi, la sua inanimata in-disposizione alla replica, mentre una volta aperto il ventaglio del-le soluzioni linguistiche, queste sono a loro volta capaci di cresce-re su se stesse secondo logiche algebriche della moltiplicazioneconcentrica ed olistica, dove non avrebbe senso, interrogandole,chiedere loro di un senso che non sia appunto il loro, perché na-to nel cortocircuito della loro crescita esponenziale. Così atteg-giandosi, in una prospettiva neo-neocritica, ritornerebbe un feno-menismo che autorizzerebbe da una parte una resa dei conti conl’essere in ragione delle sue manifestazioni evenemenziali più omeno inaspettate, come d’altra parte resterebbe legittimo uno stu-dio intenzionale-non-intenzionale del cervello e della mente chelo governa, di là dai contorcimenti su se stessa di cui spesso lamente vive nelle sue circostanze circolari.
L’ontologia della cosa in sé rimane come viva istanza materia-le di un’affettività passiva nella relazione con il mondo, primatraccia di un difficile accomodamento nel rapporto con la Lebens -welt delle cose e degli uomini, nell’Umwelt delle disposizioni all’al-tro da sé. In questa determinazione del senso la quasi-mente diPeirce, la hyle come base materiale della semiosi si configurano al-la stregua di un raddoppiamento dello an sich, non più come unaltro che è altro di fronte al sé che lo guarda, ma un altro che è ilcorpo con la mente che lo vive, sperimentandolo ogni giorno co-me alleato e come terribile nemico delle proprie ragioni, mentregli si manifesta come senso, sentimento, sensazione, fenomenolo-gie in ogni caso di una forza passiva perché non è nel governodella ragione, ma che a ben ascoltare è energia propulsiva di unvivere, che non è nella disponibilità di un’immediata traduzioneconviviale e comunitaria (Deleuze 1962). Sebeok tra gli altri, loabbiamo visto, ha insistito in ambito semiotico sulla necessità diun allargamento prospettico nello studio dei segni, mostrando apiù riprese come pur nella diversità delle sue tensioni proprio-specifiche, l’antroposemiosi vada considerata parte darwiniana-biologica di un complesso eco-sistema fisico e chimico, dove fini-sce per sciogliersi la stessa divaricazione tra significazione e comuni-cazione, nella sua presunta dirimente discriminazione dei sensi. Se
Filippo Silvestri
52
si accetta questa prospettiva metafisica, includente nell’estensionel’antroposemiosi nella biosemiosi, secondo un modello (se si vuole)di filosofia della natura (alla Schelling), si può allora riconoscere nel-la frammentarietà variegata delle diverse soluzioni-complicazioniin gioco una certa continuità che dall’animale va all’umano, se simisura il senso ultimo del linguaggio con lo sforzo diversificato dicostruire modelli, che facciano da pro-memoria strumentale sem-plificatorio nella relazione con il mondo e con tutte le diversitàche lo abitano, lo occupano, intralciando o facilitando il cammi-no di chi lo attraversa.
14. Somiglianze ed imitazioni
Così si potrebbe essere non solo in cammino verso il linguaggio (Hei-degger 1959), ma con il linguaggio in cammino nell’attraversamen-to difficile dell’essere che tocca come vita, con tutte le insidie, le sfi-de che questo viaggio comporta. Estetica e semiotica, strette in unastessa fenomenologia, con le loro varianti implicate, possono abbas-sarsi al trascendentale della sensazione-percezione nelle sue compli-cazioni interpretative, provando a ragionare sugli istanti primordia-li della costituzione del senso, in ragione delle prime ancestrali co-struzioni di modelli di mondo, fatti ad immagine e in ragione del-le somiglianze che si cercano con il complesso vitale che si attra-versa. Il linguaggio che usiamo è un archivio evocativo di immagi-ni, che sono repliche dell’esperienza che uno fa. Danesi, ritornan-do anche lui ad un “Sebeok trascendentale”, scrive a proposito diuna metafisica iconica, riallacciandola anche lui ad:
[…] una strategia di modellazione primaria che permette la crea-zione di segni che si riferiscono a qualcosa o a qualcuno attraver-so replica, simulazione, imitazione o somiglianza. I segni iconicipossono quindi avere forma vocale [onomatopee], visiva [ritrat-ti], olfattiva [profumi], gustativa [gli additivi chimici che “cercan-do di simulare il gusto dei cibi naturali”] o tattile [“una lettera al-fabetica incisa”] […] Persino i concetti più astratti […] rivelanoun collegamento iconico, a lungo dimenticato, con la sfera sen-soriale. È per questo che noi usiamo parole come avvertire, rife-rendoci ad un’idea, afferrare riferendoci a nozioni, vedere riferen-doci a punti di vista […] Langacker […] ha sostenuto che la na-
La realtà, la semiosi, il linguaggio
53
tura iconica dei concetti si manifesta anche nelle strutture forma-li del linguaggio, che sono riflessi rappresentazionali di modelliricorrenti estratti da impulsi sensoriali (colore, forma, posizione,movimento) (Danesi 1998; trad. it.: 18-9).
Ed ancora e questa volta diversamente, perché sul limite di unpassaggio dall’oralità greca alla sua scrittura platonica ed in unaprospettiva pragmatica del dire-parlare legati ad un’agire (non co-municativo), si legga quanto sosteneva Havelock:
Dai tempi di Sofocle molte cose sono accadute al discorso dellamente e alla mente stessa. Pur conservando in parte il linguaggio(orale) del fare, dell’agire e del sentire, lo abbiamo integrato, e inparte sostituito, con enunciati di fatto. I participi, i verbi e gli ag-gettivi che si comportano come gerundi hanno ceduto il passo aentità concettuali, astrazioni, oggetti. Il greco orale non sapevacosa fosse un oggetto del pensiero. Quando imparò a scrivere, laMusa dovette distogliersi dal vivo panorama dell’esperienza e dalsuo flusso incessante, ma finché rimase greca, non riuscì mai a di-menticalo del tutto (Havelock 1988, in Sini 2009: 32).
Bisogna restare all’altezza di un principio di somiglianza edimitazione, come si fosse al centro di una dirimente ragione del-la costituzione del processo cognitivo, laddove il conoscere restalegato ad una successiva traduzione-determinazione lineare nelleforme della scrittura, secondo una progressione che muove dal-l’estetica per arrivare alla logica-semiotica delle cose, che primache disciplinare è un passaggio di consegne progressivo nella co-struzione dell’edificio del sapere per stratificazioni del senso.
Deely, aprendo anche lui ad una nuova semiotica del trascen-dentale, scrive:
La prospettiva semiotica è quella nella quale “l’ente reale” e “l’en-te di ragione” si riuniscono, e non la prospettiva nella quale essisono opposti […] la “tradizione maggiore e quella minore”, ovesiano correttamente comprese, non sono più opposte di quantonon lo siano “l’ens reale e l’ens rationis” nella prospettiva propria aduna dottrina dei segni. Non vige una relazione d’esclusione maquella della parte con il tutto – così che la fallacia della pars prototo prevale quando i fautori della parte la confondono con il tut-to, opponendola ad esso (Deely 2002; trad. it.: 28-30).
Filippo Silvestri
54
Le estetiche e le semiotiche della somiglianza non valgonosolo come primo motore mobile della produzione ancestrale didispositivi iconici, nel trattamento della relazione con il mondo:solo per fermarsi agli albori, il principio dell’imitazione-somi-glianza è all’opera nell’acquisizione del linguaggio, prima nellasua forma orale, quando da madre a figlio avviene l’in-segna-mento nell’articolazione formale dei rumori in suoni, poi nellascrittura per imitazione iconologica delle lettere di un alfabeto,per cui avviene la vera e propria acquisizione all’interno delconsesso sociale, secondo le regole del vivere civile, nella comu-nicazione che lo rende possibile. Il nuovo arrivato entra in so-cietà non appena mostra di sapere imitare alla lettera la lettera“a”, disegnandola così come gli sembra somigliare al modelloprototipico rappresentato sulla lavagna, astraendo progressiva-mente da tutte le inflessioni della sua voce nell’associazione diun suono-lettera che corrisponda a quel disegno, che è propo-sto coma la prima lettera di un alfabeto che regolerà la sua rela-zione con gli altri, che lo premieranno nel momento in cui lasua “a” finalmente assomiglierà a tutte le altre “a” astratte perchécomunemente riconosciute.
Al di là della pedagogia maieutica del corretto disporsi graficonella scrittura e nella parola, assecondando repliche, simulazioni,somiglianze ed imitazioni, è utile addentrarsi nei meccanismi chelegiferano sui modi delle repliche-imitazioni del mondo, percomprendere come funzioni il motore cognitivo nella replica-ri-petizione di certi movimenti che portano all’usura dei suoi mec-canismi e che funzionano per quel tempo che funzionano e me-ritano pertanto uno studio che si provi nella comprensione dei lo-ro ingranaggi, sempre avendo all’orizzonte il senso di una certacontinuità-discontinuità tra la mente ed il corpo come replicadella continuità-discontinuità tra l’uomo e il mondo lungo l’inte-ro arco caleidoscopico della vita.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
55
Riferimenti bibliografici
Apel, Karl Otto 1973 Transformation der Philosophie, Frankfurt an Main, Suhrkamp. 1971 Hermeneutik und Ideologiekritik (Appel et alii), Frankfurt an Main,
Suhrkamp; trad. it. di G. Tron, Ermeneutica e critica dell’ideologia, Bre-scia, Queriniana, 1979.
Barthes, Roland 1964 Essais critiques, Paris, Editions du Seuil; trad. it. di L. Lonzi, M. Di
Leo, S. Volpe, a cura di G. Marrone, Saggi critici, Torino, Einaudi, 2002.1967 Système de la Mode, Paris, Seuil; trad. it. di L. Lonzi, Sistema della Mo-
da, Torino, Einaudi, 1970.
Baudrillard, Jean 1976 L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard; trad. it. di G. Man-
cuso, Lo scambio simbolico e la morte, Milano, Feltrinelli, 2009.
Bauman, Zygmunt 1999, In search of Politics, Cambridge, Polity Press; trad. it. di G. Bettini,
La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli, 2011.
Benjamin, Walter 1955 Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di R. Sol-
mi, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 1995.
Blanchot, Maurice 1955 L’espace littéraire, Paris, Gallimard; trad. it. di G. Zanobetti, Lo spazio
letterario, Torino, Einaudi, 1967.1980 L’écriture du désastre, Paris, Galllimard; trad. it. a cura di F. Sossi, La
scrittura del disastro, Milano, SE, 1990.
Boltanski, Luc; Chiapello, Ève 1999 Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Caputo, Cosimo2006 Semiotica e linguistica, Roma, Carocci.
Cassirer, Ernst 1954-58, Philosophie der symbolischen Formen, Darmstadt, Wissenschaftli-
che Buchgemeinschaft.
Filippo Silvestri
56
Chomsky, Noam 1986 Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist
Thought, Lanham, Maryland, University Press of America.2000 New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge, Uni-
ted Kingdom, Press Syndicate of the University of Cambridge, ThePitt Building, Trumpington Street; trad. it. a cura di D. Delfino e G.Graffi, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano,Il Saggiatore, 2005.
Coupland, Douglas 2009 Marshall McLuhan, Penguin Group (Canada); trad. it. di M. Pensan-
te, Marshall McLuhan, Milano, Isbn Edizioni, 2011.
D’Agostini, Franca1997 Analitici e continentali, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Danesi, Marcel1998 The body in the Sign: Thomas A. Sebeok and Semiotics, Thomas Sebeok
Monograph Series, vol. I, New York-Ottawa-Toronto, Legas; trad. it. inM. Danesi, S. Petrilli, A. Ponzio, Semiotica globale. Il corpo nel segno: intro-duzione a Thomas A. Sebeok, Bari, Graphis, 2004, pp. 3-86.
Deely, John 2002 Basics of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press; trad. it.
di M. Leone, Basi della semiotica, Bari, Edizioni Giuseppe Laterza,2004.
Deleuze, Gilles 1962 Nietzsche et la philosophie, Paris, Presses universitaires de France;
trad. it. a cura di F. Polidori, Nietzsche e la filosofia, Torino, Einaudi,2002.
1969 “De quoi on reconnaître le structuralisme?”, in Histoire de la philo-sophie, a cura di F. Chatelet, Paris, Hachette, vol. VIII ; trad. it. di L.Sosio, “Da che cosa si riconosce lo strutturalismo?”, in Storia della fi-losofia, Rizzoli, Milano, 1973.
De Mauro, Tullio2002 Prima lezione sul linguaggio, Roma-Bari, Laterza.
Derrida, Jacques1967 La voix et le phénomène, Paris, Presses universitaires de France; trad.
it. a cura di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno, Milano, Jaca Book,1997.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
57
1967 De la grammatologie, Paris, Les �ditions de Minuit; trad. it. a cura diG. Dal Masso, Della grammatologia, Milano, Jaca Book, 2006.
Eco, Umberto 1975 Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani.1997 Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani.
Fabbri, Paolo; Marrone, Gianfranco 2006 Semiotica in nuce, Roma, Meltemi.
Gadamer, Hans Georg 1972 Wahrheit und Methode, Tübingen, Mohr; trad. it. a cura di G. Vatti-
mo, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983.
Garroni, Emilio 1977 Ricognizione della semiotica, Roma, Officina. 1981 “Estetica e semiotica”, in Dufrenne M., Formaggio D. (a cura di),
Trattato di estetica, I: Storia, Milano, Mondadori.1986 Senso e paradosso, Bari, Laterza.1992 Estetica. Uno sguardo-attraverso, Milano, Garzanti.
Greimas, Algirdas Julien; Courtés, Joseph 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome II, Pa-
ris, Hachette; trad. it. a cura di P. Fabbri, Semiotica. Dizionario ragiona-to della teoria del linguaggio, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
Kierkegaard, Søren 1838 Af en endnu Levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie af S. Kierkega-
ard, Kjøbenhavn; trad. fr. a cura di Else-Marie Jacquet-Tisseau, Despapiers d’un homme encore en vie, Paris, Éditions de l’Horante, 1984.
Habermas, Jurgen 1981 Theorie des kommunikativen Handels, Frankfurt an Main, Suhrkamp;
trad. it di P. Rinaudo, Teoria dell’agire comunicativo, Bologna, Il Muli-no, 1997.
Hacking, Ian 1975 Why does language matter to philosophy?, Cambridge, Cambridge
University Press; trad. it. di B. Sassoli, Linguaggio e filosofia, Milano,Raffaello Cortina Editore, 1994.
Havelock, Eric Alfred 1988 The muse learns to write. Reflections on orality and literacy from antiqui-
Filippo Silvestri
58
ty to present, London, Yale University Press; trad. it. di M. Carpitella,La musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’anti-chità al giorno d’oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005.
Heidegger, Martin 1959 Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di
A. Caracciolo e M. Caracciolo Perotti, In cammino verso il linguaggio,Milano, Mursia, 1999.
Hjelmslev, Luis 1943 Omkring Sprogteoriens Grundlaeggelse, København, Akademisk For-
lag; Prolegomena to a Theory of Language, Madison, Wisconsin Univer-sity Press, 1943; trad. it. di G. Lepschy, I fondamenti della teoria del lin-guaggio, Torino, Einaudi, 1968.
Kallir, Alfred 1961 Sign and Design. A Psychogenetic Source of the Alphabet, Plymouth, La-
timer, Trend & Co.
Jenkins, Henry 2006 Convergence culture. Where old and new media collide, New York, New
York University Press; trad. it. a cura di V. Susca, M. Papacchioli, V. B.Sala, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007.
Lacan, Jacques 1966 “La séminare sur la “La lettre voleé””, in Ecrits, Paris, Seuil; trad. it.
di G. Contri e S. Loaldi, Il seminario su “La lettera rubata”, in J. La-can, La cosa freudiana e altri scritti, Torino, Einaudi, 1972, pp. 15-80.
Langacker, Ronald Wayne 1987 Foundations of Cognitive Grammar, vol. I: Theoretical Prerequisites, Stan-
ford, Stanford University Press.1991 Concept, image, and symbol : the cognitive basis of grammar, Berlin-New
York, De Gruyter.
Lyotard, François 1979 La condition postmoderne, Paris, Les �Éditions de Minuit; trad. it. di
C. Formenti, La condizione postmoderna. Rapporto sul potere, Milano,Feltrinelli, 2002.
Manovich, Lev 2001 The Language of New Media, Massachusetts Institute of Tecnology; trad.
it. di R. Merlini, Il linguaggio dei nuovi media, Bologna, Olivares, 2002.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
59
Marrone, Gianfranco 2000 Significato, contenuto, senso, in P. Fabbri, G. Marrone, Semiotica in nu-
ce, Roma, Meltemi, 2000, pp. 28-44; già in L. Corrain, Il lessico dellasemiotica (controversie), Bologna, Esculapio 1994.
McLuhan, Marshall 1964 Understanding Media. The Extensions of Man, New York, The new
american library; trad. it. di E. Capriolo, Gli strumenti del comunicare,Milano, Il Saggiatore, 2008.
Merleau-Ponty, Maurice1964 Le visible et l’invisible, Paris, �Éditions Gallimard; trad. it. di A. Bo-
nomi, Il visibile e l’invisibile, Milano, Bompiani, 1994.
Perniola, Mario2009 Miracoli e traumi della comunicazione, Milano, Einaudi.
Ponzio, Augusto2011 La filosofia del linguaggio. Segni, valori, ideologie, Bari, Edizioni Giu-
seppe Laterza.
Ponzio, Augusto; Petrilli, Susan; Calefato, Patrizia 1999 Fondamenti di filosofia del linguaggio, Bari-Roma, Laterza.
Putnam, Hilary1978 Meaning and Moral Sciences, London, Routledge & Kegan Paul; trad.
it. di A. La Porta, Verità ed etica, Milano, Il Saggiatore, 1982.
Quine, Willard van Orman 1936 “Truth by Convention”, in Philosophical Essays for A. N. Whitehead;
poi in The Ways of Paradox, New York, Random House, 1966; trad. it.a cura di M. Santambrogio, I modi del paradosso ed altri saggi, Milano,Il Saggiatore, 1975.
1975 Word and object, 1975, Cambridge (Mass.), The M.I.T. Press; trad. it.a cura di F. Mondadori, Parola e oggetto, Milano, Il Saggiatore, 2008.
Rossi Landi, Ferruccio1961 Significato, comunicazione e parlare comune, a cura di A. Ponzio, Vene-
zia, Marsilio.
Saussure, Ferdinand de 1916 Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1962; trad. it. a cura di T.
De Mauro, Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 1997.
Filippo Silvestri
60
Sebeok, Thomas1991 A sign is just a sign, Bloomington-Indianapolis, Indiana University
Press; trad. it. a cura di S. Petrilli, A sign is just a sign. La semiotica glo-bale, Milano, Spirali, 1998.
Sini, Carlo2009 Etica della scrittura, Milano, Mimesis.
Taylor, John Robert1995 Linguistic categorization: prototypes in linguistic theory, Oxford, Claren-
don Press; trad. it. a cura di S. Giannini, La categorizzazione linguistica.I prototipi nella teoria del linguaggio, Macerata, Quodlibet, 2003.
Tugendhat, Ernst1976 Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, Frank -
furt, Suhrkamp; trad. it. a cura di C. Penco, Introduzione alla filosofiaanalitica, Genova, Marietti, 1989.
La realtà, la semiosi, il linguaggio
61