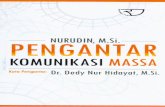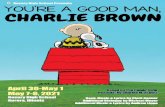Charlie Brown, piccolino di massa. Appunti per una ricerca
Transcript of Charlie Brown, piccolino di massa. Appunti per una ricerca
tAvOLA rOtONdA
— 12 —
auge un modello di critica dell’ideologia della forma come quello applicato in nuce da Eco nel saggio su superman. In effetti, è applicabile perfettamente ai meccanismi di costruzione della relazione presenti su Facebook o su altri social network la seguente considerazione di Eco: «I ‘contenuti’ ideologici […] da un lato […] si sostengono e funzionano comunicativamente grazie alla struttura […]; dall’altro, essi concorrono a definire la struttura che li esprime come una struttura circolare, statica, veicolo di un messaggio pedagogico sostanzialmente immobilistico» (AI, 253).
Certo, i contenuti di cui parla Eco sono relativi a un’idea del mondo e del suo funzionamento hard. Quelli di cui potremmo parlare a proposito dei social media riguardano invece la forma delle relazioni e l’obbligo del dire. Ma in ogni caso si ribadisce che l’azione di interpretazione dei riceventi non fa venire meno il quadro ideologico codificato nel testo, soprattutto laddove esso si ripeta con insistenza, o sia addirittura onnipresente (Colombo 2013).
Anche il ruolo del pubblico come inconsapevole attore della codificazione ideologica (Lorusso, infra), così come la costruzione del personaggio e la struttura iterativa del tempo, sono dunque eredità significative che Eco lascia, attraverso questo saggio, agli studi sui media successivi: un contributo importante, con cui non smettiamo di fare i conti ancor oggi. Un superEco dei media studies, italiani e non solo.
Charlie Brown, piccolino di massa. Appunti per una ricerca
di Gianfranco Marrone
1. A monte e a valle
Fra i meriti di Apocalittici e integrati – solo parzialmente ripreso dagli studi suc-cessivi in materia – vi è certamente quello di aver posto il problema dei media non tanto in termini di verità e menzogna, oggettività o alterazione, e dunque della loro eventuale rappresentatività di un supposto reale a essi esterno (il mon-do, la società, la storia etc.), ma semmai nei termini dei livelli di esemplarità che essi offrono al loro pubblico. Più che occuparsi di ciò che i media dicono del mondo, meglio occuparsi di come agiscono in esso. Piuttosto che concentrarsi sui media come apparati di produzione, strumenti tecnici che emettono linguaggi specifici, appare più utile indagare sui loro effetti socio-culturali. I contenuti dei media, se analizzati nelle loro articolazioni strutturali, vanno pertanto secondo Eco presi in esame non tanto dalla prospettiva dell’emittente quanto in quella del destinatario. Non a monte, dunque, ma a valle. Idea che tornerà, com’è noto, in
APOCALIttICI E INtEgrAtI: 1964-2014
— 13 —
pressoché tutta l’opera semiotica di Eco, non solo riguardo alla cultura di massa ma a qualsiasi forma di linguaggio e di semiosi, di discorso e di testo. È il primato dell’interpretazione, che dà al lettore, allo spettatore o al recettore di qualsiasi messaggio un ruolo tanto attivo quanto necessario per la costituzione e diffusio-ne del senso umano e sociale (del primato dell’interpretazione si occuperà più estesamente Lorusso, infra).
Per quel che ci riguarda qui e ora, ciò porta a mettere in luce un problema decisivo nello studio dei media, che era per gran parte già stato posto e affrontato anche in sede di estetica e di critica letteraria, e che viene da Eco riproposto e aggiornato a partire da uno studio dei prodotti della cultura di massa che cerchi di neutralizzare l’opposizione ricorrente fra apocalittici e integrati, come ricordato da Belpoliti (infra). Mi riferisco al problema dei modelli di comportamento che i prodotti dei media (e non solo di essi) propongono al loro pubblico, costruendo personaggi e situazioni che non riproducono il mondo ma si insinuano e si di-stribuiscono in esso, facendosi imitare più che imitando. gli eroi della cultura di massa, espressa nella paraletteratura, nelle canzoni di consumo o nei fumetti, da sandokan a superman, dai Beati Paoli a rita Pavone, sono portatori di ideologie e di valori che, a determinate condizioni strutturali (inscritte nelle storie che li vedono agire e patire), vengono riprese in modo più o meno pedissequo dal loro pubblico appassionato, da quelli che non caso si chiamano i loro fan.
da qui l’idea di concentrarmi sul caso di Charlie Brown e in generale dei Peanuts del grande Charles schultz, dei quali Eco si occupa in alcune pagine centrali di Apocalittici e integrati, molto note e molto citate, che meritano comun-que un’ulteriore rilettura sia per quel che riguarda il loro oggetto sia per quel che concerne il modo di affrontarlo. Perché i Peanuts? sicuramente perché si tratta uno dei pochi prodotti mediatici, se non l’unico, analizzati in Apocalittici e integrati di cui Eco dà un giudizio positivo. Un prodotto culturale di massa che dunque permette di vedere la questione dei modelli di comportamento offerti dai media alla massa in termini non solo apocalittici, come potrebbe emergere dalla lettura delle analisi di steve Canyon, superman o la canzone di consumo etc. Non a caso, astuzia della struttura, le pagine sui Peanuts stanno al centro del volume.
2. Tipo e «topos»
Prima però bisogna soffermarsi su un altro saggio di Apocalittici e integrati, dedicato all’«Uso pratico del personaggio», dove Eco pone la distinzione fra tipo e topos, chiedendosi altresì se i topoi (tutto ciò che è ‘già noto’) possano essere artistici e, parallelamente, se ci possano essere tipi anche nella cultura di massa (pensando esattamente a Charlie Brown). si tratta di un saggio molto importante per varie ragioni. Innanzitutto perché è uno dei pochi testi di critica della seconda
tAvOLA rOtONdA
— 14 —
metà del secolo scorso che si pone in modo diretto il problema del personaggio letterario, come è noto messo tra parentesi da molta tradizione novecentesca della teoria della letteratura (i formalisti e i Chicago critics), dalla narratologia (da Propp a Communications 8), dalla semiotica della letteratura e del racconto (Barthes, greimas) e solo parzialmente ripreso da Chatman e Hamon1. In secondo luogo, perché è sicuramente un saggio decisivo in Apocalittici e integrati, forse il più teorico, e non a caso introduce le grandi analisi di superman e dei Peanuts, seguendo quella di steve Canyon. È come se dopo la lettura di Canyon e le consi-derazioni generali che ne derivano, Eco sentisse il bisogno di ritornare a riflettere su una visione estetico letteraria più ampia del prodotto culturale, necessaria per affrontare superman e tutto il discorso post gramsciano sul superuomo di massa. In terzo luogo, perché questo saggio attua surrettiziamente un passaggio dalla classica estetica dell’identificazione di derivazione aristotelica (che arriva sino all’ermeneutica di Jauss) alla semiotica della cultura (qui ancora implicita, e proprio per questo interessante).
Punto di partenza del saggio è l’idea per cui è bene non considerare l’onto-logia del personaggio (ossia il suo ‘carattere’, cui aderire o da rifiutare) ma la sua sociologia, ovvero il modo in cui viene usato dal lettore. Così, se il personaggio può divenire un ‘tipo’ intellettuale e culturalmente identificabile non è per mimesi, ossia perché riprende una qualche medietà sociale rappresentandola nell’opera (magari per ragioni di poetica normativa, come nel marxismo sovietico), ma per-ché va a costruire un modello che può essere assunto, a posteriori, dalla società come interessante (diremmo oggi pertinente), anche a prescindere dall’autore e dalla sua poetica esplicita (e qui si citano Marx ed Engels su Balzac, e Lukàcs su Hoffman o stendhal). si va dunque dal personaggio verso la cultura sociale, e non viceversa.
Ma, precisamente, cos’è un ‘tipo’? si tratta di una sorta di realizzazione prag-matica del personaggio che scatta quando esso da individuale (un ‘costui’) riesce a divenire universale, di modo che più è individuale più è universalizzabile – cosa che si crea ovviamente al momento della ricezione. Il tipo non è un’idea più o meno allegorica (altrimenti l’arte si farebbe filosofia) ma una sorta di congenialità fra autore, personaggio e lettore che si produce se riesce a affinarsi una sorta di omologia emozionale fra di essi: «la forma assunta dal sistema delle sollecitazioni emotive (che è l’opera) suscita e viene a coincidere con la forma della nostra emo-zione» (AI, 188). La cosa importante è che questa omologia formale fra emozioni
1 A mo’ di reazione alle estetiche idealiste e positiviste, che avevano prodotto una critica letteraria fortemente interessata ai ‘caratteri’ dei personaggi, nonché alle loro ‘chiavi’ (ossia ai loro referenti sup-posti reali), la narratologia novecentesca, per larghi tratti fatta propria dalla semiotica, ha preferito invece occuparsi in modo pressoché esclusivo delle ‘azioni’ dei personaggi, di fatto dissolvendo lungo la stringa delle funzioni narrative e degli eventi del racconto il personaggio come oggetto letteraria e unità seman-tica. Per una rassegna delle varie posizioni teoriche circa la questione, cfr. il mio Sei autori in cerca del personaggio, (Marrone 1986).
APOCALIttICI E INtEgrAtI: 1964-2014
— 15 —
non è fine a se stessa, com’era ancora in Pareyson, ma si determina se essa va verso una direzione pratica futura: «il riconoscimento agisce come principio di una risoluzione etica» (AI, 189). E anche: «un personaggio offerto da un’opera d’arte diviene esemplare e lo riconosciamo come parte del nostro passato: a tale titolo lo assumiamo e ci fondiamo in esso nel progettare per il futuro. sentire il perso-naggio come tipico sarà dunque un ‘ricordare procedendo’» (AI, 205 nota). detto ciò, l’ontologia del personaggio ritorna, non sotto forma di spessore caratteriale (l’ethos aristotelico esaltato da hegelismo e idealismi vari) ma di articolazione interna del personaggio, e soprattutto del suo adeguato contesto (l’opera nel complesso). Aristotelicamente, secondo Eco, un personaggio è la risultante delle sue azioni, e dell’intreccio generale delle azioni raccontate nell’opera di cui fa parte. All’idealismo post crociano che privilegia il carattere dell’eroe (ethos) Eco oppone il senso che deriva dalle sue azioni (intrecciate nel mythos).
Ma come distinguere buoni e cattivi personaggi? Ci si può identificare con entrambi? Certo, anche con i cattivi, di modo che ci sarà una buona e una cattiva identificazione. da cui appunto la distinzione fra il tipo (modello che si propone al lettore grazie a tutta l’opera che gli fa da base materiale ed estetica) e il topos (Eco usa la nozione di topos nel senso di Curtius più che di Aristotele), ossia il già detto che viene ripreso in modo pedissequo senza integrarlo in modo sensato ed efficace all’interno della nuova opera in cui appare. se il tipo è un individuale che si fa universale, grazie alla tenuta complessiva del sistema-opera rispetto a un lettore che lo riattiva, il topos è un accoglimento di luoghi già noti senza una loro rimessa in sistema, di modo che il lettore non si riconosce nell’opera come universo totale e complesso, ma in alcuni suoi frammenti, che sono dunque frammenti di frammenti (AI, 210). Il tipo è una categoria della moralità, mentre il topos una categoria dell’immaginazione (AI, 212). I tipi sono modelli di vita, i topoi surrogati dell’immaginazione sotto forma di un già noto che viene sussunto acriticamente. Il tipo è arte, il topos è gioco (AI, 213). Il topos è conservatore, il tipo progressista (AI, 217).
Ecco che però, a un certo punto, Eco pone il caso dell’eroe decadente che, di solito, identificando l’arte con la vita, vede luoghi artistici dappertutto, e li riutilizza senza considerarli a partire dalla complessità della vita. dunque è un personaggio da considerare a tutti gli effetti alla stregua di un topos. spicca tuttavia il caso di Andrea sperelli, il noto protagonista del Piacere di d’Annunzio, che, a ben vedere, non è un topos ma semmai un tipo che fa uso di topoi: in questo caso, osserva Eco, l’uso dei topoi sta all’interno della storia raccontata, e non nel nesso fra brandelli di narrazione e immediata riconoscibilità di essi da parte del lettore. Così, analogamente al caso dannunziano, per quanto apparentemente molto distante, ci potranno essere, dice Eco, casi di personaggi-tipo anche nel mondo dei fumetti. E si cita a questo proposito proprio Charlie Brown (AI, 318).
tAvOLA rOtONdA
— 16 —
3. Un superuomo per tutti
La dialettica fra tipo e topos si materializza in Apocalittici e integrati attraverso l’opposizione strutturale fra superman e i Peanuts. In Apocalittici e integrati appare infatti chiaro come Charlie Brown sia da intendere alla stregua di un superman alla rovescia: non sottouomo, ché sarebbe niccianesimo di risulta, ma una specie di piccolo uomo di massa.
Come già ricordato da Colombo (infra), le storie a fumetti di superman pongono il problema della presenza del mito entro un prodotto di consumo di massa. Il mito riappare, secondo Eco, entro un contesto culturale che è però quello dell’età del romanzo. se per gli eroi classici tutto è già accaduto in una narrazione passata, e ogni loro riapparizione è una rammemorazione del già narrato, per gli eroi del romanzo tutto deve accadere nel futuro, mantenendo una certa imprevedibilità (AI, 230-231). Il problema di superman è che per lui il tempo passa senza mai invecchiare. Inghippo temporale: ogni storia ricomincia dallo stesso punto di prima. Così, superman è un eroe senza avversario, dunque senza possibilità di sviluppo (AI, 232). Il suo pubblico è pigro («sarebbe atter-rito da ogni sviluppo indefinito dei fatti», ibidem), di modo che «‘ogni storia si conclude nel giro di poche pagine» (ibidem). da qui il paradosso di superman: è un eroe di consumo che non può consumarsi; da cui l’intreccio di temporalità non coerenti fra loro (tempo della lettura, quello della singola storia, quello della narrazione complessiva etc.).
L’opposizione con i Peanuts è esplicita:
Nel saggio seguente vedremo come nei fumetti di schulz la stessa struttura iterativa del racconto non impedisca ma anzi permetta il delinearsi di per-sonaggi concreti e ‘storici’. Ma siamo allora in un campo in cui l’elemento iterativo si fa palese, voluto, vuole essere goduto come tale, diventa non cadenza fascinatoria, ma ritmo estetico: e attraverso di esso si stabiliscono i rapporti tra i personaggi e il mondo storico, con chiarezza di rimandi, con esattezza di riferimenti. I personaggi dei Peanuts non sono fungibili. Ma i personaggi di Superman sì; e superman è fungibile, in gran parte, con altro super-eroe di altra saga. Così rimane topos generico, talmente disso-ciato dal contesto in cui agisce, che la sua riduzione al minimo comune agibile, il suo negarsi alle possibilità che di fatto ha (e che verosimiglianza gli imporrebbe), appaiono così macroscopiche e disturbanti da richiedere al lettore un atto di fiducia, una ‘suspension of disbelief’ nel senso più grossolano del termine; una decisione di accettare superman per quel che è, un personaggio da fiaba, di cui godere le continue variazioni su tema. E come in tutte le fiabe, nella saga di Superman si scatenano possibilità di intreccio che vanno ignorate, pena il passaggio dalla fiaba evasiva all’appello problematico (AI, 265-66).
APOCALIttICI E INtEgrAtI: 1964-2014
— 17 —
4. Pigrizia del fuori campo
Andiamo alle pagine sui Peanuts, punto di partenza di qualsiasi altra indagine su questo fumetto, dunque assai lodate e assai criticate. Fra le critiche insensate che hanno ricevuto, c’è quella di dire che esse sono datate. Eco scrive dopo soli quattordici anni dalla nascita dei Peanuts, i quali, come tutto nella cultura di mas-sa, sono cambiati. schulz ha continuato a lavorare ben molti altri decenni dopo il 1964, facendo evolvere parecchio la sua poetica e i suoi singoli piccoli eroi. del resto, fra i temi tipici del discorso mediatico ‘adulto’, v’è anche il metadiscorso, l’assunzione esplicita, e schierata, del discorso sui media entro il discorso stesso dei media. Cosa che schulz non tarda a proporre a partire dalla sua specifica poetica (cfr. fig. 1).
Fig. 1. Il metadiscorso nei Peanuts.
vediamo invece qual è l’argomentazione di fondo del saggio. Eco rileva come nelle strisce di schulz ci sia una specie di schema sottostante da cui si di-partono infinite variazioni, che fa delle varie ‘noccioline’, loro malgrado, veri e propri ‘mostri’. Quei bimbi riprendono i problemi, le nevrosi e gli atteggiamenti
tAvOLA rOtONdA
— 18 —
degli adulti, ma lo fanno perché noi adulti li abbiamo resi tali, modificandone l’infanzia. L’infanzia stessa tuttavia riaffiora attraverso il modo particolare con cui quei bimbi, riprendendo gli atteggiamenti degli adulti, li modificano, passandoli dal filtro della loro innocenza e rendendoceli perciò ‘toccanti’. In altre parole, sembra dire Eco, l’infanzia non viene prima della maturità ma dopo di essa, mo-strandocene le infinite incrinature. Il candore dei Peanuts (al modo di voltaire, Pirandello o sciascia) non sta in un’età dell’oro perduta, in un’origine dura e pura che in seguito s’è degradata, ma in una specie di ritrovamento a posteriori di una cosa che sarebbe dovuta essere a priori: «così, in un’altalena continua di reazioni, all’interno di una stessa storia, o fra storia e storia, non sappiamo se essere di-sperati o concederci un sospiro di ottimismo» (AI, 268; il tema dell’oscillazione, cfr. Il pendolo di Foucault [1988], è tipica di Eco e di tutta la sua estetica). Questo schema che da un lato rende adulti i bambini e dall’altro re-infantilizza la maturità è la ragione per cui, sottolinea Eco, i Peanuts piacciono a tutti: il loro mondo è una «piccola commedia umana» dove un personaggio come Charlie Brown non è per nulla un essere inferiore (come pure i suoi antagonisti ripetono) ma un tipo normale. È la società sull’orlo del suicidio – il poveraccio dichiara spesso di «vivere alla mezza giornata». Ed ecco sfilare una serie di ‘caratteri’ al tempo stesso ben definiti e continuamente emendabili (non a caso, come si diceva, arricchiti e approfonditi nei decenni successivi dal loro stesso autore): Lucy insensibile; Linus emotivamente instabile (ha alle spalle Freud e soci: il suo blanket è sicurez-za da ottenere); schroeder cultore di una religione estetica contraffatta; Pig Pen sporco come scelta esistenziale; snoopy antistrofe continua ai patemi umani (sa si essere un cane e vorrebbe essere altro). tutto ciò anche grazie a una straordi-naria economia di mezzi espressivi, a un uso sapiente di minuscoli tratti grafici (gauthier 1976) che, facendo la differenza con altri fumetti (Barbieri 1991), ne accentua la poeticità.
Ma il gioco poetico non è dato soltanto da questa specie di estetica minima-lista, quanto più in generale (cosa che come è noto Eco riprenderà teoricamente nel Lector in fabula [1979]) da un uso sapiente della ‘pigrizia’ testuale. Il testo dei Peanuts è tendenzialmente pigro, lascia cioè al lettore la necessità e l’agio di riempire i vuoti di cui esso si fregia. Il caso più ovvio è quello dell’assenza/presenza degli adulti, mai visibili nelle varie strisce, eppure contraltare essenziale al mondo dei bimbi monstre. Ma, come ha ribadito Bassano di tufillo (2010), a essere assenti nel mondo dei Peanuts non sono soltanto gli adulti quanto sem-mai tutto ciò che trascende, opponendovisi significativamente, la dimensione dei bambini. In altre parole, l’alterità, mai rappresentata, significa comunque, e parecchio, grazie a una geniale estetica del fuori campo: basti pensare alla ragaz-zina dai capelli rossi, di cui Charlie Brown è follemente innamorato (fig. 2), o al gatto dei vicini, terrore di snoopy (fig. 3).
APOCALIttICI E INtEgrAtI: 1964-2014
— 19 —
Figg. 2-3. Estetica del fuori campo
Cosa che ci riporta all’opposizione di fondo fra superman e schulz, la quale non sta soltanto in un problema di contenuti (superuomo di massa vs perso-naggini di massa; omone invincibile vs looser, estetica della forza vs estetica del ‘carino’ etc.), ma anche in una questione di forme narrative e testuali. Così, se in superman il pubblico è pigro e il testo si trova costretto a dire tutto il necessario, spesso anche in modo ridondante, nei Peanuts vale il contrario: il testo è pigro e interpella un pubblico attivo. A differenziare i due prodotti è anche la gestione della temporalità: se per superman il problema sta, come s’è detto, nella riformu-lazione quotidiana della mitologia (da cui il paradosso temporale di un consumo non consumabile), per i Peanuts il tempo dominante è quello della saga:
non solo ogni puntata esaurisce una vicenda, ma la ‘saga’ nel suo complesso trae valore proprio dal sistema iterativo con cui le varie vicende concluse si addensano l’una sull’altra, da un lato portando all’esasperazione di elementi fissi, dall’altra giocando proprio sulla riconoscibilità di questi elementi fissi, e non usandoli come artifizi per coordinare la memoria del lettore, ma come veri e propri oggetti di un’ironia crescente (AI, 160).
5. Snoopy terzomondista
Fra i (non molti) studiosi che hanno ripreso e approfondito il discorso di Eco sui Peanuts occorre ricordare Omar Calabrese, che in un saggio poco noto ripreso in un libro anch’esso dimenticato (Serio ludere [1993]) parla di uno snoopy ‘ter-zomondista’. secondo Calabrese il bracchetto di Charlie Brown non è soltanto, come sosteneva Eco, un’antistrofe continua ai patemi umani, né tantomeno può essere ridotto, come tanta estetica da merchandising di massa ha fatto e fa, a una figura cute, all’idea banale del ‘cucciolo caldo’. Molto diversamente, esso
tAvOLA rOtONdA
— 20 —
sarebbe (o forse lo è diventato più chiaramente nelle strisce degli ultimi decenni del Novecento) l’eroe segreto della traduzione e dell’interculturalità. seguiamo il ragionamento di Calabrese, il quale ci riporterà al nesso fra tipo e topos che abbiamo lasciato in sospeso.
secondo Calabrese le storie dei Peanuts intrecciano due mondi. da un lato ci stanno gli umani, con tutto il gioco di scambi fra infanzia e maturità. «I bambini di schultz – scrive Calabrese – non sono affatto bambini […]; sono solo la sem-plificazione dei difetti degli adulti, resi possibili attraverso il trucco antidisneyano di una falsa freschezza e falsa ingenuità infantile» (Calabrese 1993, 48). Il loro isterismo deriva dal fatto che vivono in bilico fra due forme di vita. Motivo per cui è difficile identificarci con loro. dall’altro lato ci sono gli animali, come il già ricordato gatto dei vicini, o come Woodstock e gli altri uccellini, i quali parlano una lingua monotonale che, tranne snoopy, nessuno comprende. snoopy, dal canto suo, media fra questi due mondi senza far parte in senso stretto né dell’uno né dell’altro. Il celebre bracchetto è un mediatore, un ponte. Apparentemente sta con gli animali, che capisce solo lui. Ma per altri versi condivide l’universo affettivo degli adulti. «In questo suo star nel mezzo, finisce per possedere egli stesso un mondo ‘intermedio’, una cultura che potremmo definire creola o pidgin» (Calabrese 1993, 49) . da cui l’idea di uno snoopy terzomondista: la sua capacità traduttiva universale lo rende apolide. solitario per necessità, è uno che si arrangia. Furbetto, narcisista, sleale, smargiasso, vigliacchetto, esattamente all’opposto del suo padrone sa sempre come cavarsela. si pensi alla convenzione fumettistica che oppone la parola (balloon a linea continua) e il pensiero (balloon a nuvo-letta): snoopy la neutralizza senza alcuna difficoltà, e senza che nessuno se ne stupisca. da una parte pensa, fra sé e sé. Ma d’altra parte questo suo pensiero è sempre e immediatamente socializzato, compreso, condiviso, permettendogli di entrare in contatto con gli altri pur rimanendo entro la sua folle intimità. Questa sua ‘parola pensata’, come la definisce Calabrese, gli consente di vivere al tempo stesso da solo e con gli altri, passando in continuazione dalla sfera intima a quella pubblica, dalle perversioni più segrete alle interazioni sociali più tipiche, finendo per costruire una specie di ‘terza via’ che ne fa un caso quanto meno singolare di solitario di massa. si pensi anche alla razza canina di cui fa parte: è un beagle, un bracchetto, dunque un bastardo, una via intermedia, un immigrato, un signor nessuno, col quale, diversamente dagli umani e dagli animali ‘puri’, è proprio per questo assai facile identificarsi. Con le parole di Eco, diremo perciò che snoopy è il tipo del bastardo mediatore, del traduttore universale e necessario.
Ma la caratteristica che forse più di tutte lo identifica è la poliedricità, che Calabrese non chiama espressamente ‘neobarocca’, pur riferendosi esattamente al passare spasmodicamente di questo personaggio da una forma all’altra, da un aspetto all’altro, assumendo metamorficamente i connotati di figure, personaggi e situazioni sempre diversi. snoopy, scrive Calabrese, «rielabora le mitologie,
APOCALIttICI E INtEgrAtI: 1964-2014
— 21 —
e le traduce in aspirazioni e ambizioni». Possedendo un’immaginazione e una fantasia smisurate, il bracchetto si lancia in continue pratiche di identificazione con una miriade di altri personaggi che, a ben vedere, sono figure stereotipe, icone dell’immaginazione, della realtà storica o sociale, come il tetro avvoltoio o l’avvocato di grido, il playboy del college o il chirurgo specializzato, l’aviatore della prima guerra mondiale o il tennista impacciato, lo scrittore alle prime armi o il pattinatore galante. Ecco insomma, in un tipo come snoopy, riaffiorare una grande quantità di topoi, grazie ai quali questo personaggio, da un lato, crea le condizioni minime per una interazione sbilenca con gli altri personaggi del suo universo, consentendogli, dall’altro, di diventare materia di identificazione col lettore.
Figg. 4-7. topoi con cui Snoopy si identifica
Il gioco delle identificazioni è perciò duplice. da una parte snoopy, essendo a cavallo fra due o più mondi, è il personaggio dei Peanuts con cui riesce più facile
tAvOLA rOtONdA
— 22 —
identificarsi. dall’altra è un personaggio che, già all’interno delle storie che vive, si identifica con molte altre figure della società o dell’immaginazione, costruendo la propria tipicità proprio a partire dai topoi che risucchia e rielabora. Il suo è un perfetto uso pratico dei personaggi, finalizzato a quelle condizioni pragmatiche di esistenza sociale che, una volta assunte, vengono continuamente forzate, messe in discussione, superate, rimosse. Né apocalittico né integrato, insomma. Forse eroe decadente, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro.
La cultura cinematografica italiana: l’apocalisse come strumento di integrazione
di Giacomo Manzoli
Non è affatto immediato stabilire l’importanza di un libro come Apocalittici e integrati nel contesto di quello che a metà degli anni sessanta era uno dei cam-pi più vivaci della cultura italiana, vale a dire quello cinematografico, e di tutta l’elaborazione discorsiva che lo accompagnava.
siamo nel pieno di quella che verrà giustamente definita l’età dell’oro della cinematografia nazionale (Brunetta 1991). Il sistema industriale è florido, e si avvia a superare (fatto storico!) negli incassi il cinema americano. dal punto di vista creativo, non c’è mai stata tanta vivacità. Autori relativamente maturi come rossellini, visconti, Antonioni, Fellini sono fra gli artisti più rispettati a livello internazionale. giovani talenti premono per far valere nuove istanze, da rosi a Pasolini, da Bertolucci ai taviani a Ferreri e così via. Il cosiddetto «cinema medio», quello capace di intercettare trasversalmente tutti i tipi di pubblico, ha i suoi più straordinari interpreti in figure come Monicelli, risi, Comencini, Bolognini, Lattua-da, damiani e molti altri. La commedia all’italiana è una sorta di «forma simbolica» d’elezione per l’Italia del Boom. Perfino i generi popolari più elementari, quelli che apparentemente si limitano a copiare e sfruttare (la cosiddetta exploitation) moduli standardizzati fino all’esaurimento, è in grado di contaminare e rielaborare forme straordinariamente originali (si pensi al western di sergio Leone o all’horror di dario Argento). Insomma, l’industria culturale lavora a pieno ritmo e quella del cinema ne è uno dei motori portanti, contaminando l’alto e il basso, stabilendo alleanze e sinergie con una flessibilità e un’energia irripetibili.
Eppure, a fronte di tutto questo, accadono due fenomeni che richiedono una spiegazione. La cultura cinematografica, ovvero – come detto – l’elabora-zione discorsiva di natura critica e saggistica che riguarda i film e i registi, si va sempre più polarizzando esattamente nella direzione descritta nel testo di Eco. se produzione e consumo appaiono sempre più fluidi, sempre più predisposti ad