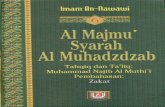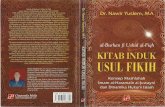[Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità,...
Transcript of [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità,...
Giovanni Casertano et al ELEATICA 2011
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
Eleatica vol 4
Series editors Livio Rossetti (Perugia)
Massimo Pulpito (Taranto)
Volume 1
Giovanni Casertano et al
ELEATICA 2011 Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
A cura di Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Academia Verlag Sankt Augustin
Questo volume egrave stato realizzato con il contributo erogato dal Ministero dei Beni e delle Attivitagrave Culturali e del Turismo ndash
Direzione Generale Biblioteche Istituti Culturali e Diritto dautore
Illustration on the cover Mosaico dei filosofi (part)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Series and book published by agreement with the Fondazione Alario per Elea-Velia onlus Ascea (SA)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uumlber httpdnbddbde abrufbar
ISBN 978-3-89665-675-9
1 Auflage 2015
copy Academia Verlag Bahnstraszlige 7 D-53757 Sankt Augustin
Internet wwwacademia-verlagde E-Mail infoacademia-verlagde
Printed in Germany
Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet das Werk unter Verwendung mechanischer elektronischer und anderer Systeme in
irgendeiner Weise zu verarbeiten und zu verbreiten Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vervielfaumlltigung ndash auch von Teilen des Werkes ndash auf
fotomechanischem oder aumlhnlichem Wege der tontechnischen Wiedergabe des Vortrags der Funk- und Fernsehsendung der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen der Uumlbersetzung und der literarischen und anderweitigen Bearbeitung
Indice
From Parmenides to Plato an overview
(Francesca Gambetti and Stefania Giombini) 7
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica
(Francesca Gambetti e Stefania Giombini) 15
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
(Giovanni Casertano) 43
I Parmenide e i dibattiti scientifico-filosofici del V secolo 45
II Protagora e Gorgia una bdquoderiva‟ del parmenidismo 45
1 Il crinale sofistico del parmenidismo Protagora 45
2 Il crinale sofistico del parmenidismo Gorgia 55
3 Ancora Gorgia su veritagrave ed errore 65
III Platone neacute confusione neacute separazione tra linguaggio e realtagrave 78
1 La duplice discendenza parmenidea 78
2 Il Parmenide 79
3 Il Sofista 88
Bibliografia essenziale 121
Il dibattito 127
L‟insoutenable poids des bdquoabsences‟ dans l‟interpreacutetation parmeacutenidienne
de Casertano (Neacutestor-Luis Cordero) 129
Essere pensare nominare alcune riflessioni su Gorgia e Platone
(Maria Carmen De Vita) 136
ηὸ λ ηὸ λ e laquoquelle che uno puograve ritenere che siano ideeraquo
(Parm 135e3-4) (Sergio Di Girolamo)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 141
L‟essere (e il non essere) nel Parmenide di Platone (Franco Ferrari) 148
Sulla natura del genere del diverso nel Sofista (Francesco Fronterotta) 153
Il tradimento di Platone (Francesca Gambetti) 159
Per un profilo di Gorgia (Stefania Giombini) 165
Logica e dialogica Analogia e dialettizzazione della realtagrave nel pensiero
platonico (Silvio Marino) 169
Commento alle lezioni eleatiche di Gianni Casertano (Lidia Palumbo) 176
La versione di Seniade e il parricidio performativo di Platone
(Massimo Pulpito) 182
Il ν ξνο diventa maestro note sull‟incontro tra Socrate e Parmenide
(Sofia Ranzato) 192
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Eleatica vol 4
Series editors Livio Rossetti (Perugia)
Massimo Pulpito (Taranto)
Volume 1
Giovanni Casertano et al
ELEATICA 2011 Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
A cura di Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Academia Verlag Sankt Augustin
Questo volume egrave stato realizzato con il contributo erogato dal Ministero dei Beni e delle Attivitagrave Culturali e del Turismo ndash
Direzione Generale Biblioteche Istituti Culturali e Diritto dautore
Illustration on the cover Mosaico dei filosofi (part)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Series and book published by agreement with the Fondazione Alario per Elea-Velia onlus Ascea (SA)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uumlber httpdnbddbde abrufbar
ISBN 978-3-89665-675-9
1 Auflage 2015
copy Academia Verlag Bahnstraszlige 7 D-53757 Sankt Augustin
Internet wwwacademia-verlagde E-Mail infoacademia-verlagde
Printed in Germany
Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet das Werk unter Verwendung mechanischer elektronischer und anderer Systeme in
irgendeiner Weise zu verarbeiten und zu verbreiten Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vervielfaumlltigung ndash auch von Teilen des Werkes ndash auf
fotomechanischem oder aumlhnlichem Wege der tontechnischen Wiedergabe des Vortrags der Funk- und Fernsehsendung der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen der Uumlbersetzung und der literarischen und anderweitigen Bearbeitung
Indice
From Parmenides to Plato an overview
(Francesca Gambetti and Stefania Giombini) 7
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica
(Francesca Gambetti e Stefania Giombini) 15
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
(Giovanni Casertano) 43
I Parmenide e i dibattiti scientifico-filosofici del V secolo 45
II Protagora e Gorgia una bdquoderiva‟ del parmenidismo 45
1 Il crinale sofistico del parmenidismo Protagora 45
2 Il crinale sofistico del parmenidismo Gorgia 55
3 Ancora Gorgia su veritagrave ed errore 65
III Platone neacute confusione neacute separazione tra linguaggio e realtagrave 78
1 La duplice discendenza parmenidea 78
2 Il Parmenide 79
3 Il Sofista 88
Bibliografia essenziale 121
Il dibattito 127
L‟insoutenable poids des bdquoabsences‟ dans l‟interpreacutetation parmeacutenidienne
de Casertano (Neacutestor-Luis Cordero) 129
Essere pensare nominare alcune riflessioni su Gorgia e Platone
(Maria Carmen De Vita) 136
ηὸ λ ηὸ λ e laquoquelle che uno puograve ritenere che siano ideeraquo
(Parm 135e3-4) (Sergio Di Girolamo)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 141
L‟essere (e il non essere) nel Parmenide di Platone (Franco Ferrari) 148
Sulla natura del genere del diverso nel Sofista (Francesco Fronterotta) 153
Il tradimento di Platone (Francesca Gambetti) 159
Per un profilo di Gorgia (Stefania Giombini) 165
Logica e dialogica Analogia e dialettizzazione della realtagrave nel pensiero
platonico (Silvio Marino) 169
Commento alle lezioni eleatiche di Gianni Casertano (Lidia Palumbo) 176
La versione di Seniade e il parricidio performativo di Platone
(Massimo Pulpito) 182
Il ν ξνο diventa maestro note sull‟incontro tra Socrate e Parmenide
(Sofia Ranzato) 192
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Giovanni Casertano et al
ELEATICA 2011 Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
A cura di Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Academia Verlag Sankt Augustin
Questo volume egrave stato realizzato con il contributo erogato dal Ministero dei Beni e delle Attivitagrave Culturali e del Turismo ndash
Direzione Generale Biblioteche Istituti Culturali e Diritto dautore
Illustration on the cover Mosaico dei filosofi (part)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Series and book published by agreement with the Fondazione Alario per Elea-Velia onlus Ascea (SA)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uumlber httpdnbddbde abrufbar
ISBN 978-3-89665-675-9
1 Auflage 2015
copy Academia Verlag Bahnstraszlige 7 D-53757 Sankt Augustin
Internet wwwacademia-verlagde E-Mail infoacademia-verlagde
Printed in Germany
Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet das Werk unter Verwendung mechanischer elektronischer und anderer Systeme in
irgendeiner Weise zu verarbeiten und zu verbreiten Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vervielfaumlltigung ndash auch von Teilen des Werkes ndash auf
fotomechanischem oder aumlhnlichem Wege der tontechnischen Wiedergabe des Vortrags der Funk- und Fernsehsendung der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen der Uumlbersetzung und der literarischen und anderweitigen Bearbeitung
Indice
From Parmenides to Plato an overview
(Francesca Gambetti and Stefania Giombini) 7
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica
(Francesca Gambetti e Stefania Giombini) 15
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
(Giovanni Casertano) 43
I Parmenide e i dibattiti scientifico-filosofici del V secolo 45
II Protagora e Gorgia una bdquoderiva‟ del parmenidismo 45
1 Il crinale sofistico del parmenidismo Protagora 45
2 Il crinale sofistico del parmenidismo Gorgia 55
3 Ancora Gorgia su veritagrave ed errore 65
III Platone neacute confusione neacute separazione tra linguaggio e realtagrave 78
1 La duplice discendenza parmenidea 78
2 Il Parmenide 79
3 Il Sofista 88
Bibliografia essenziale 121
Il dibattito 127
L‟insoutenable poids des bdquoabsences‟ dans l‟interpreacutetation parmeacutenidienne
de Casertano (Neacutestor-Luis Cordero) 129
Essere pensare nominare alcune riflessioni su Gorgia e Platone
(Maria Carmen De Vita) 136
ηὸ λ ηὸ λ e laquoquelle che uno puograve ritenere che siano ideeraquo
(Parm 135e3-4) (Sergio Di Girolamo)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 141
L‟essere (e il non essere) nel Parmenide di Platone (Franco Ferrari) 148
Sulla natura del genere del diverso nel Sofista (Francesco Fronterotta) 153
Il tradimento di Platone (Francesca Gambetti) 159
Per un profilo di Gorgia (Stefania Giombini) 165
Logica e dialogica Analogia e dialettizzazione della realtagrave nel pensiero
platonico (Silvio Marino) 169
Commento alle lezioni eleatiche di Gianni Casertano (Lidia Palumbo) 176
La versione di Seniade e il parricidio performativo di Platone
(Massimo Pulpito) 182
Il ν ξνο diventa maestro note sull‟incontro tra Socrate e Parmenide
(Sofia Ranzato) 192
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Questo volume egrave stato realizzato con il contributo erogato dal Ministero dei Beni e delle Attivitagrave Culturali e del Turismo ndash
Direzione Generale Biblioteche Istituti Culturali e Diritto dautore
Illustration on the cover Mosaico dei filosofi (part)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Series and book published by agreement with the Fondazione Alario per Elea-Velia onlus Ascea (SA)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uumlber httpdnbddbde abrufbar
ISBN 978-3-89665-675-9
1 Auflage 2015
copy Academia Verlag Bahnstraszlige 7 D-53757 Sankt Augustin
Internet wwwacademia-verlagde E-Mail infoacademia-verlagde
Printed in Germany
Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet das Werk unter Verwendung mechanischer elektronischer und anderer Systeme in
irgendeiner Weise zu verarbeiten und zu verbreiten Insbesondere vorbehalten sind die Rechte der Vervielfaumlltigung ndash auch von Teilen des Werkes ndash auf
fotomechanischem oder aumlhnlichem Wege der tontechnischen Wiedergabe des Vortrags der Funk- und Fernsehsendung der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen der Uumlbersetzung und der literarischen und anderweitigen Bearbeitung
Indice
From Parmenides to Plato an overview
(Francesca Gambetti and Stefania Giombini) 7
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica
(Francesca Gambetti e Stefania Giombini) 15
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
(Giovanni Casertano) 43
I Parmenide e i dibattiti scientifico-filosofici del V secolo 45
II Protagora e Gorgia una bdquoderiva‟ del parmenidismo 45
1 Il crinale sofistico del parmenidismo Protagora 45
2 Il crinale sofistico del parmenidismo Gorgia 55
3 Ancora Gorgia su veritagrave ed errore 65
III Platone neacute confusione neacute separazione tra linguaggio e realtagrave 78
1 La duplice discendenza parmenidea 78
2 Il Parmenide 79
3 Il Sofista 88
Bibliografia essenziale 121
Il dibattito 127
L‟insoutenable poids des bdquoabsences‟ dans l‟interpreacutetation parmeacutenidienne
de Casertano (Neacutestor-Luis Cordero) 129
Essere pensare nominare alcune riflessioni su Gorgia e Platone
(Maria Carmen De Vita) 136
ηὸ λ ηὸ λ e laquoquelle che uno puograve ritenere che siano ideeraquo
(Parm 135e3-4) (Sergio Di Girolamo)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 141
L‟essere (e il non essere) nel Parmenide di Platone (Franco Ferrari) 148
Sulla natura del genere del diverso nel Sofista (Francesco Fronterotta) 153
Il tradimento di Platone (Francesca Gambetti) 159
Per un profilo di Gorgia (Stefania Giombini) 165
Logica e dialogica Analogia e dialettizzazione della realtagrave nel pensiero
platonico (Silvio Marino) 169
Commento alle lezioni eleatiche di Gianni Casertano (Lidia Palumbo) 176
La versione di Seniade e il parricidio performativo di Platone
(Massimo Pulpito) 182
Il ν ξνο diventa maestro note sull‟incontro tra Socrate e Parmenide
(Sofia Ranzato) 192
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Indice
From Parmenides to Plato an overview
(Francesca Gambetti and Stefania Giombini) 7
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica
(Francesca Gambetti e Stefania Giombini) 15
Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone
(Giovanni Casertano) 43
I Parmenide e i dibattiti scientifico-filosofici del V secolo 45
II Protagora e Gorgia una bdquoderiva‟ del parmenidismo 45
1 Il crinale sofistico del parmenidismo Protagora 45
2 Il crinale sofistico del parmenidismo Gorgia 55
3 Ancora Gorgia su veritagrave ed errore 65
III Platone neacute confusione neacute separazione tra linguaggio e realtagrave 78
1 La duplice discendenza parmenidea 78
2 Il Parmenide 79
3 Il Sofista 88
Bibliografia essenziale 121
Il dibattito 127
L‟insoutenable poids des bdquoabsences‟ dans l‟interpreacutetation parmeacutenidienne
de Casertano (Neacutestor-Luis Cordero) 129
Essere pensare nominare alcune riflessioni su Gorgia e Platone
(Maria Carmen De Vita) 136
ηὸ λ ηὸ λ e laquoquelle che uno puograve ritenere che siano ideeraquo
(Parm 135e3-4) (Sergio Di Girolamo)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 141
L‟essere (e il non essere) nel Parmenide di Platone (Franco Ferrari) 148
Sulla natura del genere del diverso nel Sofista (Francesco Fronterotta) 153
Il tradimento di Platone (Francesca Gambetti) 159
Per un profilo di Gorgia (Stefania Giombini) 165
Logica e dialogica Analogia e dialettizzazione della realtagrave nel pensiero
platonico (Silvio Marino) 169
Commento alle lezioni eleatiche di Gianni Casertano (Lidia Palumbo) 176
La versione di Seniade e il parricidio performativo di Platone
(Massimo Pulpito) 182
Il ν ξνο diventa maestro note sull‟incontro tra Socrate e Parmenide
(Sofia Ranzato) 192
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
6 Indice
Itineraacuterios das ideias (Fernando Santoro) 199
La δ μα appare Nota a DK 28B1 28-32 e B851-61
(Alessandro Stavru) 206
Le repliche (Giovanni Casertano) 211
Gli autori 231
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
From Parmenides to Plato an Overview
Francesca Gambetti and Stefania Giombini
The Eleatic Lectures of Giovanni Casertano (= GC) delivered on the occasion
of Eleatica 2011 form the basic ingredient of this book Their aim is to show how
Protagoras Gorgias and Plato found appropriate to rethink Parmenides‟ teachings
and incorporate some corollaries of it into their own teachings
In the first lecture not published here GC resumes and updates his well-
known interpretation of Parmenides presented in his book Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (Napoli 1978) Accordingly he maintains that Parmenides
was a θπζη ινγνο fully connected with culture and science of his time and able to
distinguish between something that always remains the same in its nature and
something that instead changes Therefore he claims Parmenides should be co n-
sidered a distinguished materialist scholar Parmenides distinguishes between
something (η λ) that always is the same and eternal that is not born and does
not die that is firm and immobile and something (ηά ληα) that changes that is
born and dies that becomes and always appears in a different way A new lan-
guage and a strict methodology allowed him to prove what was the common opin-
ion about the reality lying behind what appears This way he opened the door to
the dialectic between time and timelessness shared by most subsequent Presocrat-
ics So there wasn‟t any break between Parmenides and the naturalism of the early
Ionian and Pythagorean philosophersscientists and the metaphysical thought
which allegedly began with him Ancient commentators such as Iamblichus and
Simplicius took for certain that Parmenides was a student of nature Parmenides as
a philosopher of being a metaphysical thinker bdquothe father of Western metaphys-
ics‟ is actually just a modern interpretation of which Hegel and Heidegger bear
the main responsibility
Therefore the important innovation of Parmenides‟ doctrine lies in the bdquological
proof‟ of ζήκαηα that characterize reality understood as a whole unbegotten and
imperishable (DK 28B83) entire unique immutable and perfect without end
(DK 28B84) homogeneous one continuous (DK 28B85-6) But as previously
said by the Goddess in her bdquopreface‟ of the work the young θν ξνο will not learn
only the ldquoheart of the truthrdquo ie the nature as a whole but also ldquothe beliefs of mor-
tals which comprise no genuine convinctionrdquo (Coxon‟s translation) ie nature
intended as multiplicity of phenomena in which two ldquoformsrdquo or elements fire and
night (DK 28B856-59) enter into the composition of all things
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
8 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
In view of that GC suggests to interpret the second part of the poem not as a
list of the erroneous opinions of men but as a true doctrine of Parmenides a wide-
spread and well-structured cosmological system Two aspects were new in Par-
menides 1) the logical demonstration and the formal character of the whole 2) a
clear theory of method the ldquoway of enquiringrdquo (DK 28B2) by which we can get
two sets of statements the real ones and the plausible ones This latter aspect led
him to affirm the identity between thinking and being meaning that every time you
think you think of something that exists while you may not think of something
that is not that does not exist For GC this point meant not only that thinking is
inseparably connected with thought primarily because no thought can be a thought
of nothing secondarily because no thought could fail to be thought of reality (be-
sides a reality is always expressed in thought) Therefore even the monolithic
perspective of Parmenides left the door open to the possibility of mistake long
before Gorgias and his attempt to equate being and not being true and false
In his second lecture (the first entirely printed here) GC focuses on Protagoras
and Gorgias the bdquosophistic side‟ of Parmenides‟ thought According to GC they
preserved the Parmenidean equivalence between being thinking and saying On
these grounds Protagoras claimed that truth is bdquomeasure‟ and every man by sensi-
ble experience establishes a dialectical relationship with reality This experience is
always true because reality is something given not created by him man simply
finds and captures it But the output of this or that man is a talk which is true to
himher without being bdquoobjectively‟ true The relative knowledge of each individu-
al can only grasp something an aspect of objective reality and everyone is entitled
to claim what is true for him in a given moment in given conditions As a result
no false speech is conceivable
All that implies according to GC that Protagoras accepted Parmenides‟ prin-
ciple of a direct relationship between being thinking and saying but dared to deny
its consequences for Parmenides there is only one true discourse while Protagoras
argued that all speeches are true (and at the same time false) Plato clearly wanted
to rescue truth from this subjective dimension and established an objectivistic
perspective according to which truth has a public not a private status For this
reason he wanted to reaffirm Parmenides‟ perspective and assumed that reality is
the condition of true speech while preserving the homo mensura principle Of the
long bdquostruggle‟ that Plato engaged against Protagoras ndash whose evidence is supplied
by Theaetetus and Cratylus ndash only some elements are dealt with in some detail by
GC who concentrates rather on Gorgias
The performative power of ι γνο is taken to be the very heart of Gorgias‟ in-
vestigation Besides being a very skilled rhetorician able to amaze and stun his
audience through words games in support of the most absurd or paradoxical theses
according to GC Gorgias was a true philosopher He argued that the levels of reali-
ty and of discourse about reality far from being the same remain distinct and dis-
continuous since every relationship between thinking and reality is established by
language and only thinking makes being real for man Words always express a
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
From Parmenides to Plato an Overview 9
logical organization by a subject and therefore can never be bdquoobjective‟ In this
way Gorgias opened a deep break between being and thinking not so much in the
sense that between them there is no relationship but in the sens e that such a rela-
tionship requires a careful and thorough critical reflection Therefore for Gorgias
a reality which is not filtered through discourse is unthinkable and elusive Moreo-
ver external reality is a construction made by humans that assign a meaning to
what they perceive Truth is inside the speech itself inherent to the logical stru c-
ture expressing a relationship with reality which correctly states an unverifiable
idea of reality This is the origin of belief and deception
According to GC Gorgias‟ perspective is apparently much more varied and
richer than what is commonly believed and Plato especially when writing the
Sophist offers an ample evidence of how aware he is of the force of Gorgias‟ (and Protagoras‟) theories of truth He wants to dispose of their theories he tries to do
so but he is forced to acknowledge that this undertaking is unexpectedly difficult
Let‟s analyze the third lecture (the second one printed here) In his Parmeni-des Plato distinguished two senses of being and not-being a simple or absolute
sense which refers to the plan of existence and a relative sense that refers to the
linguistic horizon He therefore acknowledged the existence or non-existence of
things and the possibility of translating reality into reliable terms According to
GC the centrality ascribed to speech is one of the most significant contributions of
Plato‟s Parmenides And insofar as Plato is now prepared to acknowledge that the
only way for humans to look at things is through thought and speech an important
(even unexpected) affinity is established with the theories of Protagoras and Gorg i-
as about how thought and speech systematically filter reality and somehow replace
it with artful substitutes whose reliability is necessarily uncertain Whence Plato‟s
need to recover if possible a sound access to truth
Plato‟s Sophist in turn takes the Sophist to be someone devoid of science
who builds illusions copies of appearance θαληάζκαηα claiming the existence of
what is not ie as a sort of elusive Proteus This somehow on the surface actually
the dialogue is looking for an alternative to Protagoras‟ and Gorgias‟ subjectivism
Plato‟s search may be qualified as an effort to single out an agreement on the
meanings through discourse (δηὰ ι γνλ) In order to refute Gorgias Plato needs to
grant reality to falsification since if truth is a relationship between existing things
falsehood is a relationship established by speech between non-existent things So
falsehood exists only as lacking relationship between real objects concerning
however only the predicational level not the ontological one
Gorgias‟ rift between being and saying which Plato wanted to sew up at the
end of the dialogue remains the following the sophist is an imitator who deceives
while the philosopher is the imitator who knows Both represent the highest ex-
pression of constitutive human ability to construct speeches and behind what
looks like a simple logical opposition the ethical and political convictions Plato
wanted to assert can actually be detected
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
10 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Discussion
NEacuteSTOR-LUIS CORDERO agrees with GC in considering Parmenides a
physiologist like other Presocratics but he criticizes some aspects of his lexical
interpretation as when for example GC distinguishes between something that is
always equal to itself ηὸ λ and something that changes ηὰ ληα He argues that
the very use of the singular ηὸ λ distinguishes Parmenides from other presocrat-
ics and makes him the philosopher who studied things that are as abs olute and
necessary beings He also complains that GC paid little attention to two terms
opinions and mortals and translated δ μαη with bdquoexperience‟ In Cordero‟s opinion
this translation is wrong because in Xenophanes and Heraclitus δ μα always means
point of view opinion GC also contradicts hims elf because he first considers Par-
menides a physiologist like the others but then he affirms a Platonic reading of the
fragments taken as a unitary text and forgets their fragmentary nature
GC replies that Cordero rightly emphasizes the speculative nature of the poem
of Parmenides but he reiterates his interpretation of λ as θύζηο that is bdquoevery-
thing‟ and not as Cordero believes as simple and abstract bdquobeing‟ GC also re-
members that before Plato the term δ μα has not been taken as a negative qualifica-
tion Therefore in the case of bdquophysical reflections‟ it is not outrageous to translate
this term with bdquoexperience‟
MARIA CARMEN DE VITA agrees with GC in interpreting the third argu-
ment of Gorgias ηκν as an attack against the dialectical unity established by Par-
menides of being thinking and saying Gorgias in fact separates ι γνο from
ξάγκαηα and gives to language a practical-persuasive function of creating a prop-
er truth This uncomfortable Gorgian legacy is dealt with not only in the Sophist as
evidenced by GC‟s Eleatic Lectures but also in the Cratylus where the notions of
κίκεζηο εἰθώλ and δήισκα are analyzed The latter term is used to indicate that
ι γνο refers to essences the nature of things Here Plato far from separating being
and saying uses the communicative dimension of language to measure the truth
and correctness of language Right in the Cratylus in fact Plato assigns to the
ὄλνκα the task of showing the essence of things he also delivers this term from its
bounds with opinion and reaffirms its value as a reliable instrument of philosop hi-
cal inquiry
GC welcomes the analysis of the Cratylus made by De Vita and helds the in-
vestigation of the names in this dialogue as a parallel and complementary argument
to those in the Sophist He also reiterates that Plato places himself between conven-
tionalism and naturalism He also acknowledges that the argument of the Cratylus
analyzed by De Vita is effective against Gorgias
According to SERGIO DI GIROLAMO GC‟s interpretation of Parmenides‟
cosmos is confirmed by Timaeus 31a4-5 and 33b4-6 where verses 28B8 42-44 are
echoed Moreover he asks GC whether compared to the pages of Republic V
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
From Parmenides to Plato an Overview 11
476e7-480a13 and 477a2-4 the issue of the δ μα as third ontological-epistemo-
logical level was an original thesis of Plato or was already present in Parmenides
Thirdly he asks how to find a relationship between the cosmological hypothesis of
the first part of the Parmenides and the gymnasia concerning ideas
GC claims that in the Timaeus Plato shows that he learned from Parmenides
not only contents but also a method while the heterogeneity between the first part
of the Parmenides and gymnasia is a further proof of the dialectical relationship
between Plato and Parmenides Furthermore he says that the final pages of Re-public V show that Plato is still depending from Parmenides‟ issue about being and
not-being although in the Meno he distinguishes opinion and knowledge according
to clearness and certainty
FRANCO FERRARI analyzes the methodological legacy of Parmenides de-
veloped by Plato in the second part of the eponymous dialogue through a rigorous
deduction of all possible consequences from a single hypothesis For Plato Par-
menides is the master of deductive logic and the supporter of an ontology that
admits the existence of a single genre the natural whole while for Socrates there
are two types of entities spatiotemporal entities and ideas Unlike GC Ferrari
denies that when Plato‟s Parmenides criticises this Socrates he represents the
authentic Platonic position GC maintains that in the first and second deduction of
the second hypothesis Plato argues that existence is a necessary postulate of every
judgement in line with the existential interpretation of Parmenides‟ being while
Ferrari who is in favor of a copulative or predicative interpretation of being as-
sumes that for Plato it is enough to determine and circumscribe what we are talking
about
GC agrees with Ferrari when he says that Plato considered Parmenides a mas-
ter of deductive logic but denies that in the γπκλαζία Parmenides considers the
objects of discussion only as spatiotemporal entities Nor does he share the opinion
that the verb to be in Plato has a single meaning either existential or predicative
The two senses of being are in his opinion always intertwined and cannot be
clearly distinguished
FRANCESCO FRONTEROTTA examines the Platonic conception of not -
being and its conceptual similarity with ηὸ ηεξνλ Each genre in fact participates
of being as it is both that particular genre and of ηὸ ηεξνλ if it has to have an
identity of its own Therefore ηὸ ηεξνλ has the property of generating not-being in
each genre a move that begets the duplication of genres (a sort of overcrowding)
Fronterotta notes that the ontological foundation of diversity gives rise to a
bdquotransgeneric‟ genre whose identity can only be absurdly different from itself The
different instead would be perfectly feasible and consistent in relation to being
which has the same ontological extension The Sophist therefore produces a dy-
namic ontology in which being and ηὸ ηεξνλ intersect with the inclusion of ηὸ
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
12 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ηεξνλ into being This seems to prefigure Aristotle‟s doctrine of the multivocity of
being
On the basis of Fronterotta‟s observations GC infers that a genuine openness
to a complete bdquorelativization‟ of the world of ideas (not as much on an ontological
level as on the epistemological one) surfaces from the Sophist
According to FRANCESCA GAMBETTI behind the political-ethical relativ-
ism of Protagoras and Gorgias can be detected some epistemological assu mptions
of Parmenides who opened to mankind the possibility of knowing the truth on the
basis of a sensorial subjectivism as shown by DK 28B7 and 16 with 28A46 and
47 This sensistic theory was distorted both by Protagoras and Gorgias in a relativ-
istic sense and by Plato in an ontological-objectivistic sense precisely in order to
refute the two sophists but with a real betrayal of his bdquovenerable and awesome‟
master
For GC the distortion of Parmenides‟ thought made by Plato is not particularly
serious because basically every interpretation is always a betrayal a declaration of
loyalty to affirm the specificity of his own thought Furthermore GC is much more
cautious on attributing to Parmenides some form of subjectivity on Theophrastus‟
basis He instead agrees with Gambetti about what may lie behind the ontological
objectivist turn impressed by Plato to Parmenides‟ thought
STEFANIA GIOMBINI highlights the paradoxical nature of the thesis held by
those scholars GC included who consider Gorgias a philosopher whose philoso-
phy consisted in his rhetoric or rather the intuition of the complexity of the logical
formalization of reality Giombini therefore calls on GC to 1) deepen his interpre-
tation by opening up to comparisons with studies that instead emphasize Gorgias‟
strong intersections between logic and epistemology 2) clarify his reconstruction
of the likely possibility of a regulative truth 3) consider the ability to read the third
corollary of ηκν not as an absolute impossibility of communicating but as a sim-
ple difficulty
GC reaffirms that Gorgias leaves no room to absolute truth since truth is a
matter of speeches about facts For the same reasons in the third cornerstone of
ηκν he cannot see mere communication difficulties because it is up to speech to
bdquoconstruct reality‟ ie speak about what lies outside the subject
SILVIO MARINO analyzes the circle produced by Plato while trying to find a
third way between Parmenides and the Sophists He interprets this circle not in a
tautological sense but holistically assuming that while turning back on itself
Plato‟s thought is always gaining new perspectives new plans without abandoning
the previous ones As a result he suggests that the mode of writing used by Plato
which expresses the dialectical relationship between reality and speeches based on
the principle of analogy should also be maintained by modern scholars while read-
ing Plato‟s dialogues
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
From Parmenides to Plato an Overview 13
GC appreciates Marino‟s interesting observations about the holistic circularity
of Plato‟s thinking and writing as well as his considerations about the dialecti-
zation of reality and discourse according to the principle of analogy Moreover he
positively assesses the suggestion to consider the Platonic logical method a dialec-
tic one in which different perspectives ‒ physical ethical political etc ‒ are a l-
ways interwoven
LIDIA PALUMBO begins by stressing the acrobatic dialectic that Plato uses
to found his ontology both in an anti-Protagorean and Parmenidean style She de-
nies that the definition of false speech is ambiguous and that Plato confuses lin-
guistic statements and real relationships in an attempt to establish the logical dif-
ference ontologically based between the speech of the sophist and the philoso-
pher Even for Plato she maintains false is not a real non-existent relationship but
the mere non-existence of verbal relations
According to GC Palumbo really captures the essence of his lectures their re-
spective positions are not far apart Palumbo maintains that for Plato we can talk
about what does not exist while for GC this non-existence does not refer to objects
but to the relationship between real entities
MASSIMO PULPITO analyzes Protagorean relativism transposed by an ob-
scure sophist as Xeniades of Corinth who according to the testimony of Sextus
Empiricus stated the falseness of every appearance and every opinion The cont i-
nuity between Protagors and Xeniades consists in the Protagorean thesis according
to which everything is true implying in the meantime its opposite ie that every-
thing is false Xeniades lies on the same nihilistic line as Gorgias whose argu-
ments root themselves on suspect linguistic ambiguities By distinguishing true
speech from the false one Plato is forced to return to Parmenides despite all the
precautions at the risk of being misunderstood and accused of parricide In Pu l-
pito‟s opinion Plato would not have killed Parmenides proving the groundlessness
of his theory but by corroborating an interpretation of his philosophy that would
have denied not only the absolute not-being but also the predicative one Affirm-
ing the polysemy of ζηίλ Plato accused Parmenides of failing to do so
GC agrees with Pulpito that Protagoras dared to break some basic tenets of
Parmenides but he has doubts about the bdquofragmentation‟ of this principle He also
thanked him for the enclosure of Xeniades from Corinth with Gorgias who would
have deliberately confused infinite time and infinite space to demons trate the am-
biguities in the language GC also appreciates the analysis of parricide made by
Pulpito
According to SOFIA RANZATO the meeting between the young Socrates and
the old Parmenides described in the homonymous dialogue and evoked in the
Theaetetus and in the Sophist intentionally emphasizes the different age of the
actors with the aim to present the theory of ideas as a work in progress not as a
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
14 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
final result The fact that the doctrine of Parmenides in the Sophist is discussed by
an anonymous Stranger of Elea and not by Socrates demonstrates the close rela-
tionship between Plato and his bdquovenerable and awesome‟ teacher right in the mo-
ment when he takes some distance from him
GC thanks Ranzato for putting the theoretical issues of Platonic thought in
connection with the dramatization of Parmenides After the first enterprise with the
chariot during Parmenides‟ youth the same Parmenides performed a second feat
when old helping young Socrates to grow up getting him ready to have access to a
special sort of knowledge
FERNANDO SANTORO argues that there were many routes that joined Elea
and Athens and not just the one described by GC in his Eleatic Lectures The only
route placed off-limits was that of not-being which is the ground of the Platonic
dialectic Thus Parmenides‟ thought so was mediated not only by Zeno and Gorg i-
as as clearly shown by GC but also by Epicharmus of Syracuse whose comedies
according to some traditions were thoroughly analyzed by Plato GC agrees with Santoro in philosophy every ban is a challenge In this way
the route of not-being becomes one of the bases of Platonic dialectic The proposal
to incorporate Epicharmus among the possible mediators and interlocutors of Plato
in respect to Eleatic philosophy is fascinating However Epicharmus was not alone
but that there probably were other mediators whose identity remains outside our
reach
ALESSANDRO STAVRU examines the question of the interpretation of Par-
menidean δ μα sometimes understood as pure deception sometimes as the best
possible explanation of the world sometimes as completion of ἀιήζεηα In Plato
the term has a negative connotation especially in the Republic while in the The-aetetus the existence of a reliable and useful δ μα is admitted The ambivalence of
Platonic positions stems from the ambiguity of this term in Parmenides according
to his goddess the opinions of mortals are bdquowithout certainty‟ and although partak-
ing to the cognitive process proposed by the goddess they are on a different level
than truth
GC denies that δ μα and ἀιήζεηα are on the same level while δ μα appropri-
ates reality without grasping its intrinsic connection ἀιήζεηα captures the same
reality in an organized manner combining the different experiences with ι γνο
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio politica Francesca Gambetti e Stefania Giombini
A meno che i filosofi non regnino nelle
cittagrave oppure quanti ora sono detti re e potenti
non si diano a filosofare con autentico impe-
gno e questo non giunga a riunificarsi il pote-
re politico cioegrave e la filosofia e ancora quei
molti la cui natura ora tende a uno di questi
poli con esclusione dell‟altro non vengano ob-
bligatoriamente impediti ndash non vi saragrave caro
Glaucone sollievo ai mali delle cittagrave e neppu-
re io credo a quelli del genere umano1
Il XX secolo si egrave caratterizzato per un profondo ripensamento della nozione
stessa di filosofia e dei suoi paradigmi interpretativi questo se da un lato ha messo
in discussione alcune certezze ermeneutiche dall‟altro ha prodotto letture piugrave libe-
re e feconde anche nel campo d‟indagine della filosofia antica Uno studio innova-
tivo di questa porzione del pensiero occidentale che aspiri a un approfondimento
della comprensione o a un rinnovamento della stessa implica necessariamente il
ripensamento dei canoni storiografici stabiliti dai vincitori che l‟hanno narrata o
per meglio dire da coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al grande
naufragio dei testi primi fra tutti Platone e Aristotele Egrave difficile negare l‟im-printing decisivo dato dallo Stagirita al comune modo di leggere i filosofi ant ichi
basti pensare alla sua nota ricostruzione delle origini della filosofia nel primo libro
della Metafisica ma anche alla sua influenza sulla grande stagione della storiogra-
fia ottocentesca in particolare quella tedesca di matrice idealistica alla quale dob-
biamo anche quell‟immenso lavoro filologico di recupero sistematizzazione e
codificazione della maggior parte dei testi della filosofia antica che ancora oggi egrave
alla base delle nostre ricerche
-------------------------------------------- 1 Platone Repubblica V 473c11-d7 traduzione di M Vegetti Napoli 2000 pp 88-89
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
16 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Il cursus studiorum di Giovanni Casertano (d‟ora in poi GC) rappresenta una
delle espressioni piugrave originali e significative di questo importante ripensamento
ermeneutico avvenuto nel secolo scorso di cui anche il presente volume egrave esempio
GC esordigrave come egrave noto con ricerche sulla sofistica e su Parmenide (con la bdquorivolu-
zionaria‟ monografia del 1978 Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza) per
poi approdare ad ampie e profonde letture dei dialoghi platonici non senza aprire
ulteriori finestre su autori come Empedocle e Protagora Accenniamo appena a
questo lungo percorso di GC percheacute di recente esso egrave stato oggetto di molteplici
interventi in occasione di λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione la Festschrift in suo onore curata da Lidia Palumbo che gli venne presen-
tata proprio in occasione delle sue Lezioni Eleatiche del 2011
Per le ragioni indicate la scelta di dedicare queste Lezioni Eleatiche al com-
plesso tragitto che da Parmenide conduce a Platone ha significato toccare le princ i-
pali tappe del suo ricco itinerario di ricerca dunque spostare l‟attenzione da singo-
le questioni storiografiche al filo conduttore che ha ispirato un complessivo ripen-
samento di questa cruciale fase del pensiero antico
In questo senso il tema affrontato ha rappresentato una vera e propria sfida un
rapido affresco di quel periodo fondativo del pensiero occidentale nel quale con
l‟epocale spostamento dell‟asse filosofico dalla Magna Grecia ad Atene la rifles-
sione logico-ontologica nata a Elea andograve a innestarsi nel particolare tessuto polit i-
co sociale e culturale della grande ιηο attica generando lo straordinario fiore
che fu il pensiero platonico della maturitagrave
Questa complessa elaborazione ermeneutica in cui i nostri filosofi sono posti
in una luce per certi versi inedita certamente susciteragrave interrogativi e stimoleragrave
ulteriori approfondimenti nel lettore cosigrave come ha fatto nel pubblico presente alle
lezioni i commenti qui pubblicati infatti rappresentano una parte significativa
dell‟ampio dibattito suscitato dai numerosi ambiti e dai nodi esegetici toccati da
GC
La questione egrave piuttosto articolata e riguarda il portato del parmenidismo nello
sviluppo del pensiero di Platone un parmenidismo perograve recepito attraverso la me-
diazione della rielaborazione della sofistica nello specifico di Protagora e Gorgia
che nella lettura platonica di fatto ne avrebbero proposto un‟abile e sottile distor-
sione Nel tentativo di ristabilire il vero pensiero parmenideo quella che GC defi-
nisce la genuina discendenza dal padre bdquovenerando e terribile‟ Platone avrebbe
addirittura paventato un vero e proprio parricidio sul cui effettivo compimento
ormai si hanno piugrave dubbi che certezze Proprio l‟impossibilitagrave di trovare un vero
fondamento ontologico al falso al non essere se da un lato fa salva la lezione
parmenidea dall‟altro lascia aperta la questione della distinzione del vero politico
il filosofo dal falso politico il sofista posta al termine dell‟omonimo dialogo
Gli assi portanti delle Lezioni Eleatiche di GC che dunque risultano euristica-
mente fecondi sono due il primo riguarda la rielaborazione protagorea e gorgiana
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 17
del parmenidismo come training filosofico formativo di Platone nella quale
l‟ontologia egrave ridotta a logologia e il ι γνο assume il ruolo fondativo della realtagrave
Il secondo asse invece descrive il tentativo di Platone di ristabilire il primato
del piano ontologico su quello logico a causa dell‟impossibilitagrave di fondare ontolo-
gicamente il non essere attraverso la risoluzione del falso nell‟alteritagrave intesa come
diversitagrave della relazione predicativa rispetto a ciograve che pretenderebbe di descrivere
Platone egrave di fatto costretto a riaffermare la centralitagrave del linguaggio e quindi la
prospettiva sofistica specialmente quella gorgiana
Protagora e Gorgia tra Parmenide e Platone
Il cammino dell‟ontologia che parte da Elea per arrivare ad Atene passa da
Abdera e Leontini Queste due tappe di matrice sofistica sono la patria rispetti-
vamente del relativismo di Protagora e della meontologia di Gorgia
Protagora e Gorgia sono due personaggi fondamentali della storia della filo -
sofia occidentale anche se sono entrati a farne parte con modalitagrave differenti l‟Ab-
derita vi egrave stato incluso giagrave dalle dossografie antiche come nel caso di Diog ene
Laerzio percheacute la portata del suo relativismo gli ha garantito una dignitagrave filosofica
giagrave riconosciuta da Platone2 Gorgia invece egrave stata un‟acquisizione piugrave tarda po-
tremmo dire anche post-hegeliana e il sofista deve sostanzialmente la sua definit i-
va inclusione nell‟olimpo filosofico grazie all‟edizione dei frammenti Diels -Kranz
nel Novecento
Oggi non vi sono riserve sul fatto che questi due pensatori rappresentino un
punto di svolta fondamentale della riflessione filosofica occidentale il loro ruolo egrave
pienamente riconosciuto anche se ogni studioso ne pondera differentemente
l‟impatto e il valore GC ha senza dubbio il merito di rimettere la questione a fuo-
co di riprenderla nella sua centralitagrave Primariamente infatti GC inquadra il portato
del parmenidismo in Protagora e in Gorgia andando a vedere nelle teorie dei sofisti
quanto l‟ontologia dell‟Eleate sia stata acquisita e rielaborata Dopo di ciograve proietta
in avanti l‟indagine e mostra come il parmenidismo filtrato dalla sofistica non sia
arrivato indenne nel pensiero platonico ma lo abbia modellato limitato posto in
discussione Nessun‟altra operazione storiografica avrebbe potuto rendere onore a
questi due sofisti piugrave di quella di GC Protagora e Gorgia ne escono filosoficamen-
te riaffermati e si guadagnano un ulteriore spazio nella storia della filosofia e nella
storia dell‟ontologia Questo egrave sicuramente uno dei numerosi meriti dell‟indagine
di GC qui presentata
-------------------------------------------- 2 Su Protagora sofista o filosofo e il punto di vista di Platone cfr N Notomi A Protagonist of the
Sophistic Movement Protagoras in the Historiography in J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Measure Leiden-Boston 2013 pp 11-36
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
18 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Venendo proprio a Protagora e Gorgia si deve dire che egrave concretamente co m-
plesso fornire un quadro delle interpretazioni sul relativismo protagoreo e sulla
meontologia gorgiana ma si puograve senz‟altro proporre un veloce affresco dello status quaestionis dei temi piugrave discussi negli ultimi dibattiti critici
Riguardo alla dottrina maggiore di Protagora l‟homo mensura la bibliografia
egrave vastissima e ultimamente si sta aprendo a nuove interessanti prospettive in dire-
zione epistemologica egrave il caso delle indagini di Ugo Zilioli che attualizza la ver-
sione protagorea alla luce dell‟indeterminismo prospettato dalla fisica contempora-
nea3 o degli studi di Annie Hourcade4 la quale intende ricostruire un contesto
abderita attraverso il legame tra l‟atomismo e la sofistica di Protagora o ancora il
contributo di Mi-Kyoung Lee che inserisce Protagora nel contesto gnoseologico
stabilito successivamente da Platone e Aristotele5 Anche gli altri nuclei delle dot-
trine di Protagora continuano ad attirare eguale attenzione sono molteplici i filoni
di studio che si sono distinti all‟interno della produzione scientifica Vi egrave ad esem-
pio un interesse per il versante politico6 del pensiero di Protagora o anche per le
riflessioni sul mito7 o ancora per il rapporto tra il pensiero di Protagora e il lin-
guaggio e la letteratura ndash come nelle letture di Aldo Brancacci8 e nella recente
monografia di Michele Corradi9 Per uno sguardo policromo e d‟insieme sono
sicuramente orientativi gli atti del convegno tenutos i all‟Universitagrave di Leida nel
2007 su Protagoras of Abdera the Man His Measure10
Come si avragrave modo di leggere nel corso di questo volume per GC il tradizio-
nale relativismo protagoreo viene accompagnato alla fiducia nell‟esperienza Pro-
tagora accoglie l‟identitagrave parmenidea di esserendashpensarendashdire ma tale adesione lo
conduce ad un esito personale mentre Parmenide giunge a postulare una unica
veritagrave Protagora arriva a sostenere tante veritagrave quante quelle che gli uomini poss o-
-------------------------------------------- 3 U Zilioli Protagoras and the Challenge of Relativism Plato‟s Subtlest Enemy Aldershot-
Burlington 2007 4 A Hourcade Atomisme et sophistique La tradition abdeacuteritaine Bruxelles 2009 5 MK Lee Epistemology After Protagoras Responses to Relativism in Plato Aristotle and
Democritus Oxford 2005 6 Cfr A Brancacci La penseacutee politique de Protagoras laquoRevue de Philosophie Ancienneraquo 30
(2012) pp 59-85 7 C Calame The Pragmatics of ldquoMythrdquo in Plato‟s Dialogues The Story of Prometheus in the Pro-
tagoras in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) Plato and Myth Studies on the Use and Status of Platonic Myths Leiden-Boston 2012 pp 127-143 e G van Riel Religion and Morality Elements of Plato‟s Anthropology in the Myth of Prometheus (Protagoras 320Dndash322D) in C Collobert P Destreacutee F J Gonzalez (eds) cit pp 145-164 M Bonazzi Il mito di Prometeo nel Protagora una variazione sul tema delle origini in F Calabi-S Gastaldi (eds) Immagini delle origini La nascita della civiltagrave e della cultura nel pensiero antico Sankt Augustin 2012 pp 41-57
8 Cfr ad es A Brancacci Protagoras l‟orthoepeia et la justesse des noms in A Dixsaut amp A Brancacci (eds) Platon source des Preacutesocratiques Paris 2002 pp 169-190 Id Dialettica e orthoe-peia in Protagora laquoMeacutethexisraquo 23 (2011) pp 53-71
9 M Corradi Protagora tra filologia e filosofia Le testimonianze di Aristotele Pisa-Roma 2012 10 J M van Ophuijsen M van Raalte P Stork (eds) Protagoras of Abdera The Man His Meas-
ure Leiden-Boston 2013
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 19
no elaborare GC si occupa poi della meontologia gorgiana dedicandogli un am-
pio spazio Anche in virtugrave di questa alta considerazione va valutata la forza
dell‟interpretazione di GC che in maniera inedita stabilisce un ruolo per niente
secondario per il sofista siceliota
La meontologia termine coniato in tempi recenti trova in Gorgia il padre na-
turale poicheacute il εξὶ ην κὴ ὄληνο (d‟ora in poi ηκν) egrave il primo grande scritto della
produzione filosofica occidentale dedicato al non essere o al nulla La lettura di
quest‟opera risulta essere uno dei grandi nodi interpretativi con cui si egrave confrontata
la comunitagrave scientifica e il dibattito egrave stato (ed egrave tuttora) ampio giagrave da quando
Guido Calogero11 nel 1932 intese Gorgia come interlocutore significativo dell‟Ele-
atismo Ma nelle tante diramazioni interpretative egrave possibile rintracciare sostan-
zialmente due linee che vanno tenute in considerazione quella che nel ηκν ravv i-
sa un testo dal carattere filosofico serio dunque un vero e proprio trattato di cara t-
tere ontologico e quella che lo vuole uno scritto epidittico sicuramente sign ifi-
cativo per la filosofia ma non un vero e proprio trattato filosofico
Sulla bdquoserietagrave‟ o meno del ηκν si discute ancora abbondantemente e nelle Le-
zioni Eleatiche GC propone l‟idea giagrave presente in altri suoi contributi del pass a-
to12 che l‟opera sia seriamente filosofica Questa prospettiva egrave stata recentemente
condivisa anche da Roberta Ioli13 Sempre sulla natura dell‟opera ha fatto scuola la
posizione di Barbara Cassin14 che ha interpretato il discorso di Gorgia come un
superamento dell‟ontologia di Parmenide in direzione della logologia ossia della
scienza della parola in grado di sorpassare la filosofia mettendone in discussione la
certezza linguistica Va inoltre ricordato l‟indirizzo piugrave tendenzialmente realista di
Giuseppe Mazzara15 che ritiene inviolabile la condizione di un richiamo alla veritagrave
offerta dai ξάγκαηα la veritagrave risulta essere l‟ideale regolativo per la dimensione
del verosimile secondo Mazzara il ηκν non afferma l‟impossibilitagrave di comunica-
re che molti ritengono attestata nel terzo caposaldo dell‟operetta ma solamente la
sua difficoltagrave la sua precarietagrave Gli ultimi decenni hanno conosciuto varie co rrenti
di pensiero nell‟interpretazione di Gorgia e del ηκν e non hanno potuto fare a
meno di discutere del rapporto tra l‟elemento teoretico e l‟aspetto marcatamente
-------------------------------------------- 11 G Calogero Studi sull‟Eleatismo Roma 1932 12 G Casertano L‟ambigua realtagrave del discorso nel perigrave tou me ontos di Gorgia (con un accenno
all‟Elena) laquoPhilosophicaraquo 5 (1995) pp 3-18 Sull‟Elena Id I dadi di Zeus sono sempre truccati Considerazioni sulla parola l‟occhio e le passioni nell‟Elena di Gorgia laquoDiscorsiraquo 2 (1982) pp 7-27 Id L‟amour entre logos et pathos Quelques consideacuterations sur l‟Heacutelegravene de Gorgias in Positions de la sophistique Colloque de Cerisy (7-17 sept 1984) eacutediteacute par B Cassin Paris 1986 pp 211-220
13 R Ioli Gorgia di Leontini Su ciograve che non egrave Testo greco traduzione e note a cura di R Ioli Hil-desheim-Zuumlrich-New York 2010 Id Gorgia Testimonianze e frammenti Introduzione traduzione e commento a cura di Roma 2012
14 Soprattutto in B Cassin Si Parmenide Le traiteacute anonyme De Melisso Xenophane Gorgias Edi-tion critique et commentaire Lille-Paris 1980 e nel suo L‟Effett sophistique Paris 1995
15 Mazzara ha proposto la sua interpretazione oltre che in molteplici articoli in due monografie Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982 e Gorgia la retorica del verosimile Sankt Augustin 1999
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
20 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
retorico del testo su questo egrave ancora fondamentale il contributo di George B Ker-
ferd del 198116 il quale ha infine privilegiato il valore filosofico dell‟opera Vi
sono poi impianti piugrave marcatamente legati all‟ermeneutica reto rico-estetica quali
le letture che definiscono l‟opera come un puro gioco verbale come ha sostenuto
Antonio Capizzi17 eo estetico come hanno sostenuto James I Porter18 e recente-
mente Alessandro Stavru19
Di Gorgia non solo il ηκν ha giocato un ruolo significativo i lettori di queste
lezioni potranno leggere che per GC anche e forse soprattutto l‟Encomio di Elena egrave un‟operetta altamente rilevante per la ricostruzione del pensiero di Gorgia Per
l‟Encomio si puograve contare su un‟abbondante letteratura in quanto l‟operetta ha
suscitato da sempre molto interesse tra i critici forse per il personaggio di Elena
che piugrave del Palamede dell‟Apologia egrave stata una figura fondamentale nella cultura
greca e nella sua produzione letteraria da Omero fino ai tragici La bibliografia
specifica sull‟operetta inizia a fine Ottocento e cresce parallelamente all‟aumento
della critica sulla sofistica che nel Novecento egrave stata oggetto di notevole rivalut a-
zione divenendo cospicua ai nostri giorni La messe di studi dunque non puograve
essere circoscritta con facilitagrave ma si puograve dire che si muove sostanzialmente sulle
linee giagrave tracciate riguardo al ηκν soprattutto in relazione al possibile sostrato
filosofico e alla natura di αίγληνλ gioco o divertissement che dir si voglia che lo
stesso Gorgia pare suggerire forse retoricamente nel finale dell‟operetta Il Pala-mede rimane sempre un po‟ piugrave a margine delle elaborazioni scientifiche ma natu-
ralmente il suo apporto puograve non essere irrilevante per la comprensione del pensie-
ro di Gorgia20
La proposta interpretativa di GC si inserisce dunque nel quadro di un‟ampia
letteratura critica e vale la pena approfondire la sua prospettiva presentata nella
prima parte della trattazione corrispondente alla sua seconda lezione C‟egrave un‟idea
attorno alla quale tutto ruota e cioegrave che Protagora e Gorgia abbiano elaborato una
comprensione profonda del parmenidismo i sofisti hanno sviluppato per GC
un‟idea credibile di come i dati di fatto si traducano in rappresentazioni pensieri
valutazioni e infine parole che al tempo stesso li raffigurano li interpretano e a
volte li tradiscono Per GC i sofisti prendono le mosse da precisi insegnamenti di
Parmenide per approdare a una comprensione matura meditata e anche molto
moderna del modo in cui le cose e i fatti assumono forme sempre nuove attraverso
le parole ciograve senza evitare di dar luogo ogni volta a una comprensione caratteriz-
-------------------------------------------- 16 JB Kerferd The Sophistic Movement Cambridge 1981 17 A Capizzi I sofisti ad Atene L‟uscita retorica dal dilemma tragico Bari 1990 A questa posizio-
ne egrave avvicinabile L Rossetti Gorgia questo sconosciuto in S Giombini Gorgia epidittico Commento filosofico all‟Encomio di Elena all‟Apologia di Palamede all‟Epitaffio Passignano s T 2012 pp 7-13
18 J I Porter The seductions of Gorgias laquoClassical Antiquityraquo 12 (1993) pp 267-299 19 A Stavru Il potere dell‟apparenza Percorso storico-critico nell‟estetica antica Napoli 2011 pp
75-97 20 Ci sia consentito rinviare al lavoro di una delle due curatrici di questo volume S Giombini Gor-
gia epidittico cit
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 21
zata da strutturale ambivalenza GC nella prima parte delle Lezioni Eleatiche rav-
visa nella bdquognoseologia‟ di Protagora e Gorgia un‟acquisizione matura e da non
marginali punti di vista in grado di confrontarsi solidamente con le elaborazioni di
Platone e Aristotele In piugrave il fatto che queste idee prendano forma in pieno V
secolo egrave il sintomo di una maturitagrave e di una modernitagrave peculiare di quel frangente
della speculazione filosofica di cui egrave urgente tornare a prendere coscienza
Il parricidio mancato i fondamenti logico-ontologici del politico
Nella propsettiva di GC pertanto quello condotto da Platone contro il movi-
mento sofistico puograve ben dirsi una sorta di corpo a corpo che ha attraversato tutta la
sua vita dai dialoghi giovanili nei quali voleva distinguere il proprio maestro
Socrate dai presunti maestri che operavano ad Atene e che dietro lauti compensi
insegnavano pseudo-saperi fino ai dialoghi della maturitagrave nei quali il confronto
si sposta sul piano teorico e al relativismo gnoseologico ed etico cerca di contrap-
porre una forma di sapere forte corrispondente a un‟altrettanto forte assiologia
Il dialogo piugrave rappresentativo di questa svolta teoretica egrave sicuramente il Par-menide nel quale Platone sembrerebbe voler rifondare la propria teoria delle idee e
attuare un recupero e una difesa del pensiero di Parmenide abilmente distorto dai
sofisti in particolare da Gorgia Se quest‟opera di recupero e difesa dell‟autentico
magistero parmenideo sia stata effettivamente compiuta da Platone se egli sia stato
un interprete fedele o se invece non abbia compiuto anche lui forzature funzionali
al proprio discorso filosofico egrave questione ancora aperta D‟altronde numerosi sono
i nodi interpretativi che caratterizzano quest‟opera e che fanno del Parmenide laquoil
dialogo piugrave enigmatico e misterioso di Platone e il testo filosofico piugrave complesso e
indecifrabile del pensiero antico [hellip] l‟opera piugrave controversa dell‟intera tradizione
occidentaleraquo21 Infatti nonostante la discordanza tra le diverse interpretazioni
paradossalmente almeno sulla problematicitagrave tutt i gli interpreti sono d‟accordo
Fin dall‟antichitagrave come ci ricorda Proclo nel suo Commento albdquoParmenide‟ si
sono contrapposti due principali orientamenti interpretativi quello logico -
argomentativo ndash che ha visto nel dialogo ora un puro esercizio formale ora una
reductio ad absurdum del metodo zenoniano (Albino) ora un vero e proprio tratta-
to sulle categorie (Alcinoo) ndash e quello ontologico-metafisico sostenuto da Plotino
e da Proclo stesso
Entrambe gli orientamenti sono stati ampiamente ripresi e approfonditi dalla
critica moderna che si egrave spesso divisa anche sulla portata teorica del dialogo d o-
mandosi se ne avesse una vista la conclusione alquanto atipica e improvvisa e se
-------------------------------------------- 21 F Ferrari Platone Parmenide Introduzione traduzione e note a cura di Milano 2004 p 9
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
22 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
l‟aveva quale dovesse essere si egrave infatti pensato che si trattasse di un jeu d‟esprit22
di una parodia laquoironica e giocosaraquo della logica eleatica alla base della dottrina
megarica23 o anche che non fosse una esemplificazione logica ma solo una pale-
stra logico-metodologica finalizzata ad una successiva rielaborazione e fortifica-
zione della teoria delle idee24
Il filone interpretativo di maggior successo egrave stato sicuramente quello logico
anche grazie alla sua riscoperta da parte degli studiosi moderni di orientamento
analitico25 ma non sono mancati i sostenitori della portata ontologico-metafisica a
cominciare dagli antichi platonici che vi videro l‟analisi dell‟essere uno parmen i-
deo su cui si fonda la dottrina delle idee e poi dai neoplatonici che vi trovarono la
fondazione delle loro ipostasi26 Probabilmente l‟interpretazione ontologica moder-
na piugrave famosa egrave quella presentata da Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia
la quale ha esaltato principalmente il portato dialettico del Parmenide come auten-
tico movimento del pensiero che concepisce le idee come unione di contrari come
l‟universale nel quale le particolaritagrave finite della realtagrave empirica vengono supera-
te27 Certamente lo statuto ontologico delle idee egrave uno dei temi centrali del dialogo
e non a caso il suo sottotitolo era Sulle Idee come ricorda Diogene Laerzio titolo
che perograve si addice molto bene alla prima parte ma non alla seconda fatto questo
connesso alla vexata quaestio della mancanza di unitagrave dell‟opera che secondo
alcuni sarebbe formata da due scritti dal contenuto eterogeneo redatti in periodi e
per scopi diversi successivamente cuciti insieme in maniera posticcia mediante
l‟intermezzo metodologico nel quale viene affermata la necessitagrave di sottoporsi
all‟importante gymnasia di analisi delle idee28
-------------------------------------------- 22 AE Taylor Plato The Man and his Work London 1949
6 tr it Platone L‟uomo e l‟opera Firen-
ze 1986 p 548 23 G Calogero Studi sull‟eleatismo Roma 1932 pp 269-311 24 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato laquoAmerican Journal of Philologyraquo 53
(1932) pp 122-38 Una rassegna delle numerose esegesi del Parmenide figura in F Fronterotta Guida alla lettura del bdquoParmenide‟ di Platone Bari 1998 pp 106-122 mentre per una visione d‟insieme dello status quaestionis si veda M BarbantindashF Romano Il bdquoParmenide‟ di Platone e la sua tradizione Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (Catania 31 maggio-2 giugno 2001) Catania 2002
25 G Ryle Plato‟s laquoParmenidesraquo laquoMindraquo 48 (1939) pp 129-51 E Tugendhat Vorlesungen zur Einfuumlhrung in die sprachanalytische Philosophie Frankfurt aM 1976 trit Introduzione alla filosofia analitica Genova 1989 JK Ackrill ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΟΝ laquoBullettin of the Institute of Classical Studiesraquo 2 (1955) pp 31-35 riedito in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology New York 1970 pp 201-209 GEL Owen Plato on not-being in G Vlastos (ed) Plato I Metaphysics and epistemology cit pp 223-67
26 Per una ripresa dell‟interpretazione neoplatonica cfr J Halfwassen Der Aufstieg zum Einen Un-tersuchungen zu Platon und Plotin Stuttgart 1992 e M Migliori Dialettica e veritagrave Commentario storico-filosofico albdquoParmenide‟ di Platone Milano 1990
27 GFW Hegel Vorlesungen uumlber die Geschichte der Philosophie Berlin 1833 tr it Lezioni sulla storia della filosofia a cura di E Codignola-G Sanna Firenze 1932
28 Egrave la tesi sostenuta da G Ryle Plato‟s Progress Cambridge 1966 tr it Per una lettura di Platone Milano 1991
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 23
Proprio la mancanza di unitagrave dell‟opera egrave uno degli argomenti usati dai critici a
favore dell‟interpretazione logico-metodologica a sua volta divisibile in due ulte-
riori schieramenti quello di chi come Cherniss Calogero o Taylor29 ritiene che il
fine del dialogo sia dimostrare la contraddittorietagrave del metodo zenoniano e quello
di chi come Palmer e GC30 vi vede alla maniera di Trasillo e Albino la messa a
punto di un metodo forte per superare le numerose aporie aperte dalle critiche
sviluppate sia all‟interno che all‟esterno dell‟Accademia alla teoria standard delle
idee formulata nei dialoghi centrali (Fedone Repubblica e Simposio)
Platone secondo Palmer vuole riappropriarsi di Parmenide e del suo ηὸ αλ-
ηειὼο ὄλ che gli consente di distinguere la δ μα dalla vera conoscenza ma vuole
soprattutto laquoto recover Parmenides from the sophistic appropriations and under-
standings to which he had been subjectedraquo31 vuole ristabilire quella che GC in
altri termini chiama l‟opposta discendenza che riaffermi la realtagrave come condizione
di veritagrave del discorso32
Se infatti come sostiene Palmer la teoria standard delle idee egrave una forma di
parmenidismo applicato al mondo eidetico egrave naturale che Platone si preoccupi di
confrontarsi con la ricezione sofistica del parmenidismo in particolare con gli
argomenti sviluppati da un acuto interprete come Gorgia che potevano benissimo
essere rivolti contro le idee stesse Gorgia infatti avrebbe sicuramente rifiutato
categoricamente l‟esistenza di tali entitagrave e anche che vi potesse essere la loro co-
noscenza Cosigrave Platone puograve facilmente immaginare che un ipotetico ascoltatore in
imbarazzo avrebbe potuto obiettare laquoche esse [scil le idee] non esistono o che se
proprio esistono egrave assolutamente necessario che siano inconoscibili alla natura
umanaraquo33
Ma mentre per Palmer tale riappropriazione si attua attraverso una discontinui-
tagrave consistente nel superamento della prospettiva monista parmenidea a favore del
pluralismo eidetico per GC invece Platone vuole tracciare una linea di continuitagrave
tra la sua dottrina e quella di Parmenide interpretato come un pluralista sul piano
ontologico ma come un monista sul piano predicativo
Probabilmente nonostante la forte influenza del parmenidismo sulla teoria
standard delle idee Platone non sostenne mai una teoria cosigrave apertamente eleatica
come invece afferma Palmer anche nei dialoghi centrali infatti egrave sempre stata
ammessa una certa pluralitagrave di idee e anche una certa possibilitagrave di stabilire rela-
zioni tra queste Certamente si puograve sostenere con Ferrari che l‟interesse per le rela-
zioni intraeidetiche aumentograve nella maturitagrave tanto da essere il focus di un dialogo
come il Sofista
-------------------------------------------- 29 AF Cherniss Parmenides and the bdquoParmenides‟ of Plato cit G Calogero Studi sull‟eleatismo
cit AE Taylor PlatoThe Man and his Work cit 30 J Palmer Plato‟s Reception of Parmenides Oxford 1999 pp 91 sgg 31 Ibidem 32 Cfr Infra p 48 33 Platone Parmenide 135a3-5 (trad F Ferrari)
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
24 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La parte piugrave originale e convincente di tutta la ricostruzione di GC sta prob a-
bilmente nella contestualizzazione politica dell‟operazione platonica Il secondo
aspetto sul quale infatti gli interpreti antichi e moderni sembrano concordare egrave
l‟assoluta apoliticitagrave di un dialogo come il Parmenide Anche l‟ambientazione al di fuori delle mura cittadine farebbe pensare all‟assoluto disimpegno del dialogo
di argomento eminentemente logico od ontologico34 Quello che GC nelle Lezioni
Eleatiche ha dimostrato in linea con tutto il suo itinerario di ricerca su Platone egrave
che nel filosofo ateniese non c‟egrave nessun aspetto della propria riflessione che non
abbia sempre e comunque una valenza anche politica La logica e l‟ontologia l‟arte
e la pedagogia cosigrave come la psicologia non sono mai d iscipline autonome chiuse
in loro stesse La filosofia di Platone come molte riflessioni filosofiche
dell‟antichitagrave secondo GC si presenta come sistema e in questo caso specifico
eminentemente orientato alla realizzazione di un ampio disegno politico che co n-
senta di realizzare una societagrave giusta nella quale ciascun uomo possa essere felice
Anche un dialogo come il Parmenide enigmatico complicato di rielaborazione
teorica e metodologica cosigrave come il lungo e tortuoso viaggio che ha portato Plat o-
ne da Atene a Elea e ritorno ci insegna GC assolve a questo compito Solo risco-
prendo la genuina discendenza parmen idea saragrave possibile distinguere l‟essere dal
non essere il vero dal falso il bene dal male il giusto dall‟ingiusto il sofista dal
filosofo
Anche il problema della definizione del sofista nell‟omonimo dialogo sembre-
rebbe essere solo un pretesto occas ionale motivato da contigenti ragioni storico-
politiche marginali rispetto alla centralitagrave della questione dei generi sommi discu s-
sa nella seconda parte dell‟opera35 Al contrario proprio le esigenze storico-
politiche fondano la necessitagrave teorica di distinguere l‟opinione e i discorsi falsi da
quelli veri questione rimasta aperta alla fine del Teeteto e ripresa nel Sofista La possibilitagrave di distinguere il vero dal falso viene ricondotta alla δὺλακηο ην
δηαιέγεζζαη che si fonda sulle idee sulla comunanza dei generi sulla partecipa-
zione intraeidetica Platone vuole fare del vero una proprietagrave delle cose piuttosto
che del giudizio su quelle schiacciando il piano logico-linguistico su quello onto-
logico Ma la formulazione non sempre chiara della propria teoria e la mancanza di
un lessico tecnico specifico codificato lasciano all‟interprete moderno numerose
questioni aperte su cui dibattere da quella che riguarda quali idee esistano a quella
relativa alla natura dei generi sommi a quella dei diversi significati di essere (es i-
stenziale predicativo identitario) ammessi piugrave o meno consapevolmente da Plato-
ne GC attraversa l‟ampio spettro dei problemi esegetici e ricostruisce puntualmen-
te le tappe del tentativo compiuto da Platone di ricondurre la contrapposizione
-------------------------------------------- 34 CH Zuckert Plato‟s bdquoParmenides‟ A dramatic Reading laquoThe Review of Metaphysicsraquo 51
(1998) pp 875-906 35 Due dettagliate ricognizioni delle principali questioni esegetiche riguardanti il Sofista si possono
trovare negli ampi studi introduttivi alle rispettive traduzioni italiane di questo dialogo curate da F Fronterotta Milano 2007 e da B Centrone Torino 2008
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 25
etico-politica tra il sofista e il filosofo al piano ontologico registrando il fallimento
del filosofo ateniese Questi non riusciragrave a dimostrare l‟esistenza del non essere
del falso ma ricondurragrave il falso all‟errata relazione stabilita tra entitagrave che nella
realtagrave non sono in relazione oppure al non mettere in relazione ciograve che invece egrave
relato Se in un primo momento il sofista e il filosofo sembravano due figure molto
simili ambedue piuttosto ambigue e di difficile definizione (Soph 216c) ndash dal
momento che hanno ugualmente a che fare con i discorsi che sono immagini che
imitano le idee ndash alla fine del dialogo il sofista saragrave colui che imita senza sapere e
che per questo inganna mentre il filosofo saragrave colui che imita sapendo Ancora una
volta il piano del confronto si consuma al livello logico L‟esito ultimo del viaggio
da Elea ad Atene in altri termini non puograve far altro che ristabilire la centralitagrave del
ι γνο e della dialettica autentici tratti costitutivi della filosofia e unici indicatori
che consentono di distinguere il sapere filosofico dalle altre forme sapere
Le lezioni di Giovanni Casertano La prima lezione
Procedendo ora ad un esame piugrave analitico delle Lezioni Eleatiche di GC ci o c-
cuperemo anzitutto della prima delle tre lezioni quella che si egrave deciso infine di
tenere fuori dal presente volume per ragioni di natura editoriale
In questa prima lezione GC ha ripreso aggiornandola la sua nota interpreta-
zione di Parmenide presentata al vasto pubblico nella monografia Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza36 con la quale aveva cercato di decostruire
l‟immagine di Parmenide laquofilosofo di un bdquoessere trascendente‟raquo che dominava il
panorama storiografico italiano ndash e non solo quello per riportare l‟Eleate laquoall‟
atmosfera culturale del suo temporaquo all‟interno della quale si trovograve per la prima
volta a sollevare laquoi problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri
della ricerca scientificaraquo37
Per GC Parmenide egrave in primo luogo e a tutti gli effet-
ti un θπζη ινγνο pienamente inserito nell‟orizzonte culturale e scientifico del
suo tempo che egrave quello dei primi studiosi greci materialisti i quali distinguevano
chiaramente tra un qualcosa che rimane sempre lo stesso nella propria natura e un
qualcosa che invece cambia pensando conseguentemente che nella realtagrave niente
nascesse e niente si distruggesse Quando Parmenide distingue tra un qualcosa (η
λ) che egrave sempre uguale ed eterno che non nasce e non muore che egrave uno co m-
patto immobile e qualcosa (ηά ληα) che cambia che nasce e muore che diviene
che appare sempre in maniera diversa egli non starebbe facendo un‟operazione
puramente linguistica o grammaticale neacute d‟altronde starebbe tracciando una oppo-
-------------------------------------------- 36 G Casertano Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza Napoli 1989
2 p 8
37 Ibidem Inoltre cfr G Casertano ParmenidesndashScholar of Nature in N-L Cordero (ed) Parmenides Venerable and Awesome (Plato bdquoTheaetetus‟ 183e) Proceedings of the Internation-al Symposium Buenos Aires October 29-November 2 2007 Las Vegas-Zurich-Athens 2011 pp 21-58
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
26 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
sizione tra ragione e sensi o tra metafisica e fisica ma starebbe affermando e di-
mostrando con un nuovo linguaggio e una rigorosa metodologia quella che era
una concezione comune Secondo GC questa concezione di una sola realtagrave che
per essere compresa deve essere studiata e pensata da due punti di vista quello
della totalitagrave e dell‟unicitagrave e quello della particolaritagrave e della molteplicitagrave egrave chia-
ramente espressa da Parmenide negli ultimi versi del fr 1 e nei frammenti 8 e 9
DK L‟orizzonte comune egrave quello della ricerca cosmologica che per GC egrave anche
ricerca gnoseologica nella quale emerge quella dialettica eternotempo che si
configura anche come rapporto tuttoparti che saragrave comune a tutti i cosiddetti pre-
socratici successivi i quali cercheranno di conciliare la generazione il mutamento
e la corruzione con l‟idea dell‟immutabilitagrave dell‟universo
GC quindi esclude categoricamente che Parmenide rappresenti una frattura tra
il bdquonaturalismo‟ dei primi filosofiscienziati ionici e pitagorici e un presunto pensie-
ro metafisico che con lui avrebbe avuto inizio Commentatori antichi come Giam-
blico e Simplicio e anche lo stesso Aristotele bencheacute responsabile di un‟immagine
distorta di alcuni aspetti della filosofia dell‟Eleate non hanno dubbi sul fatto che
Parmenide fosse uno studioso della natura Il Parmenide filosofo dell‟essere pen-
satore metafisico bdquopadre della metafisica occidentale‟ egrave in effetti solo un‟inter-
pretazione moderna e contemporanea di cui sono responsabili soprattutto Hegel e
Heidegger
La novitagrave importante della riflessione parmenidea consiste allora nella bdquodimo-
strazione logica‟ dei ζήκαηα che caratterizzano la realtagrave intesa come tutto quel ηὸ
λ che egrave detto ingenerato e indistruttibile (DK 28B83) compatto immutabile e
perfetto cioegrave senza un fine a cui tendere (DK 28B84) omogeneo uno continuo
(DK 28B85-6) Se la realtagrave come tutto egrave questa essa non si puograve accrescere da
nulla percheacute per definizione comprende il tutto (DK 28B86-9) neacute c‟egrave stato un
momento temporale in cui abbia cominciato ad esistere (DK 28B89-10) percheacute
non esiste una bdquonon realtagrave‟ dalla quale possa provenire bdquoun‟altra realtagrave‟ (DK
28B812-13) I concetti di nascita e morte sono incomprensibili se applicati al tutto
l‟essere del tutto non consente un momento in cui non era neacute un momento in cui
saragrave (DK 28B810 e 19-20) cioegrave non egrave misurabile temporalmente E neppure egrave
divisibile percheacute egrave sempre uguale immutabile e immobile senza principio neacute fine
identico a se stesso non mancante di nulla (DK 28B822-33)
Ma come preannunciato dalla Dea nel Proemio dell‟opera il giovane θν ξνο non impareragrave solamente il laquocuore della veritagraveraquo ovvero la natura intesa come tutto
ma anche laquole opinioni degli uomini nelle quali non egrave vera certezzaraquo ovvero la
natura intesa come molteplicitagrave dei fenomeni che costituiscono il tutto Nella de-
scrizione del mondo fenomenico operano due laquoformeraquo o elementi fuoco e notte
(DK 28B856-59) o luce e notte (DK 28B91) che entrano nella composizione di
tutte le cose determinandone le caratteristiche qualitative a seconda del diverso
equilibrio che si instaura tra di loro (DK 28B9) Equilibri che si costituiscono e si
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 27
disfanno che determinano le nascite e le morti spiegando il mondo del divenire
Questa dottrina parmenidea non egrave solamente un‟affermazione di principio espres-
sione della propria teoria cosmogonica e cosmologica ma egrave anche un‟affermazione
polemica nei confronti di quella cultura pitagorica che ampiamente presente
nell‟ambiente magno greco ai tempi di Parmenide e anche dopo considerava le
due serie di contrari secondo uno schema positivonegativo benemale che per lui
doveva essere proprio inconcepibile L‟originalitagrave di Parmenide sta proprio in
questa sua affermazione dell‟assoluta equipollenza e inseparabilitagrave dei contrari
non pensati come positivo e negativo in aperta polemica sia contro i Pitagorici sia
contro la visione tradizionale esiodea
Quindi la seconda parte del poema al di lagrave di questa componente polemica s e-
condo GC non deve essere vista come un elenco delle opinioni errate degli uomini
ma come autentica dottrina parmenidea
Nella sua prima lezione egli si soffermava ampiamente sulla ricostruzione del
complesso sistema cosmologico parmenideo che pure presenta numerosi nodi
ermeneutici riuscendo attraverso un sottile intreccio di frammenti e testimonianze
a restituire l‟ampiezza dell‟orizzonte scientifico trattato
I due aspetti assolutamente nuovi in Parmenide sono quindi la dimostrazione
logica e formale dei caratteri del tutto e del molteplice e la chiara teorizzazione del
metodo della laquovia di ricercaraquo (DK 28B2) attraverso la quale si puograve giungere a due
ordini di affermazioni quelle vere e quelle verosimili Proprio questo secondo
aspetto conduce all‟affermazione dell‟identitagrave tra pensare ed essere nel senso che
ogni volta che si pensa s i pensa qualcosa che egrave cioegrave che esiste mentre non si puograve
pensare qualcosa che non egrave cioegrave che non esiste Per GC questo significa non so l-
tanto che il pensare egrave inseparabilmente connesso col pensato per l‟evidente ragio-
ne che non puograve darsi pensiero che non sia pensiero di qualcosa ma anche che il
pensiero si radica nell‟essere nel senso che non egrave concepibile un pensiero che non
sia pensiero della realtagrave oppure ma egrave lo stesso che egrave sempre una realtagrave che si
esprime nel pensiero
Questa potente prospettiva lega inoltre la veritagrave all‟essere pensare e dire
l‟essere egrave evidentemente pensare e dire la veritagrave Non di meno un discorso su ciograve
che non egrave e quindi un discorso non vero puograve comunque essere fatto si puograve pensa-
re e dire anche il falso come fanno i δίθξαλνη di DK 28B6 5 che confondendo
metodi e piani attribuiscono a ηὸ λ nascere e morire (DK 28B821 e 40) essere e
non essere (DK 28B68) cambiamento di stato di forma e di colore (DK
28B8 41) tutti ζήκαηα che non appartengono a ηὸ λ ma al mondo dei ηὰ ληα
Anche nella monolitica ottica parmenidea secondo GC c‟egrave dunque spazio per
l‟errore ben prima che le smaliziate analisi di Gorgia mettessero in discussione le
due equazioni esserevero e non esserefalso
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
28 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
La seconda lezione
Passiamo ora alle due lezioni concepite come struttura portante di questo vo-
lume In quella che era stata la sua seconda lezione GC analizza il bdquocrinale sofisti-
co‟ del pensiero parmenideo soffermandosi sulle figure di Protagora e Gorgia e
collocando la lettura platonica del magistero parmenideo in una prospettiva di
continuitagrave e innovazione e non di rottura rispetto ai due sofisti i quali negando
l‟equivalenza parmenidea di essere pensare e dire affermerebbero una filosofia
della relativitagrave in ambito conoscitivo etico e politico
Per Protagora come egrave noto la veritagrave non egrave qualcosa di rivelato da sapienti o
profeti e non egrave neppure nella tradizione ma egrave bdquomisura‟ cioegrave rapporto dialettico
che di volta in volta ogni uomo mediante l‟esperienza sensibile instaura con la
realtagrave Tale esperienza viene a essere sempre vera in quanto la realtagrave egrave qualcosa di
dato che l‟uomo non crea ma semplicemente trova e coglie Proprio in virtugrave di
questo rapporto soggettivo non esiste solamente un discorso vero ma tutti i discor-
si sono veri La conoscenza relativa di ogni singolo individuo coglieragrave sempre
solamente una parte un aspetto della realtagrave oggettiva e ognuno diragrave sempre la sua
veritagrave ciograve che egrave vero per lui in quel determinato momento in quella precisa disp o-
sizione e condizione Di conseguenza non ci saranno discorsi falsi
Per GC dunque Protagora accetterebbe il principio parmenideo del rapporto
diretto tra essere pensare e dire ma ne contesterebbe le conseguenze mentre per
Parmenide infatti esiste un solo discorso vero per Protagora tutti i discorsi sono
veri e di conseguenza come affermeranno poi Platone e Aristotele contempo ra-
neamente anche falsi
L‟obiettivo di Platone saragrave proprio quello di sottrarre la veritagrave a questa dimen-
sione soggettiva personale (quindi in ultima analisi aleatoria) e di fondare una
prospettiva oggettivistica in base alla quale la veritagrave abbia una dimensione pubbli-
ca e non privata Per questo motivo cercheragrave di riaffermare la prospettiva parmen i-
dea ristabilendo l‟opposta e genuina discendenza dall‟Eleate ponendo la realtagrave
come condizione della veritagrave del discorso Della lunga lotta che Platone conduce
contro Protagora GC analizza in particolare due passi uno del Teeteto e uno del Cratilo nei quali Platone spesso in difficoltagrave a portare avanti la propria argomen-
tazione non riesce a demolire la prospettiva logico-epistemologica del sofista di
Abdera e lascia integro il criterio dell‟homo mensura
Il tema della potenza performativa del ι γνο egrave invece al centro della riflessione
di Gorgia il quale non sarebbe solamente un abile retore e uno straordinario mae-
stro della parola in grado di stupire e stordire il proprio pubblico mediante artifici
verbali introdotti a sostegno delle tesi piugrave assurde o paradossali ma sarebbe un
vero filosofo che avrebbe affrontato il complesso rapporto tra epistemologia ed
etica indagando le giustificazioni logiche soggiacenti ai comportamenti pratici
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 29
Se con Protagora per dirla con una famosa espressione coniata da Guido Ca-
logero38 la coalescenza di essere pensare e dire egrave ancora valida nel ηκν di Go r-
gia verragrave messa in discussione mediante il ribaltamento del presupposto fond a-
mentale per la costruzione del discorso conoscitivo sulla realtagrave stabilito da Parme-
nide solamente ciograve che egrave puograve essere espresso e conosciuto (DK 28B27-8) dal
momento che essere e pensare sono la stessa cosa (DK 28B3) mentre ciograve che non egrave
non puograve essere neacute pensato neacute espresso (DK 28B87-9) Per Gorgia il livello della
realtagrave e il livello del discorso sulla realtagrave non sono paritetici ma sono su due piani
ben distinti egrave il linguaggio a stabilire il rapporto tra pensiero e realtagrave ed egrave solo
attraverso il pensare che l‟essere acquista realtagrave per l‟uomo Le parole infatti non
sono mai neutre ma esprimono sempre una riorganizzazione logica del reale ope-
rata dal soggetto senza avere la possibilitagrave di affermare che tale logica del discorso
coincida con quella della realtagrave
In questo modo il Leontino viene ad aprire una frattura profonda tra essere e
pensare non tanto nel senso che tra i due non ci sia alcun rapporto quanto nel
senso che tale rapporto necessita di una attenta e approfondita riflessione critica
Infatti se egrave del tutto evidente che le cose pensate non necessariamente esistono tout court egrave altrettanto evidente che l‟uomo non ha alcun potere sulla realtagrave esterna in
quanto non dipende da lui ma ha potere solo sul discorso che ha dentro di seacute che
crea e di cui puograve stabilire le regole di funzionamento Nella lettura di GC con Go r-
gia emergerebbe dunque l‟enorme problematicitagrave della formalizzazione logica
della realtagrave empirica che ha come esito ultimo l‟impensabilitagrave e inafferrabilitagrave del
reale questione a cui si dedicheranno sia Platone che Aristotele con esiti del tutto
opposti
Per l‟appunto nel terzo θεθάιαηνλ del ηκν per dimostrare l‟incomunicabilitagrave con un altro uomo viene oppositamente sollevata la questione del rapporto tra
referente e significato il discorso sebbene sia ciograve che dagrave significato non egrave il sign i-
ficato di se stesso Il s ignificato delle parole egrave nella realtagrave esterna senza la quale i
discorsi sarebbero solamente un vuoto succedersi di parole La costruzione della
realtagrave esterna mediante l‟attribuzione di significati che valgono per l‟uomo con-
sente a quest‟ultimo di prendere coscienza del proprio agire e patire Per GC Gor-
gia verrebbe di fatto a sostenere una concezione comportamentista del significato
il quale non solo rappresenta la realtagrave ma determina l‟atteggiamento di ogni ind i-
viduo di fronte ad essa Anche l‟Encomio di Elena viene inquadrato in questa pro-
spettiva come completamento del ηκν il ι γνο la parola strutturata consente
infatti di costruire non solo modelli di vita sociale ma di fatto strutturando
l‟esperienza del singolo ne determina i comportament i In questa prospettiva viene
a collocarsi anche la particolarissima nozione di veritagrave sviluppata da Gorgia come
ornamento del discorso ovvero decoro che deriva dall‟ordinata disposizione delle
parole Qualcosa di interno al discorso stesso dipendente dalla strutturazione logi-
-------------------------------------------- 38 G Calogero Storia della logica antica Bari 1967 ristampa Pisa 2012
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
30 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
ca che esprime un rapporto con il reale che afferma correttamente ciograve che si deve
dire e confutando il contrario Il servirsi di un particolare metodo logico consente
al Leontino di svelare la veritagrave di un fatto interpretandolo ricostruendone la genesi
esplicitando il senso profondo di ciograve che tutti giagrave sanno come semplice opinione
Anche in Gorgia dunque come in Platone c‟egrave un distinzione tra opinione e
veritagrave quest‟ultima perograve non egrave qualcosa di assoluto ma di probabile di intima-
mente legato a un discorso che si costruisce in un preciso momento e in un dete r-
minato contesto Il ι γνο con la sua veritagrave agisce sull‟anima e determina il compo r-
tamento dell‟uomo attraverso la convinzione e l‟inganno Tutti i discorsi infatti
specialmente quelli poetici creano un artificio che ingannando produce affezioni
particolari Proprio quest‟effetto di fascinazione e di inganno questo aspetto psica-
gogico saragrave aspramente condannato da Platone ma non egrave vero che il discorso per
Gorgia mira solo ad ingannare a giocare con l‟animo dell‟ascoltatore indipenden-
temente dalla veritagrave Secondo GC egrave Platone ad appiattire in senso negativo la pro-
spettiva gorgiana che invece egrave da ritenersi piugrave ricca e articolata Per il retore di
Leontini infatti egrave necessario distinguere l‟inganno dal plagio il primo egrave la modifica
del modo di sentire e di pensare per effetto del ι γνο vero il secondo invece egrave
l‟effetto prodotto dal discorso falso costruito con la tecnica sofistica nel senso
negativo stigmatizzato da Platone Gorgia egrave interessato alla ricerca sulle cause
dell‟agire umano e pertanto non puograve accettare i limiti metodologici e dottrinali
della dottrina parmenidea mentre i risvolti etico-politici del controllo del discorso
non sembrano attirare il suo interesse ma al contrario rappresenteranno il focus
della riflessione platonica
La terza lezione
Veniamo ora alla seconda parte del testo di GC che corrisponde alla sua terza
lezione
L‟esigenza di bdquocostruire‟ una conoscenza reale del mondo e un modello polit i-
co fondato sul sapere in grado di armonizzare le inevitabili diversitagrave t ra gli uomini
spinge Platone a fondare il discorso vero mediante il riscontro ontologico Questa
ricerca ha il suo snodo piugrave importante in due dialoghi il Parmenide e il Sofista e
in particolare in alcune pagine ritenute da GC indicative del contributo della rifles-
sione sofistica sullo sviluppo della dottrina delle idee molto piugrave ampio e profondo
di quanto la storiografia finora non abbia messo in luce
Nel confronto iniziale tra Socrate e Zenone (prima parte del Parmenide) GC
non si sofferma tanto sulle note questioni di quante siano effettivamente le ipotesi
quali siano storicamente attribuibili a Parmenide quali a Zenone e quali ai suoi
avversari ma si limita a notare che le tesi dei due Eleati sono presentate da Platone
in maniera estremamente compatta e coerente Per Platone la tesi parmenidea
dell‟unitagrave e quella zenoniana della non molteplicitagrave di fatto sono coincidenti Tutta
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 31
l‟analisi delle diverse ipotesi serve a Platone per presentare il suo nuovo metodo
εξὶ θηινζνθίαο che a differenza di quello zenoniano che indagava il mondo
fisico delle esperienze sensibili applica l‟indagine dialettica a ciograve che si coglie
mediante il ι γνο cioegrave gli ε δε L‟uso che Platone fa delle tesi eleatiche non solo egrave
formalmente coerente ma anche storicamente preciso Secondo GC il monismo
cosmologico ha senso in quanto speculare al monismo conoscitivo come esiste
un solo cosmo allo stesso modo esiste una sola veritagrave Questo egrave l‟aspetto dell‟
eleatismo che Platone egrave interessato a recuperare anche per riscrivere meglio la
propria dottrina delle idee Se infatti da una lato viene riaffermata l‟equazione
parmenidea veritagrave = realtagrave dall‟altro egrave necessario porre una esistenza e una bdquonon
esistenza‟ proprie del piano linguistico che non coincidono immediatamente con
quello ontologico I limiti dei potenti legami che imponevano a Parmenide di non
porre il non essere vengono allora ampiamente superati mediante l‟affermazione
della possibilitagrave che sia anche qualcosa che non egrave Essere e non essere divengono
in questo modo gli indicatori di una duplicitagrave di piani ben distinti ma che si ri-
chiamano reciprocamente Di essere e non essere si possono infatti distinguere due
sensi un senso semplice o assoluto che rimanda al piano dell‟esistenza e un senso
relativo che rimanda all‟orizzonte linguistico Egrave questo orizzonte che come voleva
Protagora stabilisce l‟esistere o il non esistere delle cose che traduce la realtagrave in
termini significativi come voleva Gorgia L‟apporto piugrave s ignificativo del Parme-nide egrave dunque la centralitagrave attribuita al discorso come l‟unico orizzonte possibile per l‟uomo di guardare alle cose un orizzonte relativo proprio come quello soste-
nuto dalla sofistica che obbliga Platone a ristabilire le distanze a ricercare una
veritagrave quanto piugrave oggettiva e reale possibile Cosa che tenteragrave di fare proprio nel
Sofista Il dialogo si apre con la questione della distinzione di tre nomi e quindi di
tre generi il sofista il politico e il filosofo Dietro a ogni nome infatti si trova un
discorso che ne esplicita il piano dell‟essere il senso che perograve spesso non egrave lo
stesso per tutti gli uomini ognuno infatti in base alle proprie esperienze usa il
linguaggio in maniera personale dando luogo a una molteplicitagrave d i significati per
questo egrave necessario costruire un accordo sui significati mediante i discorsi (δηὰ
ι γνλ) Il metodo usato egrave quello diairetico aggiornamento platonico mediante la
ricerca in comune della lezione parmenidea che ha come primo fondamentale
momento la confutazione la quale consente di liberare l‟uomo dalla peggiore delle
malattie quella di credere di sapere qualcosa senza saperla Il sofista viene cosigrave a
essere smascherato come colui che senza scienza costruisce illusioni copie di
apparenza θαληάζκαηα facendo essere ciograve che non egrave
A Platone non rimane allora che costruire una gnoseologia che non si limiti a
fondare una veritagrave oggettiva ma che dia realtagrave anche alla falsitagrave per confutare defi-
nitiamente Gorgia per il quale veritagrave e falsitagrave abitano solamente il piano del di-
scorso Non rimane allora che violare il diktat imposto da Parmenide torturare il
suo scritto per svelarne il significato piugrave intimo e trovare una realtagrave anche per ciograve
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
32 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
che non egrave Platone quindi non puograve fare a meno di distinguere due sensi dell‟essere
uno piugrave debole linguistico predicativo e uno piugrave forte ontologico proprio quando
al contrario voleva ristabilire l‟unitagrave logico-ontologica affermata da Parmenide Il
non essere l‟esistenza del falso infatti viene ricondotta al diverso ossia alla predi-
cazione di qualcosa che non egrave il discorso non egrave solamente l‟unione di un nome e di
un verbo ma egrave stabilire una relazione tra due termini con la pretesa di dire qualco-
sa di piugrave sulla realtagrave di interpretarla Questo dire qualcosa di piugrave egrave un vero e pro-
prio salto qualitativo che fonda il vero e il falso Veritagrave egrave stabilire una relazione
esistente tra cose che esistono mentre la falsitagrave consiste nello stabilire tra queste
stesse cose una relazione inesistente La realtagrave del falso esiste quindi solamente
come impossibilitagrave di una relazione tra oggetti reali relazione che riguarda perograve
solamente il piano logico non quello ontologico La frattura tra essere e dire opera-
ta da Gorgia che Platone voleva ricucire alla fine del dialogo rimane il sofista egrave
l‟imitatore che inganna mentre il filosofo egrave l‟imitatore che sa Entrambi rappresen-
tano la massima espressione della capacitagrave costitutiva dell‟uomo di costruire d i-
scorsi e dietro a quella che sembra una semplice contrapposizione logica in realtagrave
si nasconde tutta la condanna etico-politica che Platone vuole affermare
Il dibattito
Le lezioni di GC hanno avuto il merito di creare un ampio quadro concettuale
che si egrave mosso attraverso tre grandi momenti della filosofia antica Parmenide la
sofistica di Protagora e Gorgia Platone L‟ampiezza e al contempo la consistenza
delle Lezioni Eleatiche del 2011 hanno posto naturalmente molti interrogativi e
grande desiderio di approfondire e confrontarsi ulteriormente Non egrave un caso allo-
ra che questo volume di atti di Eleatica sia particolarmente ricco proprio nella
sezione dedicata al dibattito Gli interventi registrati sono stati proposti nel volu-
me in ordine alfabetico mentre le risposte di GC sono state organizzate dallo
stesso studioso secondo i temi affrontati dai commentatori e tenendo conto
dell‟ordine delle lezioni
Nel dibattito sulla natura del poema parmenideo e sul senso del messaggio fi-
losofico di Parmenide Neacutestor Cordero ha dato un significativo contributo persona-
le tanto da segnare la storia delle interpretazioni in maniera sostanziale In occa-
sione di queste Lezioni Eleatiche Cordero pone a GC delle riflessioni puntuali a
partire da una questione lessicale nel testo di Parmenide appare per la prima volta
il lessema ηὸ λ una forma singolare identificante l‟opera parmenidea rispetto a
quella dei fisiologi con ciograve Parmenide avrebbe rimarcato la propria volontagrave di non
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 33
identificarsi con questi ma di proporsi come un pensatore innovativo GC h a soste-
nuto in maniera ambivalente secondo Cordero che Parmenide egrave sia un fisiologo
sia il filosofo dell‟essere questi due aspetti appaiono inconciliabili Egli poi nota
che GC ha sorvolato su due termini fondamentali le opinioni e i bdquomortali‟ Quanto
alla δ μα Cordero invita a non minimizzare questo termine che egrave uno dei cardini dell‟intero poema parmenideo e che non puograve essere riferito solo ai fenomeni ma
anche ai bdquomortali‟ che sono gli autori delle δ μαη Secondo Cordero GC scambia
le opinioni dei mortali con le opinioni di Parmenide stesso operando di fatto una
platonizzazione del suo pensiero Egli trova difficile conciliare il Parmenide pres o-
cratico presupposto da GC con quello platonizzante che ne deriva e sollecita GC a
non leggere i frr 1-19 DK come se fossero un testo unico sono frammenti e dun-
que possono essere collegati pur sempre senza prescindere da questa loro natura
Lo stato frammentario del poema impedisce una lettura della fisica di Parmenide
(che in ogni caso non corrisponde alle opinioni dei mortali) e secondo Cordero il
tentativo di comprendere Parmenide attraverso la dossografia non solo egrave improdu t-
tivo ma egrave anche fuorviante egrave piugrave proficuo affidarsi al solo Parmenide
GC risponde a Cordero riconoscendo l‟idea che i frammenti parmenidei sono
di difficile lettura (lo erano giagrave per Platone) ma egli si dichiara comunque ottimista
nel senso che a suo parere egrave pur sempre possibile costruire sulla loro base una
dottrina parmenidea Inoltre ribadisce la sua tesi di un Parmenide p resocratico che
usa il termine λ nel senso di θύζηο l‟indagine dell‟Eleate egrave sulla stessa linea di
ricerca di coloro che l‟hanno preceduto e anche di alcuni che seguirono Quanto
all‟opinione anche qui la difformitagrave interpretativa gioca un ruolo predominante tra
i due studiosi e Casertano difende l‟idea che il termine δ μα non sia di per seacute svalu-
tativo ma indichi piuttosto l‟indagine scientifica che non ha lo stesso grado di
veritagrave della riflessione metodologico-cosmologica sull‟ λ
Maria Carmen De Vita si sofferma sulla deriva sofistica del parmenidismo
ovvero sul ruolo che la riflessione gorgiana ha avuto nella speculazione platonica e
concorda con GC nell‟assegnare al terzo caposaldo del ηκν un ruolo centrale
nell‟interpretazione del pensiero del Leontino Infatti proprio qui si consuma la
rottura della stretta trinitagrave essere-pensare-dire Gorgia si mostrerebbe un filosofo
sopraffino la cui speculazione avrebbe un esito pratico-persuasivo scoprendo
l‟ineluttabile autoreferenzialitagrave del ι γνο Gorgia lega strettamente la δ μα e il ι γνο eliminando la veritagrave da ogni possibile trasmissione e facendo del ι γνο uno
strumento ostensivo in grado di creare interpretazioni senza comunicare la veritagrave
Sottolineando tale portata del pensiero del sofista De Vita nota come Platone as-
sorba l‟ereditagrave gorgiana pur muovendosi sempre nell‟orizzonte del parmenidismo
Riferendosi al Sofista e al Cratilo che sono visti in continuitagrave e complementarietagrave
contenutistica la studiosa individua in quest‟ultimo dialogo un passo dal carattere
significativamente gorgiano Crat 430a7-8 in cui Socrate distingue tra il nome e
l‟oggetto identificato con il nome La portata gorgiana dell‟affermazione socratica
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
34 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
nel contesto del dialogo viene letta da De Vita in precipua connessione con il terzo
caposaldo del ηκν la studiosa puograve cosigrave concludere che la riflessione del Cratilo
mostra il tentativo platonico di fare una sintesi tra la posizione parmenidea e quella
gorgiana Nella sua risposta GC dichiara apprezzamento per l‟indag ine di De Vita
ribadendo efficacemente quanto il Cratilo sia un dialogo utile per poter compren-
dere la posizione platonica l‟ὄλνκα egrave in relazione con la realtagrave e ha il compito di
mostrare l‟essenza delle cose Dunque il linguaggio da solo non puograve garan tire la
conoscenza poicheacute essa prende sempre avvio dalla realtagrave
Sergio Di Girolamo invita GC ad ampliare e approfondire l‟interpretazione
presentata nelle lezioni in relazione a due aspetti Il primo riguarda l‟assoluta
coerenza con cui Platone presenta il nucleo centrale delle tesi parmenideo-eleatiche
nella prima parte del Parmenide nel Teeteto e nel Sofista nei termini di un
sostanziale monismo Il secondo aspetto riguarda l‟interpretazione di tale monismo
non in senso numerico ma nel senso indicato da GC di una unitagrave del cosmo inteso
come totalitagrave unica che racchiude una pluralitagrave di enti fisici Secondo Di Girolamo
tale interpretazione troverebbe una conferma anche nei passi del Timeo 31a4-5 e
33b4-6 nei quali sarebbe possibile rintracciare addirittura un riecheggiamento dei
versi 42-44 di DK 28B8 Egli inoltre solleva la questione della possibile matrice
parmenidea di Repubblica V 476e7-480a13 e di 477a2-4 pagine in cui ciograve che
esiste completamente e ciograve che non egrave assolutamente trovano corrispond enza
epistemica nella totale conoscibilitagrave e nella totale inconoscibilitagrave Di Girolamo
chiede se l‟introduzione di un terzo livello ontologico ed epistemologico la δ μα
intermedio tra essereconoscenza e non essereignoranza debba ritenersi genuina e
originale tesi platonica o se invece non fosse giagrave presente in Parmenide Da ultimo
chiede poi a GC se egli riscontri qualche fattore di continuitagrave tra il carattere
cosmologico della ζεζηο di Parmenide nella prima parte dell‟omonimo dialogo
che riguarda le cose visibili e la gymnasia che invece riguarda gli ε δε GC ritiene che la questione sollevata da Di Girolamo ndash circa la difficoltagrave di conciliare
l‟interpretazione dell‟ λ parmenideo in senso fisico come cosmo con la
gymnasia del Parmenide che invece riguarda le idee ndash rappresenti un ulteriore
prova del rapporto dialettico tra Platone e Parmenide rapporto mediato dal
magistero della sofistica Oltre ai passi del Timeo citati da Di Girolamo ricorda
anche le pagine 27d-29d dello stesso dialogo nelle quali emergerebbe la ricezione
platonica della lezione di metodo di Parmenide Definisce invece molto importante
e intrigante la questione sollevata relativamente alle pagine finali del V libro della
Repubblica Proprio la difficoltagrave di trovare un corrispettivo della δ μα sul piano
ontologico gli fa credere che dietro a queste pagine ci sia stata la discussione
parmenidea sull‟essere e sul non essere con tutto il carico di problemi che tale
discussione comportava Le polaritagrave delineate da Platone ris pecchiano certamente
l‟impostazione eleatica tuttavia mentre nel Menone a 97a e sgg opinione e
conoscenza hanno ambedue lo stesso oggetto ma si collocano su livelli diversi di
chiarezza e di certezza nelle pagine della Repubblica esaminate rimane la
difficoltagrave a individuare sia l‟oggetto dell‟ignoranza sia l‟oggetto dell‟opinione e a
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 35
codificare chiaramente la netta differenza tra conoscenza e opinione sulla base del
loro oggetto
Franco Ferrari riconosce a GC il merito di aver prodotto un‟interpretazione di
Parmenide coerente e per molti versi condivisibile soprattutto nel richiamo alla
necessitagrave di rileggere il poema parmenideo alla luce della riflessione fisico -
cosmologica presocratica e nel soffermarsi sulla centralitagrave del motivo metodo-
logico ed epistemologico del poema Ferrari si concentra sul Parmenide e conviene
con GC nel ritenere che per Platone Parmenide egrave un maestro di metodo il metodo
della logica iper-deduttiva che sorregge la struttura dell‟intero poema parmenideo
La riflessione di Ferrari converge sul personaggio Parmenide dell‟omonimo dialo-
go platonico a suo avviso Platone usa in maniera ironica il personaggio e non gli
affida alcun ruolo strategico Infatti il Parmenide che viene presentato da Platone
assume un punto di vista riduzionista ciograve si evince dal fatto che durante il dialogo
con Socrate Parmenide da un lato ammette due tipi di enti le entitagrave spazio -
temporali e le idee dall‟altro non riduce le idee ad avere gli stessi caratteri logici e
ontologici degli individui empirici GC sottolinea Ferrari anche se non interpreta
il Parmenide del dialogo come il bdquocampione della dialettica‟ non ne offre comun-
que una giusta valutazione e lo sovrastima su questo lo studioso chiede un chiari-
mento Inoltre Ferrari si sofferma sulla determinazione del significato dell‟essere
parmenideo per GC avrebbe un valore esistenziale mentre egli propende per il
significato predicativo-copulativo A tal fine Ferrari rilegge il Parmenide platoni-
co a partire da 160b5 e per le tre pagine successive sottolineando come l‟esistenza
appaia in questi passaggi del tutto accessoria Anche su questo lo studioso chiede
un approfondimento di GC La risposta di GC egrave articolata anche in virtugrave del fatto
che pur involontariamente Ferrari egrave stato un importante interlocutore che lo ha
stimolato a un cambiamento di prospettiva circa il rapporto Parmenide-Platone
Del contributo di Ferrari GC non puograve condividere un aspetto il fatto che Parmen i-
de nella γπκλαζία tratti gli oggetti come entitagrave fisico-temporali Anche sul senso
dell‟essere se esistenziale o predicativo GC ribadisce che i due sensi possono
intrecciarsi e interagire sebbene il senso esistenziale sia precedente a quello pred i-
cativo Su questo ultimo punto GC insiste sostenendo che non egrave possibile separare
la pura esistenza dall‟esistenza determinata cosigrave com‟egrave
Francesco Fronterotta si occupa di analizzare la natura del diverso nel Sofista
platonico argomento cui GC ha dedicato una efficace analisi nel corso della III
lezione Il diverso egrave analogo alla scienza la scienza egrave una ma costituita da molte-
plici parti analogamente il diverso egrave uno ma si manifesta in molti modi tanti quan-
ti sono i generi (di cui egrave diverso) Il non essere emerge nella definizione di diverso
ma esso non egrave contrarietagrave egrave solo diversitagrave Queste ben note argomentazioni plat o-
niche creano un problema per cosigrave dire nella struttura speculativo-argomentativa
di GC Infatti GC si pone la questione se la definizione di diverso non vada a so-
vraffollare l‟Iperuranio con idee ulteriori questo per Fronterotta non rappresenta
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
36 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
un problema ed egli abbraccia la bdquoprospettiva onniestensiva‟ che emergerebbe pro-
prio dall‟opera platonica Un problema di rilievo invece per Fronterotta egrave il fatto
che il diverso appaia come un elemento bdquotransgenerico‟ ossia costituito trasversa l-
mente da elementi di genere differente (non bello non giusto e cosigrave via) che si
presentano in quanto autonomi e distinti Dunque qual egrave la natura del diverso Da
un lato esso non significa nulla se non c‟egrave rimando al genere di cui egrave diverso
dall‟altro se si fonda su di seacute esso in quanto identitagrave di seacute saragrave il diverso del d i-
verso e ciograve egrave una contraddizione Per non incedere in tale contraddizione ha senso
per Fronterotta re-immettere il diverso nell‟essere quest‟ultimo lo ricomprende-
rebbe e lo riassorbirebbe Dunque la definizione di diverso ha portato a una rifles-
sione sulla natura dell‟essere inteso come stato originario di essere-diverso che
potrebbe rappresentare un antecedente della plurivocitagrave dell‟essere di Aristotele
Questa originaria unione perograve o saragrave pensabile o saragrave data in quanto originaria e
ciograve appare aporetico Per Fronterotta se si vuole ripercorrere il Sofista platonico
non si puograve che finire in questa difficoltagrave GC trova pertinenti le riflessioni di Fron-
terotta e al contempo rileva che anche l‟identico egrave un‟idea relativa Inoltre convie-
ne con Fronterotta sul fatto che il Sofista sia un dialogo oltremodo complesso per-
cheacute qui la prospettiva platonica si relativizza totalmente se non ontologicamente
almeno sul piano gnoseologico
Francesca Gambetti rileva la portata storiografica delle lezioni di GC infatti il
percorso interpretativo offerto dallo studioso egrave in grado di stimolare un ripensa-
mento della figura di Parmenide a partire dalla critica platonica agli avversari Gor-
gia e Protagora che avrebbero utilizzato gli assunti gnoseologici parmenidei per
fondare il proprio relativismo etico-politico Gambetti rilegge alcune fonti dosso-
grafiche che una interpretazione standard di Parmenide normalmente lascia in
ombra come il fr 16 DK contenente la testimonianza in cui Teofrasto rileva
l‟interesse per la sensazione da parte dell‟eleate ma anche il fr 7 DK A differenza
di Senofane e di Alcmeone Parmenide non egrave scettico sul fatto che l‟uomo conosca
la veritagrave egli conoscerebbe bene le acquisizioni piugrave recenti circa i meccanismi
fisiologici alla base delle sensazioni Infatti apre all‟uomo la possibilitagrave di rag-
giungere la veritagrave proprio attraverso l‟affermazione del fondamento soggettivistico
della conoscenza per cui se egrave vero che il pensiero egrave una forma della sensibilitagrave
allora non solo ciograve che egrave reale egrave intellegibile ma soprattutto ciograve che egrave in tellegibile egrave
reale Parmenide ancorerebbe la propria teoria ad una rigida fisiologia della sens i-
bilitagrave e non cadrebbe nella deriva relativistica di Protagora neacute nel nichilismo di
Gorgia Platone intende confutare Protagora e Gogia riappropriandosi del pensiero
logico-ontologico parmenideo rielaborandolo sul piano etico e politico per riadat-
tarlo al contesto storico della sua Atene profondamente differente da quello di
Elea GC trova prezioso il contributo di Gambetti che prospetta integrazioni al
discorso da lui svolto e attira l‟attenzione sullo spinoso fr 16 DK Perograve il richiamo
al soggettivismo non convince del tutto GC Inoltre giudica un po‟ azzardato il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 37
passaggio da bdquociograve che egrave reale egrave anche intellegibile‟ a bdquociograve che egrave intellegibile egrave reale‟
GC conviene invece con Gambetti quando questa ravvisa la finalitagrave perseguita dal
Platone impegnato a reinterpretare Parmenide nell‟esigenza di adeguare quella
struttura filosofica al contesto dell‟Atene del IV secolo
Stefania Giombini conduce il proprio intervento mirando sostanzialmente alla
lettura che GC fa di Gorgia di Leontini Il Gorgia di GC egrave un sofista ma anche un
filosofo nel senso piugrave stretto del termine e Giombini facendo riferimento
all‟attuale dibattito storiografico sul senso della categoria di filosofo prima del IV
secolo chiede a GC se non si arrivi a un paradosso quando si fa di Gorgia un puro
filosofo infatti la sua filosofia coinciderebbe con la sua retorica giungendo cosigrave a
una equiparazione quasi ossimorica Giombini chiede poi un approfondimento
sulla logica in Gorgia infatti GC ha suggerito l‟idea che in Gorgia si attui una
particolare logica a lui peculiare Giombini richiamandosi a studi riguardanti la
presenza di elementi di logica antica nel sofista e in particolare alla presenza di
una enunciazione del principio di non contraddizione nel Palamede chiede a GC
come sia possibile conciliare le due possibilitagrave Dal principio di non contraddizio-
ne Giombini si allaccia poi al tema della veritagrave che ha un ruolo fondamentale
nella speculazione di GC l‟idea della possibilitagrave del verosimile rimanda a una
veritagrave regolativa e GC intendendo tale veritagrave come correttezza logica non risolve
la questione ma anzi la sposta con l‟esito di non produrre chiarezza Infine Giom-
bini chiede a GC se e in che misura ritiene possibile la lettura del terzo caposaldo
del ηκν di Mazzara e Rossetti i quali non vi vedono una negazione sic et simplici-ter della possibilitagrave di comunicare ma solo una certa difficoltagrave GC risponde che in
Gorgia vi egrave un concetto di veritagrave essa egrave legata all‟interpretazione poicheacute egrave impos-
sibile accedere alla veritagrave assoluta Rispetto al riferimento dell‟interpretazione del
terzo caposaldo del ηκν GC ribadisce la sua lettura del sofista e della sua opera
specifica perograve che naturalmente non ritiene che per Gorgia la realtagrave sia costruita dai
discorsi ma che i discorsi costruiscano i significati della realtagrave Gorgia viene letto
da Giombini e da GC in maniera differente e per GC questa distanza che egrave frutto
di interpretazioni diverse non appare immediatamente conciliabile
Silvio Marino si sofferma sull‟aspetto che ritiene emerga con maggiore forza
dalle lezioni di GC ovvero la circolaritagrave che il pensiero platonico produce nel
tentativo di trovare una terza via tra Parmenide e i sofisti Tale circolaritagrave egrave intesa
da Marino non in senso tautologico ma bdquoolistico‟ cioegrave nel senso di un pensiero che
ritornando su se stesso si arricchisce sempre di nuove prospettive nuovi piani
senza abbandonare i precedenti La terza via invece consisterebbe nella dialett izza-
zione della realtagrave e del discorso fondata sul principio di analogia L‟analogia tra la
realtagrave e i discorsi che gli uomini sulla base delle proprie disposizioni fanno su di
questa dovrebbe ricucire nella prospettiva platonica lo strappo aperto dai sofisti
ma poicheacute i discorsi non sono neutri non rispecchiano mai completamente la realtagrave
ma la interpretano tra questi e la realtagrave rimane sempre uno scarto incolmabile
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
38 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Tale dialettizzazione ha anche un risvolto metodologico in quanto invita a leggere i
dialoghi secondo lo stesso criterio di dialettizzazione seguito da Platone nella loro
scrittura ovvero tenendo sempre insieme non segmentando ma intrecciando i
diversi possibili piani del discorso ndash etico politico gnoseologico fisico GC rin-
grazia Marino per le sue osservazioni che colgono bene il senso delle sue analisi e
le integrano con interessanti riflessioni come quella che riguarda la circolaritagrave
olistica del pensiero e della scrittura platonica Egli inoltre apprezza le considera-
zioni sulla dialettizzazione della realtagrave e del discorso sulla base del principio di
analogia e trova interessante il suggerimento di considerare il metodo logico plato-
nico come un metodo dialogico nel quale non solo gli ὄληα ma anche gli ε δε
sono realtagrave relazionali nelle quali le diverse prospettive ndash fisica etica politica
ecc ndash si intrecciano sempre tra loro
Lidia Palumbo ripercorre lo sforzo ermeneutico compiuto da GC nell‟analisi
dell‟ultimo Platone e del suo tentativo bdquoacrobatico‟ di laquocostruire su un fondamento
parmenideo e in funzione antiprotagorea un‟ontologia cui appoggiare la critica
stessa dell‟eleatismo e la connessa difesa sofistica della centralitagrave del ι γνοraquo La
studiosa riconosce la forza dell‟interpretazione di GC e si appresta al contempo a
rilevarne alcune difficoltagrave in particolare per quanto riguarda la nozione di disco r-
so falso che a suo avviso non egrave ambigua Prendendo le mosse dalla propria inter-
pretazione del Sofista platonico e negando la tesi di GC per cui in Platone non si
puograve parlare di ciograve che non esiste Palumbo sottolinea al contrario come per il
filosofo ateniese si possa parlare di ciograve che non esiste proprio come fanno i sofisti
Di seguito la stessa Palumbo mette in evidenza un elemento cruciale della prospet-
tiva di GC per il quale lo scopo ultimo di Platone egrave di natura etico -politica Non
riuscendo a fondare la critica ontologica al relativismo percheacute egli stesso egrave re lativi-
sta Platone rifiuta questo esito percheacute ciograve lo spinge a temere per la cittagrave e per
l‟anima ossia per quella dimensione umana che egrave centrale nella sua speculazione
GC riconosce che Lidia Palumbo ha colto perfettamente le analisi proposte nelle
sue lezioni e risponde alla sua sollecitazione sostenendo che forse le loro posizio-
ni non sono poi cosigrave distanti e che in termini diversi i due stanno andando verso la
medesima direzione Per GC la falsitagrave del discorso risiede nella falsitagrave del rapporto
con la realtagrave che il discorso sancisce Egli ribadisce che a suo avviso il falso non egrave
ciograve che non esiste nella realtagrave ma una erronea relazione tra enti una relazione che
non corrisponde alla realtagrave
Le posizioni di GC convincono Massimo Pulpito il quale ammette di trovarsi
in linea con le interpretazioni proposte nelle sue Lezioni Eleatiche Sulla scorta di
questa adesione Pulpito va oltre per trarre riflessioni e conclusioni personali a
partire dall‟analisi della figura di Protagora l‟Abderita appare fedele a Parmenide
ma al contempo lo supera ammettendo che la realtagrave non coincide con l‟essere e che
dunque in essa c‟egrave spazio per il non essere il tutto parmenideo viene cosigrave fram-
mentato in favore di una riflessione sulle singole parti Protagora mette in crisi il
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 39
principio di unitagrave dell‟essere di Parmenide allo stesso modo di un altro Abderita
Democrito il quale con le nozioni coesistenti di atomo e vuoto ripropone conce t-
tualmente il rapporto essere-non essere La prospettiva parmenidea e il dibattito
che evidentemente ne seguigrave giunse fino a un autore meno noto ma non per questo
meno significativo Seniade di Corinto Questi avrebbe non solo attaccato il fo n-
damento del pensiero parmenideo (ossia la negazione del non essere) ma lo avreb-
be rovesciato arrivando a sostenere che ogni cosa ( άληα) egrave falsa con ciograve avvici-
nandosi alle medesime conclusioni raggiunte da Gorgia Pulpito affronta poi la
questione del parricidio concordando con GC nel negare il suo accadimento Se
c‟egrave stato un parricidio esso puograve dirsi solo in senso performativo ossia come parri-
cidio evocato proprio da Platone che avviene non tanto sul piano teoretico come
distruzione di una tesi quanto sul piano ermeneutico come tradimento della volo n-
tagrave filosofica di Parmenide GC apprezza le riflessioni di Pulpito in molti tratti con
particolare gratitudine per il richiamo a Seniade di Corinto e per le riflessioni sul
parricidio Dopodicheacute stimolato dalle analisi di Pulpito propone un ulteriore chia-
rimento Non egrave propriamente equivalente dire che se tutti i discorsi sono veri allora
essi saranno tutti falsi A rigor di logica lo sarebbero ma il discorso che potrebbe
apparire falso ad un uomo potrebbe esser vero per un altro e dunque esso non va
trattato come un discorso falso ma come un discorso vero per qualcun altro in
quanto il vero e il falso sono sempre da intendersi in senso relat ivo e mai assoluto
Per bocca di Antifonte nel Parmenide platonico viene narrato l‟incontro tra
Socrate e Parmenide Riflettendo sul rapporto a distanza tra Parmenide Protagora
Gorgia e Platone proposto da GC Sofia Ranzato sottolinea che la descrizione che
Platone fa del maestro bdquovenerando e terribile‟ puograve essere significativa per la com-
prensione del rapporto tra Parmenide e Platone Antifonte nel dialogo pone molta
attenzione all‟etagrave dei suoi interlocutori Socrate e Parmenide ma anche a quella di
Zenone e per Ranzato questo egrave sintomatico di una certa idea di educazione e di
crescita intellettuale un giovane Socrate propone con slancio giovanile la teoria
delle forme ed in maniera inusuale egrave dalla parte di chi deve essere educato bdquoall‟arte
dei discorsi‟ Secondo Ranzato la scelta platonica di far proporre a un Socrate
giovane la sua piugrave importante teoria non egrave indicativo di un ridimension amento
della stessa quanto piuttosto di un tentativo di presentarla come una dottrina in fieri che deve essere corroborata e perfezionata E mentre la figura di Zenone
viene sminuita Socrate con la sua proposta appare stimolante agli occhi di Parme-
nide il quale ne mette prontamente alla prova l‟intuizione teorica L‟uso del perso-
naggio Socrate cessa nei dialoghi in si cui attua una forte critica all‟Eleatismo
quando Platone egrave pronto a formulare un nuovo metodo di indagine filosofica GC
ripercorre le analisi di Ranzato sottolineando come l‟incontro tra Socrate e Parme-
nide nell‟omonimo dialogo di Platone rappresenti senz‟altro uno degli snodi
dell‟indagine filosofica platonica
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
40 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
Durante le sue Lezioni Eleatiche GC ha portato i suoi ascoltatori in un viaggio
da Elea ad Atene sostiene Fernando Santoro Ad Elea si assiste alla nascita
dell‟ontologia e ad Atene l‟ontologia eleatica trova il suo ulteriore sviluppo filos o-
fico a questo passaggio contribuisce e non secondariamente la meontologia che
secondo Santoro si rivela fondamentale nella costruzione del discorso sull‟essere
Santoro si propone di ripercorrere questo ponte tra Elea ed Atene attraverso
l‟analisi dei dialoghi Parmenide e Sofista e costruisce un suo itinerario che va da
Parmenide al suo allievo Zenone e alla meontologia di Gorgia senza trascurare altri
due ulteriori interlocutori Eraclito e Protagora Ma il percorso che ha preso le
mosse ad Elea e si egrave fatto strada fino ad Atene egrave passato da Siracusa grazie a un
pensatore meno evidente ma presente Epicarmo I punti di contatto tra le opere di
Epicarmo e i dialoghi della trilogia dialettica ndash Parmenide Sofista Teeteto ndash sono
piugrave d‟uno ma certamente non per plagio essi ci testimoniano ancora un nuovo
interlocutore di Platone che ha lasciato un segno concettuale e formale nei s uoi
dialoghi GC apprezza le riflessioni di Santoro e ne coglie gli stimoli e l‟intuizione
tanto da aggiungere che oltre ad Epicarmo la rotta tra Elea e Atene fu probabil-
mente arricchita anche da altri itinerari e personaggi che noi oggi non siamo piugrave in
grado di identificare
Alessandro Stavru concentra il suo intervento sul concetto di δ μα in Parmeni-
de tema che la letteratura critica ha inteso in molti sensi non senza creare ambigu i-
tagrave e difficoltagrave interpretative non solo nei commentatori moderni ma anche presso
gli antichi In Platone non solo nel Parmenide e nel Sofista ma anche in altri dia-
loghi soprattutto nella Repubblica (V libro) la δ μα ha duplice natura una plaus i-
bile e una fallace Tale distinzione giunge ad Aristotele (nella Metafisica) e anche
ad autori significativi quali Teofrasto e Simplicio In questi autori la δ μα ha un
ruolo non secondario nel processo conoscitivo e Stavru ritiene euristicamente s i-
gnificativo indagare la relazione tra la posizione di tali autori e il poema parmen i-
deo in particolare i frr 1 e 8 DK Nel fr 8 la dea assegna un valore fondamentale
alla δ μα nel processo conoscitivo la δ μα non egrave la veritagrave ma non egrave possibile pre-
scindere da essa Da qui la domanda essa egrave legata alla sensazione o ai fenomeni
In che modo vanno lette e raccordate le due parti del poema Infine Stavru solleci-
ta a una traduzione maggiormente letterale dei termini del Poema che riguardano la
δ μα per non perdersi nella ricerca di voci ambivalenti che possono aver deviato le
interpretazioni a partire dallo stesso Platone GC risponde alle domande di Stav ru
specificando che si deve distinguere un livello oggettivo che egrave indipendente dalla
percezione dell‟uomo e uno soggettivo che dipende dalla percezione umana Nel
livello soggettivo si situano la δ μα e l‟ἀιήζεηα la δ μα in quanto percezione po-
tenzialmente falsa in cui non si coglie il legame e l‟organizzazione attraverso il
ι γνο-λν ο e l‟ἀιήζεηα la veritagrave che coglie il mondo nella sua unitagrave
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
Da Elea ad Atene veritagrave linguaggio polit ica 41
Chi egrave Giovanni Casertano
Giovanni Casertano egrave stato docente di Storia della filosofia antica presso
l‟Universitagrave ldquoFederico IIrdquo di Napoli La sua carriera egrave iniziata con l‟insegnamento
nei licei statali italiani ed egrave poi proseguita nell‟Universitagrave partenopea prima come
assistente ordinario (a partire dal 1980) poi e dopo un breve incarico a Messina
come professore ordinario Le sue prime ricerche si sono concentrate sulla questio-
ne delle origini della filosofia ovvero sul suo originario porsi come domanda di
senso come riflessione sul come e sul percheacute della realtagrave non assunta in maniera
acritica o scontata Egrave su questi temi che negli anni ‟70 Casertano consegna alle
stampe volumi come Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti (1971) La nascita della filosofia vista dai Greci (1977) e opera particolarmente significativa
Parmenide il metodo la scienza l‟esperienza (1978) che avrebbero segnato pro-
fondamente il dibattito storiografico In particolare il volume su Parmenide si fa
notare per il netto e innovativo rigetto della tradizionale svalutazione della δ μα
secondo una linea di pensiero che riaffiora anche in queste sue Lezioni Eleatiche
L‟interesse per i Presocratici segna anche la produzione successiva con numerosi
altri saggi sulla sofistica su Parmenide su Democrito Alla fine degli anni ‟80
Casertano sposta progressivamente i suoi interessi su Platone indagato soprattutto
a partire dalla questione del rapporto tra linguaggio e realtagrave Pubblica cosigrave due
volumi significativi L‟eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone) nel
1991 e Il nome della cosa Linguaggio e realtagrave negli ultimi dialoghi di Platone nel
1996 La fiducia nella feconditagrave euristica dell‟analisi del lessico e dei campi se-
mantici lo spingono ad approfondire con letture e commenti sistematici i singoli
dialoghi platonici cui dedica a partire dal 2000 convegni biennali Ne sono deri-
vati molti volumi di atti (La struttura del dialogo platonico 2000 Il Teeteto di Platone struttura e problematiche 2002 Il Protagora di Platone struttura e pro-blematiche 2004 Il Cratilo di Platone struttura e problematiche 2005 Il Fedro di Platone struttura e problematiche 2011) che sono tutti confluiti nella collana
bdquoSkepsis‟ dell‟editore Loffredo da lui stesso diretta In anni piugrave recenti i suoi inte-
ressi si sono rivolti al rapporto tra i sofisti e Platone nella convinzione che
l‟originale elaborazione platonica sia profondamente radicata nelle grandi specula-
zioni di Protagora Gorgia e Antifonte e che la vicinanza e il debito nei loro co n-
fronti sia molto piugrave forte di quanto generalmente ammesso dagli studiosi del sett o-
re L‟intensa attivitagrave scientifica e la produzione amplissima (quasi trecento unitagrave
tra saggi volumi contributi interventi in conferenza)39 si egrave ben coordinata con
una intensa attivitagrave didattica con le famose e affollate lezioni e i seminari pomeri-
diani tenuti all‟Universitagrave di Napoli egli ha costru ito una vera e propria scuola
-------------------------------------------- 39 Per una bibliografia ragionata cfr λόγον διδόναι La filosofia come esercizio del render ragione
Studi in onore di Giovanni Casertano a cura di L Palumbo Napoli 2012 dove egrave presente anche un accurato profilo biografico
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
42 Francesca Gambetti e Stefania Giombini
con piugrave generazioni di allievi Le sue doti scientifiche e umane lo hanno fatto ap-
prezzare anche presso le universitagrave straniere dove ha tenuto numerosissimi semi-
nari convegni e lezioni Visiting Professor in molte universitagrave europee ed extraeu-
ropee nel 2012 ha ricevuto primo europeo il titolo di Dottore Honoris Causa
dall‟Universitagrave di Brasilia di cui da oltre un decennio egrave collaboratore in numerose
attivitagrave
Egrave stato Presidente della Societagrave Filosofica Italiana dal 1998 al 2001 egrave Socio
ordinario dell‟Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societagrave Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Socio ordinario dell‟Accademia Pontaniana in
Napoli Socio ordinario dell‟International Plato Society Socio ordinario
dell‟International Association for Presocratic Philosophy Socio ordinario del
Centre d‟eacutetudes sur la penseacutee antique KAIROS KAI LOGOS Membro del Comita-
to scientifico della collana di studi classici bdquoIter‟ di Santiago del Chile
Ascea maggio 2015 FG SG
La responsabilitagrave di questo saggio introduttivo che sotto molti profili egrave il prodot-to di un lavoro congiunto egrave comune alle due autrici Nondimeno la stesura delle pagi-ne 21-32 si deve a Francesca Gambetti e quella delle pagine 17-21 e 32-40 a Stefania Giombini Le curatrici ringraziano Livio Rossetti e Massimo Pulpito per le notazioni i suggeri-menti e il dialogo continuo con cui hanno supportato il lavoro editoriale
![Page 1: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: [Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050215/6337b6d5ce400ca6980922d3/html5/thumbnails/42.jpg)