MANIERI A. (2012), Gli agoni musicali nelle commedie di Aristofane, in "La commedia greca e la...
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of MANIERI A. (2012), Gli agoni musicali nelle commedie di Aristofane, in "La commedia greca e la...
TESTIMONIANZE SULLA CULTURA GRECA
1. PSEUDO ARISTOTELE, I colori, edizione critica, traduzione e commento diMaria Fernanda Ferrini, 1999, pp. 320.
2. LASO DI ERMIONE, Testimonianze e frammenti, testo, traduzione e com-mento di Guerrino Francesco Brussich, 2000, pp. 104.
3. La metafora, testi greci e latini tradotti e commentati da Giulio Guidoriz-zi e Simone Beta, 2000, pp. 244.
4. ANDREW BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, a cura diFranca Perusino e Eleonora Rocconi, 2002, pp. 164.
5. Dalla lirica corale alla poesia drammatica. Forme e funzioni del canto co-rale nella tragedia e nella commedia greca, a cura di Franca Perusino eMaria Colantonio, 2007, pp. 368, ill.
6. La commedia greca e la storia, a cura di Franca Perusino e Maria Colan-tonio, 2012, pp. 388.
PAGINE EDITORIALI_00 pp. ed. 01/06/12 09.27 Pagina 2
TESTIMONIANZE SULLA CULTURA GRECA
COLLANA DIRETTA DA FRANCA PERUSINO
6
La Collana si propone di pubblicare opere intere e raccolte di testi-monianze che illustrino i vari aspetti del patrimonio culturale deiGreci e la personalità degli autori che contribuirono ad assicurarnela continuità attraverso i secoli. L’edizione critica è affiancata dallatraduzione e da un commento nel quale saranno di volta in voltaevidenziati i contributi e le problematiche dei testi esaminati,
anche allo scopo di offrire materiale e spunti per ulteriori ricerche.
PAGINE EDITORIALI_00 pp. ed. 01/06/12 09.27 Pagina 3
La commedia greca e la storiaAtti del Seminario di studio
Urbino, 18-20 maggio 2010
a cura diFranca Perusino e Maria Colantonio
EDIZIONI ETS
PAGINE EDITORIALI_00 pp. ed. 01/06/12 09.27 Pagina 5
© Copyright 2012EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884673269-9
www.edizioniets.com
Questo volume è stato stampato con il contributodell’Università di Urbino “Carlo Bo” e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca(Programmi di Ricerca Scientifica di interesse nazionale - esercizio finanziario 2007).
Alle spese di stampa ha contribuito anche ilDipartimento di Scienze del Testo
e del Patrimonio Culturale dell’Univeristà di Urbino
PAGINE EDITORIALI_00 pp. ed. 01/06/12 09.27 Pagina 6
Il seminario che oggi si inaugura conclude un progetto di ricer-ca di interesse nazionale (PRIN) cofinanziato dal MIUR e dall’U-niversità, realizzato con la partecipazione delle Università della Calabria, di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, di Roma Tre, del Salento e di Urbino “Carlo Bo”. L’argomento proposto è di quelli che coinvolgono, si può dire a ogni passo, il lettore della commedia greca, soprattutto della commedia antica fiorita nel periodo dram-matico ma anche vivacissimo dal punto di vista politico, sociale e culturale che coincide per buona parte con il conflitto fra Atene e Sparta. Nella commedia antica non esiste soluzione di continuità fra pubblico e privato che si intersecano e si alternano così come accadeva nella vita quotidiana del cittadino ateniese. Su di essa si concentrerà, come è ovvio, la maggior parte delle relazioni; ma sarà anche interessante ascoltare come il dato storico venga sfrut-tato nella commedia del IV secolo, profondamente diversa per la mutata temperie politico-culturale.
Questa presentazione non può concludersi senza assolvere ad un compito profondamente sentito da noi e dai colleghi che co-ordinano le unità del PRIN, Carmine Catenacci, Giovanni Cerri, Pietro Giannini, Antonietta Gostoli. Abbiamo infatti deciso di de-dicare questo seminario alla memoria di Massimo Vetta che faceva parte della nostra cordata ed era stato uno dei promotori dell’ ini-ziativa maturata nell’atmosfera amichevole e rilassata di una cena in casa di Antonietta Gostoli. All’amico carissimo prematuramen-te scomparso, allo studioso acuto e sensibile della commedia greca, alla quale aveva dato numerosi contributi fra i quali spicca l’edizio-ne esemplare delle Donne all’assemblea di Aristofane, dedichiamo questo incontro associandolo nel ricordo ad altri colleghi e amici che ci hanno lasciato.
Domenico Musti aveva aperto i lavori del seminario con una complessa e articolata relazione sulle istituzioni democratiche ate-niesi nell’immaginario di Aristofane; dopo la sua scomparsa nel
novembre 2010 il recupero e la sistemazione del testo scritto, an-cora incompleto nella parte conclusiva, si devono all’affettuosa e paziente opera di Marco Santucci al quale Domenico Musti aveva affidato le sue prime riflessioni in vista della stesura definitiva da includere negli Atti. A lui e alla famiglia Musti, che ha acconsentito alla pubblicazione, la nostra sincera e commossa gratitudine per l’insperato recupero di un documento prezioso.
Nell’agosto 2010, pochi mesi dopo il nostro incontro, è scom-parso Colin Austin che aveva partecipato al seminario con un en-tusiasmo e una vitalità che sembravano aver segnato la sconfitta del male che lo affliggeva.
Nell’ottobre 2009 si era spento Roberto Campagner che, redu-ce da una impegnativa ricerca sul lessico agonistico di Aristofane, si accingeva a elaborare per il seminario un intervento sulla città di Corinto nelle commedie di Aristofane.
A questi indimenticabili amici il nostro affettuoso ricordo e il rimpianto di non averli più con noi.
Desideriamo infine esprimere la nostra gratitudine a quanti ci hanno aiutato nell’organizzazione del seminario: al collega Pietro Vannicelli che con i suoi preziosi suggerimenti ha attivamente con-tribuito alla fase preparatoria; ai nostri allievi e amici Luigi Bravi, Cristian Di Sanza e Lucia Pretelli che nella sua qualità di assessore al Turismo nel Comune di Urbino ci ha ospitati per un memorabile rinfresco in una sala del Palazzo Ducale. Un caldo e affettuoso rin-graziamento rivolgiamo infine a Mercede Amaranti che ha messo a nostra disposizione la sua competenza e ci è stata vicina in tutte le fasi della preparazione e dello svolgimento del seminario.
F.P. - M.C.
12
IntroduzIone1
Franca Perusino
La commedia greca, soprattutto quella antica, appare stretta-mente legata alle manifestazioni della polis, e non solo a quelle connesse alla guerra, ma anche alla gestione della cosa pubblica, ai contrasti interni, alle questioni giudiziarie, fino ai problemi dell’e-ducazione, della poesia, della filosofia. Se la commedia antica non intende proporre un vero e proprio programma politico o forni-re una chiave per risolvere gli svariati problemi che assillavano i cittadini ateniesi, mira tuttavia a farsi interprete delle aspirazioni, degli umori, dei disagi di singoli gruppi o di singoli cittadini e a convogliarli nei modi conformi ad uno spettacolo comico e alle attese di un pubblico radunato in teatro per riflettere ma anche per ridere e divertirsi.
La convivenza di realtà e utopia, lo slittamento da un registro all’altro, la pluralità dei generi, dei toni, dei linguaggi che contrad-distinguono il variegato universo della commedia antica ne fanno la rappresentante per eccellenza di quello che Michail Bachtin ha definito “genere serio-comico”2. nel suo libro sulle origini della guerra del Peloponneso G. M. de Ste. Croix ne fornisce una vivida sintetica definizione3:
Aristofane deve sempre essere ‘comico’: questa è la condizione impo-sta dal suo genere. Ma può anche essere serio allo stesso tempo, e molto
1 Queste pagine riprendono in parte un contributo pubblicato in S. da-ris - G. tedeschi (edd.), Memoria renovanda. Giornata di Studi in memoria di Carlo Corbato (trieste, 11 ott. 2006), trieste 2007, pp. 51-56
2 M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, trad. it. torino 1968, pp. 139-179. Inspiegabilmente Bachtin non prende in considerazione la comme-dia attica e ignora l’auspicio di Aristofane che “i giudici intelligenti (sofoiv) mi giudichino ricordandosi delle mie parole intelligenti, quelli che vogliono ridere (oiJ gelw`nte~) mi diano un premio perché li ho fatti ridere” (Eccl. 1155 s.). Cfr. W.roesler, ‘Michail Bachtin e il “Carnevalesco” nell’antica Grecia’, in W. roesler - B. zimmermann (edd.), Carnevale e utopia nella Grecia antica, Bari 1991, pp. 15-51.
3 The Origins of the Peloponnesian War, London 1972, p. 357.
14 Franca Perusino
spesso lo è. Quanto più comicamente si esprime, tanto meglio il suo mes-saggio sarà recepito e si imprimerà nella mente dello spettatore, incluso quello che rifiuterebbe lo stesso messaggio se fosse convogliato in forma seria. Sarebbe un errore sostenere che un testo comico non possa avere un contenuto serio semplicemente perché lo trasmette in forma scherzosa … la veste comica è una necessità richiesta dal genere.
Ma proprio queste caratteristiche creano spesso al lettore mo-derno difficoltà nella decodificazione e nella valutazione dei dati che emergono dalla commedia, in particolare dei dati storici. Quando entra a far parte di un contesto comico, anche il dato storico soggiace alle norme che lo regolano: rievocato, a secon-da delle circostanze, a sostegno di una tesi o di un’ideologia, può essere talora piegato ad intenti parodici o a deformazioni tese a ridicolizzare i fatti stessi o chi se ne serve. Quando il dato storico è inserito nel gioco comico, non è sempre agevole per il lettore mo-derno individuare il confine che separa il fatto reale dalla parodia o dalla deformazione alla quale il poeta lo sottopone; il compito si rivela particolarmente difficile in quei casi nei quali le nostre conoscenze del fatto sono affidate esclusivamente al testo comico e non usufruiscono del sostegno di altre fonti. Questa difficoltà non era certamente avvertita dal pubblico antico – o almeno dalla parte più colta e intelligente di esso4: dobbiamo infatti pensare ad una sostanziale omogeneità fra le conoscenze storiche del comme-diografo e quelle del suo pubblico5 e supporre che il poeta non superasse certi limiti e non si permettesse di introdurre allusioni o battute che non fossero comprensibili agli spettatori; avrebbe provocato disappunto, irritazione, noia e rischiato di prendersi qualche fischio6. Ma deformazione a fini comici di un dato storico non significa alterazione o falsificazione: è assolutamente fuorvian-
4 nelle Nuvole (v. 518 ss.) Aristofane stesso distingue gli spettatori abili e intelligenti (dexioiv, sofoiv) da quelli rozzi e volgari (fortikoiv). Cfr. anche il passo delle Ecclesiazuse citato sopra, n. 2.
5 Cfr. M.nouhaud, L’utilisation de l’histoire par les orateurs attiques, Pa-ris 1982, p. 37; L. Bertelli, ‘La memoria storica di Aristofane’, in Storiografia locale e storiografia universale (Atti del Congresso, Bologna, dic. 1999), Como 2001, p. 42 s.
6 Come, secondo un’ipotesi di e. A. Havelock (‘the Socratic self as it is parodied in Aristophanes’ Clouds’, Yale Class. Stud. 22, 1972, pp. 1-18), sarebbe accaduto per le Nuvole.
Introduzione 15
te sostenere che al poeta comico tutto era lecito in nome dello scherzo e del riso, anche la manipolazione della realtà. Perché una parodia, una caricatura, una battuta siano recepite e raggiungano lo scopo che il poeta si prefigge è indispensabile che la base non venga alterata e sia sempre riconoscibile sotto le deformazioni alle quali è sottoposta. È una legge valida per la comicità antica come per quella moderna.
Ancor meno condivisibile sembra la posizione di quegli stu-diosi che, senza tener conto delle multiformi esigenze di un testo teatrale comico, riversano sull’autore responsabilità che essi stes-si dovrebbero assumersi: per esempio quando, di fronte a passi problematici e di difficile interpretazione, liquidano la questione sostenendo che è il poeta comico a travisare i dati della realtà o, ancor peggio, che certi ‘errori’ sono imputabili ad una conoscen-za approssimativa dei fatti. Ma come si può mettere in dubbio la cultura storica dei poeti della commedia antica, fatta di esperienze personali dirette, di notizie apprese oralmente o anche dalla lettura e dall’ascolto di opere storiografiche7?
La commedia greca rappresenta una fonte da non sottovalutare, ma che ha bisogno di volta in volta di essere decodificata indi-viduandone e valutandone i diversi risvolti: c’è dunque bisogno della cooperazione dello storico, dell’esperto del teatro antico che abbia una visione pragmatica del testo e della sua destinazione, del filologo, dell’archeologo, dello studioso della religione e dei culti.
Mi auguro che da questo incontro, che non potrà certo esaurire un problema tanto complesso, la personalità del poeta comico esca meglio delineata e, ove necessario, rafforzata. Con questo spirito di collaborazione prende il via un seminario che tutti ci auguriamo vivace e proficuo.
7 Cfr. Bertelli, art. cit. (n. 5), p. 43 s.
Gli aGoni musicali in aristofane
Alessandra Manieri
le nuvole, divinità celesti venerate dai sofisti, giungono ad atene, nella parodo dell’omonima commedia, intonando un inno alla “terra di Pallade”1, patria di “riti ineffabili, offerte agli dei, templi altissimi, statue, processioni, e sacrifici e feste in tutti i pe-riodi dell’anno” (qusivai qalivai te pantodapai'sin w{rai"). la fama delle feste e degli agoni ateniesi, ricorrenti in tutte le stagio-ni2 in numero superiore a quelle celebrate presso le altre città della Grecia3, è notoriamente un topos della lode di atene. non è stra-no dunque che la commedia attica, che sempre si muove su uno sfondo cittadino, reale o ideale, attinga ripetutamente ai momenti più significativi di queste feste, che offrono uno squarcio di vita comunitaria e dunque trovano l’adesione di tutte le classi sociali che costituiscono il pubblico di un teatro.
Di fatto, non c’è fonte antica tanto rilevante quanto aristofane nel richiamare, in toni seri o caricaturali, non solo innumerevoli momenti rituali4 (quali, per fare gli esempi più noti, il corteo fallico
1 Nub. 299 ss.2 Per la distribuzione delle feste religiose ateniesi all’interno del calendario
attico, vd. roveri 1959, pp. 228-229.3 cfr. thuc. 2, 38, 1 tw'n povnwn pleivsta" ajnapauvla" th/ ' gnwvmh/ ejpori
savmeqa, ajgw'si mevn ge kai; qusivai" diethsivoi" nomivzonte", “abbiamo procu-rato allo spirito numerosissimi svaghi dalle fatiche, con la consuetudine di gare e feste religiose durante tutto l’anno”; Ps. Xenoph. Resp. Ath. 3, 2 dei' eJortavsai eJorta;" o{sa" oujdemiva tw'n ÔEllhnivdwn povlewn, “celebrano feste quante nes-sun’altra città greca”; Plat. Alcib. alt. 148e-149a pleivsta" ... qusiva" kai; kallivsta" tw'n ÔEllhvnwn a[gomen, ajnaqhvmasiv te kekosmhvkamen ta; iJera; aujtw'n wJ" oujdevne" a[lloi, pompav" te polutelestavta" kai; semnotavta" ejdwrouvmeqa toi'" qeoi'" ajn∆ e{kaston e[to", kai; ejtelou'men crhvmata o{sa oujd∆ oiJ a[lloi suvmpante" {Ellhne", “noi offriamo tra i Greci i sacrifici più belli e più frequenti e abbiamo decorato i loro templi con offerte votive come nessun altro, e offrivamo ogni anno agli dei le processioni più sontuose e solenni e spendevamo denaro quanto nemmeno tutti gli altri Greci insieme”.
4 Per i riferimenti a processioni e momenti rituali nelle commedie di aristo-fane, cfr. Bowie 1993; cole 1993.
282 Alessandra Manieri
delle Dionisie rurali negli Acarnesi 5, le cerimonie iniziatiche delle Brauronie nella Lisistrata6, i riti delle Tesmoforiazuse in onore di Demetra7, i misteri eleusini ricordati nelle Rane)8, ma anche nell’e-vocare, attraverso riferimenti espliciti o particolari allusivi, precisi contesti agonali, e la gran parte di tipo musicale9, inquadrabili nel-le manifestazioni religiose ateniesi del V secolo.
le commedie di aristofane pullulano, difatti, di un’enorme schiera di artisti di ogni categoria (poeti tragici, comici, ditiram-bografi, auleti, citarodi)10, noti per le loro esibizioni in concorsi musicali non solo ateniesi (Dessiteo, p. es., fu anche un pythionikes11, essecestide vinse anche a Delfi e alle carnee spartane12), ora celebrati, ora derisi, ora contestati dal poeta. accanto a costoro trovano menzione personaggi in vario modo coinvolti nella realiz-zazione degli agoni: oltre al pubblico e ai giudici, veri interlocutori di aristofane13, i coreghi, come l’avaro antimaco che ha lasciato i suoi coreuti senza cena a fine spettacolo14, gli ajkovlouqoi, che
5 Ach. 241-249: Diceopoli avanza intonando il canto rituale, preceduto dalla figlia, che svolge la funzione di canefora, e seguito dal servo che regge il fallo.
6 Vd. Lys. 644-649 e cfr. Gentili-Perusino 2002. 7 Vd. Thesm. 278 ss.; 834 ss.; 880 ss. 8 Vd. Ran. 316 ss. cfr. anche Eccl. 730-745, ove sarebbe parodisticamente rap-
presentata la processione delle Panatenee: vd. Vetta-Del corno 1994, pp. 216-217. 9 utilizzeremo in questo contributo l’espressione “agoni musicali” nell’ac-
cezione più ampia, comprendente, oltre alle gare musicali in senso stretto, anche gare di recitazione non necessariamente accompagnate dallo strumento, come i concorsi rapsodici e drammatici. cfr. manieri 2009, p. 25 ss. e vd. schol. aristoph. Plut. (recensio 1) 1163 massa Positano mousikoi; ajgw`ne" oiJ di∆ ojrgavnwn qumevlh" ginovmenoi kai; oiJ logikoiv.
10 tra i poeti comici sono chiamati in ballo, nelle commedie di aristofane, cratino, magnete, cratete, eupoli, frinico, ermippo, ferecrate, licide e amipsia; tra i tragici, oltre ad eschilo ed euripide, anche teognide, Geronimo, morsimo, melanzio, carcino, senocle, frinico, filocle, stenelo, acestore, tespi, agatone, iofonte, Pitangelo; tra i ditirambografi laso e simonide, ione di chio, cinesia, filosseno; tra gli auleti e i citarodi, Dessiteo, cheride, mosco, conno, artemone, arignoto, arifrade, frinide, essecestide, melete, teredone.
11 Vd. schol. Ach. 13a oJ de; Dexivqeo" a[risto" kiqarw/do;" kai; puqionivkh".12 Vd. schol. Av. 11 oJ de; ∆Exhkestivdh", kiqarw/do;" puqionivkh". nika/' de; kai;
to;n tw'n Karneivwn ajgw'na to;n ejn Lakedaivmoni, kai; Panaqhvnaia div".13 cfr., tra i numerosi contributi sul pubblico e i giudici, ehrenberg 1957,
pp. 28-50; Pickard-cambridge 1996, pp. 131 ss.; 361 ss.; loscalzo 2008.14 Ach. 1154-1155. Vd. anche Pax 1022.
Gli agoni musicali in Aristofane 283
operano come aiutanti di scena15, i rJabdou`coi, addetti al servizio di sorveglianza16, gli skeuopoioiv, o costruttori di maschere17, nessuno dei quali ha osato, per i Cavalieri, realizzare la maschera di cleone.
le commedie svelano, ancora, nei toni della satira o della pa-rodia18, la posizione conservatrice di aristofane nei confronti del-le innovazioni che i poeti del suo tempo avevano introdotto, in campo musicale, proprio per l’esigenza di assecondare il gusto del pubblico e ottenere affermazione nell’ambito dei concorsi19; atte-stano, inoltre, con l’evidenza dell’attualità, specifiche modalità di svolgimento delle gare o momenti particolari della loro procedura organizzativa. un passo degli Uccelli 20, p. es., è usato notoriamente per documentare la rappresentazione delle commedie nei pome-riggi delle stesse giornate riservate alle tragedie21; altrove aristo-fane accenna, in passi diversi, alla differente procedura che carat-terizzava l’assegnazione del coro negli agoni ditirambici rispetto a quelli drammatici. Per questi ultimi il poeta, presentando in anti-cipo il proprio lavoro, “chiedeva il coro” all’arconte, che quindi assegnava i cori e designava i coreghi. aristofane attesta questa pratica per le lenee e per le Dionisie, sia per la commedia che per la tragedia: in riferimento alla commedia e in occasione dell’agone lenaico, aristofane, nella parabasi dei Cavalieri 22, spiega perché
15 Pax 730. Per il ruolo del personale ausiliario nella realizzazione dei concorsi musicali, vd. manieri 2009, p. 82 n. 2.
16 Pax 734-735. Per il ruolo di questi funzionari negli agoni, vd. manieri 2004-05.17 Equ. 232.18 come è stato argutamente rilevato, aristofane esprime la sua critica più
severa nei confronti della nuova musica proprio “mettendola in caricatura musi-calmente” (Henderson 1962, p. 439; Pintacuda 1982, pp. 13-16), attraverso giochi verbali o nuovi coni di parole, citazioni o imitazioni di versi, lunghe parodie (vd., in Nub. 335-338, le citazioni di versi reali o liberamente rimaneggiati dal poeta, o Plut. 290-295, che contiene la parodia del Ciclope di filosseno). la stessa pratica della parodia, ricordiamo, ebbe ad atene una consacrazione negli agoni, se è vero che una gara di parodie fu introdotta alle Panatenee proprio alla fine del V sec.: vd. athen. 9, 72 (407a) ss.; 15, 56 (599a) e cfr. Kotsidu 1991, p. 57.
19 Vd. manieri 2009, p. 18 ss.20 V. 786 ss.: “se qualcuno di voi spettatori avesse le ali, quando fosse affamato
o annoiato dai cori delle tragedie, potrebbe volarsene a casa per mangiare e poi, riempita la pancia, a volo tornare da noi”.
21 Per la discussione e l’interpretazione del passo, vd. Pickard-cambridge 1996, p. 90 ss.
22 Equ. 513.
284 Alessandra Manieri
egli stesso, sino a quel momento, “non abbia chiesto il coro a pro-prio nome” (oujci; pavlai coro;n aijtoivh kaq∆ eJautovn); nella parabasi della Pace 23 sono menzionati invece due pessimi tragediografi che aspirano ad ottenere il coro alle Grandi Dionisie: “quando, a pri-mavera la rondine cinguetta felice – il riferimento è all’agone delle Dionisie che si svolge, appunto, in primavera – e non ottiene il coro (coro;n de; mh; ∆ch/) né morsimo e nemmeno melanzio”24. Per gli agoni ditirambici, invece, erano le tribù a selezionare i coreghi25, i quali poi tiravano a sorte per stabilire l’ordine nella scelta di poeti ed auleti26. Questa è la ragione per cui, negli Uccelli 27, cinesia si autodefinisce il kukliodidavskalo" per il quale da sempre fanno a guerra le tribù (o}" tai'si fulai'" perimavchtov" eijm∆ ajeiv): ciascuna tribù, con un sorteggio favorevole, aspirava a scegliere per prima per poterselo accaparrare come poeta e istruttore del proprio coro.
ma per intendere il particolare significato che aristofane attribuiva alla realtà degli agoni musicali, in quanto parte integrante della vita quotidiana di ogni cittadino ateniese, occorre, a nostro avviso, partire nell’indagine dalla più antica commedia a noi pervenuta, gli Acarnesi, che si rivela, a tal proposito, particolarmente emblematica.
Diceopoli esordisce, nel prologo, lamentando le poche gioie provate nella vita, accanto ai tanti dolori, numerosi come la sabbia del mare. Dopo aver ricordato la soddisfazione provata in occa-sione di un’umiliazione subita da cleone, egli menziona tre altre esperienze che lo hanno particolarmente coinvolto a livello emo-tivo (vv. 9-16):
∆All∆ wjdunhvqhn e{teron au\ tragw/dikovn, o{te dh; jkechvnh prosdokw'n to;n Aijscuvlon, oJ d∆ ajnei'pen: “Ei[sag∆, w\ Qevogni, to;n corovn. Pw'" tou't∆ e[seisev mou dokei'" th;n kardivan… ∆All∆ e{teron h{sqhn, hJnivk∆ ejpi; movscw/ pote; Dexivqeo" eijsh'lq∆ a/jsovmeno" Boiwvtion. Th'te" d∆ ajpevqanon kai; diestravfhn ijdwvn, o{te dh; parevkuye Cai'ri" ejpi; to;n o[rqion.
23 Pax 799 ss.24 Vd. anche Ran. 94, ove si denigrano i numerosi poetastri di tragedia, con-
temporanei del poeta, che mirano solo ad ottenere il coro (coro;n labei`n).25 Vd. Pickard-cambridge 1996, p. 104 ss.26 Vd. antiphont. 6, 11; Dem. Mid. 13.27 Av. 1403-1404.
Gli agoni musicali in Aristofane 285
in un’altra circostanza, provai invece un dolore ... tragico: aspettavo a bocca aperta la rappresentazione di un dramma di eschilo, quand’ecco l’araldo proclamò: “teognide, porta in scena il coro”. Puoi immaginare che colpo al cuore! in un’altra occasione fui felice: quando si presentò in scena Dessiteo per cantare la melodia beotica “per il vitello”. Quest’anno, invece, mi è parso di morire, mi si sono strabuzzati gli occhi quando ho vi-sto spuntare cheride per cantare l’acuta melodia. (trad. G. mastromarco)
le diverse esperienze, scandite dagli avverbi temporali (e{teron, e{teron, th'te", “in un’altra circostanza”, “in un’altra ancora”, “quest’anno”), si riferiscono chiaramente a tre eventi agonistici, due più lontani, uno più vicino nel tempo.
la menzione, a proposito del primo evento, di un dolore “da tra-gedia” (tragw/dikovn28) e dei due tragediografi, l’atteso eschilo e il poco dotato teognide, impongono l’identificazione con un agone drammatico; l’espressione dell’araldo (ei[sag∆, w\ Qevogni, to;n corovn, “conduci, teognide il coro”), rinvierebbe, in particolare, come so-stiene la quasi totalità dei commentatori29, alla cerimonia del pro-agone, preliminare alle Dionisie, che non si svolgeva in teatro pri-ma delle rappresentazioni, ma nell’Odeion, e prevedeva la parata dei poeti davanti al pubblico, col coro e gli attori, per anticipare le trame delle loro opere. un’espressione identica a quella utilizza-ta da aristofane compare difatti nella Vita di Euripide (p. 3, 11 ss. schwartz): in occasione della sua morte, è scritto, sofocle si presentò con un manto scuro e “introdusse al proagone gli attori e il coro senza la corona” (to;n de; coro;n kai; tou;" uJpokrita;" ajstefanwvtou" eijsagagein ejn tw/ proagwni)30. a proposito dei versi in questione, è bene ricordare che, quando furono rappresentati gli Acarnesi, eschi-lo era morto da più di trent’anni, ma alcune fonti, tra cui lo scolio al presente passo, riferivano di un decreto che prescriveva che i suoi drammi continuassero ad essere rappresentati alle Dionisie31. il pas-
28 cfr. olson 2002, p. 68: “the ambiguity (both ‘fit for a tragedy’ and ‘con-nected with tragedy’) is deliberate”.
29 ma cfr. Petersen 1862, pp. 665-666; leo 1878, p. 404; starkie 1979, p. 11: “eijsavgein means ‘to lead into the theatre’ through the side entrance of the orchestra”.
30 sul proagone cfr., tra gli altri, mazon 1903; Pickard-cambridge 1996, pp. 93-95.
31 Vd. schol. ad loc. timh'" de; megivsth" e[tuce para; ∆Aqhnaivoi" oJ Aijscuvlo", kai; movnou aujtou' ta; dravmata yhfivsmati koinw/' kai; meta; qavnaton ejdidavsketo e cfr. anche Ran. 838 e schol. ad loc.; Philostr. Vit. Apoll. 6, 11, 129-132 ∆Aqhnai'oi
286 Alessandra Manieri
so, dunque, è stato ampiamente discusso32 in merito alla questione riguardante le rappresentazioni postume delle tragedie di eschilo: se esse avessero luogo alle Dionisie cittadine già alla fine del V secolo e come si inserissero nei contesti agonali, in competizione con i poe-ti viventi, ovvero come repliche fuori gara, introdotte per onorare la memoria dell’indimenticato poeta. l’apparizione di teognide al posto di eschilo descritta da aristofane ha difatti creato non pochi problemi ai commentatori. c’è chi ha ipotizzato (come rogers33) che Diceopoli alludesse qui all’esito del sorteggio34 che si effettua-va durante il proagone e regolava l’ordine delle rappresentazioni (la tragedia di teognide, dunque, sarebbe stata sorteggiata prima di quella di eschilo); ovvero, chi ha proposto (vedi mastromarco)35
patevra me;n aujto;n th'" tragw/diva" hJgou'nto, ejkavloun de; kai; teqnew'ta ej" Dionuvsia, ta; ga;r tou' Aijscuvlou yhfisamevnwn ajnedidavsketo kai; ejnivka ejk kainh'"; Vita Aesch. 12 ∆Aqhnai'oi de; tosou'ton hjgavphsan Aijscuvlon wJ" yhfivsasqai meta; to;n qavnaton aujtou' to;n boulovmenon didavskein ta; Aijs cuvlou coro;n lambavnein; Quint. 10, 1, 66 correctas eius fabulas in certamen deferre posterioribus poetis Athenienses permiserunt, suntque eo modo multi coronati.
32 cfr. Del corno 1956; Di marco 1992; mastromarco 1994; Pickard-cambridge 1996, pp. 119 e 137; mastromarco 1997; Pretagostini 2003, pp. 96-100; Biles 2006-07.
33 Vd. rogers 1910, p. 4. Per la debolezza di quest’ipotesi cfr. mastromarco 1997, p. 544.
34 al momento del sorteggio nel proagone aristofane fa invece riferimento in un passo delle Ecclesiazuse (vv. 1157-1162), che citiamo per un’interessante pecu-liarità: il poeta, svantaggiato dal sorteggio effettuato durante la cerimonia prelimi-nare che stabiliva l’ordine di esibizione delle opere teatrali, invita i giudici a non penalizzare la sua commedia: “fate che il sorteggio non sia un danno, perché mi è toccato di venire per primo nell’agone… non imitate le abitudini delle donne di malaffare che si ricordano sempre degli ultimi amanti”. Questa raccomandazione poteva essere inserita nella commedia solo quando aristofane, dopo il proagone, aveva appreso l’esito del sorteggio e costituisce una delle testimonianze più signifi-cative della revisione o meglio di un’aggiunta all’ultimo momento al testo teatrale.
35 mastromarco 1997: ricordiamo, tuttavia, che teognide era un tragediogra-fo lui stesso, pur “frigido” (cfr. yucrov" in Thesm. 170) e scarsamente capace, tanto da essere soprannominato “neve” per la frigidità delle sue opere, come informa lo scolio (schol. Ach. 11 Qevogni" de; ou|to" tragw/diva" poihth;" pavnu yucrov", ei|" tw'n triavkonta, o}" kai; ciw;n ejlevgeto). Questo ci fa supporre che egli si pre-sentasse in gara con una sua tragedia e un suo coro: allo stesso evento agonistico forse aristofane allude poco più avanti negli stessi Acarnesi, quando menziona teognide che, con la sua poesia dagli effetti “congelanti”, simile ai rigori clima-tici della tracia, prendeva parte agli agoni di atene (vv. 138-140: “se la neve non avesse coperto tutta la tracia e gelato tutti i fiumi…proprio mentre teognide qui partecipava agli agoni”, ejnqadi; Qevogni~ hjgwnivzeto).
Gli agoni musicali in Aristofane 287
che teognide fosse, nella circostanza specifica, l’incapace regista di una tragedia eschilea e per questo avesse causato la delusione di Di-ceopoli; o ancora (così Di marco)36, che le repliche di eschilo, che dovevano inaugurare fuori gara la prima giornata degli agoni tragici, fossero state temporaneamente sospese, all’insaputa di Diceopoli, per ragioni economiche connesse alla Guerra del Peloponneso. non intendiamo, in questa sede, prendere parte a questo dibattito, ma semmai suggerire come il passo degli Acarnesi potrebbe non rap-presentare, per tale questione, una fonte così rilevante, o addirit-tura determinante37, come è stata ritenuta sinora. ora, ci sembra che niente, nella narrazione aristofanesca, autorizzi a pensare che la rappresentazione di una tragedia di eschilo, in quella specifica circostanza agonistica, fosse una possibilità concreta e non piuttosto solamente immaginata nella mente di Diceopoli: l’atteggiamento del protagonista che, durante il proagone, se ne sta, come letteralmente egli dice, “a bocca aperta aspettando eschilo”, sembra descrivere, al di fuori di ogni complicazione, lo stordito disorientamento del contadino, sradicato dai suoi campi e trapiantato ad atene in una realtà che poco conosce: egli, difatti, è uno dei numerosi abitanti dei demi rurali, inurbati forzatamente, per volontà di Pericle, durante la Guerra archidamica, fenomeno attestato da tucidide e indagato, in un articolo del 1989, dal compianto roberto Pretagostini38 proprio sulla base delle commedie di aristofane e degli Acarnesi in partico-lare. in questo senso, confessando la sua delusa “attesa” di eschilo, Diceopoli svelava al pubblico, attraverso una sorta di autoironia, la propria ignoranza: egli, assistendo, forse per la prima volta, alle Grandi Dionisie (il suo racconto evoca difatti un evento trascorso da tempo), aspettava ingenuamente la riproposta di un dramma di eschilo, cosa che, probabilmente, poteva avvenire senza problemi alle Dionisie rurali39, che il contadino ben conosceva e a cui nostal-
36 Di marco 1992: Diceopoli sarebbe dunque rimasto deluso nel “vedere ino-pinatamente interrotta una prassi che si era venuta consolidando negli anni pre-cedenti, quella per cui la prima giornata dedicata agli agoni tragici si apriva ormai regolarmente con una tragedia eschilea” (la citazione è tratta da p. 71).
37 cfr. slater 1990, p. 394: “Were it not for the evidence of aristophanes in Acharnians 10 ... we might suspect that the tradition of reperformances of ai-schylos in the fifth century was a projection backward of later practice”.
38 Vd. thuc. 2, 13 ss. e cfr. Pretagostini 1989.39 Per le repliche alle Dionisie rurali di drammi rappresentati alle Grandi
288 Alessandra Manieri
gicamente ripensava40. la ridicola mimica facciale descritta dal pro-tagonista è dunque espressione del suo straniamento nei confronti della realtà contingente: nella stessa accezione cavskw ritorna nei Cavalieri (v. 1032) e nella Lisistrata (v. 426): “che stai a bocca aperta, imbecille?”. così la voce dell’araldo, che annuncia al proagone la sfilata del frigido teognide, ricordato poco più avanti, nella stessa commedia, per gli effetti congelanti della sua poesia41, segnerebbe, per il povero contadino, l’amaro impatto con la nuova realtà42.
Dopo dunque la delusione provata dinanzi all’apparizione di teognide, Diceopoli confessa di essere stato gratificato, in un’altra circostanza, dall’esibizione di Dessiteo che concorreva intonando (a/jsovmeno~) un novmo~ Boiwvtio~. la natura dell’esibizione (il can-to di un nomos) e la descrizione di Dessiteo proposta dagli scolî (Dexivqeo" a[risto" kiqarw/do;" kai; puqionivkh") consentono di col-locare l’evento durante una gara di citarodia alle Grandi Panatenee, unico contesto per gare di questo genere ad atene. com’è noto, il concorso di citarodia rivestiva il ruolo più rilevante nell’intero ago-ne musicale delle Panatenee: i citarodi, unici tra le altre categorie di concorrenti, ricevevano cinque premi e tutti di notevole entità, come attesta un’epigrafe degli inizi del iV secolo (IG ii2 2311): il primo una corona d’oro di 1000 dracme e 500 dracme in denaro; il secondo 1200 dracme; il terzo 600 dracme; il quarto 400 dracme; il quinto 300 dracme. improponibile dunque la traduzione del nesso ejpi; movscw/, nel passo in questione, con l’espressione “per il vitello”, come se fosse il premio designato per la gara cui partecipò Dessiteo, pur suggerita da uno scolio e da alcuni accettata43. alle Panatenee il bue è il premio attribuito ai vincitori di pirrica44 e probabilmente
Dionisie, cfr. Vitucci 1939; Pickard-cambridge 1996, p. 63 ss.; Di marco 1992, pp. 56-57. Difficile che l’episodio cui qui si fa riferimento possa essersi svolto direttamente alle Dionisie rurali e ciò soprattutto per la difficoltà di una loro rego-lare celebrazione durante la guerra: vd. oltre e cfr. Di marco 1992, p. 57.
40 Poco più avanti nella stessa commedia, difatti, dopo aver negoziato la sua pace personale con gli spartani, Diceopoli sarebbe corso nei campi ad organizzar-ne una celebrazione.
41 Vd. sopra, n. 35.42 cfr. Biles 2006-07, p. 225: “Dikaiopolis has been rudely and abruptly sha-
ken from a reverie by the herald’s cry”.43 Schol. Ach. 13a o{ti oJ nikhvsa" a\qlon ejlavmbane movscon. Vd. Bentley
1758, p. 218; Wheelwright 1837; maas 1899.44 IG ii2 2311, 72-74.
Gli agoni musicali in Aristofane 289
anche alla tribù vincitrice nell’eujandriva45, ma a nessuna delle gare musicali. non è certa neanche l’assegnazione di un toro come pre-mio per le gare ateniesi di ditirambo: le numerose testimonianze che comprovano l’attribuzione ai vincitori di ditirambo di questo tipo di premio non si riferiscono a contesti ateniesi46. ridicola poi la proposta di clark47 secondo cui Dessiteo si sarebbe presenta-to in scena “sopra” un vitello, cioè a cavallo di esso: non biso-gna dimenticare che Dessiteo sta per prendere parte ad una gara citarodica e non ad uno spettacolo comico! non convince nean-che l’ipotesi, tra l’altro completamente ignorata dallo scolio, che ritiene il vitello argomento del canto beotico48. Dessiteo si esibisce dunque “dopo mosco”, come correttamente è inteso da molti49, anch’egli citarodo, proveniente da agrigento, ma di scarso valore, secondo la testimonianza degli scolî 50: da ciò, stavolta, la consola-zione di Diceopoli al canto di Dessiteo: se prima era stato infasti-dito dall’apparizione di teognide mentre aspettava una tragedia di eschilo, ora si rallegra che ad un pessimo citarodo come mosco ne segua un altro di gran lunga più dotato51!
ma il colpo finale alle disgrazie di Diceopoli è inferto dalla recente esibizione di cheride con il novmo~ o[rqio~, avvenuta pro-
45 IG ii2 2311, 75-76, ma vd. aristot. Ath. pol. 60, 3 e[sti ga;r a\qla toi'" me;n th;n mousikh;n nikw'sin ajrguvrion kai; crusa', toi'" de; th;n eujandrivan ajspivde", toi'" de; to;n gumniko;n ajgw'na kai; th;n iJppodromivan e[laion.
46 cfr. Pickard-cambridge 1996, pp. 108-109; ieranò 1997, pp. 70-71; 247; 271-272.
47 clark 1879, p. 181: “Dexhiteus dressed as a rustic came upon the stage mounted on a young bull or heifer”.
48 così invece landfester 1970; mastromarco 1983, p. 73 (“è naturale che il contadino Dessiteo, che si strugge per il suo demo campestre, vada in estasi per la melodia ejpi; movscw/”); thiercy 1997, p. 991; Henderson 1998, p. 59.
49 cfr. coulon-van Daele 1923, p. 12; russo 1953, ad loc.; cantarella 1972, ad loc.; sommerstein 1980, p. 41; olson 2002, pp. 69-70; Pretagostini 2003, pp. 100-101.
50 Schol. Ach. 13a e b ou|to" oJ Movsco" fau'lo" h\n kiqarw/do;" ∆Akraganti'no".
51 l’interpretazione, rileva olson (2002, ad loc.), ben si adatta al contesto. Vd. anche starkie 1979, p. 11; Pretagostini 2003, p. 101: “una volta stabilito che il testo corretto è ejpi; Movscw/, cioè quello che prevede la presenza del nome proprio, non mi sembra affatto da escludere che aristofane, ponendo queste parole in bocca al vecchio contadino Diceopoli, fosse ben conscio di poter sfruttare il possibile fraintendimento Movsco"É movsco" a livello di ricezione da parte del pubblico”.
290 Alessandra Manieri
babilmente alle Panatenee svoltesi nello stesso anno della rappre-sentazione degli Acarnesi (cfr. th'te" nel passo), dunque nell’eca-tombeone (agosto) del 426. cheride è menzionato tre altre volte da aristofane (negli stessi Acarnesi, nella Pace e negli Uccelli 52), sempre come prototipo di pessimo auleta. Di un cheride auleta parlava, secondo lo scolio agli Uccelli, anche cratino nella Nemesi 53. auletica dovette essere dunque l’esibizione del nomos critica-ta in questo passo, nonostante i dubbi generati dalle contrastanti notizie degli scoliasti che ora propongono per cheride una duplice specialità artistica (egli sarebbe stato sia citarodo che auleta54) ora riferiscono dell’esistenza di due diversi musici, un cheride citaro-do e un cheride auleta55. Queste notizie contrastanti si svilupparo-no, probabilmente, per due ragioni:
1. Per inferenza dal testo: dopo Dessiteo, citarodo che intona il nomos Boiotios, anche cheride, menzionato subito dopo, è imma-ginato come un citarodo che intona il nomos orthios. ma, come è chiaro dal contesto, gli agoni a cui i due musici partecipano sono diversi e non presuppongono la stessa specialità musicale; l’orthios, inoltre, può essere sia citarodico che auletico56.
2. Per deduzione da un frammento di ferecrate (fr. 6 K.-a.), tramandato dallo scolio al passo degli Uccelli 57 che menziona
52 Ach. 862 e 866 Qeivbaqen aujleitai; pavra, … ejpi; th;n quvran moi Cairidh'" bombauvlioi; Pax 951-952 Cai'ri" … provseisin aujlhvswn; Av. 858 sunauleivtw de; Cai'ri" w/jda/'.
53 Schol. Av. 858 aujlhthv", ou| mnhmoneuvei Krati'no" ejn Nemevsei (fr. 126 K.-a.).
54 Schol. Ach. 16a ou|to" kiqarw/do;" kai; aujlw/do;" fau'lo". Vd. anche 16b.55 Schol. Pac. 951a-b oJ Cai'ri" aujlhth;" ejpi; tai'" qusivai"… h\n de; kai; e{tero"
kiqarw/dov".56 Per l’orthios come nomos citarodico, vd. Herodot. 1, 24, 5; aristoph. Eccl.
741; Ps. Plut. Mus. 28; Suid. s.v. o[rqio" novmo": oJ kiqarw/diko;" th'" aJrmoniva"; per l’orthios come nomos auletico vd. schol. Ach. 16; schol. Equ. 8-10; Poll. 4, 65; Suid. s.v. Timovqeo": …Timovqeo" ga;r oJ aujlhth;" e[ti provsqen, o{n pote aujlou'nta levgousi th'" ∆Aqhna'" to;n o[rqion novmon ejpikalouvmenon. aristofane è così sicuro della familiarità del pubblico con questo genere di nomos che, per ben due volte (Av. 489 e Eccl. 741), si diverte con il gioco di parole o[rqrio" novmo": vd. fle-ming 1977, p. 224. Pretagostini (2003, p. 103) ipotizza che cheride abbia tentato la ‘traduzione’ del nomos orthios di tipo citarodico in una melodia auletica.
57 Schol. Av. 858 h\n de; (oJ Cai'ri" ou|to") kiqarw/do;" yucro;" kai; gevgo
Gli agoni musicali in Aristofane 291
cheride, in cui il musico sembrerebbe essere un citarodo: “… su, vediamo: chi è stato il peggior citarodo? – melete figlio di Pisia, e dopo melete ci fu … – sta buono, lo so io: cheride!”58. Win-nington-ingram59 definisce il frammento ferecrateo di valore ine-stimabile, perché offrirebbe “una testimonianza di prima mano di cheride come citarodo e, insieme, auleta”. l’esiguità dei versi non consente, tuttavia, di trarre conclusioni certe da questo frammen-to: si potrebbe persino ipotizzare la ricerca di un voluto effetto comico, per noi non evidente ma chiaro ai contemporanei, nella menzione, da parte di ferecrate, di un pessimo auleta, laddove il pubblico aspettava di sentire il nome di un pessimo citarodo. Questo anche perché la duplice specialità, pur evidentemente pos-sibile, per un musico antico, nella citarodia e nell’auletica, non era consueta né ampiamente attestata60.
resterebbe l’altra proposta degli scolî circa l’esistenza dei due musici con lo stesso nome, un citarodo e un auleta. ma pur vo-lendo dar fede a questa informazione, non ci sarebbe comunque ragione di credere che aristofane alludesse al citarodo solo nel prologo degli Acarnesi, si riferisse invece all’auleta negli altri passi delle sue commedie e, in particolare, poco più avanti negli stessi Acarnesi (vv. 860-866):
BO. “Ittw ÔHraklei'", e[kamovn ga ta;n tuvlan kakw'". Katavqou tu; ta;n glavcwn∆ ajtrevma", ∆Ismeiniva:uJme;" d∆, o{soi Qeivbaqen aujleitai; pavra,toi'" ojstivnoi" fusei'te to;n prwkto;n kunov".DI. Pau'∆: ej" kovraka". OiJ sfh'ke", oujk ajpo; tw'n qurw'n;Povqen prosevptonq∆ oiJ kakw'" ajpolouvmenoi ejpi; th;n quvran moi Cairidh'" bombauvlioi;
[Da una parodo entra un tebano seguito da un servo e da auleti che suonano in modo assordante]
nen aujlhthv". mnhmoneuvei de; aujtou' kai; Ferekravth" ejn ∆Agrivoi": “fevr∆ i[dw kiqarw/do;" tiv" kavkisto" ejgevneto; É oJ Peisivou Mevlh". meta; de; Mevlhta tiv"; / e[c∆ ajtrevm∆, ejgw/\da, Cai'ri"” (fr. 6 K.-a.). e[sti kai; e{tero" aujlhthv", ou| mnhmoneuvei Krati'no" ejn Nemevsei (fr. 126 K.-a.).
58 Per la traduzione e l’analisi del frammento di ferecrate vd. Quaglia 2005, pp. 124-130.
59 cfr. Winnington-ingram 1988, p. 252.60 non troviamo esempi nei cataloghi beotici, che pur comprovano la vittoria
degli stessi artisti in diverse specialità musicali.
292 Alessandra Manieri
Beota Per eracle, come mi fa male la gobba! ismenia, metti giù la menta: fa’ piano. e voi tutti, flautisti di tebe, andate a soffiare con le vo-stre tibie nel culo di un cane.
DiceoPoli [uscendo di casa] Basta, alla malora! allontanatevi da questa porta, vespe. ma da dove mi è piombato sulla porta di casa questo sciame di calabroni, rampolli di cheride? Possano fare una brutta fine. [i flautisti si allontanano] (trad. G. mastromarco)
Qui Diceopoli scaccia in malo modo un gruppo di auleti tebani, informandosi con fastidio della loro provenienza, tra l’altro ben documentata dal contesto61, e li definisce, in senso dispregiativo, sfh`ke~, “vespe”, e Cairidh`~ bombauvlioi, “auleti-calabroni ram-polli di cheride”. il passo è interessante per vari motivi: intanto suggerisce che il cheride qui ricordato come “capostipite” degli auleti non può che essere lo stesso cheride menzionato nel pro-logo, il quale, con la sua esibizione (dunque sempre auletica) alle Panatenee, per poco non gli aveva causato un colpo apoplettico (ajpevqanon kai; diestravfhn): quello di prendersi gioco più volte degli stessi personaggi, ben noti al pubblico, è espediente consueto dei comici e qui aristofane ride dunque di nuovo di cheride, come in precedenza era tornato a burlarsi di teognide62. risulta chiaro, inoltre, che il disprezzo manifestato da Diceopoli in questo passo si estenda dal musico rappresentante (cheride) e dallo strumento musicale utilizzato (l’aulo), denigrato attraverso espressioni volgari (v. 862 e anche oltre, vv. 868-869), all’arte dell’auletica in generale, fastidiosa come i ronzii dei calabroni63, sino a coinvolgere l’intera Beozia, ritenuta patria della disciplina e della gran parte dei musici che la praticavano. in un periodo di complicate relazioni tra atene e tebe, il passo di aristofane dimostra, dunque, come l’ostilità de-gli intellettuali ateniesi nei confronti dell’auletica64, da varie fonti
61 non mancano, p. es., nel passo, espliciti riferimenti geografici (la Beozia: vv. 859; 872; 874; tebe: 863; 868; la palude copaide: 880) e usi linguistici del dialetto beotico (cfr. i[ttw per i[stw; glavcwn∆ per blhvcwn∆; uJmev" per uJmei`"; Qeivbaqen per Qhvbaqen). Per altri dettagli che attestano la provenienza beotica degli auleti cfr. olson 2002, pp. 287-288.
62 Vd. sopra, n. 35.63 le parole di Diceopoli contengono una chiara allusione alla pratica dello
sfhkismov~ così definita da esichio, s.v.: ei\do" aujlhvsew" eijrhmevnon ajpo; th'" ejmfereiva" tw'n bom(b)w'n. Vd. Pintacuda 1982, pp. 21-22 (che erroneamente at-tribuisce il riferimento ad esiodo).
64 sull’argomento vd. manieri 2009, pp. 18-21; 283.
Gli agoni musicali in Aristofane 293
attestata, associasse a motivazioni culturali anche ragioni politiche. non era un caso che, alle Panatenee, i premi riservati agli aulodi e agli auleti fossero di gran lunga inferiori rispetto a quelli concessi per altre specialità musicali65, in maniera ben diversa di quanto invece avveniva, p. es., presso gli agoni della Beozia66.
tra i più rilevanti eventi che hanno causato forti emozioni a Diceopoli sono annoverati, dunque, tre agoni musicali, il primo drammatico, il secondo citarodico, il terzo auletico, che salgono a quattro se, come alcuni commentatori propongono67, anche il riferimento iniziale a cleone68 ricorda non un evento realmente accaduto ma una scena dei Babilonesi rappresentati alle Dionisie nel 426. così non è un caso che saranno ancora gli agoni ad accom-pagnare e a scandire lo svilupparsi delle vicende anche nel resto della commedia.
Quando, difatti, Diceopoli negozia con gli spartani la sua pace trentennale, può recarsi tranquillo, a differenza degli altri ateniesi, a celebrare le sue Dionisie rurali, che, evidentemente, da ben sei anni (cioè dall’inizio della guerra con sparta, che aveva provoca-to l’inurbamento dei contadini) non avevano potuto avere libero svolgimento nei demi dell’attica sottoposti a continue incursioni: “io dunque (dice ai vv. 201-202, in contrasto con tou;~ ∆Acarneva~ del v. precedente), liberatomi dalla guerra e dalle sventure, mi re-cherò a celebrare le Dionisie rurali” (ejgw; de; polevmou kai; kakw'n ajpallagei;" / a[xw ta; kat∆ ajgrou;" eijsiw;n Dionuvsia)69. e più avanti
65 nel catalogo sopra citato (IG ii2 2311) sono attribuiti agli aulodi e agli auleti solo due premi (rispetto ai cinque per i citarodi); i premi per gli aulodi (non sono pervenuti quelli per gli auleti) sono, rispettivamente, di 300 e di 100 dracme: il primo premio è dunque inferiore a quello dell’ultimo citarodo premiato (400 dracme, vd. sopra).
66 Vd. manieri 2009, pp. 265-266; 268-272.67 Vd. discussione in Pretagostini 2003, pp. 95-96.68 Ach. 5-6.69 lo scolio al v. 202 commenta: a[xw ta; kat∆ ajgrouv": ta; Lhvnaia legovme
na. e[nqa kai; oJ ejpilhvnaio" ajgw;n telei'tai tw/' Dionuvsw/. Lhvnaion gavr ejstin ejn ajgroi'" iJero;n tou' Dionuvsou dia; to; plektou;" lhnou;" ejntau'qa gegonevnai, “mi recherò a celebrare le Dionisie rurali: si tratta delle lenee. la festa con questo nome e l’agone che si svolge in occasione delle lenee sono consacrati a Dioniso. esiste infatti un tempio rurale di Dioniso chiamato leneo”. lo scolio è fondamen-tale per la storia delle lenee (vd. Pickard-cambridge 1996, p. 51 ss.), che in tal modo verrebbero collocate ejn ajgroi'", in contrasto con altre testimonianze che le collocherebbero in città (vd., p. es. Hesych. ejpi; Lhnaivw/ ajgwvn: e[stin ejn tw`/ a[stei
294 Alessandra Manieri
(v. 247 ss.) “che bello … celebrare felicemente le Dionisie rurali, ormai liberato dalla guerra”; e ancora, mentre procede nella sua processione (v. 263 ss.): “falete amico di Bacco, … dopo sei anni ti saluto … sono libero dai guai, dalla guerra, da tutti i lamachi”.
Quando, ancora oltre, Diceopoli, vestiti i panni di telefo, si pre-senta a difendere la sua causa e dinanzi agli acarnesi del coro e, a nome dello stesso aristofane, dinanzi al pubblico del teatro, il poeta, identificando realtà e finzione, ricrea il momento agonistico concreto della messinscena degli Acarnesi, l’hic et nunc della rap-presentazione che avviene durante le lenee, nel periodo inverna-le70, in presenza solo di cittadini e meteci (vv. 504-508): “siamo tra noi, l’agone è quello lenaico: non sono ancora presenti e non sono ancora arrivati né i tributi né gli alleati dalle loro città”.
infine, nelle ultime scene (vv. 960-962; 1000-1002; 1085c-1093b), mentre si alternano le visite dei concittadini rovinati dalla guerra e lamaco parte in battaglia per poi ritornare ferito dai combattimenti, Diceopoli partecipa ad un’altra festa dionisiaca, le antesterie, e ad uno degli agoni71 che la caratterizzavano: la gara dei “Boccali”. la gara, pur evidentemente non di natura musicale, attraverso la men-zione dei diversi elementi agonistici che la caratterizzavano (il sacer-dote di Dioniso, il premio, l’arconte re, i giudici, la vittoria finale) è chiaramente allusiva alla speranza del poeta per la propria vittoria72.
Dall’inizio sino alla conclusione della commedia, dunque, men-tre la guerra porta lentamente gli ateniesi verso la rovina, Diceopo-
Lhvnaion perivbolon e[con mevgan kai; ejn aujtw/' Lhnaivou Dionuvsou iJerovn, ejn w/| ejpetelou'nto oiJ ajgw'ne" tw'nÌ Lhnaivwn, pri;n to; qevatron oijkodomhqh'nai, “l’ago-ne nel leneo: in città c’è un leneo con un grande recinto, e in esso un tempio in onore di Dioniso leneo; fu sede degli agoni delle lenee prima della costruzione del teatro”). in realtà qui lo scolio ad aristofane commette un errore, probabil-mente pensando che questo momento agonistico e il riferimento, più avanti nella stessa commedia, all’agone leneo (v. 504 ss.) siano parte della stessa manifestazio-ne, qui la pomphv e la qusiva, lì l’ajgwvn vero e proprio (l’ipotesi è in Deubner 1932, p. 124). ma è evidente che si tratta di due agoni diversi, in due momenti diversi della commedia: qui Diceopoli è in campagna, dopo la tregua trentennale; l’auto-difesa davanti al coro è invece successiva all’incontro con euripide.
70 Per la festa primaverile delle Grandi Dionisie, vd. Nub. 311 ss. 71 Per lo svolgimento delle antesterie, vd. Pickard-cambridge 1996, pp. 1-34,
e in particolare pp. 23-24 per gli ajgw`ne" cuvtrinoi, il cui vincitore acquisiva il diritto di partecipare alle Grandi Dionisie.
72 cfr. ehrenberg 1957, p. 50.
Gli agoni musicali in Aristofane 295
li, grazie alla sua pace ‘separata’, ha potuto regolarmente continua-re con la celebrazione dei suoi agoni. Gli agoni rappresentano, di fatto, nella commedia, il contraltare delle vicende belliche e scandi-scono, nella loro attenta successione cronologica, l’anno del prota-gonista e del comune cittadino ateniese in tempo di pace: prima le Grandi Dionisie, in primavera (durante l’elafebolione, marzo-apri-le), con l’esibizione drammatica di teognide, poi le Grandi Panate-nee, in estate (durante l’ecatombeone, giugno-luglio), con gli agoni citarodici ed auletici, poi ancora, in sequenza rapida, le altre feste dionisiache, le Dionisie rurali nel mese di Posideone (novembre-dicembre), le lenee nel Gamelione (dicembre-gennaio), le anteste-rie, nel mese di antesterione (gennaio-febbraio). il coro commenta, rivolto a lamaco: “Quanto diverse le vostre strade: lui va a bere coperto di corone, tu a soffrire il freddo e a fare la guardia”.
non è un caso, dunque, che la dea Pace, nell’omonima comme-dia, quando grazie a trigeo sta per riconquistare la sua libertà, esca dalla caverna, in cui Polemos l’aveva rinchiusa, in compagnia di due incantevoli fanciulle, opora, l’“abbondanza”, e theoria, la “festa”. theoria, qui, deve essere intesa nella sua accezione più ampia, com-prendente sia gli eventi rituali e agonistici che hanno luogo nella città di atene, sia l’invio di delegati ateniesi agli agoni che avevano luogo nel resto della Grecia73. se la Guerra puzza “di rutti di cipolle con aceto” (le cipolle sono anche il pasto di lamaco, negli Acarnesi, in procinto di partire per la guerra), la Pace, che si accompagna alla festa, odora di “abbondanza, di ospitalità, di Dionisie, di flauti, di tragedie, di canti sofoclei, di tordi, di versetti euripidei”74. senza la Pace, “signora dei cori75” e “amante delle feste”76, non v’è dun-que prosperità (ojpwvra) né accoglienza degli stranieri (uJpodochv) né agoni: le Dionisie qui menzionate rappresentano tutte le feste ateniesi77, nella loro componente sia agonistica (aujlw'n, tragw/dw'n,
73 Vd. sommerstein 1985, p. 157: “Greek theoria, which can be taken to mean either: 1) a public spectacle-event of any kind (e.g. a theatrical performance, a religious procession, an athletic contest) or 2) a delegation sent to represent a state at one of the panhellenic festivals such as the olympic games”.
74 Pax 530-532 ojpwvra", uJpodoch'", Dionusivwn, / aujlw'n, tragw/dw'n, Sofoklevou" melw'n, kiclw'n, / ejpullivwn Eujripivdou.
75 Vd. Pax 976.76 Vd. Thesm. 1147.77 Vd. ieranò 1997, p. 244 e n. 42; olson 2002, p. 185.
296 Alessandra Manieri
Sofoklevou" melw'n, … ejpullivwn Eujripivdou78) sia simposiale (kiclw'n) 79.
le ripercussioni negative delle vicende belliche e della crisi eco-nomica anche sulle manifestazioni agonistiche erano d’altronde fatti ben noti ad aristofane: il passo degli Acarnesi sopra citato (v. 263 ss.) alludeva alla difficoltà di celebrare le Dionisie rurali nei demi, durante gli anni della guerra archidamica; nella fase successiva della guerra, e proprio nel periodo in cui furono rappresentate la maggior parte delle commedie di aristofane, dal 425 (anno della rappresen-tazione degli Acarnesi) sino al 405 (anno della rappresentazione del-le Rane), a causa della crisi finanziaria, il numero delle commedie partecipanti ai concorsi comici fu ridotto da cinque a tre80; verso la conclusione della guerra, nel 406-405, sempre per ragioni finan-ziarie, fu necessario ripartire le spese di ciascuna coregia, sia per la tragedia che per la commedia, fra due sincoreghi81. furono forse tali misure di economia a rendere necessaria l’emanazione del decreto che imponeva la riduzione dei compensi per i commediografi, cui lo stesso aristofane allude nelle Rane (v. 367), criticando chi “es-sendo uomo politico, divora il salario dei poeti” (tou;" misqou;" tw'n poihtw'n rJhvtwr w]n ei\t∆ ajpotrwvgei) o a richiedere un risparmio ai coreghi anche sulle spese dei costumi, come sembrerebbe suggerire lo scolio ad un passo, sempre delle Rane (v. 403 ss.), in cui il coro dice: “iacco ... sei stato tu a fare a pezzi, per scherzo e per economia, questi poveri sandali e questi stracci, e sei stato tu a trovare il modo per farci scherzare e danzare senza spesa”82.
78 È chiaro il riferimento alle gare drammatiche, ditirambiche, musicali. Vd. anche, in Nub. 311-313, la descrizione della festa primaverile delle Dionisie: h\riv t∆ ejpercomevnw/ Bromiva cavri" / eujkelavdwn te corw'n ejreqivsmata / kai; mou'sa baruvbromo" aujlw'n, “quando giunge primavera, è la festa di Bromio, e contese di cori melodiosi e suoni profondi di flauti”, con chiara allusione alle gare ditirambi-che, oltre che a quelle drammatiche.
79 ma sommerstein (1985, ad loc.) riconduce anche questo termine ad un contesto agonistico, vedendovi un’allusione al banchetto concesso dal corego ai coreuti al termine delle manifestazioni.
80 cfr. Pickard-cambridge 1996, pp. 90 e 115 e hypoth. Ach., Equ., Vesp., Ran. per le lenee e Nub., Pax, Av. per le Dionisie. Vd. anche mastromarco 1975, il quale dimostra che, solo per il periodo tra 420 e 416, si tornò alla rappresentazione di cinque commedie.
81 cfr. Pickard-cambridge 1996, p. 120 e vd. schol. Ran. 404.82 Ran. 404-409 “Iakce filocoreutav, sumprovpempev me. / Su; ga;r kates
Gli agoni musicali in Aristofane 297
sicuramente, come molti studiosi si sono sforzati di dimostra-re83, le ragioni che portarono alla decadenza delle parti corali nelle ultime commedie di aristofane, le Ecclesiazuse e il Pluto, vanno aldilà di motivazioni esclusivamente economiche, che avrebbero causato, tra l’altro, la progressiva mancanza dei coreghi. una simi-le relazione (soppressione dei cori–mancanza dei coreghi), di certo – ripeto – non esaustiva del problema, è comunque rintracciabile nelle testimonianze antiche: come è detto in Platonio84,
vennero a mancare anche i coreghi: gli ateniesi infatti non avevano più voglia di eleggere i coreghi che sovvenzionassero le spese dei coreuti. Di conseguenza, aristofane mise in scena l’Eolosicone, nel quale mancano i canti del coro. Dal momento che i coreghi non venivano designati e i co-reuti non avevano il loro compenso, gradualmente scomparvero i canti co-rali e cambiarono anche gli intrecci delle commedie 85. (trad. f. Perusino)
ai tempi dell’ultimo aristofane, in ogni caso, il problema delle spese per la realizzazione di un agone musicale non dovette essere irrilevante, se si tiene conto, p. es., che, solo per i cori ditirambici di Dionisie e targelie, servivano ogni anno 30 coreghi che pagasse-ro le spese di 30 cori, costituiti ciascuno di 50 elementi, e che, per l’allestimento di un coro ditirambico per le Dionisie, si arrivava a spendere circa 5000 dracme, per le targelie 2000, per un concorso tragico almeno 3000, per uno comico 160086.
civsw me;n ejpi; gevlwti / kajp∆ eujteleiva/ tovde to; sandalivskon kai; to; rJavko", / kajxhu're" w{st∆ ajzhmivou" / paivzein te kai; coreuvein. Vd. schol. Ran. 404 e[oike de; paremfaivnein o{ti litw'" h[dh ejcorhgei'to toi'" poihtai'", “sembra indicare che gli allestimenti forniti dai coreghi ai poeti fossero già sottoposti a riduzione”. cfr. Phe-recr. fr. 199 K.-a. oJ coro;~ d∆ aujtoi~ ei\cen davpida~ rJupara;~ kai; strwmatovdesma.
83 Vd., tra gli altri, maidment 1935; Pintacuda 1982, pp. 99-100; Perusino 1987, p. 61 ss.; Pickard-cambridge 1996, p. 121 n. 187. ma cfr. Gevaert 1881, p. 562.
84 Platon. 22 ouj ga;r e[ti proqumivan ei\con oiJ ∆Aqhnai'oi tou;" corhgou;" tou;" ta;" dapavna" toi'" coreutai'" parevconta" ceirotonei'n. to;n gou'n Aijolosivkwna ∆Aristofavnh" ejdivdaxen, o}" oujk e[cei ta; corika; mevlh. tw'n ga;r corhgw'n mh; ceirotonoumevnwn kai; tw'n coreutw'n oujk ejcovntwn ta;" trofa;" uJpexh/revqh th'" kwmwidiva" ta; corika; mevlh kai; tw'n uJpoqevsewn oJ tuvpo" meteblhvqh. Vd. an-che schol. Ran. 404 crovnw/ d∆ u{steron ouj pollw/' tini kai; kaqavpax periei'le Kinhsiva" ta;" corhgiva": ejx ou| kai; Stravtti" ejn tw/' eij" aujto;n dravmati ejfh' skhnh' me;n tou' coroktovnou Kinhsivou.
85 Per un commento al passo vd. Perusino 1989, pp. 50-52.86 Vd. lys. 21, 1-5. come dimostra una recente indagine di Wilson (2008),
non dovette essere frutto di esagerazione retorica l’affermazione di Demostene
298 Alessandra Manieri
alla luce dunque di queste considerazioni, l’ultimo riferimento di aristofane alle manifestazioni agonistiche, in una delle scene fi-nali del Pluto, merita qualche osservazione conclusiva. Qui ermes, ormai ridotto alla fame dalla nuova ridistribuzione delle ricchezze operata da Pluto, chiede di essere accolto a lavorare nella casa di cremilo, pronto a svolgere uno qualsiasi dei cinque mestieri che gli competono in base ai titoli che egli possiede87. solo l’ultima propo-sta è ben accolta da carione, il servo di cremilo (vv. 1161-1164):
sarò dunque enagonios – dice ermes – giudice delle competizioni. sa-rebbe molto opportuno questo, da parte di Pluto: celebrare agoni ginnici e musicali (poiei`n ajgw`na~ mousikou;~ kai; gumnikouv~).
Questa affermazione, posta a conclusione dell’ultima commedia di aristofane, quella che riflette sulla povertà come problema atenie-se, sia economico che sociale88, acquista una valenza particolare alla luce del nostro excursus sulla continua riflessione di aristofane circa la realtà agonistica di cui egli stesso era parte. nel nuovo mondo do-minato da un Pluto che ha recuperato la vista, l’istituzione di nuovi agoni o la celebrazione rinnovata di quelli già esistenti meriterebbe sicuramente un ruolo di fondamentale privilegio. ma la concreta realtà di atene, privata dell’impero e prostrata dalle guerre – ari-stofane lo sa bene – è completamente differente dal mondo fiabesco immaginato nel Pluto e pura utopia è dunque il sogno di manifesta-zioni agonistiche splendide e solenni come quelle di un tempo.
(4, 35) secondo cui gli ateniesi spendevano più per le Dionisie che per una spe-dizione militare.
87 Plut. 1153 ss.: strophaios, empolaios, Dolios, Hegemonios e infine enagonios.88 Vd. sommerstein 2001, p. 5. l’affermazione non ha avuto nei commenti
particolare rilevanza: cfr. Konstan-Dillon 1995, p. 383: “Hermes’ skills and dupli-city were appropriate in the reign of scarcity; now, in the Kingdom of plenty, there is employment only for his marginal festive aspect”.
Gli agoni musicali in Aristofane 299
Bibliografia
Bentley 1758 r. Bentley, Dissertation on the Epistles of Phalaris, london 1758.
Biles 2006-07 Z.P. Biles, ‘aeschylus’ afterlife: reperformance by Decree in 5th c.
athens?’, Ill. Class. Stud. 31-32, 2006-07, pp. 206-242.
Bowie 1993 a.m. Bowie, Myth, Ritual and Comedy, cambridge 1993.
cantarella 1972 Aristofane, Le commedie, a cura di r. cantarella, torino 1972.
clark 1879 W.G. clark, ‘notes on aristophanes acharnians 1-578’, Journ. Philol.
8, 1879, pp. 177-200.
cole 1993 s.G. cole, ‘Procession and celebration at the Dionysia’, in r. scodel
(ed.), Theater and Society in the Classical World, ann arbor 1993, pp. 25-38.
coulon-van Daele 1923 Aristophane, Les Acharniens; Les Cavaliers; Les Nuées, texte établi par
V. coulon et traduit par H. van Daele, Paris 1923.
Del corno 1956 D. Del corno, ‘Pox 2256, 3 e le rappresentazioni postume di eschilo’,
Dioniso 19, 1956, pp. 277-291.
Del corno 1985 Aristofane, Le Rane, a cura di D. Del corno, milano 1985.
Deubner 1932 l. Deubner, Attische Feste, Berlin 1932.
Di marco 1992 m. Di marco, ‘“aspettando eschilo” (aristoph. Ach. 9-11): l’attesa
frustrata di Diceopoli e il problema delle riprese eschilee’, in l. De finis (ed.), Dal teatro greco al teatro rinascimentale: momenti e linee di evoluzione, trento 1992, pp. 53-72.
ehrenberg 1957 V. eherenberg, L’Atene di Aristofane, studio sociologico della comme
dia attica antica, trad. it. firenze 1957 (oxford 1951).
fleming 1977 t.J. fleming, ‘the musical nomos in aeschylus’ oresteia’, Class.
Journ. 72, 1977, pp. 222-233.
300 Alessandra Manieri
Gentili-Perusino 2002 B. Gentili - f. Perusino (edd.), Le orse di Brauron: un rituale di inizia
zione femminile nel santuario di Artemide (atti del seminario di stu-dio, urbino, 23-24 maggio 2000), Pisa 2002.
Gevaert 1881 f.a. Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l’antiquité ii, Gand
1881.
Henderson 1962 J. Henderson, L’antica musica greca, milano 1962.
Henderson 1998 Aristophanes, Acharnians, Knights, ed. by J. Henderson, cambridge-
london 1998.
ieranò 1997 G. ieranò, Il ditirambo di Dioniso. Le testimonianze antiche, Pisa-ro-
ma 1997.
Konstan-Dillon 1995 D. Konstan - m. J. Dillon, ‘the ideology of aristophanes’ Wealth’,
Am. Journ. Philol. 102, 1981, pp. 371-394.
Kotsidu 1991 H. Kotsidu, Die musischen Agone der Panathenäen in archaischer und
klassischer Zeit: eine historischarchäologische Untersuchung, münchen 1991.
landfester 1970 m. landfester, ‘aristoph. ach. 13 f.’, Rh. Mus. 113, 1970, pp. 93-94.
leo 1878 f. leo, ‘Bemerkungen zur attischen Komödie’, Rh. Mus. 33, 1878,
pp. 400-417.
loscalzo 2008 D. loscalzo, Il pubblico a teatro nella Grecia antica, roma 2008.
maas 1899 m. maas, ‘eine neue Deutung des Kalbträgers im akropolis-museum’,
Philologus 58, 1899, pp. 155-156.
maidment 1935 K.J. maidment, ‘the later comic chorus’, Class. Quart. 29, 1935,
pp. 1-24.
manieri 2004-05 a. manieri, ‘Giudici corrotti negli antichi agoni’, Rudiae 16-17/2,
2004-05, pp. 353-367.
Gli agoni musicali in Aristofane 301
manieri 2009 a. manieri, Agoni poeticomusicali nella Grecia antica i. Beozia, Pisa-
roma 2009.
mastromarco 1975 G. mastromarco, ‘Guerra peloponnesiaca e agoni comici in atene’,
Belfagor 30, 1975, pp. 469-473.
mastromarco 1983 Aristofane, Commedie i, a cura di G. mastromarco, torino 1983.
mastromarco 1994 G. mastromarco, ‘eschilo e il freddo teognide (aristofane, Acarnesi
9-12)’, in Scritti classici e cristiani offerti a F. Corsaro, catania 1994, pp. 471-477.
mastromarco 1997 G. mastromarco, ‘Pubblico e memoria teatrale nell’atene di aristo-
fane’, in P. thiercy - m. menu (edd.), Aristophane: la langue, la scène, la cité (actes du colloque de toulouse, 17-19 mars 1994), Bari 1997, pp. 529-548.
mazon 1903 P. mazon, ‘sur le Proagôn’, Rev. de philol. 4, 1903, pp. 263-268.
olson 2002 Aristophanes, Acharnians, ed. by s. D. olson, oxford 2002.
Perusino 1987 f. Perusino, Dalla commedia antica alla commedia di mezzo. Tre studi su
Aristofane, urbino 1987.
Perusino 1989 Platonio, La commedia greca, edizione critica, trad. e comm. di f. Peru-
sino, urbino 1989.
Petersen 1862 e. Petersen, ‘Dichter und chorlehrer’, Jahrb. Philol. Paedag. 85, 1862,
pp. 649-666.
Pickard-cambridge 1996 a.W. Pickard-cambidge, Le feste drammatiche di Atene, trad. it. fi-
renze 1996 (oxford 19682).
Pintacuda 1982 m. Pintacuda, Interpretazioni musicali sul teatro di Aristofane, Palermo
1982.
Pretagostini 1989 r. Pretagostini, ‘Gli inurbati in atene durante la guerra archidamica
nelle commedie di aristofane’, Quad. Urb. n.s. 32 (61), 1989, pp. 77-88.
302 Alessandra Manieri
Pretagostini 2003
r. Pretagostini, ‘Gli spettacoli ad atene negli Acarnesi di aristofane’, in Il teatro e la città. Poetica e politica nel dramma attico del quinto secolo (atti del convegno internazionale, siracusa, 19-22 settembre 2001), Palermo 2003, pp. 92-105.
Quaglia 2005
r. Quaglia, ‘studi su ferecrate: i. Vita, opere, mu`qoi. ii. Gli “Agrioi: un commento ai frammenti’, Ann. Fac. Lett. Filos. Bari 48, 2005, pp. 99-170.
rogers 1910
B.B. rogers, The Acharnians of Aristophanes, london 1910.
roveri 1959
a. roveri, ‘le feste religiose’, in Enciclopedia classica iii, torino 1959, pp. 201-234.
russo 1953
c.f. russo, Aristofane. Gli Acarnesi, Bari 1953.
slater 1990
n.W. slater, ‘the idea of the actor’, in J. J. Winkler - f. i. Zeitlin (edd.), Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in its Social Context, Princeton 1990, pp. 385-395.
sommerstein 1980
Aristophanes, Acharnians, ed. by a. H. sommerstein, Warminster 1980.
sommerstein 1985
Aristophanes, Peace, ed. by a. H. sommerstein, Warminster 1985.
sommerstein 2001
Aristophanes, Wealth, ed. by a. H. sommerstein, Warminster 2001.
starkie 1979
The Acharnians of Aristophanes, with introduction, english Prose trans-lation, critical notes and commentary by W. J. m. starkie, new York 1979.
thiercy 1997
P. thiercy, Aristophane: théâtre complet, Paris 1997.
Vetta-Del corno 1994
Aristofane, Le donne all’assemblea, a cura di m. Vetta, trad. di D. Del corno, milano 1994.
Vitucci 1939
G.V. Vitucci, ‘le rappresentazioni drammatiche nei demi attici stu-diate su alcuni testi epigrafici’, Dioniso 7, 1939, pp. 210-225; 312-325.
Gli agoni musicali in Aristofane 303
Wheelwright 1837 The Comedies of Aristophanes ii, tr. c. a. Wheelwright, oxford 1837.
Wilson 2007 n.G. Wilson, Aristophanea: Studies on the Text of Aristophanes, new
York 2007.
Wilson 2008 P. Wilson, ‘costing the Dionysia’, in m. revermann - P. Wilson (edd.),
Studies in Honour of O. Taplin, oxford 2008, pp. 88-127.
Winnington-ingram 1988 r.P. Winnington-ingram, ‘Kónnos, Konnâs, cheride e la professione
di musico’, in B. Gentili - r. Pretagostini (edd.), La musica in Grecia, Bari 1988, pp. 246-263.
INDICE DEI PASSI DISCUSSI
AelianusV.H. 2, 9: 33 e n. 37
AeschinesContr. Tim. 25-26: 101 n. 89
Alcaeusfr. 306g, 5-8 V.: 55 e n. 3
348: 55 e n. 3
Alexisfr. 116 K.-A.: 367 e n. 48
246: 367 ss.
Andocides1, 97 ss.: 55 e n. 41, 96-97: 136 n. 22
AndronFHG II p. 348, fr. 7: 33 e n. 40
Anonymus Iamblichi7: 24
Archedicusfr. 4 K.-A.: 357 ss. e n. 15
Archilochusfr. 19 W.: 55 e n. 2
23, 20-21: 55 e n. 2324: 277 s.
AristophanesAch. 5-6: 82 s.
9-16: 284 ss.162-163: 44 e n. 91182-183: 38 e n. 67201-202: 293 s.224-229: 37 n. 66230-233: 38 e n. 67247 ss.: 293 s.263 ss.: 294
300-301: 88 n. 43377-382: 86 ss.502-508: 40 ss. e n. 77502-503: 87 n. 38504-508: 294508: 41 e n. 80530-533: 143539-541: 143545: 45 e n. 94560-561: 112626 ss.: 113 s.659-664: 114818-829: 213860-866: 291 s.862: 290 e n. 52866: 290 e n. 52960-962: 2941000-1002: 277 s.; 2941085c-1093b: 2941154-1155: 282 e n. 141224-1225: 2781227: 2781228: 2781231: 2781233: 278
Av. 33-45: 196 s.39-41: 198 n. 1149-52: 215 s.108: 45 e n. 97120-154: 200165: 200172: 200400-402: 44 n. 90431: 205481: 205488-500: 205489: 290 n. 56520: 214550-552: 205 s.686 s.: 67 n. 49755-756: 206786 ss.: 283 e n. 20
378 La commedia greca e la storia
809-811: 201837-845: 201 ss.849-855: 201890-894: 201904 ss.: 67904: 203959: 203 e n. 22981-985: 215986: 214991: 203997-998: 218 n. 661000-1008: 2191019: 203 e n. 231021-1053: 2221035: 2031056-1057: 2011071 ss.: 661072-1075: 1341123-1157: 2031133-1134: 2031297: 101 n. 901320 ss.: 67 n. 491403-1404: 284 e n. 271410-1469: 2131570-1571: 1401583-1585: 253 n. 531605: 1321643: 1321704: 661706-1730: 66
Eccl. 102 ss.: 22102-103: 141 n. 36183 ss.: 22183-188: 23184-188: 141 s.203: 142301 s.: 23305: 23 s.356: 142741: 290 n. 561157-1162: 286 n. 34
Eq. 137: 88 s.181: 131185-186: 131188-189: 131191-193: 131
232: 283 e n. 17256: 110276: 278285-290: 94324-325: 93327: 219351-352: 98 s.430-431: 106498 ss.: 80; 114513: 283 s. e n. 22551-558: 272624 ss.: 102 ss.626-629: 115626: 102 ss.628: 104629: 105637-638: 131 n. 6760: 106 s.786: 138845: 108864-867: 80 n. 4; 88 n. 43919-922: 93956: 92964: 135973-996: 97 s.1111-1114: 132
Lys. 490-491: 238 ss.574-586: 40 e n. 75577-578: 239 e n. 10579-581: 40 e n. 76614-705: 69 ss.614-625: 134616-625: 239 s.633-634: 135 e n. 18683-684: 91 n. 581082: 1381128-1134: 267 s.1137-1144: 31 s. e n. 281144: 321149-1156: 31 e n. 271242-1244: 30 e n. 221248-1261: 29 ss. e n. 10; 30 e n. 211252: 29 e n. 111255-1256: 29 e n. 141261-1272: 30 e n. 22
Nub. 28: 272 s.
Indice dei passi discussi 379
94-99: 161 s.94: 163 s.97: 164 s.99: 110100-125: 186 s.101: 163 s.112 ss.: 155 n. 4116: 155 n. 4137-179: 158 ss.187-189: 159 s.191-194: 159 s.200-217: 158202-203: 209239-262: 167245 s.: 164 s.258-260: 162 n. 17260: 205288-290: 183298-313: 167 s.311-313: 296 n. 78318: 110 s.331-334: 205360: 156; 160 s.362 s.: 184 s.362: 164364: 168 s.365-368: 169412-413: 162 s.418-419: 162 s.423-426: 169549-550: 80550-559: 337 e n. 50559: 80 n. 4563-626: 170 s.564: 131 s.581-594: 80591-594: 97591: 92628-631: 182636 ss.: 176657: 155 n. 4695: 178 s.700-706: 179 s.705 s.: 180742: 180 s. e n. 53743-745: 181 s.
785-790: 182842: 180882 ss.: 155 n. 4885: 155 n. 4893 ss.: 155 n. 4961-1023: 171964-972: 177965-966: 273 s.973-976: 273 s.987-989: 2731024-1033: 1721038-1043: 174 s.1105-1111: 1721145-1171: 1731146 s.: 164 s.1214-1302: 1731303-1320: 1731336 s.: 155 n. 41357 s.: 1781359 s.: 1781444 s.: 153 n. 41451 s.: 155 n. 41452-1461: 173
Pax 292-300: 39 e n. 71530-532: 295 e n. 74606-614: 143 s.649-656: 98730: 282 s. e n. 15734 ss.: 80 n. 4734-735: 283 e n. 16752-758: 89 s.754-758: 146799 ss.: 284 e n. 23951-952: 290 e n. 52976: 295 e n. 75
Plut. 124: 74; 132176-177: 141 n. 36509-516: 139 s.550: 142583-586: 269 s.1161-1164: 2981161: 2701162-1163: 270
Ran. 128 ss.: 275 s.354-368: 44 s. e n. 93367: 296
380 La commedia greca e la storia
403 ss.: 296 e n. 82539-541: 143549-578: 91686-691: 142689: 1421089-1098: 2761422-1431: 1441431-1432: 144 s.1446-1448: 1451454-1455: 1451458-1459: 145Hypoth. I: 329 s. e n. 5
Thesm. 331-351: 136335-339: 136339-340: 72352-371: 241 s.808-809: 243 s.1136-1159: 1361136-1146: 136 s.1143-1144: 72 s.; 243 s.1147: 295 e n. 76
Vesp. 31-46: 90 ss.44-46: 14454-66: 80 s.342a-343: 109417: 133421: 205463-465: 133487 ss.: 58 s.488-502: 57 ss.488-499: 133500-503: 133 e n. 10500-502: 59 s.587: 132 e n. 8596: 95605-627: 18 s.668-671: 103703-705: 19750-755: 20 s.891-1008: 95 s.1030-1035: 89 s.1031-1036: 1461043-1045: 801071 ss.: 191075-1101: 27 s. e n. 4; 44 e n. 881075-1079: 28 e n. 7
1076: 1381081: 28 e n. 81084: 28 e n. 61089-1090: 28 e n. 71114-1121: 19 s.; 44 e nn. 89 e 921156-1173: 61 ss.1168-1169: 61 s.1170-1172: 63 ss.1187-1194: 2661188: 2671197: 2661224-1226: 1381227: 1381270: 1421284-1291: 811301: 1421381 ss.: 265 s.1384: 267
fr. 71 K.-A.: 33 ss. e n. 36110: 133205: 144563: 142 s.760: 270 n. 23
AristotelesAth. pol. 16, 7: 318
16, 10: 55 e n. 4; 136 n. 2119, 1-6: 32 e n. 2928, 3: 10041: 2541, 3: 22 s.56, 3: 198 n. 9
Pol. 2, 1267b 38 ss.: 213 e n. 58 4, 1291b 14-30: 32 e n. 34 5, 1307b 7: 211 n. 49 5, 1321a 5-26: 32 e n. 34 7, 6, 1327b 7-13: 44 n. 89 7, 1328b 33-1329a 39: 32 e n. 34 7, 1328b 37-1329a 2: 40 e n. 73 7, 1329a 17-39: 40 e n. 73fr. 575 Rose = 592 Gigon: 33 e n. 39 578 = 595: 35 e n. 56
Athenaeus6, 267e-270a: 308
Indice dei passi discussi 381
Cratesfr. 16 K.-A.: 321
17: 321
Cratinusfr. 1, 2 K.-A.: 318 s.
73: 56 n. 8; 312 n. 16118: 312 n. 16130: 322131: 322171: 308 ss.; 319171, 22 s.: 309 s.171, 25: 309 s.171, 66-76: 314171, 70 s.: 315172: 319 s.175: 319 ss. e n. 34176: 308 e n. 5; 319 ss.223: 315253: 311 ss.256: 311; 317 e n. 29257: 311258: 56 n. 8; 312 s. e n. 15259: 313266: 315
Critias88 B 22 D.-K.: 106
45: 86
CyrillusContra Iul. 1, 13: 329 e n. 4
Diodorus11, 63-64: 32 e n. 3012, 10, 4: 210 s.12, 10, 5: 216 s.12, 10, 7: 211 e n. 5112, 12, 2: 21312, 12, 4: 212 e n. 5512, 14: 20412, 15, 1: 212 e n. 5612, 27, 1-28, 4: 35 n. 5512, 35: 221 s.
Diogenes Laertius2, 40: 157 n. 75, 81: 25
DurisFGrHist 76 F 66: 34 e n. 44
Etymologicum Magnums.v. Prutanei`a: 202 n. 19
Eupolisfr. 35 K.-A.: 246
99: 246 ss.99, 1-4: 248 s. e n. 3799, 23-28: 251 s.101, 5-8: 249 s. e n. 40102, 8: 56 n. 8
EuripidesPhoen. 535 ss.: 139
HellanicusFGrHist 323a F 25: 46 e n. 101
Heraclitusfr. 22 Marcovich: 97
Hermippusfr. 47 K.-A.: 82 n. 11; 314
Herodotus1, 24, 5: 290 n. 561, 60: 681, 62 s.: 603, 53, 4: 583, 81, 2: 894, 157, 2: 2174, 158, 1: 2175, 42, 6: 2085, 63, 1-65, 2: 32 e n. 295, 65: 68 s.6, 112, 1-2: 28 e n. 86, 125, 1: 1077, 223-225: 29 e n. 157, 226, 1: 28 e n. 68, 1-23: 29 s. e n. 188, 1, 1-2, 1: 29 e n. 168, 9: 30 e n. 198, 15, 1: 30 s. e n. 238, 16, 1-3: 29 e n. 17
382 La commedia greca e la storia
8, 18: 29 e n. 178, 21, 1-2: 30 s. e n. 23
HesiodusOp. 106-201: 316
108-128: 316225-237: 317236 s.: 317238-247: 317
Hesychiuss.v. sfhkismov~: 292 n. 63
InscriptionesAgora 14, 104: 359 n. 23IG I3 46, 10: 209 e n. 40
II2 657 = Syll.3 374: 362 s. e n. 322311, 72-74: 288 e n. 442311, 75-76: 289 n. 455327: 360 e n. 24
II/III3 2325, 63: 330SEG 36, 155: 360 e n. 24
41, 47: 360 e n. 2441, 107: 360 e n. 2442, 91: 359 n. 23
Syll.3 434-435: 368 s. e n. 51
IsocratesAntid. 172: 89 n. 46Paneg. 45-46: 271
Lysias21, 1-5: 297 e n. 86
Metagenesfr. 6, 2-4 K.-A.: 204 s.
6, 9 s.: 321
Nicophonfr. 21, 1 s. K.-A.: 322
PapyriP. Oxy. 663: 313 s.
2737, fr. 1, col. II 43-44: 330 e n. 11
Pausanias4, 24, 6-7: 32 e n. 30
4, 26, 5-27, 8: 2104, 27, 5-6: 2104, 27, 7: 210
Pherecratesfr. 6 K.-A.: 290 s.
113, 23 s.: 321113, 26 s.: 321137, 6: 322137, 9 s.: 321199: 296 n. 82
Philippidesfr. 25 K.-A.: 360 ss.
26: 366 e n. 44
PhotiusBibl. 93, 18: 210Lex. s.v. Samivwn oJ dh`mo~: 33 e n. 37
Phrynichusfr. 22 K.-A.:: 218
77: 341 n. 72
PindarusOl. 14, 3 s.: 67 n. 49Pyth. 8, 1 s.: 67 n. 49 8, 95 ss.: 67 n. 49fr. 105 Maehler: 67 s. 109: 67 n. 49
PlatoAlcib. I 132a: 99Alcib. alt. 148e-149a: 281 n. 3Apol. 18b 7: 164 e n. 20 18b 8: 155 n. 4 19b 5-c 1: 155 n. 4Gorg. 481c-482c: 99Hipparch. 229b: 318Hipp. mai. 285d: 207Leg. 4, 706b-d: 32 e n. 34 4, 707a-d: 32 e n. 34 4, 708c 3: 211 n. 49Phaed. 95e 7-100a 9: 151
96a 7-8: 152 96a 7: 155
96a 9-10: 152
Indice dei passi discussi 383
96b 2-c 1: 15296c 2-97b 4: 15396c 7-d 7: 15396e 1-97b 7: 15397b 5-7: 15497b 6: 152 s.97b 8-c 2: 15399e 4-6: 154100a 3-7: 155117b: 185 s. e n. 64
Prot. 337c: 207347c-e: 177 e n. 46
Resp. 3, 400b: 176Symp. 221b: 164 e n. 23; 184 s.
Plato comicusfr. 20 K.-A.: 344
21: 344 e n. 9023: 34425: 34557, 2: 341 n. 7258: 34159: 34160: 34161: 34164: 341102: 335103: 335 s.104: 335105: 335106: 330 s.; 335107: 330 s.; 335109: 335110: 336112: 335113: 336114: 343115: 342 e n. 77116: 343117: 342 s. e n. 78148: 343 n. 81150: 343 n. 81168: 332 s.; 338169: 340170: 340 s.174: 341
182: 337183: 338185: 338187: 338199: 345202: 343203: 339 s.207: 343219: 335
Platonius22: 297 n. 84
PlutarchusAlcib. 13: 332 s. 17: 218Aristid. 24, 3: 318Cim. 10, 4: 318
10, 7: 318 n. 3116: 31916, 1-17,3: 32 n. 30
Demetr. 10, 3-11, 1: 361 e n. 2711, 2: 36612, 3: 361 e n. 2826: 361 e n. 27
Demosth. 11, 2: 101 n. 91Nic. 3, 2: 101
5, 3: 211 e n. 477, 7: 1008, 6: 100 s.11, 5: 332 s. e n. 2713: 218
Comp. Nic. Crass. 3, 1: 101 n. 90Per. 4-5: 102
8: 103 n. 9726, 3-4: 33 n. 4126, 4: 35 e nn. 51-5228, 1-3: 35 e n. 5430, 3: 36 e n. 60
Tib. Gracch. 2, 2: 101 n. 90Praec. ger. reip. 799d: 100
806f-807a: 92 n. 61806f: 121
vd. Pseudo-Plutarchus
Pollux4, 65: 290 n. 56
384 La commedia greca e la storia
Polybius12, 13: 357 e n. 15
Protagorasfr. 1 D.-K.: 211 e n. 50
Pseudo-PlutarchusDe mus. 28: 290 n. 56Vit. X orat. 851d: 360 n. 25
Pseudo-XenophonAth. pol. 1, 2: 25; 32 e n. 33; 45 e n. 98
1, 19-20: 32 e n. 33; 45 e n. 98 3, 2: 281 n. 3
ScholiaSchol. Ael. Aristid. Pan. 103, 16, 34:
202 n. 19 Schol. Aristoph. Ach. 6a = Theop.
FGrHist 115 F 94: 82 n. 13; 92 n. 6113a: 282 e n. 1116: 290 n. 5616a: 290 e n. 54202: 293 n. 69508: 42 n. 84
Av. 11: 282 e n. 12 858: 290 e nn. 53 e 57Eq. 8-10: 290 n. 56 226a: 92 n. 61 276a: 278Lys. 1129: 267 1133: 268 s.Nub. 332: 210 332a: 208 n. 38 332b: 216 e n. 62 889: 155 n. 4 989c: 274 e n. 39Pac. 951a-b: 290 e n. 55Ran. 404: 296 n. 82; 297 n. 84 541: 143 679: 341Vesp. 1191a: 266 1191b: 266
Schol. Tzetz. Aristoph. Ran. 135a: 274 s. e n. 43 1087: 274 s. e n. 43
Schol. Luc. Tim. 30: 100
Semonidesfr. 7, 67-70 W.: 55 e n. 2
Simonidesfr. 584 P.: 55 e n. 2
Solonfr. 29 Gent.-Pr.: 55 e n. 3 29a: 55 e n. 2 29b, 7 s.: 55 e n. 3 30, 27: 96
SophoclesO. R. 601: 58
Strabo9, 1, 6: 36 e n. 6014, 2, 9: 212 n. 53
Sudas.v. Dhmhvtrio~: 25
o[rqio~ novmo~: 290 n. 56Plavtwn: 330Samivwn oJ dh`mo~: 33 e n. 37Timovqeo~: 290 n. 56
Teleclidesfr. 1, 4-7 K.-A.: 321
1, 12: 32145: 56 n. 8
Theognis345-347: 89347-348: 89
TheopompusFGrHist 115 F 92 = schol. Luc. Tim.
30: 10093 = Schol. Aristoph.
Eq. 226a: 92 n. 6194 = Schol. Aristoph.
Ach. 6a: 82 n. 13; 92 n. 61
Indice dei passi discussi 385
Thucydides1, 22, 1: 116; 1191, 101, 2-102, 4: 32 e n. 301, 138, 6: 1071, 139, 4: 1191, 143, 1-3: 46 e n. 991, 143, 1: 422, 11, 1-23, 3: 36 e n. 592, 11, 1-2: 36 e n. 572, 11, 3: 36 e n. 622, 11, 6-8: 36 e n. 622, 13, 6-7: 422, 13, 8: 45 e n. 952, 18, 1-5: 38 e n. 692, 20, 1-2: 36 e n. 572, 20, 3-5: 37 n. 662, 21, 1: 36 e n. 612, 21, 2: 37 e n. 632, 22, 1-2: 37 e n. 642, 23, 2-3: 37 e n. 65; 38 e n. 792, 31, 1-2: 42 s.2, 37 ss.: 242, 37, 1: 140 e n. 282, 38, 1: 281 n. 32, 63, 2: 1162, 65, 8-9: 1132, 65, 10: 1133, 17, 1-3: 45 e n. 963, 25-40: 114 ss.3, 36, 6: 1153, 37-48: 129 ss.3, 37, 1: 1163, 37, 2: 1163, 38, 4-5: 1173, 38, 7: 1133, 83, 3: 131 e n. 53, 91-92: 2083, 92, 5-6: 2024, 22, 2: 1154, 27 ss.: 118 s.
4, 90, 1: 434, 102, 4: 209 s.6, 53, 3 ss.: 716, 60, 1: 137; 253 n. 536, 61, 3: 253 n. 536, 61, 7: 1986, 104, 2: 222 n. 777, 33, 5: 222 n. 777, 57, 11: 222 n. 778, 1: 253 n. 518, 35: 2228, 45 ss.: 252 n. 508, 53-54: 237 ss.8, 63-77: 47 e n. 1038, 65-66: 2458, 66: 242 ss.8, 70, 2: 143 n. 398, 71, 1-2: 2478, 81-82: 47 e n. 1038, 86-97: 47 e n. 103
TimaeusFGrHist 566 F 35b: 357 e n. 15
Timoclesfr. 4 K.-A.: 356 s.
17: 89 n. 47
XenophonHell. 5, 4, 20-21: 36 n. 61 6, 5, 33: 32 e n. 31Mem. 1, 2, 35: 155 1, 6, 1-3: 187 e n. 67Symp. 3, 1-4: 177 e n. 47 6, 6: 163
vd. Pseudo-Xenophon
ZenobiusVulg. 1, 26: 315 n. 26
INDICE
Avvertenza 11
IntroduzioneFranca Perusino 13
Dalla polemica delle Vespe all’utopia delle EcclesiazuseDomenico Musti 17
Aristofane e la storia: conoscenza e manipolazioneMauro Moggi 27
Aristofane e la tirannideCarmine Catenacci 55
Commedia e oratoria politica: Cleone nel teatro di AristofaneMaria Grazia Fileni 79
La amathia de CleónLuis Gil 129
Le Nuvole di Aristofane e la realtà storica di SocrateGiovanni Cerri 151
Colonizar los cielosIgnacio Rodríguez Alfageme 195
La commedia e la katalysis tou demou del 411: Aristofane ed EupoliPaolo A. Tuci 235
Gli agoni sportivi in AristofanePietro Giannini 265
Gli agoni musicali in AristofaneAlessandra Manieri 281
Utopia e politica in CratinoMaría José García Soler 305
Platone comicoLucio Bertelli 329
Commedia e politica tra Demostene e CremonideNino Luraghi 353
Indice dei passi discussi 377
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di maggio 2012
finito_00 pp. ed. 01/06/12 09.30 Pagina 1





















































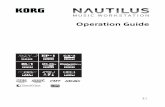








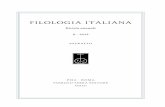








![Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63377df2d102fae1b607646b/strumenti-musicali-nelle-collezioni-siciliane-musical-instrumentas-in-sicilian.jpg)

