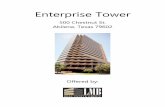Il soldato spagnolo in commedia nel '500
Transcript of Il soldato spagnolo in commedia nel '500
Donatella Pini, Marco Lombardi, Luciano Garcia Lorenzo,Frej Moretti, Marzia Pieri, Filomena Compagno,
Nicoletta Lepri, Anna Lia Franchetti,Fernando Romo Feito, Valentina Nider,
Antonio Barnes Vazquez, Katerina Vaiopoulos,Igor Melani, Enrico Di Pastena, Veronica Orazi,
Debora Sensi, Teresa Puche Gutierrez,Armando Fabio Ivaldi, Silvia Rogai, Barbara Innocenti,
Giorgia Sogos, Anna Fierro, Giulia Romanelli,Macarena Cuifias Gomez, Elisabetta Terigi, Sara Polverini,
Andrea Cellai, Serena Manfrida, Cosimo Fossi,Guido Mattia Gallerani, Rodrigo Pardo Fernandez,
Federico Fastelli, Maria Grazia Profeti
Leyendas negrase leggende auree
a cura di Maria Grazia Profeti e Donatella Pini
© copyright Af..4N~A editrice s.r.1. - Firenze 201150144 Firenze, vlll fljprluigi da Palestrina, 17 / 19 rossoTel. +39 55 / 44412Q- Fax +3955/6285887
tutti i dirltti SPIIPJ'!Servali:nessttna pat/fJ ell essere riprodotta in alcun modo((:ompres!l(J(ocopie e microfilms)senza il permesso scritto dol/a Coso Editrice
l/iaN 978-88-6055-640-0e-mail: [email protected]:/www.aiinea.it
Immll~ine di copertina:J~I1QtP Fiorentino (XV secolo), S. Maria del Soccorso (partico[are], Chiesa di S. Spirito, Firenze.
~icerche starnpate con il contributo del Dipartimento di Ro-
~llnistica dell'Universita di Padova, del Dipartimento di Studietterari, Linguistici e Filologici dell'Universita di Trento e delrogetto Proteo dell'Universidad de Burgos.
UNIYF.n~IIl,\[)
DE nllHGOS
www.protco.cu
finito di stampare nel marzo 2011
(Up", "Alinea editrice srl" - Firenze;rMhlf(l; Artee Grafica s.n.c. di Fe Valerio e C. - Citta della Pieve (PG)
IL SOLDATO SPAGNOLO IN COMMEDIANEL'500: DALLA CRONACA STORICA ALLASTILIZZAZIONE TEATRALE
Marzia Pieri
II teatro italiano di ancien regime pullu1a di cavalierie soldati spagnoli, piu ridico1i che effettivamente 'neri',macchiette del tracotante logorroico che vanta esagerateprodezze militari e amorose: a partire da1 primo '500, i1tipo arriva direttamente a1 don Alvaro de Castiglia dellaVedova sea/Ira di Go1doni, 1a commedia della furba Rosaura che si sceglie i1 marito perfetto fra una rosa geografico-antropologica di corteggiatori: «l'italiano efede1e rnatroppo geloso; l'ing1ese e sincero, rna incostante; i1 francese egalante, rna troppo affettato, e 10 spagnuolo eamoroso rna troppo graven'. Ne1 '700 (considerando i1 DonGiovanni di Da Ponte come pietra di paragone), l' esitofinale del personaggio eappunto amoroso: nell'architettura drammaturgica del canovaccio dell'Arte il capitano, giadeputato a scombinare 1a simmetria della prima e seconda coppia di innamorati come terzo incomodo, finisce perriassorbire nella smodata vanita erotica i tratti dell' originaria fisionomia militare e guerriera. Per Perrucci si trattainfatti di «una parte ampollosa di parole e di gesti che sivanta di bellezza, di grazia e di ricchezza; quando per altro eun mostro di natura, un balordo, un codardo, un pover'huomo, e matto da catena, che vuol vivere col creditod'esser tenuto quello che non e, de' quali non pochi si ragirano per 10 mondoo". Esemp1are umana ben riconoscibile,dunque: un impostore mascherato da gentiluomo e caratterizzato soprattutto dallinguaggio artificioso e frastornantedella "bravura", che ormai puo essere detta, ai suoi tempi,
I C. Goldoni, La vedova scaltra, a cura di L. Sannia Nowe, Venezia, Marsilio, 2004, p. 166.
2 A. Perrueci, Dell 'AI'/e rappresentativa premeditata ed all 'improvviso,traslatcd and edited by F. Cottieelli, A. Goodrich Heck, and T. F. Heck, Lanham,The Scarecrow Press, 2008, p. 145.
72 Marzia Pieri
in napoletano, spagnolo, romanesco, calabrese e persinosiciliano, varia mente messi in caricatura. Con una chiosasignificativa:
Quando si fa in Spagnuolo [cioe parlando in lingua spagnola] bisogna farlo con decoro, perche questa nazione per ogniverso gloriosa non patisce esser derisa, come 10 soffrono I'altre; facendosi deridere i Napolitani per sciocchi e linguacciuti,i Bolognesi per ciarloni, i Veneziani per ridicoli, i Francesi perubriachi, i Sieiliani per garruli e contenziosi, senza alterarsi, anzine godono. Ma 10 Spagnuolo ridera nell'ascoltare le bravure, manon vuol vedere nella parte, benche finta, d'un soldato ccdardie'.
Da prudente suddito del regno di Napoli di fine '600l'autore ci testimonia la necessita di andarci cauti; prendere in giro gli Spagnoli sul tasto militare euna tentazioneirresistibile ma piuttosto pericolosa.
E in effetti la storia del capitano, che in pochi decennidiventa una parte particolarmente codificata, comincia dauna leggenda nera intrisa di paura e di dolore; il dileggioastioso el'esito finale di un percorso di ricezione dove gliobbligatori ricordi letterari dell'antico si mescolano a datidi esperienza di bruciante attualita. Per quanta questo genere di riflessioni - cari agli studiosi positivisti delle "fonti" praticamente di quasi ogni tipo di testa - siano carichedi rischi, sempre minacciate di tautologie, 0 vanamenteerudite, ripercorrendo la parabola del soldato spagnoloin teatro si puo verificare come la cultura rinascimentaleaggiorni l'eredita c1assica del soldato fanfarone con robuste contaminazione attinte dal proprio presente, e quantoestrinseco sia, alla fine, il debito della commedia italianacinquecentesca nei confronti di Plauto e Terenzio su cuitanto insistono i manuali. II modello del Miles gloriosusrientra in circolazione, insieme al resto del C01pllS plautinoriscoperto quasi ex-novo dagli umanisti, negli allestimenti quattrocenteschi in latino e in volgare a Ferrara, Romae Firenze. II personaggio ridicolo e vigliacco non ha inorigine niente a che fare con la Spagna, ma diventa spagnolissimo a partire dal sacco di Roma, che dilata orribilmente nell'immaginario collettivo l' incubo della violenzalanzichenecca. La mutazione si produce all'interno del laboratorio teatrale senese - ricco, vivace e subito esportato
J Ivi.
73 II soldato spagnolo in commedia nel '500...
anche fuori di Siena - precisamente intorno agli anni '30a ridosso degli avvenimenti, in uno specifico contesto politico.
Siena, come enoto, euna citta da sempre schierata congli imperiali contra la guelfa Firenze, tradizionalmente eculturalmente assai legata aRoma, sede di un' universita aperta all'Europa, frequentata da spagnoli 0 buoni conoscitori della cultura spagnola e, in questi anni incerti edifficili, sottoposta a una fibrillazione politica interna einternazionale che vede la presenza al potere di vari luogotenenti imperiali e di una guarnigione di soldati acquartierata in citra. Sono ospiti ingombranti, di volta in voltaindispensabili 0 indesiderati, verso i quali la Repubblica(dove ormai da tempo manca una classe dirigente capace di intuire la portata della posta in gioco) assume atteggiamenti piuttosto confusi, ora affidandosi all'illustremediazione dell'imperatore ora cercando di scrollarsi dalsuo dominio in base al variare delle turbolenze interne dipartiti e fazioni. Gli spagnoli, cosi, sono contemporaneamente gli ospiti di riguardo delle feste teatrali in cui si allestiscono queste commedie e la teppa prepotente che vessa una popolazione stremata da crisi e carestie ricorrenti,mentre gli echi del sacco, con le diaspore, le uccisioni, gliscambi di prigionieri e le peripezie private pili rocambolesche coincidono in modo abbastanza sinistro, per alcuniprotagonisti di questa storia, con gli schemi alessandrini ele agnizioni della commedia letteraria. Edavvero interessante misurare la temperatura politica senese proprio a seconda di come questi spagnoli vengano immediatamentetrasposti in palcoscenico, in una citta dove I'esperienza delfare teatro, da parte di una serie di congreghe e accademiedi varia estrazione sociale, si lega in questi anni al vivotessuto della vita quotidiana.
11 soldato di ventura sbruffone e parassita etristementenoto al pubblico cinquecentesco vessato da tante campagnemilitari, e compare con specifiche varianti in molta poesiapopolaresca e musicale, pili 0 meno drammatizzata, di svariate regioni italiane, quasi sempre in coppia 0 a contrastocon la cortigiana; ne ritroviamo un esemplare (e forse unparziale modello) anche nel Centurio della Celestina (generico teatrale ante litteram largamente saccheggiato nel teatro italiano di primo'500) legato ad Areusa, che si lamentadelle sue pigrizie e ruberie e gli affida compiti di sicario, a
74 Marzia Pieri
cui egli si sottrae conla frode: ruffiano, bugiardo e spiantatoegli declama gia vanterie rocambolesche destinate a lungafortuna scenica", e forse contribuisce in qualche forma siaalla drammaturgia senese che allo specifico filone bulescodi area veneta, dove ancora troviamo bravi e puttane aIleprese con intrighi, amori e zuffe recitati e cantati in linguegergali e caricaturali. Ma si tratta di una tradizione parallela,nutrita di cronaca nera e di eredita piuttosto albanesi, grechee balcaniche, che gia il Pandolfi invitata a non sovrapporre aquella spagnola del capitano che qui ci interessa', e che alIafine prevale.
II canone della commedia classicistica italiana, dopouna stagione ricca di sperimentazioni formali di ogni genere, e fissato nel1554 da un'antologia -Delle commedieelette, uscita a Venezia per Ie cure di Girolamo Ruscelli di impianto decisamente toscano, con tre commedie senesi(Gl'Ingannati, l'Amor costante e l'Alessandro) e due fiorentine (Calandria e Mandragolay: Come spesso accadein ambito teatrale, gli stampatori precedono e stimolanoi teorici di poetica; a meta secolo la commedia letterariae ormai attestata e diffusa un po' dovunque nella formaprevalente della prosa, con una struttura in cinque atti preceduti da un pro logo e un ventaglio di personaggi borghesie cittadini aIle prese con intrighi di beffa, di adulterio e ditruffa. Si sta concludendo una fase sperimentale varia eavventurosa, in cui Firenze e Siena si erano fronteggiatea distanza utilizzando serbatoi tematici e modelli letterariabbastanza diversi. A Siena la pratica della commedia elegata principalmente allavoro degli Accademici Intronati
4 In particolarc ncll'allo XVIII, dove troviamo, ad cscmpio: «se la miaspada dovcssc dire tullo qucllo chc fa non ci sarcbbc tempo sufficicntc. Non cforsc Ici che popola la piu gran parte dei cimitcri? Chc rimpingua lc borsc deicerusichi di tulia questa terra? Non ca cagion sua chc lavorano soprallutto gliannaioli? Chi sc non lei spczza Ie colic pill robustc? Non cIci a far sfracclli congli scudi di Barccllona? Che affclta gli elmetti di Calatayud, che taglia comealtrcttanti meloni i caschelti di Almazan? Da vent' anni mi da da mangiare. Egrazie a lei sc son temuto dagli uomini e amato dallc donne [... ] Ed cscmpregrazic a lei se mio nonno fu Ccnturionc, mio padre Centurionc c sc anch' io michiamo Centurionc» (F. de Rojas, La Celestina, Milano, Garzanti, 1995,p. 241).
5 Cfr. V. Pandolfi, La Commedia dell'Arte. Storia e testa, vol. I, Firenzc,Sansoni, 1955, pp. 326-327 (reprint Fircnze, Lc Lcttcre, 1988). A proposito dibravi e buli in teatro si rimanda all'antologia a cura di B.M Da Rif, La Ietteratura"alia bulesca ", Testi rinascimentali veneti, Padova, Antenorc, 1984.
, Sulla gcncsi, Ie carallcristichc e I' influenza Icttcraria di questa "unicaantologia teatrale del Cinqucccnto confezionata in modo prcmeditatosclezionando i testi in base a cspliciti criteri normativi", si rimanda a L. Ricco,"SII Ie carte eFa Ie scene ", Teatro in forma di libra nel Cinquecento italiano,Roma, Bulzoni, 2008, pp. 172 e sgg.
75 11 soldato spagnolo in commedia nel '500...
che, in un laboratorio drammaturgico collettivo, sfornano,intorno al1530, ben quattro testi ugualmente costruiti peraccumulazione di sketches piuttosto epicizzanti che sintetici, tutti ruotanti intorno all'eredita storica del sacco,all'interno di un vasto programma di volgarizzamenti (incui il teatro fa la parte del leone) che mirano alla divulgazione qualificata e linguisticamente impeccabile di unamoderna cultura volgare antipetrarchesca e carica di valorisociali e civili; in tutte queste commedie compaiono a vario titolo soldati spagnoli, che di qui trasmigreranno nellecommedie manieristiche della seconda meta del secolo epoi nei canovacci della Commedia dell' Arte.
Le sperimentazioni intronatiche iniziano da un volgarizzamento molto libero dei Captivi di Plauto, di cui resta un manoscritto, intitolato 1prigioni, risalente agli anni'30, e che forse venne anche recitato", Negli stessi mesivengono composte Gl'Ingannati e 1'Aurelia, quindi, nel1536, l'Amar castante firmato da Alessandro Piccolomini,passando con naturalezza dalla traduzione all'invenzione esempre aggiornando il modello latino con forti riferimentialla realta cittadina circostante e peculiari aggiustamentidella/abula: i prologhi si rivolgono alle spettatrici con audace erotismo, l'intreccio si dipana su pili linee ed e costruito 'montando' per accumulo skechtes gia in apparenzarigidamente codificati, le ambientazioni sono riconoscibili grazie a una fitta trama di precisi indicatori onomastici e toponomastici, le vicende rappresentate mescolano elementi comici di derivazione carnevalesca (con acripolemiche contro il clero, i soldati occupanti e la culturapedantesca) e spunti patetico-amorosi ricavati da fonti novellistiche e cavalleresche, che conferiscono ai personaggi femminili un' inedita centralita ben poco aristotelica",e sono contestualizzate rispetto a fatti recenti: la rotta diRavenna e l'assedio di Firenze nel caso dei Prigioni, il
7 N. Newbigin, Una commedia degli lntronati: "I Prlgioni", in "Rivistaitaliana di drammaturgia, VII (1978), pp. 3-16. Sempre a sua cum la reeenteedizione del testo: 1 Prigioni di Plauto tradotti da l'Intronati di Siena, Siena,Accademia Senese degli Intronati, 2006.
8 La novella V, 5 del Decameron sugli arnanti di Agnesa e utilizzata siaper Ie integrazioni drammaturgiche all'intreccio dei Captivi ehe per I'Aurelia;fra le fonti de Gl'Ingannati, oltre ai Menaechmi, gia riseritti nella Calandriae nei Suppositi, Ie novelle di peripezia decameroniane (II, 9, III, 9, X, 10) e laBradamante ariostesca (efr. R. Bigazzi, La via romanzesca degli "Ingannati ", inF.Bruni (a curadi), La maschera e il volta. II teatro ill Italia, Venezia, Marsilio,2002, pp. 51-68).
76 Marzia Pieri
sacco di Roma in quello degl' Ingannati, e l'occupazionespagnola di Siena per YAurelia; mentre l'Amor costante,virtuoso montaggio di intrecci gia testati nelle precedenti,sta sullo sfondo di questi fatti a ridosso della vittoria diTunisi. In tutti questi testi i1 parlato della recita e semprearricchito da e1ementi pluringuistici (irresistibilmente comici per la confusione e gli equivoci che ingenerano) e dainserti performativi di grande impatto scenico, come zuffee moresche; i personaggi sono numerosi (sempre 16-17)e fortemente tipizzati sulla base di un catalogo fisso, cheprevede vecchi, innamorati, servi, parassiti, ruffiane, pedanti e, appunto, soldati.
II corpus delle commedie senesi - che va letto comeprofondamente unitario ne1 suo complesso - al di ladell'eccellenza tecnica in senso teatrale che gli epropria,ha uno spessore di contenuti di qualita e ricchezza davveronotevoli, intimamente collegati sia con la grande storia coeva che con il tessuto realistico della vita quotidiana dellacitta; e insomma, a tutti gli effetti, un documento antropologico e sociologico autorevole, che solo un accuratolavoro di edizione e di puntuale commento, ormai irrinunciabile, potrebbe portare finalmente in luce.
Gli anni del violento scontro fra Carlo V e ClementeVII si ripercuotono dunque nella vita politica della ghibellina e antifiorentina Siena generando una turbolenza.molto forte, fra intrusioni spagnole in appoggio al partitodei Noveschi e insofferenze dei Popolari, colpi di mana daentrambe Ie parti, sostituzioni di luogotenenti imperiali",esili e rientri di fuoriusciti, vani appelli alla pacificazioneinterna. In un tale contesto la scena festiva, a dispetto ditante professioni di disimpegno politico pili 0 meno prudenziali, non resta affatto neutrale, come del resto si registra anche in coevi componimenti teatrali dei Rozzi, imembri della Congrega artigiana che affianca l'accademia
9 II Duea di Amalfi, mcmbro degli Intronati, fu allontanato da Siena il23 novembre 1530 e sostituito come governatore da Don Lope de Soria, mala traeotanza dei Novesehi, riammessi in citta dall'esilio, indusse Carlo Vad allontare Don Lope ehe Ii proteggeva, affidando al Marchese del Vasto ileomando militare e a Don Pietro de la Queva !'inearieo di oratore eesareo; ilDuea di Amalfi (eognato del Marchese) fu riehiamato come Capitano del Popoloe l'esereito spagnolo, ristabilito I'ordine, ripartl infine da Siena nell'aprile del1531. Le nostre tre conuncdie si eolloeano sullo sfondo di questi avvenimenti.Si veda N. Newbigin, Politics and Comedy in the Early Years ofthe Accademiadegli Intronati ofSiena, in M. de Panizza Lorch (a eura di), II teatro italiano delRinascimento, Milano, Edizioni di Comunita, 1980, pp. 123-134.
77 II soldato spagnolo in commedia nel '500...
aristocratica degli Intronati. Non a caso nel 1533 le veglie accademiche saranno proibite per un decennio proprioa causa di queste violente lotte di fazione, di cui talvoltaamplificano gli echi, anche se e importante riconoscere ilcontemporaneo tentativo di utilizzarle, al contrario, comestrumenti per promuovere socializzazione, pacificazioniinterne, 0 almeno per abbassare illivello degli scontri.
All'intemo dell'Accademia si riuniscono infatti gentiluomini di entrambi i fronti politici, soprattutto schierati(con funzioni diplomatiche 0 incarichi istituzionali) dallaparte degli imperiali, ma si contano anche dei popolari,come ad esempio Mario Bandini e Achille Salvi, e ne eautorevole membro, con il nome di Desiato, il potenteduca di Amalfi Alfonso Piccolomini, soppiantato per alcuni mesi come rappresentante imperiale da don Lope deSoria, quindi reintegrato nelle sue funzioni come Capitanodel Popolo; entrambi costoro vengono messi in commediain un sottile gioco di rimandi alla cronaca po1itica, nienteaffatto scontato 0 inoffensivo.
L' esercizio della scrittura e della recita si configuradunque come una sorta di psicodramma collettivo, eoccasione per ripercorrere giocosamente vicende traumatichee per disinnescarne l'impatto in chiave amorosa e caval1eresca; la destinazione di questi testi resta pen') ambiguamente sospesa fra pubblico e privato: c'e un gioco di fittirimandi interni a 1uoghi e personaggi cittadini (analogo aquello della misteriosa Veniexianay, ma c'e anche l'ambizione di fame una sorta di manifesti, che ricomponganosimbo1icamente le lacerazioni interne in modo pacificato eunitario. Eprobabile infatti che I prigioni fossero destinatia una rappresentazione da tenersi alla presenza di Carlo V,impaziente e ingombrante tutore dell'indipendenza senese, mentre e celia 1a me desima destinazione prevista perGI'Ingannati, a cui l'imperatore avrebbe dovuto assisterepassando da Siena di ritorno dal congresso di Bologna del1530. In entrambi i casi non se ne fece di niente e I'impegnativo obiettivo politico affidato alle commedie fu mancato; 1a successiva storia della commedia senese avrebbecollezionato un altro 'fiasco' c1amoroso dello stesso genere, quando, ne1l536, la recita dell'Amor costante, preparata per 10 stesso imperatore all'interno di una complessatrama di festeggiamenti ufficiali, non pote tenersi nei modiprevisti (con tutte le imp1icazioni del caso) e si realizzo
78 Marzia Pieri
soltanto a Bologna, pili tardi e in tono minore. Del resto1'intera storia del teatro italiano cinquecentesco ecostellata di simili disavventure, che confermano l'impasse politica che 10 sovrasta (e che alla fine ne avrebbe strangolato10 sviluppo storico).
1 prigioni - composti fra il dicembre 1529 e il gennaio 1530 e forse destinati a una recita prevista nello stessomese di gennaio - come si e detto, rielaborano profondamente la trama plautina di riferimento in relazione all'immediata cronaca politica: dei 1036 versi dell'originalelatino (riscoperto da Cusano net 1428 e stampato per laprima volta nel1472) solo quattrocento sono letteralmente tradotti; l'intreccio eabbastanza mutato, soprattutto nelquarto atto, con l'aggiunta di un personaggio femminile(la prigioniera Gostanza intorno a cui si dipana la vicendaamorosa) e di svariate moresche (cantate e in versi) che vivacizzano il parlato della recitazione a cui il pubblico nonera ancora pienamente avvezzo. La vicenda e ambientataa Siena, durante la guerra di Firenze all'indomani della difesa di Monte Peccioli da parte delle truppe imperiali; nelcorso della campagna militare ci sono prigionieri da ambeIe patti. II vecchio senese Alessandro tenta di riscattare ilfiglio Alfonso (arruolatosi fra gli imperiali e catturato daifiorentini con grave pericolo) comprando tre prigionierifiorentini per avviare una trattativa. La vicenda si sviluppafra scambi di identita, rivalita amorose (riguardanti Gostanza, sposa clandestina di Claudio, che gli imperiali nonvogliono vendere ad Alessandro), agnizioni risolutrici econflitti in moresca fra soldati spagnoli, tedeschi e napoletani, finche il Duca di Amalfi rimettera a posta le cosecome un classico deus ex machina. Sono cosi pertinenti iriscontri con la realta complessa e tragica dell'epoca, cheil comico della rappresentazione ne risulta inevitabilmenteridimensionato, per cui il congedo agli spettatori sottolinea come la commedia sia «stata piu rigida che amorosa[] accomodata ai tempi»!",
La successiva prova degl' Ingannati, recitati per il carnevale del 1532, eormai interamente originale e ripropone molti temi e motivi messi a punto nei Prigioni; anchequesta volta i fatti rappresentati sono riferiti a vicende
10 EGodenzo, nella quinta seena del quinto atto, a eongedarsi in questitermini dallc spettatrici, promettendo, per il futuro, "cosa piu piacevolc".
79 II soldato spagnolo in commedia nel '500...
traumatiche recenti: l'ambientazione e a Modena, pili 0
meno alla fine del 1529, quando sono ancora vivi e laceranti gli strascichi politici del sacco di Roma, rna moltidettagli interni rimandano alla realta senese. II plot contamina audacemente i Menaechmi (oggetto in questi anni dimolte riscritture, culminate nella prova straordinaria dellaCalandria), con motivi derivati dal Decameron e dall' Orlando Furioso, ripropone la centralita del tema amoroso,il pluringuismo (con massicci inserti di spagnolo e latinomaccheronico) e, soprattutto, quella stretta contiguita conla musica che aveva prodotto l'inserto delle moresche neiPrigioni.
La vicenda eancora strutturata intorno ai temi amorosied economici tipici della commedia, rna tutti i personaggisono reduci dai disastri della guerra, che sembra finalmenteconc1usa e che ha segnato pesantemente le loro esistenze.La grande novita (destinata a enorme fortuna nella drammaturgia europea cinque e seicentesca) e costituita dallacentralita di un'eroina femminile scampata allo stupro deilanzichenecchi che, vestita da maschio, lotta per riconquistare l'uomo amato che l'ha dimenticata, arricchendo laserie consueta delle gags carnevalesche tipiche della commedia (affidate ai servitori, al miles gloriosus spagnolo eal pedagogo omosessuale), di un intenso patetismo quasitragico. Benevolo patron della rappresentazione e l'onnipresente Duca di Amalfi, a cui eindirizzato, nella scena seconda del terzo atto, un ammiccante resume della recentevicenda politica italiana, dove tutti i partiti in campo vengono ironicamente accomunati in una dissacrazione moltocarnevalesca". Se l'imperatore Carlo V avesse assistito aquella festa ne avrebbe certo raccolto il messaggio irenicoe Ie speranze riposte.
La scommessa dei giovani accademici di intervenirepositivamente nella vita della loro citta attraverso 10 strumento del teatro si rinnova con l'Aurelia, composta probabilmente nell' estate del 1532, quando il benevolo Duca diAmalfi aveva ripreso il suo posto alla guida di Siena dopo imesi di luogotenenza dell'assai meno malleabile Don Lope
11 11 earattere allegorieo e metateatrale di questa scena, ehe passa inrasscgna tutti i principali attori politici eontcmporanei alia eommedia, e statoillustrato da R. Andrews, Gli "Ingannati" as a Textfor Performance, in «ItalianStudies», XXXVII (1982), pp.26-48 (in partieolare aIle pp. 30-33).
80 Marzia Pieri
de Soria", che campeggia nell'intreccio come un temibile signore. Eprobabile, come attestano vari riferimentifatti dal prologo, che il testa fosse destinato a una recitaprivata carnevalesca tenutasi durante gli anni del silenzioaccademico, sfidando i divieti ufficiali 13 delle autorita, Inomi dei personaggi e le circostanze dell'azione sono, dinuovo, cosi precisi e congruenti da aver fatto ipotizzareche la commedia porti in scena un episodio realmente accaduto, cioe una contesa fra tre pretendenti - fra cui unospagnolo, protetto appunto da Don Lope - per la mana diuna ragazza; l'imbroglio si risolve senza traumi, grazie auna serie di agnizioni che mettono fuori gioco due dei trerivali, rivelandoli, rispettivamente, fratello carnale e fratel10 adottivo della medesima. Questi tre testi, cosi vicini neltempo, sono accomunati da molti elementi: la loro genesie poliautoriale!", come testimoniano le strutture composite,costruite sulla base di una serie di "teatrogrammi?", cioe disequenze drammatiche di base suscettibili di molti possibilimontaggi, che verranno piu tardi in gran parte inventariate come lazzi nella Commedia dell'Arte", e che trovanoprecoci formalizzazioni iconografiche nella pittura e nelle
12 Carlo V 10avcva inviato a Siena per tcntarc nna mcdiazionc fra i Popolarial potcrc c i Novcschi, banditi dalla citta in scguito alia disfatta di Pavia del loroallcato Francesco I; la loro riammissionc in citta significava per l'!mpcratorcspagnolo non solo una sanzionc politica del proprio prcstigio, ma soprattutto lagaranzia di soltrarrc la piccola irrcquicta rcpubblica a possibili influenza cstcrnc.L'intransigcnza dci Popolari, appoggiati dal Duca di Amalfi, 10obbligo a forzarc lamana: il sostituto Don Lope, infatti, controllava militarmcntc la citta c il tcrritoriograzic all 'appoggio di un potcntc cscrcito guidato da don Ferrante Gonzaga, versoIc cui anghcric polcmizzano con durczza tanti tcsti tcatrali di qucsti anni. I contrastifra Ic magistrature scncsi e Don Lope furono aspri c culminarono, nel fcbbraio1531, nella richicsta all 'Impcratorc di un suo allontamcnto; il Marchese del Vasto,cognato del Duca di Amalfi, chc era ncl frattcmpo subcntrato a Ferrante Gonzaga,medic fra Ic parti fino al 22 marzo, quando I' !mpcratorc richiamo finalmcntcindictro Don Lope, L'azionc dell' Aurelia si collochcrcbbc dunquc nci primi mcsidel 1531, anchc sc ci sono alcunc incongrucnzc, sucui cfr.l'introduzionc di MircillcCclsc-Blanc alla sua cdizionc, allc pp. 24-25.
13 Ivi, p. 28.14 Molte ipotcsi sono state avanzatc dalla critica per idcntificarc, a tutti
i costi, dcgli autori (per cscmpio il Castclvctro 0 il Molza per gl'Ingallllati, 0
il Vignali per l'Aurelia), ma la peculiarita dcll'cspcricnza intronatica cproprioqucsto voluto anonimato collcttivo.
15 Cfr. Cfr. G. L. Clubb, Italian Drama in Shakespeare s Time, New Havenand London, Yale University Press, 1989.
16 Lc tcstimonianzc della rapidissima traslazionc delle commcdic scncsincl vasto archivio dci rcpcrtori attoriali come fontc di gcncrici di vario gcncrcsono moltcplici; ricordiamo qui la prcscnza dell'Amor costante nella Librariadi Giulio Cesare Croce del 1592, un riutilizzo zanncsco, ricordiamo pcro,assolutamcntc parallclo c complcmcntarc alia consacrazionc lcttcraria da parte,per cscmpio, di Bernardino Pino da Cagli ncl suo trattatcllo sulla commcdiaprcmcsso all' Erofilomachia di Sforza Oddi ncl 1578. Si vcdano Ic osscrvazionidi L. Ricco, "Su le carte efra Ie scene ", cit., pp. 127 c 262.
81 II soldato spagnolo in commedia nel '500...
incisioni sugli spettacoli italiani e le maschere diffuse intutta Europa fra '500 e '600.
In tutti questi testi i soldati spagnoli sono ospiti fissiin crescita drammaturgica, parlano la loro lingua (a beneficio, evidentemente, di una fetta cospicua di spettatori egrazie al fatto che molti autori, in primis il Piccolomini,conoscevano 10 spagnolo) e oscillano per il momenta fradue diverse tipologie sociali: nei Prigioni il Capitan Camillo e Alonso Spagnuolo si confondono fra gli oltramontani morescanti nelle esose trattative per il riscatto, ma giftnell'Aurelia l' Odorigo Gaioso, corteggiatore importuno diAurelia, e temibile e temuto anche se il prologo arnmiccaagli spettatori che gli spagnoli, "questa volta non farannodelle 101'0. State sicuri: avanti che partino di qua pagaranno il frodo"!'; la sua sconfitta arnorosa eresa accettabiledall'agnizione fraterna; il Giglio degl'Ingannati, invece,e uno spiantato soldataccio che campa di espedienti edi bugie e che la serva Pasquella prende in giro in tutti imodi. L'Amor costante, dove la struttura si fa complessae i messaggi politici ancora pili ambiziosi, eintrodotto dauna sequenza dialogata metateatrale fra il Prologo, indaffarato negli ultimi preparativi, e uno spagnolo di passaggioche chiede spiegazioni sull'allestimento, fa una sorta ditraduzione in simultanea e alla fine viene cooptato sedutastante nella compagnia per fare appunto la parte del capitano, rnentre la vicenda, assai romanzesca, rnescola a pienemani personaggi italiani e spagnoli tutti di rango, rispettoai quali il neo-capitano assunto al volo dal prologo, checontinua a parlare la sua lingua per lunghe sequenze, restaisolato dall'intreccio come un riempitivo utile a dare spessore storico alla vicenda con i racconti dei suoi trascorsimilitari, ed e solo comicamente vanitoso a proposito deipropri fatti di cuore". Gli spagnoli, dunque, sono una presenza costante, talvolta fatta oggetto di derisione, rna nelcomplesso rnaneggiata con riguardo; solo indirettarnenteaffiorano nei testi lampi polemici e beffardi che segnalanola tensione e i problemi della convivenza obbligata: peresernpio nel pili tardo Ortensio del 1560 c'e una scena in
17 Aurelia (Comedic anonyme du XV/e steele), edition critique introductionet notes par M. Cclse-Blanc, Paris, Univcrsite de la Sorbonne Nouvelle, 1981,p.64.
l' Cfr. l'introduzionc di N. Newbigin, pp. 14-15, alia ristampa anastatica(Bologna, Forni, 1990) dell'edizionc veneziana del 1540 dell' Amor costante peri tipi dell' Arrivabene.
82 Marzia Pieri
cui si lamenta la decadenza dei costumi senesi che si stanno chiudendo nella bigotteria e scambiano ormai I' onestaconla maleducazione: le libere gentildonne della citta, infatti, non restituiscono pili le riverenze ai cavalieri, comeerano abituate a fare con grande civilta e disinvoltura, perche gli stranieri, equivocando il messaggio, usavano prendersi troppe liberta 19.
II personaggio del soldato cresce dunque come elemento portante di vicende sempre pili articolate e complesse infunzione di una comunicazione diretta con una parte importante e autorevole dei destinatari; il suo ruolo di caproespiatorio pili 0 meno messo alIa berlina e contenuto intermini accettabilmente carnevaleschi. Nelle successivecommedie intronatiche (l'Alessandro con il Capitano Malagigi; il gia ricordato Ortensio con don Alonso; il Capitano Tiberio degli Scambi20) la situazione non cambia molto,anche se il prologo della Fortuna, intorno a11620, fa professione di prudenza politica, dichiarando espressamente(e non si sa rispetto a quale contesto circostante):
qui non vedrete gonfianuvoli, nebravure di tagliacantoniper non lasciare forse i difetti di qualche particolare cheposcia se ne risentisse co' propri recitanti, ma si bene uninsolente pedagogo" .
L' invenzione intronatica del soldato spagnolo ridicolo etemuto, cosi carica (a Siena) di ambiguita politica, trasmi-
19 Nella scttima seena del secondo atto due donne rieordano con rimpiantoil passato civile c libero di Siena: «"Ci sarebbe ehe dire un pezzo se volessimoraeeontare tulle Ie buone usanze dismesse. E pure cuna gran vergogna chc moltcdi queste giovane d'oggi abbiano preso un costume che, quando un uomo fa lororivcrcnza, fingono di non vedere, e se ne vanno intere come Ie contadine, senzapure abbassare un poco gli occhi, e si danno ad intendere ehe l'oncsta eonsistain non fare stima di persona. Al mio tempo sarcbbc stata tenuta una zotiea coleiehe non avesse resa la rivcrcnza." "Oh, sapete, ne sono stati eagione i forcsticri,ehe, quando una donna rendeva loro un poco di riverenza, eredevano d' ave riain un pugno, e forse estato ben fallo per levare l'oceasione de' lor vantamenti?»(L 'Hortensio comedia de gl'Academict Intronatl di Siena, in Venetia, appressoDomenico Farri, MDLXXIIII, p. 33).
20 Una prova e contrario di quanta veniamo dieendo c offerta dallaseomparsa del personaggio in due commedic senesi e intronatiehe ehe ei sonogiunte pesantemente rimancggiatc in ambito fiorentino, dove questa vis polcmicanon aveva ragion di esscrc, c preeisamente la Flora del Vignali c la Pellegrino diGirolamo Bargagli. Cfr. il mio saggio Fra vita e scena. Appunti sulla commediasenese cinquecentesca, in corso di stampa, nel 20 II, nel "Bullcrtino Senese diStoria Patria".
21 II testo di questa commedia anonima, tardo prodotto intronatico, cstatoriscoperto e pubblieato da D. Seragnoli all'interno del suo II teatro a Siena nelCinquecento. "Progetto" e "niodello" drammaturgico nell'accademia degli Intronati, Roma, Bulzoni, 1980, (cfr. p. 219 per la citazione).
83 II soldato spagnolo in commedia ne! '500...
gra quasi immediatamente in Veneto, facendosi inoffensivae letteraria con il Capitan Tinea della Talanta di Aretino del1542 e con il Capitan Torquato del Capitano di LudovicoDolce del 1545 (un altro volgarizzamento attualizzante delMiles gloriosus), fino alla coppia Capitan Dante e CapitanPantaleone della Fantesca di Della Porta, sui quali si shuttureranno Ie creazioni drammaturgiche degli attori di mestiere, come vedremo fra poco. Ma prima di addentrarsi nella successiva storia, tecnicamente teatrale, del personaggiobisogna ancora ricordare cosa succede a Siena su un altroversante, in spettacoli a cui presumibilmente non assistevano gli ufficiali imperiali 0 gli ospiti aristocratici, ma unpubblico cittadino di livello sociale inferiore, cioe quelli 01'
ganizzati e prodotti all'interno della Congrega dei Rozzi informe drammaturgiche non classicistiche, intrise di un realismo quotidiano e polemico. Anche in molti di questi testisi fa costante riferimento agli Spagnoli, ma a quelli in carnee ossa con cui la gente minuta aveva a che fare, responsabilidi devastazioni e ruberie, fisicamente prepotenti e minacciosi e dunque odiati e derisi: nella Commedia nuova in moresea di Marcello Roncaglia, del 1537, un contadino disperatosi traveste da predone spagnolo per uscire dai guai e neisuoi Inganni dei servitori, dell'anno successivo, compareuno spagnolo violento e manesco; nel Vanta di un soldatodi Antonio di Pietro di Mico detto il Correggiolo (1546) ilpro logo annuncia agli spettatori che gli spagnoli gli hannorubato il testa e i costumi; come ladroni e saccheggiatorisono evocati 0 raffigurati nella Lite amorosa di FrancescoContrini (1550), nella Mascherata della sposa che va a marita (1573) e nel Dialogo di Pastinaca e Maca del Falotico. E ancora: nel Batecchio del Fumoso (1549) i pastorilamentano le malefatte dei soldati che li hanno affamati ehanno tolto loro ogni velleita amorosa; mentre il Travagliodello stesso Fumoso denuncia con violenza l' occupazionemilitare di Siena ed e al centro di un serio incidente politicointerno: nel 1552 l'ipotesi della recita suscita un'aspra discussione fra i Rozzi, che temono appunto le reazioni deglispagnoli". L'autore eespulso dalla Congrega il 27 marzo,
22 Cfr. C. Mazzi, La congrega dei Rozzi di Siena nel secolo )..'V1, Firenze,Le Monnier, 1882, vol. I, p. 254 c R. Alonge, La riscoperta rinascimentale dellealro, in R. Alonge e G. Davieo Bonino (a cura di), Storia del teatro moderno econteniporaneo I La nascita del teatro moderno. Cinquecento-Seicento, Torino,Einaudi, 2000, pAS.
84 Marzia Pieri
fugge da Siena e la va a recitare a Roma; a fine anno la commedia viene infine recitata anche a Siena per il cardinale diFerrara Ippolito d'Este, luogotenente del re di Francia che eil nuovo difensore della citta; il prologo elogia i francesi cheli hanno liberati dall' odioso rischio di essere tutti mandatia remare a Piombino sulle galere imperiali, e l'intreccio epunteggiato di denunce della carestia e delle razzie operatein campagna dall'esercito invasore. Ancora una volta duevillani disperati si travestono da predoni spagnoli, imitandone goffamente la parlata.
A questi esempi se ne potrebbero aggiungere altri, eanche metterli a confronto con Ie prose narrative recitatefra i Rozzi durante le loro riunioni", dove ancora si associano agli spagnoli exempla di tono tragico 0 ridicolo,come nella questione XLII, proposta dallo Stecchito, relativa alla vicenda di una donna romana, messa incinta daun ufficiale spagnolo che le ha ucciso il marito e che, perevitare che si procuri un aborto, Ie rapisce il figlioletto finoal compimento della gravidanza.
A Siena, dunque, la percezione e la trasfigurazione seenica del tema appare profondamente diversificata a livellisocio-economici diversi, in materia inversamente proporzionale alla natura dei rapporti che autori e spettatori stringonocon gli occupanti, rna certamente la loro massiccia presenza in citra ne rende naturale il coinvolgimento teatrale; 1'uso della lingua spagnola in scena, prima di attestarsi comegergo attoriale, e diffuso e consolidato come strumento dicomunicazione con una parte cospicua della platea cittadina;un problema non sentito altrove, per cui ad esempio, nell'antologia veneziana gia ricordata, una nota della stampatore,in difficolta nel restituirne la grafia e i segni diacritici dellalingua, suggerisce senz'altro di trascrivere in modo approssimativo, e di risolvere poi il problema in scena, fingendo chesi tratti di storpiature recitative:
Et in universale per tutte quelle parole spagnuole [...Jsidice che non si attenda alla ortografia spagnuola, percheco i nostri caratteri solo non s' eper questa volta potutarappresentar pienamente, ne ce ne siamo curati perche
2J Presso la Biblioteea degli Intronati di Siena si eonserva una raeeoltamanoseritta intitolata Quistioni e chasi di pill sorte reeitate in 10 Congrega de'Rozi per i Rozi (eon segnatura H.XI.6) eontenente i resoeonti delle riunioni dellaCongrega dal gennaio 1532 a11549, dove il personaggio ritorna in vari contesti,sempre in ruoli scioechi 0 violenti.
85 II soldato spagnolo in commedia nel '500...
gl'italiani nostri meglio sapran proferir vegliacco, et hagliar, che vellaco e hallar. Et in quanta alle parole se molte non sono pure spagnole, avvertasi che gli autori l'hanfatto a studio perche mostrino aver corrotta la lingua inItalia?".
I comici dell'Arte, da subito in stretta relazione con ilbacino teatrale senese, ereditano il personaggio net "pacco" della drammaturgia intronatica a cui molto attingono,e trapiantano nei lora spettacoli il plurilinguismo iberico,rielaborando la parte in una serie di varianti personali deisingoli attori, che ripropongono la forbice originaria fral'altero gentiluomo e il bravaccio ridicolo. La parte implica una doppia competenza verbale e performativa (e delresto gli esordi scenici erano stati in moresca, come ancoraricordano a meta '600 le sagome duellanti e danzanti deicapitani di Callot); Domenico Bruni spiega che quella delcapitano euna parte tecnicamente difficile proprio per ragioni verbali: "s'il Capitano parla spagnuolo serrato, diceche non l'intende, se italianizato grida che non fa bene daspagnuolo'?"; si richiede la capacita di inventare un gramelot comunicativo fortemente connotato, uno spagnoloda palcoscenico certamente ormai lontano da quelle recitesenesi degli anni '30.
Le bravure del Capitan Spavento di Francesco Andreini (ex soldato in proprio) sono del 1607, e del 1621 e lacommedia-generico di Silvio Fiorilli I tre capitani vanagloriosi, che compendia, in un'intricata rete di peripeziefamiliari, tutte le possibili varianti del soldato fanfarone,che l'autore (napoletano e quindi esperto di spagnoli) interpretava magistralmente come Capitan Matamoros, inconcorrenza con i grandi Capitan Rinoceronte di Girolamo Garavini (che l' Arlecchino Martinelli giudicava il migliore dei tre) e Capitan Spavento di Francesco Andreini.E ricordiamo che Fiorilli eanche l'inventore di Pulcinella, un autentico doppio del capitano, altrettanto alienatoe surreale. II percorso seicentesco della parte, che non euna maschera ma ne ha molte caratteristiche, non equi dinostra pertinenza, ma ricordiamo un'altra tessera senese di
24 Delle commedie elette novamente raccolte insieme con le correzioni e allnotazioni di Girolamo Ruscelli, libro I, Venezia, Plinio Pietrasanta, 1554, p. 291.
25 D. Bruni, Miserie de' Comici. Prologo da Fantesca, in F. Marotti G.Romei, La Commedia dell 'Arte e la societabarocca. La professione del teatro,Roma, Bulzoni, 1991, p. 388.
86 Marzia Pieri
questa storia, che da realistica si fa vertiginosamente artificiosa e astratta: si deve a un professore in Siena di linguaspagnola, traduttore di Cervantes e autore di un vocabolario spagnolo-italiano, Lorenzo Franciosini, la stesura diuna potenziale raccolta di parti Ie Rodomontadas espaholas, recopiladas de los comentarios de los muy espantosos,terribile e invencibles capitanes, Matamoros, Crocodilo yRajabroqueles (Rodamontate 0 Bravate spagnole, cavateda' comentari de' spaventevolissimi, terribilissimi, ed invincibili capitani Ammazzamori, Coccodrillo e Scheggiabrocchieri, Venezia 1627). Falliti i tentativi di dialogo,rimaste inascoltate 0 impraticabili le denunce di merito,resta i1 ridicolo come sublimata e inoffensiva vendetta dicartapesta.