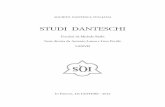Sidney Sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia, in "Rivista di Studi Danteschi", n. 2 / 2014,...
Transcript of Sidney Sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia, in "Rivista di Studi Danteschi", n. 2 / 2014,...
374
SIDNEY SONNINO: UN CASO DI BIBLIOfILIA E DANTOfILIA
In tutte queste affinità passanti tra la Divina Com-media e la loro emancipata ed autocritica persona-lità protestante, i dantisti della Riforma trovaro-no uno stimolo ideale al proprio amore a Dante.1
1. La passione antiquaria tra Sette e Ottocento
L’Ottocento fu un secolo in cui il collezionismo librario erudito ed antiqua-rio di marca settecentesca, aristocratica, venne soppiantato dai grandi capitalisti borghesi che facevano incetta delle edizioni pregiate e rare, per farne collezioni private uniche che poi prevalentemente diventano pubbliche per il senso di fi-lantropia di personaggi come Andrew Carnegie, John Pierpont Morgan e altri capitani d’industria.2
L’idea di questo articolo nasce dall’accostamento dei concetti “amore per Dante” e “amor di libro”,3 un binomio non nuovo, dal momento che chi colle-ziona edizioni pregiate e rare di Dante è tecnicamente un bibliofilo, di un gene-re – si potrebbe dire – evergreen, come la letteratura critica dantesca, ma inevita-bilmente con una specializzazione piú o meno esaustiva, vista l’ampia messe pubblicistica che in epoca moderna la bibliografia dantesca ci offre.
In una testimonianza dell’epoca ricaviamo lo spirito con cui Sidney Sonnino, partecipe di entrambi i caratteri suddetti, veniva allestendo la sua collezione:
Quella raccolta sonniniana di opere dantesche aveva formato una delle piú intense gioie intellettuali della sua vita. Volume per volume, egli era venuto radunando que’ libri nella propria casa, con la finissima comprensione del competente e dell’innamorato, non
1. P. Chiminelli, La fortuna di Dante nella cristianità riformata (con speciale riferimento all’Italia), Roma, Bilychnis, 1921, p. viii, dall’introduzione firmata « dalla Fiorenza di Dante, 14 maggio 1921 ».
2. Cfr. A. Kerbaker, Lo scaffale infinito: storie di uomini pazzi per i libri, Milano, Ponte alle Grazie, 2013.
3. Al binomio del titolo è intitolato un paragrafo del mio contributo per i 150 anni dell’U-nità d’Italia presso la Società Dantesca Italiana di Firenze: R. De Laurentiis, La ricezione di Dante tra Otto e Novecento: sondaggi tra bibliografia e diplomatica, in Culto e mito di Dante dal Risorgi-mento all’Unità. Atti del Convegno di Firenze, Società Dantesca Italiana, 23-24 novembre 2011, a cura di E. Ghidetti ed E. Benucci, in « La Rassegna della letteratura italiana », a. cxvi 2012, pp. 443-94, alle pp. 467-70. Ad esso si rimanda per notizie sullo stato del collezionismo librario dell’epoca, in particolare la fetta di mercato che nei cataloghi viene etichettata come “Dante-sca”, e per l’evoluzione storica del culto di Dante nell’arco del nostro Risorgimento.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
375
con la cieca prodigalità del collezionista danaroso. I testi piú antichi, gli esemplari delle edizioni piú rare, gl’introvabili incunaboli ornati delle prime incisioni in legno dell’arte della stampa si trovano in quella raccolta, ricca tra l’altro di un esemplare della Commedia nell’edizione fiorentina dell’Àncora e di un altro esemplare dell’edizione Fulignate [e dell’incunabolo di Federico de’ Conti, Venezia (già Jesi), 1472], appartenuto ad Ugo Fo-scolo e al Panizzi e postillato dal primo.4
La bibliofilia in generale venne poi alimentata dai progressi dell’arte tipo-lito-grafica nel XIX secolo che permisero la produzione di veri capolavori a metà tra manufatto artigianale e prodotto seriale industriale, per es. nelle dimensioni dell’oggetto tipografico.5 Nel 1878 si registra una Divina Commedia in 128° (1000 copie, pp. 499, 1 c. di tav. con ritratto, mm. 57 × 37), conosciuta tra gli appassio-nati e addetti ai lavori come il “Dantino”, uscito dalla Tipografia Patavina della Minerva dei fratelli Salmín.6
Un altro risultato delle moderne tecniche di stampa fu la nascita del mercato delle riproduzioni facsimilari.7 Si veda il caso del facsimile di Vallecchi (2003) di un’opera dantesca di lusso del 1921: l’edizione della Vita Nuova – per il centena-
4. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 171, ma con qualche imprecisione bibliografica. Per un primo riscontro con i pezzi citati, cfr. Censimento dei Commenti danteschi. 3. Le « Lecturae Dantis » e le edizioni delle opere di Dante dal 1472 al 2000, a cura di C. Perna e T. Nocita, Roma, Salerno Editrice, 2012. Un veloce elenco del Fondo Sonnino rispetto al posseduto della Biblio-teca della Casa di Dante in Roma comprende: 12 incunaboli (le principes di Foligno e Venezia, 1472) dei 15 della Commedia, 27 delle 32 cinquecentine, le 3 edizioni del Seicento, 22 delle 32 del Settecento, ecc. (cfr. E. Esposito, La “Casa di Dante” romana e la critica dantesca, in L’A, n.s., a. xxxiv 1993, nn. 1-2 pp. 113-26); a distanza di vent’anni il patrimonio è passato a 37 edizioni della Commedia per il XVI sec., 10 opere per il XVII sec., 57 per il XVIII sec. (cfr. il sito web: http://www.casadidanteinroma.it).
5. I libri microscopici di solito hanno il testo inciso, litografato o impresso a cliché, e infatti dall’Ottocento col processo della fotoincisione si potevano rimpicciolire a piacere testi già stampati. Ben altro fascino hanno le edizioni minuscole realizzate con caratteri mobili (non troppo oltre corpo 4).
6. L’editore milanese Gnocchi, con Cesare Cantú, nel 1878 volle « innalzare tipografica-mente il piú piccolo tra i grandi monumenti levati a imperitura memoria di Dante ». Venne commissionata la fusione della serie tipografica alla fonderia Corbetta di Milano; Giuseppe Gech (1856-1941) compose il “Dantino” utilizzando, al ritmo di una pagina al giorno, un tota-le di 486000 caratteri di tipo bodoniano, detti “occhio di mosca” per le dimensioni, in corpo 2 su 3 punti; fu stampato dai fratelli Luigi e Antonio Salmín, titolari della tipografia a Padova; venne fuori un’ed. della Divina Commedia oggi presente alla Berio di Genova e al Centro Dantesco di Ravenna. Nel 1880 Hoepli pubblicò (in sole 50 copie) con le stesse dimensioni una Galleria dantesca microscopica: 30 fotografie dei disegni danteschi di Francesco Scaramuzza, con il testo di Cesare Fenini.
7. G. Malafarina, Bellezza e fedeltà: storia e cultura del facsimile, nel catalogo della mostra Miniatura viva: codici, facsimili, miniatori di oggi, Firenze, Biblioteca Riccardiana, 31 maggio-26 lu-glio 2013, a cura di G. Malafarina, Padova, Nova Charta, 2013, pp. 21-31: « letteralmente “fa’ una cosa simile”, calco neolatino apparso per la prima volta in Inghilterra già nel Seicento, ma
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
376
rio, su testo del Barbi (1907), commissionata dalla Banca Italiana di Sconto (so-cio benemerito della Casa di Dante) – fu stampata, imitando lo stile di un codi-ce miniato, dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo in tiratura limitata a 1321 esemplari numerati e firmati.8 Chissà che un esemplare di queste edizioni “speciali” non sia finito nella biblioteca di Sonnino.
2. Sonnino predantesco
Sidney Costantino Sonnino (Pisa, 11 marzo 1847-Roma, 24 novembre 1922),9 statista dell’Italia liberale tra Otto e Novecento (fu due volte capo del Governo: 1906, 1909-’10), in politica fu un “conservatore riformista”, « e come tale sapeva di riuscire inviso cosí all’estrema Destra come alla estrema Sinistra »;10 contrario a Giolitti a cui negò la fiducia nel 1892. Di famiglia ebraica originaria di Livorno: il padre Isacco fu banchiere, con affari in Egitto, si era sposato al Cairo con rito anglicano in ossequio alla fede della moglie inglese, dopo aver abbandonato la comunità israelitica di famiglia. Alla nascita di Sidney i genitori « dichiarano di professare il culto protestante, e protestanti nacquero e rimasero i figli e le figliuo-le ». I genitori infatti registrarono la sua nascita solo nel 1864, con una particolare dispensa concessa dal ministero di Giustizia per “ignoranza della legge”.11
entrato ufficialmente nell’uso comune solo nella prima metà dell’Ottocento dopo avere otte-nuto nel 1835 il beneplacito dell’Académie française ».
8. Per questa edizione commemorativa venne ricreata la filiera della manifattura di un codice medievale: « quasi tutto a colori è il ricco corredo illustrativo in cui si cimentarono due quotati artisti del tempo: Vittorio Grassi, autore delle immagini, e Nestore Leoni, che si dedi-cò ai fregi e al frontespizio. A Enrico Brignoli si deve la nitida trascrizione del testo », scheda di L. Cesareo, in Miniatura viva, cit., p. 64. L’edizione facsimilare Vallecchi presenta un volume di commentario a cura di Emilia Anna Talamo, storica dell’arte, in particolare della miniatura. « E non è raro il caso che la realizzazione del facsimile diventi l’occasione per uno studio par-ticolarmente approfondito, che di norma sfocia nel volume di commentario » (ivi, p. 25), come nel nostro caso. L’attenzione per la miniatura di fattura del 1921 (Grassi e Leoni sono accredi-tati nel frontespizio) ma, per ovvi motivi, richiamante uno stile medievaleggiante, si può de-clinare in forme diverse: « quella di una rappresentazione stilisticamente coerente con le me-raviglie contenute in quei vetusti tomi miniati dell’età di mezzo, e quella invece che piú libe-ramente si interconnetteva alle mode artistiche della propria contemporaneità » (ivi, p. 35). L’abruzzese Leoni (1862-1954 ca.) lavorò all’Istituto Geografico Militare di Firenze, fu abilissi-mo in calligrafia e disegno, specializzato nella realizzazione di codici miniati, tra cui proprio la Vita Nuova realizzata a partire dal 1919 e offerta nel 1923 a papa Pio XI (ivi, pp. 37-38).
9. Per un primo inquadramento biografico, vd. la voce a cura di A. Torre, in Enciclopedia Italiana (1949); vd. http://www.treccani.it/enciclopedia/sonnino-sidney-costantino-baro-ne/; e la sua scheda di senatore sul sito del Senato.
10. G. Biagi, Passatisti, Firenze, Edizioni La Voce, 1923, pp. 171-214, a p. 206.11. Ivi, p. 175: « Prima che il Codice Civile del 1865 regolasse la complessa materia, l’igno-
ranza della legge, per un acattolico, era giustificabile. Per i cattolici lo stato civile era tenuto dai parroci e s’iniziava con la fede di battesimo, ed anche per gli acattolici, in forza della legge
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
377
Il giovane Sidney frequentò l’università già all’età di 15-18 anni, rivelandosi un enfant prodige degli studi. Per la sua biografia utile è il medaglione (« la prima e piú significativa rievocazione della vita e, soprattutto, della giovinezza dell’uo-mo politico toscano »)12 che gli dedica Guido Biagi nel 1915, uscito su « La Lettu-ra ».13 Lo stile affabulatorio di Biagi restituisce in brevi ma efficaci tratti la vita di Sonnino, ripercorre le tappe dell’educazione nel Granducato:
A quei tempi, fra il 1859 e il ’60, gli studi secondari in Toscana si stavano a malapena ordi-nando […] non c’erano altre scuole pubbliche che quelle dei Padri Scolopi […]. Ma co-teste non erano scuole officiali, alla cui istituzione s’affrettò a provvedere il Governo Provvisorio Toscano istituendo quel Liceo Fiorentino che ebbe prima la sua sede in piazza Santa Croce, in faccia alla chiesa, e piú tardi, col nome di Liceo Dante, trasmigrò nei loca-li del convento di Santa Trinita in via Parione. Il R. Liceo […] sorse subito in antagonismo dal padre con l’Istituto degli Scolopi […]. A Pisa e a Siena, alle due Università toscane, si andava dopo aver compiuto il corso filosofico o quello di scienze, e per entrambi si ri-chiedeva un esame d’ammissione.14
Una volta all’università a Pisa, Sonnino studiò Scienze giuridiche, con tesi di laurea dal titolo Il testamento non ha effetto se non per la cooperazione tacita dello Stato che ne garantisce l’efficacia. Esso non ha nulla di comune con nessuna specie di contratto. Da subito mostra un’attitudine verso i temi politici e sociali, riscontrabile anche nella composizione del suo fondo librario di formazione, che si può enucleare dal catalogo (infra) conservato nell’archivio di famiglia a Montespertoli.15 Me-morabile resta lo studio condotto sulle condizioni socio-economiche della Si-cilia (« un’inchiesta all’inglese » nel biennio 1876-1877), svolta insieme al baro-ne Leopoldo Franchetti (1847-1917, anch’egli proveniente dalla ricca borghesia ebraica di Livorno), con cui condivise una lunga e solidale comunanza di ricer-che e di lavoro.
Nella Firenze post-capitale Sonnino partecipò attivamente alla fondazione di
toscana del 1817, gli stessi parroci avevano precisamente le medesime funzioni degli attuali ufficiali dello stato civile ».
12. P. Carlucci, Il giovane Sonnino fra cultura e politica: 1847-1886, Roma, Archivio Guido Izzi, 2002, p. 22 n. 16.
13. G. Biagi, in « La Lettura », vol. xv 1915, n. 7 pp. 603 sgg.; poi in Id., Passatisti, cit.; una galleria di ritratti che vuole essere quasi un bilancio di un’epoca che si chiude. Fra Sonnino e Biagi vi fu un carteggio, di cui le lettere dello statista al prefetto della Biblioteca Laurenziana sono conservate presso la Bibl. Nazionale Centrale di Firenze (avanti cit. BNCF), Carte Biagi, ins. 7, 34 (13 pezzi nel periodo 1878-1913).
14. Biagi, Passatisti, cit., pp. 178-79.15. A sud-ovest di Firenze, a Montespertoli, nella campagna del Chianti lungo la via vol-
terrana, il barone Isacco Sonnino acquistò un castello che fu già della famiglia del Machiavel-li (a quanto riferisce Biagi, Passatisti, cit., p. 196); a Sidney fu affidata dal padre la direzione del la tenuta agricola, che ancora oggi i suoi eredi gestiscono, conservano e promuovono alla frui-zione del pubblico.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
378
sodalizi e cenacoli, che si occupavano anche di arte e poesia (per es. il Circolo filologico), che avevano come riferimento il salotto buono della signora Emilia Peruzzi, nell’antico palazzo di Borgo de’ Greci e all’Antella.16 Alcuni nomi chia-ve di questa “Società dei pranzi settimanali” sono quelli di Pasquale Villari, Vil-fredo Pareto, Renato Fucini. Una rete di contatti del ceto di notabili della Destra storica liberale ben ricostruibile dal Carteggio di Sonnino degli anni 1891-1922.17
Proprio da una lettera a donna Emilia abbiamo indizi di come fosse lo stato delle sue conoscenze linguistiche e letterarie, a 25 anni; di come si andava per-fezionando nella lingua italiana, vista la sua formazione poliglotta, chiedendo consigli alla corrispondente.18
Fu amico di Zanobi Bicchierai (Prato 1816-1887) – letterato, giornalista, revi-sore di stampe dell’editore Le Monnier, insegnante di italiano e latino al liceo pubblico, direttore della Scuola normale maschile di Firenze –19 dopo essere stato suo allievo, insieme al fratello Giorgio. Dal Bicchierai – già noto alle cro-nache dantesche per essere stato, insieme a Giovanni Costantini, il traduttore e
16. L. Cerasi, Gli ateniesi d’Italia: associazioni di cultura a Firenze nel primo Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000. Nella BNCF si trova un piccolo gruppo di lettere di Sonnino a Tomma-so Cambray-Digny, amico d’università e redattore dello statuto sociale del Circolo filologico di Firenze, sorto nel 1870, e presieduto da Ubaldino Peruzzi. Cfr. P. Carlucci, Un’amicizia controversa: Sidney Sonnino ed Emilia Peruzzi (1872-1878), in Ubaldino Peruzzi: un protagonista di Fi-renze capitale. Atti del Convegno di Firenze, 24-26 gennaio 1992, a cura di P. Bagnoli, Firenze, Festina Lente, 1994, pp. 161-77.
17. S. Sonnino, Carteggio, a cura di P. Pastorelli e B. Brown, Roma-Bari, Laterza, 1974-1981, 3 voll. Tra gli altri corrispondenti, anche il ministro della Pubblica istruzione Edoardo Daneo, due volte in quel dicastero (1909-1910, 1914).
18. Pubblicata da P. Carlucci, Lettere di Sidney Sonnino ad Emilia Peruzzi: 1872-1878, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1998, p. 79; si firma il « romito di Montalbino » [frazione nella campagna di Montespertoli, dove Sonnino amava ritirarsi in solitudine], 11 ottobre 1872: « Continuo a leggere il Machiavelli, il Dante, il Foscolo, il Giusti, il Nievo – avrei la “Revue” e molti libri tedeschi da studiare, ma ho paura di escire dall’italiano per non interrompere il processo (si può dire?) di assorbimento. Credo che processo sia inglese, in questo senso. Nel Giusti ho trovato la parola “vago” nel senso di incerto, indeterminato. […] Nel Fanfani [Voca-bolario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1855] non c’è. Che ne dice lei? Nel Nievo poi trovo delle parole che mi paiono molto ardite ». Cfr. R. Melis, « Una babelica natura »: Sidney Sonnino, Emilia Peruzzi e il problema della lingua a Firenze dopo l’Unità, in « Lingua nostra », vol. lxiv 2003, fasc. 1-2 pp. 1-28.
19. Biagi, Passatisti, cit., p. 181: « correva da una lezione all’altra, sempre affaccendato e suda-to, senza veder nessuno attraverso ai grossi cristalli de’ suoi occhiali d’oro a stanghetta. Tutti lo chiamavano Bobi Bicchierai ». Cfr. A. De Gubernatis, Dizionario biografico degli scrittori con-temporanei, Firenze, Le Monnier, 1879, ad vocem. L’inclinazione letteraria del Bicchierai, una volta trasferitosi a Firenze, ebbe modo di svilupparsi in attività pedagogica: nel 1860 fu nomi-nato dal governo provvisorio toscano Ispettore per le scuole secondarie, e in tale veste diede alle stampe un discorso tenuto davanti agli alunni, dal titolo: Degli Ufizj dell’odierna letteratura in Italia, Firenze, Tip. Galileiana, 1860; e si ricorda anche un’Antologia poetica ad uso della gioventú, Firenze, Le Monnier, 1855.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
379
correttore delle fatiche bibliografiche del Batines, che proprio a Prato faceva stampare a metà degli anni Quaranta di quel secolo la sua monumentale, per quanto incompleta, Bibliografia dantesca –,20 è probabile che il giovane Sonnino ereditasse le curiosità bibliografiche dantesche, facendolo diventare amante delle edizioni della Commedia; se è vero che delle « affettuose relazioni »21 si in-staurarono fra il maestro e l’« antico discepolo suo »,22 che avevano trent’anni di differenza d’età.
In séguito, aggiunge Biagi di Sonnino: « il suo maggior godimento fu lo stu-dio, la ricerca solitaria del vero, la conversazione ideale con i grandi spiriti che hanno lasciato al mondo una indefettibile eredità di sapienza ».
3. Vicende delle carte Sonnino
Per il Centro studi Sidney Sonnino (fondo archivistico e annessa biblioteca) a Montespertoli, nel castello di famiglia, si veda innanzitutto l’Inventario. Il fon-do comprende 149 buste: « L’archivio di Sonnino è l’ennesima testimonianza, affermatasi nel corso dell’Ottocento e ancor piú nel Novecento, del prevalere degli archivi di persona sugli archivi di famiglia, in conseguenza di mutamenti che vedono la famiglia perdere progressivamente centralità nell’organizzazione sociale ed economica a favore dell’auto-documentazione dell’individuo, in di-pendenza delle cariche pubbliche ricoperte e nella contingenza delle attività della persona. La stessa finalità di conservazione dopo la morte, non avviene piú per motivi di continuità patrimoniale ma per motivi di ordine culturale, affetti-vo, politico e, a volte, anche economico ».23
Tra le carte Sonnino, dopo la scomparsa, l’intervento dell’autorità si limitò al prelevamento delle carte di Stato conservate presso l’abitazione romana, senza considerare la possibilità di esistenza di altri spezzoni di esse nelle ben note re-sidenze di Firenze (via Il Prato), Montespertoli e Castiglioncello (Castello del Romito); e per conseguenza si ebbe « una mancanza di linearità spazio-tempo-rale dell’archivio, risultato finale di vari eventi, a cominciare dalle dispersioni dovute alla pluralità delle sedi di conservazione, dalla frammentarietà e da lacu-
20. Cfr. P. Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia catalogo delle edizioni, traduzioni, codi-ci manoscritti e comenti della ‘Divina Commedia’ e delle opere minori di Dante, seguíto dalla serie de’ bio-grafi di lui. Traduzione italiana fatta sul manoscritto francese dell’autore, Prato, Tip. Aldina, 1845-1846, 2 tomi (Nuova ediz. anast. con una Postfaz. a cura di S. Zamponi, Roma, Salerno Editrice, 2008, 3 tomi).
21. Carlucci, Il giovane Sonnino, cit., p. 44.22. Cosí Sonnino si definisce in una lettera da Roma, 16 ottobre 1880, indirizzata a Bicchie-
rai (BNCF, Carteggi vari, cass. 226, n. 186). 23. Inventario dell’Archivio Sidney Sonnino, a cura di R. Baglioni, Firenze, Polistampa, 2010;
le citazioni da R. Baglioni, Nota archivistica, ivi, p. 14, partic. nn. 7 e 10. Cfr. anche Sidney Son-nino e il suo tempo. Atti del Convegno di San Casciano in Val di Pesa e Montespertoli, 1997, a cura di P.L. Ballini, Firenze, Olschki, 2000.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
380
ne incolmabili ». Le tessere del mosaico erano i « referti, verbali, appunti di col-loqui avuti con personalità del calibro del principe von Bülow, insieme ai rap-porti della Questura […] parte delle carte Sonnino pertinenti alla politica inter-na, pari a due buste, era stata depositata presso l’Archivio centrale dello Stato ».
Alla morte di Sonnino mancò quindi un intervento tempestivo in grado di assicurare l’integrità del suo lascito documentario e librario all’archivio compe-tente per territorio. Sembra infatti che la biblioteca della dimora romana di Sonnino (via delle Tre Cannelle, 13) sia andata smembrandosi già durante il Ventennio (informazione avuta da Letizia Pagliai, conservatrice dell’archivio).24 Nel dopoguerra inoltre gli eredi scelsero di alienare il palazzo romano, con all’interno la collezione bibliografica prevalentemente non-dantesca, per evita-re la fiscalità patrimoniale dell’epoca; pare che tra gli acquirenti piú attenti ci fosse un giovane Giovanni Spadolini, già professore universitario di Storia con-temporanea, che rilevò l’intera collezione della « Nuova Antologia », rilegata dalla prima annata del 1866 (informazioni avute da Caterina de Renzis Sonnino e Cosimo Ceccuti).
4. Dante e la Riforma
Il culto per Dante di Sonnino, come si è visto con retroterra ebraico da parte di padre e anglicano da parte di madre, subisce una forma di annessione in uno scritto di Piero Chiminelli, La fortuna di Dante nella cristianità riformata (con speciale riferimento all’Italia),25 dove viene definito « il piú grande ministro dantofilo che la terra del Poeta abbia espresso » – senza dimenticare peraltro il De Sanctis ministro dell’Istruzione del neonato Regno – ed è allineato sulla sponda della cultura protestante; benché Sonnino si ritenesse un laico e acattolico (cioè un cristiano non cattolico).26 La sua religione non fu quella ebraica del padre, né
24. Baglioni, Nota archivistica, cit., pp. 14-16: « Resta in ultimo da chiarire il nesso esistente tra le sue carte ed il vastissimo patrimonio librario raccolto ed oggi irrimediabilmente meno-mato. […] Si trattava soltanto di alcuni frammenti di quell’attività, di testimonianze saltuarie ed incomplete, ovvero di contributi utili solo se contestualizzati a piú organiche collezioni e ad archivi ad essi complementari ».
25. Piero Chiminelli, pastore protestante formatosi alla Scuola teologica battista di Roma, fu molto attivo nella evangelizzazione: tenne conferenze su argomenti religiosi e filosofici (Giordano Bruno) e di attualità (sulla pace); si stabilí in Sicilia alla fine del primo decennio del Novecento, con nomina a pastore ufficiale della chiesa di Floridia (prov. di Siracusa); qui si occupò di istruzione con doposcuola, università popolare, fondazione di un circolo culturale.
26. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 164: « È vanto altissimo del protestantesimo ita-liano che un sí grande personaggio gli appartenga e ne sia anzi l’espressione piú alta di quella sete di perfezione e di nobiltà morale che interiormente lo tormenta », riferendosi a Sonnino, per quanto possa attagliarsi anche al trasmutabile Dante; si menzionano i grandi interpreti dell’« ininterrotta tradizione della Riforma italiana – tradizione che da P. Sassi e da L. Castel-vetro vien giú fino a Sonnino » (p. 170). Un canto che i protestanti riformati avranno apprez-zato è senz’altro Par., xxix, in particolare la terzina: « Non disse Cristo al suo primo convento:
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
381
quella anglicana della madre (Sonnino era « un protestante che con i protestanti in carne ed ossa non aveva niente da fare », ha notato Giorgio Spini), ma piutto-sto « una religione basata solo sulla coscienza individuale o lontana dai dogmi e dalle liturgie delle fedi rivelate »: la religione del dovere.27
Come nella tradizione riformata protestante vale, tra le altre, la regola della Sola Scriptura (la Bibbia è l’unica autorità per il cristiano), cosí nel rapporto elet-tivo di Sonnino – cresciuto in un ambiente di cristianesimo riformato – con la Divina Commedia sta « la vera ed intima ragione dell’impero spirituale che Dante – piú d’ogni altro nel mondo dopo il Libro dei libri – esercita su gli italiani con il suo poema ».28 E infatti l’evangelico battista Piero Chiminelli, nel fare la storia della ricezione dantesca nella cristianità riformata, punta ad esaltare questa par-te del mondo cristiano come la piú adatta ad accogliere Dante come “testimone della verità”, con opportuno richiamo al Vangelo di Giovanni (colloquio con Nicodemo, iii 7: « dovete nascere dall’alto »), alla « nuova nascita predantesca-mente descritta nell’Evangelio dello spirituale apostolo e tanto oggi necessaria agli uomini della vecchia Italia! ».
Chiminelli poi fa risuonare questo evento con l’Incipit vita nova dantesco, forse anche con qualche forzatura a detrimento dell’amore eziologico per Bea-trice (l’allegoria dei poeti),29 ma funzionale alla visione di un lettore evangelico di Dante (secondo l’allegoria dei teologi). Mentre l’aggancio sarebbe anche piú congruo con l’explicit del prosimetro: quell’« intelligenza nova […] / […] pur su lo tira » dell’ultimo sonetto (vv. 3-4), che Dante stesso ci aiuta a interpretare in prosa: « Ne la seconda [parte del sonetto] dico perché va là suso, cioè chi lo fa
/ “Andate, e predicate al mondo ciance”; / ma diede lor verace fondamento » (vv. 109-11), da interpretare con Marc., 16 15: « Gesú disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vange-lo ad ogni creatura” ». Cfr. anche Evangelici in Parlamento (1850-1982): discorsi parlamentari di Sidney Sonnino [et alii], a cura di G. Long, Roma, Camera dei Deputati, 1999, pp. 281-315, per una forma simile di cooptazione.
27. Cfr. G.B. Varnier, Sidney Sonnino e la questione religiosa, Firenze, Olschki, 2000. Per spiegare la posizione di Sonnino, mi rifaccio alle parole del filosofo ed economista Friedrich von Hayek (1899-1992): « Il Protestantesimo mi è sempre parso come un passo nel processo di emancipazione da una superstizione. Un passo che, una volta compiuto, deve portare alla completa assenza di fede. Ma il buonsenso che sta alla sua base può pur sempre tenere una persona, che non accetta tutte le dottrine cattoliche, all’interno della cristianità. In altre parole, ho sempre ritenuto che solo i due estremi, fede o assenza di fede, fossero due posizioni stabi-li » (cfr. F.A. von Hayek, Autobiografia, trad. it., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 19).
28. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 168. G. Spini, Sonnino e l’Inghilterra, in Sidney Son-nino e il suo tempo, cit., pp. 1-4, riferisce che a Montespertoli c’è ancora la Bibbia che era appar-tenuta alla madre Giorgina, e su cui Sonnino ha segnato la data della sua morte, con l’indica-zione « questo è il piú triste giorno della mia vita ». Anche l’identificazione della figura di Bea-trice con « solo un’altra presenza femminile beatificante » è, secondo Spini, una chiara allusio-ne alla madre.
29. Tuttavia sull’origine e il significato da attribuire al titolo del prosimetro, cfr. da ultimo l’incartamento di A. Casadei, Dante oltre la ‘Commedia’, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 227 sgg.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
382
cosí andare » (Vita nuova, xli 4). Invece Sonnino nella lectio di Par., vi, usa il sin-tagma Incipit vita nova per scandire – sulla scorta di D’Ancona –30 il passaggio epocale dai fasti imperiali di Federico II, con la effimera fiammata di Arrigo VII, a un « movimento della civiltà [che] procede a spirale e non a circoli chiusi » (un’allegoria dei politici?).31
In ambiente riformato poi torna utile e viene evidenziata la polemica dante-sca contro il potere temporale della Chiesa (termine papismo di fonte protestan-te coniato nel XVII sec.): nella terza cantica l’invettiva fiammeggiante di s. Pie-tro in persona (« Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio », Par., xxvii 22-24) non poteva non fare di Dante il campione del protestantesimo, come il latore di un « indi-stinto senso d’un mondo che si trasformava; della ribelle indipendenza moder-na del giudizio; dell’impronta individuale regolatrice delle iniziative esteriori ed interiori dell’uomo moderno previsto dal Virgilio dantesco »32 (« libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non fare a suo senno », Purg., xxvii 140-41).
Anche il ripescaggio di testimonianze documentali su Dante viene ad essere argomento per la propaganda protestante: « nella constatazione della fallibilità d’una chiesa che si diparte dai basilari principi evangelici; nell’audacia d’opporre un fiero “Quod nihil fiat” alle esorbitanze ecclesiastiche »;33 nell’affermazione del sapere laico e, infine, nell’avvertita necessità di un ritorno alle pure origini cristiane.
5. Dantofilia
Il “lavoro seguitato” su Dante da parte dello statista livornese iniziò relativa-
30. Cfr. N. Vianello, s.v. D’Ancona, Alessandro, in ED, vol. ii 1970, pp. 302-3: « Della Monar-chia […] pose in rilievo la novità del concetto che l’informa: l’instaurazione di un’autorità nuova, morale e giuridica, “sotto il cui patrocinio gli uomini formerebbero una sola famiglia”, congiunta non dalla violenza, ma dalla concordia ».
31. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, Bari, Laterza, 1972, 2 voll., vol. ii (1903-1920), p. 1198: « Arrigo VII fu l’ultimo imperatore che rispondesse all’ideale schiettamente ghibellino; come Bonifacio VIII fu l’ultimo pontefice che impersonasse il principio teocratico del medio evo. […] Dante sognò un ritorno al passato, che non era possibile; ma con la stessa sua idealiz-zazione del passato spargeva i germi di un avvenire, da lui non travisto nella sua forma reale, bensí nello spirito suo di cosmopolitismo, di tendenza alla pace, alla libertà, alla tolleranza ».
32. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. vii.33. Ibid., in nota: « È questa la frase scultoria che Dante, mentre fu priore a Firenze, scrisse
di suo pugno sotto una esagerata richiesta, ch’era una esorbitante pretesa, di papa Bonifacio VIII. Da qui nacque la prima fiera animosità tra il poeta ed il pontefice ». L’episodio risale alla radunanza del Consiglio dei Cento il 19 giugno 1301, chiamata a decidere sulla richiesta del pontefice (nella persona del segretario Matteo d’Acquasparta) di prorogare la concessione del presidio di cento cavalieri fiorentini in suo aiuto nella guerra contro Margherita Aldobrande-schi, il solo « Dante Alagherii consuluit quod de servitio faciendo domino pape nichil fiat ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
383
mente tardi, poiché nelle ricerche condotte sul giovane Sonnino, che indagano la biografia fino ai quarant’anni, Paola Carlucci non ha rilevato riferimenti con-tinuati a Dante Alighieri e alla Commedia – d’altronde anche De Gubernatis nella scheda del 1880 non ha modo di alludere a un Sonnino “dantista” – salvo qualche recensione di libri di argomento dantesco; e il ricorso a versi danteschi in sede epigrafica in almeno due casi da me rintracciati: un breve articolo del 1873 e la traduzione nel 1905 dei saggi di Theodore Roosevelt.34
Pertanto solo nel pieno dell’attività politica di Sonnino, con l’inizio del nuovo secolo, potrà nascere quell’inclinazione dantofila, che lo porterà a farsi collezio-nista, lettore e critico. Il dantismo di Sonnino è collocabile nel generale moto di « acceso patriottismo » seguíto alla lunga stagione risorgimentale, e per alcuni aspetti non ancora conclusa alla fine della grande guerra; sebbene in veste ag-giornata rispetto a certi cascami di idolatria e retorica dantesca.35
« Come sempre sognò la elevazione e la redenzione d’Italia, cosí egli associò costantemente a questo suo sogno l’altro della massima espansione di Dante nel mondo ».36 Nell’archivio di Montespertoli è presente un dossier sulla “natura-lizzazione” nel diritto comparato, con un documento intestato a Bonaldo Strin-gher, Relazione del vice presidente Stringher al xvi Congresso della ‘Dante Alighieri’ […] 21 ottobre 1905 [studio dell’emigrazione italiana e sui diritti di cittadinanza, Roma 1905, 40 cc.].37 Questo ci ricorda come la nascita e il consolidamento della « So-cietà nazionale Dante Alighieri » nelle capitali e nei principali paesi esteri fosse importante in quel periodo per offrire un punto di riferimento alle numerose comunità di italiani all’estero, per acculturarli, o alfabetizzarli nel caso prevalen-te di operai, di basso livello sociale e culturale; e per creare una sensibilità per i diritti da esigere nel paese ospitante.38
34. Il primo passo dantesco è Purg., i 71-72, usato per Una proposta, in « Fanfulla » del 21 gen. 1873, firmandosi « Spartaco »; l’altro, Inf., xxvi 119-20, nello stesso anno della conferenza su Par., vi: in oltre trent’anni Sonnino compie la parabola da lettore per sé a conferenziere dantesco. Sono debitore dei riscontri alle ricerche di Paola Carlucci.
35. Cfr. P. Carlucci, Senza politica: l’ultimo Sonnino (1919-1922), in Sonnino e il suo tempo (1914-1922), a cura di P.L. Ballini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 307-24, a p. 319 (apparso anche su « Rivista storica italiana », vol. cxxi 2009, n. 2 pp. 869-88).
36. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 12. 37. Per es. nella busta 65 (Materiali a stampa e manoscritti sulla naturalizzazione, il diritto di fami-
glia e l’educazione, 1895-1913) si trova un fascicolo contenente una raccolta di materiale a stampa per una comparazione internazionale della legislazione in tema di naturalizzazione (disegni di legge, 1904-1907, con precedenti). A differenza di oggi, all’epoca erano gli italiani emigrati all’estero che lottavano per vedersi riconosciuti i diritti; di queste realtà Sonnino ebbe espe-rienza diretta durante la carriera diplomatica.
38. La nascita nel 1889 della « Società nazionale Dante Alighieri » si deve a un gruppo di esuli triestini capeggiati da Giacomo Venezian; ebbe filiali in tutte le grandi città del mondo. Cosí recitava l’art. 1 dello statuto: la Società « si propone di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana fuori del Regno ». Sonnino ne diventa socio nel 1900 su invito di Ernesto Na-
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
384
Un ruolo valido tutt’oggi, con Dante che rappresenta il simbolo (brand per usare un termine di moda) della italianità nel mondo, in senso culturale e com-merciale, qualcosa di simile agli Istituti italiani di cultura all’estero. Tuttavia le difficoltà oggettive sulla diffusione e difesa della lingua italiana all’estero c’erano allora come oggi, ed erano ben chiare a Sonnino consapevole dei limiti di una rete di sedi estere come quella della « Dante Alighieri », e anche di possibili scon-finamenti rispetto alla loro funzione originaria, come ribadito in un passo del suo carteggio: « non doveva fare dell’irredentismo e della politica ma occuparsi soltanto della difesa della lingua »;39 come pure bisognava tenere presente il li-mite della « Dante »: « trovo sempre troppo ambizioso il programma. Lo limi-terei alla diffusione della lingua, senza mescolarci il “genio italico” e la “civiltà italiana”. Con la lingua si ottiene il resto, e non si eccitano diffidenze e divisio-ni ».40
Chiminelli attribuisce la dantofilia di Sonnino a due ragioni: la prima è – co-me detto – quella risorgimentale, di ordine storico o anagrafico; l’altra di ordine privato: « L’altro impulso che attrasse Sonnino nel cerchio magico di Dante fu una sottile affinità e quasi un’intima relazione che intercede fra il suo spirito e il suo mondo morale e lo spirito e il mondo morale di Dante ».41 Negli estimatori di Sonnino emerge infatti l’inevitabile paragone con Dante: « E se oggi a Trento Dante piú non attende, se oggi il Carnaro bagna confini italici, gran parte del merito spetta a questo magnifico patriotta [sic] il quale […] era stato l’unico ta-citurno in un paese di chiacchieroni ».42
than. A proposito della nostra lingua in Sud America, egli riferisce di aver sentito raccontare di « figlie d’Italiani uscire dalle scuole italiane dell’Argentina “cinguettando tra loro in castiglia-no”; e non c’è un comunetto argentino, non che un parlamentino provinciale colà in cui sia permesso discutere in italiano. L’avvenire italiano colà mi par dunque una illusione finché si voglia preparare co’ mezzucci della Dante Alighieri » (cfr. E. Minuto, Il partito dei parlamentari: Sidney Sonnino e le istituzioni rappresentative (1900-1906), Firenze, Olschki, 2004, p. 42).
39. Sonnino, Carteggio: 1891-1913, cit., p. 512. Cfr. A. De Lucis, Abusi consolari: il ministro Sidney Sonnino nell’interesse degli emigrati e della giustizia provvede alle manchevolezze dei R. Consolati italiani d’America, San Francisco, s.e., 1918.
40. Sonnino, Carteggio: 1891-1913, cit., p. 221, pezzo n. 210, lettera a Villari, Roma, 24 feb-braio 1898; si tenga conto che Pasquale Villari fu presidente della « Dante » dal 1896 al 1903.
41. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 166: « Un’istintiva e signorile temperie di auste-rità e di rettitudine ravvicina l’esule della Fiorenza del Trecento al ministro di Stato dell’Italia del secolo ventesimo. Se il primo venne definito cantore della rettitudine, questi può a ragio-ne chiamarsi lo statista della rettitudine ».
42. Ibid. Altro aneddoto simile in Biagi, Passatisti, cit., p. 214: « Si racconta che il principe di Bülow, partendo da Villa Malta, quando nel maggio 1915, cercò di impedire che l’Italia parte-cipasse alla guerra, abbia esclamato: “Fra trentasei milioni di chiacchieroni italiani, il solo ta-citurno doveva proprio capitare a me! C’era ancora qualche spina a Villa delle Rose! ». Villa Malta era la dimora romana di von Bülow, base per il suo tentativo fallito di far rimanere l’I-talia neutrale nella grande guerra. Anche G.A. Haywood, Failure of a dream: Sidney Sonnino and
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
385
Piú privatamente la cifra dell’ “isolamento” nelle vicende cruciali della vita attiva e politica poteva funzionare come denominatore comune tra Sonnino lettore della Divina Commedia e il suo Dante. Lo studioso neozelandese Geoffrey Haywood ha evidenziato come nella prevedibile sconfitta elettorale del 1904, Sonnino cercasse la consacrazione dello sconfitto, integerrimo e solitario. Un atteggiamento psicologico rivelato in una lettera a Pasquale Villari, nella quale l’impopolarità politica è associata all’integrità.43 Inoltre l’origine ebrea di Sonni-no, mai rimossa, nonostante lo esponesse alla diffidenza della Repubblica delle Lettere o della dialettica politica,44 insieme al milieu protestante cui veniva acco-stato, costituirono un elemento di differenziazione tanto per la famiglia che per Sonnino come uomo pubblico.45
Non è casuale che Sonnino nella lettura di Par., vi, parlasse di « alto insegna-mento morale che raggia da ogni pietra di questo titanico edificio », egli subí il fascino di Dante fino a farne colui che « al di sopra dei partiti, vecchi o nuovi, ciascuno dei quali vorrebbe invano appropriarselo, al di sopra delle particolari credenze ed opinioni, egli vola come aquila, personificando quanto vi è di piú lea-le e diritto, di piú squisitamente morale nell’anima di nostra gente ».46
the rise and fall of liberal Italy: 1847-1922, Firenze, Olschki, 1999, p. 4, non manca di segnalare l’a-spetto caratteriale: « Throughout his public life, Sonnino was notorious for being Il taciturno and Il solitario. One historian has described him as the “most enigmatic of Italian politicians”. Another [Giorgio Spini] refers to him as “a sort of sphinx” ».
43. Lettera citata in Haywood, Failure of a dream, cit., p. 288 n. 79, del 5 luglio 1899: « Cer-tainly Dante made this role available to him in a way that dignified all his repressed romanti-cism and melancholy. This may explain why, at this time of political set-back, he delivered one of his rare public speeches outside parliament, a speech on canto vi of Dante’s Paradiso ».
44. Nell’Ottocento si ricorda Carducci che, sulla nascita della « Rassegna settimanale », giu-dicava i fondatori Sonnino e Franchetti come « due israeliti [… che] hanno l’ottima idea di ri-metterci 60mila lire, pur che vada », lettera a Lidia [Carolina Cristofori Piva] del 16 dicembre 1877, in G. Carducci, Edizione Nazionale delle opere, vol. xi. Lettere, Bologna, Zanichelli, 1947, pp. 211-12. Per il Novecento valga l’esempio intinto di retorica antiebraica in funzione soprattutto politica del D’Annunzio, La coscienza nazionale, in « Il Giorno », 21 maggio 1900. Tuttavia come ha precisato Spini, Sonnino, cit., p. 1: « aveva certamente sangue ebreo in senso biologico nelle vene per via degli avi paterni, però non era ebreo – ripeto – perché secondo la legge ebraica è ebreo il figlio di madre ebrea; inoltre il padre prima che Sonnino venisse concepito aveva ab-bandonato l’ebraismo per aderire alla Chiesa d’Inghilterra ».
45. Carlucci, Il giovane Sonnino, cit., p. 43: « si tratta di un elemento significativo nella co-struzione della sua personalità che non può essere trascurato ».
46. S. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’ letto nella sala del Collegio Nazzareno in Roma, Firenze, Sansoni, 1905, p. 39 (corsivo mio). Haywood, Failure of a dream, cit., p. 289, riporta il passo di Sonnino tradotto in inglese. Sulle tipicità del genere lectura, confronto e dissenso con esegesi pregressa, « rischio dell’ingerenza personale del chiosatore nei luoghi di piú difficile compren-sione », cfr. E. Landoni, “Lectura Dantis” tra istituzionalità e libertà, in Dante in lettura, a cura di G. De Matteis, Ravenna, Longo, 2005, pp. 51-62, a p. 53.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
386
6. Officina dantesca
Nella sezione dei manoscritti dell’Archivio Sonnino sono presenti le stesure delle recensioni per la rubrica « Bibliografia » della « Rassegna settimanale ».47 Le opere di argomento dantesco schedate sono:
– uno studio in francese di Filomeno Abate, Dante dans les impressions de La-martine, Messine, Impr. Capra, 1878 (3 cc., pp. 65-66 della busta 12);
– La Vita Nuova di Dante Allighieri, con proemio e commento di Giuseppe Romanelli, nuova ed. ad uso delle scuole, Viterbo, Monarchi, 1878 (7 cc., p. 83 dell’inserto 12 della busta 7, fasc. 1, vol. ii, n. 5, data Firenze, 4 ago. 1878);
– Gherardo Ghirardini, Della visione di Dante nel Paradiso terrestre: tesi di laurea, Bologna, Fava e Garagnani, 1878 [ma 1877] (pp. 133-34, 3 cc. dell’ins. 10, b. 7, fasc. 4, vol. ii, n. 8, data Firenze, 25 ago. 1878);
– Pietro Mattei, Della sintassi e dello stile dei predecessori di Dante: studi, Trieste, Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico, 1878; p. 203, 3 cc. (ins. 12, b. 8, fasc. 4, vol. ii, n. 12, data Firenze, 22 sett. 1878);
– Alessandro D’Ancona, Il Veltro: studi danteschi di Isidoro Del Lungo, pp. 70-73, 5 cc. dell’ins. 4, b. 12, fasc. 3, vol. vi, n. 135, data Roma, 1 ago. 1880;
– Andrea Gloria, Del volgare illustre: dal sec. VII fino a Dante, Venezia, Antonelli, 1880; pp. 94-95, 2 cc.
La busta 67 invece contiene « manoscritti e studi danteschi, 1905-1920 », si di-vide in 3 fascicoli: due contenenti il materiale per le lecturae Dantis; e il terzo contenente « appunti, spunti e riflessioni inerenti alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso » (s.d., cc. 1-270, con allegato quadernetto). È superfluo rilevare che dal materiale di studio e ricerca su Dante, la preferenza di Sonnino doveva andare verso la seconda e terza cantica, per registro e contenuti stilisticamente piú affi-ni alle sue riflessioni, non trovando nell’Inferno sufficiente presa per i suoi inte-ressi.
Inoltre il Sonnino lettore aveva l’abitudine di annotare in quaderni – a mo’ di rubrica ordinata alfabeticamente per soggetti – citazioni letterarie e aforismi. Si ricorda che l’edizione della Divina Commedia usata per le citazioni nelle letture è quasi sempre quella oxoniense del Moore (Tutte le opere di Dante Alighieri, 19043 [18941]), che aveva il vantaggio pratico di raccogliere in un solo volume tutta
47. « La Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti », fondata da Sonnino e Leopoldo Franchetti (esce dal 6 gennaio 1878, con sede in via Tornabuoni 4, fino al 1882), fu un foglio innovativo per l’epoca, divenendo uno dei canali del positivismo nei vari campi del sapere, con collaborazioni di Carducci, Ferdinando Martini, Enrico Panzacchi, D’Ancona, Bartoli (pseud. Tiresias), Alessandro Chiappelli. Ai primi segni di crisi la redazione si spostò da Firenze a Roma, in coincidenza con la carriera politica di Sonnino (dal maggio 1880, eletto nel collegio di San Casciano Val di Pesa), e dopo il 1882 si ebbe la trasformazione in quotidiano.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
387
l’opera dantesca,48 mentre per un’edizione italiana simile bisognerà aspettare il 1921. Per gli strumenti di corredo, Sonnino ricorre al lavoro di Paget Toynbee, A dictionary of proper names and notable matters in the works of Dante (1898), ma nella versione Concise (1914); per la vita di Dante utilizza invece Boccaccio, e lo cita esplicitamente al termine della lettura: « Il suo nome per essere stropicciato dal tempo sempre diventerà piú lucente »,49 come il gradino in marmo della soglia del sacello di Dante a Ravenna, levigato e consumato dai tanti passi in pellegri-naggio.
7. Lectura Dantis come identificazione: Paradiso, vi
Un’avvisaglia della letteratura italiana delle origini usata per contrappuntare le vicende della propria vita, in effetti Sonnino ce la dà allorché avendo deciso di rinunciare alla carriera forense, avanzò un’incompatibilità caratteriale, facen-dosi forte di una citazione dal Petrarca autobiografico,50 inserita in una lettera del giugno 1872 ad Emilia Peruzzi. La nobile fiorentina ricevette altre confiden-ze e riflessioni nelle lettere che Sonnino le scriveva: « Anche nella Divina Com-media scorgo la medesima morale – l’insegnamento vorrei che uscisse dai fatti e non si dicesse come si dice una predica ».51
È probabile che l’idea di una conferenza dantesca fosse partita dall’ambien-te fiorentino, presidiato da Guido Biagi, grande promotore di eventi culturali, stando alla proposta fatta già nell’inverno del 1903 a Sonnino di tenere una lezio-ne alla società « Leonardo da Vinci », cenacolo di varia cultura sorto nel 1902 a Firenze per iniziativa di alcuni intellettuali;52 invito poi declinato per i « mille
48. B.F. Brown, Prefazione, in Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., vol. i (1870-1902) p. xxi: « Per i due saggi [danteschi], dopo un attento esame degli appunti ritrovati a Monte-spertoli e a Roma alla Casa di Dante, è confermato che Sonnino si è servito quasi sempre della edizione oxoniense delle opere di Dante (1904), testo che è stato consultato per questa edizione ».
49. Tratto da La vita di Dante scritta da Giovanni Boccaccio, testo critico con introduzione, note e appendice di F. Macrí-Leone, Firenze, Sansoni, 1888, p. 75.
50. F. Petrarca, Posteritati, a cura di P.G. Ricci, in Id., Prose, a cura di G. Martellotti et al., Milano-Napoli, Ricciardi, 1955, p. 11: « Non perché non mi piacesse la maestà del diritto, che indubbiamente è grande e satura di quella romana antichità di cui sono ammiratore, ma per-ché la malvagità degli uomini lo piega ad uso perfido. E cosí mi spiacque imparare ciò che non avrei potuto usare onestamente, ed il comportamento retto sarebbe stato imputato ad impe-rizia ». Sonnino leggeva il passo nel volumetto Autobiografie: Petrarca [et alii], pref. di A. D’Ancona, Firenze, Barbèra e Bianchi, 1859, pp. 36-37, probabilmente nella versione di Antonio Marsand.
51. Carlucci, Lettere di Sidney Sonnino ad Emilia Peruzzi, cit., pp. 26-28 e 290 (corsivo nel testo).
52. Cfr. L. Orvieto, Storia di Angiolo e Laura, Firenze, Olschki, 2001, e A. Orvieto, Storia e
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
388
impegni parlamentari ».53 Tra le letture romane dei primi anni si registra appun-to Sonnino con Il canto vi del ‘Paradiso’: conferenza tenuta nella sala del Nazzareno in Roma, alla “Lectura Dantis” il 19 febbraio 1905.54 Nel decennio 1901-1910 si registra-no per lo stesso canto le lecturae di A. Colombo, Dante e Giustiniano (letto il 7 aprile 1900 a Vigevano, stampato a Pinerolo il 1907), e di Orazio Bacci, che la eseguí a Firenze in Orsanmichele nel 1903.55
La lectura è ripubblicata nel 1972 da Laterza, con le giunte autografe seriori di Sonnino inserite nella copia di lavoro Sansoni 1905, e recuperate da Benjamin F. Brown (Università del Kansas), il quale con una tesi di dottorato – dal titolo The stranger in two worlds – a fine anni ’60 ha avuto il merito di far emergere l’archivio nel castello a Montespertoli.56 Nell’opuscolo del 1905 le note al testo – verosi-milmente letto nella conferenza in forma di manoscritto, o utilizzato come traccia per un discorso a braccio – sono stampate in fondo; mentre nella ristam-pa del 1972 sono a piè di pagina, e con la sigla n.d.c. quelle in cui Brown trascrive le postille di mano del Sonnino.57
La conferenza si apre con il richiamo alla serialità (« Come abbiamo visto nel canto precedente […] »), consueto nei calendari di lettura stagionali. Ma nella copia postillata Sonnino rimuove questo elemento deittico, pensando già a una nuova stesura saggistica autonoma.58 Nel limite canonico di un’ora di tempo,
cronaca della « Leonardo », a cura di N. Maggi, con un saggio di C. Del Vivo, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.
53. Lettera di Sonnino a Biagi, Roma, 15 dicembre 1903: l’ostacolo logistico di lasciare Ro-ma – anche solo per pochi giorni – a causa degli impegni pressanti della politica, verrà supe-rato optando per Roma come sede della conferenza, dopo poco piú di un anno.
54. Apparsa poi in « Nuova Antologia », s. iv, vol. cxvi, n. 40 (o 798), 1 mar. 1905, fasc. 200 pp. 3-21. Fu pubblicata, senza note, nel « Giornale d’Italia », 3 mar. 1905. Infine nella collezione sansoniana della « Lectura Dantis romana » (cfr. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit.).
55. Per questi riferimenti mi sono avvalso dell’utile repertorio Le « Lecturae Dantis » e le edi-zioni delle opere di Dante, cit., pp. 248-49.
56. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., pezzo n. 211, pp. 1177-211.57. L’edizione sansoniana (Lectura Dantis) del 1905 presenta nel colophon, in forma di trian-
golo rovesciato alla maniera delle antiche stampe: « Letto nella Sala del Nazzareno in Roma […] il iv [sic] febbraio mcmv ». Inizialmente Sonnino, con modestia, non pensava di essere pubblicato nella collezione sansoniana, vista l’uscita nella « Nuova Antologia », « e non sup-pongo che il lavoro possa avere un interesse sufficiente per una seconda riproduzione » (let-tera a Biagi, 21 feb. 1905). Ma dall’iniziale scetticismo, Sonnino sembra gradualmente convin-cersi della validità del testo della conferenza, chiedendo un parere a Biagi come dantista e uomo di editoria: « intorno alla eventuale ristampa della mia conferenza […] per parte del Sansoni; si fa? hai lette quelle note che ho aggiunte? ti sembrano opportune, oppur no? Se Sansoni accetta, quando mi manderà le bozze? e a quando il fascicolo? » (lettera del 10 mar. 1905).
58. Alla « Leonardo » che insiste per averlo come lettore di Dante, egli replica: « non mi è possibile disporre del tempo voluto per trasformare in qualsiasi guisa la mia lettura del canto vi. Ora non si tratta di una conferenza sul concetto dell’Impero nel Paradiso, ma di una semplice
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
389
davanti a un pubblico numericamente a metà tra uomini e donne, ma non al-trettanto nel condividere l’incombenza di « Questa morale [che] non s’indirizza a voi, gentili signore, che della cosa pubblica non vi occupate, ma volge il taglio a noi, uomini politici »;59 il conferenziere giunto al termine della dissertazione cita ancora due brani di Dante. Il primo è Conv., i 3 4-5, cosí postillato: « Non conosco nella nostra letteratura squarcio piú commovente di questo, nella sua semplice sincerità ». L’altro è: « Io non posso fuggir, ch’ella non vegna / ne l’ima-gine mia » (vv. 16-17 dalla celebre montanina Amor, da che convien pur ch’io mi do-glia), usati da Sonnino per riferirsi non alla donna amata da Dante ma alla sua Fiorenza la cui « crudeltà […] lo serra fuori », una traslazione che anche Dante svolge nel congedo della canzone.60
Sono due citazioni dal Dante dell’esilio, che richiamano la cifra di affinità che Sonnino sente verso il suo poeta; una “morale” che si riassume nella sentenza di Firenze del 10 marzo 1302 per la condanna a morte: « Igne comburatur sic quod moriatur »; un “fuoco” metaforico che entrambi subirono: nell’esilio Dante e nell’irriducibilità al piccolo cabotaggio della politica italiana e poi della diplo-mazia internazionale Sonnino; in tal modo per entrambi risuonò il giudizio: “siano banditi, cosí che non diano fastidio”.61
illustrazione del canto vi » (a Biagi, 23 feb. 1905). Dalla lettera a quest’ultimo emerge anche un curioso particolare: « fammi sapere […] con quale abito si fanno le conferenze di sera alla “Leonardo”, ossia se debbo portare costí con me la redingote o il frac. Naturalmente, a cose eguali, preferirei la prima » (ivi). La conferenza probabilmente fu ripetuta a Firenze (ospite della « Leonardo »?) o altrove, stante l’invito aperto da parte degli amici toscani. Quasi che ci avesse preso gusto alla nuova veste di dantista: « S’intende che da ora in là mi iscrivi tra i soci della Dantesca, in modo che io possa seguitare a ricevere il Bollettino regolarmente » (a Biagi, 20 dic. 1907). È da escludersi una lettura presso la Società Dantesca Italiana nel periodo 1906-1914, come risulta dagli Atti e notizie dell’Istituto; devo alla bibliotecaria Laura Breccia il con-trollo e la precisazione: « Durante la guerra le letture furono tenute nella Sala Luca Giordano del Palazzo Medici Riccardi ». Invece nell’aprile del 1921 Sonnino fu invitato a tenere una lectio su La politica di Dante da Del Lungo per conto della Società; ma ancora una rinuncia a causa di scarsa salute e di una malcelata diffidenza verso certe « carnevalate » del Centenario (lettera a Bergamini, 16 dic. 1921); per quanto da parte sua non vi fossero dubbi « verso chi è stato cosí efficiente strumento del risorgimento nazionale » (in The Dante Society Lectures, London, The Athenaeum Press, 1906, 3 voll., vol. ii p. 236).
59. Sono parole di Sonnino in chiusura della lectura: Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 40.
60. Ivi, p. 38; nel suo commento alle Rime dantesche, Contini ricorda « a titolo di curiosità, l’interpretazione politica del Bartoli: amore per Firenze » (Dante Alighieri, Rime, a cura di G. Contini, Torino, Einaudi, 1995 [19391], p. 205). Nel congedo Dante allude alla « crudeltate » di « Fiorenza, la mia terra, / che fuor di sé mi serra » (vv. 83 e 77-78). Si delinea qui un caso di lettore-interprete che adatta la lettera del testo dantesco, modificando il significato rispetto all’uso originario, per descrivere i sentimenti di Dante o di Sonnino stesso.
61. Cfr. G. Petrocchi, Vita di Dante, Roma-Bari, Laterza, 19933.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
390
Siamo a ridosso di un periodo intenso per Sonnino, i due incarichi come primo ministro del governo italiano, seppure brevi tra il 1906 e il 1909-’10. Se-condo Haywood la scelta di una lectio su Par., vi, avvenne perché « it examined the relationship between politics and justice ».62 A una esegesi totalizzante di Sonnino per il divino poeta e in particolare di Par., vi, un canto di storia e filoso-fia della politica calzante per il suo ruolo di diplomatico, fa pensare il passo: « Dante visse con intensa passione nelle lotte e negli avvenimenti del suo tem-po; le sue idee di ordinamento sociale e politico si collegavano strettamente con la sua fede religiosa, con tutte le sue convinzioni intorno e ai destini dell’uma-nità e alle leggi dell’universo ».63
Un canto che non poteva essere “interpretato” che da Sonnino, trattando della missione politica in terra dell’impero simboleggiato dall’Aquila, una sto-ria plurisecolare ripercorsa con prodigiosa sintesi ed icastica efficacia, dove Dante si serve del personaggio di Giustiniano per narrare le principali tappe della storia di Roma: « l’unico [canto] della Commedia che sia tutto preso dal discorso di una sola persona, dal primo all’ultimo verso » e appena una similitu-dine.64
Paradiso vi – com’è noto – richiede che si abbia la Monarchia accanto: quando a Costantino si rimprovera lo spostamento della capitale dell’impero da Roma a Bisanzio, e la pia intentio della donazione, è necessario richiamare il trattato latino di Dante a ii 12 8; e poi sciogliere il nodo dell’autenticità o ritenuta tale dell’atto di donazione di Costantino, una falsificazione avvenuta tra 750 e 850 d.C., ma scoperta solo agli inizi del XV sec., sebbene Dante stesso la revocasse in dubbio usando prudenza: dicunt, ut dicunt, poiché de iure « Costantino non poteva alienare l’imperio e la chiesa non lo poteva ricevere ».65
Un altro argomento richiamato dalla Monarchia (libro iii) « nell’accingersi a parlare della missione storica dell’Impero, [… è] la doppia natura, terrena e ce-leste, umana e divina, del Redentore », dalla quale discende la « singolare im-portanza dialettica e sentimentale che il Medio Evo annetteva alle analogie, ai simboli e alle assomiglianze simmetriche »,66 secondo un modello attivo anche
62. Haywood, Failure of a dream, cit., p. 289.63. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 6.64. Ivi, p. 5.65. Ivi, p. 7 n. 3, viene citato lo studio di J. Bryce, Holy Roman Empire, uscito da Macmillan
(London, New York) già negli anni Ottanta dell’Ottocento, il quale ritiene strano che Dante non mettesse in dubbio l’autenticità, o almeno la legittimità, dell’atto di donazione di Costan-tino. Sul tema cfr. B. Nardi, La “donatio Costantini” e Dante, in Id., Nel mondo di Dante, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1944, pp. 107-59, e P.G. Ricci, s.v. Donazione di Costantino, in ED, vol. ii 1970, pp. 569-70.
66. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 10; viene ricordato in particolare il cap. xvi del libro iii della Monarchia, presente nell’ed. Rostagno, ma riassorbito nel cap. xv nell’ed. a cura di P.G. Ricci.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
391
nell’Aquila imperiale,67 investita di una missione storica e divina a un tempo.68 Dante ricorda questo aspetto con citazione dal poeta noster Virgilio, quando An-chise preconizza al figlio: « tu regere imperio populos, Romane, memento » (Aen., vi 852, citato in Mon., ii 6 9). Il motivo simbolico dei due soli (Purg., xvi 107: papato e impero, cioè Pietro e Cesare), secondo Sonnino, era contrario sub specie allegoriae al topos dei “lumi celesti” (sole e luna) che da Gregorio VII era passato a Innocenzo III e Bonifacio VIII, in cui la luna (impero) ha una luce riflessa e non propria, « ogni autorità terrena dovendo derivare da quella ecclesiastica ».69
Sonnino allega il parere di James Bryce secondo cui la Monarchia, « in cui Dante espose sistematicamente tutta la sua teorica imperialista, è riuscito un epitaffio, anziché una profezia. […] Dante s’innamorò dell’ideale simmetrico della doppia potestà imperiale e papale, giusto quando, per la feroce lotta seco-lare tra loro, i due istituti si erano in gran parte reciprocamente fiaccati ». E in effetti all’epoca della lectura del 1905 si respiravano venti di guerra per le contese tra nazioni, uno scenario in cui il papato davvero appariva come interlocutore debole e poco influente.70 Anche Sonnino piú in là, da ministro degli Esteri, si rese conto di come la politica internazionale andasse cambiando: con l’inter-vento degli Stati Uniti nella grande guerra a partire dall’aprile 1917, il disegno del presidente Wilson di favorire la nascita di un organismo garante di un « nuovo ordine nelle relazioni internazionali » per una pace durevole, lo avrebbe spinto a smussare la concezione di “imperialismo” (politica di potenza o “sacro egoi-smo”) vecchia maniera.
67. Uccello-simbolo sia dell’egemonia politica di Roma che della volontà di Dio, di cui Roma è uno strumento. « Poscia che Costantin l’aquila volse » (v. 1) è l’unica occorrenza espli-cita, poi richiamata con perifrasi nel canto: « uccel di Dio » v. 4, « sacre penne » v. 7, « le sue ali » v. 95, « artigli » v. 107. Per ulteriori osservazioni, mi sono valso di N. Longo, Il canto della giusti-zia: ‘Paradiso’ vi, in « Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze », n.s., a. lxix 2007, pp. 105-43, con bibliografia finale dove però manca la lectura di Sonnino.
68. Mon., ii 5 19: « subiciendo sibi orbem cum jure hoc fecit »; ivi, ii 6 4: « Romanus populus ad imperandum ordinatus fuit a natura »; i passi sono ricordati in Sonnino, Il canto vi del ‘Para-diso’, cit., p. 41 n. 5. Mentre in Conv., iv 5 4: « ordinato fu per lo divino provedimento quello popolo e quella cittade, che ciò dovea compiere, cioè la gloriosa Roma ».
69. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., p. 1185 n. 14. Ovviamente – aggiunge Sonnino – una rettifica dottrinale e politica, quella di Dante, che non piacque ai gesuiti edito-ri della Commedia nel 1723, con dedica a papa Clemente XII. Un papismo ancora attivo nel 1891, quando la traduzione (Prato, Giachetti, con dedica a Leone XIII) del poema in latino a cura del frate minore Giovanni Bertoldi da Serravalle (risalente al 1416, durante il concilio di Costanza), viene modificata in nota con una variante (interpolazione) « lumi », ignorata dal traduttore che conserva « duos soles »; Serravalle completò il lavoro con un commento coevo alla traduzione.
70. Bryce, Holy Roman Empire, cit., p. 264. Per es. il famoso art. 15 del Patto di Londra – su richiesta di Sonnino – escludeva la Santa Sede da qualsiasi conferenza internazionale per la pace.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
392
Fine è l’osservazione sui luoghi che « Dante aveva dinanzi agli occhi in Ra-venna,71 mentre scriveva questi canti del Paradiso, i grandi monumenti erettivi da Giustiniano, e la stessa immagine di lui ritratta nei bellissimi mosaici della chie-sa di San Vitale », un corto circuito poi evidenziato in modo circostanziato dal ravennate Corrado Ricci.72
Un commento che Sonnino ha presente, per citarlo nella lettura, è quello del Tommaseo (1837), che « rileva a questo punto come un difetto la insistenza con cui, nel discorso imperiale, si batte ripetutamente sull’io di chi parla, e sul fatto stesso del parlare », ma Sonnino non è d’accordo col dantista dàlmata: « Tale ri-petizione però parmi voluta dal Poeta per accentuare il carattere personale del-la narrazione; con che si rendono pure piú naturali i bruschi trapassi da un argo-mento all’altro: dal discorso di sé alla storia dell’Aquila; dai partiti del tempo al-l’assetto del cielo di Mercurio, e da questo alle vicende di Romeo ».73
Il lungo e rapido volo dell’Aquila imperiale è il percorso di una missione che nell’immaginario storiografico di Sonnino ha provato a rivivere in figure ecce-zionali come il riformatore religioso Arnaldo da Brescia (discepolo del filosofo Abelardo, giustiziato nel 1155); o l’ultimo dei tribuni del popolo romano Cola di Rienzo (autore di un commento alla Monarchia, anch’egli conquistato dalla « pa-rola consolatrice di un altro profeta perseguitato »).74 Sonnino cita in nota Una lettera inedita di Cola di Rienzo e l’episodio collegato di una richiesta del tribuno romano al viceré aragonese in Sicilia per un’alleanza navale: « Tanto ingenua durava ancora, alla metà del secolo decimo quarto, la fede nella forza e nel dirit-to del solo nome di Roma ».75
Dissente poi da un « aspro giudizio » nella Vita di Dante scritta da Cesare Bal-bo: « Vedasi a quale assurdità tragga la ricerca dei fatti a prova di un cattivo argo-mento. Qui un fatto è provato buono solamente da ciò che è succeduto »; tutta-via il virgolettato di Balbo è a memoria, volendo Sonnino forse riassumere il
71. Ravenna, già sede della corte di Teodorico, aveva incarnato nella storia dell’Aquila im-periale un autonomo centro politico italico, per merito anche di intellettuali di primo piano come Boezio e Cassiodoro.
72. Cfr. C. Ricci, L’ultimo rifugio di Dante, Milano, Hoepli, 1921, e di recente L. Pasquini, Iconografie dantesche: dalla luce del mosaico all’immagine profetica, Ravenna, Longo, 2008.
73. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 21. Cosí Tommaseo: « da tali ripetizioni e fami-gliarità non rifugge. Ma troppo spesso il parlante accenna di parlare » (cit. dal Dartmouth Dante Project, ch. a Par., vi 82-84).
74. Tra 1905 e 1906 D’Annunzio avrebbe pubblicato su « Il Rinascimento » la sua Vita di Cola di Rienzo, poi in volume nel 1913. La recente edizione Dante Alighieri, Monarchia, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di D. Ellero, Roma, Salerno Editri-ce, 2013, ripropone in appendice il Commento di Cola, insieme ad altre opere che hanno costi-tuito l’epitesto storico del trattato dantesco.
75. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., pp. 41-42 n. 6; la lettera è pubblicata a cura di G. Tomassetti, in « Nuova Antologia », vol. iii 1904, p. 310.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
393
senso a commento delle dimostrazioni storiche che Dante dà a sostegno della sua tesi imperialista nella Monarchia.76
Sonnino si spiega precisando che « nel considerare Dante non dobbiamo vo-lerlo “appropriare a parte”, come egli accusa i ghibellini di fare del segno impe-riale. Non dobbiamo voler nemmeno, con un anacronismo degno della scola-stica medioevale, attribuire a lui una mentalità tutta propria del secolo nostro ».77 Se all’epoca in cui Dante scriveva l’elemento religioso filtrava « in ogni singolo fatto umano [e] pervadeva tutta la vita sociale », esso doveva essere percepito come epifenomeno della generale teodicea: « È stolta cosa il pensare che le forze che Dio conforta possano riuscire inferiori nella pugna ».78
Su come Sonnino vedesse la questione Chiesa e Stato, ho trovato un brano risalente al 1913, un rapido giudizio in cui si chiedeva « da chi debba dipendere la determinazione della linea di confine tra le funzioni dello Stato e quelle della Chiesa. […] Le cose di Cesare di qua, quelle di Dio di là. Ma in questo basso mondo,79 in pratica, non è cosí. Vi è sempre una zona grigia dove i due confini tendono a sovrapporsi e confondersi. Si cita san Paolo: “Oportet magis obedire deo quam hominibus”. Sta benissimo; ma gli uomini ci sono forzatamente cosí di qua come di là, nella Chiesa come nello Stato; e Dio parla dovunque luce una coscienza umana. Nel Medioevo la Chiesa reclamava imperiosamente per sé l’esclusivo diritto di tracciare la linea di confine; poi scese per forza di cose a piú miti consigli e si ricorse per secoli in via di transazione al sistema dei concorda-ti ».80 In definitiva Sonnino « continued to believe that the Church and the Lib-eral regime would always be “adversaries” ».81
Una settimana dopo la lettura del vi del Paradiso, nel numero del 26 febbraio 1905, la rivista nazionalista « Il Regno », solitamente vicina alle posizioni politiche dell’esponente della Destra storica liberale, in un pezzo dal titolo Corrispondenza
76. Cito ora da Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., pp. 1184-85 (oppure Id., Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 12 n. 7). Ecco il passo di C. Balbo, Vita di Dante, Firenze, Le Mon-nier, 1853, pp. 345-46 (ii 11): « a dimostrare e le strane aberrazioni dello spirito ghibellino, e come un altissimo ingegno possa essere da un falso assunto precipitato; e come, precipitando, Dante pur fosse trattenuto o dalla nativa moderazione, od anche piú dagli antichi pensieri, dagli abiti giovanili, e quasi dal sangue, dall’animo guelfo ».
77. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., pp. 12-13.78. Mon., ii 9 6, cit. in italiano in Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 13 (o Id., Scritti e di-
scorsi extraparlamentari, cit., p. 1185), che aggiunge: « Nessuno metteva in dubbio la ragionevo-lezza del giudizio di Dio, ossia del duello giudiziario [ordalia?], ed esso doveva valere per gli Stati a piú forte ragione che per gl’individui ».
79. Forse un’eco di « L’aiuola che ci fa tanto feroci » (Par., xxii 151)?80. Tratto dall’articolo Chiesa e Stato (con data 10 dic. 1913), raccolto nella silloge di brevi
scritti: Sonnino, a cura di G. Rabizzani e F. Rubbiani, Milano, Risorgimento (R. Caddeo & C.), 1920, pp. 34-35.
81. Cfr. Sonnino, Carteggio: 1891-1913, cit., lettera a Bergamini del 5 ago. 1903. Il passo ingle-se è tratto da Haywood, Failure of a dream, cit., p. 288.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
394
romana, faceva le lodi del discorso su Dante: « his utterly selfless determination to infuse Italian public life with patriotic faith ».82 Ma un riconoscimento piú si-gnificativo venne da Ernesto Giacomo Parodi nella recensione sul « Bullettino della Società Dantesca Italiana » del 1905: la conferenza « merita d’essere segna-lata per la sua grande limpidità, per la sicurezza di provetto dantista […] e soprat-tutto per la robustezza del pensiero storico e civile che domina e informa tutta l’esposizione ».83 Le due letture di Paradiso vi di Firenze (Bacci) e Roma (Sonni-no) sono rammentate da Giovanni Rosadi (un giurista di formazione), il quale notava ironicamente che questi « leggendolo a Roma, raccolse maggior gloria nel sacro poema di cento canti che nel suo onesto governo di cento giorni ».84
Nel Dartmouth Dante Project cercando il nome Sonnino, lo troviamo citato nel commento Casini-Barbi (1921) in quattro luoghi; tre volte nel commento Truc-chi del 1936; e una volta nei commenti Giacalone (1968) e Bosco-Reggio (1979), tutte occorrenze per il vi del Paradiso, a conferma di come la lettura dello statista, ancora all’altezza degli anni ’20 – finché durò il ricordo di essa – ebbe un certo rilievo, e alcuni luoghi critici sono diventati canonici, passando da un commen-to all’altro.85
8. Sonnino ambasciatore del dantismo in Europa
Non poté replicare di persona la lectio a Londra, su invito della Dante Society;
82. Ivi, p. 327 n. 134.83. E.G. Parodi, rec. a Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., in BSDI, n.s., vol. xii 1905, pp.
186-88. All’invito di Parodi con « cortesi espressioni », per conto della Società Dantesca Italiana, di tenere una lectura nella Sala d’Orsanmichele, Sonnino rinuncia perché « carico di lavoro e di impegni »; cfr. Fondo Parodi, busta n. 16, ins. 67, della Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, lettera da Antignano (Livorno), 29 ago. 1905. Sonnino poi ricambiava la stima verso Parodi dantista: « di alcuni suoi scritti danteschi […] ne farò pronta ricerca e li leggerò con grandissimo interesse ».
84. Cfr. E.G. Parodi, in BSDI, n.s., vol. xxv 1918, fasc. 1-3 p. 29, riferendo della lectura di Par., vi, di Rosadi in Orsanmichele nel 1911; e aggiunge: « Oggi, dopo averlo veduto, standogli assai vicino, alla prova, non gli negherebbe di aver raccolto gloria anche nell’azione politica, ma potrebbe dire invece (e soprattutto in questi ultimi giorni dell’agosto 1918), che non deve però avervi raccolto altrettanta gioia o soddisfazione che in quel tentativo letterario »; la precisa-zione amara è del Parodi, presidente del Gruppo Nazionalista di Firenze, che dall’appoggio a Sonnino (cfr. il telegramma del ministro degli Esteri a Parodi ancora suo sostenitore nel gen -naio 1918) passò alla delusione per gli esiti della conferenza di pace a Parigi. Ma vd. anche il « Forte, drammatico ritratto » nel tombeau di E.G. Parodi, L’On. Sonnino, in « Il Marzocco », vol. xxvii 1922, fasc. 49 p. 1.
85. Alcune chiose come: Bisanzio capitale dell’impero per volere di Costantino, con un « corso contrario alle leggi e della natura e della storia »; « Rovesciando in certo modo la tesi guelfa, che dalla incoronazione di Carlo Magno traeva argomento per far derivare ogni pode-stà imperiale dal Pontefice, [Dante] fa invece quasi dipendere dall’assunzione delle insegne dell’Impero per parte del Re franco la vittoria sua sui Longobardi e la salvezza della Chiesa » (Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., pp. 7-8, 22).
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
395
ma il manoscritto inviato per l’occasione venne letto da Mariano Cerasoli il 23 marzo 1906. Sonnino « had very kindly promised to read this Lecture at the meeting of January 30th; but a political crisis in Italy obliged this eminent states-man to remain at his post in the Italian Parliament and to accept on that very day from the King of Italy the charge of forming a new Government ».86
Fu cosí che continuò quella tradizione di uomini di Stato, anche al massimo livello, dediti privatamente a Dante, ma la cui lettura poi in modo quasi natura-le diveniva materia di riflessione anche filosofica e politica.87 Un segno del tem-po trascorso dalla lettura del 1905 si trova nella copia di servizio postillata da Sonnino, in cui, augurando un’epoca di pace come da annunzio evangelico, ag-giunge a mano: « ideale cui agogna pur oggi, dopo sei secoli da Dante, l’ancora parvoleggiante istituto della Lega delle Nazioni ».88
Il colloquio ideale, e anche dialettico, col suo poeta sulle « teoriche di ordina-mento politico »,89 continuava da parte del fedele lettore. Un “corpo a corpo” con i testi danteschi che ha modo di essere portato in pubblico nella visita uffi-ciale a Londra del 1917, stavolta come ministro degli Esteri, e un po’ ancora am-basciatore del dantismo, nel terzo anniversario dell’entrata in guerra dell’Inghil-terra, durante il discorso tenuto alla Queen’s Hall; in cui all’argomentazione geometrica del diplomatico, fa da puntello la citazione della lectio del 1905, con il passo del Convivio:
Gli scopi per cui lottiamo […]: la liberazione dei nostri fratelli [delle terre irredente …]; col desiderio costante di collaborare pure attivamente a tutti i tentativi di una maggiore organizzazione generale che assicuri per l’avvenire nel comity of nations il rispetto della equità e dell’umanità nelle relazioni tra gli Stati grandi e piccoli, e della piena libertà di
86. Dalla nota di Luigi Ricci (1841-1913), fondatore della London Dante Society (1881), che spiega l’assenza di Sonnino, nominato Presidente del Consiglio l’8 febbraio 1906. Il testo come letto da Cerasoli, senza note, è raccolto nel vol. ii di The Dante Society Lectures, cit., pp. 200-37; cfr. la notizia di E.G. Parodi, in BSDI, n.s., vol. xvii 1910, pp. 300-1. Ricci fu un esule garibal-dino di Vasto, in Abruzzo, concittadino di Gabriele Rossetti, entrambi insegnanti al King’s College e appassionati dantisti.
87. Nel vol. i delle Lectures, ho reperito il testo in inglese (trad. it. di Luigi Ricci) di una Lecture delivered at the xixth Annual Meeting of the Dante Society of London […] by the Baron [Fran-cesco] De Renzis il 7 giugno 1899, dal titolo Dante. Il barone De Renzis (1836-1900), originario di Capua e impegnato nella carriera diplomatica, fondatore del « Fanfulla » (1870-1899), aveva sposato la sorella di Sonnino, Edith, da cui ebbe tre figli, tra cui Leone, che ereditò le sostanze dallo zio celibe a patto che assumesse anche il cognome materno.
88. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., p. 1199 n. 36, usa il calco inglese League of Nations; la Società delle Nazioni nacque ufficialmente il 28 giugno 1919 – qualche prodromo già nel 1907 – con l’intento di superare le discordie tra Stati che avevano portato alla grande guerra, ed evitarne il ripetersi in futuro.
89. The Dante Society Lectures, cit., p. 208: « Le teoriche di ordinamento politico non possono in ogni periodo storico, per quanta varietà presentino tra loro, non essere tutte imbevute dell’ambiente generale del tempo ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
396
ciascuno Stato nel regolamento delle proprie questioni interne. Al quale proposito [co-me giustamente sta a cuore al presidente Wilson …], e a riprova che non sono un conver-tito dell’ultima ora,90 mi fo ardito ricordare alcune parole da me pronunciate, or sono dodi-ci anni, in una conferenza su Dante, a riguardo delle aspirazioni del divino poeta verso una monarchia universale, « … il quale tutto possedendo – cito le parole di Dante – e piú desiderare non possendo, li re tenga contenti nelli termini delli regni, sicché pace intra loro sia, nella quale si posino le cittadi, e in questa posa le vicinanze s’amino… ». Io dice-vo allora: « […] rimane sempre piú viva in ogni cuore ben nato l’aspirazione del Poeta (da raggiungersi bensí per altre vie che non quelle da lui vagheggiate), di una umanità piú strettamente unita […], pur rispettando insieme ogni maggiore sviluppo delle autono-mie nazionali e locali ».91
L’estimatore di Sonnino, Piero Chiminelli, avrebbe ricordato questo discorso cosí:
Per questa identità di rapporti ideali cui nella sua mente assurgono Italia e Dante, accad-de che allorquando a Londra [nel 1917] Sonnino fu invitato a parlare avanti a una folla innumerevole, egli chiese a Dante l’espressione del proprio pensiero e ricordando sere-namente la sua fede nell’amore dei popoli e nella pace feconda, frutto di giustizia inter-nazionale, egli addusse un passo del Convivio di Dante come proprio testo [il già ricorda-to Conv., v 4 4]. […] Quella conferenza sul canto in cui Dante celebra le origini divine dell’Impero Romano, diede a lui modo di esporre armoniosamente e senza nessuna violenza verbale il pensiero politico che anima tutta la sua attività d’uomo pubblico e la rettitudine dantesca che c’è in lui. Nelle magnifiche linee della sua esegesi che ricostru-isce idealmente la vagheggiata figurazione dantesca, il conferenziere dà vita e rilievo al proprio intimo io e a quel luminoso e tutto suo disegno di realtà politica e storica […]. Tale Dante e tale il suo interprete!92
Esempio suggestivo di come far rivivere la grande letteratura in funzione della stringente attualità, di utilizzarla perfino come guida. Pur con queste premesse,
90. Corsivo mio. Se Sonnino stesso accennò un’excusatio non petita, l’accusatio manifesta doveva essere quella “palinodia” che alcuni storici gli hanno attribuito, cioè l’aver abbandonato lo sche-ma imperial-coloniale di Disraeli, per assumere la coabitazione pacifica fra Stati: « La tesi impe-rialista di Dante è semplice nel suo ordito. Condizione alla felicità umana è la pace universale. […] Per ottenere questi postulati di civiltà e questa pace occorre una certa unità di organizzazio-ne generale dello stato », o di un sovra-stato come la Società delle Nazioni, e poi l’Onu. « Con ciò Dante non vuole soppresse le autonomie nazionali e locali », le quali devono essere rispettate e potersi sviluppare (The Dante Society Lectures, cit., pp. 220-21 e 224).
91. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., pezzo n. 310, 4 agosto 1917, discorso tenuto davanti al Prime Minister, pp. 1657-61, in inglese e italiano; uscito su « The Times » del 6 agosto; il manoscritto è in Archivio Sonnino. L’auto-citazione da Haywood, Failure of a dream, cit., p. 24 (o Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., p. 1197), e Conv., iv 4 4. L’inciso su Wilson manca nell’originale italiano, ma figura sia nel testo pubblicato come articolo sul « Times » sia nel discorso pronunciato a Londra (ivi, p. 1661).
92. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., pp. 166-68.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
397
in sostanza, al trattato di pace di Parigi Sonnino uscí perdente dagli accomoda-menti geopolitici, superato da un nuovo modo di fare politica estera; fu definito out of harmony con la nuova diplomazia. Un giudizio secco, spendibile oltre che per lo statista, anche retrospettivamente per la visione politica di Dante, tanto remota quanto impraticabile.93
I rapporti con i dantisti d’Albione erano proficui, sia per l’amore degli inglesi per Firenze, dove una folta colonia di intellettuali e artisti ormai risiedeva stabil-mente, e viceversa per diversi italiani che avevano inoculato la passione per Dante nei loro soggiorni anche forzati: Rossetti, Foscolo, Mazzini, Panizzi. Non si dimentichi che la Oxford Dante Society nasce in Inghilterra già nel 1876, quasi 12 anni prima che in Italia, ad opera di Edward Moore. Un primo ministro inglese, William Ewart Gladstone (1809-1898), fu anch’egli bibliofilo e appassio-nato di Dante.94
Invece come esempio di collezionista e studioso di primo livello insieme, si ricorda la figura di Paget Jackson Toynbee (1855-1932), che amava schermirsi dichiarandosi un « privato cittadino che si è dedicato a Dante »;95 tuttavia la sua Dante collection96 rappresenta un caso esemplare di collezione privata ad uso di un dantista, che poi viene messa a disposizione del pubblico degli specialisti:
The whole of my Dante collection, to which I am continually adding is to go to the Bodle-ian Library at Oxford. Dr Moore’s collection was bequeathed by him to the library of his old College, Queen’s College [Moore era scomparso nel 1916]; so that Oxford will be well provided in the future, & will have every encouragement to pursue the study of Dante.97
Moore e Toynbee decidono di lasciare la propria biblioteca dantesca, su cui
93. La definizione inglese si trova nel necrologio uscito su « The New York Times », 25 novembre 1922; cfr. I. Garzia, Sonnino alla Conferenza della pace, in Sonnino e il suo tempo (1914-1922), cit., pp. 289-305.
94. Cfr. William Gladstone: a prime minister who read books, in « The Telegraph », 7 ott. 2009; A. Isba, Gladstone and Dante: Victorian statesman, medieval poet, London, Royal Historical Society, 2006. La Società Dantesca conserva delle lettere autografe di Gladstone indirizzate all’abate Giuliani, titolare della cattedra dantesca a Firenze; una, esposta in mostra nella Sala Mazzoni del Palagio dell’Arte della Lana, ha data 20 dic. 1882.
95. Cfr. lettera del 15 feb. 1918 a Guido Biagi (BNCF, Carteggio Biagi 7, 63 [ins. 2]): « I am only a private individual who has worked at Dante for a good many years; & owing to various circumstances I have never had the chance of spending more than a few weeks, now more than thirty years ago, in Italy ». Nel 1909 Toynbee diede alle stampe l’ampia e documentata rassegna Dante in English literature: from Chaucer to Cary (ca. 1380-1844), London, Methuen, 1909, 2 voll. Inoltre gli va il merito storico di aver individuato la presenza del cursus come spia diri-mente per l’attribuzione a Dante della Quaestio de aqua et terra.
96. Cfr. D. Zancani, Una biblioteca di cent’anni fa: la « Dante collection » di Paget Toynbee (1855-1932), in Anatomie bibliologiche: saggi di storia del libro per il centenario de « La Bibliofilía », a cura di L. Balsamo e P. Bellettini, Firenze, Olschki, 1999, pp. 495-512.
97. Lettera del 30 nov. 1921 (BNCF, Carteggio Biagi, 7 63 [ins. 5]).
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
398
avevano basato le loro opere di studi e ricerche, alla Bodleian Library dell’Uni-versità di Oxford, in cui si erano formati e dove insegnavano. Della Dante Soci-ety Toynbee farà la storia nel 1920,98 dopo che ne era diventato segretario dal 1916, succedendo a Moore.
In verità, come racconta uno storico della biblioteca Bodleiana, le donazio-ni di Toynbee di materiale italianistico e dantesco erano iniziate già nel 1912 e proseguite fino a raggiungere cinque consistenti “rate” di lascito, lui vivente, quasi a sfoltire la libreria privata, lasciando per sé pochi ed eletti libri.99 Alla sua morte risultavano già donati 3785 libri, piú i 1400 volumi – la réserve dello studio-so – entrati in biblioteca per lascito testamentario. La Bodleiana poteva cosí fregiarsi con « one of the finest collections of the best Italian literature in Chri-stendom », custodita nella sala piú importante della Biblioteca, l’Auctarium.100
Per gli acquisti di Toynbee sulla piazza fiorentina un libraio antiquario ricor-rente è Ulisse Franchi (1833-post 1916), che « attende da mane a sera alla descri-zione dei testi, delle edizioni dei libri che vanno e vengono di continuo nella libreria di Oreste Gozzini ».101 Da lui Toynbee compra nel 1883 tre aldine, come
98. P. Toynbee, The Oxford Dante Society: a record of forty-four years (1876-1920), Oxford, Oxford Univ. Press, printed for private circulation, 1920, elenca soci con profilo, riunioni e materie trattate.
99. E. Craster, History of the Bodleian Library, Oxford, Clarendon Press, 1952, p. 282; e « Bodleian Quarterly Record », vol. iv 1923-1925, p. 75: « In 1912 Dr. Paget Toynbee sent to Bodley his first large donation, comprising some 360 works, chiefly printed editions of Boc-caccio and Petrarch, with some general works […]. In the next year a further series of 375 vo-lumes was received, largely Italian translations of the classics, with many Aldine, Elzevir, and Giunta editions. In 1916 about 350 volumes of editions of Dante’s works were added, and in the following year Dr. Paget Toynbee sent nearly 700 volumes of Dante editions, translations and commentaries. […]. The collection of portraits and masks in the Dante window of the Picture Gallery, and their description and arrangement, are also due to his generosity […] it is moreover, an Italian library of which the University and the Bodleian may be justly proud ».
100. Falconer Madan, paleografo e direttore della Bodleiana dal 1912 al 1919, scrisse lettere a Toynbee nel periodo delle donazioni, per ringraziarlo; in una del 13 giugno 1913 si compiace che « All the chief Dante scholars alive are connected with Oxford. You, the Vice-Chancellor, Shadwell, Moore, W.W. Jackson, Tozer ».
101. Vd. Note biografiche di un vecchio libraio, Ulisse Franchi, scritte da un amico in occasione della sua nomina a Cavaliere della Corona d’Italia, San Casciano Val di Pesa, Stab. tip. fratelli Stianti, 1916, pp. 5-6: « Datosi per tempo il Franchi al commercio librario, fu il creatore tra noi delle aste spesso combattute a torto da tanti librai italiani quanto erano accolte con favore all’estero e giudicate utilissime al commercio librario. Nel lungo suo tirocinio, compilò e diffuse oltre a mille cataloghi, ricca suppellettile di notizie preziose per i bibliofili e le biblioteche. Godé per questo titolo dell’amicizia di molti letterati e ricercatori intelligenti di libri. […] Né mancaro-no al Franchi lettere e diplomi onorifici di pubbliche biblioteche per doni ad esse fatti; né mancarono attestazioni di qual conto si tenesse il suo giudizio e la stima sul pregio degl’incu-naboli e dei libri piú rari, su le caratteristiche di certe edizioni e marche e disegni e stampe e incisioni, e silografie, e sulle legature piú famose ». Dopo aver diretto un paio di librerie a suo
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
399
riportato nella handlist di un quaderno intitolato « Catalogue of the library of Paget Toynbee », in cui il dantista inglese annotava località, libreria, prezzo e anno d’acquisto: un documento importante per la storia del collezionismo e del commercio librario. Se ne forniscono delle cifre riassuntive: su un totale di 272 libri risulta che il 63,23% venne acquistato in Italia, il 25,37% in Inghilterra, l’8,09% a Parigi e il 3,31% a Monaco di Baviera. Dei 172 pezzi comprati in Italia, le città piú ricorrenti sono Bologna (Romagnoli 64 + Zanichelli 3) e Roma con 47 pez-zi (Benedetti, Nardecchia, Silvio Bocca, ecc.).102
Il percorso inverso Londra-Roma fece l’incunabolo della Commedia stampa-to a Jesi103 e postillato da Foscolo, acquistato da Sonnino (come si ricava da una lettera a Biagi del 25 novembre 1907), dietro la consulenza dello stesso prefetto della Laurenziana – la casa di molti codici danteschi – che fece da mediatore con la parte venditrice, la vedova di Louis Fagan (1845-1903), conservatore del gabi-netto disegni e stampe del British Museum.104
Pure in Germania il dantismo romantico è legato all’iniziativa dantofila di bibliotecari (Julius Petzholdt) e monarchi (Giovanni di Sassonia); la Deutsche
nome, a séguito di avversità negli affari, divenne dipendente della libreria Gozzini. Cfr. F. Cristiano, L’antiquariato librario italiano di fine Ottocento e un suo protagonista: Ulisse Franchi, in Cento anni di Bibliofilia. Atti del Convegno internazionale di Firenze, 22-24 aprile 1999, a cura di L. Balsamo, P. Bellettini, A. Olschki, Firenze, Olschki, 2001, pp. 209-34.
102. Cfr. la descrizione dettagliata in Zancani, Una biblioteca, cit., p. 506. All’interno del piatto anteriore compare l’azzurro ex-libris di Toynbee con una citazione da Petrarca (Epist., i 7). Furono invece ricevute come « gift from A.J. Butler » (1894) Le terze rime di Dante (titolo di gusto classicistico, non piú ripreso), aldina del 1502 detta anche “vulgata del Bembo”, innova-tiva per il formato in-ottavo – mentre l’in-folio è tipico del XV sec. – senza commento, con testo curato filologicamente, stampato in corsivo; ne esistono contraffazioni (lionesi e italia-ne: Firenze, Venezia), senza note e marca tipografiche, sintomo del successo del formato ta-scabile creato da Manuzio, che firmava a volte anche le prefazioni. Cfr. F. Cristiano, L’anti-quariato librario in Italia: vicende, protagonisti, cataloghi, Roma, Editrice Gela, 1986.
103. Come si è creduto a lungo (fino al 1974, se non oltre) prima che si rettificasse il luogo di stampa in Venezia, nell’officina di Federico de’ Conti, che operò nelle due città ma in tem-pi diversi.
104. « Ho ritirato stamane dalla posta il Dante di Jesi – e ti ringrazio di tutte le noie che ti sei prese […] Ti sono grato di avermi fatto fare questo acquisto, dandomi occasione di salvare per l’Italia il prezioso volume. Aspetto con desiderio la tua illustrazione del volume ». Sonnino poi dà lui stesso una prima expertise: « Nel volume ci sono tre fogli manoscritti, il primo una specie di registro-indice, che non è della stessa mano degli altri due; ma non sembrano scritti della medesima mano nemmeno il 2° e il 3°. Quale è quella di Foscolo? Nell’Athenaeum [July 14, 1900] Mr. Fagan parlava di “several leaves of notes” di mano di Foscolo. Tu che hai altri manoscritti di Foscolo nella Laurenziana, ne avrai fatto il confronto ». Biagi avrebbe pubblica-to nello stesso periodo una « Nota bibliografica » (« illustrazione ») Di un esemplare dell’edizione di Jesi della ‘Divina Commedia’ appartenuto a Ugo Foscolo, Firenze, Stabilimento Aldino L. France-schini, 1907 (per le nozze della figlia di Olschki, in 100 copie), poi anche in « Rivista delle bi-blioteche e degli archivi », vol. xviii 1907, nn. 10-11 pp. 145-49.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
400
Dante Gesellschaft (1865) era sorta un decennio prima dell’omologa inglese; e contatti tra le varie società avvenivano grazie agli studiosi che si scambiavano i contributi, ma anche per mezzo di personalità politiche o di ricchi collezionisti che facevano da tramite per traduzioni di opere innovative nel campo degli stu-di danteschi. Un po’ come si è appena visto con Sonnino, in Germania una figu-ra utile per questi contatti fu Guglielmo Locella, console a Dresda, appassionato di Dante, che tradusse l’Iconografia dantesca di Volkmann (Firenze, Olschki, 1898).
9. Cantiere dantesco in editoria
Com’erano il dantismo e la dantologia all’epoca di Sonnino? Il cantiere del-l’edizione completa delle opere del poeta era in piena attività grazie alla nuo va filologia della scuola fiorentina, sapientemente coordinata da Michele Barbi; nel 1914 sarebbe arrivato il patrocinio dello Stato per l’Edizione Nazionale che av rebbe visto la luce nel 1921 con l’editio minor del Dante « in un solo volume », senza apparato.
Se prendiamo come limiti temporali le date delle due lecturae Dantis di Son-nino, 1905-1920, possiamo ricordare due anniversari: 1911 e 1921, rispettivamen-te 50 anni dall’Unità e 600 anni dalla morte di Dante. Dalla specola privilegiata della casa Olschki, attiva sia nel pubblicare titoli danteschi che nel ricercarne sul mercato antiquario, « di tempo in tempo aderendo alla parabola evolutiva della critica senza distinguersi almeno fino al 1920, per contributi particolarmente validi ed originali »,105 si notava che era proprio la connotazione elegante ed eru-dita della sezione dantesca del catalogo dell’editore ebraico che poteva incurio-sire un cliente come Sonnino.
Come coglie bene Cristina Tagliaferri, la fase pionieristica e fondativa delle prime edizioni critiche, con o senza apparato, e le edizioni scolastiche, erano compito di altri editori sulla piazza fiorentina: Le Monnier e Sansoni col loro blasone ottocentesco, l’ebraico Bemporad anch’esso dedito allo scolastico e a cui fu affidato il “Dante del 1921”, in concorrenza con altri editori, ma non Olschki, che ebbe tuttavia un ruolo importante nel ricoprire un segmento specifico di mercato e interessi dantistici: « Da un antiquario editore infatti non ci si aspetta-va il commento originale o la critica innovatrice bensí l’opera specializzata e ben fatta »;106 e vista l’esperienza cosmopolita dello stesso editore-libraio antiquario
105. C. Tagliaferri, Olschki: un secolo di editoria, 1886-1986, Firenze, Olschki, 1986, 2 voll., vol. i p. 197: « Possiamo cosí osservare che, mentre fino ai primi del Novecento la Olschki non disdegnò chiose e commenti, lo scorrere del primo decennio del nuovo secolo vide sbocciare l’approccio ‘estetico’ », già evocato dal collaboratore Giuseppe Lando Passerini sulle pagine sia del « Giornale Dantesco » che del « Marzocco ». In quest’ultimo cfr. del conte cortonese, Con Dante e per Dante, vol. viii, fasc. 19 apr. 1903, p. 1; e Letture dantesche: i fuochetti di padre Pistelli, vol. xi, fasc. 5, ago. 1906, p. 2.
106. Tagliaferri, Olschki, cit., p. 197.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
401
si prospettava un proficuo contatto con istituti e persone stranieri, tutti amanti di Dante, e potenzialmente interessati a cessioni e acquisti di pezzi librari.
Vi è una testimonianza dei canali di approvvigionamento per la passione dantesca di Sonnino nel mercato delle edizioni pregiate. Mi riferisco alla “gran-de edizione” del sacrato poema con le 101 figure della stampa veneziana del 1491, promossa da Olschki ricorrendo il cinquantenario dell’Unità d’Italia.107 Di que-sta « edizione monumentale » – limitata a 300 esemplari su carta a mano Miliani di Fabriano, piú sei esemplari in pergamena per collezionisti di prima grandez-za come Ahmed pascià d’Egitto, Pierpont Morgan, Marco Besso e il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, al quale fu presentata nella tenuta di San Rossore – Son-nino, fino all’anno prima presidente del Consiglio, riuscí ad avere una copia della terza tiratura “economica”: « copie rilegate alla bodoniana che fu riservata alle biblioteche e agli studiosi al prezzo di 250 lire ».108
Nel manifesto di presentazione Olschki scrisse del « ricordo del Vate della nuova gente latina [… la cui poesia è] preceduta da una vita di Dante scritta da D’Annunzio [com’era negli accordi col vate moderno] passo a passo spiegata col
107. Riporto il testo di un’inserzione pubblicitaria apparsa all’interno della copertina del catalogo n. 83 Incunabula typographica del 1912, con accluso elenco dei sottoscrittori: « La Come-dia del divino Dante Alighieri da Firenze con la esposizione di Giuseppe Lando Passerini da Cortona, e con un proemio di Gabriele d’Annunzio / édition monumentale dédiée à sa ma-jesté le Roi d’Italie […] Tirée à 300 exemplaires numérotés, sur papier de luxe, avec le portrait du poète et la marque de l’éditeur en filigrane, 2 ff. n. ch., x et 524 pp. ch. Grand in-folio, avec les 101 gravures de l’édition vénitienne du mars de 1491 » al prezzo di 600 franchi; mentre si saliva a 3000 per avere uno dei sei « exemplaires sur vélin avec les lettres initiales et les armoi-ries du souscripteur enluminées », peraltro già épuisées. Si trova in Tagliaferri, Olschki, cit., pp. 191-93 n. 111. Su questa « prima edizione monumentale moderna […] impressa con inchiostro rosso e nero, su due colonne, delle quali una reca il testo, l’altra il commento, […] grandi ini-ziali antiche ad ogni canto », a cui Olschki pensava da diverso tempo, cfr. L’edizione monumen-tale della ‘Divina Commedia’, in « La Bibliofilía », vol. xi 1909-1910, disp. 10-11 p. 446 e passim. Nell’Archivio Olschki si trovano le carte Olschki-Passerini che documentano fin nel det ta-glio la fase del Progetto; in una lettera Passerini, allora direttore del « Giornale Dantesco », scri-ve: « in quarto grande o piccolo folio, a imitazione delle piú belle e celebrate edizioni antiche del primo secolo della stampa, ma condotta, sí nella parte artistica come nella letteraria, con gusto e metodi moderni: per modo che, il commentario, sobrio ma largo, accompagnerà il testo passo passo, incorniciandolo all’uso dei glossatori ». Il conte Passerini, a sua volta, rac-colse un’importante collezione dantesca poi donata all’Accademia Petrarca di Arezzo; cfr. E. Boffa, La biblioteca dantesca di Giuseppe Lando Passerini, in « Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze », n.s., vol. lxix 2007, pp. 339-54.
108. Se pensiamo che dopo una decina d’anni in azienda, nel fare i conti dell’impresa, venne fuori un disavanzo di appena 300 lire, si capisce l’oculatezza finanziaria dell’editore fiorentino. Cfr. Tagliaferri, Olschki, cit., p. 193 n. 116, ricavato da Pro memoria del 12 dicembre 1922, con-servato in Archivio Olschki, carte Olschki-Passerini. Cfr. anche l’articolo a firma Il Bibliofilo, La ‘Divina Commedia’ monumentale, in « La Bibliofilía », vol. xiv 1912-1913, disp. 4-5 pp. 121-30.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
402
nuovo commento specialmente estetico ».109 Visto che D’Annunzio è stato chia-mato in causa, può essere utile ricordare anche la sua “biblioteca d’autore”, che presenta una consistente parte dantesca. Scrive al bibliotecario del Vittoriale, Antonio Bruers (1887-1954): « Mio caro Antò, […] considero importante la nuo-va sezione della Biblioteca: quella di fronte alla porta del Mappamondo. Nel com-partimento centrale porrò una effigie di Dante: ai piedi dell’effigie alcune edi-zioni della Comedía da me annotate, e alcune singolarità dantesche. Nei palchet-ti laterali, nei piú bassi, vorrei opere di commento dantesco e “testi di lingua” de’ primi secoli: XIII, XIV ».110
Tuttavia l’ordine biblioteconomico poteva non combaciare con le esigenze di D’Annunzio come si evince da questo brano di lettera: « il tuo ordine di bibliote-cario disperde le opere che formano la mia raccolta di libri “da capezzale”. Non ho trovato – con grave dolore – uno o due volumi di testi francesi: chansons de geste, lais, dits, etc. ».111 Ecco come D’Annunzio concepiva la propria biblioteca:
109. Da notare come Passerini, di formazione storico-erudita, venga presentato come au-tore di un commento rispondente alla nuova moda estetica allora in via di affermazione. Il manoscritto della prefazione di D’Annunzio, con la sua calligrafia ad ampi tratti, è conservato nella Biblioteca del Centro dantesco dei Frati minori conventuali a Ravenna; è stata definita da E. De Michelis, Tutto D’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1960, p. 375: « impettita », e « inami-data »; la mancata “vita di Dante” ripiegò su un approccio estetico piú confacente alle corde del poeta pescarese. E si ricorda da ultimo, sempre con i tipi Olschki, l’edizione della Commedia per i 150 anni dell’Unità, con commento dei coniugi Hollander; anche questa edizione, cele-brativa e di lusso, si fregia di un contributo speciale: la lettera proemiale di Roberto Benigni.
110. Cfr. Carteggio D’Annunzio-Bruers, a cura di M. Menna e R. Castagnola, con un saggio di L. Lattarulo, Lanciano, Carabba, 2011, lettera del 17 luglio 1933, p. 63. Il volume contiene il saggio del bibliotecario A. Bruers, La Biblioteca del Vittoriale (1938), pp. 47-68, che ci dà alcune informazioni sul funzionamento della collezione bibliografica dannunziana: gli oltre 30.000 libri erano divisi per materie, corrispondenti alle esigenze topografiche della casa al Vittoriale. “Dante” occupa uno spazio autonomo. L’effigie è una xilografia di Adolfo De Carolis, Dantes Adriaticus, mentre la “singolarità” è l’edizione monstre per dimensioni dell’Inferno illustrata dal pittore genovese Amos Nattini (1923). Cfr. anche A. Villari, Gabriele d’Annunzio e il Vittoriale: guida storico-artisitica, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2009, pp. 37-38. Faccio notare come l’ordine di disposizione nelle pareti della sequenza di scaffali e palchetti per D’Annunzio do-vesse quasi richiamare la mise en page di un codice della Commedia: il testo al centro, con anno-tazioni autografe, e il secolare commento, con le fonti in lingua o classiche, tutto intorno; non manca il corredo figurativo con la dislocazione nella « Stanza del Mappamondo », dedicata alle serie d’arte (già Thode), dell’ed. Nattini 1923. In modo simile qualcuno ha definito gli appara-ti di note alla Commedia come un “battiscopa”.
111. Bruers, La Biblioteca del Vittoriale, cit., pp. 66-67, lettera del 2 sett. 1935, citata da Bruers per spiegare le difficolta di organizzare una raccolta vasta ad usum artificis: « Tutti i miei colleghi bibliotecari mi comprenderanno se dirò loro che la questione dello schedario per materia era divenuto il mio incubo quotidiano. Se io avessi potuto abitare continuamente al Vittoriale, avrei potuto sopperire alla deficienza, dato che io conoscevo ormai, uno per uno, tutti i libri del Comandante. Ma per tre quarti del mese io ero lontano, tormentato dal pensiero che la diffi-coltà di ritrovare certi libri potesse addirittura tarpare nel Comandante l’impeto, la passione del
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
403
« Tu hai veduto gli scaffali nuovi. Avrei voluto indicarti quale specie di libri sia da collocarvi: non libri vani, ma strumenti di studio; perché considero quell’andito co-me una prosecuzione della Biblioteca madre » (giugno 1933).112 Non fu facile per Bruers conciliare le buone regole della biblioteconomia con le esigenze dell’ “ope-raio della parola” – come D’Annunzio si definiva – che nell’ “officina” come ogni “artefice laborioso” voleva l’accesso immediato ai suoi attrezzi (« i miei libri mi sono prossimi, come se io tenessi pur sempre le dita tra i viventi fogli »).113
Anche la rilegatura dei volumi piú importanti fu seguita dal D’Annunzio bibliofilo, con contatti ripetuti col legatore; scrive infatti: « gli darò i volumi per i saggi, determinando i modi del dosso ».114 La stessa fattura delle rilegature è associabile a periodi precisi, come per es. quelle con l’insegna del “labirinto” ri-salgono al periodo francese. Analogamente anche la provenienza di libri da un fondo o l’altro delle collezioni Sonnino, a volte, si ricava da elementi di possesso come la segnatura « Romito » impressa sulla costola delle opere.115
10. Casa di Dante in Roma
Una busta dell’archivio Sonnino riguarda la gestione della « Casa di Dante » romana (b. 68, con documentazione dal 1913 al 1922), di cui il barone fu uno dei fondatori, e tra i soci piú attivi, donando nel 1920 un nucleo consistente della sua collezione dantesca alla futura biblioteca. La busta contiene in prevalenza il carteggio relativo all’amministrazione contabile della Casa di Dante; ma in par-te è presente anche corrispondenza inerente lo scopo dell’associazione ed alcu-ni manoscritti ed opere a stampa di Sonnino.
Il primo impulso venne dall’interessamento e il patronage della Regina Mar-gherita. Sonnino promuove la costituzione, a Roma, della Fondazione « Casa di Dante », ubicandola nel Palazzetto degli Anguillara, presso il Lungotevere omo-
lavoro ». E a proposito degli “schedarii” Bruers « dovette rifare tutte le segnature e tutte le sche-de » per assecondare la topografia variabile di D’Annunzio verso la sua collezione libraria.
112. I corsivi sono nel testo a stampa (non si specifica se sono anche nella lettera): Carteggio D’Annunzio-Bruers, cit., p. 13 n. 14, si ipotizza che la « Biblioteca madre » « è probabilmente il primo nucleo di quella di D’Annunzio, ma potrebbe anche essere quella del Thode », prece-dente inquilino di Villa Cargnacco ed esperto di storia dell’arte.
113. Ivi, p. 67, lettera a Bruers del 29 nov. 1937, la quale si chiude con citazione di un emisti-chio dantesco premonitore: « su l’orlo de la vita » (Purg., xi 128).
114. Ivi, p. 64. Fu il poeta pescarese un collezionista vorace, e mobile, spesso in fuga da una residenza all’altra: dalla Capponcina di Settignano fino al Vittoriale, passando per la Francia dove fece larghi acquisti di libri. Cfr. in particolare la prefazione alla Vita di Cola di Rienzo, in-dirizzata all’amico bibliotecario Annibale Tenneroni (1855-1928), pagine in cui il perfetto arti-sta gareggia col perfetto bibliofilo.
115. Cfr. Baglioni, Nota archivistica, cit., p. 15 n. 17: « Il maggior numero delle opere del fondo è identificato dalla segnatura con cui erano state registrate, riportata sulla carta di ri-sguardia anteriore dei volumi, o dalle note manoscritte di possesso ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
404
nimo (accanto a piazza Gioacchino Belli, nel rione XIII di Trastevere); sede prima in affitto, e poi ceduta dal Comune di Roma (sindaco Valli), il 21 settem-bre 1921, « in uso perpetuo » alla Fondazione.116 La trasformazione della « società di cultura dantesca »117 in ente morale, con annesso “schema di statuto” (istanza formale del 27 aprile 1914), viene approvata con R.D. 16 luglio 1914, n. 796. Nel Consiglio direttivo erano, oltre a Sonnino presidente, Corrado Ricci, Piero Mi-sciattelli. Lo statuto del cenacolo dantista venne ancora perfezionato dall’orga-no direttivo, e approvato con R.D. del 25 agosto 1920, n. 1470.
« Il ministro dantofilo appariva poi in bella luce di mecenate munificentissi-mo quando concorse, col dono della sua preziosa collezione dantesca, alla for-mazione della biblioteca da lui stesso ideata per la “Casa di Dante” ».118 Come bibliotecario – espressamente richiesto da Sonnino al ministero competente – venne cooptato il giovane Luigi De Gregori (1874-1947), citato in una lettera di Sonnino a Bergamini,119 destinato a diventare uno dei migliori operatori della sua generazione.120 Anch’egli concorse a promuovere la biblioteca dantesca –
116. Il Palazzetto degli Anguillara, risalente al sec. XIII, subí una ristrutturazione alla fine del XIV sec., divenne del Comune in séguito ad esproprio nel 1887, venne restaurato nel corso di un decennio, cercando di salvare quanto ancora c’era di originario pur con interventi molto “liberi” dell’architetto Augusto Fallani. P. Misciattelli, La Casa di Dante in Roma, in « Il Gior-nale d’Italia », 16 gen. 1914, scrive che Sonnino aveva dissuaso anni prima il sindaco Nathan dal costruire un monumento di marmo o di bronzo in onore di Dante, convincendo i sindaci successivi (Apolloni, Rava) invece a concedere in affitto alla Casa di Dante il complesso degli Anguillara. Cfr. anche L. De Gregori, Torre Anguillara e la Casa di Dante, in « Bollettino del R. Istituto di Archeologia e Storia dell’arte », vol. ii 1928, nn. 5-6 pp. 111-16, a p. 115, che cita Cor-rado Ricci: « La nobile idea [della cessione in perpetuo e gratuita] nacque in Campidoglio, in un dialogo passato fra il barone Sonnino e l’avvocato Francesco Saverio Benucci, durante la visita del Lord Mayor [sindaco] di Londra » (settembre 1918, sindaco Prospero Colonna); e grazie alle delibere comunali del 23 e 27 febbraio 1920 (sindaco Apolloni).
117. Definizione dal « Verbale della adunanza dei soci del 27 aprile 1914 », nel i Registro conservato alla Casa di Dante, pp. 7-13 (numerate a mano).
118. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 171. In occasione del Centenario dantesco del 1921 il Governo italiano (ministro competente Croce) stanziò la somma di L. 70.000 per la sistemazione di questa biblioteca dantesca nella Casa di Dante, cfr. « Gazzetta Ufficiale », 25 aprile 1921; inoltre fu procurato un cospicuo nucleo di opere di consultazione generale.
119. Sonnino, Carteggio: 1916-1922, cit., pezzo n. 533, p. 742 (da Quercianella, 5 ott. 1922), in cui gira a Bergamini un’ « acclusa lettera » di De Gregori preoccupato « sul possibile da farsi per parare al guaio segnalato della eccessiva invasione dei nostri locali per parte delle Regie Guar-die ». La cronologia della vita di De Gregori in questo periodo lo dà dal 1915 direttore pure della Biblioteca romana Sarti, anch’essa originata da una collezione privata; cfr. Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo, repertorio online all’indirizzo www.aib.it, il cui omologo a stampa è G. De GregoriS. Buttò, Per una storia dei bibliotecari italiani del XX secolo: dizionario bio-bibliografico 1900-1990, Roma, Aib, 1999.
120. Cfr. la biografia del figlio G. De Gregori, Vita di un bibliotecario romano: Luigi De Gregori, Roma, Aib, 1999; nella cronologia per l’anno 1920, 4 giugno: « È nominato membro del Consi-glio direttivo della Casa di Dante, con l’incarico di curare la Biblioteca dantesca », a p. 8. Nella
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
405
aperta del tutto al pubblico il 27 maggio 1921 – e le attività della Casa di Dante presso la comunità bibliotecaria internazionale, come in occasione della visita guidata di un gruppo di colleghi americani – tra i quali anche il dantista Theo-dore Koch – in visita ufficiale a Roma nel 1928 (una sorta di Bibliographical Tour). Ecco come l’ospite De Gregori illustrò gli incunaboli danteschi, spostati per l’occasione alla Biblioteca Casanatense:
There is a glass case, my dear Mr. Koch, which I wish to call especially to your attention. It contains the Fifteenth century editions of the Divine Comedy, owned by the Casa di Dante in Rome, but brought here [in Casanatense] for purpose of study. In the Fifteenth century there were fifteen editions of the Divine Comedy. You, the wise cataloguer of the very rich Dante Collection presented by Fiske to the Cornell University, will be glad to find here together fourteen of them.121
Fu cosí che Sonnino fece del palazzetto medievale, all’altezza dell’Isola Tiberi-na, il sacrario (con i cimeli bibliografici e non solo)122 e la cattedra (con le lecturae) di Dante a un tempo.123
riunione del Consiglio direttivo del 6 aprile 1921 viene nominato “socio benemerito” « per es-sersi dedicato con tanto intelletto d’amore a l’incremento ed al riordinamento della biblioteca dantesca ». E cfr. anche l’articolo G. De Gregori, La “Casa di Dante” in Roma e il contadino dantista, in « Studi Romani », vol. xlvi 1998, n. 1 pp. 110-13, a p. 111: « Sonnino volle regalare a mio padre una edizione tascabile della Commedia con sua dedica ». Inoltre il figlio Giorgio fece dall’estate del 1931 un tirocinio di bibliotecariato nella collezione dantesca seguita dal padre: « con la mia presenza, la biblioteca venne aperta al pubblico due volte alla settimana dalle 16 alle 19, tre ore che io trascorrevo compilando qualche scheda e mantenendomi aggiornato con la bibliografia dantesca sia corrente che retrospettiva. Di pubblico vero e proprio non c’era da parlare: tutt’al piú capitava qualche membro del Consiglio, qualche studioso di Dante, qualche frequentatore delle conferenze a chiedere un’informazione bibliografica o un libro in prestito ». Dopo che Giorgio De Gregori, ormai non piú tirocinante, venne trasferito a Firenze, alla Biblioteca Na-zionale Centrale, il suo posto alla « Casa di Dante » fu preso dalla sorella Maria nell’agosto 1937.
121. De Gregori, Vita di un bibliotecario romano, cit., pp. 48-49. Koch era noto come biblio-grafo e dantista per aver aggiornato il repertorio catalografico dantesco conservato alla Cor-nell University Library, Catalogue of the Dante collection presented by Willard Fiske, compiled by Th.W. Koch, Ithaca, Ithaca Univ. Press, 1898-1900, 2 voll.
122. Tra i cimeli non bibliografici si ricorda la maschera di Dante che troneggia a capo della cattedra del conferenziere; essa venne murata da De Gregori junior con l’aiuto dello scultore-autore Tommaso Gismondi e Nicolino [Niccolò?] Gallo, che fu anch’egli interessato alla bibliografia dantesca, se vale il nome tra quadre. Un altro oggetto sicuramente suggestivo, per cui De Gregori senior si spese inutilmente per averlo, fu il “bastone dantesco” che il “con-tadino dantista” Giacomo Ferrari da Quattro Castella (Reggio Emilia) portò in giro per la penisola, in bicicletta, al contempo recitando Dante con l’ausilio di scene e personaggi scolpi-ti sul grosso bastone di 13 chili. La sua impresa finí sulle pagine del « Corriere della sera », 11 settembre 1941 [ma 1931], con un pezzo intitolato: Il contadino predicatore della ‘Divina Commedia’. Per entrambi gli episodi cfr. De Gregori, La “Casa di Dante” in Roma, cit.
123. Chiminelli, La fortuna di Dante, cit., p. 170: « La sola “Lettura di Dante” avrebbe potuto
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
406
Esiste infatti un legame tra l’attività della Casa di Dante in Roma (nata uffi-cialmente il 18 gennaio 1914) e il ciclo delle lecturae Dantis romane, che passa at-traverso affinità elettive tra persone. Le letture, promosse dalla contessa Natalia della Rocca in Francesetti (del castello di Malgrà) – cognata del fratello Giorgio Sonnino –,124 erano iniziate nel 1901, sull’esempio delle omologhe fiorentine: si svolgevano nella grande sala di Palazzo Poli a piazza Fontana di Trevi; poi tra-sferite nel settecentesco salone o aula magna del Collegio Nazareno, per inte-ressamento del dantista Luigi Pietrobono. Per inaugurare lo status di “ente mo-rale” della Casa di Dante, Pasquale Villari tenne una conferenza il 18 gennaio (vd. la firma inaugurale della regina Margherita nel registro delle attività della Casa),125 sul tema Dante e l’Italia, scegliendo cosí un’interpretazione libera, non legata a un singolo canto.
11. La bibliofilia dantesca: una testimonianza di storia della cultura
Della bibliofilia di Sonnino abbiamo notizia in una nota di Roberto Baglioni:
Il suo ricchissimo fondo librario, allestito nella residenza romana di via delle Tre Cannel-le e definito dall’amico Alberto Bergamini « la piú grande biblioteca privata che abbia visto dopo quella di Croce »,126 è testimoniato, nella sua imponenza, dalla documentazio-ne fotografica rinvenuta in archivio. Lo spezzone superstite di quel fondo (meritevole di
col tempo degenerare in vuoto accademismo o in superficiale e brillante palestra di vanità letterarieggianti. Bisognava crearle attorno un focolare di studi fecondi, di ricerche avvivatrici, in una parola […] una biblioteca costituita con criteri scientifici ».
124. Le affinità elettive tra i Sonnino e le donne di casa Francesetti trovarono nell’amore per Dante ulteriore rafforzamento; per es. nel rapporto piú che amicale tra Hilda (figlia di Natalia) e Sidney che, oltre a scriversi lettere (Archivio Sonnino, busta 146), lavorarono insie-me alla traduzione della raccolta di saggi The Strenous Life dell’allora presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt (Id., Vigor di vita, Milano, Treves, 1905); piú tardi Hilda diventa cassiera della Casa di Dante, portando in dote il fondo gestito per le letture dantesche romane; cfr. Verbale del 27 apr. 1914, riportato da L. Scorrano La “Società Dantesca Italiana” e la “Casa di Dante” in Roma, in « Otto/Novecento », vol. xviii 1994, n. 2 pp. 61-78; poi con lo stesso titolo in La Società Dantesca Italiana 1888-1988. Atti del Convegno di Firenze, 24-26 novembre 1988, a cura di R. Abardo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, pp. 55-73, a p. 68.
125. Vd. ora in Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, vol. i. Inferno, 1. Canti i-xvii, a cura di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 2013, inserto iconogr., tav. 1.
126. Alberto Bergamini (1871-1962), giornalista e politico, si vide affidata da Sonnino nel 1901 la direzione de « Il Giornale d’Italia », in cui introdusse per la prima volta nella storia del-la stampa italiana la “terza pagina” composta con il carattere tipografico “elzeviro”, da cui il nome della stessa rubrica giornalistica. Il primo pezzo fu sulla Francesca da Rimini di D’Annun-zio (prima nazionale, 10 dic. 1901); cfr. anche C. Ceccuti, Sonnino e Bergamini: la nascita de « Il Giornale d’Italia » e l’appoggio ai due ministeri, in Sidney Sonnino e il suo tempo, cit., pp. 339-56. Fra i primi a scrivervi furono Alessandro D’Ancona, Francesco D’Ovidio, Isidoro Del Lungo,
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
407
un compiuto progetto di catalogazione), che oggi si trova a Montespertoli, è pari a circa 200 metri lineari di scaffalatura e raccoglie, per la maggior parte, edizioni di storia, dirit-to ed economia dalla seconda metà del Settecento agli anni ’20 del Novecento, oltre alla collezione completa di importanti riviste internazionali come la « Revue des Deux Mon-des » (1831-1884). Al suo interno, riconducibile al profondo interesse di Sonnino per Dan-te, la preziosa raccolta libraria della Divina Commedia (in gran parte donata alla “Casa di Dante” di Roma), che comprende alcune pregevoli edizioni con il commento di Cristo-foro Landino, nonché copie anastatiche ottocentesche e opere storiografiche inerenti l’argomento. Un piccolo catalogo del fondo librario, redatto da Sonnino nel 1875, si trova in Archivio Sidney Sonnino Montespertoli […].127
Riporto qualche notizia anche su Benedetto Croce come possessore di una ricca biblioteca – se non bibliofilo specializzato in letteratura “dantesca” –, e comunque dantista “influente”, essendo titolare del dicastero dell’Istruzione nel-l’anno del centenario del 1921, per non dire del famoso saggio dello stesso anno, La poesia di Dante. Da una testimonianza di Massimo Gatta sappiamo che Croce fu un « bibliofilo divenuto tale però solo negli ultimi anni, […] che non disprez-zava di acquisire piú edizioni di uno stesso testo ritenuto fondamentale, per confrontarne le diverse lezioni filologiche, per apprezzarne le bellezze tipogra-fiche dissimili, per accertarne le provenienze e provarne cosí una sottile gioia ». La sua collezione a Palazzo Filomarino « divenne negli anni, anche grazie alla collaborazione prima di Michele Coscino, bibliotecario alla Universitaria di Na-poli, che aveva eseguito un primo ordinamento all’inizio del secolo, poi di Gino Doria e quindi, dal 1945 e fino alla morte del filosofo, della fedele Dora [Beth] Marra, un perfetto strumento di lavoro, essenziale ai suoi studi ».128
Il generoso lascito librario di Sonnino fu presto emulato da altri eminenti
Francesco Torraca e Guido Mazzoni: i piú bei nomi del dantismo di fine Ottocento e primo Novecento. La direzione passò in séguito a Michele Torraca.
127. Baglioni, Nota archivistica, cit., p. 14 n. 8; in sigla ASSM, busta 70, fasc. 8, simile a un’a-genda-rubrica. Cfr. anche Id., Un nuovo strumento di corredo per l’Archivio di Sidney Sonnino, in « Rassegna degli Archivi di Stato », n.s., vol. iii 2007, n. 1 pp. 180-89; L’Archivio di Sidney Sonnino, a cura di R. Baglioni, Firenze, Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Toscana, 2009.
128. Le due citazioni di Massimo Gatta si trovano risp. in Omaggio a Benedetto Croce. Mostra bibliografica in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2002-2003, Campobasso, 16 dicembre 2002, a cura di M. Gatta, Campobasso, Univ. degli Studi del Molise, 2002, pp. 9-10; e in L’a-morosa avventura: Benedetto Croce e i libri, in Id., In viaggio verso Crisopoli: piccole storie di editori e tipo-grafi, Campobasso, Palladino, 2003, pp. 107-39, a p. 115; entrambi con utile bibliografia. Sul vantaggio di avere piú esemplari della stessa edizione, cfr. il concetto di “bibliografia testuale”, o “filologia dei testi a stampa”, secondo G.T. Tanselle, Letteratura e manufatti, Firenze, Le Lettere, 2004, p. 43: « Che cosa fare dei doppioni è un’altra questione che spesso in passato ha diviso bibliografi e bibliotecarî. […] Può darsi che le copie di un libro prodotto a macchina non presentino varianti con la frequenza di un libro stampato a mano, ma differenze vi esisto-no davvero » (trad. di L. Crocetti).
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
408
cultori delle edizioni dantesche, che incrementarono le raccolte della Casa di Dante: tra i primi si ricordano Crescentino Giannini e Ferdinando Martini, se-guiti da Giovanni Jannuzzi, Luigi Valli, Siro Chimenz, Giovanni Fallani e Luigi Gui.129 E ancora il ministro della Pubblica istruzione Pietro Fedele (1925-’28), che donò un esemplare dell’edizione veneziana di Pietro Cremonese del 1491, impreziosito dalle « annotazioni marginali manoscritte » e dalle oltre 400 figura-zioni tra fregi, vignette e miniature già attribuite a Pietro da Figino, ora ricono-sciute di Antonio Grifo.130
12. Varie forme di collezionismo dantesco
Il posseduto della Biblioteca della Casa di Dante si è cosí arricchito fino a costituire una raccolta specialistica di oltre 15.000 pezzi tra codici, volumi a stampa, opuscoli e periodici. Uno dei pezzi pregiati è il codice di patina lingui-stica settentrionale C H I (già appartenuto a Sonnino con segnatura I R 42), importante nella ricostruzione stemmatica, attuata a suo tempo da Giorgio Pe-trocchi che gli dedica l’Appendice ii al suo contributo per il primo Centenario della Società Dantesca Italiana, dove il codice viene appellato “Il Sidney Sonni-no”, a dimostrazione di come un manoscritto importante della Commedia, che viene da molto lontano, trovi una nuova identità nella vicenda del suo possesso-re (tecnicamente detta provenance).131
129. Cfr. la scheda sulla Biblioteca della Casa di Dante, in Storia della letteratura italiana, dir. E. Malato, vol. xiii. La ricerca bibliografica. Le istituzioni culturali, coordin. S. Ricci, Roma, Salerno Editrice, 2005, pp. 953-54: « L’attuale fisionomia della biblioteca privilegia la produzione filologi-ca e critica moderna e contemporanea, ma non mancano, nella collezione quasi completa delle edizioni della Commedia, esemplari di pregio. È il caso del codice C H 1, dell’incunabolo vene-ziano del 1491 illustrato e corredato del commento di Cristoforo Landino, o della cinquecentina veneziana stampata da Sessa nel 1564 con disegni marginali attribuiti a Giorgio Vasari ». Si ripor-ta la bibliogr. allegata alla scheda: La “Casa di Dante” romana, in « Giornale Dantesco », vol. xxv 1922, pp. 181-83; L. Gui, La “Casa di Dante” in Roma, L’A, a. xxviii 1987, n. 2 pp. 48-56; E. Esposito, La ‘Lectura Dantis’ nella “Casa di Dante” in Roma, in Filologia e critica dantesca. Studi offerti a Aldo Val-lone, Firenze, Olschki, 1989, pp. 569-600, con prospetto delle letture per gli anni 1914-1988; Id., La “Casa di Dante” romana e la critica dantesca, L’A, a. xxxv 1993, nn. 1-2 pp. 113-26 (elenco letture 1988-1994); Scorrano, La “Società Dantesca Italiana” e la “Casa di Dante” in Roma, cit., pp. 55-73.
130. Vd. ora la recentissima riproduzione in facsimile, Comedía di Dante con figure dipinte. L’incunabolo veneziano del 1491 nell’esemplare della Casa di Dante in Roma con postille manoscritte e figure miniate, Roma, Salerno Editrice, 2014.
131. G. Petrocchi, La tradizione settentrionale della ‘Commedia’ dall’età del Boccaccio a quella del Villani, in La Società Dantesca Italiana 1888-1988, cit., pp. 357-434, append. alle pp. 427-32; il con-tributo è stato anticipato in Id., Itinerari danteschi, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 171-221. Cito da p. 372: « la schedatura del Sidney Sonnino è flagrante prova che i codici settentrionali, cosí rivelatori prima del Boccaccio, in pieno Quattrocento, anzi già nell’ultimo ventennio del Trecento, non hanno piú nulla da tramandare, immersi come sono in un bagno di contami-nazioni le piú diverse, in un reticolo confuso e inestricabile, senza alcuna linea di continuità,
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
409
Purtroppo, come per altre biblioteche illustri e storiche, anche la biblioteca romana è stata vittima di un furto ad opera di professionisti nel 2000,132 ma fortu-natamente il prezioso cimelio è stato recuperato dal nucleo Tutela patrimonio culturale dei carabinieri.133 Evidentemente la bibliofilia, che porta a creare biblio-teche specializzate, può anche essere di segno contrario, istigando allo smembra-mento di complessi bibliografici integri e consegnati alla storia del libro e della lettura, in nome del guadagno criminale e di una passione altrettanto forte (che potremmo declinare come “bibliomania”, ‘fascino del collezionismo’).134
Spesso le riscoperte di importanti tesori bibliografici avvengono anche a di-stanza di secoli, e come sempre, ogni libro ha il suo destino; in un’asta può acca-dere di trovare un lotto come questo: « Jacopo Mazzoni, La difesa della Commedia di Dante, Cesena, 1587, con note autografe di Torquato Tasso, fitte nel proemio, nell’Introduzione, nel sommario. […] L’edizione di Mazzoni, che di per sé non vale neanche 1 milione di lire (è una cinquecentina di scarso interesse), è stata aggiudicata a 125 milioni di lire. Avevamo in questo caso delle indicazioni dal proprietario che ce l’ha consegnato (“il volume, noto, proveniva dalla biblioteca Falconieri, ma se ne perdono le tracce all’inizio del XIX secolo”). […] Acquista-to dal Ministero, è ora a disposizione degli studiosi alla Nazionale di Napoli ».135
e con una patina linguistica interessante il dialettologo, non impegnante menomamente l’e-ditore ». Si tratta di un codice cartaceo, collocabile nell’ultimo quarto del XV sec., misura 215 × 155 mm., una taglia media a piena pagina, manufatto di livello elevato sia da un punto di vista codicologico che paleografico (umanistica corsiva), quasi un codice di lusso, forse concepito per resistere alla concorrenza degli incunaboli; purtroppo è acefalo, lacunoso e mutilo (Inf., i 49-Par., xiv 32), con glosse sparse in volgare e latino di mano del XVI sec., copiature dei com-menti di Iacomo della Lana, Pietro Alighieri e il già menzionato Giovanni Bertoldi da Serra-valle; legatura moderna in cartone; a c. 1r sottoscrizione di un possessore (« Joseph Fabrizi, 1830 »); sul dorso precedente segnatura manoscritta (« Z.338 ») e infine nel piatto anteriore il cartellino con segnatura Sidney Sonnino, I.R.42; rilievi tratti da S. Bertelli, La ‘Commedia’ all’an-tica, Firenze, Mandragora, 2007, pp. 36, 71, 158.
132. Altro caso clamoroso di sottrazione di libri preziosi si è registrato nel 2011, nella Biblio-teca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, dove studiò Vico.
133. Cfr. la notizia (6 set. 2009) del recupero sul sito www.patrimoniosos.it: il pezzo recu-perato « apparteneva a un complesso di 80 preziosissimi volumi entrati nella collezione pub-blica in seguito a una donazione privata ». La filiera criminale sembra avere delle costanti: un ricco bibliofilo commissiona furti direttamente o si rifornisce presso librai antiquari, ignari o consapevoli di aver acquistato materiale rubato, o nelle aste internazionali piú o meno quota-te. Invece per la bibliofilia di Sonnino parla « chi lo vide un giorno lieto come un fanciullo d’aver venduto la sua automobile per acquistar due rare edizioni della Divina Commedia » (De Gregori, Torre Anguillara, cit., p. 114).
134. Cfr. Thomas Frognall Dibdin (1776-1847), bibliografo inglese, autore di Bibliomania, or book-madness: a bibliographical romance (1809), libro di successo all’epoca; Dibdin fu inoltre tra i fondatori nel 1812 del Roxburghe Club, la piú antica associazione di bibliofili del mondo.
135. F.M. Bertolo, Il mercato delle aste, in Dal manoscritto alla rete, Premessa di A. Bon, a cura di A. Albori e V. de Buzzaccarini, Verona, Nova Charta, 2004, pp. 105-33.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
410
Accanto ai furti e alle scomparse dal pubblico dominio, vi sono da segnalare anche le falsificazioni, rivolte soprattutto a cimeli di innegabile attrazione, co-me la editio princeps di Foligno 1472: racconta Alberto Vigevani che un cliente gli voleva vendere un facsimile spacciandolo per la prima edizione a stampa della Commedia, peraltro facilmente riconoscibile dalla filigrana della carta risalente al 1911. In questo caso la non rarità dell’edizione folignate ha permesso una cono-scenza ampia del manufatto, e quindi anche di potenziali falsi.136
Quasi coeva alla istituzione della Casa di Dante fu, sempre a Roma (Largo di Torre Argentina 11), la Fondazione intitolata al comm. Marco Besso (Trieste 1843-Milano 1920), costituita nel 1918 per interesse del presidente delle Assicu-razioni Generali, finanziere appartenente ad una antica famiglia ebraica se far-dita;137 anch’egli dantista amatoriale, come Sonnino, con cui era in corrisponden-za, e “socio benemerito” della Casa di Dante.138 Vale per Besso la stessa miscela fatta di culto di Dante e bibliofilia, che trovavano nella casa editrice e libreria antiquaria Olschki una sponda propizia,139 se consideriamo l’amore con cui ha formato la sua collezione dantesca, certamente – fra le private – una delle piú cospicue d’Italia, con la preziosità di incunaboli, cinquecentine e via via tutte o quasi le edizioni italiane e le traduzioni nelle piú diverse lingue del mondo.140 Se ne ha la conferma nel catalogo di Antonio Martini (Edizioni delle opere di Dan-te nella Biblioteca della Fondazione Marco Besso, Roma, s.e., 1967), che si limita alle sole opere dantesche, cui vanno aggiunte, pertanto, oltre alle successive acqui-sizioni, tutta la ricca letteratura su Dante, i repertori bibliografici e iconografici, i periodici specializzati.141
136. L’episodio di A. Vigevani, La febbre dei libri: memorie di un libraio bibliofilo, Palermo, Sel-lerio, 20002, è citato da P. Scapecchi, Dal manoscritto all’incunabolo: la continuità tra i codici e i primi libri a stampa, in Dal manoscritto alla rete, cit., pp. 17-44, a p. 22; un altro esemplare della princeps mutilo di una carta è stato aggiudicato per un miliardo di vecchie lire a Parigi; la BNCF ne possiede 2 copie; sono censiti 31 items in collezioni pubbliche.
137. M. Besso, Autobiografia, con prefazione del senatore L. Rava, Roma, Fondazione Mar-co Besso, 1925; A. Caracciolo, Una diaspora da Trieste: i Besso nell’800, in « Quaderni storici », vol. xviii 1983, n. 54 pp. 897 sgg.
138. Dal « Verbale dell’adunanza del 28 marzo 1920 »: Sonnino dà lettura della lettera con la quale il comm. Besso trasmette la somma di L. 100.000 come dono alla Casa di Dante; si trova in La Società Dantesca Italiana 1888-1988, cit., pp. 70-71.
139. Anche se purtroppo nell’Archivio Olschki si conserva una sola lettera di Besso all’edi-tore; come poco o nulla si trovava nella Fondazione Besso, a quello che scrive Tagliaferri, Olschki, cit., p. 196 n. 124, salvo rinvenimenti posteriori a quella data.
140. Besso per esempio curò il saggio, con tre bibliografie, confezionato nell’elegante vo-lume con settanta tavole: La fortuna di Dante fuori d’Italia (Firenze, Olschki, 1912), in tiratura di 200 esemplari, destinati ad un pubblico di élite, anche all’estero.
141. Tratto dal sito www.fondazionemarcobesso.it. Besso sviluppò ampi interessi negli stu-di umanistici che gli permisero di pubblicare, con amore di bibliofilo, lavori di notevole con-tenuto. A queste pubblicazioni è strettamente legata la storia della sua biblioteca che venne formandosi a sostegno delle ricerche necessarie per le sue opere; dice infatti nelle sue memo-
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
411
13. L’ultima lectura Dantis: Beatrice
Dopo il giugno 1919, reduce dalla Conferenza di Versailles, dove come mini-stro degli Esteri, insieme al presidente del Consiglio Orlando, aveva rappresen-tato l’Italia uscita dalla grande guerra – con tutto quello che ne derivò per la fine del sogno di un’Italia modernamente liberale e la “vittoria mutilata” –,142 Son-nino ritornò alla vita privata, e riprese i suoi studi, allestendo un’altra lectio dan-tesca, su Beatrice, cosí che mentre quella di inizio secolo sul vi del Paradiso po-teva intendersi come un manifesto di politica internazionale ricavato da una lezione di storia sotto forma di altissima poesia, la meditazione su « quella che imparadisa la mia mente » (Par., xxviii 3) diventava invece motivo di bilancio di un’esistenza individuale e dell’umanità intera.143
Lo studio uscí come saggio nuptialis dedicato A donna Livia Borghese nella lieta occasione delle sue nozze, in data Firenze, 29 dicembre 1920. All’epoca circolarono due emissioni: in 35 pagine di 26 cm., quella per nozze Borghese (Roma, Tip. del Senato di G. Bardi, 1920); e poi in rivista sulla « Nuova Antologia », 16 febbraio 1922. I materiali preparatorî sono conservati nel fasc. 2 della busta 67 dell’archi-vio.144 Chiminelli all’altezza del ’21 dà lo studio ancora per inedito, ma una pri-ma lettura venne fatta da Sonnino, a sostituzione d’una conferenza di Giovanni Bertacchi, nella Casa di Dante, per la riunione domenicale del 10 aprile 1921, replicata a breve distanza l’8 maggio.145
rie: « ognuna delle mie pubblicazioni si riallaccia ad una delle sezioni della mia biblioteca e non so piú se sono le raccolte che mi hanno condotto a formare i miei libri, o se è stata la preparazione di questi che mi ha condotto a raccogliere i materiali. Il vero è che le due diret-tive si sono intrecciate reciprocamente spingendomi » (Besso, Autobiografia, cit., p. 157).
142. Haywood, Failure of a dream, cit., p. 477 n. 7: « At the end of the war, D’Annunzio pre-sented Sonnino with a copy of Cantico per l’ottava della vittoria (published by Fratelli Treves, Milan 1918), with the inscription: “a Sidney Sonnino perché severissimamente custodisca la Vittoria nostra intera” ». Anche prima del conflitto l’interventismo di D’Annunzio aveva fatto leva su Sonnino: cfr. D’Annunzio et al., Discorsi della guerra; nota di S.E. Sonnino alle potenze, Mi-lano, Esperia, s.d.
143. Cfr. Haywood, Failure of a dream, cit., p. 528: « In his meditation on Beatrice, Sonnino confessed the unrequited yearning and profound loneliness, indeed the ultimate futility, of his life. […] As a colleague at the Casa di Dante noted, Sonnino understood Dante in the same terms he understood himself: “He stood a stranger in this breathing world” ». Cfr. il necrolo-gio di P. Misciattelli, L’on. Sonnino e la Casa di Dante, in « Il Giornale d’Italia », 26 nov. 1922.
144. Sono 25 cc. manoscritte, con corredo di esemplare stampato per nozze, glossato da Sonnino stesso, con appunti, 2 cc. e 1 ritaglio a stampa di foto: L’on. Sonnino parla di Beatrice al Lyceum, 1 c., dove avvenne la lectura Dantis, pubblicata da « Nuova Antologia », 16 feb. 1922, pp. 318-36.
145. A. Calza, L’on. Sonnino parla di Beatrice alla “Casa di Dante”, in « Il Giornale d’Italia », 12 aprile 1921. Le due letture vengono annotate da Sonnino nel suo diario: vd. S. Sonnino, Diario 1916-1922, a cura di P. Pastorelli, Bari, Laterza, 1972, vol. iii p. 372: « Letto oggi alla Casa di Dante la nostra “Beatrice” […]. Letto “Beatrice” […] seconda volta ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
412
Sonnino nel preparare la lettura poteva avvalersi degli scritti a lei dedicati di Alessandro D’Ancona (1835-1914), che nel 1872 a Pisa aveva curato un’edizione della Vita nuova « riscontrata su codici e stampe »; anch’egli ebreo, e con cui ave-va carteggiato. Infatti nel richiamare la questione sulla reale esistenza o meno di Beatrice, Sonnino cita Bartoli come negatore dell’esistenza, mentre l’altro par-tito era tradizionalmente piú numeroso; tra questi D’Ancona, di cui viene ri-chiamata una prova a favore.146
Sonnino cuce la storia di Beatrice come ce la narra Dante in Vita nuova, Rime, Convivio e Divina Commedia; in particolare la cantica del Paradiso viene difesa contro quelli che, come Croce, osservano che « difetta di pathos, di nota passio-nale. Fatta astrazione del gaudio trascendentale delle anime per la diretta loro visione di Dio, non vi si parla […] che d’intensità di luce e di movimento, […] e tutto ciò lascia un po’ freddo il cuore umano. Non è esatto. Dante introduce nel Paradiso, di cui i tratti per arrivare a commuoverci debbono essere necessaria-mente umani e terreni, un elemento tutto nuovo e moderno, quello della per-fetta comunione delle anime tra loro, della completa e reciproca loro permea-bilità ».147
« Vi è tutta una letteratura, specialmente anglosassone, su questo tema dell’i-solamento spirituale », scrive Sonnino nel presentare l’intertestualità sul concet-to che egli ricava dalla lectio su Beatrice, per opposizione. Ma non mancano an-che testi francesi (Flaubert, Maupassant, France); imposta infine un contraddit-torio tra D’Annunzio e Novalis sulla forza d’amore.148
Uno scenario che al Sonnino critico dantesco ancora imbevuto di spirito ri-sorgimentale fa venire in mente il Mazzini dantista: « Il tentativo d’inanellare il reale e l’ideale, il simbolo e l’invisibile, la terra e il cielo, tramuta l’amore di Dante in tal cosa che non trova analogia fra i mortali; […] un amore mesto e tormen-tato da un senso perenne d’aspirazione a un ideale non raggiunto [… esso] non inaridisce gli altri affetti, ma li feconda tutti, aggiunge forza al sentimento del dovere e spande la vita dell’anima sino agli ultimi confini della terra ».149
La lectio risulta come l’ultimo scritto nella bibliografia di Sonnino,150 mentre
146. Lettere di Sonnino con i dantisti D’Ancona e D’Ovidio sono conservate presso la Scuo-la Normale Superiore di Pisa. Del primo cfr. A. D’Ancona, Scritti danteschi, Firenze, Sansoni, 1912, p. 226. Del resto un articolo di D’Ancona era stato allegato già nella lectura di Par., vi: cfr. Id., La politica nella poesia del secolo XIII e XIV, in « Nuova Antologia », vol. iv, gen. 1867, pp. 5-52.
147. Il passo è tratto da Sonnino, Beatrice, cit., ora anche in Id., Scritti e discorsi extraparlamen-tari, cit., scritto n. 312, pp. 1675-702, a p. 1697.
148. « L’amore è il supremo sforzo che l’uomo tenta per uscire dalla solitudine del suo esse-re interno; sforzo come tutti gli altri inutile » (Il trionfo della morte) vs « L’amore […] rende le individualità comunicabili e comprensibili » (Fragments, trad. it. di Sonnino).
149. G. Mazzini, Scritti editi ed inediti, Milano, Tip. Aliprandi, 1897, vol. iv, to. ii. Letteratura, pp. 191 sgg.
150. Come attestano P.L. Ballini e R. Nieri, Sidney Sonnino, Firenze, Polistampa, 2008, p. 21, e Haywood, Failure of a dream, cit., p. 4.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
413
come discorso pubblico sul sito della Casa di Dante, nell’elenco dei lettori tro-viamo Sonnino impegnato ancora una volta nel vi del Paradiso il 26 febbraio 1922. Quasi il “canto del cigno” dell’intensa vita culturale e politica di Sonnino: « Il grande tormento del nostro tempo sta nel sentimento profondo della com-pleta, insanabile solitudine morale dell’individuo, chiuso in se stesso e tagliato da ogni possibilità di fusione con gli altri. Restiamo sempre stranieri gli uni agli altri […] nulla vale a sfondare il muro che ci separa spiritualmente ».151 Le rifles-sioni di Sonnino sono valide sempre, oppure risuonano significative per un’e-poca di crisi com’era quella del primo dopoguerra. Una crisi che muoveva da lontano, effetto anche del modernismo in senso lato, poi dispiegatasi in pieno Novecento: « Questo senso di solitudine dell’anima si è fatto nell’età recente piú vivo e tormentoso, per effetto dello stesso movimento di progressiva spiritua-lizzazione ed elevazione del concetto della divinità, in dipendenza del progres-so scientifico moderno e della trasformazione che ha subíto tutta la nostra rap-presentazione ideologica dell’universo e delle sue leggi ».152
14. Nutrimento e conforto
In un articolo-necrologio del 25 novembre 1922, dal titolo Lo scrittore, si dice che Dante era stato per Sonnino « nourishment and comfort ». Sempre a ridosso della scomparsa dell’uomo politico, l’amico Piero Misciattelli, anch’egli consi-gliere alla Casa di Dante, scrisse nel necrologio per Sonnino: « amidst the often tempestuous events of his political career, reading and studying the sacred Poem were for Sonnino the dearest comfort and almost the only refuge for his spirit ».153
Lo stesso senso di sicurezza e ristoro che ricercava quando andava nel suo buen retiro sulla costa livornese. Ecco come ce lo descrive Guido Biagi:
Chi avesse voluto conoscerlo nell’indole sua vera, nel suo aspetto piú sincero, avrebbe dovuto vederlo o nella biblioteca del suo palazzo di via delle Tre Cannelle a Roma, una vasta sala che occupava due piani, tutta foderata di scaffali e di libri, o nella “batteria” del suo cosiddetto castello del Romito vicino a Livorno. […] La “batteria”, una vasta terrazza coperta dov’erano feritoie per spingarde o per cannoncini […] e accanto […] costruí una torre e un piú basso edificio per farne una tranquilla dimora estiva ed autunnale […] passava il tempo […] a leggere, a studiare, girando in su e in giú per l’ampia sala […]. Se
151. Sonnino, Beatrice, cit., p. 1697. Haywood, Failure of a dream, cit., p. 4, traduce: « comple-te, uncurable moral solitude of the individual. We remain strangers to each other even after having fought all the battles of life side by side »; Sonnino poi ricorre a versi di Matthew Ar-nold: « Yet each will have one anguish – his own soul / which perishes of cold » (Progress, vv. 31-32, da M. Arnold, Poems, London, Macmillan, 1888, p. 108).
152. Sonnino Beatrice, cit., pp. 1697-98.153. Riporto i passi in inglese dalla fonte secondaria Haywood, Failure of a dream, cit., p. 289
n. 81.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
414
avevate la fortuna d’essere di quei pochi ai quali egli concedeva la sua confidenza, […] vi avrebbe mostrato i suoi libri, le minuscole edizioni di Dante, la raccolta di Divine Com-medie che egli mise insieme silenziosamente e che legò alla Casa di Dante in Roma, vi avrebbe parlato delle conferenze romane, evitando di farvi sapere ch’egli le aveva pro-mosse e fondate sull’esempio della Lectura Dantis fiorentina. Se aveste guardato nelle lu-cide scansie di quella singolarissima sala, vi avreste veduto volumi d’ogni genere, e molti stranieri, che rispecchiavano la coltura e gli studi del padrone di casa: tutti libri oserei dire “vissuti”, perché stavano a rappresentare lunghe ore di meditazione e di raccogli-mento. Se si facesse il catalogo di quella biblioteca e si pubblicasse, vedreste di quali let-ture si fosse arricchita la mente del nostro grande statista.154
Sonnino stesso ci dà una chiave di lettura postrema del suo amore per Dante:
Della gigantesca opera di Dante, che riassume in sé tutta un’èra di storia umana, e pro-ietta come un faro radioso la sua luce sopra tanti secoli da venire, si può ben dire quel ch’egli dice della sua donna: « Io non la vidi tante volte ancora, / ch’io non trovasse in lei nova bellezza » (Rime, xci 71-72). Ed è dilettevole talora abbandonarsi alle varie impres-sioni che essa desta in noi, facendo astrazione da ogni considerazione di critica storica o letteraria, e al solo lume del sentimento nostro odierno. Leggendo la Divina Commedia, se da un lato non riusciamo forse piú ad avvertire, o per lo meno ad assaporare a dovere, qualche finezza, qualche particolare intonazione troppo strettamente connessa con la mentalità del tempo per non essersi, per cosí dire, volatilizzata col processo dei secoli, dall’altro possiamo scoprire in essa, quasi ad ogni lettura, nuove sfumature di sentimento e di pensiero che dovevano sfuggire ai contemporanei, in quanto rappresentano i primi germi di tutto un concepimento della vita proprio dell’anima moderna.155
A posteriori si può dire che le due lezioni dantesche di Sonnino – svolte in tempi diversi della sua vita: appena prima delle impegnative prove di statista il canto di Giustiniano, e al termine della sua carriera politica il profilo di Beatrice – hanno una relazione chiastica: da un lato il quasi profetico lettore di Dante che si iden-tifica ora in Giustiniano (voce di Dante, d’altronde) cioè il novellatore di leggi, lo “straniero” dei due mondi, abbozzando una Realpolitik manifestatasi prima e durante la grande guerra; poi con la pace, au contraire, svolge una lectio sulla vi-cenda privata e sentimentale di Beatrice, e chiude il discorso con una speranza umanitaria di amore tra individui.
Ma riandando a Par., vi – e abbiamo visto come Sonnino continuasse fino all’ultimo a chiosare la copia stampata della lectura del 1905 e a usare il canto co-me materia di argomentazione politica –, prende risalto la figura di Romeo di Villanova, cioè di colui che pur avendo agito in vita per il bene comune, da alto funzionario (anche di Belisario si è ipotizzato che non venisse ricambiato ade-
154. Biagi, Passatisti, cit., pp. 210-13.155. Sonnino, Beatrice, cit., pp. 1696-97.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
415
guatamente da Giustiniano per i servigi resi),156 si vede non ricompensato in terra come avrebbe sperato o meritato, con la frustrazione di vedere « l’opra grande e bella mal gradita » (Par., vi 129), il mondo per cui si era speso prendere un’altra direzione; e qui è immediato il richiamo alla delusione con cui Sonnino uscí dalla scena politica internazionale.157
Perciò Sonnino si sente vicino a Dante anche in tempi e umori diversi (la speranza nel 1905, il disincanto nel 1920); e, ancora, a Giustiniano, sospetto di aver seguíto in un primo tempo l’eresia monofisita: motivo in piú di identifica-zione per Sonnino, acattolico e di madre anglicana; o a Romeo di Villanova (una sorta di cameo per il pro bono malum; « sembra star qui nel secondo cielo, piú, direi, per tenere il posto a Dante, che per conto proprio »).158
Infatti Sonnino pensa che anche Dante – come bilancio di un’esistenza di exul inmeritus – possa essere destinato a questo cielo,159 a norma di Par., v 105: « Ecco chi crescerà li nostri amori »; ma la maggior parte degli esegeti ritiene che il giubilo delle anime luminose sia per la risposta da fornire al visitatore di pas-saggio, piuttosto che per una futura assunzione di Dante nel proprio cielo.160 Insomma anche l’auto-profezia ante eventum che Dante sembra fare sulla fama
156. Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 10.157. Valgono per Romeo i versi già usati con Giustiniano in Par., v 107-8: « vedeasi l’ombra
piena di letizia / nel folgòr chiaro che di lei uscia ». Viene bene qui ricordare la citazione da parte di Sonnino di un passo di Francesco D’Ovidio, il quale, « in uno dei geniali suoi Studi sulla ‘Divina Commedia’ [Milano, Sandron, 1901, p. 16], paragona il poema ad una luminaria di cui miriamo lo spettacolo a lumi in parte già spenti. Molte allusioni alle persone ed ai fatti del giorno hanno perduto il loro sapore; molti modi di sentire e di pensare cui vi si fa appello sono svaniti per sempre. Il poema ferveva di tutta la vita del tempo; riboccava di idee, di suggestioni, di impulsi che oggi in parte tacciono, inerti e freddi, e che talvolta non riusciamo nemmeno piú ad avvertire […] questo grandioso monumento, che sembra contenere in sé l’anima di tutto un millennio di vita dell’umanità, ci presenta, col volgere degli anni e dei secoli, sempre nuovi aspetti, s’illumina di nuove luci, parla con nuove voci alle generazioni che si succedono » (Sonnino, Il canto vi del ‘Paradiso’, cit., p. 38). Suggestivo è accostare la metafora di D’Ovidio a quella simile di Dante in Par., v 130: come la « lumera » (lo spirito di Giustiniano e tutte le anime del cielo di Mercurio, e degli altri cieli) si fa piú lucente « letizia » quando ha modo di spiegare al pellegrino la propria virtú, allo stesso modo una figura, un personaggio della Commedia ac-quista “fulgore” ogni volta che un lettore la sa apprezzare per identificazione o altro.
158. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., p. 1207: « Dante risponde alla vile taccia di baratteria, lanciatagli contro nel bando di Firenze, col riservare a sé il cielo di chi ha giusta-mente (rettamente?) amministrato (secondo giustizia?) (da uomo giusto?), di chi ha reso sette e cinque per diece » (appunti autografi aggiunti alla versione del 1905).
159. Ivi, p. 1204: « Siamo proprio nel cielo che riserva a se stesso il Poeta ».160. Posizione esegetica che anche Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., p. 1700,
sembra assumere con la conferenza su Beatrice: « un paradiso in cui le anime sono liberate da questo tormento della solitudine morale, godendo della beatitudine di immedesimarsi nel pensiero e nel sentimento altrui, pur conservando la propria individualità ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
416
del suo poema – sebbene in forma dubitativa –161 punta molto piú in alto, verso qualcosa di piú onnicomprensivo.
Sulla viva giustizia Sonnino rileva – sulla scorta di uno storico di filosofia del diritto – come « concetto singolarmente moderno e che fa contrasto con la sco-lastica che identificava il diritto con la legge positiva e questa considerava soltan-to come il comando di un superiore », la definizione dantesca di « un equilibrio (proportio) dei rapporti reali e personali tra gli uomini, che osservato conserva la società, e corrotto la corrompe ».162
L’ultimo Sonnino è percepito ormai in perfetta simbiosi con la « sua bibliote-ca [… dove] figura in modo particolare la sua raccolta dantesca. L’amore pel di-vino poeta lo avvince forse piú della politica e quando non è ministro, l’ufficio che piú lo allieta è quello di Presidente della Casa di Dante in Roma ».163 La no-mina a socio da parte dell’Accademia della Crusca il 7 giugno 1921 per i meriti acquisiti a difesa e valorizzazione della lingua italiana, che è tutt’uno con Dante, dovette essere piú apprezzata di quella a senatore di qualche mese prima.
Corrado Ricci, nuovo presidente della Casa di Dante, lo avrebbe ricordato dopo la scomparsa: « Non molto il Sonnino scrisse su Dante; ma quel che scrisse basta a rivelare la serietà e severità e penetrazione de’ suoi studî ».164 Ai funerali in rito anglicano, il feretro ricevette il saluto fascista,165 ma non è certo che il de-funto avrebbe gradito. Gli fu intitolata la piazza (già piazza d’Italia) contigua alla Torre degli Anguillara, e che ancora oggi porta il suo nome. Fu proprio il biblio-tecario Luigi De Gregori a difendere l’intitolazione della piazza quando fu mes-sa in discussione in tempi di antisemitismo di regime, mostrando a Mussolini in persona l’aporía tra patriottismo (memoria del Sonnino firmatario del Patto di Londra) e difesa della razza, che una scelta del genere avrebbe generato.166
161. Vd. Par., xvii 118-20: « e s’io al vero son timido amico, / temo di perder viver tra coloro / che questo tempo chiameranno antico ». Sonnino legge « vita fra coloro ».
162. Mon., ii 5 1; Sonnino rimanda a G. Carmignani, Considerazioni su Dante e il libro ‘De Monarchia’, in Id., Storia della origine e de’ progressi della filosofia del diritto, Lucca, Tip. Giusti, 1851, pp. 90 sgg.
163. F. Rubbiani nella prefazione a Sonnino (1920), cit., p. v. Con analogo tono De Gregori, Torre Anguillara, cit., p. 114: « Dante e quei libri e il poter dar vita all’Istituto sognato, furono il miglior conforto dei suoi ultimi anni ».
164. C. Ricci, Sidney Sonnino: discorso pronunziato il 14 gennaio 1923 alla “Casa di Dante” in Ro-ma, Roma, Tip. del « Giornale d’Italia », 1923; una copia del tombeau è stata reperita nel Fondo Ernesto Ragionieri della Biblioteca omonima di Sesto Fiorentino.
165. Cosí Ricci descrivendo il momento della tumulazione di Sonnino in una grotta rica-vata nella scogliera del Romito, « estrema propaggine del Montenero livornese, sospinta, co-me un desiderio d’immensità, sul mare »: « Quando, infine, sulla salma scese il sigillo sepolcra-le, le braccia dei giovani presenti si tesero romanamente » (ivi, p. 28).
166. Luigi De Gregori faceva parte della commissione di toponomastica del Comune di Roma. A Firenze oltre a una via cittadina, c’è la « Sala Sonnino » (già Sala dei Bassorilievi) in Palazzo Medici-Riccardi, sede della Provincia e della Prefettura.
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
sidney sonnino: un caso di bibliofilia e dantofilia
417
Per chiudere lievemente riporto un caso curioso, accaduto alla Bibl. Nazio-nale Centrale di Firenze: richiedendo la copia posseduta della lettura su Beatrice: per le nozze Borghese, con coll. 16793.23 (opusc. in miscellanea), mi è stata conse-gnata in una busta protettiva – trattandosi di materiale già alluvionato – la sola copertina (senza supporto) con stampato Beatrice (in rosso), abbinata a un fasci-colo tutt’altro (a sua volta mancante di copertina), ma sempre di argomento dantesco, custodito nella stessa cassetta, e con una fatale attinenza – almeno cosí mi è sembrato – proprio a Sonnino. Un opuscolo della fluviale pubblicistica nella ricorrenza centenaria del 1921: autore Gino Bernocco, che da Cherasco, 25 luglio 1920, dedica il “libriccino” al ministro alla Minerva, sen. Benedetto Cro-ce.167 Nello scritto introduttivo l’autore ricorre al luogo comune “torniamo a Dante”, come impulso a tornare allo studio genuino dell’opera dantesca – su suggestione di un passo di Cesare Balbo nella sua Vita di Dante;168 anzi può esse-re che il titolo del celebre articolo sonniniano Torniamo allo Statuto (1897) rical-casse già l’invito di Balbo, cioè un ammonimento a tornare alla lettera del testo d’origine: sia esso lo Statuto Albertino o la Commedia.169
Anche oggi, come sembra di essere tornati a una politica di stampo albertino, con prerogative monarchiche o presidenziali, cosí non mancano le agguerrite edizioni critiche e/o commentate del poema dantesco, tutte valide, le quali a volte piú che restituirci, farci tornare a Dante, sembrano seguire il fenomeno: “a ciascuno il suo Dante”.
Rossano De Laurentiis
★
Il contributo prende le mosse dall’accostamento dei termini bibliofilia e dantofilia, che trovano una sintesi nella figura di Sidney Sonnino (1847-1922), di famiglia ebraica di Li-vorno, statista dell’Italia liberale, nonché cultore dell’Alighieri e critico dantesco in due letture: la prima, relativa al canto vi del Paradiso (1905), investita di un sentimento di
167. G. Bernocco, La ‘Divina Commedia’ esposta in tre quadri sintetico-sinottici ed illustrata con otto tavole originali: pel vi centenario della morte di Dante Alighieri (1321-1921), Firenze, Bemporad, 1921.
168. Cfr. C. Balbo, Vita di Dante, Firenze, Le Monnier, 1853 (18391), p. 440: « Torniamo pure [a Dante], abbandoniamoci all’onda che ci fa tornare al piú virtuoso fra’ nostri scrittori, a colui che è forse solo virilmente virtuoso fra’ nostri classici scrittori ».
169. Un caso si potrebbe definire di “bibliomanzia”, sintomatico in un occhio abituato a cavilli bibliografici: nel nostro caso l’errore topografico (scambio di 2 opuscoli, collocati 16793.23 e 16793.15, vicini in un raccoglitore per materia dantesca) ha portato all’accostamento di Balbo e Sonnino sul terreno del dantismo; inoltre accomunati dallo slogan (torniamo a…), utilizzato con successo da Sonnino stesso in politica. Purtroppo dietro mia segnalazione non si è potuto ritrovare il supporto mancante alla copertina della lectio su Beatrice, che cosí « è andata persa » nell’alluvione (anche questo un segno?).
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018
note e discussioni
418
identificazione col suo Dante, alla vigilia di grossi impegni diplomatici; la seconda, su Beatrice (1920), diventa l’occasione per una riflessione sulle relazioni tra individui visti come “monadi solitarie”. Il rifugio tra i volumi della sua collezione dantesca – conside-rata in relazione ad altre biblioteche d’autore dell’epoca – ha rappresentato per Sonnino la realizzazione di una forma mentis protestante che nel “libro” trova « una indefettibile eredità di sapienza ».
The paper arises from the comparison of the terms ‘bibliofilia’ and ‘dantofilia’, perfectly matching in profile like that of Sidney Sonnino (1847-1922), Italian liberal statesman of a Livornese jewish family, cult follower of Dante, and also Dante scholar because of two lectures: the first, given on the eve of some important diplomatic tasks, is about the 6th Canto of ‘Paradise’ (1905) and is invaded by a feeling of identification of the author with ‘his’ Dante; the second, focusing on ‘Beatrice’ (1920), be-comes the pretext for a consideration on the relationship among individuals as “lonely monads”. The fact Sonnino took refuge in the volumes of his library – which is in this paper compared with other li-braries of personalities of that time – allowed him to create a protestant ‘forma mentis’ able to find in the “book” a « heritage of wisdom ».
Con
tent
acc
esse
d by
Uni
vers
ità d
egli
Stu
di d
i Fire
nze
[IP a
ddre
ss 1
50.2
17.7
6.13
6] o
n 09
/11/
2018