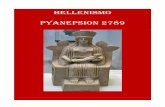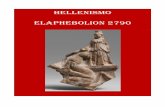Griseldaonline. Una rivista nell'era digitale, Bologna, Archetipolibri, 2007
Transcript of Griseldaonline. Una rivista nell'era digitale, Bologna, Archetipolibri, 2007
GriseldaonlineUna rivista letterarianell’era digitalea cura diElisabetta Menetti
I-VI 2-11-2007 14:56 Pagina III
© Archetipolibri - Gedit Edizioni 2007prima edizione: novembre 2007
progetto editoriale: Elisabetta Menettiresponsabile di redazione: Daniela Artioliredazione: Daniela Ambrosi
copertina e progetto grafico: Avenida (Modena)fotocomposizione: Nuova MCS (Firenze)stampa: Press Service (Osmannoro - Firenze)
ArchetipolibriBologna, via Irnerio 12/5telefono 051.4218740fax 051.4210565www.archetipolibri.it
Archetipolibri è a disposizione degli autorie degli editori che potrebbero avere dirittisui testi contenuti nell’antologia.
I-VI 2-11-2007 14:56 Pagina IV
Indi
ce
www.griseldaonline.it rivista letteraria nell’era digitalea cura di Elisabetta Menetti
00 IntroduzioneElisabetta MenettiGriseldaonline e le forme della comunicazione letteraria
00 Letteratura e nuove tecnologieFrancesca Tomasi Le nuove frontiere digitali del sapereumanistico
I saggi00 Fernanda Alfieri Il corpo del rifiuto tra eresia e ortodossia00 Nicola Bonazzi Parodia e scatologia: quando la letteratura
prende in giro se stessa00 Gianni Celati Lo spirito della novella00 Francesco Citti, Lucia Pasetti Un rifiuto della storia: Eliogabalo,
l’imperatore che morì nella cloaca00 Federico Condello Corpus loquens. Marchi, ferite e tatuaggi
in Grecia antica00 Claudio Franzoni Strascinare i nemici. Rileggendo Fortini00 Paola Vecchi Galli Le parole del nemico: Dante, Petrarca00 Fabio Giunta Ammalato? Ammaliato! Il corpo incantato
di Torquato Tasso00 Matteo Martelli I giovani e la scienza antica:
tra rigore numerologico e calore naturale00 Ivan Rivalta Addio giovinezza!00 Lucia Rodler Le funzioni della fisiognomica da Della Porta
a Lombroso00 Andrea Severi La spazzatura gradita a Italo Calvino. Un breve
percorso tra i rifiuti de ‘La pubelle agréée’00 Riccardo Stracuzzi ‘Giovinezza’ di Montale: una lettura
di «Falsetto»
Le interviste00 Marc Augé «Contemporaneità impossibile» e «iniziazione
negativa». Intervista di Donatella Allegro e Federico Condello00 Marc Augé Bricolage riciclaggio e riproduzione sociale. Intervista
di Donatella Allegro e Federico Condello00 Valerio Magrelli Il corpo difettoso. Intervista di Nicola Bonazzi00 Mario Rigoni Stern Nemico: una parola assente. Intervista
di Elisabetta Menetti00 Edoardo Sanguineti La terra è un inferno globalizzato. Intervista
di Riccardo Bonavita00 Edoardo Sanguineti «Io è un altro», uno slogan per la lotta
al narcisismo. Intervista di Riccardo Bonavita
I-VI 2-11-2007 14:56 Pagina V
Indi
ceI percorsi didattici
00 Rita Boschi Mercanti e viaggiatori. Un percorso iconograficoattraverso il Decameron
00 Mara Ferroni Medusa e le altre. Lo sguardo della donnae l’occhio del poeta tra mito e letteratura
00 Roberto Fiorini I corpi e le cose. Sensualità baroccaed estasi mistica
00 Magda Indiveri “Di ogni cosa resta un poco”. Letteraturae resto
00 Carlo Varotti Inferni e mondo contemporaneo
00 Appendice Indice generale Griseldaonline 2002-2007, a cura di DonatellaAllegro
I-VI 2-11-2007 14:56 Pagina VI
Griseldaonline e le formedella comunicazione letterariaElisabetta Menetti
1. Da Griselda a Griseldaonline
Griselda è l’ultimo personaggio protagonista del Decameron (X, 10) diGiovanni Boccaccio.1 Dalla centesima novella, da una zona liminare e diconfine del capolavoro trecentesco,giunge l’enigmatica personalità di unagiovane pecoraia, Griselda, vittima per lunghi anni delle angherie di unmarchese che la vuole sposa e sottomessa. L’apparente insensibilità delladonna, separata dal mondo e chiusa in un’aurea di forza e insieme di debo-lezza, rende imperscrutabile e misterioso il suo comportamento, che peròle assicura la promozione sociale: da pecoraia a marchesa. Nel frattempoper quattordici anni il marito-padrone la umilia nei modi più crudeli einspiegabili.Alla fine è il marchese a restare sconfitto, perché la magnani-mità e la forza di questa povera pecoraia sovrastano moralmente la folliadi un uomo ricco, potente ma debole.Griselda, per alcuni interpreti, è il simbolo della generosità e della mitezza,ma anche di una imperdonabile passività femminile. Per altri è un esempiodi grandezza morale,di forza e di determinazione.In generale su questo per-sonaggio grava la contraddittorietà, insita in ogni dibattito interpretativo.Una contraddittorietà che si risolve nella sostanziale enigmaticità del caso:una storia o una favola2 che lascia ancora oggi i lettori stupiti e incerti sulgiudizio finale. Ultima, in ordine di tempo, anche la lettura di Gianni Celati
Introduzione
1 Ricordo qui una scheda della novella, contenuta nel sito, con le informazioni bibliograficherelative: http://www.griseldaonline.it/archivio/Chi_Griselda.htm.2 Su questo aspetto della novella si era soffermato Francesco Petrarca, in dialogo con l’ami-co Giovanni:colpito dalla personalità della donna, il poeta preferiva definire la novella di Gri-selda fabula e non historia, poiché non sapeva dire se il soggetto fosse reale o inventato(«nescio an res veras an fictas que iam non historie sed fabelle sunt ob hoc unum»): G. Boc-caccio, F. Petrarca, Griselda, a cura di L. C. Rossi, Palermo, Sellerio, 1991.3 Rimando al saggio di Gianni Celati, contenuto nel presente volume: G. Celati, Lo spiritodella novella.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina VII
secondo il quale «la silenziosa costanza di Griselda nell’obbedire alla “mattabestialità”del marito ci lascia sbalorditi,anche ammirati,ma è un monstrumin cui non potremo mai vedere una virtù condivisa da altri umani».3
Griselda è diventata così per i fondatori di Griseldaonline,studiosi dei testiletterari antichi,una sfida e un invito.Una sfida a mantenere viva nelle pro-prie convinzioni interpretative l’idea che la complessità dei testi letterariimpone apertura al confronto e al dialogo tra posizioni diverse,anche con-traddittorie. E un invito ad accogliere ciò che un autore classico avevalasciato ai margini della sua opera: l’enigmaticità dei processi umani, traforti convinzioni e improvvisi sperdimenti e, infine, l’affermazione dellamagnanimità, al di sopra ogni altra virtù.Griselda, con qualche licenza creativa, si è trasformata in Griseldaonline(www.griseldaonline.it): un luogo di dibattito, messo in rete e reso acces-sibile a tutti coloro che desiderano confrontarsi con la letteratura e con lacritica letteraria. Griseldaonline è un portale di letteratura finanziato dalDipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, sostenuto da GianMario Anselmi e progettato nel 2002 da un gruppo di giovani, interessatia sperimentare nuove potenzialità di ricerca letteraria e di comunicazio-ne,offerte dal mondo digitale.4 È un luogo in cui transitano le idee di moltistudiosi, di scrittori e di poeti che hanno deciso di riflettere sulle risorsedel medium informatico.L’esperimento di Griseldaonline riguarda una nuova forma saggistica, chesia capace di tenere insieme profondità ermeneutica e leggerezza compo-sitiva e che sia in grado di immaginare un percorso interpretativo al con-tempo lineare e a rete. Un percorso essenzialmente letterario ma che siavvale anche di voci provenienti da altre discipline, come avviene in alcu-ni saggi di critica cinematografica, di storia delle idee, di antropologia o disociologia, pubblicati dal 2002 ad oggi.5 La ricerca letteraria si può muo-vere così a largo raggio,mettendo a frutto la versatilità del mezzo,che con-sente permeabilità tra contesti anche molto diversi.I saggi di Griseldaonline sono digitali, pubblicati in rete (ma stampabili equindi disponibili anche off-line), e dotati di link testuali e iconografici(questi ultimi navigabili solo online), che corrispondono molto bene alle
VIII Introduzione
4 I fondatori della rivista, oltre a me, sono: Gian Mario Anselmi, Nicola Bonazzi, FrancescaTomasi, Claudio Tubertini e Carlo Varotti.5 Si vedano in questo senso nel numero 2 (2002-2003, L’altro) i saggi di: M. Callari Galli, Losguardo dell’antropologo, http://www.griseldaonline.it/callari_galli.htm; C. Galli, L’Altro in pro-spettiva politica, http://www.griseldaonline.it/galli_carlo.htm; R. Menarini, Gli Alieni e il cine-ma: ossessioni americane, http://www.griseldaonline.it/percorsi/menarini_roy.htm; F. La Polla, Atale of two cities. La città di Batman, http://www.griseldaonline.it/percorsi/lapolla.htm.Oppure, per quanto riguarda il numero 5 (2005-2006, Ai giovani), l’intervista a Marc Augé diDonatella Allegro e Federico Condello, alla quale si aggiunge quella dedicata al tema del nume-ro 6 (2007-2008, Rifiuti, scarti esuberi), qui ripubblicate. Sempre nel numero 6: G. Manzoli,Cos’è il “trash” & cosa è trash, a cura di M. Bonomo, http://www.griseldaonline.it/percor-si/6bonomo.htm; F. Pitassio, Il rifiuto e lo sguardo, http://www.griseldaonline.it/percor-si/6pitassio.htm.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina VIII
esigenze critiche, fondate sullo scavo di antiche e nuove intertestualità trale opere letterarie.Rispetto alla critica tradizionale tutto ciò può sembrare un modo “barbaro”di fare saggistica,quasi fosse una risorsa intellettuale buttata in rete e lascia-ta inutilmente fluttuare nell’immensità del web. Ma il mondo digitale,applicato anche alle scienze umane, è un’opportunità offerta dalla nuovatecnologia della parola difficile da ignorare. Persino i padri della nostra cri-tica incoraggiano tentativi di evasione ed eversione.A questo proposito siusa spesso ricordare Walter Benjamin, il quale, ragionando sul dadaismo,aveva avvertito come ogni «formulazione nuova, rivoluzionaria» sia desti-nata a «colpire al di là del suo bersaglio».6 Nuove forme di pensiero e nuovilinguaggi nati dal mondo digitale e diffusi via internet possono risultare“screditati”,mediocri,“barbarici”,ma hanno tuttavia la forza di esprimere ilnuovo, di guidare la transizione e di aprire un nuovo passaggio verso laconoscenza. Non a caso molti teorici della multimedialità e alcuni scrittorihanno ritrovato nelle riflessioni sull’opera d’arte nella sua riproducibilitàtecnica un’inizio, anzi il bandolo di un’intricata matassa teorica.7
2. Sezioni e struttura
Il portale, come illustra Francesca Tomasi nell’analisi morfologica del sitocontenuta in queste pagine,contiene una rivista letteraria (composta da tresezioni principali: Formazione e didattica, Percorsi di Griselda e Infor-matica umanistica) e una rubrica dedicata agli Speciali per il sito del quo-tidiano «La Repubblica» di Bologna8:un insieme ricco di contributi e di atti-vità, che è articolato secondo differenti finalità comunicative. I confini trauna sezione e l’altra sono segnati da un differente processo di comunica-zione che vede autori e lettori intrecciati da finalità e obiettivi comuni.Nei Percorsi si propongono saggi di critica letteraria, che intendono rivol-gersi ad una comunità scientifica ben definita (la ricerca universitaria) mache possono essere apprezzati anche da lettori non specialisti. Formazio-ne e didattica offre percorsi letterari chiari e aggiornati, con antologia ditesti e approfondimenti bibliografici, secondo uno schema didattico moltousato nelle scuole, come il commento e l’analisi dei testi. Nella sezione
IXElisabetta Menetti
6 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi,1966, p. 42.7 Così anche Alessandro Baricco, alle prese con la scrittura e i nuovi media, fa iniziare da Ben-jamin il suo viaggio letterario: I barbari. Saggio sulla mutazione, Roma, Fandango, 2006.8 Le due sezioni letterarie sono frutto del lavoro di tutta la redazione di Griseldaonline:Dona-tella Allegro, Nicola Bonazzi, Stefano Colangelo, Federico Condello, Magda Indiveri, ElenaLamberti, Elisabetta Menetti,Andrea Severi,Riccardo Stracuzzi, Francesca Tomasi,Carlo Varot-ti. In particolare la sezione di Formazione e didattica è curata da Magda Indiveri e CarloVarotti, con una parte significativa dedicata all’Adi Scuola (Associazione degli Italianisti –Sezione Scuola). Il progetto e il coordinamento della sezione di Informatica umanistica èdi Francesca Tomasi. La sezione Griselda-la Repubblica.it è curata da Nicola Bonazzi.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina IX
Informatica umanistica vengono analizzati i testi letterari secondo imetodi informatici più aggiornati e si discutono tesi, progetti e finalità diuna disciplina sempre più presente nel mondo della ricerca universitaria.Nella rubrica Griselda-la Repubblica.it, infine, si inseriscono brevissimipezzi di stile, letture suggestive, “ancoraggi” testuali, capaci di suscitareinteresse e di attirare curiosità nei lettori di un quotidiano online.Griseldaonline è, dunque, multigenetica e multiforme: ha diverse nature e,quindi, insegue differenti finalità comunicative. Dai saggi universitari (IPercorsi di Griselda e Informatica umanistica),ai percorsi didattici (For-mazione e didattica) agli articoli giornalistici, legati all’attualità culturale(Griselda-la Repubblica.it) la comunicazione del portale spazia e siamplia, modellandosi su diversi interlocutori.L’imprevedibilità del lettore online viene accolta e gestita da un sito cheoffre prodotti editoriali differenti e che ospita saggi utili ad una ricercaavanzata e specialistica, approfondimenti didattici e metodologici ed eser-cizi di scrittura e di riflessione letteraria.Leggere Griseldaonline è semplice,perché semplice è la sua organizzazioneparatestuale e ipertestuale. È una piccola foglia di un infinito rizoma delsapere, che presenta ad una prima visita caratteri morfologici chiari, direttie semplici. È un prodotto ipertestuale di base, che segue un’organizzazionelogica dei contenuti sia assiale sia reticolare. Si sviluppa secondo un elencodi contributi, divisi per finalità (critica letteraria, didattica e ricerca informa-tica) e organizzati intorno ad un tema, che cambia ad ogni nuovo numero.La home page e tutte le sezioni si distribuiscono secondo una struttura linea-re e verticale,mentre i singoli saggi e articoli attivano link,suggerimenti iper-testuali sia iconografici sia propriamente testuali che vanno a formare unapiccola rete di rimandi interni. Chi legge, dunque, si trova di fronte ad unipertesto plurimo, articolato in sezioni e dalla grafica statica, che periodica-mente viene aggiornato con nuovi approfondimenti e che, ad ogni nuovonumero, cambia anche il tema di riferimento. Questo articolato corpustestuale si affida ad una home page,che funge da vetrina delle novità o dellerilevanze in linea ed è organizzata secondo le regole di base di ogni mes-saggio pubblicitario.Visual e headline,come è tradizione, si dividono lo spa-zio della prima comunicazione del percorso concettuale suggerito, creandoun doppio linguaggio che illustra e spiega il tema prescelto. Per quantoriguarda l’impaginazione la scelta dei colori orienta la lettura dell’intero sito:rosso (home page e cornice stabile del sito), giallo (I Percorsi di Griselda),blu (Formazione e didattica), verde (Informatica umanistica).L’associazione tra messaggio critico-letterario (la pagina scritta resta bian-ca, come un foglio di carta, peraltro stampabile) e messaggio pubblicitario(l’uso vivace dei colori nelle singole cornici e la dinamica tra visual eheadline) si deve alla felice intuizione grafica.9 In altre parole il lettore
X Introduzione
9 Il progetto grafico è stato curato da Elisabetta Ognibene, direttore creativo di Avenida.Comunicazione & Immagine, Modena (www.avenida.it).
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina X
web, già da tempo abituato a decifrare le macrostrutture testuali dei for-mat pubblicitari o degli articoli di giornale, viene accolto da una homepage familiare e tradizionale, che richiede un meccanismo di decifrazionemolto semplice e diretto.10
A questa ambivalente natura, che oscilla tra la stabilità (l’ordine verticaledelle sezioni, degli elenchi di saggi e delle novità) e la dinamicità (la struttu-ra reticolare che sollecita e attiva il lettore-navigatore ad agire in modo auto-nomo e trasversale sui link o sulle diverse sezioni) si aggiunge un elementodi unità: le due sezioni letterarie (Percorsi di Griselda e Formazione eDidattica) sono organizzate intorno ad un solo tema, che cambia ad ogninuovo numero: come ad esempio “Inferni”,“L’altro”,“Il corpo”,“Il nemico”,“Ai giovani”,“Rifiuti, scarti, esuberi” e “A rovescio”. Il principio alla base diquesto esperimento editoriale riguarda principalmente la divulgazione didiversi metodi di ricerca sui testi letterari antichi e contemporanei a partireda temi che provengono da sollecitazioni, da urgenze della storia e dal nor-male flusso di idee, che investono quotidianamente ogni ricercatore e letto-re.Griseldaonline è un punto,sul quale convergono diverse direttrici di pen-siero,di metodi,di affiliazioni e di suggestioni che intrecciano il mondo realecon la riflessione creativa e scientifica sul mondo di invenzione letteraria.
3. Un esempio di rimediazione
Non c’è dubbio che Griseldaonline sia una delle possibili realizzazioni edi-toriali delle più recenti teorie di comunicazione letteraria – e precisa-mente di critica letteraria – applicate alle nuove tecnologie della parola,che hanno rivoluzionato il mondo del sapere degli ultimi venti anni. Difatto Griseldaonline è un prodotto editoriale nuovo e originale che, tutta-via, emerge tardi rispetto alle premesse teoriche, a volte preveggenti, cherisalgono alla metà degli anni Sessanta del secolo passato.Il percorso critico, che chiarirebbe le premesse teoriche di questo pro-getto universitario, potrebbe iniziare da molto lontano: addirittura da Ben-jamin, come è stato già ricordato. Ma si potrebbe procedere anche a ritro-so con George P. Landow, ripercorrendo la storia delle teorie che riguar-dano l’organizzazione dei testi nel mondo digitale.11 Si potrebbe anchecominciare a riflettere sul mezzo, seguendo il percorso tracciato da Mars-hall McLuhan. O, ancora, ripartire dall’intuizione di Walter J. Ong, circal’avvento di una nuova oralità secondaria, con tutte le trasformazioni pre-viste sulle nuove forme letterarie. In fondo, un ipertesto come Grisel-
XIElisabetta Menetti
10 Per quanto riguarda la comunicazione del messaggio pubblicitario, in relazione anche allatradizione retorica antica si veda Retorica del linguaggio pubblicitario di Stefano Calabre-se, in collaborazione con Cristina Bronzino (di imminente pubblicazione: Archetipolibri,Bologna).11 Cfr. G. P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, Milano, Bruno Mon-dadori, 1998.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina XI
daonline, potrebbe essere spiegato anche prendendo a prestito l’idea dirizoma di Deleuze e Guattari12 oppure i concetti di ordine e di rete, checollega una più ampia gamma di tassonomie, secondo il pensiero diMichel Foucault.13 Come si può notare le strade che si possono intra-prendere sono molte; e si intrecciano pericolosamente. Chi studia ilmondo digitale, applicato agli studi umanistici, è ovviamente incline a fareopere di trascinamento da un mondo (quello dominato dalla tecnologiadel libro a stampa) ad un altro (la tecnologia digitale), richiamando nelnuovo scenario elettronico categorie critiche e chiavi interpretive dimedia e lunga durata. Spesso, infatti, gli studiosi dei nuovi media cercanodi riformulare le proprie convinzioni critiche a partire dall’evoluzionedelle teorie letterarie novecentesche (da Benjamin a Kristeva, da Barthesa Derrida a Borges), riconoscendo in esse i fondamenti necessari delle teo-rie dell’ipermedialità.Tuttavia, la nozione che più di ogni altra si è presta-ta a definire in modo convincente i nuovi contesti culturali ipermediali èquella di intertestualità. Un termine multiuso, che ha dimostrato grandeversatilità ermeneutica e che ha conferito spessore epistemologico allenuove dinamiche dell’ipertesto, della multimedialità e, soprattutto, degliscambi intermediali: si potrebbe dire da Julia Kristeva a Jay David Bolter.14
A guidare lo sviluppo di tale ipertrofica dimensione testuale e mediale delmondo digitale e del web,è una sorta di imperativo teorico: «riconfigurare» iltesto, per dirla con Landow. Metatesti, paratesti, peritesti, epitesti, ipotesti eipertesti: il largo impiego nel campo della multimedialità della terminologiacritica genettiana,denota l’urgenza,per chi si occupa di media digitali,di attri-buire un nome, o molti nomi, ad un processo di trasformazione che ha coin-volto la configurazione del testo e che, di conseguenza, coinvolge oggi ilsapere umanistico,che con i testi si misura e si confronta.Ecco,dunque,unaprospettiva dalla quale è possibile suggerire di guardare, con qualche utilità,a Griseldaonline: un concreto esempio di “riformulazione” o di riposiziona-mento, dove la principale finalità risiede nello studio di una nuova modalitàcomunicativa, che deve coinvolgere sia la ricerca scientifica sia la scritturasaggistica. Le nuove tecnologie hanno anche offerto la straordinaria oppor-tunità di una divulgazione su vasta scala, potenzialmente globale di prodottieditoriali. Le varie forme di testo digitale, che si affiancano al testo a stampa,
XII Introduzione
12 Su questo ancora Landow, L’ipertesto..., cit., p. 79 ss.13 Si vedano su questo argomento e in particolare sul riuso di materiali critici nel contestoelettronico e informatico: Oltre il testo: gli ipertesti, a cura di M. Ricciardi, Milano, FrancoAngeli, 1994; G. Gigliozzi, Il testo e il computer. Manuale di informatica per gli studi lette-rari, Milano, Bruno Mondadori, 1997;A. Cadioli, Il critico navigante. Saggio sull’ipertesto ela critica letteraria, Genova, Marietti, 1998;T. Eagleton, Introduzione alla critica letteraria,Roma, Editori Riuniti, 1998. Per quanto riguarda l’italianistica: F.Tomasi, La rete della filolo-gia. L’edizione digitale e le banche dati testuali: una rassegna per l’italianistica, in B. Ben-tivogli e P.Vecchi Galli, Filologia italiana, Milano, Bruno Mondadori, 2002.14 Sulla simultaneità dei concetti di intertestualità e di postmodernismo, si veda: S.Calabrese,www.letteratura.global, Torino, Einaudi, 2005. Per la complessità di queste categorie criti-che nella cultura mediale: G. Guagnelini,V. Re, Visioni di altre visioni: intertestualità e cine-ma, Bologna,Archetipolibri, 2007, pp. 205 ss.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina XII
consentono di superare un mezzo più antico, per affidare al web la diffusio-ne, la circolazione e la condivisione di testi, più o meno elaborati.Una doppia anima, off- e online, suggerisce, dunque, di riconfigurare oriformulare il modo in cui gli umanisti del nuovo millennio scrivono e,soprattutto, comunicano. In questo senso appare sempre preziosa l’eredi-tà lasciata da Italo Calvino,nel momento in cui intuiva la necessità di rifor-mulare la letteratura a partire da nuovi obiettivi. Nella sua ultima lezionesulla molteplicità lo scrittore invitava a pensare la letteratura come ad una«moltiplicazione dei possibili»,dove si disperde «quell’unicum che è il self»nel tentativo di recuperare la «continuità delle forme» come avviene inOvidio o l’identificazione del poeta con «la natura comune a tutte le cose»,come si legge in Lucrezio.15 L’invito di Calvino è, dunque, di non temerema di ripercorrere con coraggio la molteplicità del mondo, che può esse-re contraddizione e rivelazione, insieme.L’idea della dispersione del sé nella molteplicità delle informazioni è, adesempio, un aspetto centrale della riflessione di Jay David Bolter, il qualeha analizzato a fondo le relazioni tra l’utente e l’ampia varietà dei mediacontemporanei. Sulle orme di McLuhan, secondo il quale, come è noto, ilcontenuto di un medium è sempre un altro medium, anche Bolter riflettesul sé rimediato, in quanto attore principale della nuova cultura popolarecontemporanea e multimediale.L’identità di ogni lettore,o meglio,utente non solo si esprime attraverso moltimedia ma viene anche di volta in volta “rimediata”,nel senso di riutilizzata dadiversi media: «il sé ipermediato è un network di affiliazioni che sono incostante mutamento». Il «sé interconnesso» (networked self), spiega ancoraBolter, è «costantemente impegnato a creare e a distruggere collegamenti».16
Il medium digitale invita alla comunicazione globale: questo aspetto, spie-ga forse, la peculiarità di Griseldaonline. La scelta di mettere in rete i saggiletterari, concepiti e organizzati secondo i nuovi paradigmi del sapere digi-tale, rivela la volontà di accettare la sfida e di provare a riconfigurare ilsapere umanistico, a rimediare i contenuti di una ricerca, a dialogare con imolti e altri sé, impigliati nella rete. In altre parole Griseldaonline proponea un ipotetico networked self di condividere letture e riflessioni, nate dallarimediazione di un metodo e di un linguaggio critico e scientifico.
4. Griselda di carta
La versione di carta di un prodotto editoriale digitale – e attualmente onli-ne – è un modo per raccogliere in modo definitivo i risultati di un movi-
XIIIElisabetta Menetti
15 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti,1988, p. 120.16 J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi enuovi, Milano, Guerini e Associati, 2002, p. 266. Su McLuhan si veda: E. Lamberti, MarshallMcLuhan tra letteratura, arte e media, Milano, Bruno Mondadori, 2000.
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina XIII
mento di idee, che riconosce nel mutamento e nella trasformazione icaratteri più positivi e creativi di ogni elaborazione di ipertesti digitali.Nella carta, tuttavia, si desidera imprimere l’esperienza passata che conti-nua a vivere nel presente e si proietta nel futuro, sempre pronta ai cam-biamenti e alle nuove sollecitazioni del web.In questo volume, dunque, si riuniscono saggi inediti, tra i quali il percor-so sulla novella italiana di Gianni Celati, e interviste, percorsi didattici ealtri saggi già presenti online e pubblicati dal 2002 ad oggi, rivisti dagliautori in occasione di questa nuova pubblicazione.I contributi sono tratti dai sei numeri (dal 2002 al 2007) e hanno scandi-to le fasi di studio e di ricerca sia della redazione sia dei molti autori chehanno collaborato.Nel portale sono archiviati tutti i numeri dedicati ai vari temi che hannoadunato i diversi contributi: numero I (2002), Inferni; numero II (2002-2003), L’altro; numero III (2003-2004), Il corpo; numero IV (2004-2005),Il nemico; numero V (2005-2006), Ai giovani; numero VI (2006-2007),Rifiuti, scarti, esuberi; numero VII (2007-2008), A rovescio. L’articolazio-ne e la complessità della rete griseldiana,al di là della scelta antologica car-tacea, può essere recuperata nella sua interezza consultando l’Appendice,posta alla fine del presente volume e curata da Donatella Allegro. Un’ap-pendice che può fungere da indice per una consultazione diretta e liberaonline, sempre disponibile ai lettori web.
Un caloroso ringraziamento a Gian Mario Anselmi, Direttore del Diparti-mento di Italianistica, che ha sostenuto con lungimiranza e con generosi-tà il progetto griseldiano. Un sentito grazie all’editore Claudio Tubertini(Gedit Edizioni-Archetipolibri) che ha contribuito con serietà e compe-tenza a sviluppare un portale che oggi conta più lettori di ieri. A NicolaBonazzi, Francesca Tomasi e Carlo Varotti, amici di sempre, un affettuosoringraziamento per aver voluto arricchire fin dall’inizio con la loro conti-nua presenza, con i loro scritti e con i loro consigli questa comune espe-rienza editoriale e di ricerca. A Valentina Desalvo, che ha promosso unanuova e originale iniziativa di collegamento editoriale tra i siti di «LaRepubblica» Bologna e Griseldaonline, un riconoscente grazie.Ricordo tutta la redazione,che in questi anni ha lavorato con passione allepagine griseldiane: Donatella Allegro, Nicola Bonazzi, Ippolita Checcoli,Stefano Colangelo, Federico Condello, Magda Indiveri, Elena Lamberti,Alberto Natale,Andrea Severi, Riccardo Stracuzzi, Francesca Tomasi, CarloVarotti. Ringrazio tutti gli autori e i collaboratori che hanno contribuitocon fiducia alla crescita di Griseldaonline.Un pensiero speciale, infine, a Riccardo Bonavita, che ci ha lasciati troppopresto.
XIV Introduzione
001 Introduzione 2-11-2007 14:56 Pagina XIV
Letteratura e nuove tecnologie
Le nuove frontiere del sapere umanisticoFrancesca Tomasi
All’origine della humanities computer science1
Is humanities computing a discipline?2 Questo è l’interrogativo con ilquale ci è sembrato interessante avviare su Griseldaonline una discussio-ne che riguarda l’adesione a metodologie e strumenti che provengonodall’universo della scienza dell’informazione da parte di sempre piùnumerosi settori disciplinari di area umanistica: dalla critica testuale allacritica letteraria, dalla biblioteconomia all’archivistica, dalla paleografiaalla codicologia,dalla storia alla filosofia,dalla linguistica alle scienze dellacomunicazione.L’informatica come disciplina teorica, cioè come scienza dell’informazio-ne,assieme all’impiego del calcolatore come strumento,hanno infatti con-tribuito a ridefinire le pratiche relative ai sistemi di trattamento, alleforme della distribuzione e ai criteri di fruizione dei dati di natura uma-nistica. I livelli di intervento automatico sulle fonti si sono sviluppatirispetto ai diversi settori della comune pratica di analisi ed esegesi deglioggetti di studio e ricerca delle discipline umanistiche, nell’ottica di unarivisitazione delle procedure tradizionali. Siamo di fronte agli esiti dellariflessione su una nuova teoria della testualità (intesa in senso estensivo),sollevata dall’approccio computazionale e dall’ambiente digitale, edespressa da nuovi paradigmi concettuali di riferimento, che si incarnanoin nuove modalità della ricerca scientifica.
1
1 Sulla distinzione fra “humanities computer science” e “humanities computing” cfr. Compu-ting in Humanities Education: a European Perspective, ed. by K. Smedt et al., Bergen, Uni-versity of Bergen, HIT-centre, 1999, (http://helmer.hit.uib.no/AcoHum/book/), precisamentenel secondo capitolo: European studies on formal methods in the humanities, pp. 28-34(http://helmer.hit.uib.no/AcoHum/fm/fm-chapter-final.html).2 T. Orlandi, Is humanities computing a discipline?, in «Jahrbuch für Computerphilologie»,IV,2002,pp.51-58.Si vedano poi i diversi contributi raccolti in occasione del seminario inter-disciplinare tenuto allo IATH (Institute for Advanced Technology in the Humanities dell’Uni-versità della Virginia) sul tema Is Humanities Computing an Academic Discipline?(http://www.iath.virginia.edu/hcs).
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 1
È sembrato doveroso esprimere un parere in merito dal momento che, inseguito alla tentata abolizione della laurea specialistica da parte del ministroMoratti, è seguita una petizione firmata da centotrenta studiosi di discipline“tradizionali” in difesa dell’Informatica Umanistica.3 Per questa ragione si èaperto un forum di discussione e si è dedicato il primo numero della rivistaal problema del riconoscimento del settore che,secondo i desiderata di unofra i più autorevoli sostenitori della scienza,Tito Orlandi, prende il nome di“Informatica Umanistica”4 (d’ora in poi IU). L’attivazione, fra le nuove laureemagistrali del prossimo ordinamento didattico, di un LM-43 in “Metodologieinformatiche per le discipline umanistiche”5 conforta la direzione intrapresa.Interrogarsi sugli aspetti che fanno dell’IU una disciplina,cioè riflettere sulsuo statuto disciplinare, è infatti operazione necessaria e funzionale percapire quali siano gli ambiti di studio e di ricerca che rientrano nel settore.Si deve infatti rilevare che un numero sempre più consistente di progettisviluppati in ambiente digitale è il risultato della ricerca di studiosi che tra-dizionalmente si occupano di scienze umane, che sempre più numerosisono i tentativi di definire modelli concettuali per oggetti umanistici e che
2 Letteratura e nuove tecnologie
3 Così riporta il comunicato stampa: «nell’era delle reti e delle nuove tecnologie, letterati, filo-sofi e umanisti non servono più? Un gruppo di oltre 130 docenti ed esperti di numerose uni-versità italiane e straniere è convinto del contrario, e lo ha scritto in una lettera al ministroLetizia Moratti. Nei mesi scorsi, la stampa aveva attribuito al ministro qualche perplessità suinuovi corsi di laurea in informatica umanistica. Dai resoconti dei giornali però l’informaticaumanistica usciva ridicolizzata come disciplina – accostata a materie come “Scienze del fioree del verde”, ecc. Ebbene: secondo i firmatari dell’appello (fra cui Alberto Asor Rosa, RemoCesarani,Tullio De Mauro,Roberto Vacca,ecc.),nell’era della società dell’informazione c’è undisperato bisogno di editor, bibliotecari, archivisti, filologi, storici, filosofi, linguisti, ecc. chesiano in grado di utilizzare in modo innovativo gli strumenti informatici e sappiano riflette-re sulle loro caratteristiche e potenzialità. Ciò che le facoltà umanistiche rivendicano èinsomma la loro capacità di analizzare, gestire ed elaborare – in maniera certo non esclusiva,ma con un ruolo specifico e rilevante – anche le nuove forme della conoscenza». Cfr.http://www.griseldaonline.it/informatica/petition/index.htm.4 I documenti del numero I di Griseldaonline (2002) sono ora accessibili all’indirizzo:http://www.griseldaonline.it/informatica/archivio.htm.5 Riportiamo direttamente parte della declaratoria, nello specifico la sezione relativa allecompetenze che un laureato in questa classe deve acquisire:– possedere una formazione di base negli studi linguistici, filologici e letterari, o storici e filo-sofici, o nel campo del patrimonio culturale, o delle arti, musica e spettacolo, o delle scienzedella comunicazione, o della formazione;– essere capaci di affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi diappropriati strumenti informatici di analisi;– possedere gli strumenti teorici, metodologici e tecnici relativi al trattamento informatico deitesti, delle immagini, del suono e del video nell’ambito delle attività di carattere umanistico;– essere capaci di impostare e realizzare banche dati e archivi digitali con sistemi di gestio-ne negli ambiti specifici di competenza;– conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica sul trattamento degli oggetti digi-tali e delle tecnologie loro correlate;– conoscere i principi costitutivi della comunicazione e sicurezza telematica ed essere ingrado di utilizzarne pienamente gli strumenti;– possedere gli strumenti teorici, metodologici e tecnici per il riconoscimento e manteni-mento della autenticità e la conservazione degli oggetti digitali;– essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua del-l’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 2
il ricorso a pratiche automatiche, ma anche il riconoscimento di teoriecomputazionali nel trattamento di dati testuali, trova una forte connota-zione in senso teorico, metodologico e applicativo.6
Il rapporto fra informatica e discipline umanistiche sembra insomma averacquisito una specifica dimensione operativa. Ogni disciplina di area uma-nistica, che potremmo definire tradizionale, ha sviluppato differenti stra-tegie computazionali, in forma direttamente proporzionale alle esigenzedel settore di competenza (la linguistica, la storia, la biblioteconomia, laletteratura, la paleografia, la codicologia, ecc.), ma quasi tutte le disciplinecondividono metodologie formali nella gestione automatica dei dati –come ad esempio lo sviluppo di basi di dati o il ricorso a linguaggi di codi-fica o ancora lo studio di modelli per i metadati – e concordano su di unuso non esclusivamente tecnico dello strumento informatico.7
Sembra che quanto sostenuto da Fabio Ciotti, in un recente intervento suGriseldaonline, possa ben rappresentare lo status quaestionis in materia,relativamente a due livelli pertinenti l’IU:
1) esiste un nucleo teorico, metodologico e strumentale comune che emer-ge dalle numerose esperienze di ricerca con metodi informatici in ambitoumanistico (un tema esemplare è quello della rappresentazione formale deidocumenti e della codifica testuale);2) il rapporto tra l’informatica e le singole discipline umanistiche non èesclusivamente strumentale ma investe anche aspetti metodologici ed epi-stemologici di ciascuna disciplina (l’uso di strumenti informatici, ad esem-pio, nello studio del testo letterario comporta l’esplicitazione e la formaliz-zazione delle procedure analitiche e la loro verifica sperimentale).8
Una serie di comuni metodologie informatiche percorre cioè trasversal-mente le discipline umanistiche “tradizionali” e costituisce una base diriflessione sulle tipologie di intervento automatico che riguardano le ope-razioni legate alla rappresentazione e alla conservazione delle fonti, allemodalità della sua manipolazione, ai criteri del trattamento e alle formedella sua disseminazione e distribuzione. Ma tale “trasversalità” coinvol-ge la nozione dell’interdisciplinarietà: le competenze che è necessariomettere in campo, all’atto dell’impiego di tecnologie informatiche e tele-matiche, richiedono necessariamente una solida conoscenza dei settoriscientifico-disciplinari coinvolti.
3Francesca Tomasi
6 Un inventario delle iniziative di informatica umanistica svolte in varie sedi europee è statocurato da Tito Orlandi, ed è ora pubblicato nel purtroppo ormai datato volume Computingin Humanities Education: a European Perspective, cit., pp. 13-62. Ma si veda anche il reper-torio di risorse di informatica umanistica in rete: Institutional models for humanities com-puting, a cura di W. McCarty (King’s College London) e M. Kirschenbaum (University ofMaryland), http://www.allc.org/imhc/.7 Cfr. sulla questione il contributo di Ciotti all’indirizzo: http://www.griseldaonline.it/infor-matica/ciotti.htm.8 http://www.griseldaonline.it/informatica/ciotti.htm.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 3
Se guardiamo ai progetti in potenza e a quelli già fruibili, ai centri specia-lizzati nell’applicazione delle nuove tecnologie,9 ai prodotti digitali diambito umanistico (come banche dati testuali, concordanze e sistemi dianalisi del testo, archivi di immagini digitali di fonti primarie, edizioni cri-tiche in formato ipertestuale),10 ai corsi di IU attivati presso gli Atenei (sin-goli insegnamenti e corsi di laurea, master, dottorati, ecc.),11 e ancora alleriviste12 e alle numerose pubblicazioni scientifiche in materia,13 è imme-diatamente chiaro che un’autonoma dimensione disciplinare è pienamen-te giustificabile.Certo non sempre i risultati raggiunti da singoli o da centri di ricerca atte-stano la piena consapevolezza – che si reputa necessaria – del senso del-l’adesione all’informatica come scienza dell’informazione; non rari sono icasi di prodotti informatici che sono solo il risultato di un trasferimentodi media, vale a dire di un uso squisitamente strumentale della macchina.Diventa allora ancora impellente chiarire il senso di un connubio troppospesso frainteso o non condiviso.Potremmo anche tentare di ragionare sulla bipartizione suggerita da GinoRoncaglia e che investe la discussione fra IU trasversali e IU specifiche.14
Roncaglia sviluppa la discussione rispetto ai diversi ambiti di applicazio-ne delle nuove tecnologie alle scienze umane, vale a dire l’uso degli stru-menti informatici per la filologia e l’ecdotica, l’uso dei linguaggi di mar-catura, l’associazione di metainformazioni e le correlate ontologie per imetadati e ancora:
la riflessione sul concetto di documento digitale e sulle sue caratteristiche,con particolare riferimento alle modalità e agli strumenti utilizzati per la suaproduzione (e all’influsso di tali strumenti sulle forme del documento pro-dotto), alla sua struttura e organizzazione interna (differenze fra organizza-
4 Letteratura e nuove tecnologie
9 Fra gli enti italiani si possono ricordare (senza pretesa di esaustività): Cisadu (Roma), Crilet(Roma), Signum (Pisa), Cibit (Pisa), ILC del CNR (Pisa); fra quelli esteri molti i centri in Ame-rica: CETH (Center for Electronic Texts in the Humanities della Rutgers University), IATH(Institute for Advanced Technology in the Humanities dell’Università della Virginia), STG(Scholarly Technology Group della Brown University di Providence); ovviamente poi le asso-ciazioni ACH (Association for Computer in the Humanities) e ALLC (Association for Literaryand Linguistic Computing).10 Un ottimo repertorio in D. Fiormonte, Scrittura e filologia nell’era digitale,Torino, Bolla-ti Boringhieri, 2003, che dedica una sezione a strumenti (per la critica e l’analisi dei testi) eprodotti (edizioni elettroniche e archivi multimediali) per la filologia digitale,http://www.digitalvariants.org.11 Cfr. http://www.allc.org/imhc, sezione III, Teaching programmes.12 Come «Literary and Linguistic Computing», «Computers and the Humanities» (ora «DigitalHumanities Quarterly», http://www.digitalhumanities.org), «Journal of the Association forHistory and Computing».13 Si segnala la preziosa bibliografia di IU, curata da Alberto Camplani, accessibile presso ilsito del Cisadu (Centro interdipartimentale di servizi per l’automazione nelle discipline uma-nistiche): http://cisadu4a.let.uniroma1.it/cisadu/biblioteca/cerca-catalogo.php. Si tratta delcatalogo della biblioteca del Cisadu, che, per ricchezza di materiali, si presenta come la piùesaustiva risorsa bibliografica (e repertorio monografico) su territorio nazionale.14 http://www.griseldaonline.it/informatica/roncaglia_secondo.htm.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 4
zione lineare e ipertestuale dell’informazione, tipologie diverse di ipertesti,organizzazione di basi di dati, ecc.), alla sua identificazione (con il connessoproblema di distinguere e gestire versioni successive, varianti, marcaturediverse di uno stesso documento), alla sua distribuzione e fruizione (gestio-ne dei diritti, interfacce hardware e software per la consultazione, la lettura,la ricerca), alla sua manipolazione, alla sua conservazione nel tempo (infor-mation repositories, archivi e biblioteche digitali, che sono nel contempo –e in maniera assai più strettamente integrata di quanto non avvenisse nelmondo cartaceo – istituzioni per la conservazione e per la distribuzione del-l’informazione), al suo reperimento (OPAC e strumenti di indicizzazione,inventariazione e ricerca online).
Continua quindi Roncaglia:
Si noterà come tutti questi ambiti di lavoro rappresentino interessi largamentecomuni e trasversali rispetto alle diverse discipline nelle quali si articola la ricer-ca di ambito umanistico: un letterato, uno storico, un filosofo avranno certobisogno anche di strumenti specifici, così come di una specifica riflessionesulla ricaduta nel loro particolare ambito disciplinare degli strumenti e delletematiche “trasversali” che abbiamo cercato di delineare; ma avranno altrettan-to bisogno di principi,metodologie,strumenti teorici (e pratici) comuni,e dun-que di una disciplina comune che aiuti ad elaborarli. Così come, del resto, unostorico, un letterato, uno storico della filosofia utilizzeranno ciascuno nel pro-prio ambito disciplinare strumenti e metodologie ricavate da discipline auto-nome e in questo senso trasversali, come la filologia o la paleografia.
Sono quindi le potenzialità della testualità elettronica, dei modi dell’inte-rattività, delle diverse forme della descrizione uniforme, dell’integrazionefra media a dover essere oggetto di riflessione e a costituire il nucleo fon-dante di ogni applicazione orientata alla creazione di oggetti digitali dis-tribuiti. Ma è soprattutto la necessità di capire in quale senso l’informati-ca possa svolgere un ruolo significativo nella riflessione umanistica: algo-ritmi e strutture di dati, formalismi e linguaggi informatici,modelli e formedi modellazione della conoscenza, settori cioè dell’informatica che posso-no davvero costituire il valore aggiunto della computabilità umanistica: lahumanities computer science.Arriviamo allora all’«Informatica umanistica come disciplina teorica» (Buz-zetti) e questo significa pensare a tale campo come:
disciplina che riflette sulle forme di rappresentazione della conoscenza piùadeguate alle singole discipline umanistiche, sui modelli di dati che se nericavano, e sull’implementazione dei formalismi che si possono applicare atali modelli di dati. Da un lato la “semiotica” della rappresentazione digitale(T. Orlandi), dall’altro i procedimenti di elaborazione di tali forme specifichedi rappresentazione della conoscenza.15
5Francesca Tomasi
15 http://www.griseldaonline.it/informatica/buzzetti.htm.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 5
Potremmo, nel dettaglio, partire dai paradigmi propri alla scienza dell’in-formazione, che hanno un diretto riscontro sulle modalità della ricercadelle scienze umane. Parleremo allora di:– Metodi, nei termini delle modalità dell’approccio computazionale altesto, inteso in senso di sequenza finita di simboli: analisi, trattamento edelaborazione, disseminazione, fruizione lato utente.– Modelli, ragionando sul concetto di punto di vista e sul momento del-l’elaborazione dello schema concettuale, sulla base degli obiettivi del pro-cesso computabile.– Sistemi di formalizzazione, riflettendo su linguaggi formali, thesauri etassonomie, vocabolari controllati, istanze di normalizzazione.– Strumenti teorici, metodologici e tecnici, in termini di conoscenze cheè necessario mettere in atto a fronte di un sistema informativo da realiz-zare come sistema informatico accessibile.Griseldaonline si inserisce in questo contesto di riflessione teorica; il chesignifica un ripensamento delle metodologie legate alla ricerca in ambitoumanistico. Ricerca che, avvalendosi dell’informatica come disciplina,deve ridefinire i suoi confini e ridisegnare i criteri e le forme di analisidelle fonti testuali, le modalità della disseminazione delle conoscenze ei sistemi di accesso all’informazione.
Griseldaonline: il modello ipermediale
All’origine di ogni progetto ipertestuale risiede una riflessione sulladimensione del testo e sul suo statuto ontologico, con la consapevolezzadella complessità veicolata dal vocabolo, in quanto oggetto informaziona-le complesso e polisemico. Bisognerà anche riflettere sull’ambiguità delsignificato del concetto di testo che il processo di “ipertestualizzazione”sottende, nel solco del nesso vincolante fra intentio operis, intentio auc-toris e intentio lectoris.Non siamo, come è noto, di fronte a un mero sistema di riversamento disequenze di significanti grafici nella memoria del calcolatore o di impiegodella macchina informatica per la realizzazione di un oggetto elettronico.Avvicinarsi alle nuove tecnologie non deve essere inteso solo come utiliz-zo di un certamente potente strumento, ma anche come ripensamentodelle strategie comunicative nella direzione dell’adesione all’informaticacome disciplina teorica ovvero come scienza dell’informazione;dobbiamoporci nell’ottica di un’esegesi delle modalità di rappresentazione e tra-smissione del significato veicolato dal testo, prodotto di nuove forme ditestualità originate da nuovi modelli testuali di riferimento, una rivolu-zione nell’organizzazione e nella trasmissione del sapere. Ecco allora chele scienze umanistiche si trovano a riflettere sui metodi della ricercadisciplinare, e questo significa ragionare su quanto le nuove tecnologieimplichino un ripensamento di tali metodi.
6 Letteratura e nuove tecnologie
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 6
Lavoriamo sulla presentazione della risorsa intesa come percorso di inda-gine su corpora di materiali a lettura multisequenziale e multilineare: ela-borazione di tragitti di lettura a libera scelta del lettore, ma con un vinco-lo forte dettato dalla selezione dei materiali effettuata in origine da chi hadefinito il progetto ipertestuale. La presunta libertà del navigatore risultaquindi manipolata dall’intenzionalità selettiva del progettista del costrut-to. Ogni prodotto ipertestuale significa infatti selezione e organizzazionedegli elementi significativi ed è quindi necessariamente un processoermeneutico, un’azione interpretativa; è la scelta di un preciso punto divista sull’oggetto dell’analisi.L’obiettivo ideale, che cerchiamo di perseguire, è fornire prodotti diversiattorno a un fulcro semantico prestabilito, in un ottica intertestuale (testioriginali,saggi,bibliografie, letture,commenti,percorsi iconografici), lascian-do al lettore l’adesione ad uno specifico percorso. La scelta tematica simuove per lemmi topici (gli inferni, l’alterità, il corpo, il nemico, i giovani, irifiuti) attorno ai quali vengono definiti tragitti di lettura significativi, trami-te materiali di differente natura e tipologia. Il principio che sovrintende allascelta dei contributi si snoda infatti in una direzione “multi” e “inter” disci-plinare (la letteratura e i classici greci e latini, la letteratura e le arti, il teatro,la musica) nell’ottica di una contestualizzazione sincronica dell’ambitosemantico. Grande attenzione si è prestata poi alla dimensione multimedia-le come strategia di comunicazione unitaria di contenuti informativi, sullascorta del concetto di testo sincretico greimasiano:più linguaggi eterogeneiche contribuiscono simultaneamente alla trasmissione di un significato.16
Per ora ci si è concentrati sulla sola dimensione iconografica come strategiasemantica; percorsi iconografici accompagnano infatti ogni tema semestra-le a corredo del bagaglio informativo fornito dal materiale testuale.
Organizzazione logicaNon esiste un nucleo centrale, a livello testuale, attorno al quale si snoda-no i contributi ma la definizione di un paradigma concettuale, cioè la defi-nizione di un lemma caratterizzante,attorno a cui si inseriscono i vari con-tributi, a pari livello rispetto all’albero della struttura. Ed è una caratteri-stica che connota la rivista come pubblicazione, in cui ogni documentopreserva comunque la sua indipendenza, poiché la mappa concettualeorganizza i materiali in porzioni, ognuno con la sua locazione.Lo schema materiale dell’ipertesto è teoricamente aperto a modifiche delcontenuto e degli elementi organizzativi. L’ipertesto non è un progettofinito, ma un organismo in continua evoluzione, si evolve e naturalmentecambia nel tempo, accumula nuovo materiale e le sue strutture organiz-zative vengono modificate. Ed è la duplice caratteristica di una rivista elet-
7Francesca Tomasi
16 Dall’archivio ipermediale di Dante Gabriel Rossetti sviluppato da J.McGann (http://www.ros-settiarchive.org) al Dante multimediale dell’Università di Princeton (http://www.prince-ton.edu/dante).
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 7
tronica che, superando i limiti materiali imposti dal cartaceo, non prevedeargini nelle dimensioni della pubblicazione digitale e, in quanto prodottoche riflette anche sull’evoluzione delle tecnologie,mantiene sempre aper-ta la possibilità di un ripensamento delle scelte di articolazione logica.È evidente che di fronte alla multiforme vitalità della proposta semanticaofferta dal Web, l’anarchica nebulosa informativa che la rete progressiva-mente amplifica rende disorientante la navigazione. Griseldaonline è unarivista ipermediale di letteratura italiana che vuole proporre, nel rispettodegli standard del W3C e riflettendo sui precetti della nielsoniana webusability e dei principi dell’accessibilità, nuovi modelli di testualità inambiente digitale.Ma più che una rivista si è tentato di realizzare un portale verticale di let-teratura fornendo una finestra per l’accesso, nel contempo, a:– saggi di approfondimento su temi letterari e di teoria della letteratura,ma anche a studi divulgativi su percorsi tematici (Percorsi),– strumenti (corsi e proposte didattiche) per la didattica della letteratura(Formazione e didattica),– nuove tecnologie per le scienze umane (Informatica umanistica).L’attenzione privilegiata alla dimensione didattica (strumenti ad uso di stu-denti e percorsi di formazione e impiego didattico per insegnanti) nondimentica anche l’interesse per la dimensione scientifica dei materialiinformativi; i contributi proposti vogliono infatti rivolgersi nel contempo astudenti e insegnanti (che possono utilizzare i percorsi proposti per unadidattica del testo letterario che, tramite le nuove tecnologie, è un proces-so in transizione) ma anche a studiosi o semplici curiosi della disciplina.
Architettura del sitoPer quanto concerne l’organizzazione strutturale del sito (architettura dell’i-pertesto) la definizione della mappa concettuale ha avuto origine dall’enu-cleazione dei tre settori di primo livello (Percorsi, Formazione e didattica,Informatica umanistica) per definire il navigatore generale del sito (navi-gazione principale), cioè le macrosezioni pertinenti ciascun settore. Nellospazio del paratesto l’uso del navigatore è l’elemento di interattività chegestisce il dialogo con l’utente ed è stato quindi oggetto di riflessione ancheper la definizione del valore del link, con un’attenzione speciale alla dimen-sione semantica della parola chiave in qualità di strumento segnico significa-tivo. Ogni sezione è corredata quindi da una navigatore speciale (navigazio-ne secondaria) che coordina invece i contenuti analitici di ciascun livello.Per quanto riguarda i singoli contributi (saggi, microscopie e percorsididattici) la tipologia dei link in-text (navigazione contestuale) – cioè quel-li che sovrintendono al rapporto del testo con se stesso a livello di para-testo, metatesto e intertesto – si snoda in una duplice direzione: esplicati-vi (nella forma di note) e di approfondimento a livello biografico, biblio-grafico, iconografico, e accesso ai testi primi in versione full-text (conapertura in pagina nuova).
8 Letteratura e nuove tecnologie
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 8
Gestione metadatiAssociare al dato, rappresentato dal testo, informazioni aggiuntive, utili aconnotare la sua identità di risorsa elettronica (a livello descrittivo, strut-turale e gestionale/amministrativo)17 è requisito fondamentale per ogniprocesso di creazione di oggetti digitali. È in fase di studio un modellodi gestione dei metadati, nell’ottica della definizione di un sistema didescrizione uniforme delle risorse elettroniche (nel solco del SemanticWeb18). Per ora le prime forme di descrizione e rappresentazione dellemetainformazioni che qualificano i contributi si sono mosse nella dire-zione del Dublin Core19 (per la semantica della descrizione).A questo siaggiunga che si è aderito al sistema DOI (Digital Object Identifier)20 perl’assegnazione di un codice identificativo univoco a ciascun articolodella rivista.Obiettivo è poi l’ingresso in ACNP (catalogo italiano dei periodici)21 e ladefinizione di un sistema di puntamento reciproco. Si è già provvedutoalla registrazione del sito in Tribunale e all’acquisizione del numero di regi-strazione ISSN (International Standard Serial Number) come pubblica-zione seriale.
9Francesca Tomasi
17 Questa è la tripartizione adottata in letteratura. In Italia l’ICCU (Istituto Centrale per ilCatalogo Unico) ha elaborato il sistema MAG (Metadati Amministrativi Gestionali) per i meta-dati amministrativi e strutturali (http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/metaAG1.pdf) eimporta Dublin Core per i metadati descrittivi. Fra i progetti internazionali si veda il sistemaMETS (Metadata Encoding and Transmission Standard): http://www.loc.gov/stan-dards/mets.18 Cfr. la specifica del W3C sul Semantic Web: http://www.w3.org/2001/sw/.19 Si tratta di un set di 15 elementi base per la descrizione di una risorsa elettronica:Nome – Etichetta assegnata al dato Identificatore – Identificativo univoco assegnato al dato Versione – Versione del dato Registrazione di autorità – Entità autorizzata a registrare il dato Lingua – Lingua nella quale il dato è indicato Definizione – Indicazione che rappresenta chiaramente il concetto e la natura essenziale deldato Obbligatorietà – Indica se il dato è richiesto sempre o solo in alcuni casi (contiene un valore) Tipo di dato – Indica la tipologia del dato che può essere rappresentato nel valore del datostesso Occorrenza massima – Indica un limite alla ripetibilità del dato Commento – Un’osservazione che concerne l’applicazione del dato Sito ufficiale: http://dublincore.org; manuale: http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/, traduzione italiana a cura dell’ICCU: http://www.ic-cu.sbn.it/genera.jsp? id=116.20 «The DOI System is for identifying content objects in the digital environment.DOI® namesare assigned to any entity for use on digital networks.They are used to provide current infor-mation, including where they (or information about them) can be found on the Internet.Information about a digital object may change over time, including where to find it, but itsDOI name will not change» (http://www.doi.org).21 «Il Progetto ha avuto origine negli anni ’70 su iniziativa dell’ISRDS-CNR per realizzare unArchivio Collettivo Nazionale dei Periodici (da qui la sigla ACNP). Dal 1988 il Centro Inter-Bibliotecario dell’Università di Bologna cura, in collaborazione con il CNR, le proceduregestionali online e l’OPAC del catalogo» (http://www.cib.unibo.it/acnp). Per l’accesso diret-to al catalogo: http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 9
Tecnica di implementazionePer quanto riguarda il codice si sono rispettate le specifiche della DTDHTML(4)22 per la gestione della struttura logica del testo (con elaborazio-ne di template) delegando ai fogli di stile CSS (esterni e in linea)23 lagestione del layout. È in previsione, sempre nell’ottica di una rivisitazionedelle scelte originarie,una conversione integrale del sito in formato XML24
(all’interno di un Content Managment System).25
Sezione di informatica umanisticaLa sezione di informatica umanistica possiede un’identità parzialmenteautonoma rispetto alle altre due sezioni, nel senso che non è previsto unadeguamento al tema semestrale. La tipologia delle informazioni disponi-bili nella sezione vuole fornire un quadro d’insieme delle metodologie dianalisi del testo letterario tramite metodologie computazionali:1. Saggi scientifici, che aprono la sezione e campeggiano in home, su untema a cadenza annuale, proposti da autorevoli studiosi della disciplina (ilriconoscimento dell’informatica come disciplina, informatica e disciplineumanistiche, informatica e critica del testo).2. Esemplificazione di procedimenti automatici applicati a testi letterari(codifica XML/TEILite26) su alcuni testi del canone italiano (adottando unacodifica legata alle diverse peculiarità dei testi proposti). Rilevante è statoil ruolo attivo degli studenti nella creazione degli oggetti digitali.3. Un manuale d’uso in versione ipertestuale (per l’applicazione di prati-che computazionali al testo letterario).4. Dei tutoriali di supporto (che affiancano il manuale e aiutano nell’ap-prendimento dei linguaggi).5. Un elenco di risorse online per la letteratura italiana (ciascuna accom-pagnata da una scheda descrittiva analitica).6. Una bibliografia (per macro settori di pertinenza).Il concetto di ipertesto e la sua dimensione multimediale sono stati al cen-tro della riflessione sulle modalità dell’organizzazione logica dei testi dellarivista e del corredo paratestuale (navigatori, livelli diversi dei link internial testo, strumenti di supporto e ausilio). Il progetto di creazione di unoggetto ipermediale è scaturito però da presupposti teorici, metodologici
10 Letteratura e nuove tecnologie
22 La specifica all’indirizzo: http://www.w3.org/TR/html4/.23 Homepage ufficiale dei CSS (Cascading StyleSheet) a cura del W3C: http://www.w3.org/Style/CSS/.24 Extensible Markup Language: http://www.w3.org/XML/.25 Letteralmente “sistema di gestione dei contenuti”. Si tratta di una classe di sistemi softwa-re per organizzare le informazioni nella creazione di siti web.26 La TEI (Text Encoding Initiative, http://www.tei-c.org), è un progetto che vuole individua-re e definire tutti i fenomeni di interesse nell’analisi di un testo letterario (o umanistico in sensolato), assegnando un nome convenzionale a ciascuno di tali fenomeni (elementi del testo) edefinendo le relazioni che tali fenomeni intrattengono tra di loro.Esiste una traduzione italianadella versione “Lite”della TEI, cioè una versione ristretta dello schema di codifica che contem-pla i soli elementi base della codifica: http://www.tei-c.org/Lite/teiu5_it.html.
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 10
e tecnici di più ampia portata. La realizzazione di una risorsa digitale deveessere infatti il risultato dell’elaborazione di un modello ideale, risultato diun’analisi dei contenuti che si intendono destinare alla macchina, quindielaborare e rendere accessibili.Tale fase di modellazione, che coinvolge ilprocesso di definizione della mappa concettuale, richiede consapevolezzadel testo e delle modalità della sua rappresentazione informatica, nonchédelle tecniche specifiche (a livello di standard e di linguaggi) che per-mettano la preservazione dell’informazione distribuita. Creare un oggettodigitale costringe quindi ad un ripensamento del sistema di ideazione ecomposizione del testo e alle forme diverse della sua disseminazione equindi della fruizione. Un processo quindi che costringe a ripensare allatestualità elettronica, intesa in senso estensivo, come momento di rifles-sione teorica, metodologica e tecnica.
11Francesca Tomasi
002 Tomasi 2-11-2007 14:56 Pagina 11
I saggi
Il corpo del rifiuto tra eresia e ortodossiaFernanda Alfieri
Fra XVI e XVII secolo il matrimonio prende forma di istituzione. Per lungotempo governato prevalentemente da istanze private (accordi contrattid’impulso senza testimoni, nei modi e nei luoghi più improbabili, o concor-dati dalle famiglie degli sposi secondo logiche d’interesse), viene condottofuori dall’ingovernabile mondo delle volontà individuali e portato di fronteal sagrato, al cospetto della comunità. Solo in presenza del sacerdote e dialmeno due testimoni le intenzioni degli sposi diventano,da semplice scam-bio di promesse altrimenti sfuggenti e aleatorie, l’atto di creazione di un vin-colo inscindibile, riconosciuto nei suoi effetti materiali e immateriali dal-l’intera comunità.Questo è il portato del decreto Tametsi,emanato nel 1563nelle ultime battute del Concilio di Trento per definire il legame coniugalequanto alla sua dimensione formale.1 Non l’unica, né la più bisognosa diconferma in tempi di risistemazione complessiva dell’ortodossia dopo labufera protestante.Per la sua istituzione divina, come vuole la vicenda para-disiaca di Adamo ed Eva, emblema assoluto e atemporale della storia dellenozze (precede tutti i tempi e inalterato ne sovrasta l’immaginario), la cop-pia di sposi detiene infatti un’ulteriore, intrinseca dimensione di trascen-denza, rafforzata dalla grazia santificante del sacramento.Quest’ultimo, enorme punto – che il matrimonio fosse sacramento – erastato messo in discussione dai riformatori.Come possono i papisti, si eranochiesti Giovanni Calvino e Martin Chemnitz (autore di un criticissimoesame dei decreti conciliari,confutati uno ad uno,quasi a formare un corsodi teologia ad uso delle chiese luterane) sostenere che quel contratto civi-le, creato per generare ed educare la prole, è anche istituto santificante,quando le loro auctoritates non hanno mai perso occasione per tacciarlodei peggiori effetti inquinanti (immundities, pollutio e carnale sordes2)?
2
1 Sul matrimonio pre e post-tridentino rimando principalmente alla serie “I processi matrimo-niali degli archivi ecclesiastici italiani”curata da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni,di cuil’ultimo volume è I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, Il Mulino, 2006.2 I. Calvinus, Institutio christianae religionis, in Opera omnia, IX, Amstelodami, apudviduam Iohannis Schipperi, 1667, p. 397; M. Chemnicius, Examen decretorum Concilii Tri-
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 13
C’è,è indubbio,un nodo da districare,una spina nel fianco del pensiero cri-stiano sul matrimonio che, segnato fin dalle sue origini da un filone di ten-denza rigorista, spesso sull’orlo dell’eresia, stenta ad accettare la positivitàdi quei fenomeni che stravolgono il corpo – necessariamente sessuato – dichi sceglie la via della coniugalità. I difensori dell’ortodossia impugnanoquesto scoglio e intraprendono un riepilogo della storia dell’idea di matri-monio che, fra articolate disputationes e accese controversiae, ridefiniscela situazione coniugale negli aspetti più profondi, problematizzandone ledinamiche costitutive.3 Con uno scavo indagatorio nelle pieghe del talamoche non teme di sconfinare nell’inopportuno,reso decoroso dal fine urgen-te (ristabilire l’esatta dottrina, ribadire una veritas catholica) e dai modiasettici e consequenziali dell’armatura scolastica, scongiurano le insinua-zioni dei riformatori, che avevano tentato di colpire la sacramentalità delmatrimonio utilizzando le diffidenze verso l’istituto coniugale espresse,neisecoli, proprio da quei Doctores fondanti per la parte cattolica. Nel respin-gere l’accusa di aver rifiutato il matrimonio, istituto per la pratica delcorpo, organizzano un’imponente riflessione sulle fondamenta della veri-tas catholica, attraverso una doppia, travagliata operazione: la rielaborazio-ne e la presa di distanza da quegli antichi spettri ereticali, rinfocolati dallerecenti enormità protestanti, che avevano pronunciato nei confronti delmatrimonio uno sprezzante rifiuto, e l’esame delle difficoltà dell’ortodos-sia, che al rifiuto alterna un’argomentata perplessità.
1. Gli eretici antichi e l’ambiguo effetto del rifiuto del corpo
Dopo aver predicato trent’anni a Salamanca, aver offerto a Filippo II parerida consigliere e partecipato alle sessioni iniziali del Concilio di Trento, ilfrancescano Alonso de Castro riordina in quattordici libri Adversus omneshaereses tutte le aberrazioni ereticali conosciute nella storia, disposte alfa-beticamente per argomenti. Molte le malìe dell’errore. Ogni ambito dell’esi-stenza,dal nutrirsi, all’indossare scarpe, al concepire il divino,è stato minac-ciato da straordinari abbagli. A leggerli così, ripercorsi sistematicamentecome propone il francescano, si presentano in tutta la loro assurda e com-plicata miseria. Sarebbe stato invece così semplice attenersi alla verità. Il let-tore coevo a Castro vi avrebbe visto solo la premessa della più grande frat-tura confessionale mai avvenuta, sperimentata in tempi così recenti. La gal-
14 I saggi
dentini, II, Francofurti ad Moenum, apud Paulum Reffelerum, 1576, pp. 1209-1210. Su matri-monio e continenza nel pensiero dei riformatori, vedi: J. F. Harrington, Reordering Marriageand Society in Reformation Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp.62-71; M. Banner, Sexualität in Theologische Realenzyklopädie, XXXI, Berlin-New York, deGruyter, 2000, pp. 203-204; M. E. Schild, Ehe, ivi, IX, pp. 336-343.3 Per le discussioni tridentine sul dogma della sacramentalità, si veda G. Le Bras, Mariage, inDictionnaire de théologie catholique, IX, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1927, col. 2223-2246; H. Jedin, Storia del concilio di Trento, IV/2, Brescia, Morcelliana, 1973, pp. 139-173; J.Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 289.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 14
leria di dannati accolta nella voce Nuptiae è aperta dagli Encratiti, i primi afare del rifiuto del matrimonio una delle principali forme di ostentazionedella loro settaria peculiarità.4 Sotto la guida di Marcione si astenevano dalconsumo di carne e reputavano la pratica sessuale, anche all’interno delmatrimonio,una forma di disordine e corruzione,notando in quella sorta diaffossamento della mente che segue ogni atto carnale un evidente segno didegradazione.Dal loro gruppo, fiorito nel II secolo,veniva escluso chiunquepraticasse quella commistione che è propria dell’umanità caduta dopo ilpeccato di Adamo.Se il progenitore non avesse peccato,non ci sarebbe statainfatti nessuna copula. Della stessa opinione erano gli Armeni, definitiva-mente esclusi dalla vera fides dai decreti del concilio di Calcedonia, cheerravano convinti che se Adamo ed Eva fossero rimasti nello stato in cui Dioli aveva voluti, mai avrebbero dovuto unirsi. Le nozze, intese come unionecarnale, sono illecite in quanto estranee alla natura dell’uomo così come erastata pensata in origine.In altro modo avrebbe dovuto propagarsi la specie umana.Per questa stes-sa ragione i seguaci di Eustazio di Sebaste, che dall’Armenia insegnava l’a-stinenza dai cibi e dall’unione coniugale, giungevano a separare con laforza chi già aveva contratto matrimonio. E se Saturnino dalla Siria procla-mava che nubere et generare era opera di Satana, i seguaci di Priscillianoin Spagna nel IV secolo argomentavano il loro orrore eretico per le nozzee la procreazione con l’inadeguatezza del corpo alla perfezione dell’ani-ma, vedendo per questo nella plasmatio del corpo lo specchio della per-versità diabolica, e nei semi della conceptio nell’utero (la sostanza raccol-ta e trattenuta dall’atto femminile del con-capere) l’azione demoniaca.E se si tentasse allora di tornare all’innocenza originaria, quando il corponon era ancora coperto di vergogna e nessuna urgenza spingeva l’uomo ela donna ad accoppiarsi? Ci provarono gli Adamiani. Datisi un nome cherimandava al loro progenitore e modello, convinti di poter recuperare quel-la purezza delle origini che ignorava l’attrazione fra i corpi, usavano riunirsiin promiscuità, del tutto privi delle vesti. Organizzati secondo un sistematecnicamente tanto complicato quanto funzionale alla loro aberrazione,ricostruivano il loro paradiso originario nelle cavità torride degli ipocausti
15Fernanda Alfieri
4 A.de Castro,Adversus omnes haereses libri XIV, Parisiis,ex officina calchographica Michae-lis Vascosani, 1541, fol. 174 v. Su matrimonio e corporeità nel pensiero cristiano antico esisteuna letteratura vastissima che qui può essere indicata parzialmente: P. Brown, The Body andSociety.Men, women and Sexual Renounciation in Early Christianity, New York,ColumbiaUniversity Press, 1988 [trad. it. Il corpo e la società. Uomini, donne e continenza nel primocristianesimo, Torino, Einaudi, 1992]; G. Sfameni Gasparro, C. Magazzù, C.Aloe Spada (a curadi), La coppia nei Padri, Milano, Edizioni Paoline, 1991; U. Mattioli (a cura di), La donna nelpensiero cristiano antico, Genova, Marietti, 1983, pp. 17-50; G.Armas, Hacía una ética cri-stiana del hogar, in «Augustinus», III, 1958, pp. 83-121;A. Rousselle, Porneia: de la maîtrisedu corps a la privation sensorielle: IIe-IVe siècles de l’ère chrétienne, Paris, Presses universi-taires de France,1983 [trad. it.Sesso e società alle origini dell’età cristiana, Roma-Bari, Later-za, 1995]; P. Nardi, L’eros nei Padri della Chiesa. Storia delle idee, rilievi antropologici, Mon-tespertoli,Aleph, 2000; U. Bianchi (a cura di), La tradizione dell’enkráteia.Atti del colloquiointernazionale Milano 20-23 Aprile 1982, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1988.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 15
(le camere a volta sotterranea in cui era installato l’impianto di riscalda-mento), cui si accedeva avendo affidato i propri indumenti ad appositicustodi del guardaroba. Allora nudi celebravano i sacramenti, uniti in unacomunità che voleva riprodurre quella situazione edenica in cui Adamo edEva non solo non provavano pudore l’uno al cospetto dell’altra,ma non ave-vano nemmeno necessità di congiungersi carnalmente per rimediare a queldestino di morte che ebbe inizio dopo la loro caduta. La leggenda di Barna-ba apostolo consegna l’immagine grottesca e stralunata di uomini e donneche corrono portando con sé – non indosso! – i vestiti,ambulantes nudi inpreda a quel turbamento che la nudità inevitabilmente arreca agli uominidopo il peccato di Adamo. Illusi di tornare a uno stato di originaria imper-meabilità agli stimoli visivi, presuntuosi nell’ambizione di poter rinunciareal matrimonio, sfidando la legge del pudore essi – ci dice il Cathalogus hae-reticorum, con cui nel primo quarto del XVI secolo il domenicano Bernar-do di Lussemburgo ricapitolava antiche eresie e nuove luterane deviazioni– non facevano altro, in fondo, che alimentare la propria concupiscenza.Il rifiuto del corpo conduce, insomma, a una sua paradossale centralità,che presto si converte in frenesia. Come accadde agli Adamiti (stessa radi-ce, stesse velleità edeniche) fioriti in Boemia nel XV secolo, resi ebbri allimite della follia dalla fiducia (errata) nella loro imperturbabilità.Ancorapiù oltraggiosi degli Adamiani, si piegavano all’ordine del maestro Picardo,un folle venuto dalle Fiandre che imponeva la nudità non solo nelle assem-blee, ma in ogni momento della giornata.Apparentemente estinto, il fiume carsico dell’eresia del corpo nudo sareb-be più volte riemerso.Per esempio,un secolo più tardi ad Amsterdam,doveun gruppo di Anabattisti – eretici moderni con una recidiva ambizione ada-mitica – gettati gli abiti nel fuoco come offerta in sacrificio all’Eterno, con-servando sulla testa solo un nastro per tenere i capelli raccolti, avevanoattraversato le strade della città gridando come folli alla fine del mondo.Ma se nei casi dei seguaci di Adamo il corpo rifiutato nel suo uso naturaleserviva a dichiarare il disprezzo per la situazione degradata dell’umanità, seper gli allucinati di Amsterdam la nudità esprimeva ansie millenaristiche eun distacco preventivo dalla contingenza prima che la Fine giungessecogliendoli impreparati, spesso il nucleo dell’eresia risiede molto più sem-plicemente in un particolare spiritus libidinis (da cui si origina) o in carnisobscenae delectationes (nelle quali l’eresia sfocia).Aggiungeva questa con-siderazione il francescano Miguel de Medina,5 invitato da Filippo II ad argo-mentare contro le pretese dei tedeschi di entrare nel sacerdozio pur con-servando le proprie mogli.Argomento,quello dell’eresia della carne,da sem-pre rischiosissimo e pieno di implicazioni,se già Paolo nella Lettera ai Gala-ti (5, 19-22) includeva nel celebre elenco delle opere carnali, accanto a for-
16 I saggi
5 M. Medina, De Sacrorum hominum continentia, Venetiis, ex officinis Iordani Zileti, 1569,prologo. Sull’autore, vedi E.D’Alençon,Medina Michel, in Dictionnaire de Théologie Catho-lique, cit., 10/I, coll. 481-485.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 16
nicatio, immunditia, impudicitia e luxuria, anche haereses, volendosignificarne la stretta relazione. Del resto, che vi sia un nesso tra comporta-mento osceno e aberrazione della credenza religiosa è un fatto già segnatonei monumenta della storia della Chiesa dei primi secoli. Molti coprironocol pretestuoso velo della religione le loro carnis furiosae delectationes. Sipensi solo a Simon Mago, il principe di tutti gli eretici, che oltre a voleracquistare col denaro lo Spirito santo, predicava l’uso promiscuo delledonne, a capo di una setta di mystici sacerdotes che libidinose vivunt;6
oppure ai Carpocraziani e alle loro abbuffate di cibo,che precedevano altreben più gravi abbuffate, celebrate in totale promiscuità e oscurità.
2. Moderare l’ostilità, interrogare i perplessi
Nel 1605 usciva a Madrid il terzo tomo delle Disputationes de sanctomatrimonii sacramento del gesuita Tomás Sánchez, prefetto di casi dicoscienza, ovvero per più di trent’anni ultimo risolutore dei dilemmi piùintricati, che i confessori della città di Granada gli sottoponevano in cercadell’opinione più solida.7 Nella sua summa sul tema coniugale (uno deiprimi trattati post-tridentini interamente dedicati all’argomento in tutte lesue sfaccettature) riflette sulle ragioni della squalifica integrale della situa-zione coniugale operata dagli antichi difensori della purezza paradisiaca.Organizzando un discorso complessivo su tutti i colori della dottrina, inun’esigenza di riassetto e conferma della verità autentica, constata che laminaccia alla dignità delle nozze non proviene soltanto dalle eresie chesin dai primi secoli dell’era cristiana avevano rifiutato la pratica del corpo,specialmente se è dentro l’istituto per la sua santificazione.Vi sono pure, infatti, diversi doctores catholici fra i sostenitori dell’ideache nell’atto consumato fra i coniugi si annidi una forma di malvagità chenemmeno la dignità e costumatezza date dalla fides coniugale possonoeludere. Anche nell’ortodossia, lo scoglio pare risiedere nell’inevitabilecompromissione del matrimonio con la corporeità. Sorgente di vita e di
17Fernanda Alfieri
6 Irenaeus, Contra haereses libri quinque, Patrologiae cursus completus. Series graeca(d’ora in avanti PG),VII, accurante J. P. Migne, Parisiis, Granier, 1857-1866, col. 670 e Augusti-nus Hipponiensis,De haeresibus ad Quodvultdeum liber unus, in Patrologiae cursus com-pletus. Series latina (d’ora in avanti PL), XLII, accurante J. P. Migne, Parisiis, Garnier, 1844-1865, coll. 21-50.7 Su Tomás Sánchez, vedi C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, I, Bru-xelles-Paris, Oscar Schepens-Alphonse Picard, 1896, col. 53-537; N. Antonius, Bibliothecahispana, II, Romae, ex officina Nicolai Angeli Tinassi, 1672, pp. 251-252; H. Hurter, Nomen-clator literarius theologiae catholicae, III, Oeniponte, Libraria academica wagneriana, 1907,coll. 593-598;A.Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, IV,Madrid, 1913, p. 65; M. Ruiz Jurado, Para una biografía de Tomás Sánchez, in «Archivo Teo-lógico Granadino»,XLV,1982,pp.15-51;E.Olivares,Ediciones de las obras de Tomás Sánchez,ivi, pp. 53-199; dello stesso autore, En el cuarto centenario de la publicación de los tomos2° y 3° del tratado de Tomás Sánchez, in «Archivo Teológico Granadino» LXVIII, 2005, pp. 5-78; J. J. Lozano Navarro, Tomás Sánchez, Granada, Editorial Comares, 2000.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 17
morte, il corpo del coniuge diminuisce se stesso, lasciando parte di sé nelprocesso di generazione, e spezza l’interezza di mente con cui sarebbeinvece chiamato a dedicarsi al divino (Paolo, I Cor 7, 32-34), oscurandonela lucidità con continui richiami al corpo sessuato dell’altro.8 Non proprioun fatto neutro, insomma,né di poca cosa.Del resto, l’atto coniugale – cheè usus matrimonii, ovvero in assoluto l’atto del matrimonio – ha unruolo talmente centrale da richiedere al gesuita la stesura di un interolibro (uno su dieci) ad esso dedicato. Che, appunto, si apre con unadomanda intorno alla positività dell’uso del corpo all’interno del matri-monio. È in questione non solo la sua bontà, ma anche la sua capacità diavvicinare l’uomo all’acquisizione della salvezza.9 E a questo proposito iperplessi sono diversi, recuperati e interrogati dal difensore dell’ortodos-sia attraverso un gioco di rimandi (la spirale barocca delle mille auctori-tates) che affonda di nuovo nel cuore della Chiesa dei primi secoli.
3. Nelle gabbie di carne. Lo Spirito nega la propria presenza
Il popolo di Israele si trovava da mesi nel deserto, sopravvivendo graziealla manna che la notte si posava sul campo con la rugiada. Stanco dinutrirsi di quel cibo, prese a lamentarsi rimpiangendo le delizie della terradi schiavitù, sovrabbondante di cocomeri, meloni, porri, cipolle e aglio.Mosè, gravato dal peso della guida del popolo, invocò Dio chiedendo diesserne alleviato. Dio gli ordinò allora di radunare settanta uomini fra glianziani, sui quali promise che avrebbe infuso quello Spirito santo di cui ilprofeta già era pieno. Lo Spirito si posò su di essi e profetizzarono.Fra il 245 e il 247 Origene commentava a Cesarea l’episodio narrato nellibro dei Numeri (11, 1-26), chiedendosi in che modo lo Spirito santopotesse abitare gli uomini, essendo essi inevitabilmente inclini a peccare.Può, insomma, essere presente sempre, in tutte le azioni, anche nelle piùinsignificanti o non assolutamente positive? Individuato da Sánchez comeuno dei più accaniti fautori della squalifica dell’uso del matrimonio, Ori-gene concludeva che vi sono effettivamente alcuni atti che,pur non essen-do proprio peccaminosi, non sono tuttavia degni di tanto ospite. Fra que-sti, gli atti del matrimonio: nel tempo in cui vengono consumati lo Spiri-to, presente di solito nella coppia quando i coniugi sono capaci di conte-nersi, si allontana.10 L’idea che l’unione fisica getti gli uomini in uno stato
18 I saggi
8 Sulla “cultura dell’uno” nel pensiero cristiano del matrimonio, E. Dieni, Tradizione «juscor-poralista» e codificazione del matrimonio canonico, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 571-589.9 T. Sanchez, Disputationes de sancto matrimonii sacramento, II, Venetiis, apud Iuntas,1606, p. 175.10 Origenes, Homiliae in Numeros, in PG XII, col. 610.Vedi F. Cocchini, La normativa sulculto e sulla purità rituale nella interpretazione di Origene, in «Annali di storia dell’ese-gesi» XIII/1, 1996, pp. 143-158.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 18
di menomazione trova giustificazione nell’idea origeniana della doppiacreazione.La prima vide comparire intelligenze pure,spiriti in armonia coldivino, neutri, privi di sesso; la seconda avvolse le anime di corpi distintiin maschi e femmine, gabbie di carne imbrigliate nella contingenza, sog-gette alle schiavitù del mondo. Il corpo è segno della lontananza da quelmomento originario della storia dell’uomo in cui egli gravitava indistintonell’orbita dell’amore divino, fuso con esso in perfetta armonia. Nella con-dizione attuale, contrarre matrimonio significa dunque accettare una cor-poreità sessuata che accentua la determinazione del soggetto in uomo odonna, assegnandogli un ruolo in un mondo di contingenza e morte. Nonsi dovrebbe invece abbandonare la veste del corpo e recuperare un’es-senza originaria che ci vedeva tutt’uno con Dio, neutri e indeterminati?Non dovremmo tenerci distanti dall’abbuffata degli imperfetti, che cerca-no di colmare nell’unione sessuale la loro fame di completezza? Il pensiero di Origene era stato impugnato dai riformatori per dimostrareche, mancando lo Spirito santo nell’atto coniugale, il matrimonio non èsacramento. In coitu negant unquam spiritum sanctum adesse.11 Rober-to Bellarmino, autore di un imponente sistema di Controversie destinatea confutare la devianza ereticale in tutte le sue forme, frutto di dodici annidi corsi tenuti al Collegio Romano, avrebbe risposto che se lo Spirito èassente è perché un suo speciale aiuto in questo caso è inutile.Vi sono atti,come quello fra coniugi, che essendo buoni ma naturalia non necessita-no di quella divina presenza. In essi tutto avviene “secondo natura”. Se Diointerviene, è nell’indurre i coniugi alla volontà di procreare.Al resto pen-sano, spinti da forza propria sine novo et speciali Dei auxilio, i natura-lia instrumenta della generazione.12
4. Politica del turpe. Se il corpo rifiuta l’obbedienza
Il turpe è ciò che accade quando una giusta gerarchia viene violata e la sov-versione è evidente. E la giusta gerarchia è quella della ragione che dominasulle altre forze dell’anima e sui meccanismi del corpo.Così stando all’EticaNicomachea, alla luce della quale Alonso Tostado di Avila, vescovo e autoredi un monumentale commento alle Scritture, commenta la Genesi sul finiredel Quattrocento.13 Quando le forze vitali, con movimenti puramente vege-
19Fernanda Alfieri
11 Calvinus, Institutio..., cit., p. 397.Vedi nota 2.12 R. Bellarminus, De controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos,in Opera omnia, II, Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1620, p. 1282. Su Bellarminorimando principalmente a F. Motta, Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma,Brescia, Morcelliana, 2005.13 A.Tostatus, Commentaria in Genesim, in Opera omnia, I,Venetiis, apud Nicolaum Peza-nam,1728, p.423.Sulla vita e sull’opera di Tostado,vedi E.Mangenot,Alphonse Tostat, in Dic-tionnaire de théologie catholique, cit., 1/I, coll. 921-923; P. L. Suárez, En el V centenario deAlfonso Tostado de Madrigal, in «Salmanticensis», II, 1955, pp. 140-150.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 19
tativi e nutritivi svincolati dalle nostre volontà agiscono negli organi ad essedeputati, non accade nulla di turpe, tanto più che tutto questo non si svol-ge in superficie, ma in luoghi ben nascosti all’interno dell’organismo (il sin-tomi del desiderio di cibo, per esempio, o i processi di elaborazione dellesostanze nutritive).Vi sono invece delle parti dell’anima che, pur essendoirrazionali, comunicano con la ragione e sono ad essa assoggettabili.14 Sitratta della concupiscibilis e dell’irascibilis, che talvolta alla ragione obbe-discono, talvolta resistono, suscitando così il disordine turpe. È soprattuttoin concupiscentia che questo si verifica, una forza che si insinua insidiosa-mente e difficilmente può essere riassorbita prima che trovi sfogo. Più sem-plice da gestire è l’ira, ci si possono fare i conti, addirittura syllogizare. Chipronuncia una parola violenta o percuote qualcuno,non può farlo se non èla volontà a muovere la lingua e la mano,che funzionano ugualmente anchese non animate dall’ira. Il meccanismo governato dalla concupiscentia,ben-chè chiaramente intelligibile (agli occhi del teologo che utilizza gli stru-menti della biologia aristotelica), ha invece qualcosa di inesorabile: dallaanticipazione delle delizie che verranno (il pensiero della voluptas che siotterrà dall’atto generativo) si innescano i processi fisiologici che prepara-no alla generazione, sottoponendo il corpo a un turbamento che difficil-mente può essere riassorbito dall’azione della ragione. Alcune parti delcorpo – quelle interessate alla continuazione della specie – sono più di altrecolpite da questa dinamica sovversiva. Qui, una volta innescato il processo,se la ragione stabilisce la sua cessazione, la disobbedienza al suo dettame ècerta. La geografia del corpo ha quindi un’isola di impermeabilità al con-trollo razionale.Agli occhi del teologo, ciò che distingue gli organi corporeigli uni dagli altri, oltre alla funzione, è la loro governabilità, e le dinamichedelle potenze dell’anima e del loro agire sul corpo si possono descriverecon un vocabolario politico: usurpatio, inoboedientia, rebellio, resisten-tia. Ci sono vires inferiores che devono essere imperatae, et non impe-rantes. Non devono intraprendere nessuna iniziativa, ma attendere l’impe-rium rationis, alla quale spetta definire et praecipere. Se questo accade, èusurpatio. Se l’istinto respinge un ordine razionale, come quando si accen-de un desiderio errato per una donna che appartiene ad altri,è invece aper-ta inoboedientia et rebellio. Qui si verifica il massimo grado di vergogna:quanto più strenua è la resistenza, tanto maggiore è il turpe e tanto piùarrossiamo vergognosi, sensazione ancora più forte se il disordine è mani-festo, riflettendosi negli organi esterni. Perché ciò che accade alle partidestinate alla generazione è evidente. Nessuno nota il disordine dello sto-maco, mentre a tutti è visibile ciò che avviene nei vasa genitalia.
20 I saggi
14 Sulla ripartizione dell’anima in Aristotele, vedi M.Vegetti, L’etica degli antichi, Roma-Bari,Laterza, 1989, pp. 173-210; sulla sua ricezione nella teologia scolastica, R.A. Couture, L’impu-tabilité morale des premiers mouvements de sensualité de Saint Thomas aux Salmanti-censes, Roma,PUG,1962;M.Bergamo,L’anatomia dell’anima.Da François de Sales a Féné-lon, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 29-65.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 20
Et istud magis manifestatur in actu coniugali. Per alcuni Doctores catholi-ci questo è motivo di perplessità intorno all’onestà del matrimonio. Come sipuò pensare che sia una condizione del tutto rispettabile, se costringe chi lopratica – chi usa del matrimonio – ad assistere alla sconfitta del controllo sudi sé, quando una forza innata assorbe la ragione e non si è più in grado digovernare il corpo in tutti i suoi movimenti? Una perdita di controllo la cuipremessa è scritta nella storia dell’umanità.Accadde infatti ai progenitori chela libido acquistasse al suo diritto, così come si fa con gli schiavi (mancipa-vit), le parti destinate alla generazione, in modo che solo lei potesse decideredei loro movimenti. È per questo che anche ora nessun’altra parte del corporisulta così chiaramente soggetta a una forza indipendente,nessun altro gene-re di movimento obbedisce così palesemente a regole proprie. Un territoriosul quale nessun atto di forza si impone, ma che richiede uno speciale prin-cipatus politicus liberalis, in cui l’autorità non si esercita qualiter vult,facendo osservare le sue regole, sed qualiter potest rogando et suadendo.
5. Se la perdita di interezza spinge fuori dal sacro e fuori dalla comunità
I dodici pani, dodici come le tribù di Israele, offerti a Dio ogni sabato, pos-sono essere mangiati solo dai sacerdoti e dai loro figli, a patto che non sisiano da poco uniti alle proprie mogli. Questa fu la condizione posta daAchimelech, il sacerdote di Nob,quando offrì i pani della proposizione deltempio a David e ai suoi uomini: solo se erano mundi, maxime a mulie-ribus. Dall’episodio del primo libro di Samuele (I Sam 21, 2-7) Gerolamo,che nella summa di Sánchez15 e presso il difensore dell’ortodossia16 è frale schiere dei perplessi intorno all’esercizio nuziale, trae la conclusioneche ogni tipo di commistione fisica è immunda. Per quale ragione lo sia,e in base a cosa si qualifichino le immundities, era dilemma non sfuggitoall’onnivoro commentatore di Avila, il Tostado a venticinque anni già pro-fessore di filosofia e teologia a Salamanca, che delle varie immunditiesaveva tentato di costruire una scala, i cui gradi sono scanditi dalla duratadell’allontanamento dal sacro e dalla collettività patite dall’immondo.Se la immunditia è grave quanto più esclude dalla comunità, le peggioriallora sono la lebbra e l’inarrestabile fluxus seminis della gonorrea, checostringono chi ne soffre all’allontanamento per tutta la durata dellamalattia; il contatto con un corpo morto procura invece una contamina-zione che dura sette giorni, mentre quella causata dall’atto sessuale simantiene fino alla sera.17 Quest’ultima immundities viene da dentro ilcorpo e, a differenza delle altre, è connaturata alla condizione umana per-
21Fernanda Alfieri
15 Sanchez, Disputationes..., cit., p. 175.16 Bellarminus, De controversiis..., cit., col. 1282.17 Tostatus, In I Regum, in Opera omnia, cit.,VI, p. 142.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 21
ché accompagna i necessari fatti della generazione. È infatti immonda lapuerpera, la donna mestruata e chi si è accostato legittimamente alla pro-pria moglie.Achimelech stesso, quando indagò sulla purezza degli uominidi David, non alluse a loro eventuali unioni illecite, ma intese come porta-tore di immundities anche l’atto cum propria uxore.18
Nessuna delle condizioni evidenziate da Tostado è in sé peccato ma, inrelazione a un peculiare sistema di regole, sembra piuttosto far piombarel’individuo in una sorta di “irregolarità” non priva di conseguenze. Nellaversione dei Settanta, immundities è akatharsìa, che nella religione vete-rotestamentaria può definire lo stato di chi viene a contatto con le forzeocculte della vita e della morte.19 Ciò che pertiene alla generazione è lega-to a dinamiche involontarie (non dipendenti dall’uomo) di devastantegrandiosità che una volta messe in moto, dal buio e inafferrabile misterodella vita e della morte, aderiscono all’organismo di chi le sperimentaintaccandolo.Ogni corpo che versa sangue,che sia nella forma di mestruoo di seme, è teatro dell’enorme e incontrollabile potenza della forza dellavita. Ma è anche inevitabilmente una scena di morte, perché ogni proces-so generativo comporta una necessaria perdita di essere. Una parte di vitase ne esce dal corpo,che da “più fertile”e “più vitale”si trasforma in “menofertile”e “meno vitale”. Si entra così in una specie di stato di deprivazione,che rende il tempio (il luogo del sacro) inaccessibile all’uomo debilitato.Qui dimorano le forze divine, l’incontro con le quali, per chi non è abba-stanza “pieno di vita” (di seme vitale) può essere molto rischioso, perchéla vista di Dio ha una forza tale da poter uccidere.20 Ma l’irregularitas dichi non è mundus sta anche nell’essere “fuori posto”, o in una condizio-ne depotenziata nella quale non dovrebbe trovarsi. L’uomo che emetteseme si rende diverso da quello che è di solito, divenendo diminuito edebole. Per questo David e i suoi uomini si erano mantenuti puri (dove-vano affrontare un viaggio, spiega David stesso al sacerdote), così comefanno i soldati prima di andare in guerra.Il concetto di immundities è solitamente accostato a quello di coinqui-natio, che indica ogni atto che causa perdita di interezza. Che il mesco-larsi alle donne provochi la cessazione della integrità per eccellenza, laverginità, è il messaggio che trapela dall’immagine apocalittica (Ap 14, 4)
22 I saggi
18 Ibidem.19 Sui temi del puro e dell’impuro nell’Antico Testamento, vedi il fondante e discusso M. Dou-glas, Purity and Danger.An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London, Routled-ge, 1966 [trad. it.Purezza e pericolo, Bologna, Il Mulino, 1975]; J.Neusner,The Idea of Purityin Ancient Judaism, Leiden, Brill, 1973; P. Sacchi, “Omnia munda mundis” (Tito, 1,15): ilpuro e l’impuro nel pensiero ebraico, in Il pensiero di Paolo nella storia del cristianesimoantico, Genova,Università di Genova, 1983,pp.29-55;E.Biale,Eros and the Jews.From Bibli-cal Israel to Contemporary America, Berkeley, University of California Press, 1997 [trad. it.L’eros nell’ebraismo. Dai tempi biblici ai giorni nostri, Firenze, Giuntina, 2003, pp. 53-56].20 Vedi F.Hauck,R.Meyer,Katharòs, in Grande lessico del Nuovo Testamento, IV,Brescia,Pai-deia, 1968, coll. 1255-1296; vedi anche Miasma, Miasmòs, ivi,VII, col. 219-226; vedi anche L.Legrand, La virginité dans la Bible, Paris, Éditions du Cerf, 1963, pp. 65-70.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 22
dei centoquarantaquattromila al seguito dell’Agnello sul monte Sion, elet-ti di Dio, segnati dal sigillo in fronte che li rende invulnerabili alle sedu-zioni del falso profeta. Riscattati dalla terra, partecipano della beatitudinedi Dio perché sono vergini. Hi sunt qui cum mulieribus non sunt coin-quinati.21 Fra tutti gli uomini essi sono le primizie, graditi a Dio come losono i primi frutti della stagione, seguaci dell’agnello mente et corpore,fide et spe. Non hanno perduto l’unità del corpo e della mente contraen-do matrimonio, che comporta la necessaria fine dell’interezza, la rotturadell’equilibrio autosufficiente. Implicati nella vita comune, mescolati altransitorio, divisi fra sé e un “altro da sé” che distoglie dal proprio centro,i non virgines (i coinquinati) non accederanno alla beatitudine finalecosì come non possono accedere al sacro nel tempio.
6. L’impuro viene da dentro
I doctores catholici temevano che nell’atto coniugale si trovassero immun-dities e coinquinatio, valori mutuati dal codice di purità veterotestamen-tario e dalle allusioni escatologiche dell’Apocalisse, ma arricchiti ora dinuove implicazioni. Nell’analizzare il problema sopra illustrato, il teologomoderno sottolinea che sono fatti naturali e in quanto tali non possonoessere considerati peccato. Se rendono chi li sperimenta indegno di acco-starsi al sacro non è, come vuole l’antico codice di purità, per la contami-nazione contratta in seguito ad emissione di liquidi vitali,ma per lo stato dianarchia che accompagna il fatto fisiologico. Perché chi si accosta allamoglie non può evitare di subire, in una parte del proprio corpo, lo scate-namento di un “sussulto orrendo” (motus foedus) che è eredità del pecca-to dei progenitori. Il tabù non deriva tanto, dunque, dal legame dell’attogenerativo con le forze occulte della vita e della morte, ma col manifestar-si in esso delle conseguenze della caduta di Adamo ed Eva. Il fattore inqui-nante che deve perturbare i Doctores catholici non è l’elemento seminalein sé, traccia della incomprensibile e sovrastatrice forza sacra della vita, mal’anarchia che si scatena in quella provincia del corpo di cui vergognarsi,teatro nel quale si ripete ogni volta la tragedia della perdita dell’integritàoriginaria. Ciò che spaventa è dentro l’uomo, ad esso connaturato e inscin-dibilmente legato alla sua storia. È la traccia della colpa dei padri, che pun-tualmente, in ogni atto di produzione della vita, affiora con i suoi effetti didisordine. Ciò che perturba non è la perdita di sostanza vitale, ma lo scon-volgimento che accompagna il genere umano dalla cacciata dell’Eden,dallaperdita della vita eterna e dall’inizio, dunque, della morte.In questo senso immundities può significare irregularitas: se si accostaalla propria donna l’uomo non è più totalmente vigile su di sé, intero nelsuo autocontrollo. È fuori dalla sua regola originaria. E allora, paradossal-
23Fernanda Alfieri
21 Sanchez, Disputationes..., cit., p. 175.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 23
mente, in questa prospettiva non c’è alcuna differenza se l’atto è consu-mato legittimamente con la propria moglie, nella totale promiscuità onelle situazioni più degradanti.22 In ogni caso l’uomo si riduce a uno statovergognoso di doppiezza. Perduta l’interezza, diviene spezzato, ibridonella compresenza di più poli di forza slegati fra loro. Turpitudo etimmundities vanno per questo insieme: sono la perdita di controllo, ilsovvertimento delle gerarchie interne e la divisione che inducono l’uomoa provare un’inevitabile vergogna. Non è un problema di perdita di vita edi conseguente allontanamento dalla collettività e dal sacro. Ma di perditadel controllo e di allontanamento da se stessi:23 l’impuro è ciò che non èconforme all’ordine razionale. Il rifiuto dell’uso del corpo sessuato affon-da ora le sue radici nella sfera dell’individualità.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6alfieri.htm.
24 I saggi
22 Tostatus, In I Regum, cit., p. 172.23 Non è possibile trattare qui della ricezione della dottrina agostiniana dei “beni del matri-monio” che ne compensano le “diminuzioni” (detrimenta) e lo legittimano, per la qualerimando principalmente a Dieni, Tradizione «juscorporalista», cit., pp. 590-598; A. Mat-theeuws, Union et procréation. Développements de la doctrine des fins du mariage, Paris,Éditions du Cerf, 1989, pp. 32-50.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 24
25Nicola Bonazzi
Parodia e scatologia: quando la letteratura prende in giro se stessaNicola Bonazzi
Passeggiando fra l’erba alta che è spuntata intorno alla città di Troia, BalsoSnell si imbattè nel famoso cavallo di legno dei greci. Essendo egli un poeta,ricordava l’antico canto di Omero, e decise di trovare un modo per entrarci.Esaminando il cavallo, Balso scoprì che c’erano solo tre aperture: la bocca,l’ombelico, e l’apertura posteriore del canale alimentare. La bocca era fuoriportata, l’ombelico si dimostrò un cul-de-sac, e così, dimenticando la propriadignità, si avvicinò all’ultimo orifizio. O Anus Mirabilis!1
I capoversi iniziali del primo libro di Nathanael West, The dream life ofBalso Snell o, nell’ormai introvabile traduzione italiana, La vita in sognodi Balso Snell, ipostatizzano efficacemente l’atteggiamento agonistico cheil giovane scrittore americano si compiace di intrattenere con l’industrialetteraria contemporanea. Il viaggio di Balso Snell è un’avventura all’in-contrario, vera e propria (alla lettera) mise-en-abîme che riproduce, rove-sciato, e dunque parodizzato, il possibile esordio della letteratura dallapancia cava, ma ripiena di eroi in assetto di guerra, del cavallo di Troia.Dalla fuoriuscita di quegli eroi, sorta di evacuazione mitica e fondativa,tutto, ovvero il canto dell’aedo Omero, e il canto tout-court, poetico,epico, narrativo dell’intera civiltà letteraria aveva avuto inizio. Quello diBalso, allora, è un nuovo avvio, una ri-fondazione, che per avere luogo,costringe l’eroe eponimo, o se si vuole, nel gioco antifrastico, l’anti-eroeeponimo (già il nome, Balso Snell, odora di slapstick, cioè di abbassamen-to parodico),a penetrare nell’orifizio posteriore del cavallo e percorrerne,a ritroso, l’intero canale intestinale. Dentro, Balso non troverà certo guer-rieri armati di lame dardeggianti bagliori di mitologico splendore, ma, nel-l’ordine: una guida che tenta maldestramente di discutere i fondamentidell’arte; un ossesso che si sta trafiggendo con puntine da disegno e la cuiultima fatica letteraria è una vita di San Pulce,ovvero un parassita in gradodi costruirsi una chiesa nell’ascella di Gesù Cristo; un tale John Raskòlni-kov Gilson, assassino dodicenne di un idiota; Miss McGeeney, impegnatanella biografia di Samuel Perkins, un tizio dall’odorato mostruoso, capacedi «acquisire i principi inerenti ai triangoli isosceli attraverso l’olfatto»;2 lastessa McGeeney, infine, assunte le fattezze di Janey Davenport, non siterrà dallo scrivere un romanzo epistolare alla maniera di Richardson.
3
1 N.West, La vita in sogno di Balso Snell. Un milione tondo, Bari, De Donato, 1973, p. 43.2 Ivi, p. 74.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 25
3 F. Binni, Un’arma lucida e i sogni. Il realismo di Nathanael West, in N.West, La vita insogno di Balso Snell..., cit., p. 28.4 Ivi, p. 29.
26 I saggi
Era stato lo stesso West, in una manchette promozionale per il proprio libro,a riassumere così il significato del testo: «Diventa chiaro a Balso che l’intesti-no del cavallo è abitato unicamente da autori in cerca di un pubblico. Dis-gustato, cerca di uscire ma è trattenuto d’astuzia ad ascoltare altri racconti.Tutti questi racconti sono primi piani elefantini di varie posizioni letterarie edei loro modi tecnici».3 Quello che il primo romanzo di West ci apparecchiaè insomma un viaggio scatologico attraverso i rifiuti escrementizi dell’indu-stria letteraria; Balso è una sonda gettata nelle viscere lutulente della lettera-tura, là dove si produce lo scarto, il superfluo, il non-necessario. Nell’offrircila sua fastidita parata di scorie antopomorfizzate, la satira di West agisce indue direzioni: in primo luogo contro l’eccesso di letteratura, un eccesso chenega l’esperienza, la pura realtà delle cose, avendo l’ambizione di sostituirsiad essa; in secondo luogo contro i seguaci delle mode letterarie, i contraffat-tori che,non potendo vantare la grazia genuina dei modelli, sono costretti adallestirne brutte copie ammuffite in partenza. Non è un caso che tutti i per-sonaggi incontrati da Balso scrivano à la manière de, facciano il verso aqualche corrente o monumento letterario, «frustrati poseurs»4 nella cui affet-tazione priva di eleganza si misura il distacco doloroso dalla vita vera, lo scac-co inflitto dalla mancanza patologica di senso pratico.Scatologia e parodia vanno qui a braccetto: ognuno dei tipi presentati daWest è la caricatura di una moda;meglio,essendo la moda l’artificiata ed este-nuata imitazione di un modello ridotto a merce, quei tipi, dal cultore diDostoevskij al cultore di Joyce, diventano caricatura al secondo grado, cari-catura di una caricatura, rappresentazione ulteriormente degradata, e perconverso parodica al massimo grado,di uno stile già riprodotto con goffa insi-pienza. Joyce,appunto (anzi, la maniera di Joyce), fornisce,col famoso quan-to parossistico monologo di Molly Bloom, la traccia per il sottofinale di BalsoSnell,dove i flussi di coscienza di Balso e di Miss McGeeney convergono nel-l’agognato (da Balso) amplesso, che “libera” definitivamente il protagonistadall’invasione mentale di tutto il ciarpame letterario fin lì incontrato.Ma era stato poi lo stesso Joyce, in una pagina piuttosto nota dell’Ulisse, astabilire una divertita e insieme crudele equazione tra escremento e catti-va letteratura, quando (siamo nel quarto episodio, Calipso – La colazio-ne), Leopold Bloom, avvertendo un lieve sommovimento intestinale, sireca nell’angusto gabinetto esterno della propria abitazione per compier-vi l’atto escretivo,non senza premunirsi di una lettura adeguata, che possaaccompagnare e in qualche modo agevolare l’atto stesso. La lettura vieneindividuata nel «racconto a premio» di un quotidiano. Bloom
lesse tranquillamente, trattenendosi, la prima colonna e, cedendo ma resi-stendo, attaccò la seconda.A mezza strada, la sua ultima resistenza cedendo,
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 26
5 J. Joyce, Ulisse, Milano, Mondadori, 1989, p. 69; ma tutto il passo è citato da C. Spila, Comi-co, parodia, scatologia, in S. Cirillo (a cura di), Il comico nella letteratura italiana.Teorie eproblemi, Roma, Donzelli, 2005, p. 609.6 J. Joyce, Ulisse, cit., p. 70.7 C. Spila, Comico, parodia, scatologia, cit., pp. 610-611.8 L. Lazzarini, Introduzione a Audigier, poema eroicomico antico-francese in edizione cri-tica, Firenze, Sansoni, 1985, p. 30.9 G.Celati,Finzioni occidentali.Fabulazione, comicità e scrittura,Torino,Einaudi,1986,p.61.10 P. Camporesi, Il paese della fame, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 27 e 29-30; ma si vedaanche, come esemplificazione di tale discorso, il fabliau Il peto del villano, in Fabliaux. Rac-conti francesi medievali, a cura di R. Brusegan,Torino, Einaudi, 1980, pp. 154-159.
27Nicola Bonazzi
permise ai suoi intestini di liberarsi comodamente mentre leggeva, leggevaancora pazientemente, quella leggera stitichezza di ieri sparita del tutto.5
Il gesto finale di Bloom («strappò bruscamente metà del racconto e ci sinettò»6) racconta di una disposizione ferocemente critica di Joyce nei con-fronti di quella “paraletteratura”che ha infestato per decenni le pagine deigiornali, buona solo, eventualmente, a garantire una giusta funzionalitàintestinale e a sostituire, dove necessario, la pratica maneggevolezza dellacarta igienica.Nota poi Cristiano Spila, che al brano joyciano, tra vari altri esempi di“escrementalità”moderna, ha dedicato una notevole lettura, come la cifradi questa pagina dell’Ulisse pertenga più al registro grottesco che paro-dico, in quanto «l’eroe joyciano è ormai entrato nella regione in cui le abi-tudini e i bisogni del corpo non sono più un incantesimo;perciò lo vedia-mo aggirarsi con le braghe calate in cerca di uno spazio per defecare, perallegoricamente ricordarci il problema dei problemi: l’evacuazione quo-tidiana e il connesso problema delle scorie. Comburenti e combustioni».7
La quotidianità borghese della defecazione ha tolto insomma ogni aura dieversiva comicità alla medesima, quella grandiosa intenzionalità sovverti-trice entro i cui termini si gioca il riso parodico e carnevalesco di bach-tiniana memoria, a cui ancora pare attingere West nel suo Balso Snell.Naturalmente è a un’altra quotidianità che occorre risalire per andare alleradici di una tale tradizione comica, ovvero quella dell’uomo medievale, ilcui riso partecipa non solo di consapevoli e deliberati procedimenti lette-rari,quanto di una complessiva visione del mondo,dove,accanto al momen-to serio ed ufficiale, esiste sempre anche il suo ribaltamento comico, dimarca spesso oscena.8 La parodia sussiste allora come necessario disinnescoad una ritualità, persino liturgica, dalle movenze singolarmente gravi, quan-do non addirittura cupe. Del resto, la teoria umorale della medicina ippo-cratica, per cui ogni guarigione è un’espulsione,9 o le credenze popolari,che individuavano nella “ventosità” anale la nativitas rusticorum e ne ipo-tizzavano successivamente la morte,quando l’anima veniva peteggiata fuori,testimoniano di una liminarità originaria tra scatologia e riso rituale.10
Ma se, in tali testi, l’elemento per così dire “antropologico”non dovrà esse-re sottovalutato, nemmeno si potrà attribuire ad esso l’intera responsabi-
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 27
11 Audigier..., cit., p. 11.12 Douin de Lavesne, Trubert, a cura di C. Donà, Parma, Pratiche, 1992, vv. 1748-56. Su que-sto, dello stesso Donà, si veda Trubert o la carriera di un furfante: genesi e forme di unantiromanzo medievale, Parma, Pratiche, 1994.13 Audigier..., cit., p. 123.
28 I saggi
lità del rovesciamento parodico, che pertiene invece per buona parte adun gioco tutto letterario e di testa, assodato ormai da tempo che i com-ponimenti comici medievali, anche i più osceni, non appaiono autentica-mente popolari, ma elaborazioni di chierici o giullari dalla penna piutto-sto scaltrita. Così, il più famoso poema eroicomico in antico-francese,l’impudicissimmo Audigier, pare «attingere liberamente all’intero reper-torio di tecniche e topoi epici per sprofondarli in una gigantesca paludestercoraria».11 Qui, più che all’episodio dell’adoubement dell’eroe com-piuto su un letamaio, vero centro attorno al quale ruota tutto il poemetto(e che ritornerà in un altro celebre testo comico medievale, il Trubert diDouin de Lavesne12), converrà guardare all’incontro amoroso tra Turgibuse Rainberge, che prepara il concepimento dell’eroe:
«Venite avanti, – fa lei – o figlio di barone,accoccolatevi qui accanto e facciamo la cacca!Ho mangiato iersera prugne a profusionee ora i nòccioli mi schizzan dal culo,ma non ho portato nulla per nettarmi;voi avete una bella cotta di scarlatto:pulitemici il culo, con la falda,altrimenti non avrete il dono del mio amore».«Signora, – disse il vassallo – lo faremo;per cotanto servigio certo non lo perderemo».Quindi le pulì il culo tutt’intorno;e così si fidanzarono stando coccoloni.13
Il problema che affligge Rainberge è lo stesso che affliggerà secoli dopo Leo-pold Bloom; medesima è pure la soluzione, affidata ad un oggetto chiamatoa raffigurare simbolicamente quell’aspetto della cultura contemporanea chel’autore prende a bersaglio;se nel moderno Bloom è la stessa pagina di gior-nale contenente il racconto a premi a essere scelta, senza mediazioni, perl’operazione di nettaggio (alla quotidianità sciatta dell’episodio può addirsisolo uno sguardo ironicamente denotativo), nell’anonimo medievale è lasopraveste cavalleresca, con tutto il corredo di clichés e stereotipi letterariche essa si porta dietro, a compiere la detersione conclusiva.Non può a questo punto non sovvenire alla memoria la notissima pagina del«nettaculo» nel Gargantua rabelaisiano, dove il protagonista, alla ricerca diun buon materiale per portare a compimento l’operazione di cui sopra,elenca al padre tutti quelli sperimentati, argomentandone qualità e asprez-ze, e concludendo non esservi «nettaculo migliore di un papero ben coper-to di pennematte, a condizione che gli si tenga ben stretta la testa fra le
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 28
14 F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele, recato in lingua italiana da Augusto Frassineti. Con leillustrazioni di Gustave Doré. Introduzione di Giovanni Macchia,Milano,BUR,1984,vol. I,p.85.15 M.Bachtin,L’opera di Rabelais e la cultura popolare,Torino,Einaudi,1979,p.413.Sul con-cetto di “mondo alla rovescia” si vedano (per limitarci solo a qualche titolo): G. Cocchiara, Ilmondo alla rovescia,Torino, Boringhieri, 1963; J. Le Goff, L’immaginario medievale, Roma-Bari, Laterza,1988; Id., Il meraviglioso e il quotidiano nell’occidente medievale,Roma- Bari,Laterza, 1990; G.Angeli, Il mondo rovesciato, Roma, Bulzoni, 1977; P. Burke, Cultura popola-re nell’Europa moderna, Milano, Garzanti, 1980;V. Fortunati, G. P. Zucchini (a cura di), Paesidi Cuccagna e mondi alla rovescia, Firenze,Alinea editrice, 1989.16 Ibidem.17 Rabelais, Gargantua e Pantagruele, cit., pp. 353-365.18 A. F. Doni, La libraria, Milano, Longanesi, 1972, p. 245.19 Ivi, p. 246.20 Anonimo di Utopia (Ortensio Lando), La Sferza de’ scrittori antichi et moderni, a cura diP. Procaccioli, Roma, Beniamino Vignola Editore, 1995, p. 55.21 Ivi, p. 57.
29Nicola Bonazzi
gambe».14 Qui la satira parodica si indirizza, più che su preciso fenomenoletterario, su un’intera cultura (quella definitoria medievale, ma anche quel-la umanistica nelle sue manifestazioni più grossolanamente cavillose) senti-ta ormai come avvizzita e superata. Il comico, qui, «libera le cose dalla serie-tà menzognera, dalle sublimazioni e dalle illusioni suscitate dalla paura»:15
quella paura che la dottrina speciosa (di cui saranno eredi il Manfurio bru-niano ma pure l’Azzeccagarbugli manzoniano) suscita presso gli ingenui egli incolti.Non a caso, la pagina dei «nettaculi» rappresenta uno dei momen-ti di «quel grande inventario del mondo che Rabelais fa alla fine di un’epo-ca vecchia e all’inizio di un’epoca nuova».16 Non meno sintomatico il fattoche nella biblioteca del convento di San Vittore visitata da Pantagruel almomento del suo arrivo a Parigi, accanto ai numerosi titoli che scimmiotta-no la seriosità di titoli ben più gravi e importanti,si trovino per esempio unaArs honeste petandi in societate, un De modo cacandi e una Martingaladei cacatori:17 il basso corporeo liquida definitivamente l’intellettualismoalto e stitico dei «sorbonisti» alla ricerca di qualche credito culturale.Quasi negli stessi anni in cui scriveva Rabelais, anche in Italia (ed esatta-mente a Venezia) alcuni autori sono impegnati a fare i loro conti con unacultura considerata inservibile e con tutto l’ingente materiale librario daessa prodotto: nel 1551 (ovvero nove anni dopo l’edizione lionese dell’o-pera di Rabelais) Anton Francesco Doni scriverà nella propria Librariaun’epistola A coloro che non leggono, definendo quella dei libri, una«maladizione»18 ed evidenziando l’inutilità di mettersi «inanzi tanti librac-ci»;19 mentre altrove Ortensio Lando esorta un amico a cambiare «in tanticoriandoli»20 i grossi volumi della sua libreria o a farne «de’ cartocci spe-ciali» per «involgervi le sardelle, le arenghe et la tonina»:21 l’erudizioneposticcia diventa, nel furor iconoclasta di questi autori, materiale di scar-to buono solo per un gioco da bambini o per proteggere la freschezza diqualche alimento.Contemporaneamente affiora l’idiosincrasia nei confronti di autori e cor-renti passate a moda, come lo speciosissimo petrarchismo tanto in voga
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 29
22 N. Franco, Le pistole vulgari. Ristampa anastatica dell’ed. Gardane, 1542, a cura di F. R. de’Angelis, Bologna,Arnaldo Forni Editore, 1986, c. 62 r.23 N. Franco, Il petrarchista, a cura di R. Bruni, Exeter, University of Exeter, 1979, p. 40.24 Ivi, p.47.25 G. Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado,Torino, Einaudi, 1997, pp. 151-162.
30 I saggi
nel Cinquecento: è il sulfureo Niccolò Franco ad affermare recisamenteche molti poeti non si fanno scrupoli di spacciare «urina per acquarosa»;22 lo stesso Franco allestisce, con il Petrarchista, un pamphlet pole-mico contro la moda arrembante: descrivendo la visita compiuta da dueamici presso l’antica abitazione del poeta a Valchiusa, li mostra intenti adammirare, tra diverse reliquie della famosa Laura, un suo «nettadenti» e«molti fragmenti di un orinale»,23 mentre, alle prese direttamente con glioriginali del Petrarca, li conduce a leggere sotto la cancellatura il verso ini-ziale del sonetto Io ho pregato amore e ne ’l riprego: Io n’ho’ncacatoamore, e gliene incaco.24 Di nuovo la parodia si serve della scatologia perfare piazza pulita di false miti o idola riconosciuti.La letteratura, cioè, nel momento in cui produce un genere, una correntedi successo, o teorizza uno stile che si rivelerà poi dominante, producesempre anche gli anticorpi in grado di disattivare la degenerazione osses-siva di tali fenomeni: essuda i germi della propria malattia, proprio comeaffermano i dettami della teoria ippocratica.Difficile allora credere che l’ambito eroicomico, condannato per statuto avolgere al “basso”tutti i luoghi tipici dell’armamentario epico,25 possa essererimasto immune dalla scatologia parodizzante: la ricognizione riserva, entrola tradizione italiana, la sorpresa di ben due Merdeidi, pronte, già dal titolo, afar lo sconcio verso ai poemi consacrati a qualche impresa o gesta eroiche.Soccorre l’indagine un curioso ed erudito repertorio bibliografico, stampatoa Parigi nel 1850, la ben nota (ai cultori del genere) Bibliotheca scatologica,a sua volta impostata come una parodia di ben più serie e ponderose operebibliografiche, se è vero che il titolo completo recita: Bibliotheca scatologi-ca ou catalogue raisonné des livres traitant des vertus faits et gestes detrès nobles ingénieux MESSIRE LUC (A REBOURS) seigneur de la chaiseet autre lieux; e se è vero, anche, che l’intestazione di luogo e data di stam-pa reca: Scatopolis, chez le marchand d’aniterges, l’année scatogène 5850.Il volume si pone dunque come la più completa ed esaustiva bibliografiadedicata alla scatologia letteraria: non stupisce trovarvi, tra gli altri, i nomidi Plauto, Catullo, Orazio, Marziale, Dante, Rabelais, per tacere di altri.A pagina 24 della nostra Bibliotheca, per arrivare al punto, troviamo cita-ta una Merdeide di Nicolò Bobadillo, pubblicata a Spira nel 1629, e unaMerdeide di tal Abate Penoncelli, pubblicata a Torino nel 1806. L’anonimoestensore della Bibliotheca afferma di non sapere se si tratta di due operedifferenti sotto lo stesso titolo o semplicemente di due edizioni diversedella stessa opera: oggi come oggi, il catalogo ICCU varrebbe a sgannarlosenza indugi. Il primo testo, infatti, appartiene a una silloge che compren-de anche la Murtoleide di Giambattista Marino e la Marineide del rivale
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 30
26 G. B. Marino, La Murtoleide fischiate del caualier Marino con la Marineide risate del Mur-tola, in Spira, Henricus Starckius, 1629. Il Melzi (Dizionario di opere anonime e pseudonimedi scrittori italiani) attribuisce senz’altro il poemetto allo stesso Murtola,sul quale si veda ancheT.Vallauri, Storia della poesia in Piemonte,Torino,Tipografia Chirio e Mina, 1841, II, p. 425.27 Noi abbiamo utilizzato la seconda edizione, stampata a Torino, presso la tipografia Bellardie Appiotti, nel 1874.28 Su questa nozione ovvio il rimando a G. Genette, Soglie: i dintorni del testo,Torino, Einau-di, 1989.
31Nicola Bonazzi
Murtola,26 più qualche altro componimento burlesco; il secondo è operaa sé stante,di mole ben maggiore rispetto all’esiguo poemetto secentesco,su cui vale però dare qualche ragguaglio, perché rappresenta, con le sue27 ottave di elaborata oscenità, un curioso esempio di quello spirito fiera-mente antispagnolo che circolò in Italia nei primi tre decenni del XVIIsecolo, e di cui le Filippiche contro gli Spagnuoli di Alessandro Tassoni(1614) rappresentano il documento più rilevante. Il sottotitolo del com-ponimento, del resto, parla chiaro: «Stanze in lode delli stronzi della RealVilla di Madrid». Senza volerci soffermare sull’esame di una scrittura cheaffonda l’affettazione tutta barocca dello stile nei liquami della volgaritàescrementizia, va tuttavia notato come il registro eroicomico sia modula-to con perizia dal falso Bobadillo (nascondersi dietro un nome spagnolodovette sembrare, allo sconosciuto poeta, una beffa ulteriore verso gliodiati dominatori): dall’obbligatoria invocazione alle Muse, alla ricorrenzadi nomi del repertorio classicheggiante (si susseguono, nel testo, «Arpie»,«Bellona», «Marte», «Xerse», «Aurora», «Antheo», «Protheo», e così via) finoall’allocuzione conclusiva in cui l’autore invita la Casa Reale a mutare iltoponimo della capitale (da Madrid a Merdid...), tutto contribuisce a defi-nire la fisionomia di un autore per nulla trascurato, in grado di passarecon elegante noncuranza dai toni epici a quelli satirici e turpi, capace didominare, in definitiva, un’ampia tastiera di registri letterari; ciò che nonsembra riuscire, invece, al famigerato abate Penoncelli della seconda Mer-deide, un testo come si diceva molto più vasto (tre cantiche per ben 407ottave complessive), ma insieme più sciatto e gratuito. Proprio la suaabnorme sconcezza, tuttavia, la sua esaustività escrementizia, suscitano nellettore avventuroso qualche curiosità che merita di essere soddisfatta.Anche in questo caso la parodia scatologica assale per prima cosa l’intesta-zione,dal momento che si dichiara l’opera essere stampata «In Cancherano,dalle stampe di Bernardo Culati, presso Fabriano Medardo Stronzino, Libre-ria all’insegna del Mappamondo»: la creatività onomastica,a contatto col les-sico della scatologia, sembra trovare esca adatta al proprio estro.27 Ma è poitutto quello che oggi si definisce il paratesto28 a essere investito di una irre-frenabile foga parodica: prima dell’inizio del canto vero e proprio, nonchéalla fine del terzo e ultimo, stanno una serie di sonetti proemiali, di epitaffi,di «favolette» e «novellette» in senari che,anticipando e continuando il giocoosceno del testo, sembrano complessivamente fare il verso a tutto quell’ap-parato di componimenti augurali e introduttivi che sempre accompagnava
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 31
29 F. Rico, Le armi di don Chisciotte, in Mappe della letteratura europea e mediterranea, I.Dalle origini al Don Chisciotte, a cura di G. M.Anselmi, introduzione di Antonio Prete, Mila-no, Bruno Mondadori, p. 356.30 Su questo testo si veda il classico V.Cian,La satira (dall’Ariosto al Chiabrera),Milano,Val-lardi, 1939, pp. 117-122.31 Il quale, come si evince da alcune occorrenze presenti nel testo, doveva essere originariodi S. Giorgio Canavese in Piemonte.32 Dalle ottave riguardanti il Baretti parrebbe essere questi ancora in vita al momento dellastesura del poemetto, la cui data di composizione sarebbe dunque anteriore al 1789, essen-do questo l’anno di morte dell’autore della Frusta.
32 I saggi
la stampa di un poema,e verso il quale già Cervantes,per fare l’esempio piùillustre (chissà quanto presente all’autore della Merdeide...), si era mostratomolto critico nel Prologo al primo libro del Chisciotte.29 D’altro canto, giàle prima ottava dichiara la materia e il registro dell’opera,se è vero che i dueversi iniziali («Alla carlona, in stil bernesco io bramo/Di cantare,non donne,non eroi...») rimandano, prima, a due campioni della poesia satirica e burle-sca (scontato il riferimento a Berni,meno ovvio,ma ugualmente pertinente,quello alle Satire alla carlona del senese Pietro Nelli30); e poi all’incipit delFurioso, tanto famoso da diventare emblematico e per questo, più di altri,da citare e scardinare. I riferimenti letterari in funzione parodica si susse-guono nel testo: il nostro autore31 è abbastanza smaliziato da sapere di poterassegnare alla rima baciata che chiude l’ottava il compito di rovesciare versoil “basso” l’“alto”della citazione, con valore dunque di sorpresa e di inaspet-tata destabilizzazione del codice epico. È quello che accade per esempionella sesta ottava del primo canto,dove i rimandi petrarcheschi e danteschidei versi iniziali («Voi che ascoltate il vario mormorio/Di questi miei tumul-tuanti fiumi/D’accenti, che fanno aspro il suono e rio...») vengono violente-mente aggrediti dalla chiusa d’ottava («Perciò non mi volgete i biechilumi/Dicendo,o dir volendo che sia cosa/Il cantar della Merda vergognosa»);ma sono svariati i riferimenti colti di cui il nostro presumibilmente falsoabate costella il poema: si citano Franco Sacchetti (canto I,ott. 19); in un solcolpo Ariosto, Berni, Pulci,Tassoni,Tasso (canto II, ott. 6, senza distinguereperaltro tra autori praticanti il codice epico-cavalleresco e quelli praticantil’eroicomico); il Della Casa, come autore,ovviamente,del Galateo (canto II,ott.108); il Baretti (canto II,ott.110-11332); si prelevano versi famosi,decon-testualizzandoli entro un ambito osceno (canto III, ott. 24, v. 1: «E va gridan-do: Pace, pace, pace»; ivi, ott. 41, v. 2: «Voci alte e fioche, e suon di man conelle»; ivi, ott. 107, v. 8: «Che quanto all’uomo piace è breve sogno»). È chiaroche la parodia di questa seconda Merdeide sta tutta dentro un carnevalescoconsapevole e insistito: il primo canto, del resto, narra l’avventura di duemedici (anzi «fisici dottor», canto I, ott. 9), Cecco e Malaguisa, alle prese conun tal Sterculio Merione (nomen omen, e ci mancherebbe), mago e scien-ziato della Media, che li inizia ai segreti medicamentosi degli escrementi; idue tornano in patria e di loro il poeta altro non può dire se non che «s’am-malâro» e, proprio come nelle leggende medievali sul villano (il cui rilancioappare qui troppo adeguato per essere casuale), «o tosto o tardi l’anima
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 32
33 Sul concetto di Stimmung si veda naturalmente L. Spitzer, L’armonia del mondo. Storiasemantica di un’idea, Bologna, Il Mulino, 2006.
33Nicola Bonazzi
cacâro» (p. 49, ott. 126); il secondo canto si dilunga nell’enumerazione edescrizione dei diversi tipi e qualità della materia in questione, che, solita-mente rimossa dalla sfera linguistica e socio-comunicativa, scatena qui unfuoco d’artificio lessicale ed etimologico che investe ogni categoria delreale (si va dalla sedia «Stercoraria» dei pontefici alle deformazioni operatecon divertita impudenza su nomi come Medoro, Medea e Merdocheo), perpoi ripiegare su due oscenissime novellette antifratesche; il terzo canto siapre su una processione di ignoti personaggi (ma si tratta probabilmente dinomi a chiave, legati forse all’ambiente letterario da cui proviene il poeta)verso il paese di Cuccagna, dove tuttavia non arrivano per una sciocca con-tesa nata tra loro: contesa che degenera presto in una battaglia combattutaa colpi di sterco, cui pone fine un tal Ombergio chimico parigino, del qualeil buon gusto impone qui di tacere l’attività principale; una preghiera dibenevolenza al lettore, al quale il poeta brinderà in «osteria» con un «fiasco»di vino, chiude il poemetto.Questi sommari accenni alla tenuissima trama, ma ancor più le ripetuteparodizzazioni dei linguaggi specialistici presenti nel testo, in particolarequello medico e quello filologico-umanistico, testimoniano che l’ambito dipertinenza del poemetto è appunto il carnevalesco più spinto. Piacerebbedire che ci troviamo di fronte, per l’insistenza per nulla eufumistica con cuiè posto in atto il rovesciamento,ad una sorta di Audigier della tradizione ita-liana; naturalmente non è così: la presa in giro praticata dalla Merdeide pie-montese non si esercita, come là, su nessun codice letterario particolare, senon, in maniera del tutto meccanica, su quello epico; ma ciò è inevitabileladdove si voglia istruire una sorta di “epopea della merda”; e comunque laparodia appare frutto troppo fuori stagione (s’intende rispetto al grandemomento quattro-cinquecentesco dell’epica) per essere presa sul serio enon solamente, come alla fin fine si rivela, per uno scherzo goliardico purcondotto con perizia di mezzi; infine, la Merdeide del sedicente Penoncellinemmeno presenta, come la Merdeide antispagnola, i caratteri dell’urgenzasatirica.Tuttavia anche questo prodotto di singolare indecenza può e deveattrarre la nostra attenzione: relegato per almeno un paio di secoli negliEnfers delle biblioteche,merita,come un reperto salvatosi dai continui nau-fragi della nostra storia letteraria,di ritrovare uno spiraglio di luce che possarilevarne il valore di documento, forse estremo,di quella incessante volontàdi canzonatura che gli abitatori delle stanze “basse”rivolgono sempre ai fre-quentatori dei piani nobili del grande palazzo delle lettere: quelli, in specialmodo, che vi si ritrovano senza averne i titoli, scimmie di ben altri poeti,genuini e veraci. È la beffa che insensibilmente introduce una crepa nell’ar-monia del mondo, l’originaria Stimmung;33 che ci ricorda che, accanto allevicende di personaggi all’apparenza intangibili quali sovrani o eroi, o allevicende comunque straordinarie, ai drammi e alle passioni di cui i grandi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 33
scrittori intessono le loro narrazioni; accanto a tutto questo sta, irriducibile,il corpo, nell’urgenza di ben altri drammi, fisiologici e “sporchi”; nella lutu-lenza delle sue scorie e dei suoi rifiuti: prezzo da pagare per riacquistare al“corpo”della letteratura la sua integra sanità morale.Ecco,di questa crassa presa di coscienza,di questo rovesciamento osceno, laMerdeide ottocentesca rappresenta forse l’ultimo sussulto: dopo, soprattut-to nel Novecento, anche la merda è diventata faccenda alta, materia simbo-lica,oggetto di speculazioni perfino filosofiche:ma il Novecento, si sa,non èpiù secoli di eroi, e a tutti ha tolto, almeno un poco, la voglia di ridere.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6bonazzi.htm.
34 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 34
Lo spirito della novellaGianni Celati
1. Novelle come merci pregiate
Le antiche raccolte di novelle, dal Novellino duecentesco al Decamerone,alle raccolte quattrocentesche e cinquecentesche, fino a quel punto disvolta che è il Cunto de li cunti di Basile, sono dei bazar di roba messainsieme, con un fasto rituale ancora visibile, benché lontano dalle nostreabitudini. Il Decamerone somiglia a quei vecchi suk arabi dove trovaviprofumi, gioielli, spezie, stoffe che venivano da tutte le parti, e ogni merceportava con sé il ricordo delle linee di circolazione dei commerci nel nordAfrica. Le raccolte novellistiche erano collezioni di aneddoti, favole, leg-gende, motti arguti, d’origine scritta e orale. La varietà di questi zibaldonidipendeva da una vasta circolazione di motivi narrabili, legata alle rotte deipellegrini e dei mercanti. Per questi tramiti debbono essere giunti moltiesempi di narrativa araba, indiana, provenzale e francese, che hanno tra-sformato i modi dei racconti nostrani. Le prime due novelle del Decame-rone parlano di mercanti fiorentini a Parigi, un buon terzo delle altre sonoambientate in luoghi d’Europa e del Mediterraneo,come vicende o emble-mi o fantasie di terre lontane. In tutte si vede l’afflusso di materiali etero-genei, passati da una tradizione all’altra. Ed è ciò che rendeva le raccoltenovellistiche degli empori di mercanzie pregiate, dove ogni storia ha lanatura del frammento disperso, come le reliquie dei santi o i gioielli por-tati in Europa dagli antichi viaggiatori. È una narrativa di motivi intreccia-ti,dove ognuno vale in sé come memoria di accadimenti nel vasto mondo;e parla d’un mondo ancora inteso come un tessuto di meraviglie, allamaniera di Marco Polo e dei viaggiatori arabi.
2. Le novelline. Accumulo di pezzi sparsi
Quel libro di novellette che ora chiamiamo il Novellino, composto tra il1280 e il 1300, resta l’esempio d’una narrativa fatta con l’accumulo dipezzi di riporto, sparsi ed eterogenei, collegati da nessun motivo oltre algusto del narrare. Si è pensato a un compilatore che disponesse d’unavasta biblioteca nel nord Italia, forse nella Marca Trevigiana, perché ilNovellino si distingue per la grande quantità di spunti presi direttamentedai libri. Benché il suo titolo originale (Libro di novelle et di bel parlargientile) si inquadri in una tradizione già viva di raccolte novellistiche,questo libro resta un unicum nel campo delle forme narrative. Perché è
35Gianni Celati
4
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 35
come un esperimento per ridurre il fenomeno chiamato “raccontare sto-rie”al suo nucleo minimo.Che cos’è una storia? È un collegamento tra fattiantecedenti e conseguenti. Per gli antichi era una specie di effetto ottico,definito post hoc propter hoc, per cui ciò che viene prima in un raccontoci dà l’impressione d’essere la causa di ciò che viene dopo, anche se nonsi tratta d’una conseguenza logica.Tutto il narrare è un gioco di effetti illu-sori. Ma come si produce l’effetto che una storia debba concludersi inpunto preciso? L’interruzione non è una conclusione. La conclusione giu-stifica il racconto, perché è il momento in cui l’ascoltatore vede o crededi vedere il significato o la morale della storia. Nei ritagli nel Novellino ilmodo usuale è quello di concludere la novella con un motto o con unarisposta arguta che risolve un contrasto.Anche dove si tratta di ritagli daromanzi noti, come nella novellina LXV, che riassume un episodio delRoman de Tristan di Béroul, la conclusione cade dove si ricompone unconflitto – e in questo caso si tratta del conflitto tra Tristano e re Marco,ricomposto grazie ad un «savio avedimento» (sotterfugio). La nota finalesul «savio avedimento», che è l’inganno della regina Isotta per nascondereal marito il proprio adulterio con Tristano, funge da morale e da insegna-mento. In questo senso produce l’effetto illusorio d’una conclusione.
3. Miniaturizzazione e fasto rituale
Il carattere esemplare del Novellino sta in una fine arte del racconto scrit-to: arte del ritaglio e della miniaturizzazione di episodi già narrati nei libri.Questi sono spunti che (come dice il prologo) il lettore di «cuore nobile eintelligenzia sottile» può usare per farne a sua volta dei racconti offerti achi desidera istruirsi. Il fasto rituale delle novellette sta in questo “sapere”racchiuso nell’involucro del “bel parlare”,come un monile o un anello cheracchiuda un motto sapienziale.La miniaturizzazione dei racconti consistenella loro brevità, che racchiude i «fiori del parlare», le «belle risposte» e le«cortesie» vantate nel prologo. Ecco il senso della riduzione d’ogni fram-mento libresco a un nucleo minimo di parole, quelle strettamente neces-sarie per creare l’effetto del racconto concluso. In alcuni casi basta addi-rittura una frase a far tutto, come a esempio nella novella XVII: «Pietrotavoliere [mercante], fu grande uomo d’avere [fu uomo molto ricco], evenne tanto misericordioso [e divenne così caritatevole] che ’mprimatutto l’avere dispese a’ poveri di Dio [che dapprima diede tutte le sue ric-chezze ai poveri], e poi, quando tutto ebbe dato, et elli si fece vendere[dopo aver tutto dato, si mise in vendita come schiavo], e ’l prezzo diedeai poveri tutto [e diede il ricavato ai poveri]». La consecuzione dei fatti quiculmina in ciò che noi chiameremmo un colmo, il “più di così non si può”,ossia un comportamento impensato o impensabile – il mercante chevende perfino se stesso per dare il guadagno ai poveri. Il che fa l’effettod’una conclusione, perché è come se il pensiero non potesse procedere
36 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 36
oltre e dovesse fermarsi a riflettere. Questo è un modo di usare e incana-lare sparsi pezzi di racconto, mescolando motivi che vengono da fontidiverse, come succederà spesso nelle future novelle.Altrove può trattarsid’un paradosso, d’una burla, d’un inganno; ma l’arte novellistica dell’effet-to conclusivo tocca sempre qualcosa che dà l’idea dell’eccesso,del colmo,dell’imparagonabile, e che ci lascia sospesi in uno stato di stupore o dimeraviglia.
4. Un genere ibrido e anomalo
Quando andavo a scuola io, tutta la novellistica italiana si riassumeva nelDecamerone; ma il Decamerone non era studiato come l’esempio d’ungenere narrativo, bensì solo come l’opera di Boccaccio. L’abitudine di stu-diare i testi letterari solo in quanto opere di autori illustri ha oscurato persecoli la tradizione della novella. Soltanto nell’ultimo secolo sono diventa-te facilmente accessibili le raccolte di Sacchetti, Masuccio, Sermini, Ser-cambi, Fortini, Straparola Grazzini e altri. Con questo allargamento d’oriz-zonte si è cominciato a vedere come i narratori abbiano abbandonato loschematismo dei vecchi racconti morali, dando più peso ai dettagli, allefigure dei personaggi, alle tonalità della lingua secondo i tipi di racconto.Si intuisce anche l’esistenza d’un diffuso collezionismo dei motivi narra-bili, legato all’abitudine di scambiarsi aneddoti e storie: usanza innestatasulle pratiche della conversazione quotidiana, che diventano la compo-nente centrale di questo nuovo sistema narrativo. Sulla scia del Decame-rone e del Trecentonovelle di Sacchetti, la novella fiorisce come genereprevalentemente toscano, ma anche ibrido e anomalo. Infatti è una narra-tiva dove non c’è una netta separazione tra tragico e comico, tra tono mag-giore e tono minore, tra gioco immaginativo e verosimiglianza. Una novel-la poteva essere fiaba, leggenda, burla, motto celebre, cronaca cittadina,tragedia storica, avventura in terre lontane, oppure l’esempio morale nelleprediche di San Bernardino o le facezie del Piovano Arlotto. Rispetto aigeneri letterari affermati, si può dire che fino al Cinquecento la novellanon rappresenti un vero genere letterario (nonostante la grande famagoduta da Boccaccio), ma il semplice riaffiorare d’una usanza cittadina oborghigiana: lo scambio di storie, favole, facezie giunte all’orecchio, tratte-nimento spicciolo, chiacchiera conviviale ma anche recita da strada, comeesisteva per le strade di Roma ai tempi di Plinio, e come esiste ancora invari angoli del mondo.Tutto questo ha reso la novella un genere un po’equivoco, poco riconoscibile, soprattutto fuori dalla Toscana. Ed è interes-sante che, nella sua Piazza universale di tutte le professioni del mondo(1585),Tomaso Garzoni accenni solo di sfuggita al mestiere del novellieri,nel Discorso L, e li identifichi con gli inventori di burle («burlieri»), dun-que mettendo Boccaccio in compagnia dei buffoni di corte. Poi nel famo-so Discorso CIV, dedicato ai ciarlatani di piazza, Garzoni non nasconde la
37Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 37
sua schietta opinione su cosa fosse il novellare: un puro imbroglio e abba-glio delle parole. «Qui si tesse la favola… Il plebeo s’arriccia, il villanostremisce alla novella che vien raccontata...».
5. Circolazione fuori dai libri
In realtà la novella non s’è mai staccata del tutto dallo sfondo in cui Gar-zoni la colloca, vuoi come burla depositata nelle carte, fola o diceria dapubblica piazza, intrattenimento di corte, o recita in raduni convivialicome quelli evocati in molte raccolte novellistiche. Rispetto ai generi dimaggior prestigio, come il poema epico, la lirica e l’oratoria, la novella sidistingue per quest’altro tipo di circolazione, non chiuso negli spazi dellapagina scritta. Si sa di novelle di Sacchetti raccontate fino a pochi anni fanelle campagne toscane. Una rara scena in ambito popolare è descritta inuna lettera di Andrea Calmo, commediografo, poeta e attore veneziano,morto nel 1571.Parla dell’ascolto di novelle in una taverna veneta, attornoa narratori con repertori di storie in voga, i quali raccontano: «le più stu-pende panzane, stampie e immaginative [le più stupende panzane, stram-berie e invenzioni] del mondo,de comare oca,del fraibolan [del pifferaio],del osel bel verde [dell’uccellin bel verde], de statua de legno [della statuadi legno], de bossolo de le fade [del bossolo delle fate], d’i porceleti [deiporcellini], de l’asino che adete romito [dell’asino che si fece romito], delsorze che andete in pelegrinazo [del sorcio ch’andò in pellegrinaggio],dellovo che se fiese miedigo [del lupo che si fece medico], e tante fanfalugheche non bisogna dir [e tante fanfaluche che non è il caso di dire]» (Lette-re, libro IV, 42). Si riconoscono in questo repertorio varie storie che gire-ranno in tutta Europa, cominciando da quella di Comare l’Oca, che darà iltitolo alla raccolta favolistica di Perrault, Les Contes de Ma Mère l’Oye(1687). Simili usanze di racconti in comitiva accompagnano tutta la tradi-zione della novella, negli intrattenimenti campestri, di stalla o di cortile,con repertori di fiabe, storie di meraviglie e aneddoti buffi: in Rome,Naples et Florence, nel 1826, Stendhal registra simili narrazioni in ambitopopolare; e dice che arrivando una sera a Calstelfiorentino, ha trovato una«compagnia di braccianti [che] improvvisavano, ognuno al suo turno, rac-conti in prosa d’un genere come quello delle mille e una notte». E aggiun-ge: «Ho passato una serata deliziosa, dalle sette a mezzanotte, ascoltandoquei racconti [dove] il meraviglioso più stravagante crea avventure cheportano a sviluppare le passioni più vere e più impreviste». Ancora miamadre da bambina ascoltava fiabe e novelle su streghe e banditi, nelleriunioni di stalla in una sperduta località sulle foci del Po.Tutto questo cirimanda ad abitudini che arrivano quasi fino a noi, come pratiche di con-versazione e di intrattenimento, fuori dalla testualità fissa dei libri.
38 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 38
6. Giochi di variazioni
Il carattere misto dei materiali novellistici, senza limiti precisi tra la formascritta e orale, è stata la grande spinta vitale della novella; perché attraver-so i motivi narrabili che passavano da un narratore all’altro senza nessunasorveglianza nascevano variazioni imprevedibili.Un motivo novellistico trai più diffusi è quello della donna malmaritata con marito stupido e geloso,la quale risolve la situazione accoppiandosi con un amante simpatico.Que-sto tema trova una notevole variante in una novella di Sermini, dove ladonna per sottrarsi al marito beve una pozione che la fa sembrare morta(Novelle, 1). Qualche decennio più tardi ritroviamo il motivo della pozionein una novella di Masuccio, ma applicata a un altro tema diffuso, quello deidue innamorati ostacolati dalle famiglie (Novellino, 33).Nel secolo seguen-te il racconto è rielaborato da Luigi Da Porto, nella lunga novella di Giu-lietta e Romeo (Storia di due nobili amanti): novella poi ripresa da Ban-dello (Novelle, II, 9), per finire attraverso altri passaggi nella mani di Shake-speare. L’esempio mostra come un motivo narrabile si ri-orienti di conti-nuo, perché il fatto stesso di circolare lo traduce in una serie di variazionidi cui non conosciamo i margini precisi – infatti niente ci assicura che nonci fossero versioni orali con orientamenti ancora diversi, rispetto a quellinoti.Tutto questo è lontano dal nostro modo di pensare, perché per noiogni racconto corrisponde necessariamente ad un testo unico, chiusoentro i limiti dello spazio scritto.La novella invece si dichiara sempre comeracconto d’un racconto, udito dal narratore che lo ripete per noi. Questa èla differenza della novella rispetto ai racconti moderni: nella novella nonesiste l’idea del racconto originale, il racconto d’autore come lo intendia-mo ora, bensì quella d’una ripetizione con continue varianti. Ed è come inmusica: un motivo implica sempre certe variazioni secondo lo stile di chilo esegue.Viceversa, i racconti moderni sono concepiti come parte di unatestualità fissa, in cui parrebbe che la lingua si fosse già tutta oggettivata epurificata nella scrittura. Il risultato è un narrare chiuso, come immunizza-to e sottratto all’incontrollabile circolazione delle parole.
7. La compagnia d’ascolto
Sulla scia del Decamerone e del Trecentonovelle, scrivere novelle è diven-tato un passatempo privato, borghese, con tratti già stereotipati, sintassimodesta, ancoraggio nel sentito dire locale. Ma anche in queste novelle simantiene il senso e la forma del racconto orale, dove chi narra si rivolgeagli ascoltatori per mettere in comune la storia che racconterà, come inuna presupposta convergenza di gusti. Cito un attacco di Sermini: «...per-ché non passi senza alcuna memoria, una piacevole novelletta alle mieorecchie venuta, mi piace narrarvi» (Novelle, 1). È questo che distingue lanovella dal racconto storico: non una testimonianza sui fatti narrati, quan-
39Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 39
to una compagnia d’ascolto che testimonia (“in effige”, per così dire) unacomunanza di gusti e di abitudini. Ecco un attacco di Sercambi: «Piacevo-li donne, e voi altri, venerabili persone, a me occorse in nella mente unanovella la quale a vostro contentamento dirò» (Novelle, 8). La compagniadi ascolto è parte stabile della cornice del Decamerone, dove un gruppodi giovanotti e donzelle si scambiano racconti. Anzi, si può dire che lanovella nella sua forma più tipica sia precisamente questo: la messa inscena d’uno scambio di racconti, con un appello agli ascoltatori, comerichiamo all’essenza dialogica del novellare: «Piacevoli donne e voi grazio-si gioveni, fu,non è ancor molto, in una nostra villa non guari lontana dallacittà...» (Fortini, Notti, I). E questa diventa una specie di segnatura chemarca la tradizione più tipica della novella, basata su dialoghi, pratiche diconversazione e scambi da narratore a narratore.
8. Novelle e pratiche di conversazione
Nell’anonimo Novellino duecentesco si legge che il libro tratta di «fiori delparlare, di belle cortesie e belle risposte». La novella nasce come sviluppodi cerimonie cortesi ed è largamente modellata sui modi del dialogo neitesti medievali. Boccaccio ha elaborato quei cerimoniali con la cornice incui sono incassati i racconti: ossia la storia di sette donzelle e tre giovanifiorentini che vanno in campagna per sfuggire alla peste e si raccontanonovelle a turno per dieci giorni. Quella è la compagnia d’ascolto, da cui sisviluppano dialoghi e commenti alle storie narrate; e che ci dà il sensod’entrare in un luogo di amichevoli conversarî, dove il dialogo cortese simescola alla conversazione urbana, arguta, libera da censure dogmatiche.L’innovazione di Boccaccio sta nell’usare gli schemi di conversazione peramalgamare materiali narrativi eterogenei sul filo del discorso. E comeavviene nelle conversazioni, anche qui ognuno ha un turno di parola perraccontare una storia; poi ogni storia fa venire in mente qualcosa di simi-le a un altro narratore e si creano catene di storie su temi simili.Dopo Boc-caccio, è Masuccio Salernitano che porta l’impianto conversativo dellenovelle alla forma più stilizzata. Il suo Novellino distingue le fasi del turnodi parola, dividendole in un esordio sotto forma di presentazione oratoriadella novella per definirne il tema o lo scopo morale, in una narrazione einfine in un commento conclusivo dell’autore. È un modo per presentaregli schemi di conversazione come un cerimoniale, con cui la merce pre-giata dei racconti trova un fasto che li esalta, portandoli all’altezza deiromanzi cortesi, con racconti che sembrano imitare le illustrazioni minia-te di quei libri. E già nel prologo, detto Parlamento de lo autore al librosuo, l’immagine del libro di novelle come una nave incantata ricorda la nefde joie e de deport dei romanzi arturiani, scena d’una conversazione favo-losa su temi d’amore e di svago.
40 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 40
9. Shahrazad
Nelle novelle di Sacchetti non esiste la messinscena della compagnia dinarratori-ascoltatori, né la presentazione oratoria delle novelle per annun-ciare il loro tema. Il Trececentonovelle si regge sui modi elementari dellaricreazione comica, che servono a far svaporare le disgrazie individualinelle risate collettive. L’istinto narrativo di Sacchetti segue modi mimiciritmi a scansioni rapide, orecchiati sul dialogo familiare, sul litigio comico,dove tutto torna sempre al grembo comunitario, alle chiacchiere del sen-tito dire locale. La festa qui è soltanto sospensione del lavoro, momento diriposo ascoltando racconti. L’elaborata messinscena di Boccaccio ha giàperso contatto con questi modi semplici di ricreazione, e per quanto ilDecamerone preceda il Trecentonovelle di circa 30 anni, sembra giàproiettato in un’altra era. È la differenza tra il narratore paesano e unnuovo narratore che si richiama all’esperienza allargata dei viaggi e deicommerci e dei racconti venuti da lontano. In generale si sa poco di comesiano giunti in Europa molti esempi di novellistica orientale, dai tempidelle crociate e poi per vari secoli, presumibilmente per via orale e attra-verso viaggiatori veneziani (Francesco Gabrieli, Dal mondo dell’Islam,1954). Comunque, la cornice del Decamerone, con la compagnia di nar-ratori che si scambiano storie,deriva da un imprestito venuto dall’oriente:ed è un modulo della novellistica arabo-persiana che sarà conosciuto inEuropa solo quattro secoli dopo,con la prima traduzione delle Mille e unanotte, realizzata da Antoine Galland. Nelle Mille e una notte lo scambio distorie avviene tra Shahrazad, sua sorella Dinarzade e il sultano Schahriar.Ogni notte Dinarzade sveglia Shahrazad invitandola a raccontare storiefino all’alba; e Scherazade racconta storie che destano la curiosità nel sul-tano, in modo da poter riprenderle la notte successiva, e poi di notte innotte – così sfuggendo alla morte che la aspetta secondo il decreto diSchahriar. Se Shahrazad narrando inganna il sultano e sospende la propriacondanna, i narratori di Boccaccio ingannano il tempo in epoca di peste,e sospendono l’incombenza della morte. Nei due casi c’è uno schemacomune, dove i racconti si propongono come una sospensione dell’in-combenza del tempo che ci porta verso la morte o le disgrazie della vita;e così i racconti prendono il senso d’un incantamento in cui gli uominidimenticano tutto il resto. Nella storia di Shahrazad ogni racconto è uninganno; nessuno è al servizio d’una verità: tutti servono solo per sospen-dere il tempo di vita, di novella in novella, di giorno in giorno.
10. Sul tempo sospeso del narrare
Le novelle iniziavano sempre con tempi indefiniti come l’imperfetto, che èuna temporalità di scorcio, nel vago della lontananza: «Fu già in Siena unodipintore, che avea nome Mino, il quale avea una sua donna assai vana...»
41Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 41
(Sacchetti, Trecentonovelle, 84). È la forma più antica di racconto, ed è iltipico attacco delle fiabe:“C’era una volta...”. L’imperfetto sospende tuttonell’atto del dire, del narrare, ed è questo che produce un alone immagi-nativo nelle parole; una specie di in illo tempore come quello dei raccon-ti mitici. Le novelle passano ai tempi puntuali quando si tratta d’un fattoche rompe un tran tran consueto:“Avvenne un giorno che...”. Ma anche levicende intermedie hanno una temporalità di scorcio, finché si arriva alpunto memorabile della storia. Questo è sempre presentato con un tempopuntuale, il passato remoto, passato assoluto che accentua la tensione delracconto.Andreuccio da Perugia, ingannato dalla Siciliana, caduto nella dis-carica di escrementi, si ritrova di notte nel vicolo e «cominciò a batter l’u-scio e gridare; e tanto fece così che molti circostanti vicini desti, si levaro-no» (Dec. II, 5). Con questo tempo verbale il racconto diventa più teso; maè una scena dove niente è spiegato, niente descritto; l’azione in corso èappena accennata; e qui “immaginare” vuol dire più che altro riconoscereun movimento di ombre verso cui la nostra attenzione è attratta, e con cuisi produce una sospensione più netta del tempo vissuto – dove il telefononon suona più per noi, e rumori del traffico nella strada accanto non arri-vano più al nostro orecchio. Altro esempio: la scena dove Nastagio degliOnesti vede sopraggiungere la donna ignuda attaccata dai cani e dal cava-liere nero nella pineta di Ravenna (Dec. V, 8): quella pineta è un “là” ipote-tico che ci costringe a uno sforzo immaginativo per figurarci l’improvvisoconfluire dell’aldilà e della vita terrena in un’unica scena. Non c’è nessunadescrizione d’ambiente; c’è solo lo slancio del dire, del narrare, che creauna sospensione dove balenano fantasmi imprecisati, ma sufficienti perprodurre quell’altra sospensione che consiste nel dimenticare se stessi.
11. Cerimoniali introduttivi e loro inversione moderna
I racconti che mirano alla sospensione del tempo hanno bisogno di ceri-monie d’avvio, con l’anda d’un bel parlare che crea l’effetto d’un tempoindefinito – non il tempo dei fatti, ma quello del dire e del narrare. Nellanovella di tipo boccaccesco, era questa la funzione dell’esordio, semprestilisticamente elevato, che creava l’atmosfera del racconto: «Ornatedonne e amorosi giovani, io voglio, [in] scambio di ridere, farvi con la miafavola meravigliare» (Grazzini, Cene, 9). L’esordio serviva a mettere l’ascol-tatore al corrente del tenore della novella narrata, colmando le distanze –come quando s’invita qualcuno a casa propria e la cerimonia dell’accogli-mento abolisce l’estraneità. Le narrative moderne aboliscono i cerimonia-li e fanno un lavoro inverso:partono da un’estraneità del lettore,che dovràscoprire da solo di cosa si parla e cosa succede, come se si ritrovasse dicolpo in un paese sconosciuto. Ad esempio il Mastro-don Gesualdo diVerga (1889), tra i più grandi romanzi europei del suo secolo, cominciacon il fuoco nella notte in casa Trao: le urla, il subbuglio, i vicini che accor-
42 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 42
rono, i salvataggi. Ma noi non sappiamo chi siano questi Trao, non sappia-mo niente dell’ambiente e della storia. È vero che poi tutto sarà chiarito,gli antecedenti saranno dipanati;ma davanti a quell’inizio il lettore si trovacome se piombasse in uno stato d’emergenza. Non viene guidato cerimo-nialmente nel racconto, ma catapultato nei fatti. L’inizio di Mastro-donGesualdo è uno straordinario esempio di narrativa moderna che porta insé qualcosa vicino a una sintomatologia d’origine: quella dell’estraneitàdell’individuo moderno rispetto al proprio ambiente. In ciò si vede ilsegno della vita urbana, degli individui che si sfiorano per strada in mutualontananza, ognuno chiuso nel proprio guscio. La situazione in cui piom-ba il lettore con il fuoco in casa Trao dà subito l’idea d’una dimensione divita dove tutti diventeranno estranei rispetto a tutti gli altri. Premonizioneformidabile sui tempi a venire, fino all’immagine di don Gesualdo solonella sua stanza, malato, isolato, che ascolta da lontano le voci del mondo.
12. Il sapore dei fatti oggettivi
Nella narrativa che sorge alla fine del XIX secolo, i romanzi e raccontidebbono impostare la narrazione su valori di verità relativi alla vita cor-rente; e non può più esserci la sospensione nel tempo indefinito del nar-rare come nelle forme narrative antiche (“C’era una volta”, “Narrasi”).Caratteristico delle nuove forme è l’uso del linguaggio come serie di dida-scalie sceniche (“Egli disse”,“Essa si voltò e rispose”,“Giovanni ebbe unsussulto e si destò”),dove i fatti non sono più lasciati nella vaghezza imma-ginativa, ma affidati a una descrizione puntuale, nella distanza del vedere.Cito l’inizio d’un romanzo di Maupassant, Bel Ami (1885): «Quando la cas-siera gli ebbe dato il resto della moneta da cento soldi,Georges Duroy uscìdal ristorante».Tutto è posto subito nella distanza del vedere, come indi-cazione dell’oggettività impersonale dei fatti. I fatti si svolgono su unpiano di fondo senza contatto con chi legge; senza il “qui” immaginosodove in un romanzo di Balzac o Stendhal il narratore confidava al lettore isuoi commenti, a mo’ di divagazione. Ora non ci sono più commenti nédivagazioni. Subito tutto assume il sapore di estraneità dei fatti “oggettivi”.Ciò dipende molto dall’uso sistematico del passato remoto, che essendoun tempo puntuale presenta i fatti come avvenuti in un luogo e in unmomento precisi; dunque fa sì che tutte le frasi diventino asserzioni asso-lute. Ed è come quando Cartesio dice che posso concepire l’idea di trian-golo senza il contributo dei sensi. Sì, io intuisco l’idea di triangolo perchélui mi dice come è fatto, e posso ricostruirmelo in mente. Così mi rico-struisco in mente questa scena. Il mondo è diventato un fatto oggettivo làdavanti ai miei occhi. Bene, non c’è più bisogno di immaginarsi niente.Dice Cartesio: «le favole fanno immaginare molti avvenimenti come possi-bili, che non lo sono affatto» (Discours de la méthode, I). L’immaginazio-ne è la causa prima dell’inganno dei racconti, questo si sa.
43Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 43
13. Trame novellistiche
Due cose adunano lo sparso mondo delle novelle, facendone una narra-tiva senza precedenti: il Decamerone, lettura di riferimento per più di tresecoli, e la passione del dialogo e dello scambio, propria d’una classededita agli scambi, quella dei mercanti. Protagonisti di centinaia di novel-le, i mercanti sono una razza di gente pratica, pronta a tutti gli incontri,che sa aderire all’eterogenea sostanza del mondo. «Conviene nella molti-tudine delle cose, diverse qualità di cose trovarsi», dice Boccaccio a con-clusione del Decamerone. È il principio dell’ibridismo novellistico, e vaassieme a un’idea della vita terrena come variabilità e mutevolezza, cherichiede perpetui adattamenti, negoziati e scambi. Questo si applica alletrame novellistiche, dove la sorpresa viene dall’eterogeneità degli incon-tri e casi, che producono continui ribaltamenti delle situazioni. Lo sche-ma elementare nelle favole e novelle consiste nel porre una situazione eribaltarla. Poi possono esserci due ribaltamenti, in andata e in ritorno,come nella novella di Andreuccio, che va a Napoli per affari; è truffatodalla Siciliana, perde i soldi; ma nell’avventura notturna trova l’anello del-l’arcivescovo, recupera i soldi e torna a casa ricco. Possono esserci ribal-tamenti plurimi: Landolfo Rufolo, ricco mercante, parte per fare affari,questi vanno male; allora lui si fa corsaro; di nuovo ricco; catturato daigenovesi, di nuovo in disgrazia; ma la nave fa naufragio; lui si trova a gal-leggiare su una cassa di gioielli, di nuovo ricco (Dec. II, 4). Può esserci ilribaltamento paradossale: Ser Ciappelletto, ateo, ladro, sodomita, bugiar-do, alla fine fatto santo (Dec. I, 1). L’eterogeneità dei casi si coniuga conuna ontologia del mutevole, cioè con l’idea d’una perpetua instabilitànegli stati di cose. «Considero le cose di questo mondo non avere stabili-tà alcuna, ma essere sempre in mutamento» (Dec., Conclusione). Questaconcezione è la molla di tutti gli alti e bassi che animano le trame novel-listiche. La minaccia del mutevole incombe sulle ricchezze, sugli amori,sugli affari, ed è personificata dalla figura mitologica della Fortuna: «Ma lafortuna, nemica de’ beni umani, disturbatrice dei piaceri terreni, contrariaalle voglie dei mortali…» (Grazzini, Cene, II, 6).Al centro di questo uni-verso sempre in altalena, c’è il simbolo della Ruota del Tempo, dove ciòche è in alto è destinato a cadere in basso, e viceversa: «Mirabile certa-mente è la instabil varietà del corso della nostra vita […] Vedrai oggi unonel colmo innalzato d’ogni buona ventura, che dimane troverai cadutocon rovina ne l’abisso delle estreme miserie» (Bandello, Novelle, III 68).Questo è un mondo dove, nell’eterogeneo flusso di situazioni e casi dis-parati («l’instabil varietà», dice Bandello), niente è mai del tutto in salvo;dunque un mondo con un alto tasso di imprevedibile. Il che ha una con-seguenza sulle trame: quella degli effetti di meraviglia, prodotti dai pro-digi, dalla violenza o dalle stranezze del fato.
44 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 44
14. Effetti di meraviglia
Le sorprese con meraviglia sono punti con un tacito risvolto numinoso,come paradossi della sorte,esempi dell’instabile Ruota del Tempo che portacon sé l’impensato o l’impensabile. In una novella alla quarta giornata delDecamerone, c’è la ragazza Isabetta innamorata del suo Lorenzo. Poi i suoifratelli glielo uccidono, allora lei prende la testa di Lorenzo e la mette in unvaso assieme a una pianta di basilico, pianta che ogni giorno irrora con lesue lacrime. Dopo di che: «Il basilico divenne bellissimo e odorifero molto».È un passaggio che ricorda i crolli patologici con fissazioni ossessive, maanche le forme di destino tragico con metamorfosi nei miti greci: come ildestino di Dafne, di Progne e Filomela, che l’eccesso del soffrire trasformain un lauro, in una rondine e in un usignolo. Simile è la metamorfosi doveIsabetta, da normale ragazza innamorata si trasforma in un mostro del dolo-re; dopo di che fa fiorire il basilico con le sue lacrime.Altro eccesso del sof-frire che produce una mutazione naturale impensata. La meraviglia rifletteun colmo emozionale, un traboccamento verso la dismisura, verso la sogliadel non umano o d’una follia arcaica, con il senso dell’uomo travolto dallaviolenza inconsulta del fato. L’effetto di meraviglia esiste anche sul versantecomico. La prima novella del Decamerone, quella su Ser Ciappelletto, con-centra il gioco delle sorprese precisamente su un effetto di meraviglia. Leattese dipendono dalla presentazione di Ser Ciappelletto come bugiardo,ateo, falsario, ladro,bestemmiatore, assassino e sodomita;mentre la sorpresaspunta a metà racconto, nella sua confessione col frate, dove il suddetto sispaccia per ferventissimo credente. Questo diventa poco a poco un puntod’eccesso, perché ad ogni battuta di Ser Ciappelletto si va oltre tutte leaspettative, e ogni volta spalanchiamo gli occhi per il crescendo delle sueinvenzioni da falsario, fin quando sappiamo che è diventato un santo delluogo. È il colmo che un tipo come lui sia canonizzato come santo, ed è unpunto d’eccesso paradossale che corrisponde sul lato comico all’eccessodel dolore di Isabetta.Le sorprese con meraviglia hanno questo tacito risvol-to: come mutazioni paradossali che portano verso un divenire impensato oimpensabile. La novella non sorprende con i fatti narrati ma con le meta-morfosi dell’impensato. Ricordo quella novella di Basile, nella prima giorna-ta del Cunto de li cunti, dove la moglie del re riesce a ingravidarsi con unapozione magica,ma per i fumi della pozione si ingravida anche la serva, e siingravidano perfino i mobili, i tavoli,gli armadi,che partoriscono degli arma-dietti e dei tavolini. Questa mi sembra la sintesi paradossale degli effettiimpensati di meraviglia, una tendenza al metamorfismo generale.
15. Il narrare festivo
Quando si legge Boccaccio, Sacchetti, Masuccio, Grazzini, Fortini o Basile, aogni novella si ha il senso che raccontare sia una festa. L’estro ameno dei
45Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 45
nostri novellatori era legato a raduni di allegre brigate, e buttava sempre ingiochi di stravaganza, d’oscenità, o nelle burle crudeli di Grazzini o nelcapriccio delle parole che fanno una danza come in Basile. L’esaltazionenovellistica non è pensabile se non come evento festivo che sospende leusanze pratiche della vita quotidiana, e raduna una compagnia in un luogodi lieti conversarî, dove si consuma cibo e parole e ricchezza. Il tema pri-vilegiato era sempre nel segno d’una burla, con virtuosismi immaginativiche rendono memorabili certi giochi del “far credere”, ingannare, turlupi-nare mariti gelosi,menar per il naso gli stolti,creare sotterfugi, travisare unacosa per l’altra. Le metamorfosi dell’inganno sono al centro dell’invenzio-ne novellistica, con punte ineguagliabili come quella di Ser Ciappellettoche diventa santo a forza di frottole, o del Grasso Legnaiolo, a cui riesconoa far credere d’essere diventato il compare Matteo.Tutto ciò porta con séun’ebbrezza, uno stato esilarante: come se il novellare fosse un uso benefi-co e purgativo dell’umana propensione alla credulità, all’imbecillità – a illu-dersi, ingannarsi,allucinare una cosa per l’altra. Il brio narrativo vive di que-sti giochi illusori, sprechi di parole, ghiribizzi e stravaganze che sospendo-no ogni serietà dei discorsi, ogni serio proposito per la vita. Nello stessotempo la licenza festiva della novella ha un’aria di fronda, come sfida ai“barbagianni”(categoria indicata nel Pecorone di Giovanni Fiorentino), agliottusi, ai gretti, ai bigotti. Di più: narratore e ascoltatore sembrano già dasempre uniti dal gusto dei sottintesi e delle facezie, che implicano un’a-pertura mentale, una sottigliezza ironica, un’indipendenza di testa.
16. Lo spirito della novella
Lo spirito della novella è lo spirito della beffa, e la beffa, la burla, l’ingan-no sono innanzi tutto racconti per corbellare qualcuno. Calandrino è lafigura boccaccesca del corbellato per eccellenza, e appena sente dire chenel paese di Bengodi v’è una montagna di parmigiano e un fiume di ver-naccia, è subito preso all’amo dalle parole. Poi va in cerca della pietra cherende invisibili, con i suoi soci beffardi Bruno e Buffalmacco, i quali fin-gono di non vederlo più; sicché lui, credendosi invisibile, quando torna acasa e s’accorge che sua moglie lo vede benissimo, la vuole ammazzare dibotte perché crede gli abbia rovinato la magia (Dec. VIII, 3). Il centro diquesti racconti è l’eccesso di stupidità, che si porta dietro la profanazionecomica di ciò che la stupidità accetta supinamente.Ad esempio: Puccio, aforza di sentir prediche, vuole diventare santo; al che un monaco promet-te di aiutarlo e gli prescrive certe penitenze, dove Puccio si consuma indigiuni, mentre il monaco in un’altra stanza prende piacere con suamoglie (Dec. III, 4). Lo spirito della novella è uno scetticismo fantasiosoche ci illumina su un generale inganno: l’inganno delle parole per spac-ciare come dogmi le rimasticature di ciarle, i castelli di panzane, i panegi-rici di frottole, le prediche dei preti per inebetire le folle o le invenzioni
46 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 46
dei frati per sfogare le voglie carnali. Ed ecco una storia su questi temi: unabate convince Ferondo di esser morto e già arrivato in purgatorio, dovelo trattiene per un po’ con belle invenzioni, per godersi intanto suamoglie. Quando poi Ferondo miracolosamente resuscita, va in giro a rac-contar alla gente «novelle sulle anime dei loro parenti» e «le più belle favo-le del mondo de’ fatti del purgatorio», e «la rivelazione statagli fatta per labocca del Ragnolo Braghiello [L’angiolo Gabriello]» (Dec. III, 8). Sonoesempi di inganni delle parole, dove non c’è più divario tra ingannatore eingannato: le fole dell’uno producono le panzane dell’altro, e tutto scivolanella generale tendenza degli uomini ad essere presi all’amo dalle chiac-chiere. Questa vertigine generalizzata produce mostri, perché il mondocosì pesantemente inquadrato dalle ciarle è simile a quello di Ferondoquando parla del purgatorio, e ogni ciarla diventa un raggiro del propriosimile, rintontito dalle parole.
17. Uomini, dementi e bestie
Nel Decamerone una buona metà delle novelle parla di inganni, raggiri,eccessi di stupidità, effetti comici delle burle. Questa è materia privilegia-ta di racconto, quasi l’immaginario allo stato puro, paragonabile solo aquello dei poemi cavallereschi, come volo di testa. Ma la massa dei credu-li e ottusi che popolano queste novelle fa anche pensare a uno stato diidiozia diffusa nell’umanità. Dante parlava della “mente” come parte supe-riore dell’anima, dove si colloca la virtù intellettiva; e diceva che moltipaiono essere del tutto privi di tale facoltà, perciò sono chiamati «amentie dementi» (Convivio, III, ii, 19).Va anche ricordata la novella boccaccescasu Guido Cavalcanti, il quale, trovandosi un giorno presso una chiesa dovesono delle arche sepolcrali, accerchiato da una banda d’amici intenziona-ti a trascinarlo con loro, risponde: «Voi mi potete dire a casa vostra ciò chevi piace». Poi, con un salto da «uomo leggerissimo», scavalca l’arca e se neva. La sua battuta viene spiegata dal capo brigata così: egli ha voluto direche «noi e gli altri uomini idioti e non letterati siamo, a comparazione dilui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti, e per ciò, quiessendo [presso le arche sepolcrali], siamo a casa nostra» (Dec. VI, 9). Lanozione di “uomini morti” è simile a quella di Dante, il quale, parlando dichi non segue nessuno studio o disciplina, diceva: «è morto [come uomo]ed è rimasto bestia» (Convivio, IV,vii,14).La battuta ha senso anche in rap-porto alla filosofia averroista di cui Guido è stato studioso, e dove uno deipunti critici era la proposizione “Homo non intelligit” – da intendere: chicomprende non è il singolo, ma l’intelletto generale che raduna tutti gliuomini. Ciò implica che dove non vi sia uno sviluppo mentale per risaliredai propri fantasmi immaginativi alle forme dell’intelletto generale, l’uomoresta un “uomo materiale”, “semplice” o “grosso”, come si diceva nellenovelle. Dai «dementi» di Dante agli «uomini morti» di Guido c’è la linea
47Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 47
d’un dubbio sulle facoltà umane, che tocca una vasta zona del pensierod’epoca. È anche il senso riposto delle beffe: come è possibile che unCalandrino sia detto uomo razionale? Lo spirito della novella ha l’aria d’unumanesimo ribaltato, che anziché convincerci che umanità e razionalitàsono la stessa cosa, ci mette nella posizione di cogliere la formula dellaloro massima distanza (“Homo non intelligit”).
18. Comica di Ganfo pellicciaio
La figura comica più proverbiale nella storia della novella è Calandrino:«uom semplice», con una «semplicità» da cui da cui Bruno e Buffalmacco«gran festa prendevano». Il semplice deriva dalla figura evangelica deipoveri di spirito destinati al regno dei cieli, ma qui assume il ruolo di zim-bello degli uomini di mente sottile. Sullo sfondo di queste implicazioni, siprofila una strana novella di Sercambi – quella su Ganfo pellicciaio, «omomateriale e grosso di pasta», altro semplice tra i più memorabili (Novelle,2). Dunque Ganfo va ai Bagni di Lucca per curarsi; ma quando deve entra-re in acqua e vede tante persone, si chiede: «Tra tanti, come farò a ricono-scermi?» Allora si mette un segno di croce sulla spalla, ed entrato in acquaguarda il segno e si dice: «Sì sono proprio io». Poi però l’acqua spazza viail suo segno di croce e lo deposita su un altro bagnante, al quale Ganfodice: «Tu sei io e io son tu». E l’altro per mandarlo al diavolo gli risponde:«Va’ via, tu sei morto».Al che Ganfo si crede morto, torna a casa, si stendesul letto, si lascia mettere nella bara (Ganfo è sempre come se obbedisseagli ordini o alle ingiunzioni delle parole,prendendo tutto alla lettera).Poi,mentre lo portano al cimitero, per strada una cliente gli manda una male-dizione, perché gli aveva portato una pelliccia da riparare e lui è mortosenza restituirgliela. E Ganfo risponde nella bara: «Se io fossi vivo comesono morto, ti risponderei come si deve». Racconto d’una idiozia miste-riosa e assoluta, che ricorda le comiche del cinema muto; ma dà anche l’i-dea d’un paradiso dei semplici, essendo peraltro intitolato De simplicita-te. Niente qui indica che l’uomo sia uomo in quanto creatura razionale; alcontrario,c’è una viva incertezza su cosa sia la razionalità,e su quella coin-cidenza con se stessi che chiamiamo “io”, nonché sui segni che ci mettia-mo addosso per distinguerci dagli altri – parodia dell’identità razionaleche tutti perpetuiamo.
19. La novella del Grasso legnaiuolo
Uno degli sviluppi più sintomatici delle burle novellistiche non va cerca-to nei testi letterari, bensì nella voga delle beffe cittadine. Erano beffearchitettate da artisti d’un genere quasi teatrale, perché implicavano unamessinscena e una recita delle parti per ingannare la vittima designata.L’e-
48 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 48
sempio più celebre è una beffa organizzata a Firenze nell’anno 1409,architettata da Filippo Brunelleschi, con una brigata d’artisti e artigiani fio-rentini, e un vasto concorso di comparse. La beffa sarà narrata in molteversioni, tra cui la più ampia è attribuita ad Antonio Manetti, redatta attor-no al 1446, a cui si dà il titolo di La novella del Grasso legniaiuolo.Vitti-ma designata: «il Grasso», artigiano intagliatore, che «aveva un poco delsemplice».Si tratta d’una recita collettiva per far sì che il Grasso creda d’es-sere diventato un tal Matteo. Dunque, quando torna a casa alla sera, unavoce che sembra la sua gli grida da dentro: «Matteo vai via che ho da fare».Passa un amico e lo saluta: «Buonasera Matteo». Lui va in piazza ed è arre-stato su denuncia d’un creditore che lo identifica come Matteo. Si chiede:«Sono forse Calandrino a esser diventato un altro senza accorgermene?». IlGrasso vede l’ombra della beffa, ma trovando mezza città concorde nelprenderlo per Matteo smette di far resistenza, per non essere trattato dascemo. Ciò non toglie che sia travagliato dall’idea d’una possibile meta-morfosi di se stesso, e che a momenti cominci a crederci, stimolato dallechiacchiere dei suoi persecutori.A un certo punto gli organizzatori dellabeffa mandano un prete, ignaro dello scherzo, per convincere il Grasso asmetterla di credersi il Grasso;e questo prete lo rimprovera per la sua osti-nazione, perché si fa ridere dietro come strambo. Secondo il prete lastramberia si cura con i buoni esempi:esempi dei “valenti uomini”che con“lo scudo della pazienza” superano ogni avversità. Qui la beffa retroagiscedalla burla al sempliciotto alla caricatura di untuose figure delle morale:quelli che incarnano una sicura coincidenza con se stessi, ciò che lorochiamano coscienza – col motto incosciente di Ganfo: «io sono proprioio». Nella storia del Grasso c’è il senso di un’incursione da parte dei fan-tasmi pubblici della morale, i fantasmi d’un “dover essere”, che sconvolgo-no il luogo delle immagini della mente e vi impiantano i segni d’un ordi-ne coercitivo esterno. In realtà è la storia di un’incertezza fondamentaleche riguarda tutti, tra l’idea d’una coincidenza con se stessi e il sensod’una estraneità a se stessi: incertezza disonorevole, da tenere semprenascosta, perché somiglia alla pazzia.
20. Mariotto diventato albero
Nella schiera dei semplici va inscritto il Mariotto di Grazzini, che facevaridere tutti con le sue castronerie, perché «credeva in cose tanto sciocchee goffe» da sembrare piuttosto una bestia addomesticata che un uomovero e proprio (Cene, II, 2). E come il Puccio boccaccesco a forza di ascol-tare i frati voleva diventare santo, così Mariotto a forza di ascoltare predi-che non vedeva l’ora di morire – perché gli era stato detto che «questa vitanon era vita, anzi una vera morte», e invece «chi moriva, di là cominciavaa vivere una vita senza affanni».Questo è l’avvio del racconto.Dopo di chesua moglie si prende nel letto un amante; e i due assorti nell’acre piacere
49Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 49
dello spasmo genitale sono seccati dal grullo Mariotto che invoca lamorte, per cui decidono di metterlo in una bara e spedirlo al cimitero.Potrebbe essere una comica come quella di Ganfo, se non fosse per comesi risolve. Grazzini segue la filosofia boccaccesca d’un determinismo natu-rale, come quello che produce l’attrazione tra i sessi. Ma in Grazzini ildeterminismo tocca tutti i comportamenti umani, come esempi d’unanatura indifferente a qualsiasi ordine morale. E non ci sono santi né eroi;ci sono solo trucidi e sciocchi; e una vita governata da scelleratezze e sor-dide mene. Ma ecco allora che il semplice non è più come Calandrino, unbalordo marginale rispetto al saldo mondo dei Bruno e Buffalmacco.Mariotto incarna l’essenza pura della bestialità di questo mondo, doveniente ha la salda trama del reale, tutto pare un incubo di fantasmi postic-ci. Come quando sulla via del cimitero, dopo essersi cacato addosso, luisalta fuori dalla bara; e a quel punto si capisce che niente è controllabile,tutto svaria e tracolla nell’insensato. L’acqua dell’Arno prende fuoco, luiresta bruciato in Arno, quasi obbedendo a un detto popolare fiorentino; edopo non somiglia più a un uomo,ma ad un «ceppo di pero verde,abbron-zato e arsiccio». Proprio quella morte comica fa di lui una figura che spic-ca tra tutte le maschere d’una bestialità nascosta dietro le norme dei traf-fici quotidiani; mentre lui, fin dall’inizio vicino all’essenza della purabestialità, morendo regredisce a purissima materia vegetale, come quellada cui nascerà Pinocchio. E questa mi sembra la conclusione ideale ditutte le leggende novellistiche sull’idiozia dei “semplici”.
21. L’eredità provenzale
Nel prologo alla prima giornata del Decamerone, Boccaccio annuncia loscopo delle sue cento novelle. Queste sono narrate per dare sollievo a chine ha bisogno,dice,ma in particolare alle donne con amori segreti, costret-te a nascondere le loro fiamme amorose e perciò tanto più assillate dai pen-sieri. Che il narrare sia una cura contro le tristezze e gli affanni è un’ideaantica, che in qualche modo associava l’arte narrativa a un sapere medicodi tipo ippocratico. La novità nell’annuncio di Boccaccio sta nell’indicareuna cura non più rivolta a pratiche e usi esterni, ma alla dimensione deipensieri intimi e delle fantasie incontrollabili. La familiarità con tale dimen-sione è attribuita soprattutto alle donne, perché più soggette alla reclusio-ne nell’ambito familiare. Le donne, soggette ai «comandamenti de’ padri,delle madri, de’ fratelli e de’ mariti», chiuse nelle loro stanze, dice l’autore,rimuginano pensieri facilmente inclini alla malinconia,quando siano mossio insidiati da forti desideri. Queste turbe sono l’oggetto della cura novelli-stica e anche il punto d’intesa con le donne amorose a cui il libro si rivol-ge. È un punto d’intesa che si colloca nella sfera intima dei fantasmi amo-rosi; ciò che Dante chiama «la secretissima camera de lo cuore»: ossia l’in-teriorità come luogo completamente immaginario, e proprio perciò sede
50 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 50
di tutti i tremori ed emozioni del corpo. Nei suoi cenni introduttivi Boc-caccio sembra ripercorrere la via dei poeti provenzali, che usavano la poe-sia come alleanza segreta con la donna, segno di amori da tenere nascostinel luogo immaginario dell’interiorità. Ed ecco le donne con amori segretia cui è destinato il libro, che fanno pensare a casi simili nelle storie deipoeti provenzali, ma anche ai modi di devozione alla donna sviluppatenella lirica italiana: modi che lo stesso Boccaccio ha ripreso ed esaltatonelle sue precedenti opere e nei suoi versi. Così il Decamerone recuperala ricerca dei poeti provenzali, d’un contatto tra genere maschile e femmi-nile che non sia esteriore come quello del matrimonio. Il mezzo di contat-to per i poeti provenzali era la poesia, come alleanza segreta e intima conla donna,e qui sono queste «cento novelle,o favole o parabole o istorie chedire le vogliamo» – che nell’ultima pagina l’autore chiama «le mie novelleper cacciar la malinconia delle femmine».
22. Il piacere degli amanti
Nella novella di Masetto da Lamporecchio, due novizie parlano dell’amo-re e una dice di aver udito «che tutte le altre dolcezze del mondo sono unabeffa rispetto a quella quando la femina usa con l’uomo» (Dec. III, 1). Sicapisce l’insistenza di Boccaccio nell’evocare il piacere carnale provatodalle donne. È un richiamo alle «leggi di natura» da cui il corpo è regolato,e all’amore come una potenza di natura che è «vano voler contrastare»(Dec. IV, introduz.). L’amore visto come “legge di natura” giustifica l’arbi-trarietà degli impulsi sessuali, e di conseguenza giustifica anche le mogliche sfogano quegli impulsi fuori dal matrimonio. Ad esempio, MadonnaFilippa,denunciata per adulterio, convince i giudici di non aver fatto nien-te di male, in base a questo ragionamento: che lei non si è mai negata almarito, ma avendo in corpo qualche bisogno in più, e non volendo get-tarlo ai cani, le è parso giusto prendersi un amante (Dec. VI, 7). In realtà, auna veduta d’insieme, parrebbe che gli sfoghi carnali delle mogli abbianopoco sapore senza l’inganno ai mariti; perché un buon venti per cento dinovelle presentano mogli che optano per le «dilettose gioie» con l’aman-te, mentre il numero di mogli non adultere è veramente minimo in tuttoil libro. Certo, la moglie che gabba il marito con una frottola mentre godecon l’amante, è un motivo tra i più ricorrenti in tutta la nostra novellisti-ca; ma in Boccaccio prende un sapore diverso dal solito. Anche nei rac-conti più vicini alla farsa sessuale popolare, gli amori muliebri extramatri-moniali nel Decamerone prendono il senso d’una sovranità che si realiz-za tramite l’arbitrio; perché i sotterfugi, gli inganni, i nascondimenti, rea-lizzano l’arbitrio d’un piacere carnale senza più le sorveglianze di maritoo famiglia (Dec. VII, 2, 4, 9). Cito la novella di quel marito che si spaccia daconfessore per cogliere in fallo la moglie; ma la moglie gli ribalta l’ingan-no, lo mette dalla parte del torto e lo tradisce a piacimento: «Per che la
51Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 51
savia donna, quasi licenziata a’ suoi piaceri [divenuta libera nei suoi pia-ceri]», «poi più volte con lui [con l’amante] buon tempo e lieta vita sidiede» (Dec. VII, 5). Conclusione con una strana leggerezza, dove l’arbitriodel piacere sembra l’adesione ad una amicizia tra i sessi che non ha piùniente di esteriore. Ci sono altre novelle che andrebbero studiate da que-sto punto di vista. Il piacere degli amanti diventa una sovranità intima, sot-tratta alle censure della consapevolezza,per il sotterfugio che rende segre-to il loro piacere. Come nell’esempio di Tristano e Isotta: tenuta segreta,l’amicizia tra uomo e donna si realizza nella dimensione più immaginariapossibile, che è anche la più impenetrabile, e perciò ha l’aspetto d’unapiena sovranità. Anche questo fa parte dello spirito della novella, comeresiduo d’un esperimento mentale tentato dai provenzali, di cui restanotracce fino alla storia della Montanina di Sermini (Novelle, 1), quella diMariotto e Gianozza di Masuccio (Novellino, 33), di Giulietta e Romeo diDa Porto, e fino a Shakespeare.
23. Sull’eros nel Decamerone
Le novelle boccacesche sfuggono a qualsiasi assegnazione morale, anchelà dove presentano modelli di comportamento esemplare. L’atto di Fede-rigo degli Alberighi di offrire all’amata il falcone, ultima sua risorsa, è unmodello di devozione e nobiltà; ma è anche un colmo paradossale che cicolpisce come uno strano gioco della sorte, non come un esempio daseguire.E la silenziosa costanza di Griselda nell’obbedire alla «matta bestia-lità» del marito ci lascia sbalorditi, anche ammirati, ma è un monstrum incui non potremo mai vedere una virtù condivisa da altri umani. In Boc-caccio manca del tutto una metafisica della virtù, sostituita da un deter-minismo di natura, come quello che produce l’attrazione tra i sessi. Perquesto l’unica vera colpa individuabile nel Decamerone è la colpa del dis-amore, condannata nella novella di Nastagio degli Onesti con una penainfernale, e in quella di Tedaldo degli Elisei con queste decise parole: «L’u-sare la dimestichezza d’un uomo [per] una donna è peccato naturale», «ildiscacciarlo da malvagità di mente procede» (Dec. III, 7). Il naturalismoboccaccesco si regge semplicemente sulla favola di quel tale che, vissutosempre in isolamento assieme a un padre ascetico, la prima volta che vededelle donne desidera soltanto quelle, e il resto non conta più niente perlui. Morale: «ha più forza la natura che l’ingegno» (Dec. IV, introduz.). La“natura” è la potenza attrattiva tra i sessi, come un incantesimo generaleche guida le vite degli uomini.Ma questa attrattiva non si distingue mai dalsuo fondo illusorio: l’abbaglio delle apparenze, i miraggi delle favole, i tra-visamenti della passione. Nell’introduzione alla quarta giornata c’è chideride l’autore per la sua passione per le donne, consigliandogli di trovardel pane per risolvere quella fame, e d’andare a cercarselo nelle favole(nelle illusioni).Al che l’autore risponde che i poeti trovarono più risorse
52 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 52
nelle favole che i ricchi nei loro tesori. L’intreccio tra attrazioni dell’eros eillusioni delle favole non è negato, bensì presentato come ciò con cui «ipoeti fecero fiorire la loro età» (riferimento ai maggiori poeti del dolce stilnovo, indicati qualche pagina prima come maestri d’amore). La novellaboccaccesca crea sempre l’esaltazione narrativa con le ombre dell’illuso-rio, spandendo inganni, sotterfugi, abbagli e raggiri, come quelli dellemogli per imbrogliare i mariti; e per il resto narra semplicemente i movi-menti d’attrazione tra i sessi (solo una ventina di novelle parlano d’altro),che hanno l’aria d’essere l’infinita ripetizione d’un gioco, o il gioco delmondo. Ed è il risultato del naturalismo boccaccesco: se l’eros è una folliache porta a seguire un’attrazione irresistibile attraverso le ombre di ciòche è illusorio (le ombre che avvolgono tutta la terra come una marea,diceva Giordano Bruno), questa follia è però integrata nella natura e nelgioco del mondo.
24. Coda
Il Cinquecento è il secolo in cui la novella diventa un genere letterarioriconosciuto, di moda, e un genere che tutti si sentono di poter praticare– un po’ come succede col romanzo al giorno d’oggi. Così diventa unaforma ufficiale, ancora ibrida, ma ufficializzata dall’uso, e con libri che sta-biliscono cosa sia e come si debba scrivere una novella. Nel 1573 è datoalle stampe un Decamerone ripulito nella lingua e nelle parti licenziose,messo in regola secondo i canoni dei libri correnti, e secondo un’unifor-mità letteraria ormai prescritta. Si capisce che la novella boccacesca è unamemoria illustre,ma con una vivacità fuori epoca,che stona con gli stili invoga. Una cosa che si può notare negli stili dei novellieri cinque-seicente-schi, è una patina d’indifferenza sistematica che avvolge i loro testi, ren-dendoli quasi tutti come appiattiti nello stesso stampo oratorio, con unasparizione della singolarità del diverso. Qui sto cercando d’abbozzare unpanorama di fondo senza nessun valore critico, ma che mi serve per farcapire quale miracolo sia stato l’apparizione di Lo cunto de li cunti diBasile, nell’anno 1634. Lo cunto è nello stesso tempo un seguito della tra-dizione boccaccesca e la fine di questa tradizione con l’apertura verso unaltro genere – quello della fiaba. Come in nessun’altra raccolta di raccon-ti per trecento anni, qui si vede riapparire la festosità del narrare e l’eb-brezza dell’illusorio. E questo per un effetto regressivo, con il ritorno a unprima della novella, al tipo di racconto minimo e più elementare: quelloper bambini, affidato da tempo immemorabile alle nonne. Dice una narra-trice di Boccaccio: «Quando c’invecchiamo,né marito né altri ci vuol vede-re, anzi ci cacciano in cucina a dir delle favole colla gatta e noverare lepentole e le scodelle» (Dec. V, 10). Quel genere infimo diventa uno spetta-colo di parole, un intrattenimento senza nessuna volontà di narrare i “fattidel mondo”, e che svuotandosi di senso prende il senso d’una parodia
53Gianni Celati
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 53
generale del milieu per cui è stato confezionato. Dice Michele Rak che lefiabe di Basile erano scritte per riempire le conversazioni del dopo pasto,come gioco cortigiano inteso a far sorridere la smorta nobiltà napoletana.E pensando alla storia della principessa che non riusciva a ridere, con cuiil Cunto si apre, c’è da credere che la festosità barocca fosse più o menoarenata in simili secche. Ma la felice ebbrezza che attraversa questo libroviene da un’altra parte; viene dal dialetto napoletano, dalla raccolta dimodi di dire napoletani, e dalla raccolta di fiabe delle nonne, per la primavolta ordinate e raccontate in modo da farne veramente un genere. E intutto questo fin dall’apertura si sente l’eco del sapere di Shahrazad, il sape-re del narratore-guaritore che sa tenere il tempo sospeso con l’artificiodelle parole, allontanando di racconto in racconto l’incombenza dellamorte: «L’ultima felicità dell’uomo è il sentire racconti piacevoli, perchéascoltando cose amabili, gli affanni evaporano, i pensieri fastidiosi vengo-no sfrattati e la vita si allunga» (Basile, Cunto,Apertura).
Per una versione ridotta di questo saggio: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6celati.htm.
54 I saggi
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 54
Un rifiuto della storia: Eliogabalo, l’imperatore che morì nella cloaca*Francesco Citti, Lucia Pasetti
1. Eliogabalo il “Trascinato”
Fu assalito [...] e ucciso in una latrina in cui aveva cercato di rifugiarsi. Fupoi trascinato per le vie. Per colmo di disonore, i soldati gettarono il cada-vere in una fogna. Poiché il caso volle che la cloaca risultasse troppo strettaper ricevere il corpo, lo buttarono giù dal ponte Emilio nel Tevere, con unpeso legato addosso perché non avesse a galleggiare, di modo che nonpotesse aver mai a ricevere sepoltura.Prima di essere precipitato nel Tevere,il suo cadavere fu anche trascinato attraverso il Circo. Per ordine del senatofu cancellato dalle iscrizioni il nome di Antonino, che egli aveva assunto pre-testuosamente, volendo apparire figlio di Antonino Bassiano, e gli rimasequello di Vario Eliogabalo. Dopo la morte fu chiamato il “Tiberino”, il “Tra-scinato” l’“Impuro” e in molti altri modi, ogniqualvolta capitava di dare unnome ai fatti della sua vita. E fu il solo tra tutti i principi ad essere trascina-to, buttato in una cloaca, ed infine precipitato nel Tevere.
Così è descritta la singolare fine di Eliogabalo (imperatore tra il 218 e il222)1 nella Historia Augusta (17, 17, 1-6),2 opera «singolarissima e miste-riosissima», secondo la definizione dell’ultimo editore italiano; basti ricor-dare che ci sono dubbi sulla paternità, sulla data e sul suo significato.Quan-to all’autore, è stata a lungo discussa la tradizionale attribuzione a ElioLampridio;per diversi motivi (incongruenze interne,citazioni dello storicoAurelio Vittore, vissuto intorno al 360 d.C.) si è giunti alla conclusione checi troviamo comunque di fronte all’opera di un solo autore, sia che si trat-ti della rielaborazione di opere antecedenti, o di una vera e propria falsifi-cazione parodistica, databile probabilmente intorno alla fine del IV secolo.
55Francesco Citti, Lucia Pasetti
5
* Questo contributo è nato in occasione della giornata di studi Eliogabalo l’adolescente alpotere tenutasi a Ravenna il 3 febbraio 2007 (www.classense.it), in concomitanza con lospettacolo teatrale Heliogabalus di Fanny & Alexander (cfr. il sito http://www.heliogaba-lus.org).1 L’imperatore deriva il suo nome da Elagabalo (“El delle montagne”), divinità orientale pro-tettrice di Emesa, luogo di origine del personaggio; la versione greca Eliogabalo è derivatadalla frequente paretimologia del semitico “El” (che indica la divinità), con Helios, il “Sole”.2 Il testo di riferimento è P. Soverini (a cura di), Scrittori della Storia Augusta,Torino, UTET,1983, 2 voll. L’opera è una raccolta di 39 biografie imperiali da Adriano a Diocleziano (esclu-so), e dunque dal 117 al 284, attribuite a sei diversi autori.Ad Elio Lampridio spetterebberole vite di Commodo, Diadumeno,Alessandro Severo ed Eliogabalo: quest’ultima è dedicata aCostantino (imperatore dal 306 al 337).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 55
Ancora più problematica l’interpretazione del significato delle Vite: secon-do l’ipotesi più accreditata esse riflettono un ambiente tradizionalista e filo-senatorio,contrario all’ascesa di novi homines.3 La fine di Eliogabalo vienein effetti giustificata con questa affermazione: «Questo accadde per il gene-rale odio di tutti,dal quale gli imperatori debbono guardarsi in maniera par-ticolare,dato che chi non riesce a guadagnarsi l’amore del senato,del popo-lo e dei soldati,non merita neppure la sepoltura».Tale interpretazione trovaconferma nella costante contrapposizione tra Alessandro Severo (impera-tore tra il 222 e il 235), idealizzato per la sua politica filosenatoria, ed Elio-gabalo: un mostro che disprezza e ridicolizza il senato sin dal suo arrivo aRoma, quando «diede ordine che sua madre fosse invitata a parteciparvi.[...] Egli fu l’unico fra tutti gli imperatori sotto il cui regno una donna [...]entrò in senato», come si preoccupa di precisare Lampridio, aggiungendo(18, 2) che dopo Eliogabalo «la prima cosa che ci si preoccupò di stabilirefu che mai più una donna potesse entrare in senato, e che chi si fosse resoresponsabile del verificarsi di un fatto del genere, fosse condannato amorte e la sua memoria maledetta».Non manca tuttavia chi – come RonaldSyme4 – ritiene che l’opera sia il divertissement di un dotto senza scrupo-li che ha costellato la sua narrazione di invenzioni di ogni genere per unpubblico desideroso di curiosità erudite e scabrose. In questo caso ci tro-veremmo di fronte ad una dissacrante e compiaciuta rappresentazione dieccessi viziosi e particolari piccanti, per certi versi non molto lontana,come vedremo, dal Super-Eliogabalo di Arbasino.Qualunque chiave di lettura si voglia adottare, nel ritratto di LampridioEliogabalo è oggetto di ostentato disprezzo, in piena coerenza con la fineingloriosa che gli viene attribuita. Già in apertura della Vita l’autore mani-festa una certa ripugnanza per la materia trattata: «non mi sarei mai risol-to a scrivere la vita di Antonino Eliogabalo» – afferma – «nella speranza chenessuno sapesse che egli era stato un imperatore romano»; Eliogabaloviene infatti collocato sullo stesso piano «dei Caligola,dei Neroni,dei Vitel-li», gli imperatori “cattivi” il cui ricordo dovrebbe essere rimosso, se nonpermettesse di «apprezzare la capacità di discernimento dei Romani», cheriservarono loro una morte violenta e la cancellazione della memoria:5 un
56 I saggi
3 Cfr. Iulius Capitolinus, Optilius Macrinus, introduzione, testo critico, traduzione e note acura di E. Pasoli, Bologna, Patron, 1968, p. 7; P. Soverini, Introduzione a Scrittori della StoriaAugusta, cit., in particolare pp. 23-26 e 51-52.4 Cfr. Ronald Syme, Ammianus and the Historia Augusta, Oxford, Oxford University Press,1968, in particolare pp. 176-191, 203-210 e passim; Id., Emperors and Biography. Studies inthe Historia Augusta, Oxford, Clarendon Press, 1971, pp. 73-75 e passim. Per una discussio-ne e una rassegna bibliografica cfr. P. Soverini, Introduzione a Scrittori della Storia Augusta,cit., vol. I, pp. 9-57; inoltre sulla rappresentazione parodica del principe, cfr. G. Mader,Historyas Carnival, or Method and Madness in the Vita Heliogabali, in «Classical Antiquity», 24,2005, pp. 41-172.5 E in verità la damnatio memoriae non ha tanto lo scopo di cancellare il ricordo, quantodi eternare la memoria delle iniquità commesse da chi la subisce: si veda in proposito la pre-fazione di G.Brizzi a S.Gualerzi,Né uomo, né donna, né dio, né dea.Ruolo sessuale e ruoloreligioso dell’imperatore Elagabalo, Bologna, Pàtron, 2005, p. 6.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 56
destino rappresentato iconicamente dalla cloaca in cui finisce Eliogabalo.Vergogna e disgusto affiorano anche nell’appello finale al dedicatario, l’im-peratore Costantino,a cui lo storico porge esplicitamente le sue scuse (34,2-3): «Sento il bisogno di scusarmi se ho dovuto riferire cose come queste,che pure ho ricavato da diverse fonti, per quanto abbia cercato di taceresu molti episodi disgustosi e a cui non si può neppure accennare senzaprovare la più profonda vergogna; quello che poi non ho potuto fare ameno di dire, mi sono sforzato di velarlo usando, nei limiti del possibile,dei giri di parole». E ancora, ponendo Eliogabalo tra gli imperatori “pessi-mi” afferma di aver scritto tutto «controvoglia e riluttante».Tra i tanti aspetti della personalità di Eliogabalo su cui si appunta il dis-prezzo dello storico, uno in particolare incuriosisce: si tratta delle innova-zioni introdotte dall’imperatore, un argomento che nelle biografie impe-riali occupa una rubrica specifica, solitamente in funzione di elogio.6 Nelcaso di Eliogabalo, invece, viene sottolineato il carattere futile e irrisoriodelle invenzioni. Gli ambiti di eccellenza dell’imperatore riguardano infat-ti l’abbligliamento, la cucina, l’arredamento e gli scherzi: «Fu il primo cit-tadino privato a coprire i letti con coperte trapuntate d’oro. [...] Fu ancheil primo a possedere fornelli e pentole d’argento, e per primo inoltre vasicesellati, sempre d’argento, del peso di cento libbre ciascuno, e alcuni raf-figuranti le scene più sconce. [...] Per primo inventò il vino aromatizzatocon la resina di lentischio o con la menta e tutto questo genere di mistu-re che sono ancora oggi di moda tra le persone raffinate. [...] Per primofece fare le polpette con carne di pesce e di ostriche, litostriche e altrisimili molluschi marini, e di gamberi, calamari e squille.A molti degli amicidi più bassa condizione faceva trovare, al posto dei normali divani dimensa, dei cuscini pieni d’aria e, durante il pranzo, li faceva sgonfiare, cosìche spesso i poveretti si ritrovavano all’improvviso a mangiare sotto iltavolo. Fu così che egli per primo ebbe ad escogitare la trovata di far dis-porre il semicerchio dei sedili per terra,anziché sui letti tricliniari,per ren-dere possibile agli schiavetti che stavano ai piedi degli ospiti di scioglieree sgonfiare i cuscini». Primeggiò anche nel sesso (33, 1): «Escogitò certigeneri di godimenti pervertiti, così da superare in ciò gli amasii dei suoipredecessori viziosi, ed era ben al corrente di tutti gli apparati di depra-vazione di Tiberio, di Caligola e di Nerone». L’originalità della sua morte,dunque, trova una precisa corrispondenza nella sua vita.
57Francesco Citti, Lucia Pasetti
6 Così è, ad esempio, per Adriano, di cui si dice che (Hist.Aug. 1, 11, 2) «per primo fece eri-gere un muro lungo 80 miglia, il cui scopo era quello di tenere lontani i barbari dai Romani»(il celebre “vallo di Adriano”), oppure che (1, 20, 6) «per primo istituì la carica di avvocatodel fisco». Alcune innovazioni sono attribuite anche ad Alessandro Severo, costantementecontrapposto a Eliogabalo come una sorta di “doppio positivo”: di lui si loda infatti l’attivitàdi restauratore e promotore di opere pubbliche, come le terme, dove «fu il primo imperato-re a dare a una vasca il nome di Oceano» e «fu il primo ad usare un tipo di lavorazione mar-morea detta Alessandrina [...] impiegando tale genere di rivestimento marmoreo per lastri-care i cortili del Palazzo» (18, 25, 5-7).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 57
2. Il dissoluto per antonomasia
L’immagine di cattivo imperatore fornita dall’Historia Augusta è conferma-ta dalle altre fonti che recano notizia del personaggio:gli storici greci DioneCassio (per Eliogabalo, in realtà, ne abbiamo solo un’epitome7) e Erodiano,entrambi vissuti tra II e III secolo d.C. e quindi anteriori a Lampridio.Tra idue, pure accomunati dal ricorso ad una topica consolidata nella caratteriz-zazione degli imperatori “cattivi”, è stata ravvisata qualche differenza di pro-spettiva: Dione, un alto funzionario imperiale saldamente iscritto in un oriz-zonte filosenatorio, insiste maggiormente, in linea con Lampridio, sui vizidell’imperatore (soprattutto sulle relazioni sessuali che lo rendono dipen-dente da personaggi di bassa condizione). Erodiano, di estrazione socialeinferiore, sembra più colpito dall’attività religiosa di Eliogabalo, cultural-mente più vicino all’Oriente “barbaro” che al mondo greco.8 Le tre operestoriche, pur con diverse sfumature, concorrono a definire, come trattidistintivi del personaggio, l’arbitrio, la dissipazione, la lussuria: elementidestinati a sclerotizzarsi nei secoli successivi.Un’immagine negativa dovevaessere data dal carme intitolato Antonino Eliogabalo (Auson. 23 = I Cesa-ri, vv. 138-139) di Decimo Magno Ausonio, uomo politico e scrittore origi-nario di Bordeaux, vissuto nel IV secolo; del componimento restano solo iprimi due versi: «Osi ancora insozzare le stanze di Augusto, tu che porti fal-samente il nome degli Antonini?» (Tune etiam Augustae sedis penetraliafoedas, / Antoninorum nomina falsa gerens?), dove l’autore riecheggiachiaramente la polemica di Lampridio contro l’adozione del nome di Anto-nino da parte di Eliogabalo, che col suo comportamento avrebbe corrottoquel nome.All’inizio del V secolo lo storico Orosio avrebbe tratteggiato cosìil regno di Eliogabalo: «Nell’anno 970 dalla fondazione di Roma,Marco Aure-lio Antonino, ottenuto l’impero come ventesimo da Augusto, lo tenne perquattro anni. Questi, sacerdote del tempio di Eliogabalo, non lasciò altramemoria di sé se non quella assai infamante di stupri, delitti e di ogni tipodi oscenità.Durante una rivolta militare fu ucciso a Roma con la madre» (Lestorie contro i pagani, 7, 18,4-5). E la figura delineata dalla storiografia anti-ca riappare, inalterata, nelle pagine di Gibbon, per cui Eliogabalo «corrottodalle passioni della gioventù,dai costumi della patria e dalla sua propria pro-
58 I saggi
7 Del libro LXXX (o LXXIX, a seconda della divisione adottata) della Storia Romana, in cuiè riportata la vicenda di Eliogabalo, ci è giunta l’epitome bizantina di Xiphilinus.8 Per un sintetico resoconto dei problematici rapporti tra gli storici greci e Lampridio, cfr. J.S. Hays, The Amazing Emperor Eliogabalus, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1972 (Londra1911), pp. 6-9; si vedano inoltre A. Schreithauer, Die Regierungszeit des Kaisers Elagabal inder Darstellung von Cassius Dio und Herodian, in «Hermes» 118, 1990, pp. 335-372, cheevidenzia analogie e differenze tra la trattazione di Dione e quella di Erodiano (che da Dionesembrerebbe dipendere), e M. Sommer, Elagabal, Wege zur konstruktion eines “schlechten”Kaisers, in «Scripta Classica Israelica», 23,2004,pp.95-110,che individua un’identità di vedu-te tra Historia Augusta e Dione, portatori di un’ideologia apertamente filosenatoria, e Ero-diano, greco di Antiochia e forse proprio per questo meno disponibile ad accettare l’identi-tà barbara di Eliogabalo.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 58
sperità, si abbandonò ai piaceri più grossolani con sfrenato furore, e neigodimenti trovò presto la sazietà e la nausea»; nel riferirne la morte, poi, lostorico settecentesco si allinea apertamente al giudizio degli antichi:«Il sena-to bollò la sua memoria di perpetua infamia,e i posteri hanno ratificato que-sta giusta sentenza».9 Anche al di fuori dal genere storiografico Eliogabalodiventa l’icona del potente lascivo e pazzo, dedito al lusso e ai piaceri piùsfrenati. Spesso è menzionato per le sue frivole invenzioni: Daniello Bartoli(La ricreazione del savio 1,12,577),10 nel concludere un suo discorso sullecaratteristiche dei fiori, spiega di non voler approfittare oltre della pazienzadei suoi lettori: «ché io vo’ qui ricrearne l’ingegno, non affogarvelo dentro,come faceva Eliogabalo con i suoi amici,con una nuova invenzione di mortetroppo acerbamente deliziosa»; l’erudito allude scherzosamente all’uso diun particolare apparato conviviale che consentiva a Eliogabalo di riversaresui suoi ospiti un pioggia di fiori, con il rischio di soffocarli («facendo azio-nare il soffitto girevole di certi triclinii, sommergeva i suoi parassiti con unapioggia di viole e altri fiori, tanto che alcuni, non riuscendo a risalire allasuperficie, vi morirono soffocati», Hist.Aug. 17, 21, 5). Che la sontuosità deibanchetti di Eliogabalo fosse divenuta proverbiale, è dimostrato ad esempioda un episodio dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1726), in cui il pro-tagonista, ricevuto dal governatore di Glubbdubdrib,avendo la possibilità diincontrare alcuni personaggi del passato (da Socrate e Epaminonda fino aTommaso Moro),non rinuncia a un pranzo cucinato dai cuochi di Eliogaba-lo: «Passai cinque giorni a conversare con molti altri sapienti dell’antichità evidi la maggior parte dei primi imperatori romani. Indussi il governatore aevocare i cuochi di Eliogabalo perché ci allestissero un pranzo,ma non pote-rono dar prova della loro perizia, per mancanza di materiali».11 Anche Man-zoni (Promessi Sposi 5,86) ricorre a Eliogabalo come iperbolico termine diconfronto per ironizzare sull’abbondanza della tavola di Don Rodrigo intempo di carestia: «i pranzi dell’illustrissimo signor don Rodrigo vincono lecene d’Eliogabalo; [...] la carestia è bandita e confinata in perpetuo da que-sto palazzo,dove siede e regna la splendidezza».Per questa via si giunge finoal romanzo di Kurt Vonnegut, La colazione dei campioni (1973), una fero-ce satira della società americana, le cui stravaganze sono interpretate comeevidenti segni di malattia e di decadenza. Nel dialogo surreale tra un eccen-trico scrittore di romanzi di fantascienza e il suo pappagallo Bill, Eliogabaloviene chiamato in causa a simboleggiare l’umanità corrotta, colpevole diaver causato, con la sua ferocia, la rovina del pianeta:
“Siamo tutti Eliogabali, Bill” gli diceva. Così si chiamava un imperatore romanoche si fece fare da uno scultore un toro di ferro, vuoto dentro e di grandezza
59Francesco Citti, Lucia Pasetti
9 Cfr. E. Gibbon,Storia della decadenza e caduta dell’impero romano, traduzione di G. Friz-zi,Torino, Einaudi, 1967, vol. I, pp. 140-141.10 Cfr.D.Bartoli,La ricreazione del Savio, a cura di B.Mortara Garavelli,premessa di M.Corti,Parma, Guanda, 1992, p. 245.11 J. Swift, I viaggi di Gulliver, traduzione di C. Formichi, Milano, Mondadori, 1982, p. 421.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 59
naturale, con uno sportello che si chiudeva da fuori. Il toro aveva la bocca spa-lancata,e questa era la sola altra apertura verso l’esterno.Eliogabalo faceva entra-re una creatura umana per lo sportello, che poi veniva chiuso da fuori. I rumo-ri che l’essere umano faceva all’interno del toro venivano fuori da una boccaspalancata.L’imperatore invitava gente a una bella festa,con abbondanza di ciboe vini e belle donne e bei ragazzini,dopodiché faceva accendere della ramagliada un servo. La ramaglia stava sotto a della legna che stava sotto al toro.12
In realtà nella tradizione greca e latina il toro di metallo è addebitato alla cru-deltà di Falaride, tiranno di Agrigento;13 sembra inoltre estranea all’aneddoti-ca antica la spettacolarizzazione della tortura,che il personaggio di Vonnegutimmagina crudelmente attuata sullo sfondo di un convivio: proprio questoparticolare,peraltro,rende plausibile l’attribuzione della trovata a Eliogabalo,le cui bizzarre invenzioni avevano spesso a che fare con il banchetto.
3. Eliogabalo esteta decadente
All’immagine stereotipata di Eliogabalo sopravvissuta fino a oggi, già dallafine dell’Ottocento se ne affianca un’altra, risultato di una radicale rivaluta-zione.È del resto ben noto l’interesse suscitato nella sensibilità fin de siècledalle epoche cosiddette “decadenti”; a questi periodi, in cui si vede il tra-monto e insieme il culmine di una civiltà, viene attribuita un’estrema raffi-natezza estetica, terreno fertile per il formarsi di individualità eccezionali, incui l’intellettuale tardo ottocentesco si identifica; su tale rispecchiamento èincentrato il celebre verso di Verlaine: «Sono l’Impero al limite estremo delladecadenza» (Languore). La figura di Eliogabalo conosce allora una partico-lare fortuna, garantitagli proprio da quei tratti che, nel passato, ne avevanodeterminato la condanna: l’amore per il lusso, la perversione, il rifiuto delleconvenzioni. Come icona di sontuosità è evocato, assieme ad altri perso-naggi simbolici, dallo stesso Verlaine (Rassegnazione, in Poesie saturnine,1-3): «Bambino, andavo sognando Ko-Hinnor, / sontuosità persiana e papale,/ Eliogabalo e Sardanapalo!»;14 analogamente nel Ritratto di Dorian Grey diWilde (1891) Eliogabalo compare, con altri imperatori “corrotti”, tra le figu-re a cui si ispira l’eroe di un romanzo alla moda (il misterioso Yellow book)che Dorian, a sua volta, elegge come modello di vita:
novello Caligola,aveva gozzovigliato con i fantini dalle tuniche verdi,nelle loroscuderie e aveva pranzato in una mangiatoia d’avorio, insieme ad un cavallo
60 I saggi
12 Cfr. K.Vonnegut, La colazione dei campioni, traduzione di A.Veraldi, Milano, Feltrinelli,2005, p. 31; sul senso del riferimento a Eliogabalo, cfr. R. Merrill, Vonnegut’s Breakfast ofChampions:The Conversion of Heliogabalus, in «Critique» 18, 1977, pp. 99-109: 104.13 Del toro di metallo parlano ad esempio Plinio il Vecchio (Storia Naturale 34, 89) e Orosio(Le storie contro i pagani 1, 20, 3); tutte le testimonianze sono raccolte da G. Lippold, PaulysRealencylopädie der classischen Altertumwissenschaft, XIX, 1938, col. 797, s.v. Perilaos 9.14 Cfr. P.Verlaine, Poesie e prose, a cura di D. Grange Fiori, Milano, Mondadori, 1992, pp. 26(Rassegnazione) e 376 (Languore).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 60
dal frontale ingemmato. Come Domiziano, aveva errato in un corridoio daimuri di marmo politi come specchi, cercando con lo sguardo il riflesso delladaga che doveva por fine ai suoi giorni, ammalato di quella noia, di quel tae-dium terribile castigo di quelli cui la vita nulla nega [...] come Eliogabalo,aveva imbellettato il viso, e con le donne aveva filato la lana, e aveva traspor-tato la Luna da Cartagine per unirla in matrimonio mistico col Sole.15
Rispetto agli imperatori a cui è accostato, Eliogabalo si distingue qui perl’ambiguità sessuale e il misticismo.D’Annunzio nel suo Libro segreto rievocherà ancora una volta, ma conuna connotazione decisamente positiva, lo sfarzo della «via lastricata dimarmo laconico e di porfido da Eliogabalo»;16 ma l’esempio più significa-tivo e organico della rivalutazione decadentista di Eliogabalo rimane laraccolta di poesie Algabal, di Stefan George (1892). L’opera è dedicata aLudovico II di Baviera, il re esteta che George percepisce come affine a séper creatività e stravaganza;Algabal è detto «fratello minore» di Ludovico,sia perché (come sottolinea la Bornmann nel commento alla dedica17)«Eliogabalo morì diciottenne – l’età vissuta lo fissa dunque come giovi-netto rispetto al quarantunenne Ludovico – sia perché nella prodigalità,nella smisurata fantasia creatrice, nell’isolamento e nella determinazionead abbandonare volontariamente la vita, il re bavarese appare come un fra-tello maggiore più forte e deciso». Significativa la scelta di Algabal, unaforma non attestata del nome di Eliogabalo, dovuta, come spiega lo stessoGeorge, a esigenze puramente eufoniche: Algabal suona più armoniosoall’orecchio del poeta. Lo stesso approccio estetizzante viene adottato daGeorge nella selezione del materiale offerto dalle fonti antiche (Erodiano,Cassio Dione, ma soprattutto Lampridio), a lui ben note: i tratti più volga-ri e degradanti, come la dipendenza dalla madre e dalla nonna, la mortenella cloaca,vengono trascurati,mentre l’accento cade sulla passione este-tica e sul misticismo. Algabal è dunque l’ennesima incarnazione dell’este-ta decadente, sulla scia del Des Esseintes di Huysmans, di cui condivide ilgusto per il lusso, per l’artificio e per la bellezza: in Giorni «porta unaveste serica turchina / disseminata di agate e zaffiri / baccellata d’argentointorno ai bordi; / ma le braccia non ornano monili»; trascorre il suo tempoin «sale fastose», che il poeta rievoca recuperando dettagli dalle fonti anti-che. George segue gli storici antichi anche nel fare di Algabal un sacer-dote, più che un sovrano; divenuto imperatore, egli rimpiange l’infanzia inSiria,quando poteva dedicarsi esclusivamente al culto divino: «giorni gran-di, quando il mio spirito imperava, / giorno infausto quando i templi ripu-diai della mia patria» (Die Andenken). Nella dedizione di Algabal al culto
61Francesco Citti, Lucia Pasetti
15 O.Wilde, Il ritratto di Dorian Grey, traduzione di R.Calzini,Milano,Mondadori, 1982,cap.IX, p. 187.16 G. D’Annunzio, Prose di ricerca, di lotta, di comando e di conquista, Milano, Mondado-ri, 1950, II vol., p. 172.17 S. George, Algabal, a cura di B. M. Bornmann, Firenze, Le Lettere, 2003, p. 62.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 61
pagano del Sole, presentato come una sorta di religione del Bello, che sipone al di là dell’Umano, George manifesta l’influenza di Nietzsche, inpolemica con il cristianesimo e la morale tradizionale.In un simile orizzonte si attua prevedibilmente la totale rimozione dellamorte nella cloaca, episodio assai poco funzionale alla rivalutazione este-tizzante del personaggio.
4. L’imperatore anarchico
Eccoci giunti al Novecento, un secolo che offre numerosi e interessantiesempi delle oscillazioni a cui la figura di Eliogabalo è soggetta con il varia-re delle coordinate culturali: il percorso proposto qui è necessariamentescorciato e selettivo.18 È prevedibile che un personaggio del genere nonpotesse suscitare alcuna simpatia nella cultura di regime del Ventenniofascista. La condanna del degenerato Eliogabalo è inappellabile nella intro-duzione di Cristina Agosti-Garosci a una traduzione dell’Iridione diZygmunt Krasinski datata 1926 e aperta da una solenne dedica al «Duced’Italia».19 L’Iridione, pubblicato nel 1836, è un dramma patriottico in cuiil polacco Krasinski offre un’immagine degradata della Roma tardo impe-riale paragonandola implicitamente al potente impero russo, oppressoredella Polonia. Nell’opera Eliogabalo compare solo in alcune scene, ogget-to inconsapevole di un complotto ordito dal protagonista Iridione, chedesidera così vendicare la sua patria, la Grecia, da secoli oppressa dallapotenza romana. Nella sua Introduzione la Garosci (p. 26) descrive inquesti termini l’Eliogabalo di Krasinski:
La figura di Eliogabalo è mirabilmente scelta a rappresentare la decrepitezzae la corruzione dell’impero.Egli non è un romano,è uno straniero,nato sottoil cielo ardente dell’Asia, nutrito del molle e osceno culto di Mitra; è un fan-ciullo con istinti di vegliardo, non ha passioni, ma solo curiosità, il vuotomortale del suo spirito è illuminato dal fuoco fatuo della lascivia.Al suo fian-co consiglieri venali, sacerdoti dei misteri orientali, buffoni [...] pretorianiimbelli mirabilmente completano il quadro della decadenza dell’impero.
Appena una decina di anni dopo, nel 1934, esce in Francia l’Eliogabalo diArtaud.20 L’opera, che si colloca tra il saggio biografico e il romanzo stori-
62 I saggi
18 Molteplici e trasversali a diversi generi, gli esempi della fortuna di Eliogabalo nel Nove-cento: ci limiteremo a ricordare il romanzo storico di Louis Couperus, De Berg van Licht(1905), l’opera musicale Héliogabale (1910) di Déodat de Séverac, il dramma satirico Helio-gabalus, a Buffoonery in Three Acts, di Henri Louis Mencken - George Jean Nathan (1920),l’“allegoria per musica” Heliogabalus imperator di Hans-Werner Henzes (1972) e il ballettoPhaidra/Heliogabalus di Sylvano Bussotti (1981).19 Z. Krasinski, Iridione, traduzione di C. Garosci, introduzione di C. Agosti-Garosci, Roma,Colombo, 1926.20 A.Artaud,Eliogabalo o l’anarchico incoronato, a cura di A.Galvano,Milano,Adelphi,1991.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 62
co, esprime tutta l’insofferenza dell’autore per la cultura francese e per laciviltà europea contemporanea. Si tratta di una radicale rivalutazione diEliogabalo, che non esclude, ma anzi enfatizza polemicamente tutti i trattisgradevoli e degradati evitati dagli esteti del decadentismo. L’analisi vera epropria della vita di Eliogabalo è presentata nel capitolo III, L’Anarchia, apartire dalle fonti, in particolare da Lampridio: questi ricorda che Elioga-balo a Roma (la traduzione è di Artaud, molto vicina all’originale) «si com-piaceva [...] di far rappresentare la favola di Paride; egli stesso vi interpre-tava il ruolo di Venere, e lasciando improvvisamente cadere sino ai piedile vesti, interamente nudo, una mano sul seno, l’altra sui genitali, s’ingi-nocchiava, e, sollevato il posteriore, lo offriva ai compagni di corruzione»(pp.107-108). In Lampridio Artaud coglie non tanto una intonazione mora-listica, quanto piuttosto il timore della dissacrazione: «per Lampridio, que-sta rappresentazione al naturale e davanti a centomila persone della favo-la di Venere e di Paride, con lo stato febbrile ch’essa crea, coi miraggi chesuscita, è un esempio d’anarchia pericolosa, è la poesia e il teatro posti sulpiano della realtà più veridica» (p. 108). In realtà, l’apparente contraddi-zione con leggi e costumi romani, «quell’esempio di anarchia che consisteper un imperatore romano, nel prendere il vestito di un altro paese, e perun uomo nell’indossare abiti femminili [...], quel che è anarchico dalpunto di vista romano, è per Eliogabalo la fedeltà a un ordine» (p. 109),risponde alle leggi della religione cui è iniziato.«Io vedo in Eliogabalo» – continua Artaud – «non un pazzo, ma un insorto:1) contro l’anarchia politeistica romana; 2) contro la monarchia romana[...] in lui le due ribellioni, le due insurrezioni si fondono, esse dirigonotutto il suo comportamento, esse comandano tutte le sue azioni sino allepiù infime durante il suo regno di quattro anni» (p. 116).Accanto ad unaideologia che potremmo definire “democratica” perché «il popolo non èmai sfiorato, mai toccato dalla sua tirannia sanguinaria» (p. 123), in lui simanifesta soprattutto un gusto poetico per la sistematica dismisura, teo-rizzata a rischio della propria vita. Una vita che infatti si conclude nelmodo più orribile, come risulta evidente dal tragico racconto di Artaud,assieme riscrittura e commento della narrazione di Lampridio: «Il Tevere ètroppo lontano. I soldati troppo vicini. Eliogabalo, folle di paura, si getta aun tratto nelle latrine, si tuffa fra gli escrementi. È la fine. La truppa, che loha visto lo raggiunge; e già i suoi stessi pretoriani lo afferrano per i capel-li. È una scena da macello, uno scempio ripugnante, un antico quadro dimattatoio. Gli escrementi si mescolano al sangue, scivolano a un tempocol sangue sulle spade che frugano nelle carni di Eliogabalo e di suamadre. Poi si traggono i loro corpi [...] una folla immensa marcia verso illungofiume [...] “Alle fogne” urla ora il popolino che ha approfittato delleliberalità di Eliogabalo, ma che le ha troppo ben digerite.“Alle fogne i duecadaveri, il cadavere d’Eliogabalo, alle fogne!”. Dopo essersi ben rimpinza-ta di sangue [...] la truppa cerca di far passare il corpo d’Eliogabalo nellaprima bocca di fogna in cui si imbatte. Ma benché sia sottile, è tuttavia
63Francesco Citti, Lucia Pasetti
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 63
troppo largo. Bisogna provvedere» (p. 129). Limato e piallato, il cadavereviene infine gettato nel Tevere; nel commento conclusivo all’episodio,Artaud ristabilisce il nesso tra la vita e la morte di Eliogabalo, ma – dan-done una lettura di segno opposto rispetto a quella tradizionale – sull’a-nalogia fa prevalere l’antitesi: «Così finisce Eliogabalo, senza epitaffio esenza tomba, ma con dei funerali atroci. È morto vilmente, ma in stato diaperta ribellione;e una simile vita,coronata da una tale morte,non ha biso-gno, mi pare, di conclusione» (p. 130).
5. Super-Eliogabalo
La rilettura di Artaud rappresenta un punto di riferimento imprescindibileper la fortuna che Eliogabalo conosce nel secondo Novecento, segnatodalle esperienze della Neoavanguardia e quindi dall’esplosione del Post-moderno. Una tappa obbligata è, a questo punto, il Super-Eliogabalo diAlberto Arbasino.21 Composto nel «fatale ’68» e pubblicato nel 1969, ilromanzo sfrutta tutte le risorse formali dell’avanguardia (dalle «parole inlibertà», ai calligrammi, dalla citazione, al catalogo, alla filastrocca), spin-gendo all’estremo la mescolanza tra i generi.La narrazione si frantuma cosìin una successione di lunghi frammenti: dal corteo iniziale che accompa-gna Eliogabalo nel suo week-end a Ostia, fino all’apoteosi finale, in cui l’im-peratore diventa dio a sorpresa compiendo anche buffi miracoli.Arbasinopropone, come dice egli stesso, «una sfrenata performance contro ognioppressione e repressione razionalistica, politica, culturale e scientifica».Trasgressivo e ostentatamente kitsch, il suo Eliogabalo è consapevole dellesue passate incarnazioni letterarie, più volte rievocate esplicitamente, apartire da Artaud, che rimane il modello fondamentale («Eliogabalo perArtaud è il Metternich dell’anarchia, il Pompidou del disordine, è unMachiavelli beatle che propone con strumenti sacrosanti e sistematici diper-sov-vertire ogni gerarchia sacrosanta di valori grecoromani sclerosati»,p. 47); rispetto ad Artaud, tuttavia,Arbasino sembra enfatizzare la dimen-sione ludica, in linea con le tendenze della neoavanguardia. Si tratta di unanticlassicismo ironico che affiora chiaramente nel rapporto con le fontiantiche; infatti,oltre ad Artaud, l’Eliogabalo di Arbasino legge gli storici cheparlano (o meglio, sparlano) di lui:Cassio Dione,Erodiano e Lampridio, suiquali emette a sua volta giudizi impietosi: «quel Dione maldicente [...]però sempre meglio (forse) che l’insulso Lampridio o l’ottuso Erodiano»(p. 111) (quest’ultimo è altrove definito «una serva»). Lampridio, il «redat-tore gossip della Historia Augusta», viene letto «come se fosse un roto-calco dal parrucchiere»:per riderne (mentre legge, l’imperatore «ride,ride,
64 I saggi
21 A. Arbasino, Super-Eliogabalo, Milano, Adelphi, 2001. Arbasino è tornato sul tema anchenelle raccolte poetiche Rap, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 107 (Le rose di Eliogabalo) e Rap 2,Milano, Feltrinelli, 2002, p. 71 (Historia Augusta).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 64
ride continuamente», p. 65); ma alla fine Eliogabalo se ne stanca e lo gettain un fosso con un giudizio sprezzante («Difettoso centone mirante a com-piacere i più abborracciati mercati elisabettiani e antifascisti.Ma con cadu-te inconsce e scadenti nel poverismo più stracciaculo»,p.98).Va detto chedi tutti e tre gli storici sono riportati ampi stralci, di cui lo stesso Arbasinofornisce una traduzione irriverente, caricando di ironia il tono moralisticodell’originale: per coglierne il tenore basta qualche breve passo, ad esem-pio quello, tratto dall’epitome di Cassio Dione (80, 16, 1-2), in cui è rievo-cata la figura di Aurelio Zotico, amante plebeo di Eliogabalo; eccone la ver-sione di Arbasino (p. 116): «Questo Aurelio non soltanto aveva un corpotutto bello, facendo dell’atletica, ma in particolare superava enormementechiunque altro per la grossezza dei suoi organi. Questa circostanza fu rife-rita all’Imperatore dai suoi agenti sempre all’erta per tali Grandi Organi, ecosì l’uomo fu immediatamente sottratto all’atletica e spedito a Roma». E,poco oltre: «Appena lo vide, Eliogabalo balzò in piedi a tempo di musica,e non appena Aurelio lo salutò con la formula di rito,“K?rie Autokràtor,Kaîre”(Salve,Signor Imperatore),piegò il collo per assumere una posa gra-ziosa e civettuola, e buttandogli addosso gli occhi ardenti gli rispose senzaesitazione,“Mé me lège K?rion; egò gàr K?ria eimì” (Non chiamarmi signo-re, sono una Signora, come nelle riviste!)». La sottolineatura ironica è otte-nuta grazie a pochi, ma accorti espedienti: il più evidente è l’esplicitazio-ne di elementi che il testo greco sottintende, come il riferimento ai «Gran-di Organi» (con uso enfatico della maiuscola), dissimulati nell’originale daun pronome neutro (una traduzione più “fedele” suonerebbe: «questa cir-costanza fu riferita all’Imperatore da coloro che erano alla ricerca di talicose»); l’ironia si fa ancora più marcata nella descrizione dell’atteggiamen-to di Eliogabalo: mentre nell’originale l’accento cade, non senza disprez-zo, sull’effeminatezza del personaggio (evidenziata dall’uso del verbogynaikízo, «mi comporto da donna»), nella traduzione la «posa graziosa ecivettuola» suggerisce, con un voluto e divertito anacronismo, l’atmosferadella rivista, esplicitamente rievocata nella traduzione dal greco dellarisposta di Eliogabalo («come nelle riviste!»): una deviazione dalla tradu-zione, da cui risulta più che mai evidente la completa assimilazione deltesto antico nel tessuto del romanzo.Tra i diversi brani ripresi dagli stori-ci antichi non mancano i resoconti della morte di Eliogabalo, sia nella ver-sione di Lampridio, sia in quella di Erodiano.Anche qui sono presenti sot-tolineature ironiche: ad esempio in Lampridio i «fatti della sua vita» (quaesub eo facta videbantur) diventano «cosacce», ma soprattutto la rievoca-zione dell’episodio della cloaca («Fra tutti gli imperatori fu l’unico a venirtrascinato e gettato in una fogna») è oggetto di aperta contestazione daparte del personaggio-lettore: piccato di essere considerato l’unico adaver subito una simile sorte, Eliogabalo commenta: «Con tanti saluti allaVita di Cola di Rienzo e buonanotte all’Edoardo II di Marlowe?» (p. 94).Più brusca la reazione all’analogo racconto di Erodiano: «Basta. Storiogra-fia di destra. Butta via tutto» (p. 120). In effetti al Super-Eliogabalo di Arba-
65Francesco Citti, Lucia Pasetti
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 65
sino tocca una fine ben diversa:vittima in un complotto ordito dal suo pre-cettore in un Tempio del tutto simile a un enorme centro commerciale,muore aggredito da due aquile e viene immediatamente divinizzato: «Lafine spettacolare di Eliogabalo provoca scroscianti applausi a scena aper-ta, innumerevoli chiamate,richieste di bis,e trambusti religiosi sublimi constanding ovations». La paradossale apoteosi di questo Eliogabalo lettera-rio sembra voler riscattare la morte degradante dell’Eliogabalo storico.
6. Intervista dalla Cloaca Massima
Nella linea di Artaud e Arbasino si inserisce anche un altro testo contem-poraneo: si tratta di una delle Interviste impossibili mandate in onda daRadio Rai a metà degli anni Settanta e recentemente ripubblicate in volu-me.22 Tra gli illustri personaggi, storici o letterari, intervistati da protago-nisti della cultura contemporanea,compare anche Eliogabalo, interpretatoper l’occasione da Paolo Poli; l’intervistatore, nonché autore del dialogo, èLuigi Malerba. L’incontro, trasmesso per radio il 12 aprile 1975, si svolgenella Cloaca Massima e si apre significativamente con una scherzosa riva-lutazione del luogo associato alla fine dell’imperatore (p. 160):
Malerba:“È la prima volta che mi trovo di fronte a un imperatore, anche se illuogo scelto per l’incontro non è precisamente una reggia, e certo il menoadatto a ospitare chi porta un nome come il vostro: Eliogabalo. È lo stessonome del vostro dio Sole adorato nella lontana Siria”.Eliogabalo:“Vuol dire che si trova a disagio in una fogna? Ma si tratta dellaCloaca massima!”.Malerba:“Capisco, ma è sempre una fogna. Strano luogo per incontrare unimperatore che porta il nome del dio Sole”.Eliogabalo:“Dal momento che sono stato condannato alle fogne, ho sceltoper il nostro incontro la più bella e nobile fogna del mondo, un capolavorodi architettura e di ingegneria idraulica, un’opera stupenda costruita nellagrande epoca repubblicana”.
Eliogabalo si presenta dunque come un imperatore filo-repubblicano, uninnovatore incompreso, portatore di «una strategia nuova» che – natural-mente – è stata fraintesa da «storici illustri e spregiudicati», a cominciareda Lampridio. Egli dichiara infatti (p. 162):
Dal momento che non riuscivo a conquistare l’impero romano e a mutarneil volto per mezzo della religione, cercai di metterlo in crisi dall’interno e diaccelerare quel processo di dissoluzione che era già avviato da almeno unsecolo. Credete di averla inventata voi la contestazione! Il primo contestato-re del potere sono stato io e la mia contestazione l’ho fatta da solo, appro-
66 I saggi
22 L.Tavolini (a cura di), Le interviste impossibili: ottantadue incontri d’autore messi inonda da Radio Rai (1974-1975), Roma, Radio Rai-Donzelli, 2006.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 66
fittando di una posizione di privilegio quale è il seggio imperiale. Sono cer-tamente il primo imperatore, romano o non romano, che abbia perseguitoun disegno politico così rivoluzionario con perfetta coscienza e una lucidavisione del futuro. Nessuno più facilmente del nocchiero può mandare afondo la nave.
Contestatore e rivoluzionario, l’Eliogabalo di Malerba è in sintonia con ipersonaggi di Artaud e di Arbasino, che mostra di conoscere e di apprez-zare, ma rispetto ai quali manifesta una più solida coscienza politica eideologica; infatti quando gli viene chiesto se conosce l’Eliogabalo diArtaud, risponde (pp. 163-164):
Certamente, l’ho letto varie volte. E conosco anche il Supereliogabalo diArbasino, se è per questo.Tutti e due questi libri in modo diverso si sonoavvicinati alla verità assai più dei libri di storia che sono stati scritti sul perio-do del mio impero. Il fatto sorprendente è che gli storici si sono accostati almio personaggio con indignazione moralistica,mentre gli scrittori mi hannoavvicinato con simpatia o almeno con interesse umano. Artaud, da buonuomo di teatro, ha messo in evidenza il lato teatrale, rituale e religioso delmio comportamento, ma ha dimenticato la finalità politica che lo muovevadall’interno.Arbasino si è servito del mio personaggio per sostenere una suasofisticata idea della decadenza, anche questa più letteraria che politica. Madevo riconoscere, sia nel caso di Artaud che in quello di Arbasino, una novi-tà rispetto ai testi degli storici: sia l’uno che l’altro riconoscono come dietrole mie follie non ci sia un folle, ma un uomo.
L’Eliogabalo ideologizzato di Malerba rivendica la scelta dello scandalocome gesto politico per scuotere Roma dalla corruzione – con un chiaroriferimento anche all’attualità. Lo scandalo era la via più breve per fare«esplodere le contraddizioni di quel sistema autoritario che, con la scusadi portare la civiltà e la pace romana alle popolazioni barbare, avevamosso guerre di conquista contro nazioni inermi, commettendo effera-tezze innominabili e i più turpi genocidi». Una civiltà, amministrata in real-tà da «una masnada di gente avida e crapulona, grassi mercanti, militariottusi, governanti corrotti e famelici» (p. 165). L’intento di Eliogabalosarebbe dunque di trasformare l’impero «in una repubblica democraticaalla maniera dell’antica Grecia, non alla maniera in cui intendete la demo-crazia voi posteri» (p. 167).Da cattivo imperatore a sostenitore della democrazia diretta: non confor-me al modello antico di buon imperatore romano, Eliogabalo finisce perintegrarsi bene in quello moderno di contestatore del sistema.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6citti.htm.
67Francesco Citti, Lucia Pasetti
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 67
Corpus loquens. Marchi, ferite e tatuaggi in Grecia anticaFederico Condello
1. Corpo che scrive, corpo inscritto
Una sorta di risalita al corporeo» – confessava Barthes nelle sue Variationssur l’écriture: e il termine «risalita» (remontée) non è senza rilievo – puòsuscitare nel semiologo un’improvvisa diversione, che conduce dall’acce-zione metaforica della scrittura verso «l’aspetto “manuale” del termine [...],la scription (l’atto muscolare d’articolare scrittura, di tracciare delle lettere)[...]: quel gesto con il quale la mano impugna uno strumento – punzone,calamo, penna, – l’appoggia su una superficie, vi avanza premendo o carez-zando, e traccia forme regolari, ricorrenti, ritmate (non occorre dir di più:non si parla necessariamente di “segni”).1
Dovrà stupire, una simile diversione? Che lo stile non sia solo affare digusto o questione lato sensu letteraria – che lo stile, a conti fatti,“punga”o per lo meno “interpunga”, nella misura in cui esso pone inevitabilmen-te, e per differentiam, una questione d’identità o addirittura di singolarità– è assunto cui non guida tanto la facile etimologia («punzone, calamo,penna») quanto la riflessione che, sulla scorta di Nietzsche, hanno con-dotto gli Sproni di Derrida:2 lo “stile” – o, se vogliamo, la metaforica écri-ture del primo Barthes, con un traslato che ancora non conosceva «risali-ta al corporeo»3 – apre in questo senso il campo della pura differenza,della “spaziatura” che, situandosi a monte di ogni linguaggio convenuto,fonda il campo stesso della segnicità: tematiche note, dacché vige il post-moderno, e non è il caso di insistervi troppo. Stupisce allora che una simi-le diversione coinvolga il corpo, lo invochi dappresso come un’entità chetrascende la stessa nozione di «segno», ormai notoriamente esposta a
68 I saggi
6
1 R. Barthes, Variazioni sulla scrittura, seguite da Il piacere del testo,Torino, Einaudi, 1999,p. 5. Riproduco l’originale scription, dove l’ottima traduzione di C. Ossola preferisce tentareun’audace «impennatura». Quanto a «risalita» (remontée), sin dalla scelta terminologica Bar-thes sembra evocare un autentico “mito della caverna” a rovescio; il che si spiega, mi pare,con il sostrato lacaniano della riflessione qui condotta: cfr. infra.2 J. Derrida, Sproni. Gli stili di Nietzsche, Milano, Adelphi, 1991. Sul tema si veda anche lasolenne ouverture di J. Lacan, Scritti,Torino, Einaudi, 1974, pp. 6 ss., a commento del buffo-niano «lo stile è l’uomo».3 Cfr. R. Barthes, Il grado zero della scrittura,Torino, Einaudi, 1982; sui rapporti fra il primoBarthes (la stagione “semiologica”) e le più tarde tematiche relative al plaisir e alla jouis-sance testuali – che danno per assimilata la lezione lacaniana – cfr. per es. S. Heath, Vertigedu déplacement. Lecture de Barthes, Paris, Fayard, 1974, in part. pp. 149-176; si veda inoltreA. Lavers, Roland Barthes. Structuralism and After, London, Methuen, 1982.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 68
sospetti di spiritualismo?4 Lungi dal costituire una tardiva concessione alleragioni del corporeo, inteso come asemantico o presemantico, la rifles-sione dell’ultimo Barthes configura piuttosto – ben più che in filigrana –una radicale simbolizzazione del corpo (scrivente o meno) che va di paripasso con una marcata declinazione sensuale della stessa écriture; e sequest’ultima sembra perdere la sua identità metaforica, è solo per recupe-rarla, a un livello ancor più fondamentale, quale marca o traccia simbolicache segna il registro corporeo sin dalla sua stessa costituzione: cadenzadella mano scrivente, interpunzione del ritmo,corporeità dello stilus e deisupporti che ad esso oppongono una variabile, ma tangibile, resistenza.Il corpo che Barthes eleva a soggetto dell’écriture è evidentemente uncorpo che il simbolico5 ha già assoggettato: un corpo sul quale esso ha giàiscritto – in termini di regole,misure, tempi – una traccia indelebile.È que-sto il corpo della riflessione lacaniana, il corps morcelé («corpo a fram-menti») che la storia tortuosa del soggetto conduce a precaria unità: frut-to di una «anatomia fantasmatica»,6 di una mappatura immaginaria e di unalenta costruzione simbolica;7 e proprio del “corpo scrivente” Barthes sot-tolinea il fondamento disciplinare e coercitivo («dal momento che prolun-ga il corpo, la scrittura comporta inevitabilmente un’etica»)8, sicché esso èancora, se si vuole, il corpo degli amanuensi, la cui testimonianza si affidaalle querimonie così frequentemente registrate nelle subscriptiones appo-ste in calce ai nostri codici: tres digiti scribunt, totum corpus laborat.9
Il corpo che scrive è dunque, sin dal principio,un corpo iscritto:un corpomarchiato dalla “lettera” del simbolico.10 Che dire, dunque, di un corpoche a tale iscrizione – a tale lettera – dia una parvenza di realtà, al puntodi prendere, per così dire, la lettera alla lettera? Solo qualche spunto, nellepagine a seguire, su un tema che attende ancora una trattazione organica;e che qui si inquadra provvisoriamente a partire da uno sguardo privile-
69Federico Condello
4 Cfr.per es. J.Derrida,Della grammatologia,Milano, Jaka Book,1969,pp.49-108; la più nettaesposizione del tema è in Id., Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione, Verona,Ombre Corte, 1999, pp. 27-34; ma si veda anche l’ormai classico J. Culler, Sulla decostruzio-ne, Milano, Bompiani, 1988, pp. 81-100.5 Per la nozione di «simbolico» cfr. J. Lacan, Scritti, cit., index s.v. «ordine simbolico».6 Lacan, Scritti, cit., p. 91.7 Su questi temi cfr. da ultimo A. Zenoni, Il corpo e il linguaggio nella psicoanalisi, Milano,Bruno Mondadori, 1999, in part. pp. 102-137; si veda anche M. Combi, Corpo e tecnologie.Simbolismi, rappresentazioni e immaginari, Roma, Meltemi, 2000, pp. 47-61. Una sintesioriginale della posizione lacaniana si può leggere in J.-D. Nasio, Cinque lezioni sulla teoriadi Lacan, Roma, Editori Riuniti, 1998, pp. 127-134.8 R. Barthes, Variazioni..., cit., p. 54 (e più ampiamente pp. 53-55).9 Motivo ricorrente, per cui cfr. e.g. British Library, ms. Harley 3013 (ASMMF 272), f. 96r. Ingenerale sulle subscriptiones e sulle loro forme, si può vedere ora la ricca raccolta di con-tributi offerti da E. Condello e G. De Gregorio (a cura di), Scribi e colofoni. Le sottoscrizionidi copisti dalle origini all’avvento della stampa, «Atti del seminario di Erice. X Colloquiodel Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993)», Spoleto, Centro Studisull’Alto Medioevo, 1995.10 Su «lettera» e «simbolico», cfr. ancora Lacan, Scritti, cit., pp. 29-30, 57-58, 265-269, e ora Id.,Dei nomi del padre, seguito da Il trionfo della religione.Testi riuniti da J.-A. Miller,Torino,Einaudi, 2006, pp. 5-32.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 69
giato: lo sguardo dei Greci, che del corpo – e della scrittura come noi laintendiamo – passano spesso per inventori.
2. Totem e Tattoo: il corpo dei barbari
«Il miglior modo di testimoniare a se stessi e agli altri che si fa parte delmedesimo gruppo, è di imprimersi sul corpo una medesima marca didistinzione» – osservava il Durkheim delle Formes élémentaires.11 I paral-leli etnologici, inutile dirlo, si sprecano: e per i cultori dell’anthropologiedu proche,una cospicua letteratura psicologica e sociologica – non di radosospesa fra paternalismo e giovanilismo – sopperisce al bisogno di docu-menti contemporanei.12 Il tatuaggio, il branding, il body-painting – non siperde occasione di ribadire – sono innanzitutto marchi d’identità, crismid’appartenenza, in ogni senso “iscrizioni”: a un gruppo (magari ideale) esulla propria pelle (per convenzione reale).13 Ma ciò che all’interno delgruppo è segno di adesione e di coesione, non potrebbe che essere, agliocchi dell’estraneo, marca di estraneità: ecco allora che la cultura europeamoderna – quella cultura che sulla “bella semplicità” del corpo nudo hacostruito, e ben prima di Winckelmann, uno dei suoi più saldi idola esteti-ci14 – individua nella pelle iscritta e tatuata dei selvaggi un discrimine (uncrimen) tra i più vistosi.È l’immagine che restituisce,per esempio, lo sguar-do del Ramusio, quando nei suoi Viaggi di Marco Polo (II 46) descrive gli
70 I saggi
11 E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Milano, Edizioni di Comunita,19823, p. 380.12 Per un’antropologia del tatuaggio, si veda la sistemazione fornita da J.T. Maertens, Le des-sin sur la peau, Paris,Aubier, 1978,e più recentemente C.R. Sanders,Customizing the Body.The Art and Culture of Tattooing, Philadelphia,Temple University Press, 1989 (con partico-lare attenzione alle sub-culture contemporanee) e A. Gell, Wrapping the Images. Tattooingin Polynesia, Oxford, University Press, 1993, pp. 1-39; per un approccio psicosociologico (opsicopatologico) al fenomeno del tatuaggio nelle società occidentali contemporanee si pos-sono consultare, fra i tanti altri,A. Castellani, Ribelli per la pelle. Storia e cultura dei tatuag-gi, Genova, Costa & Nolan, 1995;A. M. Casadei, Psicologia del tatuaggio, Imola, La Mandra-gora, 1997; M. Castellano, S. Della Giovanpaola, Il tatuaggio: moda o bisogno di identità?, in«Attualità in psicologia», II, 1998, pp. 209-218; G. Pietropoli Chermet,A. Marcazzan, Piercinge tatuaggio: manipolazioni del corpo in adolescenza, Milano, Franco Angeli, 2000. Per unariflessione critica sulla cosiddetta anthropologie du proche, cfr. per es. M.Augé, Nonluoghi.Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1993, pp. 13-42.13 Tale prospettiva rischia però di appiattire su una facile vulgata sociologica la ricca feno-menologia (e la probabile sovradeterminazione) che emerge invece dalla letteratura antro-pologica: cfr. per es. O. Konig, Pelle, in Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, acura di A. Borsari, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 438-447; si veda inoltre – per gli aspet-ti della somatografia più difficilmente riducibili a messaggi identitari – D.Anzieu, L’io-pelle,Roma, Borla, 1987.14 Sul tema è da vedere M.Warnke, Il bello e il naturale. Un incontro letale, in I Greci. Sto-ria, cultura, arte, società, I. Noi e i Greci,Torino, Einaudi, 1996, pp. 343-368. Per un paginawinckelmanniana esemplare, cfr. Storia dell’arte nell’antichità, Milano, SE, 1990, pp. 118-19.Per un caricaturale ribaltamento del canone, R. Strassoldo, Sade trionfante o il corpo nel-l’arte contemporanea, in Corpo futuro. Il corpo umano fra tecnologie, comunicazione emoda, a cura di L. Fortunati et al., Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 74-86, con bibliografia.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 70
abitanti della «provincia di Cangigù» precisando che essi, «così uominicome donne,hanno tutto il corpo dipinto di diverse sorti d’animali e uccel-li, perché vi sono maestri che non fanno altr’arte se non con un’agucchiadi designarle, o sopra il volto, mani, gambe e ventre, e vi mettono colornegro, che mai per acqua over altro può levarsi via: e quella femina overouomo che n’ha più di dette figure è riputato più bello». Era del resto già losguardo dei viaggiatori europei che nel XV secolo visitarono la Birmania(in primis Nicolò de’ Conti)15, e sarà ancora quello di James Cook – redu-ce da Tahiti nel 177116 – quello attribuito da Melville al suo Ismaele – ilritratto indimenticabile di Quiqueg17 – quello di Cesare Lombroso – infles-sibile esploratore delle carceri italiane sul finire dell’Ottocento18 – e finan-che quello di alcuni ispirati censori contemporanei.19
Ma qual era lo sguardo dell’uomo greco, preteso inventor del “corpo natu-rale”,20 spettatore di un’epifania che avrebbe palesato all’Occidente, in unabbaglio dai riverberi secolari, la nuda bellezza corporale? Le testimonianzeantiche sono univoche e unanimi: il tatuaggio – il corpo iscritto – è cosa daBarbari;ovunque sia questione di segni tratti sulla pelle nuda,siano essi inci-si o dipinti, delebili o indelebili, vergati a pennello, ad ago o a fuoco, si trat-ta sempre di Barbari: ossia, semplicemente, di non-Greci, senza che qualcheulteriore coordinata etnica o geografica aiuti a precisare, in senso diverso
71Federico Condello
15 Cfr. Nicolò de’ Conti, Viaggi in Persia, India e Giava, a cura di M. Longhena, Milano, Edi-zioni Alpes,1929,pp.142-43: «gli maschi et le femine hanno per consuetudine di pugnersi conuno stilo di ferro el corpo, et fannolo di varii colori per modo che sempre stanno dipinti».16 Su Cook è ora da vedere M. Sahlins, Capitan Cook, per esempio. Le Hawaii, gli antropo-logi, i nativi, Roma, Donzelli, 1997, con importanti riflessioni su colonialismo, esotismo eantropologia.17 Cfr. H. Melville, Moby Dick o la Balena, traduzione di C. Pavese, Milano,Adelphi, 1987, p.57: «Quand’ebbe finito si volse e allora, numi del cielo, che spettacolo! Una faccia! Era d’uncolore fosco, rossastro, gialliccio, tutta stampata qua e là di larghi riquadri nerastri. Ecco, èproprio com’io pensavo, un compagno terribile, ha preso parte a una rissa, ha toccato feritespaventose, e ora vien qua, arriva adesso dal chirurgo. Ma in quel momento l’altro capitò avoltare la faccia verso la luce, in modo che vidi benissimo che i riquadri scuri delle guancenon potevano assolutamente essere cerotti. Erano macchie quelle, di qualunque genere fos-sero. Da principio non seppi cosa pensare, ma subito mi si affacciò un sospetto della verità.Ricordai la storia di un bianco, baleniere anche lui, che, capitando fra i cannibali, era statotatuato».18 C.Lombroso,L’uomo delinquente,Milano,Fratelli Bocca,1896 (rist.Roma,Napoleone,1971).19 «Tätowieren war früher ein Markenzeichen der Halb- und Unter-welt [...] heute sollte nach-denklich stimmen,daß der Tätowierungsboom einhergeht mit dem Aufblühen einerseits heid-nischer, andererseits esoterischer, okkulter Strömungen [...]. Deshalb sollten Christen vonjeglicher Form der Tätowierung Abstand nehmen»: cito dall’illuministico scritto di A. Seibel,Zeichen der Sklaverei, in «Idea Spektrum», 29, 1998, pp. 7-8.20 La prospettiva resa celebre da B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo,Torino, Einaudi, 1963, pp. 19-47, che data risolutamente a età postomerica l’idea di “corpo”come intero organico e coeso, è stata recentemente ribadita da G. Reale, Corpo, anima, salu-te. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Milano, Cortina, 1999, pp. 15-40. È difficile, tutta-via, sottrarsi alla sensazione che tale approccio presupponga una concezione ancora teleologi-ca e idealistica (ovvero, per dirla con Gramsci,“partenogenetica”): se si ammette l’idea di unafondamentale costituzione simbolica del corpo (cfr. supra), non si vede ragione per attribuiremaggiore o minore “dignità simbolica” a questa o a quella forma del corporeo, disposte lungola linea di uno “sviluppo”, o di una Entdeckung, segretamente e forzatamente gerarchica.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 71
dalla semplice contrapposizione binaria, la matrice culturale o la funzioneparticolare del fenomeno. Ecco allora Erodoto osservare per primo, tra lefonti a noi note, che presso i Traci «l’essere tatuato [estíchthai] è giudicatosegno di nobiltà, mentre è ignobile il non esserlo» (V 6, 2);21 ed ecco Seno-fonte, poco più tardi, testimoniare della stessa pratica presso il popolo deiMossineci (Xen. Anab. V 4, 32), residente sulla costa sud-orientale del MarNero,22 mentre già Aristofane ne aveva parlato come di un tratto antono-mastico dei generici Istrianoí (fr.90 K.-A.)23 e qualche secolo più tardi Stra-bone ne attribuirà l’uso agli Illiri (Strab.VII 5, 4)24, Plinio ai Daci (Plin. NHXXII 2, 1)25, Pomponio Mela agli Agatirsi (Pomp. Mel. II 10)26, Luciano agliAssiri (Lucian. De Syr.Dea 59)27 e lo storico Erodiano ai ben più remoti Bri-tanni (Hdn. III 14,7).28 Che in tanta varietà geografica (e in tanta monotoniaetnologica) i Traci mantengano comunque un ruolo principe, dimostra nonsolo la relativa frequenza delle testimonianze antiche,29 ma anche il fattoche un notevole professionista «tatuatore» (stiktés) sia il Kosis menzionatoin un mimo di Eronda (Herond. 5, 65-66: «manda a chiamare Kosis il tatua-tore con gli aghi e l’inchiostro: in una sola botta diventerai di tutti i colori»):
72 I saggi
21 Traduzione di G. Nenci in Erodoto. Le storie,V. La rivolta della Ionia, Milano, FondazioneL.Valla-Mondadori, 1994, p. 15. Sulle tecniche antiche per la pratica del tatuaggio, e soprat-tutto per la sua cancellazione, qualche informazione si può reperire in Aet. Iatr. lib.VIII 12.22 «Quando [i Greci], a forza di marciare, giunsero in regioni amiche, furono mostrati loro ifigli dei notabili della zona, bambini ingrassati e nutriti con noci bollite: erano obesi, bian-chissimi, poco ci mancava che fossero tanto larghi quanto alti, avevano il torace completa-mente tatuato con fiori variopinti» (trad. di A. Barabino, in Senofonte, Anabasi, Milano, Gar-zanti, 1992, p. 285). Sui Mossineci e sul loro “mondo a rovescio” (specie per quanto concer-ne le abitudini sessuali), cfr. anche Ap. Rh. II 1019 ss.23 L’espressione tà métopa Istrianá è attribuita ad Aristofane lessicografo Esichio, s.v. Istria-ná (i 1033 Latte), che la riferisce, con verosimiglianza, al tatuaggio come uso caratteristicodelle popolazioni Danubiane (quindi afferenti – pur nella genericità del rinvio – al mondotrace: cfr. Kassel-Austin, ad l.).24 «La terra degli Iapodi è povera, ed essi vivono per lo più di grano e di miglio; il loro arma-mento è di tipo celtico; sono tatuati come gli altri Illiri e come i Traci».25 «Osservo che alcuni dei popoli stranieri ricorrono a certe erbe per scopi ornamentali erituali; presso i Barbari le donne si truccano il viso con diverse erbe; e anche i maschi, pres-so i Daci e i Sarmati, tatuano il proprio corpo».26 «Gli Agatirsi si tingono [pingunt] i volti e gli arti, in misura proporzionata al prestigio diciascuno, e comunque tutti con gli stessi segni e in maniera indelebile [sic ut abluinequeant]». Si vedano gli ulteriori paralleli citati da P. Parroni in Pomponii Melae de Choro-graphia libri tres, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984, p. 282.27 «Sono tutti tatuati, alcuni sulle mani, altri sul collo; e perciò tutti gli Assiri portano tatuag-gi [stigmatophoréousini]». Si veda in proposito la ricchissima nota ad l. di J. L. Lightfoot,Lucian. On the Syrian Goddess, Oxford, University Press, 2003, pp. 529-531.28 «[I Britanni] non si preoccupano del fango,poiché vanno col corpo quasi interamente sco-perto: non usano vesti, ma cingono di ferro i fianchi e la gola [...]. Sono soliti tatuarsi la pellecon disegni variopinti, che rappresentano ogni sorta di animali: la ragione per cui non sicoprono è appunto il desiderio di mettere in mostra i tatuaggi» (trad. di F. Càssola. in Erodia-no, Storia dell’impero Romano dopo Marco Aurelio, Firenze, Sansoni, 1967, p. 183)29 Oltre al citato Erodoto, cfr. Clearch. ap.Athen. XII 524d = fr. 46 Wehrli, che attribuisce l’u-sanza del tatuaggio all’originaria marchiatura subita dalle donne di Tracia per opera degliSciti; Cic. De off. II 7, 25; Plut. Mor. 557d;Artemid. I 8; Dio Chrys. Or. 14,19. Si veda inoltre ACommentary on Herodotus, by W.W. How and J.Wells, II, Oxford, Clarendon Press, 19282,pp. 2-3, al cui dossier aggiungerei almeno Dialex. fr. 2, 13 D.-K.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 72
il suo nome – ha puntualizzato Headlam – rinvia appunto all’area bitino-trace.30 Sarà appena il caso di ricordare che pochi popoli come Traci e Scitisi sono prestati, nell’immaginario greco, al gioco identitario del verkehrteWelt, fornendo per quasi ogni tratto culturale ellenico una puntuale e para-dossale assiologia a rovescio, facilmente inquadrabile in termini lotmania-ni:31 sicché, anche a proposito del barbarico “corpo iscritto”, i commenta-tori hanno opportunamente sottolineato il sovvertimento che presiede a talirappresentazioni;32 né un simile rovesciamento dell’imago corporea e dellasua funzione segnica si limita, per ciò che concerne i Barbari, ai soli tatuag-gi: come ha osservato Hartog, nel descrivere i riti funerari che gli Sciti tri-butano al sovrano morto, Erodoto (IV 71)33 stabilisce un’inevitabile com-plementarità fra il silenzio impenetrabile degli astanti e la consuetudine cheimpone loro di graffiare e mutilare i propri corpi: «gli Sciti, benché non ele-vino voce e non articolino parola, in realtà parlano,ma parlano a modo loro,sul loro corpo e attraverso il loro corpo. Mutilandosi, essi iscrivono sul pro-prio corpo la legge scita e fanno del corpo la celebrazione e l’orazione fune-bre del re morto. Il loro corpo, attraverso le sue cicatrici, diventerà memo-ria».34 Se la eusebéia greca dètta prolissi epitafi agli oratori convocati sullapubblica tribuna, e vieta al contempo, almeno sin da Solone, d’incidere sulproprio corpo i segni del lutto35 – ma più di una traccia resterà nella prati-ca del kopetós, ampiamente testimoniata per via letteraria e iconografica –la religiosità dei Barbari si esprime proprio attraverso una scandalosa scrit-tura corporale, fatta d’incisioni e recisioni cruente, che hanno del restoampio riscontro nella pratica funeraria dei nomadi eurasiatici.36
73Federico Condello
30 Herodas. The Mimes and Fragments, with notes by W. Headlam, ed. by A. D. Knox, Cam-bridge, University Press, 1922 (ora London, Bristol Classical Press, 2001, p. 256).31 Si veda in proposito F.Hartog,Lo specchio di Erodoto,Milano, Il Saggiatore,1992,e più recen-temente C. Marcaccini, Il ruolo dei Traci nell’immaginario greco di IV-V sec.a.C. tra storiogra-fia ed iconografia, «RSA» XXV, 1995, pp. 7-53, con ampia documentazione; un’utile panoramicain A.Corcella,Erodoto e l’analogia,Palermo,Sellerio,1984,pp.69-91.Per il tema del “mondo allarovescia” nella cultura antica, cfr. H. Kenner, Das Phänomen der verkehrten Welt in der grie-chisch-römischen Antike, Klagenfurt-Bonn, Kärnten & Habelt, 1970; per l’opposizione cultura /non cultura, cfr. il classico J. M. Lotman,Testo e contesto, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 14 ss.32 Cfr. per es. Nenci in Erodoto, cit., p. 161.33 «Le sepolture dei re si trovano presso i Gerri, là fin dove il Boristene è navigabile.Qui,quan-do il loro re è morto, scavano in terra una grande fossa quadrangolare e, quando l’hannoapprontata, prendono il cadavere (con il corpo coperto di cera, con il ventre aperto e puli-to, riempito di cipero triturato, di incenso, di semi di sedano e di anice, quindi ricucito) e loportano su un carro presso un altro popolo. Quelli che accolgono il cadavere trasportatofanno come gli Sciti reali: si tagliano un pezzo d’orecchio, si radono i capelli tutti intorno, siincidono tutto intorno le braccia, si graffiano la fronte e il naso, si trafiggono con frecce lamano sinistra» (trad. di A. Fraschetti, in Erodoto. Le storie, IV. La Scizia e la Libia, a cura di A.Corcella e S. M. Medaglia, Milano, Fond.Valla-Mondadori, 1993, p. 83).34 F. Hartog, Lo specchio di Erodoto, cit., p. 135.35 Sul lógos epitáphios ateniese cfr. N. Loraux, L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraisonfunèbre dans la Cité classique, Paris, Mouton, 1981. Sulle presunte leggi funerarie di Solonesi vedano le osservazioni di C. Ampolo, Il lusso funerario e la città arcaica, in«AION(archeol)»,VI, 1984, pp. 71-102.36 Cfr.per es.G.Dumézil,Storie degli Sciti,Milano,Rizzoli,1980,p.245,nonché il materiale cita-to da A. Corcella in Erodoto. Le storie, IV, Milano, Fondazione L.Valla-Mondadori, 1993, p. 290.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 73
A tale forma di scrittura corporale – tatuaggio se non autentico scaring –si oppone dunque l’imago illibata del corpo ellenico: illibata sino all’esi-bizione, semplice e orgogliosa,di quella nudità maschile che per i Greci dietà classica fu segno di prestanza atletica e di eroica virilità: un tratto emi-nentemente aristocratico, che le nostre fonti, non a caso, si compiaccionodi contrapporre proprio agli usi dei Barbari.37 Ma il motivo del sovverti-mento assiologico, comunque esso si declini, è davvero uno schema con-cettuale sufficiente a chiarire l’attenzione che i Greci di ogni epoca hannomostrato verso la scandalosa scrittura corporale dei Barbari? L’indicazionerischia di suonare vaga o sbrigativa, se non si precisa che in questo comein altri casi appare evidente come ogni cultura – intesa in una prospettivaidentitaria e quindi, a fortiori, discriminante – non si costituisca semprein opposizione a un’alterità concepita quale “non-cultura” ovvero mera“natura”: la definizione che ogni “cultura” dà di se stessa sembra piuttostoil risultato di una precisa segmentazione condotta entro uno spettro con-tinuo di alterità germinali, che dal minimum della “natura” sale per gradisino al maximum di una “iper-cultura” incontrollata e paradossale; è quiche trova fondamento la possibilità, tante volte esplorata, di una doppia esimultanea antitesi, che segna il luogo immaginario della “cultura” allosnodo fra le opposte estremità del proprio annullamento (la “natura”) edella propria corruzione (l’“iper-cultura”).38 È qui che si articola, fra i
74 I saggi
37 Si veda per es. Hdt. I 10, 3: «presso i Lidi, così come presso quasi tutti i Barbari, farsi vederenudi comporta una grande vergogna, anche per un uomo», con le precisazioni di G. Burzac-chini, Nudità e vergogna presso Lidi e barbari (Hdt. I 10,3), in «Eikasmós», XII, 2001, pp. 85-88, di cui si seguono qui le scelte critico-testuali. Per altri luoghi e per le relative discussionicritiche, cfr. per es. J.A.Arieti,Nudity in Greek Athletics, in «CW», LXVIII, 1975, pp. 431-436; N.B. Crowther, Athletic Dress and Nudity in Greek Athletics, in «Eranos», LXXX, 1982, pp. 163-168; da ultima P.A. Hannah, The Reality of Greek Male Nudity. Looking to African Parallels,in «Scholia»,VII, 1998, pp. 17-40, con acute rettifiche sul tema della nudità eroica, solitamenteintesa quale frutto di idealizzazione artistica o letteraria: ma se davvero il corpo nudo fu real-tà quotidiana prima o più spesso che Idealtypus iconografico, ciò non toglie che, varcata lasoglia della rappresentazione, lo stesso “corpo nudo”si espone al gioco della differenza segni-ca e si assume l’onere (semiotico) della sua “interpretabilità”; le osservazioni della Hannah,utili contro la pruderie di certa critica, non devono perciò fomentare una forma di riduttivorazionalismo o di cattivo empirismo. Per il “corpo” femminile e per la sua concettualizzazioneil discorso è naturalmente diverso: si vedano per es. S. Campese, P. Manuli, G. Sissa, Madremateria. Sociologia e biologia della donna in Grecia,Torino, Boringhieri, 1983.38 Sul valore “iper-culturale” della scrittura corporea, cfr. per es. M. C.Taylor, Skinscapes, inPierced Hearts and True Love, New York, Handy Marks Publications, 1995; T. Maldonado,Corpo: artificializzazione e trasparenza, in Corpo futuro, cit., pp. 25-34. Per converso, unottimo esempio di nostalgica idealizzazione della somatografia “primitiva” si può leggere inU. Galimberti, Il corpo, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 185-86: «da sempre il corpo è superficiedi scrittura, superficie atta a ricevere il testo visibile della legge che la società detta ai proprimembri marchiandoli [...]; marchiando il corpo, [le società arcaiche] lo de-signavano comel’unico spazio degno a portare il segno del gruppo [...];quelle almeno scrivevano la legge sulcorpo, e con quel marchio scongiuravano la legge separata, lontana, dispotica, la legge che,articolandosi nel rapporto comando-obbedienza,conosce solo il potere coercitivo [...]. Il suomodo di dominare, infatti, non è nell’imporre un segno, come facevano i primitivi col mar-chio, ma nello svuotare di senso tutti i simboli a cui il corpo, nella sua originaria ambivalen-za, potrebbe dare espressione»; un’opposizione che – se degna di sussistere – potrebbe sem-mai essere inquadrata in termini di “biopolitica” foucaultiana: dove il potere non “svuota” il
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 74
tanti, il discorso ideologico dell’esotismo, semplice rovescio di un’alteritàche si dà tanto per difetto quanto per eccesso:39 nel caso della scritturacorporale barbarica – come poi avverrà per quella forma legalizzata dibody painting che è la cosmesi femminile40 – siamo evidentementedinanzi a un soggetto ibrido,che da un lato sembra opporsi all’intatta sim-plicitas del corpo ellenico, dall’altra – per il suo carattere cruento – man-tiene comunque forti legami con la sfera della più tradizionale sauvageriedei Barbari, rinnovando il fantasma del “corpo a frammenti” secondoun’ambiguità che Lacan, meglio di altri, evidenzia:
abbiamo qui un rapporto specifico dell’uomo col proprio corpo, che simanifesta anche nella generalità di una serie di pratiche sociali, dai riti deltatuaggio, dell’incisione, della circoncisione nelle società primitive, fino aquella che potremmo chiamare arbitrarietà procustea della moda, in quan-to smentisce nelle società avanzate quel rispetto delle forme naturali delcorpo umano la cui idea nella cultura è tardiva.41
Motivo polisemico, il corpo iscritto che i Greci osservano con malcelatoraccapriccio sortisce per questa via un effetto ideologico di cui sarebbeerrato sottovalutare la portata: accanto ad altri temi ricorrenti della rap-presentazione barbarica, esso innesca un meccanismo che ricorda da vici-no quello descritto da Barthes per ogni impiego di messaggi connotati: un“segno secondo” (o parassitario) che si dia chiaramente per tale, esibendoo denunciando il proprio artificio, mira innanzitutto a suggerire la pretesanaturalità del “segno primo”(presunto ma impossibile “grado zero”) su cuiesso si sostiene.42 Il corpo iscritto dei Barbari, secondo questa prospetti-va, mira innanzitutto, in un processo di riflessione per contrasto, a sancirela naturalità del corpo ellenico, a celarne il carattere di “prodotto” cultura-le, a promuoverne l’apparente – “feticistica”, diremmo con Marx – origi-narietà; intendiamo quel “corpo” ellenico (soma) di cui Mario Vegetti haevidenziato meglio di altri la laboriosa elevazione a concetto, fra V e IVsecolo a.C., mostrando come esso si dia in un doppio processo ideologi-co che da una parte “somatizza” la psyché, dall’altra, appunto,“psicologiz-
75Federico Condello
senso (del corpo o di altra pretesa “origine”), bensì più sistematicamente lo produce e lodetermina (cfr. per es. M. Foucault, L’ordine del discorso. I meccanismi sociali di controlloe di esclusione della parola, Milano, Feltrinelli, 1972).39 Sul mito della “semplicità” selvaggia e in generale sulla fascinazione del Barbaro, si puòvedere in sintesi F.Turato, La crisi della città e l’ideologia del selvaggio nell’Atene del V sec.a.C., Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1979; per l’ambivalenza del selvaggio nel teatro classico, cfr.P. Ceccarelli, Le monde sauvage et la cité dans la comédie ancienne, in «EL», I, 1992, pp. 23-37;C.Mauduit,Le sauvage et le sacré dans la tragédie grecque, in «BAGB»,1988,pp.303-317.40 Un orientamento generale sul tema della cosmesi nella cultura classica (e sul dibattitoideologico da essa suscitato), fornisce la brillante Introduzione di G. Rosati a Ovidio. Icosmetici delle donne,Venezia, Marsilio, 19882, pp. 9-38.41 Lacan, Scritti, cit., pp. 98-99 (corsivo mio).42 R. Barthes, L’avventura semiologica,Torino, Einaudi, 1991, pp. 27-35: 30. In generale per iltema della “connotazione” cfr. Id., Miti d’oggi,Torino, Einaudi, 1974, pp. 191 ss.; Elementi disemiologia,Torino, Einaudi, 1966, pp. 79-83.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 75
za” il soma.43 È un corpo la cui naturalezza appare già ampiamente mani-polata dalla riflessione psicologica, biologica, estetica: un corpo che cometale, nella sua ostentata integrità, può opporsi inter alia al corpo iscrittodei Barbari, sancendo così, e perentoriamente, il suo effetto di feticcio.
3. Marchi, merche e mercature: il corpo degli schiavi
Che i tratti culturali attribuiti ai Barbari siano destinati a un puntuale tra-vaso metonimico che ne fa altrettante caratteristiche degli schiavi, è unprocesso che non può sorprendere, fondato com’è su un’identificazione –quella fra “non-cultura”barbarica e “non-cultura”servile – destinata a seco-lare fortuna,44 e non priva di concreti fondamenti nella realtà dello schia-vismo antico, almeno per quanto concerne la chattel-slavery.45 La regolavale anche per il tema della scrittura corporale.In un documentato lavoro del 1976, che costituisce a oggi uno dei pochicontributi sul tatuaggio in Grecia antica,Ugo Fantasia mostrava come l’usodegli stígmata corporali si situi all’incrocio fra àmbito barbarico e àmbitoschiavile:
l’uso di tatuare il corpo a scopo ornamentale o come segno di uno status par-ticolare non è assolutamente praticato dai Greci [...]; e agli occhi di un greco,segni e figure impressi sulla pelle denotano quanto meno l’origine barbara.
76 I saggi
43 M.Vegetti,Anima e corpo, in Il sapere degli antichi,Torino,Boringhieri,1985,pp.201-228:214 («la somatizzazione dell’anima genera qui propriamente la nascita concettuale delcorpo. Il soma non è più un aggregato di membra, un recipiente di fluidi vitali, e neppure“materia”, controparte opaca dello psichico. Esso è invece pensato come “organo”, cioèstrumento finalizzato allo svolgimento delle funzioni dell’anima e quindi, al pari di essa, dif-ferenziato in una serie di parti capaci di collaborazione e di conflitto, e interpretabile secon-do una potente metafora unitaria e insieme articolata come quella politica. Alla somatizza-zione dell’anima viene così fatta corrispondere una psichicizzazione – e dunque una politi-cizzazione – del corpo»). Sul “corpo”politico e politicizzato dell’ideologia greca classica, al difuori dell’àmbito specialistico si possono vedere le riflessioni – a tratti spericolate – di A.Cavarero, Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Milano, Feltrinelli, 20002, inpart. pp. 17-110; più salutare, quanto al rapporto corpo/potere, la lettura del classico M. Fou-cault, Sorvegliare e punire,Torino, Einaudi, 1976, la cui prospettiva è ora ripresa (con qual-che fumosità) da D. Kamper, Corpo, in Cosmo, corpo, cit., pp. 409-418. Sul tema limitrofo del“corpo (politico) del re”, cfr.da ultimo G.Agamben,Homo sacer. Il potere sovrano e la nudavita,Torino, Einaudi, 1995, pp. 102-115.44 Cfr. per es. M.Vegetti, Il coltello e lo stilo.Animali, schiavi, barbari, donne, alle originidella razionalità scientifica, Milano, Il Saggiatore, 1979; W. Nippel, La costruzionedell’«altro», in I Greci, cit., I, 165-196.45 Per la chattel-slavery o «schiavitù-merce», alimentata in gran parte da barbari, cfr. per es. leriflessioni di P.Vidal-Naquet, in Actes du Colloque 1971 sur l’esclavage,Paris,Les Belles Lettres,1972, pp. 25-44, nonché i contributi raccolti in M. Moggi e G. Cordiano (a cura di), Schiavi edipendenti nell’ambito dell’oikos e della familia, «Atti del XIII Colloquio GIREA (Pontignano,Siena,19-20 novembre 1995)»,Pisa,ETS,1997.Un’ottima panoramica sulla schiavitù antica è inA. Paradiso (a cura di), Ateneo. Schiavi e servi, con una nota di L. Canfora, Palermo, Sellerio,1990.Per il duplice concorso di elementi materiali e immaginari in ogni logica di carattere raz-zistico, cfr. M.Wieviorka, Lo spazio del razzismo, Milano, Il Saggiatore, 1993, pp. 165-168.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 76
In secondo luogo,è impossibile separare i termini che fanno perno su stízein[“tatuare”,“marchiare”] da fatti e situazioni inerenti alla condizione servile.46
Un termine nodale, in questa prospettiva, è il sostantivo stigmatías, impie-gato a indicare lo schiavo che il padrone marchia a titolo punitivo,47 in gene-re per la tentata fuga, come ritiene Fantasia, ma forse anche per motivi piùgenerici, come suggerisce l’interpretazione dell’Etymologicum Magnum,s.v. stigmatías (p. 727 Kall.: «chiamano così gli schiavi marchiati perchéimproduttivi [achresímous]»), e come mostrano alcuni luoghi menandrei.48
Illuminano tali usi alcuni passi di particolare chiarezza. Negli Uccelli di Ari-stofane, il Corifeo illustra i vantaggi dei costumi vigenti nella nuova città diNefelococcugìa (vv.755 ss.):«Le cose che giù sono sconce e perseguite dallalegge, da noi, fra gli uccelli, sono bellissime [...]. Uno di voi è per caso unoservo fuggitivo, lo bollano [drapétes estigménos]: da noi passa per un fran-colino striato».49 Nella stessa direzione vanno luoghi come Aeschin.De fals.leg. 79 («tu hai tutto dello schiavo tranne il marchio del fuggitivo»), Pl. Leg.IX 854d («chi è colto nell’atto di compiere un furto sacrilego, se schiavo ostraniero sia marchiato sulle mani e sul volto con un segno che ricordi il suodelitto [grapheìs tèn sumphorán]»50), Lucian. Timon. 17 («[il dio Pluto] daalcuni preso a calci, ridotto in pezzi, consumato, da altri tenuto in ceppicome uno schiavo fuggitivo segnato col marchio [hósper stigmatías dra-pétes]»51), Clem.Alex. Paed. III 10, 4 («i marchi [stígmata] indicano lo schia-vo fuggitivo [drapéten]»). La pena designata con il termine di stígma – chepuò denotare tanto il marchio a fuoco o il branding, quanto il tatuaggio52 –doveva essere particolarmente frequente e temuta: il termine stigmatíasricorre non di rado in concomitanza con il semplice doûlos (per es. Her-mipp. fr. 63,19 K.-A.; cfr. anche Ar. Lys. 330-31) e Cassio Dione registra conuna certa sorpresa il caso di uno schiavo,marchiato dal suo proprietario per-
77Federico Condello
46 U.Fantasia,Astikton Chorion, in «ASNP», s. III,VI/4,1976,pp.1165-1175:1169.Prima di talestudio, occorre far uso del vecchio (ma ricchissimo) P.Wolters, Elaphostiktos, in «Hermes»,XXXIII, 1903, pp. 265-273. Più recentemente sul tema è tornato, con dovizia di esempi, C. P.Jones, Stigma.Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity, in «JRS», LXXVII, 1987,pp. 139-155. Si devono invece all’immaginazione dell’autrice tutti i presunti casi di “scritturacorporale”analizzati da L.Faranda,De-scrivere la sofferenza, patire la scrittura.Metafore delcorpo nell’universo femminile greco, in F. Rosa (a cura di), «Il mio nome è sofferenza». Leforme e la rappresentazione del dolore,Trento, Università degli Studi, 1993, pp. 59-78.47 La prima occorrenza del sostantivo è in Asio (VI sec. a.C.?), fr. 1,1 W.2 = G.-P.248 In part. Sam. 323, con il commento di A.W. Gomme e F. H. Sandbach, Menander.A Com-mentary, Oxford, University Press, 1973, p. 577. Anche Luc. Catapl. 24 – dove Radamantespiega a Cinisco come ogni cattiva azione imprima sull’anima uno stigma qual è quello degli«schiavi marchiati» – fa pensare a un uso alquanto generalizzato della pratica punitiva. Cfr.inoltre l’eloquente Plut. Mor. 463a-b. e Ps.-Phocyl. Sent. 225.49 Trad. di B. Marzullo, Aristofane. Le commedie, II, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 382. Sul passosi veda N. Dunbar,Aristophanes.Birds, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 470,ad vv. 760-761,con utili precisazioni sul fenomeno della fuga servile.50 Trad. di G. Reale, Platone.Tutti gli scritti, Milano, Rusconi, 1991, p. 1647.51 Trad. di V. Longo, Luciano. Dialoghi, I,Torino, UTET, p. 153.52 Per i diversi usi si veda Jones, Stigma..., cit., pp. 151-154: la prevalenza del “tatuaggio” sulbranding sembra però assodata.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 77
ché fuggitivo, che al momento del bisogno – nel bel mezzo delle stragi per-petrate dal “secondo triumvirato”– non solo non serba rancore al padrone,ma si prodiga per metterlo in salvo (HR XLVII 10, 4).Dalle nostre fonti si ricava qualche utile notizia anche circa la natura deisegni tatuati o impressi sulla pelle dei servi: se non si tratta del semplicesigillo del proprietario (Diog. Laert. IV 7, 46), lo stigma può consistere inun vero e proprio messaggio verbale,come l’ordine inciso da Istieo sul cra-nio raso di un servo, secondo un celebre racconto erodoteo (Hdt.V 35),53
o come quello presupposto dal citato Pl.Leg. IX 854d,o come la frase – evi-dentemente stereotipata – che dobbiamo a uno scoliaste del già richiama-to Eschine (schol.Aeschin. 2, 79, p. 56 Dind.: «gli schiavi fuggitivi venivanomarchiati sulla fronte, cioè venivano segnati con la frase “prendimi, sto fug-gendo”»); nota in latino, per analoghi scopi, è la sigla FHE (Fugitivus hicest).54 Evidentemente un accorgimento di carattere precauzionale – ope-rato a scanso di recidive, e magari corroborato da pubblici annunci odenunce araldiche55 – che tuttavia non fa passare in secondo piano la purae semplice degradazione del corpo schiavile a supporto di un’umiliante,dolorosa (e certamente rischiosa)56 pratica scrittoria: un fenomeno bennoto, del resto, nella storia secolare del tatuaggio,57 che chiama a illustra-zione il trattamento che i prigionieri di guerra ricevettero durante il con-flitto fra Ateniesi e Samii:marchiati gli uni con il simbolo della nave sámai-na, gli altri con quello della civetta (emblemi monetari delle due città), atitolo di scorno e di infamia servile.58 Un uso analogo sembra presupposto
78 I saggi
53 «[Aristagora] meditava una rivolta. Accadde anche che gli arrivasse da Susa, da parte diIstieo, un uomo con la testa tatuata che gli annunciava di ribellarsi al re. Infatti Istieo, volen-do segnalare ad Aristagora di ribellarsi, non aveva d’altra parte nessun modo sicuro per farlo,dal momento che le strade erano sorvegliate e quindi, avendo rasato il capo del più fedeledei servi, vi incise dei segni, e attese che gli ricrescessero i capelli; e non appena gli furonocresciuti lo mandava a Mileto, ordinandogli soltanto, una volta giunto a Mileto, di dire ad Ari-stagora di guardare sul suo capo dopo avergli rasato i capelli. E i segni [stígmata] indicava-no,come ho detto prima, rivolta» (trad.di Nenci, in Erodoto, cit.,pp.44-45).Erodoto non pre-cisa né il contenuto né la natura (verbale o iconica) del messaggio;ma Polyaen. I 24,1, ripren-dendo l’episodio, attribuisce a Istieo un micro-lettera dotata di completa intestazione.54 Da cui l’ingiurioso homo trium litterarum, «uomo dalle tre lettere» (Plaut.Aul.325).Petro-nio (103), da parte sua, menziona il notum fugitivorum epigramma per totam faciem; altripassi latini in Fantasia, Astikton Chorion, cit., 1172 e in G.T. Haneveld, On the Early Historyof Tattooing, in «Janus», LVII, 1970, 150-155.55 Su quest’ultimo uso si veda K. J. Dover, Greek and the Greeks. Collected Papers, I. Lan-guage, Poetry, Drama, Oxford, Blackwell, 1987, pp. 187-188. Per il marchio sugli schiavicome garanzia contro il furto, cfr. invece Xen. De vect. IV 21: ma la testimonianza non vageneralizzata (cfr. Fantasia, Astikton Chorion, cit., p. 1173 n. 19).56 Su quest’ultimo punto cfr. Jones, Stigma..., cit., p. 143.57 Sul tema è da vedere ora il documentato lavoro di M. Gustafson, Inscripta in fronte. PenalTattooing in Late Antiquity, in «ClAnt», XVI, 1997, pp. 79-105, con ampia bibliografia.58 La vicenda è testimoniata da Duride (FGrHist 76 F 66), da Plutarco (Vita di Pericle, 26, 4) eda Eliano (VH II 19) e cinicamente allusa da Aristofane (fr.71 K.-A.),che parla appunto dei Samiicome di un dêmos polugrámmatos (“letterato” nel doppio senso di “colto” e “marchiato consegni grafici”): cfr.Wolters, Elaphostiktos, cit., pp. 265-266; Fantasia, Astikton Chorion, cit., pp.1172-73. Identico trattamento riservarono i Persiani ai Tebani secondo Hdt.VII 233. Ne fa unsegno di dolorosa umiliazione, da applicarsi ai nobili, il feroce Caligola: cfr. Svet. Cal. 27, 3.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 78
dalla cosiddetta Elegia del tatuaggio (adesp. SH 970).59 Non è un caso delresto che la violenza degli stígmata si sia prestata facilmente a usi metafo-rici assai eloquenti: con estrema frequenza i verbi del tatuaggio o del bodypainting alludono, nei comici, al puro e semplice effetto di lividi corpora-li, quasi che due realtà concrete e abituali della vita servile (lo stigma e labastonatura) fossero destinati a convergere in un’unica raffigurazione daiconfini indistinti. Così lascia intuire Aristofane (Vesp. 1296: «io sono finito,marchiato [stizómenos] dal bastone», si lamenta lo schiavo Santia) e cosìconferma a più riprese Plauto (cfr.per es.Poen.25-26,dove l’attore del Pro-logo avverte gli schiavi perché «se ne vadano a casa ed evitino un doppioguaio: farsi ricamare la schiena [varientur] qui dalle verghe e a casa dallesferze»;Epid. 625-626,dove il servo di Stratippocle pronostica: «il mio grop-pone sarà una bella tela, che un Apelle e uno Zeusi dipingeranno a pennel-late d’olmo [pigmentis ulmeis, con allusione al legno della verga]»).Siamo dunque dinanzi a un corpo degradato, umiliato, privato della suaumanità? Il corpo dello schiavo, per potersi prestare a supporto di penosie indelebili stígmata, deve forse perdere la sua natura di corpo? Conside-razioni di carattere umanitario, ispirate a una prospettiva cristiana che delcorpo seppe valorizzare l’essenza sacrale e “creaturale”,60 sono in questofrangente così poco vere che lo schiavo,disponibile alla marchiatura,è taleproprio in quanto puro corpo: sôma – come “anima”nella Russia di Gogol– sarà antonomasia usitata, in epoca ellenistica, per indicare il servo.Tuttofa credere che proprio la semplice e nuda corporeità connessa all’idea delsôma schiavile renda disponibile e praticabile la forma di umiliante e para-dossale “scrittura” di cui abbiamo tratteggiato alcuni esempi: se, come si èsuggerito sopra, è un corpo profondamente “psicologizzato” quello che sioppone, nella sua ostentata illibatezza, al corpo iscritto dei Barbari, nonsorprende che la riduzione di un corpo a semplice e inanimato sôma –che gli schiavi condividono del resto con gli animali, ugualmente sotto-posti all’impressione di marchi simbolici61 – produca, per contraccolpo,quel processo di “iper-culturalizzazione” in cui sembra consistere la prati-ca della scrittura corporale.62 Per farsi “corpo parlante”, il corpo deve
79Federico Condello
59 Qui la voce narrante si rivolge evidentemente a un nemico, minacciandolo di imprimergliinfamanti stígmata,probabilmente su ogni parte del corpo:cfr. la nota ad l.di H.Lloyd-Jones,P. Parsons, Supplementum Hellenisticum, Berlin-New York, De Gruyter, 1983, p. 479, nonchéi contributi di S. R. Slings, Hermesianax and the tattoo elegy (P. Brux. inv. E 8934 and P.Sorb. inv. 2254), in «ZPE», XCVIII, 1993, pp. 29-37 e H. Lloyd-Jones, Again the Tattoo Elegy,in «ZPE», CI, 1994, pp. 4-7.60 Sulla rivalutazione del “corpo” da parte del cristianesimo – tema di notoria complessità –si veda recentemente la presa di posizione di G. Reale, Corpo, anima, salute..., cit. Il termi-ne “creaturale”è ovviamente sottratto a E.Auerbach, Mimesis. Il realismo nella cultura occi-dentale,Torino, Einaudi, 1956, passim. La rivalutazione cristiana della corporeità non va con-fusa,naturalmente, con una rivalutazione della sessualità: cfr. recentemente S.Pricoco (a curadi), L’eros difficile: amore e sessualità nell’antico cristianesimo, Soveria Mannelli (CZ),Rubettino, 1998, con bibliografia.61 Cfr. per es.Ar. Nub. 23, con il commento di K. J. Dover, Aristophanes. Clouds, Oxford, Cla-rendon Press, 1968, pp. 95-96.62 Sulla scrittura corporale come tentativo di controllare e irreggimentare (“culturalizzare”)
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 79
innanzitutto essere ridotto al silenzio. O, in altri termini, un corpo ridottoal silenzio, disanimato, disappropriato, non potrà che esporsi a forme diriappropriazione segnica di cui il tatuaggio, la marchiatura e ogni sorta di“ferita simbolica” costituiscono altrettanti conati,63 sospesi fra il valoresimbolico e il puro e semplice acting out.Pur nel rischio di sovrainterpretazione che comporta tale lettura di unapratica che resta complessivamente oscura, come molto di ciò che con-cerne il rapporto dei Greci con i propri schiavi, non può essere esclusoche le testimonianze relative allo sguardo ellenico sui “corpi iscritti” diservi e Barbari possano incontrare, su questo punto, le riflessioni che lapsicoanalisi – specialmente di matrice lacaniana – ha svolto sullo statutoliminare del corpo, fra “proprietà” e radicale “estraneità”, sulla sua difficol-tosa costruzione simbolica64 e sulle pratiche di manipolazione che tale sta-tuto provoca per fatale e necessario contraccolpo.65
4. Ferite, cicatrici e promemoria
Non c’è dubbio che la più famosa, fra le cicatrici della letteratura occi-dentale, sia ancora quella che la serva Euriclea, esterrefatta sino alle lacri-me, scopre praticando a un oscuro viandante il bagno prescritto dall’usoospitale; ed è il segno che le svela – dopo un lungo itinerario di raggiri edi travestimenti66 – l’identità del reduce Odisseo:
ora la vecchia, toccando la cicatrice con le due mani aperte,la riconobbe palpandola, e lasciò andare il piede.Dentro il lebete cadde la gamba, risonò il bronzoe s’inclinò da una parte: in terra si sparse l’acqua.A lei gioia e angoscia insieme presero il cuore, i suoi occhis’empiron di lacrime, la florida voce era stretta.Carezzandogli il mento, disse a Odisseo:“Oh sì, Odisseo tu sei, cara creatura! E non ti ho conosciutoprima d’averlo tutto palpato il mio re! [...]”.67
80 I saggi
il sôma, cfr. P. Du Bois, Il corpo come metafora.Rappresentazioni della donna nella Greciaantica, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 181-182.63 Per una riflessione psicoanalitica sul tema che qui si evoca,cfr.B.Bettelheim,Le ferite sim-boliche: un’interpretazione psicoanalitica dei riti puberali, Firenze, Sansoni, 1973.64 Oltre a quanto abbiamo citato più sopra, cfr. per es. F. Dolto, L’immagine inconscia delcorpo.Come il bambino costruisce la propria immagine corporea,Milano,Bompiani,1998,passim e in part. pp. 31-37.65 Cfr. per es. le considerazioni che sul “corpo anoressico” e sulla sua manipolazione condu-ce, in chiave lacaniana, M. Recalcati, L’ultima cena.Anoressia e bulimia, Milano, Bruno Mon-dadori, 1997.66 Per i giochi d’identità cui Odisseo si sottopone nel corso del suo viaggio,cfr.per es. S.Mur-nagham, Disguise and Recognition in the Odyssey, Princeton, Princeton University Press,1987;P.Pucci,Odysseus Polytropos. Intertestual Readings in the Odyssey and the Iliad, Itha-ca (NY), Cornell University Press, 19992.67 Trad. di R. Calzecchi Onesti, in Omero. Odissea,Torino, Einaudi, 1963, p. 549.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 80
L’episodio, dopo aver ispirato ad Auerbach la ben nota teoria sull’anti-rea-lismo classico,68 ha offerto il destro per una recente riflessione sullo sta-tuto degli idionimi personali in età antica: con l’ipotesi, alquanto sorpren-dente, secondo cui la teoria kripkiana dei “designatori rigidi” – di cui lostesso creatore sottolineava del resto il carattere spontaneo e diffuso69 –dovrebbe essere retrodatata almeno all’alto arcaismo;70 e ciò proprio gra-zie a un caso conclamato di scrittura corporale, sul cui carattere univocoe risolutivo (un sêma ariphradés, un «segno chiarissimo»: Od. XXI 217) lareazione della vecchia serva non lascia dubbio alcuno.La suggestione è avvincente, ed è un peccato che ad essa ostino troppe etroppo valide ragioni: dallo stesso carattere non verbale del sêma,71 sinoall’accezione pericolosamente generica cui il concetto di “designatorerigido”si trova così confinato,72 e soprattutto all’indebito “sostanzialismo”che per questa via s’insinua surrettiziamente nella teoria kripkiana;73 sel’unica definizione corretta di “designatore rigido” è quella che ne rileval’invarianza semantica entro enunciati controfattuali,74 e se il principaleidolo polemico della trattazione kripkiana va individuato proprio nella“teoria della descrizione” elaborata da Frege e da Russel, quindi perfezio-nata da Searle,75 appare curiosa l’abusio che ne estende la validità sino a
81Federico Condello
68 Dopo la celebre analisi di Auerbach, Mimesis..., cit., pp. 3-29, secondo la quale lo stile ome-rico, con il suo “primo piano perpetuo”, sarebbe incapace di autentici effetti realistici, lascena centrale del libro XIX – e in particolare il lungo excursus che precede la commossaagnizione – è stato sottoposto ad analisi che ribaltano i presupposti e le conclusioni delromanista: cfr. per es. A. Köhnken, Die Narbe des Odysseus. Ein Beitrag zur homerisch-episch Erzähltechnik, in «A&A», XXII, 1976, pp. 101-114; I. J. F. De Jong, Narrators and Foca-lizers,Amsterdam, Grüner, 1987, pp. 22-23.69 Cfr. S. Kripke, Nome e necessità,Torino, Boringhieri, 1982, p. 10.70 In questa direzione M. Salvadore, Il nome e la persona. Saggio sull’etimologia antica,Genova, Università di Genova, 1987, pp. 9-10, e soprattutto G. Lombardo, Il nome di Odisseoe la orthotes antroponomastica in Omero, in «Helikon», XXXIII-XXXIV, 1993/1994, pp. 73-119: 91-94.71 Si veda Lombardo, Il nome di Odisseo..., cit., p. 91, secondo il quale il gusto antico per inomi parlanti «sembra anticipare il moderno statuto semantico del nome proprio. Esso anziin qualche modo lo rafforza e lo integra. In quanto contrassegno individualizzante, il nomeproprio aderisce al suo referente oggettivo, senza la mediazione del significato [...]. CheOmero abbia chiaramente intuito quella che i logici chiamerebbero oggi la funzione di desi-gnatore rigido del nome proprio, ci viene confermato da un particolare decisivo [...]: l’ana-logia con la cicatrice» (corsivo mio); ma per questa via, gli unici e autentici “designatori rigi-di” rischiano di trovarsi nella teoria semiotica dello swiftiano Balnibarbi (cfr. in proposito R.Jakobson, Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, p. 21).72 Su tale slittamento semantico, foriero di numerosi equivoci, si veda in sintesi J. Molino, Lenom propre dans la langue, in «Langages», LXVI, 1982, pp. 5-20: 15.73 J.-C. Pariente, Le nom propre et la prédication dans les langues naturelles, in «Langages»,LXVI, 1982, pp. 37-65: 60. Ma si veda lo stesso Kripke, Nome e necessità, cit., p. 24.74 Kripke, Nome e necessità, cit., passim e soprattutto pp. 11-13, 42-54 (cfr. in part. p. 50:«chiameremo qualcosa un designatore rigido se in ogni mondo possibile esso designa lostesso oggetto»), 76.75 Sull’apporto di J. R. Searle (Nomi propri, in La struttura logica del linguaggio, a cura diA. Bonomi, Milano, Bompiani, 1973, pp. 249-258) alla teoria delle descrizioni, si può vedereper es. D. Silvestrini (a cura di), Individui e mondi possibili. Problemi di semantica moda-le, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 17-87: 76-77.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 81
quello che pare piuttosto il dominio delle connotazioni – anche in questocaso la toccante agnizione di Euriclea lascia adito a pochi dubbi – e che facoincidere il palesarsi dell’identità non con una fredda prova di commu-tazione logica, bensì con un lungo excursus che riassume il passato del-l’eroe. Se davvero la cicatrice denota Odisseo,“Odisseo”, evidentemente,connota insieme il proprio passato e il proprio futuro narrativo: il segnoindelebile, la scrittura corporale, genera qui un’intera storia – o se voglia-mo,per paradosso,una singolare “descrizione definita”alla maniera di Rus-sel. Nessuna ipotetica “trasparenza”, dunque, fra il segno e il suo referen-te,76 né alcuna resistenza alla prova dei “mondi possibili”, ché un mondonarrativo dove le robuste ginocchia di Odisseo non serbino segni di caccegiovanili, è senz’altro “controfattuale”,ma non logicamente illegittimo:77 laoulé genera qui la storia di un individuo,e solo per suo tramite denota l’in-dividuo che in tale storia, a ben vedere, si risolve.Qual è dunque lo statuto di tali semata, iscritti sul corpo di personaggiche le fonti classiche – purtroppo con avarizia – consegnano alla nostramemoria? La cicatrice è per essenza un segno che rimane (cfr. e.g. Plut.Mor. 65d), il suo colore scuro staglia sulla pelle (cfr.Aristot. Probl. 889b-890b), in particolare su quella del volto (Plut. Mor. 800e) e la medicinaantica non è aliena, a questo proposito, da preoccupazioni di carattereestetico (cfr. e.g. Gal. XVIIIa p. 378 Kuhn); da un punto di vista semiotico,la cicatrice va ovviamente rubricata fra i “segni indicali”: essa è tecnica-mente un sêma hypomnestikón (cfr. Sext. Emp. Pyrrh. hypoth. II 102, chela cita accanto all’esempio canonico del “fumo” [kapnós] quale “indice”del fuoco). Ma se tale hypómnema, anziché trovarsi rubricato a puro“segno”di una passata ferita – come il fumo lo è di un fuoco presente – silascia coinvolgere nel gioco inevitabile dei messaggi connotati? Ecco allo-ra che la cicatrice diviene, prima che il marchio di un’identità, il segnoevocativo di una storia. Così è per Odisseo, come si è visto, e così sembraessere anche per le volontarie cicatrici che costituiscono l’essenza dei ritifunerari scitici (cfr. supra); ma così è anche per Filottete – il morso dellaserpe è descritto da Sofocle quale permanente cháragma (Phil. 266-267)78 – e per Oreste,riconosciuto da Elettra grazie a una cicatrice che rin-via a un episodio della comune fanciullezza (non a caso una battuta di cac-
82 I saggi
76 Essa sarebbe poi del tutto vanificata se si credesse – come sembra fare Lombardo, Il nomedi Odisseo..., cit.,p.94 n.57 – alla suggestione di K.Marót,Odysseus-Ulixes, in «Acta Antiqua»,VIII, 1960, pp.?? 1-6, che ipotizza un calembour fra il termine oulé e l’idionimo extraomeri-co Oulusseús.77 Per l’applicazione agli universi narrativi della teoria dei “mondi possibili”, d’obbligo il rin-vio a U. Eco, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979.78 «Figlio mio, tu che sei stato generato da Achille, / io in persona sono quello, del quale haiforse udito / che è in possesso delle armi di Eracle, / il figlio di Peante, Filottete, quello che idue / comandanti insieme al capo dei Cefalleni / hanno gettato via, infami, così in solitudine,/ afflitto da un morbo selvaggio, / segnato dal marchio feroce [agríoi charágmati] di vipe-ra assassina» (Soph. Phil. 260-267, trad. di G. Cerri, in Sofole. Filottete, a cura di G.Avezzù e P.Pucci, Milano, Fondazione L.Valla-Mondadori, 2003, pp. 38 e 40).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 82
cia: Eur. El. 571-575)79, e così sarà, ad esempio, per il Clitofonte di AchilleTazio (VIII 5, 1), finanche per le lucertole di Eliano (NA II 23) e natural-mente per il Cristo giovanneo dinanzi a Tommaso (cfr. Nonn. Paraphr. XX127). Un segno corporale può addirittura essere l’indizio dei propri lega-mi parentali (cfr.Aristot. De gen. an. 721b)80, rimandando la storia del sog-getto alle sue origini più remote; essa può essere titolo d’onore per uncombattente (cfr. e.g. Lucian. Navig. 37), ma non mancano stígmata cor-porali che siano segno di più umili vicende: una lite amorosa o un barbie-re incapace (cfr. il dolente Mart. XI 84, 13-16)81; non sorprende che si dis-pongano a una vera e propria lettura ermeneutica le cicatrici sognate,nonmeno di quelle reali (Artemid. III 40);per questa via, lo stesso termine oulépuò divenire sinonimo di evento passato o colpa pregressa (Philostr. VA II30): un «morso che fa sanguinare la memoria» e che per sempre è desti-nato a ravvivarla, «come una cicatrice permanente» (Plut. Mor. 126f).Di qualsiasi storia, vicenda o peripezia sia la traccia, il segno corporeo –cicatrice o ferita – tradisce con la sua iscrizione il passato recente o remo-to del soggetto: ne rinvia la presenza a una trama di accadimenti che con-dizionano la sua identità, che complicano la sua apparente “datità”. Lungidall’essere il segno di un’ipotetica trasparenza dell’individuo a se stesso,l’oulé connota e non denota, marchia prima che identificare secondo laplacida convenzionalità di un “designatore rigido”.A suo modo, violandol’ideale o idealizzata semplicità del corpo, restituisce ad esso tutto il suopeso e il suo spessore: siamo ancora nell’àmbito di un segno “sovrimpres-so”, che continua a offrirsi come occasionale accidente di un corpo checonserva la sua pretesa naturalezza e nasconde la sua essenza di costruttostorico-sociale, sottraendosi – se non per occasionali sovrimpressioni – algioco dei segni e alla sua fuga, potenzialmente infinita. Ma non è lontana,a ben vedere, la prospettiva che del corpo stesso, e della sua “naturale”conformazione, farà un segno da interpretare: la téchne fisiognomica, conil suo complesso ed enigmatico cifrario, ambientata in Grecia almeno dalV secolo a.C. La fisiognomica stessa, del resto, affonda le sue radici in anti-che tecniche di ermeneutica corporale che prestavano attenzione, innan-zitutto, alla presenza di “sovrimpressioni” superficiali che poco hanno da
83Federico Condello
79 «Vecchio.Vedo qui Oreste, il figlio di Agamennone. / Elettra. Qual è il segno che mi puòconvincere? / Vecchio. Una cicatrice [oulén] sul sopracciglio, che si procurò una volta / conte, cadendo, nel cortile del padre, mentre cacciava un cerbiatto. / Elettra. Come dici? Vedo ilsegno [tekmérion] di quella caduta!» (Eur. El. 571-575; trad. di S. Fabbri, in Euripide. Suppli-ci. Elettra, Milano, Mondadori, 1995, p. 123).80 «I bambini nascono simili ai loro genitori non solo per quanto riguarda i caratteri conge-niti, ma anche per quanto riguarda i caratteri acquisiti: per esempio, se i genitori hanno dellecicatrici, è capitato che i figli recassero il segno della cicatrice nello stesso luogo dei genito-ri, e a Calcedone, poiché un padre aveva un’incisione sul braccio, la stessa scritta, benchéconfusa e sbiadita, apparve a marchiare il corpo del figlio».81 «Le stimmate che io porto sul mento / quante un grugno ne ostenta / di pugile in pensio-ne, non mia moglie / me le ha fatte, folle di furore, / con le sue ugne, ma il braccio / scelle-rato di Antioco e il suo ferraccio» (trad. di G. Ceronetti, in Marco Valerio Marziale. Epi-grammi,Torino, Einaudi, 1979, p. 797).
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 83
spartire con un’autentica “semantica”del corpo (la umsatu dei testi cunei-formi mesopotamici, per esempio)82; e resta da vedere, a proposito dellafisiognomica greca, se i “segni incarnati” in tratti tipologici più o menocanonizzati non costituiscano, piuttosto che una rivelazione, un ulterioremascheramento del corpo e della sua precaria costituzione in feticcioideale (non a caso, resterà centrale per la fisiognomica l’idea del “giustomezzo”)83; un ulteriore passo, insomma, sulla via della “psicologizzazione”(inconsapevole) del corpo: una più profonda discesa, piuttosto che un’im-provvisa – ma non necessariamente liberatoria – «risalita».84
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/3condello.htm.
84 I saggi
82 Su tali “marchi innati” della pelle (nei o “voglie”), indagati dai più antichi testi di fisiogno-mica mediorientale,cfr.G.Raina, Introduzione a Pseudo Aristotele.Fisiognomica,Milano,Riz-zoli, 1993, pp. 7-8, e più in generale J. Bottero, Sintomi, segni, scritture nell’antica Mesopota-mia, in Divinazione e razionalità, a cura di J.-P.Vernant,Torino, Einaudi, 1974, pp. 73 ss.83 Cfr. Raina, Introduzione a Pseudo Aristotele..., cit.84 Sulla fisiognomica antica cfr. J. Schmidt, Physiognomik, in RE XX/1, coll. 1064-1074; M. H.Marganne, De la physiognomie dans l’Antiquité Gréco-Romaine, in Rhétorique du corps,ed. par P. Dubois et Y.Winkin, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1988, pp. 13-24; per una storiadella fisiognomica e delle sue alterne fortune, si possono vedere P. Magli, Il volto e l’anima.Fisiognomica e passioni, Milano, Bompiani, 1996; L. Rodler, Il corpo specchio dell’anima.Teoria e storia della fisiognomica, Milano, Bruno Mondadori, 2000; F. Caroli, Storia dellafisiognomica.Arte e psicologia da Leonardo a Freud, Milano, Electa, 2002.
003 Alfieri 2-11-2007 14:57 Pagina 84
85Claudio Franzoni
Strascinare i nemici. Rileggendo FortiniClaudio Franzoni
Quale sarà stata la reazione degli alunni nel sentire il professore che com-mentava una foto della guerra nel Vietnam utilizzando un passo dell’Ilia-de (o forse spiegava il passo omerico tenendo in mano quella foto recen-tissima)? È Franco Fortini a raccontare la sua iniziativa didattica, di certoinusitata per un istituto tecnico «verso il 1965», in un articolo sul «Corrie-re della Sera» di molti anni dopo (3 novembre 1983).La fotografia «rappresentava un carro armato americano nel Vietnam; conla sua mole esso occupava quasi per intero il rettangolo dell’immagine.Dal carro armato una fune tesa verso lo spettatore strascicava per i piediil corpo seminudo di un vietnamita. Lessi la pagina dell’Iliade». Lo scattonon era di un reporter svedese, come credeva di ricordare Fortini, ma diun fotografo giapponese, Kyoichi Sawada, e non era del 1965, ma dell’an-no seguente, lo stesso in cui vincerà il Premio Pulitzer.Ma quale pagina lesse Fortini? Perché Achille si accanisce sul cadavere diEttore in occasioni diverse. Subito dopo averlo ucciso, gli fora i tendinidelle caviglie per farvi passare corregge di cuoio e attaccarlo al carro (Ilia-de, 22.396); comincia a trascinarlo e prima Priamo ed Ecuba, poi Andro-maca, lo scorgono così nella spianata «davanti alla rocca» (Iliade, 22.405 ess., 464).Arrivato all’accampamento dei Greci,Achille getta Ettore «a fac-cia in giù» accanto al cadavere di Patroclo (Iliade, 23.24 e ss.). Conclusi igiochi funebri per Patroclo, lega il corpo di Ettore alla cassa del carro, e lofa girare tre volte attorno alla tomba di Patroclo; la scena si ripete all’au-rora per dodici giorni (Iliade, 24.16 e ss.; 413-4).Come mai Fortini riparla nel 1983 di questa lontana lezione scolastica?Perché qualche sera prima i telegiornali avevano trasmesso le immagini di«alcuni militari americani a Grenada» che «strascicavano per i piedi i corpidi militari o di civili dell’isola (o di Cuba o di chissà che altro luogo), cheessi avevano ucciso nel corso di una difesa della libertà occidentale». Ciòche colpisce Fortini, in questa ennesima versione moderna degli ultimilibri dell’Iliade, è l’assenza di elementi “funzionali”: «li trainavano a lungoper terra, la faccia in basso a “mordere la polvere”; anche quando avreb-bero potuto sollevarli».Trainare i cadaveri aveva solo una funzione simbo-lica, proprio come certi gesti: quello, ad esempio, di baciare la terra patria:lo aveva fatto Ulisse a Itaca (Odissea, 13.354), nota Fortini, e lo avevanofatto in quei giorni altri giovani americani rimpatriati proprio da Grenada.A che cosa si deve questa persistenza dei gesti? Questo è la domanda difatto posta da Fortini, che si chiede se quello strazio di cadaveri «non fossestato previsto e raccomandato» in un regolamento, in una circolare, in una
7
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 85
1 M.Aurelio, Ricordi, 10.10 (trad. E.Turolla).2 P. Zanker, I barbari, l’imperatore e l’arena. Immagini di violenza nell’arte romana, inUn’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano,EDITORE??, 2002, fig. 22 a p. 38 (pp. 38-62).
86 I saggi
conversazione tra ufficiali e truppa. Qualcuno avrà insegnato a quei sol-dati che «i cadaveri dei nemici non sono in nulla diversi da quelli dei cin-ghiali» o si era trattato di un comportamento «spontaneo»? Questo, infatti,è il problema vero: se queste forme comportamentali, ripetute da millen-ni, siano istintive o apprese. La risposta di Fortini è che «quel modo» –«antico quanto il mondo e praticato dall’età omerica a Piazzale Loreto» –veniva ormai eseguito «scientificamente. dopo accurate indagini di antro-pologi», per terrorizzare e dissuadere; e fa un nuovo esempio, il colpo distato cileno. Nessuna spontaneità nei soldati, nessuna nel cameraman diGrenada, che avrà così consentito ai telespettatori americani di commuo-versi rivivendo la propria gioventù in divisa in Corea o in Vietnam e raf-forzando «gli spiriti militari, il senso del destino ineluttabile, il virile animodel “dirty job” necessario a che il viso della patria, della mamma e dellaragazza rimangano sempre puri e luminosi».L’alternativa tra violenza spontanea e violenza programmata viene ripro-posta nel finale dell’articolo:
Mie concittadine, una scelta vi è lasciata. Salvo imprevisti, i vostri figli o tra-scineranno con la faccia a terra i corpi dei propri coetanei o a quel medesi-mo modo saranno trascinati. Da gente che parli la loro stessa o un’altra lin-gua non importa. E non solo per le occorrenze atroci delle battaglie quandogli uomini si imbestiano: ma perché per far sopravvivere l’impero uno odieci o cinquant’anni bisogna atterrire l’avversario e i suoi parenti, le donneche si affacciano ai casolari dell’Appennino, i ragazzi che di nottetempo pos-sono sparare sulle sentinelle dell’occupante.
La profezia non faticò ad avverarsi, anche se non riguardava madri italia-ne: nel 1993 in Somalia toccò proprio a un soldato americano, con lavariante del trascinamento per le braccia. Qui l’obbiettivo del gesto nonera certo quello di «far sopravvivere l’impero»: dunque una ferocia deriva-ta da una pianificata riduzione a bestia del nemico o dovuta all’“imbe-stiarsi” dei soldati di ogni guerra?Bisogna ammettere che quest’ultima è la spiegazione che ci viene piùnaturale. È questo del resto il pensiero sotteso a una famosa immagine diMarco Aurelio: «Il ragno si fa bello perché ha preso una mosca; qualcunoperché ha preso una lepre;un altro,una sardella con la rete adatta;un altroun cinghiale; un altro, un orso; un altro, dei Sàrmati [...]».1 Ma, se ripartia-mo dall’Iliade, osserviamo che si tratta di un “imbestiamento” solo appa-rente. Prima che il duello inizi, Ettore dichiara che, nel caso vinca, nonintende «sconciare orrendamente» il corpo di Achille e, anzi, lo restituirà(Iliade, 22.256); Ettore sapeva benissimo che quello era l’esito normale diun duello.Viceversa è lo stesso Achille,dopo la vittoria sul figlio di Priamo,
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 86
3 Cfr. anche A. Carile, Potere e simbologia del potere nella nuova Roma, in Comunicare esignificare (Settimane di studio del CISAM, LII, Spoleto, 2004), Spoleto, EDITORE??, 2005, I,pp. 394 ss. (in part. le tavv. IX-XI sul motivo del calpestare il vinto). Per quanto riguarda l’i-conografia vetero e neotestamentaria, cfr. E. Dinkler-von Schubert, s.v. Fusstritt, in Lexiconder christlichen Ikonographie,2,coll.67-69.Per immagini di trascinamento nei martirî di sanZotikos e di sant’Oreste, cfr. E. Castelnuovo e G. Sergi (a cura di), Arti e storia nel Medioevo.I, Tempi spazi istituzioni,Torino, EDITORE??, 2002, p. 723, figg. 13-14.
87Claudio Franzoni
a gridare al nemico che la rabbia e il furore lo spingerebbero a tagliargli lecarni e a divorarle (Iliade, 22.346).Tale soluzione estrema – quella sì esitodi una rabbia senza freno – non si avrà, ma lo strascinamento del cadave-re di Ettore sì, e ripetute volte. In quest’ultima azione c’è dunque molto dipiù di una ferocia gratuita: «Ora cantando il peana [...] trasciniamo costui»grida Achille ai compagni (Iliade, 22.392); quelli stessi che, poco prima,erano accorsi sul luogo del duello, avevano ammirato il guerriero caduto,denudato, e lo avevano colpito con le loro armi (Iliade, 22.370-1).Si colpisce un corpo inoffensivo e il gesto non ha affatto una valenza fun-zionale. Perché insomma infierire su un cadavere sotto le mura di Troia (maanche nel Vietnam o in Somalia?). Probabilmente l’uomo ripete inconsape-volmente i movimenti con cui l’animale,dopo un combattimento,verifica lamorte dell’altro; ma, in ogni caso, si tratta di ben altro. Un percorso simile aquello proposto da Fortini è stato proposto recentemente da Paul Zanker,che ha accostato una foto di pochi anni fa e una scultura classica;2 la foto èquella di un soldato che nella guerra civile in Jugoslavia calpesta il cadaveredi un nemico; la statua è quella del teatro di Hierapytna (Creta), in cui l’im-peratore Adriano calpesta un nemico. A prima vista è più chiaro il movi-mento dell’imperatore: non c’è infatti dubbio che egli sia in posa e che tra-mite questa posa lo scultore non abbia voluto fissare un movimento preci-so, ma abbia cercato di simboleggiare la forza invincibile con cui Adrianodomava le popolazioni barbariche. Ma se guardiamo con attenzione sco-priamo che pure il soldato moderno non agisce guidato da un impulsobestiale: è tranquillo, guarda il fotografo con uno sguardo obliquo e com-piaciuto; in un certo senso non rappresenta solo se stesso e il cadavere delnemico non rappresenta solo il caduto.Anch’egli, insomma, è in posa.Il fatto è che sia nel caso del nemico calpestato, sia in quello del nemicotrascinato,sull’elemento “funzionale”(scaricare l’odio e la paura per il con-tatto ravvicinato con l’avversario) prevale l’elemento simbolico; tanto ilnemico sconfitto, quanto il vincitore vengono proposti come immagini: ilnemico atterrato – calpestato o trascinato – è qualcosa da mostrare comemonito ai nemici,come stimolo esaltante ai compagni (e in un certo sensoanche a se stessi).3
Prendiamo uno dei Desastres de la guerra di Goya: un uomo è stato lega-to ai piedi e due lo trascinano, mentre altri lo percuotono e altri ancoraguardano lo spettacolo. La sequenza fotografica che Mario De Biasi realiz-zò durante la rivolta d’Ungheria del 1956 è una ulteriore conferma che l’ac-canimento è funzionale all’ostentazione: il cadavere di un sospetto mem-
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 87
4 A. Colombo, Mario De Biasi, Milano, EDITORE???, 1999, p. 114.5 Un altro caso di trascinamento del cadavere al di fuori di un contesto propriamente bellico èquello riferito nell’Historia Augusta (Comm., 17.4) a proposito di Commodo: «Il senato e ilpopolo chiesero che il suo cadavere fosse trascinato con un uncino e precipitato nel Tevere [...]».6 Sul tema cfr. ora le importanti osservazioni di G. De Luna, Il corpo del nemico ucciso: vio-lenza e morte nella guerra contemporanea, Torino, EDITORE???, 2006 (in particolare ilcapitolo Tra arcaismo e modernità, pp. 51-54).7 Per l’età antica: E. La Rocca, Ferocia barbarica. La rappresentazione dei vinti fra MedioOriente e Roma, in «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts»,109,1994,pp.31 ss.8 M. Guarducci, Epigrafia greca, vol.?? II, Roma, EDITORE???, 1969, p. 523. Per il mondoromano, cfr. ad es. CIL I, 682 (Perugia), col commento di T. Mommsen («Ioci militaris defugiente hoste acerbitatem quivis perspicit»); oppure cfr. CIL I, 684.9 Boston, Museum of Fine Arts 63.473.A. Kossatz-Deissmann, in LIMC, I, 1981, s. v. Achilleus,nr. 586.
88 I saggi
bro della polizia segreta viene prima trascinato per i piedi,poi appeso a unalbero;4 la situazione è enormemente diversa da quelle precedenti, primadi tutto perché qui non sono coinvolti soldati, e il punto di contatto è unosolo: lo sconciamento del cadavere non avviene in segreto, ma tra la folla.5
Al di là dei toni cinematografici, la versione del trascinamento di Ettore cheMatsch dipinse per l’Achilleion, la residenza che Elisabetta d’Austria (Sissi)realizzò a Corfù, coglie un aspetto rilevante del mito: lo sconciamento delnemico è rivolto ai Greci che inseguono a piedi e a cavallo il carro di Achil-le e ai Troiani che osservano la scena dall’alto della rocca.Dall’Iliade fino a oggi esistono, per così dire,“tecniche del corpo”propriedella guerra,e, tra esse,anche quelle che fanno i conti con i corpi dei cadu-ti: quelle che riguardano i propri morti (il recupero, il pianto, gli onori...),quelle che riguardano i corpi del nemico; in quest’ultimo caso il cadaveredel nemico può diventare icona efficace e sbrigativa da ottenere, ammo-nimento per gli sconfitti, esaltazione per i vincitori.6 C’è appena bisognodi ricordare l’inveterato ricorso al taglio – e alla necessaria ostentazione –delle teste dei nemici sconfitti: gli esempi si affollerebbero dalla ColonnaTraiana a oggi.7 La guerra si rivela, da questo punto di vista, spazio di tena-ci persistenze, e non sarebbe difficile procedere come Fortini, accostandotesti di ieri e immagini di oggi, o viceversa; e – abbandonando i corpi perosservare le armi – affiancare le ingiurie per il nemico imbrattate sumoderne bombe in procinto di essere sganciate, con gli insulti graffiti suiproiettili di piombo di qualche esercito greco o romano;8 oppure guarda-re come dal mondo antico fino a oggi le armi e le macchine da guerra pos-sano essere sagomate e configurate ad assomigliare ad animali feroci;oppure osservare come nel mondo antico fino ad oggi ammucchiare learmi dei nemici sconfitti sia un modo per celebrare i vincitori.
Trascinare Ettore in immagini: aggiunte e sottrazioni
Ecco il trascinamento del cadavere di Ettore su una hydria attica della finedel VI secolo.9 Che il pittore volesse raccontare le storie dei canti XXII-XXIV
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 88
10 Anche il particolare dei tendini forati compare solo su una tarda incisione di J. B. Probst.11 Ivi, nr. 588: lekythos a figure nere, Gruppo di Leagros (fine del VI secolo a.C.), Delo B6137.546.12 Ivi, nr. 592: anfora a figure nere, Pittore di Priamo (c. 520 a.C.), Londra, British Museum99.7-21.3.
89Claudio Franzoni
dell’Iliade è certo, ma è altrettanto sicuro che non possiamo parlare di illu-strazione in senso proprio. E questo d’altra parte è sempre vero nel rappor-to tra immagini e testi:ben raramente le prime ne sono una piatta e rigida tra-scrizione.Nella hydria di Boston,come spesso nelle immagini di età arcaica,vengono condensati più momenti di un racconto. La quadriga sta appenamuovendosi (Achille ha ancora un piede a terra) ma è in due posti diversi: èsotto le mura di Troia – perché è certo ad esse che si riferiscono le architet-ture all’estremità sinistra – ma è anche nei pressi della tomba di Patroclo, iltumulo biancastro che si intravede sulla destra; per non lasciare dubbi allospettatore, il ceramografo fa volare su di esso una figuretta armata di tuttopunto, l’eidolon di Patroclo. E come se non bastasse, una figura femminile siaffretta verso Achille: è forse Iris, che tuttavia in Omero si reca da Priamo,mentre è Teti che si reca dal figlio (Iliade,24.120-137;144-188).Momenti bendistinti si intrecciano: a sinistra Ecuba e Priamo si affacciano a vedere loscempio del figlio, eppure il carro, dalla parte opposta, ha già raggiunto ilcampo greco, dove – addirittura – si sono già chiusi i funerali di Patroclo.Ma il rapporto con il testo dell’Iliade è inteso liberamente non solo e nontanto perché se ne sommano passi differenti. Il pittore infatti, rispetto aquello, opera per sottrazioni e aggiunte. Da una parte corregge l’eccessi-vo accanirsi di Achille sull’avversario: come nell’Iliade il corpo di Ettorenon viene sfigurato (per intervento di Apollo e Afrodite), ma neppure lo sidescrive a faccia in giù, dettaglio che invece nel testo omerico è esplicito;dall’altra il pittore inserisce il motivo dell’eroe che si gira per guardare igenitori di Ettore, accentuando in questo modo la crudeltà dell’uno e lasofferenza degli altri. L’episodio omerico viene dunque riformulato – è ilbisogno di raccontare più momenti in una sola scena che lo impone – maviene anche rimodulato; esito più di una diversa sensibilità, che dellenecessità imposte dalla traduzione da testo a immagine. Mostrare il mododi agire di Achille interessa più che descrivere minutamente il penososconciamento del corpo dell’eroe troiano, aspetto che, del resto, vieneomesso anche nella tradizione successiva.10
Altri vasi della fine del VI secolo del resto confermano questa interpreta-zione dell’episodio del trascinamento, con alcune varianti significative. Suuna lekythos a figure nere di Delos, la quadriga si è fermata poco più in làdella tomba di Patroclo;11 anche in questo caso – a differenza del testoomerico – il carro non è guidato da Achille, ma da Automedonte. L’eroescende dal carro e si avvicina al cadavere di Ettore, le cui caviglie sonoannodate agli assi delle ruote, e guarda verso il tumulo su cui sembra vola-re l’eidolon dell’amico vendicato così brutalmente. Un altro vaso a figurenere introduce una variante ancora;12 Achille, appiedato, sosta chinandosi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 89
13 Sulle diverse interpretazioni, cfr. LIMC, ibidem.14 Toledo Museum of Art, anfora, Rycroft Painter (520-510 a.C.); A. Kossatz-Deissmann, inLIMC, I, 1981, s. v. Achilleus, nr. 649.15 Cambridge, Fogg Art Museum, 1972;A. Kossatz-Deissmann, in LIMC, I, 1981, s. v. Achilleus,nr. 655.
90 I saggi
sul cadavere per osservare che i sassi e gli urti sfigurino adeguatamenteEttore. E del resto perché compare sull’anfora anche la scritta KONISOS,se non per evocare quella polvere che, abbruttendolo, umilia il guerrierotroiano sconfitto?13 «E intorno al corpo trainato s’alzò la polvere: i capelli/ neri si scompigliarono; tutta giaceva in mezzo alla polvere / la testa, cosìbella prima» (Iliade,22.400-3).Smontare dal carro e verificare la rovina delcorpo sconfitto è momento del tutto assente dai tre canti omerici, eppu-re di ottimo effetto nel disegnare l’accanimento di Achille.Nell’episodio omerico del riscatto di Ettore (Iliade, 24.468-670), il tratta-mento riservato da Achille al nemico passa in secondo piano rispettoall’intenso e commovente dialogo tra il vecchio re e l’eroe. A giudicaredalle parole di Priamo («Non farmi sedere sul seggio, figlio di Zeus, finchésenza cure / Ettore giace straziato nella tua tenda, ma subito rendimelo,che possa vederlo») il cadavere del figlio è nella tenda, ma non si vede; esembrerebbe che fino alla fine Priamo non lo veda, se è vero che Achilleordina espressamente alle schiave di lavare e ungere il cadavere in un altroluogo, fuori dalla vista del re (Iliade, 24.580-2). Nella ceramica attica, inve-ce, la presenza di Ettore ha un notevole risalto: mentre Priamo entra nellatenda, il cadavere è bene in vista e in una posizione del tutto speciale. Suun’anfora del 520-510 a.C., dunque pressoché contemporanea ai vasi coltrascinamento del guerriero troiano,14 Priamo arriva da Achille mentrequesti, in disparte rispetto agli altri compagni, ha appena finito di man-giare. Nel poema si dice con chiarezza che Achille era seduto e che eraancora lì la tavola (Iliade, 24.475-6), ma non che l’eroe banchettassesdraiato come si userà più tardi in Grecia; ma soprattutto non si parla diEttore che qui è buttato a terra, in prossimità della kline del suo uccisore.Inserire anche il cadavere di Ettore nella scena del riscatto, discostandosiin tal modo dal testo omerico, è sicuramente spiegabile entro l’economiadel racconto per immagini: la scena senza la figura giacente di Ettore per-deva di chiarezza e incisività. Ma le ragioni di questo inserimento nonsono solo queste, tanto più che è indiscutibile, almeno in alcune opere,che il cadavere è sotto la mensa o addirittura il letto dell’eroe greco.Siamoinsomma davanti a una tacita riprovazione del comportamento di Achille,che lascia insepolto e troppo visibile il corpo dell’avversario; e infattiquando esso verrà restituito Automedonte e Alcimo lasciano sul carro diPriamo (Iliade, 24.580-1) «due lini e un ben tessuto chitone, per restituirecoperto il corpo da ricondurre a casa».Anche nel mondo antico è normanascondere alla vista i cadaveri.Ma dove è gettato, esattamente, Ettore? In questo ed altri casi non c’è dub-bio che Ettore sia accanto al letto e alla tavola imbandita. In un vaso della
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 90
16 K. Friis Johansen, The Iliad in Early Greek Art, Copenhagen, EDITORE???, 1967, pp. 133ss.;A. Kossatz-Deissmann, in LIMC I, 1981, s. v. Achilleus, nr. 659.17 Ettore è chiaramente sotto la kline in altri vasi:A. Kossatz-Deissmann, in LIMC, I, 1981, s. v.Achilleus, nrr. 656, 656.18 Friis Johansen, The Iliad in Early Greek Art, cit., p. 139.19 F. Lammert, s. v. Trópaion, in RE,VII,A, 1, 1939, coll. 663 ss.
91Claudio Franzoni
cerchia di Euthymides (c. 510 a.C.), Ettore – corpo ferito, capelli scompi-gliati e corde alle caviglie – è certamente davanti alla kline di Achille.15
Invece le cose cambiano su uno skyphos del Pittore di Brygos (c. 485a.C.):16 i piedi della mensa ancora ricolma di cibo e in parte anche quellidella kline coprono il corpo nudo dell’eroe sconfitto e non c’è dubbioche il ceramografo intendesse dipingere Ettore sotto il letto di Achille.17 Èmolto probabile che il Pittore di Brygos sia arrivato a questa soluzioneindotto, per così dire, dall’ambiguità prospettica dello schema preceden-te, ma è certo che la sua intenzione è quella di accentuare il comporta-mento insensibile e violento di Achille: Priamo è già davanti a lui e nep-pure lo guarda, e perdipiù tiene ancora in mano un pezzo di carne e uncoltello; alle ferite sulla carne di Ettore risponde l’abbondante finezzadelle ornamentazioni sulla kline.Il comportamento di Achille non è certo proposto come modello. D’altraparte, è un fatto che il motivo del trascinamento del cadavere di Ettore siadel tutto assente nella ceramica attica dal 500 a.C. in poi.18 Si tratta diun’assenza casuale? Certo i comportamenti dell’eroe erano del tuttoopposti a quell’ideale di moderazione del vincitore in guerra che si profi-la ad esempio nell’Agamennone di Eschilo (vv. 336 ss.) e che verrà richia-mato anche nel discorso di Nicolao in Diodoro (13.20 e ss.). È notevoleche mentre va scomparendo la raffigurazione del trascinamento di Ettore,si diffonda una pratica prima del tutto assente, quella di innalzare trofei –effimeri oltretutto – sul campo di battaglia:19 l’eterna necessità di spetta-colarizzare la vittoria ora sembra affidata a poche armi prese ai vinti,inchiodate su un palo in una posizione ben visibile.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/franzoni_2.htm.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 91
Le parole del nemico: Dante, PetrarcaPaola Vecchi Galli
Dante, il nemico e il gran nemico
La letteratura italiana ha, come è lecito attendersi, un primo mortale nemi-co, Satana,1 il cui nome significa in ebraico “avversario”: in Matteo XIII 39«inimicus est diabolus»: e d’altronde diabolus è, etimologicamente,“coluiche porta la divisione”. Usa già il termine Iacopone da Todi in moltissimesue laude (la parola nemico vi compare 29 volte):2
Or oderite bataglia che mme fa ‘l falso Nimico,e siràve utilitate, s’ascoltate quel ch’e’ dico.Lo Nimico sì me mette sottelissima bataglia:con quel venco sì m’arfere, sì sa metter so travaglia.[…] Oi Nimico engannatore, come c’entre per falsia!Fusti fatto glorioso en quella granne compagnia;multi beni Deo te fece, se l’avissi conservati;appitito essciordenato su de cel v’à traboccati (56, vv. 1-4; 11-14)3
E lo riprende Dante, quando, all’inizio dell’Inferno, presenta uno deimostri infernali, Pluto,con parole che alludono alle sue qualità diaboliche:
quivi trovammo Pluto, il gran nemico (Inf.VI, 115);
che è come dire il diavolo, l’avversario dell’uomo nella tradizione biblicae patristica. Già prima di iniziare il suo viaggio, nel III canto dell’InfernoDante aveva alluso al campo semantico dell’inimicizia estendendolo dal-l’orizzonte degli uomini a quello della divinità.Si parlava in quel caso degliignavi, ugualmente spiacenti al cielo e all’abisso:
Incontanente intesi e certo fuiche questa era la setta d’i cattivi a Dio spiacenti e a’nemici sui (Inf. III, 61-63).
92 I saggi
1 Cfr. almeno, sul tema: J. Burton Russell, Il diavolo nel medio evo, Roma-Bari, Laterza, 1987;N. Forsyth, The Old Ennemy. Satan and the combat myth, Princeton, Princeton UniversityPress, 1989; G. Minois, Piccola storia del diavolo, Bologna, Il Mulino, 1999.2 I controlli numerici sono stati effettuati, qui e per Dante, sulla LIZ 4.0, Letteratura italia-na Zanichelli, CD-Rom dei testi della letteratura italiana, a cura di P. Stoppelli ed E. Picchi,Bologna, Zanichelli, 2001.3 Iacopone da Todi, Laude, a cura di Franco Mancini, Roma-Bari, Laterza, 1980.
8
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 92
L’esperienza dell’inimicizia, però, non comincia per Dante nel nome deldemonio.All’inizio della Commedia l’autore ha implicitamente avvertito chela battaglia del diavolo contro il bene è persa in partenza. La prima allusionea quel genere di conflitto compare infatti, nel poema, fra gli epiteti che spet-tano a una santa:Lucia,nimica di ciascun crudele,di Inf. II,100;mentre l’in-vincibile potenza in guerra contro i propri nemici è quella di Dio, l’avversa-rio di ogni male di Inf. II, 16, e l’imperador che là su regna di Inf. I, 124.Saldando l’ambito concettuale del nemico a quello della guerra,4 il Medioe-vo cristiano sa insomma percepire un massimo conflitto, quello contro gliavversari delle potenze infernali.5 Al diavolo, antagonista dell’uomo in que-sta pugna spiritualis, la letteratura assegna lineamenti aspri, materiali, dacombattente in battaglia.6 Sulla scorta della Bibbia, della teologia, della poe-sia sacra, la lotta sostenuta dal demonio non è però leale, a campo aperto:quel nemico – lo aveva già detto Iacopone – è subdolo,engannatore,agiscecon falsìa, combatte contro l’uomo una sottelissima bataglia. Più tardi,anche Dante rincalzerà le orrende prerogative del primo nemico, ripetendodi lui che ha vizi assai, è bugiardo e padre di menzogna (Inf. XXIII, 143-144), e raffigurandolo, specie nei canti di Malebolge, come un diavol nero,infido e attaccabrighe, una sorta di laida caricatura dell’angelo divenutomalvagio uccello, e dell’uomo degradato sino al “basso corporeo” (nelsegnale di partenza della compagnia diabolica di Inf. XXI, 136-139). Mentreraffigura la marcia dei dieci “nemici” (il drappello dei diavoli che sorveglia-no le boglienti pane dei barattieri, e che guidano lui e Virgilio attraverso labolgia) come un parodico corteo da battaglia o da giostra terrene.Qui Dantecoglie l’occasione per esibire un ricco vocabolario di guerra, alla cui mar-tellante, vorticosa, quasi giocosa sonorità fa da contrappunto l’immaginescomposta dell’esercito dei nemici infernali (a poco a poco però trasforma-to, nella percezione dei lettori, in compagnia di ghiottoni da taverna):
Io vidi già cavalier muover campo,e cominciare stormo e far lor mostra,e talvolta partir per loro scampo;corridor vidi per la terra vostra,
93Paola Vecchi Galli
4 Su questo ancoraggio cfr. C. Galli, Sulla guerra e sul nemico, www.griseldaonline.it.5 Il fenomeno della guerra (e della violenza civile e signorile) permea tutto il lungo periodoche denominiamo Medio Evo, dando vita a una società quasi permanentemente militarizza-ta: sul tema sono due classici i libri di F. Cardini, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultu-ra della guerra dall’età feudale alla grande rivoluzione, Firenze, Sansoni, 1982, e di P. Con-tamine, La guerra nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1986. Il rapporto fede-guerra è inveceillustrato da P. Crépon, Le religioni e la guerra, Genova, Il Melangolo, 1992, e da G. Minois,La Chiesa e la guerra. Dalla Bibbia all’era atomica, Bari, Dedalo, 2003.6 Ricordo solo di sfuggita che l’immagine della pugna spiritualis, fortunatissima nella lettera-tura, religiosa e non, del Medio Evo, trova un’espressione paradigmatica, che dà appunto vita aun topos di lungo periodo, nella Psychomachia, la battaglia dei vizi e delle virtù, di Prudenzio.Sul tema cfr.anche Bernardo di Clairvaux,Il libro della nuova cavalleria.De laude novae mili-tiae, traduzione e cura di F.Cardini,Milano,Biblioteca del Senato,2004.Per le caratteristiche deidiavoli danteschi è ancora utile il saggio di A. Graf, Demonologia di Dante, in Id., Miti, leggen-de e superstizioni del Medio Evo (1892-1893) ora:Milano,Bruno Mondadori,2002,pp.257-91.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 93
o Aretini, e vidi gir gualdane,fedir torneamenti e correr giostra;quando con trombe, e quando con campane,con tamburi e con cenni di castella,e con cose nostrali e con istrane;né già con sì diversa cennamellacavalier vidi muover né pedoni,né nave a segno di terra o di stella.Noi andavam con li diece demoni.Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa coi santi, e in taverna coi ghiottoni (Inf. XXII, 1-15).
Vi è anche uno scontro diretto, una punga (“pugna”,“battaglia”) con i dia-voli, nella Commedia, in forma di tenzone e di assalto a una città:7 è quel-la che Dante sceneggia nei canti VIII-IX dell’Inferno, quando, dopo averdescritto i misteriosi cenni di avvistamento dalla palude Stigia alle torri,assegna alla città di Dite un grande stuolo (“esercito”), alte fosse, mura diferro; e descrive la trattativa con avversari che chiudono le porte in facciaa Virgilio;quindi il nulla di fatto dei contendenti,e infine l’arrivo del Messodivino che sbaraglia ogni resistenza dei diavoli aprendo la porta con ilsemplice tocco di una verghetta, e consente ai due poeti di concluderefelicemente l’assedio sanz’alcuna guerra.La riflessione sul peccato viene insomma corredata, nell’iconografiamedievale e almeno sino a Dante,dalla visione diretta del nemico in guer-ra (Satana,appunto),ora in abiti di tentatore,ora in veste di aguzzino infer-nale, più spesso imbracciante armi (come lance, spiedi, pugnali, bastoni)che richiamano il truce corredo bellico della soldataglia del tempo.8 Visua-lizzare il diavolo significa insomma raffigurare un nemico in campo.Non basta. Proprio nel centro dell’universo è confitto il maggiore dei dia-voli, Dite (vocabolo con cui Dante denomina Lucifero o Satana in Inf. XI65, XII 39 e XXXIV 20), che di lì a poco il poeta chiamerà anche, perifra-sticamente, lo ’mperador del doloroso regno (XXXIV 28). Dunque, il dia-volo, il “nemico”, oltre che avversario nel campo della vita, è a sua voltaimperatore di un regno, il regno del male: la sua essenza infernale vienequi descritta con una transumptio che attinge all’ambito dell’umanitàcivilizzata; in altre parole pertiene, oltre che all’orizzonte spirituale, allasfera dell’uomo socializzato e mondano. Non per caso, Dite maciulla nellesue tre bocche orribili tanto i nemici di Cristo quanto quelli dell’Imperoromano, Giuda come Bruto e Cassio.Viene da pensare anche al Leopardidell’Inno ai Patriarchi (Canti,VIII) che, sulla scia del Genesi, attribuisce
94 I saggi
7 Su questo tema cfr. le riflessioni di Sergio Cristaldi sui canti VII-IX dell’Inferno, per Esperi-menti danteschi a Milano, I ciclo di letture dell’Inferno che si è tenuto presso l’Universitàdi Milano nel 2005: la lezione è disponibile sul sito www.esperimentidanteschi.it.8 Sul rapporto testo sacro-immagine nel Medioevo cfr. in particolare L. Bolzoni, La rete delleimmagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena,Torino, Einaudi,2002.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 94
l’origine della civiltà (e la conseguente fondazione della città) non tanto auna concordia solidale fra gli uomini, ma al delitto di Caino – il primonemico che un uomo abbia conosciuto – il quale
Primo i civili tetti, albergo e regnoAlle macere cure, innalza (vv. 46-47).
A un’analogia più familiare, da vita quotidiana, rinvia invece l’immaginedell’antico avversario, “pescatore” di uomini (e dunque parodia di sanPietro), di Purg. XIV 143-151. Con le parole di Virgilio a Dante:
[...] «Quel fu ’l duro camoche dovria l’uom tener dentro a sua meta.Ma voi prendete l’esca, sì che l’amode l’antico avversaro a sé vi tira:e però poco vale freno o richiamo.Chiamavi ’l cielo e ’ntorno vi si gira,mostrandovi le sue bellezze etterne,e l’occhio vostro pur a terra mira;onde vi batte chi tutto discerne».
Oppure – per mantenerci all’interno di un bestiario tradizionale – ilnostro avversaro di Purg.VIII, 95 è il serpente dell’Eden, la «biscia / forsequal diede ad Eva il cibo amaro» (ivi, 98-99).Dalla percezione (o dall’istituzione) di una figura altra, tradotta in emble-mi di guerra o di malgoverno, o in immagine di vizio e di peccato, Dantesi congeda, un’ultima volta, nella preghiera al Padre di Par. XI (vv. 19-21),insistendo sulla lotta contro un avversario che preclude, incalzando lavirtù, la pace del regno di Dio:
Nostra virtù che di legger s’adonanon spermentar con l’antico avversaro,ma libera da lui che sì la sprona.
Ciò tuttavia non basta a esaurire il tema: ad esempio, in Dante il nemicopuò essere, in un uso di minor respiro, Amore, che combatte le tradizio-nali “battaglie” dello Stilnovo. E, come è ovvio, anche la morte, e non soloquella, violenta, inferta dall’uomo a un altro uomo:Morte villana, di Pietànemica (VIII, 8, 1) è il capoverso di uno dei più famosi sonetti della Vitanova. Ma è decisiva, soprattutto, l’inimicizia dell’uomo su questa terra: dicui la cultura dell’età di Dante (o di una generazione precedente la sua)fornisce esempi innumerevoli, puntando quasi esclusivamente sull’oriz-zonte del malgoverno e del conflitto civile. Ne aveva dato un primo sag-gio Brunetto Latini nel Tesoretto (vv. 114-122):
Al tempo che Fiorenzafroria, e fece frutto,
95Paola Vecchi Galli
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 95
sì ch’ell’era del tuttola donna di Toscana(ancora che lontanane fosse l’una parte,rimossa in altra parte,quella d’i ghibellini,per guerra d’i vicini) [...].9
In questa accezione, parlare del nemico significa insomma entrare in con-tatto con la dimensione più prettamente politica dell’opera di Dante, e inparticolare della Commedia.10 Anzi, verrebbe quasi da pensare che questainimicizia sia figura (una sorta di dolorosa, fatale anticipazione) di quellache si coltiva con il diavolo all’interno e all’esterno dell’io, e di cui verràchiesto conto all’uomo dopo la sua morte.Di certo Dante non risparmia l’in-vettiva contro l’avversario politico, già a partire dal Convivio, dove i nemicidell’Impero divengono, in prospettiva escatologica, anche nemici di Dio:
Ponetivi mente,nemici di Dio, a’ fianchi,voi che le verghe de’reggimenti d’I-talia prese avete – e dico a voi, Carlo e Federigo regi, e a voi altri principi etiranni – (Cv. IV VI 10);
mentre in una pagina precedente Dante aveva dimostrato la necessità del-l’Impero proprio a partire dalle coppie oppositive guerra/pace, moltepli-ce/uno, che sono sottese alla sua percezione del conflitto:
Onde, con ciò sia cosa che l’animo umano in terminata possessione di terranon si queti, ma sempre desideri gloria d’acquistare, sì come per esperienzavedemo, discordie e guerre conviene surgere intra regno e regno, le qualisono tribulazioni delle cittadi, e per le cittadi delle vicinanze, e per le vici-nanze delle case [e per le case] dell’uomo; e così s’impedisce la felicitade. Ilperché, a queste guerre e alle loro cagioni tòrre via, conviene di necessitadetutta la terra, e quanto all’umana generazione a possedere è dato, essereMonarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe avere; lo quale, tuttopossedendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti nelli ter-mini delli regni, sì che pace intra loro sia, nella quale si posino le cittadi, e inquesta posa le vicinanze s’amino, [e] in questo amore le case prendano ogniloro bisogno, lo qual preso, l’uomo viva felicemente: che è quello per cheesso è nato (Cv. IV IV 2).
96 I saggi
9 Ricordo solo, di sfuggita (rinviando al Cd-Rom LIZ 4 per altri riscontri testuali) la straordi-naria diffusione dei lessemi guerra e nemico in autori come Bono Giamboni, Brunetto Lati-ni, Dino Compagni: a riprova di un uso di questi termini che richiama sempre l’orizzonte delconflitto civile.10 In questa prospettiva sono numerosi i rinvii bibliografici: fra i più recenti segnalo (ancheper risalire alla bibliografia pregressa) U. Carpi, La nobiltà di Dante, Firenze, Polistampa,2004; e O. Capitani, Dante politico, in AA.VV., “Per correr miglior acque…”. Bilanci e pro-spettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio,Atti del Convegno interna-zionale di Verona-Ravenna, t. I, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 57-69.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 96
In quest’ottica (o tipologia) – e nella vacanza dell’Impero – il nemico è anzi-tutto il nemico personale o di “gruppo”: in altre parole, il suo orizzonte è laguerra civile (un aspetto del conflitto radicalmente illegittimo, in quantoconsiste nel trattare il vicino e il simile come l’altro, il diverso). Di questogenere di avversari Dante dà un’immagine virulenta, da uomo animato dapassioni di parte, quasi sempre eludendo il principio evangelico di amare inemici e fare del bene a coloro che ci odiano.11 Precetto a cui la Comme-dia riserva uno solo degli exempla del Purgatorio,quando,tra i casi di man-suetudine, sceneggia il martirio di Santo Stefano, figura di Cristo:
E lui vedea chinarsi, per la morteche l’aggravava già, inver’ la terra,ma de li occhi facea sempre al ciel porte,orando a l’alto Sire, in tanta guerra,che perdonasse a’ suoi persecutori,con quell’aspetto che pietà diserra (Purg. XV, 109-114).
Mentre in una sola altra occasione – ma ci troviamo ancora nella Vitanova –, Dante si appropria del comandamento di Cristo, attribuendo aBeatrice il dono di una fiamma di caritade che, permeandolo, lo purificada ogni inimicizia e lo libera da tutti i nemici:
Dico che quando ella apparia da parte alcuna, per la speranza de la mirabilesalute nullo nemico mi rimanea, anzi mi giugnea una fiamma di caritade,la quale mi facea perdonare a chiunque m’avesse offeso; e chi allora m’a-vesse domandato di cosa alcuna, la mia risponsione sarebbe stata solamente‘Amore’, con viso vestito d’umilitade (VN XI).
Nella Commedia invece entra in gioco a pieno titolo l’inimicizia terrena; el’uso che fa Dante della parola nemico è quasi sempre al plurale, «saldandoinsieme i semantemi di hostis e di inimicus», il nemico pubblico e quelloprivato.12 Ben oltre i luoghi – non molto numerosi, per la verità – in cui sinomina espressamente il nemico, la cifra di questa inimicizia è onnipresen-te.A partire dalla profezia di Ciacco sui cittadin de la città partita, Firenze(Inf.VI, 61), che mostra dal vivo i meccanismi dell’ostilità municipale:
[...] Dopo lunga tencioneverranno al sangue, e la parte selvaggiacaccerà l’altra con molta offensione [...] (Inf.VI, 64-66).
E la percezione dell’inimicizia si allarga nell’apostrofe-invettiva contro l’I-talia del VI del Purgatorio, dove Dante abbozza un ritratto animalesco del-
97Paola Vecchi Galli
11 All’interno dell’orizzonte del perdono va tuttavia ricordato l’ultimo verso della canzonedantesca Tre donne: «che ’l perdonare è bel vincer di guerra» (Rime, 47, 107).12 Cfr. la voce Nemico, nemica di Emilio Pasquini per l’Enciclopedia dantesca, Roma, IV, Isti-tuto della Enciclopedia Italiana, 1973.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 97
l’inimicizia (gli italiani divenuti l’uno contro l’altro cani rabbiosi):
Quell’anima gentil fu così presta,sol per lo dolce suon de la sua terra,di fare al cittadin suo quivi festa;e ora in te non stanno sanza guerrali vivi tuoi, e l’un l’altro si rodedi quei ch’un muro e una fossa serra (Purg.VI, 79-84).
Va detto che questa pulsione conosce in Dante varie gradazioni di tono.Viè quella, appena accennata, dei nemici di Cangrande della Scala: ma in talcaso il campo semantico dell’inimicizia viene neutralizzato retoricamentedall’iperbole (Par. XVII, 85-87):
Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che ‘ suoi nemicinon ne poran tener le lingue mute.
Vi è, d’altra parte, una percezione del nemico quasi decorativa, forse sug-gerita dal ricordo vivo di uno scontro municipale ben risolto, quandoDante paragona il proprio timore di fronte agli avversari diabolici allapaura che lui stesso aveva visto dipingersi negli occhi dei nemici sconfit-ti alla Caprona:
Per ch’io mi mossi e a lui venni ratto;e i diavoli si fecer tutti avanti,sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto;così vid’io già temer li fantich’uscivan patteggiati di Caprona,veggendo sé tra nemici cotanti (Inf. XXI 91-96).
Altri episodi, invece, sono più sostanziosi: come quando Dante parla di unaguerra decisiva per il miles christianus, quella combattuta per la fede. Lareligione stessa è un campo di battaglia alla quale Dio ha provvidenzial-mente armato, come per una singolar tenzone, due campioni, San France-sco e San Domenico. Del secondo, in particolare, Dante dà una descrizionenel segno dell’agonismo, denominandolo amoroso drudo / della fede cri-stiana, ma soprattutto benigno a’ suoi e a’ nemici crudo (Par. XII, 55-57):
L’essercito di Cristo, che sì carocostò a riarmar, dietro a la ’nsegnasi movea tardo, sospeccioso e raro,quando lo ’mperador che sempre regnaprovide a la milizia, ch’era in forse,per sola grazia, non per esser degna;e, come è detto, a sua sposa soccorsecon due campioni, al cui fare, al cui direlo popol disviato si raccorse (Par. XII, 37-45).
98 I saggi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 98
Ma a questa guerra fa almeno una volta da contraltare la scena,di feroce regi-stro parodico, in cui Dante rovescia il senso comune della parola nemico,mostrando come, per un papa, l’avversario, il nemico per antonomasia, nonè sempre il saracino o l’eretico, ma il suo stesso perseguitato gregge:
Lo principe de’ novi Farisei,avendo guerra presso a Laterano,e non con Saracin né con Giudei,ché ciascun suo nimico era Cristiano,e nessun era stato a vincer Acri,né mercatante in terra di Soldano,né sommo officio né ordini sacriguardò in sé [...]. (Inf. XXVII, 85-92).
E ancora più decisa è la condanna di Dante quando contrappone la mili-zia del cielo alle armi sleali di un pontefice che fa la guerra a colpi di sco-munica:
O milizia del ciel cu’ io contemplo,adora per color che sono in terratutti sviati dieto al malo essemplo!Già si solea on le spade far guerra;ma or si fa togliendo or qui or quivilo pan che ’l pio Padre a nessun serra (Par. XVIII, 124-29).
In questa pluralità di motivi un dato resta fermo. L’inimicizia di Dante,tanto quella spirituale, interna all’uomo (ma esteriorizzata nel diavolo, percombatterla meglio), quanto quella di segno politico e religioso (sempreguerra civile, cioè illegittima, all’insegna della malvagità), attraversa di pre-ferenza immagini di guerra, delle quali la Commedia è, tanto dolorosa-mente, pregna. Una summa se ne può leggere nel canto dei seminatori didiscordia (“nemici di tutti”, quindi, e avversi a ogni legge e a ogni regolaumana), che si apre con una rossa visione di macello dove precipita il sub-lime (o la tragedia) della storia. Questa può dirsi, in Dante, la percezioneultima dell’inimicizia fra gli uomini, una mattanza che assorbe e livella inun’unica carneficina le guerre puniche, le conquiste normanne e gli scon-tri fra Angioini e Svevi in terra di Puglia (Inf. XXVIII, 7-21):
S’el s’aunasse ancor tutta la genteche già, in su la fortunata terra di Puglia, fu del suo sangue dolenteper li Troiani e per la lunga guerrache de l’anella fé sì alte spoglie,come Livio scrive, che non erra,con quella che sentio di colpi doglieper contrastare a Ruberto Guiscardo;e l’altra il cui ossame ancor s’accogliea Ceperan, là dove fu bugliardo
99Paola Vecchi Galli
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 99
ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzodove sanz’arme vinse il vecchi Alardo;e qua forato suo membro e qual mozzomostrasse, d’aequar sarebbe nullail modo de la nona bolgia sozzo.
È una scena sozza e allucinata che trova conferma – ma non altrettanto vivi-da – in molti altri luoghi della Commedia:non è un caso che la parola guer-ra vi ricorra complessivamente diciotto volte (dieci nell’Inferno,cinque nelPurgatorio, tre nel Paradiso).A partire dalla guerra / sì del cammino e sìdella pietate di Inf. II, 4-5, questo campo semantico e concettuale, pur rare-facendosi via via, mostra come tutto il poema sia attraversato, in ogni suacantica, dal tema del conflitto e dalla figura del nemico.Alcune regioni d’I-talia – la Romagna, ad esempio – ne ricevono una stimmate permanente,come concessione a una topica che trovava conferma nelle interminabilicontese civili consumate a memoria d’uomo in terra di Romagna.Per boccadi Guido da Montefeltro e di Dante (Inf. XXVII, 25-38):
«Se tu pur mo’ in questo modo ciecocaduto se’ di quella dolce terra latina ond’io mia colpa tutta reco,dimme se Romagnuoli han pace o guerra;ch’io fui d’i monti là intra Orbinoe ’l giogo di che Tever si diserra».E io, ch’avea già pronta la risposta,senza indugio a parlare incominciai:«O anima che se’ là giù nascosta,Romagna tua non è, e non fu maisenza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni [...]».13
Nessun dubbio che dietro questo luogo si celi, scandito (come nell’apo-strofe all’Italia, nell’exemplum di santo Stefano, nell’invettiva del Paradi-so contro le scomuniche)14 dalle parole-rima terra: guerra: (di)serra, unnodo, culturale e umano, profondo. La terra (intesa anche come “città”) fascattare nella memoria di Dante il vocabolario della guerra e l’immaginedel recinto, che racchiude o preclude, serra o disserra: insomma, la guer-ra combattuta e sperimentata da Dante – come da molti altri nel suotempo – è una tragica, particolaristica contrapposizione nei confronti delvicino, che ha il potere tremendo di escludere l’uomo dalla sua stessaidentità, resecandone le radici familiari e cittadine.
100 I saggi
13 La descrizione dei Romagnoli decaduti e dilaniati da terribili contese civili è ripresa daDante anche in Purg. XIV, 91-123.14 E si noti che la stessa serie di parole-rima (terra : guerra : diserra) è anche nel canto XIdel Paradiso, vv. 56-60 (il canto di san Francesco), e compare fra le Rime di Dante, nella can-zone Tre donne (Rime, 47): cfr. per quest’ultima E. Pasquini, La terzultima palinodia dan-tesca, «Atti della Accademia delle Scienze di Bologna», Classe di scienze morali, XXII, 1985,pp. 73-82.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 100
Se il nemico stenta a varcare le soglie del Paradiso,15 non è però vero cheDante nell’ultima cantica non nomini più, neppure di sfuggita, i proprinemici per eccellenza, gli stessi cittadini di Firenze. Solo che, ormai, l’ini-micizia ha imboccato la strada della teodicea, della lontananza-rimozione,sfiorata dagli ultimi tocchi di un amaro sarcasmo civile,di chi è guarda dal-l’alto l’aiuola che ci fa tanto feroci (Par. XXII, 151). Non è più il conflit-to bruciante che appariva nell’articolata profezia dell’Inferno sul destinofuturo di Dante. Per bocca di Brunetto Latini:
«Ma quello ingrato popolo malignoche discese da Fiesole ab antico,e tiene ancor del monte e del macigno,ti si farà, per tuo ben far, nimico;ed è ragion, ché tra li lazzi sorbisi disconvien fruttare al dolce fico [...]» (Inf. XV, 61-66).
Di certo i canti di Cacciaguida (Par. XV-XVII) sono al centro di una com-plessa (ri)scrittura che risemantizza, e soprattutto neutralizza, il camposemantico della guerra. Dante vi compila fra l’altro un’anagrafe minuziosadelle famiglie fiorentine, collocate però in un tempo remoto in cui tutti –non due soltanto – potevano dirsi giusti, e dunque pacifici. Con le paroledi Cacciaguida:
«Con queste genti, e con altre con esse,vid’io Fiorenza in sì fatto riposo,che non avea cagione onde piangesse.Con queste genti vid’io gloriosoe giusto il popol suo, tanto che ’l giglionon era ad asta mai posto a ritroso,né per division fatto vermiglio» (Par. XVI, 148-154);
e, soprattutto, adopera per Firenze le parole, mai usate prima, della pace,del dolce ostello, della fida cittadinanza, riconsacrandola come città idea-le, dove è possibile nascere, vivere e morire cristiani:
Fiorenza dentro de la cerchia antica,ond’ ella toglie ancora e terza e nona,si stava in pace, sobria e pudica (Par. XV, 97-99);
A così riposato, a così belloviver di cittadini, a così fidacittadinanza, a così dolce ostello,Maria mi diè, chiamata in altre grida;e ne l’antico vostro Batisteoinsieme fui cristiano e Cacciaguida (ivi, 130-135)
101Paola Vecchi Galli
15 È la tesi sostenuta, e splendidamente argomentata, da Carpi, La nobiltà di Dante, cit.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 101
Nel canto XXV del Paradiso, infine, il nemico muta nuovamente di segno.Non si è mai notato come, nella Commedia, questa parola ricorra per l’ulti-ma volta – e significativamente – nel medesimo verso che contiene, dinuovo per l’ultima volta, anche la parola guerra (v. 6).Ancora più straordi-nariamente, e rovesciando la contrapposizione abituale, Dante non si raffi-gura in questi versi come attorniato dai nemici, sì invece divenuto lui stessonimico ai lupi che li danno guerra. Il cambiamento di percezione è, a mioparere, decisivo: non si tratta della reazione, pur violenta, all’inimiciziaaltrui, ma finalmente dell’azione di un inerme e innocente agnello chevince la battaglia finale (quella profetica e poetica) contro i lupi che da sem-pre lo minacciano (Par. XXV, 1-9):
Se mai continga che ’l poema sacro,al quale ha posto mano e cielo e terra,sì che m’ha fatto per più anni macro,vinca la crudeltà che fuor mi serradal bello ovile ov’io dormi’ agnello,nimico ai lupi che li danno guerra;con altra voce omai, con altro velloritornerò poeta, e in sul fontedel mio battesmo prenderò ’l cappello.
Nell’illusione del ritorno l’agnello avrà la meglio sui lupi, e si realizzerà laparabola evangelica del Buon Pastore. Non nel presente, di cui la storiasancisce una volta di più il fallimento, ma nella salda prospettiva dell’eter-no – fra l’aspettativa del futuro e il ricordo del bello ovile di Firenze – l’i-nimicizia di Dante si dissolve in pace vittoriosa.
b. Petrarca: il nemico interno
Se da Dante passiamo a Petrarca, lo scenario della guerra e del nemicocambia in modo decisivo. Entrano in scena nuovi modelli epistemologiciche mettono in ombra il nemico del presente: la strada percorsa è quelladell’attenuazione, dove, più che il nemico, è messa in gioco l’inimicizia.Dopo che la Commedia ha descritto a fondo la battaglia dell’anima con-tro l’eterno avversario, e ha composto una minuziosa anagrafe dell’inimi-cizia municipale a confronto con la luce epica della pace imperiale, il sot-totono petrarchesco apre insomma le porte alla molteplicità del modernoche si confronta con l’anima dell’uomo e con l’antico.Il diavolo – l’avversario dantesco, impegnato in una guerra, continua eoggettiva, contro l’uomo – non ha grande stampa nell’opera di Petrarca.Non credo infatti che vi sia mai evocato, se non in rarissimi contesti meta-forici, il campo semantico dell’inferno (un campo estremo,non oggetto dipossibile mediazione); né che vi ricorra, se non per sommi capi e in epi-sodi isolati, la visione dell’umanità punita dalle fiamme eterne (e infatti
102 I saggi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 102
solo accennata da Petrarca, nella Nota dei peccati, nell’espressione «opor-tet [...] iudicii diem et confusionem dampnationis et eternum formidaresupplicium», o dall’eterno supplicio di De remediis II 110, De luxuria).16
In tale abbassamento di toni,delle fauci dell’avversario resta però qualchetraccia in Epystole I 6, 153-154: «ni Deus omnipotens tanto me turbine fes-sum / eripiat manibus suis de faucibus hostis»,e,con parole simili, anchein Ep. I 14. Modellata su echi danteschi è invece l’evocazione dei diavoliin un contesto santo per eccellenza, quello del trapasso di Laura (Trium-phus Mortis I, 154-156). Ma l’antico avversario di Dante, il diavolo, arretradi fronte alla “guerra” della Morte contro la donna:
Nessun degli adversarii fu sì arditoch’apparisse già mai con vista oscura,fin che Morte il suo assalto ebbe fornito.
E ancora, il nemico dell’uomo è presente nel Canzoniere,17 ad esempioquando, in RVF 81, 4 e ss., Petrarca lo chiama in causa contrapponendogliun grande amico, Cristo (e si noti la sottile trappola semantica, che indu-ce il lettore a identificare il diavolo con Amore):
Io son sí stanco sotto ’l fascio anticode le mie colpe et de l’usanza riach’i’ temo forte di mancar tra via,et di cader in man del mio nemico.Ben venne a dilivrarmi un grande amicoper somma et ineffabil cortesia;poi volò fuor de la veduta mia,sí ch’a mirarlo indarno m’affatico.Ma la sua voce anchor qua giú rimbomba:O voi che travagliate, ecco ’l camino;venite a me, se ’l passo altri non serra.Qual gratia, qual amore, o qual destinomi darà penne in guisa di colomba,ch’i’ mi riposi, et levimi da terra?
E se è vero che in questo sonetto Petrarca è debitore soprattutto alla Bibbia(dai Salmi al Vangelo di Matteo),18 anche in RVF 62 l’immagine del duro
103Paola Vecchi Galli
16 Neppure i Psalmi penitentiales fanno eccezione a questa scelta teorica e espressiva. Il quadrodella morte spirituale e della piaga purulenta del peccato del VI Psalmus penitentialis è, a benguardare, una presenza rara, dove è la rusticitas del modello biblico a giustificare l’oltranza deivv.2 e 10: «Obtorpui infelix et contremui vehementer:horror mortis superastitit michi. [...] / Illicvulnus situ putruit; illic vite mee metuo; illic, Domine, manus tuas adhibe velociter»: cfr. F. Petrar-ca,Psalmi penitentiales, a cura di R.Gigliucci,Roma,Salerno Editrice,1997,pp.51-53. Il testo diDe remediis è citato da Pétrarque,Les remèdes aux deux fortunes, De remediis utriusque for-tune, Préface de G.Tognon, Introduction, notes et index par C. Carraud, Grenoble, Millon, 2002.17 E cfr. anche la canzone alla Vergine, RVF 366, 72-75: «Ma pur in te l’anima mia si fida,/pec-catrice, i’ no ’l nego,/Vergine; ma ti prego/che ’l tuo nemico del mio mal non rida».18 Cfr. in proposito il commento di Rosanna Bettarini a F. Petrarca, Il Canzoniere.Rerum vul-garium fragmenta,Torino, Einaudi, 2005, I, pp. 410-11.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 103
adversario lascia aperta un’ambiguità (fra il diavolo della tradizione cristia-na e Amore) che – lo abbiamo visto – non è isolata nel Canzoniere (cfr.RVF107, 13 e 360, 76):
Padre del ciel, dopo i perduti giorni,dopo le notti vaneggiando spese,con quel fero desio ch’al cor s’accese,mirando gli atti per mio mal sí adorni,piacciati omai col Tuo lume ch’io torniad altra vita et a piú belle imprese,sí ch’avendo le reti indarno tese,il mio duro adversario se ne scorni (vv. 1-8).
Si percepisce, insomma, una desemantizzazione dell’avversario spirituale,che quasi si identifica con il peccatore medesimo e le sue tentazioni: in altreparole,quando parla del nemico,Petrarca pensa soprattutto alle proprie pul-sioni e passioni, e solo raramente chiama in causa l’altro dall’uomo, Satana.La polisemia del nemico si arricchisce così di nuove sfumature.Val la penaosservare, ad esempio, che la parola guerra ricorre ben trentuno volte nelCanzoniere: e che il suo significato via via trapassa, nella seconda parte dellibro di poesia,dalla guerra cortese contro Amore e la dolce nemica o dolceguerrera (Laura) a una guerra ben più decisiva combattuta dall’amante aproprio danno, contro la propria salvezza eterna. In particolare, i due com-ponimenti finali del Canzoniere (un sonetto e la Canzone alla Vergine)richiamano senza soluzione di continuità – per di più collegati da una sotti-le connessione intertestuale – una “guerra” spirituale di cui non è neppureindicato il nemico (a meno che esso non sia alluso dal possessivo mia cheprecede la parola guerra), ma per la quale sono invocati due alleati, il Re ela Regina del cielo. E si noti che, rispetto a Dante, la rima guerra: terra diRVF 366, 12-13, non evoca l’immagine della città, sì invece la natura del-l’uomo, pulvis terrae nella Bibbia e in Agostino.
RVF 365:
I’ vo piangendo i miei passati tempii quai posi in amar cosa mortale,senza levarmi a volo, abbiend’io l’ale,per dar forse di me non bassi exempi.Tu che vedi i miei mali indegni et empi,Re del cielo invisibile immortale,soccorri a l’alma disvïata et frale,e ’l suo defecto di tua gratia adempi:sí che, s’io vissi in guerra et in tempesta,mora in pace et in porto; et se la stanzafu vana, almen sia la partita honesta.A quel poco di viver che m’avanzaet al morir, degni esser Tua man presta:Tu sai ben che ’n altrui non ò speranza.
104 I saggi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 104
RVF 366, vv. 1-13:
Vergin bella, che di sol vestita,coronata di stelle, al sommo Solepiacesti sí, che ’n te Sua luce ascose,amor mi spinge a dir di te parole:ma non so ’ncominciar senza tu’ aita,et di Colui ch’amando in te si pose.Invoco lei che ben sempre rispose,chi la chiamò con fede:Vergine, s’a mercedemiseria extrema de l’humane cosegià mai ti volse, al mio prego t’inchina,soccorri a la mia guerra,bench’i’ sia terra, et tu del ciel regina.
In parallelo, la parola pace (37 volte nel Canzoniere) è l’ultima dei Frag-menta, e subisce la stessa evoluzione spirituale (dal campo semantico delpeccato d’amore a quello della pacificazione delle passioni e del libro,evocate nei primi versi di 316, 1-2: «Tempo era omai da trovar pace o trie-gua/ di tanta guerra, et erane in via forse»):
Raccomandami al tuo figliuol, veracehomo et verace Dio,ch’accolga ’l mïo spirto ultimo in pace.
Nemico dell’uomo è l’uomo stesso, mentre la scoperta dell’Io comporta ilpotenziamento delle forze oscure che lo tengono in balia. Penso ad esem-pio alla Institutio regia della Fam. XII 2 a Nicola Acciauoli, gran Siniscal-co del re di Napoli.19 Persino l’educazione del sovrano, il giovane re Luigi,prevede pause di introspezione che sembrano tolte di peso dal Secretum,piuttosto che da uno Speculum principis:
Nulla homini pertinacior lis quam cum animo moribusque suis; nusquamminus indutiarum; intra murum pugna est (§ 6);
[...] scies unum esse laboris et vite finem tibique et omnibus claris virisisque ad extremum spiritum vel cum visibili vel cum invisibili hoste luctan-dum fore (§ 8).
Più che il diavolo, a Petrarca stanno a cuore i nemici veri dell’uomo, idomestici hostes che «intus interea animum oppugnant atque expugnant»(De remediis I, 91, 16): in altre parole i suoi peccati e le sue debolezze. Eancora (ibidem):
105Paola Vecchi Galli
19 Sulla lettera e il suo significato politico-morale,cfr.M.Feo,Politicità del Petrarca, in AA.VV.,Il Petrarca latino e le origini dell’umanesimo, I, «Quaderni petrarcheschi», IX, 1992-1993,pp. 116-28. La citazione delle Familiares è, qui e di seguito, da F. Petrarca, Opere, vol. I, Intro-duzione di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 1975 (con traduzione di E. Bianchi).
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 105
Vera et firma potentia in virtute fundata est. Fundamentum si detraxeris,quomaior, eo periculosior structura. Quod implere opibus domos ouvat, arvalegionibus, maria classibus, si intus interea domestici hostes animum oppu-gnant atque expugnant? Vis ut te potentem fatear: illos doma finibusque tuispelle, vince iram, vince cupiditatem, vince libidinem, vince teipsum, fameatque anime hostem tue. Quenam ista potentia est vincere alios, passioni-bus suis vinci?
È straordinaria questa progressiva introiezione dell’avversario – fatto tut-t’uno con il soggetto –; e straordinaria anche, in parallelo, la sottrazionedella guerra e del nemico alla sfera d’azione del soggetto. Che è anzi, nelDe remediis, esortato dalla Ratio a rinunciare alla vendetta, a non goderedella morte del nemico («Quomodo de illius morte gaudeas quem dilige-re iubearis, non ut hostem, sed ut proximum eiusdem opus opificis?», Deremediis I, 104, 12); in una rimozione sempre più ferma del conflitto chesi sviluppa in trattatelli dai titoli eloquenti (De remediis, I 90, 91, 92, 97,101, 102, 103, 104, 105, 106): De tranquillo statu, De potentia, De gloria,De exercitu armato, De vindicta, De spe vincendi, De victoria, De ini-mici morte, De spe pacis, De pace et indutiis. Di nessun valore è la vitto-ria dell’uomo su un altro uomo; terribile la morte di un nemico, che è inrealtà tuo consorte:
Si quam vestre conditionis memoriam haberetis, nunquam homo de mortehominis gauderet; quando enim, queso, duorum, qui simul ad suppliciumducerentur, alter alterius de morte gaudium cepit, sciens sibi idem suppliciigenus instare et non potius in illius morte sua cogitans ingemuit? (De reme-diis I, 104).
Con una sfumatura un po’ diversa, invece, nella Fam. X 3, 25 a GherardoPetrarca dice del fratello da poco convertito (la lettera è del 1348) che èdiventato «vir Deo ex hoste familiaris, ex adversario civis»: in questo casoè l’uomo, quasi alter ego e alleato del diavolo, a essere nemico (hostis eadversarius) di Dio, mentre il monaco Gherardo è ora familiaris e civisdella “città di Dio”.Questa trattata finora è la guerra introspettiva e spirituale, il cui nemico èinterno; ed è centrale nell’opera di Petrarca. Dall’infinita polisemia eambiguitas petrarchesca si sviluppa però anche una guerra diversa, cheDante non ha conosciuto con questa ampiezza: che non coincide con lamalvagità, ma con la civiltà. È un conflitto esterno, di Roma contro i bar-bari; escludente in quanto inteso a contrapporre orizzonti diversi di civil-tà (non più la dantesca respublica christiana, ma la nuova respublica lit-terarum).Su un versante politico, anche Petrarca conosce, come Dante, il nemico inarmi: sua è la massima Dum erunt homines non deerunt hostes (Deremediis I, 103, 18: De victoria). Non fosse altro, la sua grande canzonepolitica, Italia mia (RVF 128) – che mette in scena le consuete guerre
106 I saggi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 106
intestine della penisola, ora aggravate dall’incognita delle truppe merce-narie straniere, destinate a divenire una costante della politica italiana neisecoli futuri –, ne è la conferma. Così come conobbe e praticò l’ostilitàmunicipale, e prese parte, almeno per qualche anno, al progetto utopisti-co di restaurazione repubblicana – non privo di eccessi ai danni degliavversari – di Cola di Rienzo.Tutto ciò basti per accennare che i tempi di Petrarca furono tempi diaspri conflitti (la Guerra dei cento anni, ad esempio), e che egli ebbemodo di percepirlo con chiarezza, oscillando tra riflessioni de inquietototius orbis statu (Fam. XV 7) e premonizioni de mutatione temporum(Sen. X 2), mentre l’Europa «si sfinisce con grave reciproca guerra».20 Datale percezione traggono forza soprattutto alcuni fra i mitologemi piùduraturi della cultura europea, come la contrapposizione umanistica fraciviltà romana e germanica: contrapposizione a cui Petrarca connette ilricordo di una civiltà in armi sempre vittoriosa (e la seconda guerra puni-ca ne è l’emblema):
Aspice Romanos animos: cum semper, tum presertim bello Punico secundo,non tanta defectione sociorum, non conspiratione regum ac gentium, nontot infelicibus preliis ac ruinis pene ultimis victi sunt,nulla unqam apud illospacis mentio, nullum diffidentie vestigium, nulla denique nisi alta prorsus etinvicta consilia. Hoc sane quid est aliud quam virtute animi fortune duritiemmollire, atque illam in pudorem sui et amorem tui cogere? Tandem igitur, utdignum erat, emersere, et millies strati surrexere altius, ut non hostestantumsuos modo tam formidabiles, sed totum mox ex ordine terrarum orbem, vir-tus illis ac fortuna subiceret (De remediis II, 73, 6: De infausto prelio).
La questione non riguarda solo lo scontro fra due Comuni o due Signorieitaliane, o il proprio, privato, destino politico: l’Italia intera è chiamata arispondere del proprio valore contro il furor di lassù (la non-civiltà deibarbari del Nord Europa). Petrarca che si accinge a diventare, con l’Uma-nesimo, modello e maestro della civiltà europea ha fortissimo il senso del-l’inimicizia e dell’inferiorità dei popoli d’Oltralpe. Il grido «vertù contrafurore / prenderà l’arme, et fia ’l combatter corto: / ché l’antiquo valore /ne l’italici cor’ non è anchor morto» (128, 93-96) diventerà, nei secoli, unadelle più famose citazioni petrarchesche, ripresa anche da Machiavelli nel-l’ultimo capitolo del Principe.Il nemico politico entra in tal modo in letteratura (diventa un nemico cul-turale), e assume un profilo riconoscibile all’interno di una tradizione distudi che ancora non possono dirsi politici, ma semmai eruditi e antiqua-ri. Sono innumerevoli i luoghi dove Petrarca delinea il mito di Roma anti-ca, cui si oppone una barbarie che si identifica, di volta in volta, di tempo
107Paola Vecchi Galli
20 Mi si permetta di rinviare in proposito a P.Vecchi Galli, L’identità europea: il caso “Petrar-ca”, in Francesco Petrarca intellettuale e poeta cristiano agli albori dell’età moderna,Bologna, Quaderni della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2004, pp. 97-108.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 107
in tempo, con gli avversari di quella.21 Nasce – e durerà per tutto il corsodell’Umanesimo – il nemico per antonomasia della civiltà latina: il Carta-ginese (Annibale, a cui si contrappone l’eroe repubblicano, Scipione Afri-cano), nell’Africa e nel De viris illustribus (due opere dove ricorre osses-sivamente il campo, metaforico o reale, della guerra e del nemico); masono nemici anche il tedesco furor; il barbaro britanno, fautore di un filo-sofia priva di humanitas; e il Gallus, nella Invectiva contra eum quimaledixit Italiae.22 In quest’ultima operetta, in particolare, Petrarca tornaancora sul mito di Roma – ora, nelle sue aspettative, di una Roma cristiana– superiore all’Europa intera: ciò che era già stato detto nella canzone Ita-lia mia (RVF 128, vv. 33-51):
Ben provide Natura al nostro stato,quando de l’Alpi schermopose fra noi et la tedesca rabbia;ma ’l desir cieco, e ’ncontr’al suo ben fermo,s’è poi tanto ingegnato,ch’al corpo sano à procurato scabbia.Or dentro ad una gabbiafiere selvagge et mansüete gregges’annidan sí che sempre il miglior geme:et è questo del seme,per piú dolor, del popol senza legge,al qual, come si legge,Mario aperse sí ’l fianco,che memoria de l’opra ancho non langue,quando assetato et stanconon piú bevve del fiume acqua che sangue.Cesare taccio che per ogni piaggiafece l’erbe sanguignedi lor vene, ove ’l nostro ferro mise.
Il nemico si incarna in forme diverse: ma dalla storia e dalla civiltà diRoma, divenuta da repubblicana imperiale e cristiana, Petrarca recupera ilsignificato del presente e il valore di una contrapposizione a un nemicoche definisce barbaro. Ed è perciò interessante che, nel fervore dell’in-vettiva, Petrarca adotti un linguaggio da combattente, per sé e per il pro-prio avversario: entrambi sono nemici in campo,hostes, e quasi al terminedel libello Petrarca affermerà:
108 I saggi
21 Sul tema, che ha alle spalle una bibliografia vastissima, rinvio a A. Giardina-A.Vauchez, Ilmito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari, Laterza, 2000 (con numerosi rinviia Petrarca); e, per altri approfondimenti, M. Fumaroli, Rome dans la mémoire et l’imagina-tion de l’Europe, Roma, 1997.22 Se ne veda il testo (con trad. it.) in F. Petrarca, Opere latine, a cura di M.A. Bufano, Intro-duzione di M. Pastore Stocchi, Milano, UTET, 1975, II, pp. 1153-1253 (da cui si cita). Una sche-da dell’opera, a cura di M. Berté, in Petrarca nel tempo.Tradizione lettori e immagini delleopere, a cura di M. Feo, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 2003, pp. 432-34.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 108
Ego tamen externo et valido bellatore non moveor, sed in mea opinione per-sisto, quam, ut reor, experientia veritasque adiuvant (Contra eum qui male-dixit, p. 1232).
Ancora più interessante è la riflessione su un certo nemico privato che sisviluppa in queste e in altre pagine di Petrarca. Non si tratta, come inDante, di descrivere la calunnia delle corti – morte comune nella poesiadel Medioevo –, né l’avversario politico, ma il nemico intellettuale e per-sonale, che spesso condivide le tue stesse ambizioni ma è mosso dall’invi-dia; che è ostile per il gusto di danneggiare, e sparla e critica.A tale avver-sione è speculare (ed è antidoto) l’amicizia. Da Fam. IX 5, 6 (a Ugolinovescovo di Parma):
Claude, precor, aurem susurronibus animumque tuum in silentio de rebusmeis interroga; is me hostem tuum negabit animumque fatebitur; illos autemveros hostes, qui virus absconditum et fel melle permixtum sub labiis grunt,quo gemerosam animam latenter infiiant et preclaram famam infami verbo-rum verborum veneficio decolorent, non sine amicitiarum iactura, qua vixalia nobilibus animis maior sit.
Con maggiore intensità, punto dagli strali polemici dei suoi detrattori(quattro aristotelici veneziani), nel De sui ipsius et multorum ignorantia(e nella Sen.V 2), Petrarca darà dell’invidia, che fomenta questa inimiciziapervertendo l’umana benevolenza, una descrizione espressiva, sul filodelle indicazioni dottrinali di Gugliemo Peraldo e di Pietro Bersuire.23 Inquesta luce, l’invidia stessa – avulsa dall’uomo – è il nemico, che impegnaa un insolitum pugne genus, «scende in campo armata di faretra, aggredi-sce a colpi di freccia, e ferisce di lontano» (De ignorantia, 5).Ma in particolare colpisce che proprio il mestiere del letterato sia visto daPetrarca come una battaglia, anzi come una guerra contro rivali che sem-pre lo costringono, pur desideroso di pace, al conflitto: «Nunquam ne igi-tur quiescemus? Semper conflictabitur hic calamus?» (De ignorantia, 1);«Avidissimus pacis in bellum cogor» (ivi, 3); e ancora: «Operosa et difficilisres est fama, et precipue literarum. Omnes in eam vigiles atque armatisunt. [...] intento animo ereptisque auribus semper in acie standum est»(ivi, 53). Oppure, con metafore un po’ diverse, questo nemico si arma deipropri libri come di truppe mercenarie, osa scendere in campo senzadichiarare guerra apertamente all’avversario, ma lo colpisce da lontanocon fragili saette (Contra eum qui maledixit, p. 1156).È qualcosa di più e di diverso dalla “guerra di parole” (partimen, certa-
109Paola Vecchi Galli
23 Ad esempio, con l’immagine della rabida invidia, e degli invidiosi come cani latranti. Del-l’invidia, subita e descritta da Petrarca, ha dato un robusto quadro teorico e analitico C. Poli-to, «Inter cunctas eminens obliqui causa iudicii livor». Annotazioni in margine al Deignorantia petrarchesco, «Studi e problemi di critica testuale», 41, 1990, pp. 5-28 (anche conqualche rinvio alla poesia volgare petrarchesca). L’edizione consigliata del De sui ipsius etmultorum ignorantia è quella a cura di E. Fenzi, Milano, Mursia, 1999 (da cui si cita).
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 109
men, disputatio)24 con cui la cultura del tempo affronta i temi del saperenelle aule universitarie e nelle diatribe dottrinali. Petrarca la descrive così:
Sane in hac tanta scientie inopia, ubi implumes alas vento aperit humanasuperbia, quam frequentes et quam duri scopuli! Quot quamque ridiculephilosophantium vanitates! Quanta opinionum contrarietas, quanta pertina-cia, quanta protervia! Qui sectarum numerus, que differentie, quenam bella,quanta rerum ambiguitas, que verborum perplexitas! (De ignorantia, 203).
Anche dentro le mura delle Atene celestiali vi sono dunque nemici, e nonsempre, pur nel riparo dell’otium, all’intellettuale più solitario e intro-spettivo è concessa la pace:
Doctis, facie licet incognitis, inter se cogitatio multa est, nisi hanc livor autexcellentie appetitus abrupuerit [...]. Quibus quandoque cessantibus,novum dictu, claros inter viros esse videtur emulatio quedam, quasi ventisquiescentibus tuens mare, cuius duplicem rei causam apud quosdam lego.Una est favor discipulorum atque sequacium, qui libentius quieturos contra-riis sententiis in certamen trahit; altera vero paritas ipsa, que, sine sensueorum qui in comparationem adducuntur, spectantium iudiciain diversumagit, ut quamvis in se concordes duo viri et passionibus liberi, videanturtamen inter se taciti, quasi duo propinqui montes, aut totidem turres escel-se, de altitudine eminentiaque contendere (De ignorantia, 215-216).
La riflessione su questa inimicizia si traduce in presa di distanza di Petrar-ca dalla cultura del suo tempo, dalla Scolastica, dalla dialettica, dalla medi-cina: dalla scienza litigiosa dei moderni come dalle forme tradizionali delsapere. Pur nella contrapposizione, e in nome dell’«impegno etico»(Fenzi), Petrarca aspira a semplicità espressiva, non al soccorso di una fru-sta retorica; si sottrae alla disputa (puntando semmai, come nel Secretume nel De sui ipsius, al dialogo e al colloquio), attenuando l’asprezza innome di una verità che, percorsa dal dubbio, appartiene – o potrà appar-tenere – anche all’avversario (la paritas del De ignorantia). Semmai, persuperare la bellicosità insita nel conflitto intellettuale, Petrarca inventa,per i docti – anche se collocati su fronti contrapposti – un avversario cheli accomuna, gli indocti:
Solent enim docti indoctis esse odii ac stupori; horum illi igitur, modo facul-tas affulserit, famam rodunt. (De ignorantia 215).
110 I saggi
24 Tema sul quale rinvio, per le linee generali e per il periodo che da Petrarca porta allamodernità, a Sapere e/e` potere. Discipline, Dispute e Professioni nell’Universita` medie-vale e moderna. Il caso bolognese a confronto.Forme e oggetti della disputa delle arti, vol.I, a cura di L.Avellini, Bologna, Comune di Bologna - ISB, 1990, pp. 259-279. Per altri aspetti,è invece importante F.Tateo, Il dialogo da Petrarca agli umanisti, in Il Petrarca latino e leorigini dell’Umanesimo, II, pp. 537-554.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 110
Ma, soprattutto, il combattimento spirituale e ideologico spesso non negalegittimità al contendente; anzi tenta di includerlo nella sfera “affettiva” emorale del soggetto. Eludendo lo scontro dottrinale, scartando dal pianodella scienza al piano della virtù e della sapientia, Petrarca può rimuove-re persino il nemico che più è suo – l’avversario intellettuale – nel nomedell’amore, dell’aspirazione al bene e della comune, condivisa e consape-vole ignorantia:25
Itaque longe errant qui in cognoscenda virtute, non in adipiscenda, et multomaxime qui in cognoscendo, non amando Deo tempus ponunt (De igno-rantia, 149).
Aliud est enim scire atque aliud amare,aliud intellegere atque aliud velle […]Quid profuerit autem nosse quid est virtus, si cognita non ametur? […]Tutius est voluntati bone ac pie quam capaci et claro intellectui operamdare.Voluntais siquidem obiectum, ut sapientibus placet, est bonitas: obiec-tum intellectus est veritas. Satius estautem bonum vellequam verum nosse.Illud enim merito numquam caret; hoc sepe etiam culpam habet, excusatio-nem non habet (ivi, 144-148).
Nil superest aliud, nisi […] amicos reliquos censoresque simul meos preceratque obsecrem ut deinceps me, etsi non ut hominem literatum, at ut virumbonum, si ne id quidem,ut amicum,denique si amici nomen pre virtutis ino-pia non meremur, at saltem ut benivolum et amantem ament (ivi, 220).
In questa prospettiva sta la modernità di Petrarca, che sperimenta le tem-peste dell’animo come le guerre di civiltà, ma non trasmuta nell’inumani-tà dell’ostilità assoluta: il combattimento spirituale non ha ancora uccisolo spirito, come invece avverrà nel XX secolo.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/4vecchi_galli.htm.
111Paola Vecchi Galli
25 Su questo tema si veda in particolare quanto scrive Fenzi, Introduzione del De ignoran-tia, in particolare pp. 65 ss.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 111
Ammalato? Ammaliato! Il corpo incantato di Torquato Tasso Fabio Giunta
Torquato Tasso, secondo quanto scriveva il Solerti nella celebre biografia,«credeva nell’arte maga o naturale o demonica, perché ne aveva tanti esem-pi da non poter dubitare. Era forse un principio di allucinazione».1 La valuta-zione del Solerti può costituire una sorta di appiglio per una breve indaginecirca la vicenda magica vissuta dal Tasso.Ma ad essa si debbono subito affian-care le considerazioni di Ezio Raimondi, nel suo saggio memorabile Tragrammatica e magia, dove il magico demoniaco – visto come un’allucina-zione,un’angoscia solitaria che opprime l’animo disarmato del poeta – diven-ta «l’assedio minaccioso di un mondo inafferrabile di fruscii, di voci (“tintin-ni di orioli da corda”, ripetono i suoi racconti, a distanza di anni...), di fanta-smi che egli crede di percepire e di cui si sente vittima,prigioniero infelice».2
Non si tratterà qui della malinconia del Tasso la cui ricostruzione ha forsescarsa rilevanza per la storia della letteratura. Si vedrà piuttosto, fra le letteredel poeta, come questo “temperamento” malato abbia permesso al Tasso diessere annoverato tra i poeti in preda al “furor”.Successivamente si potrà evi-denziare quanto, in merito alle cause delle disgrazie del poeta,può attribuirsialle sue personali convinzioni e quanto alle credenze dell’epoca in cui visse.
Nell’epistolario tassiano
È ormai noto come il nesso genio-follia,3 associabile all’umore nero dei“saturnini”, sia stato ricodificato nel De vita4 di Marsilio Ficino5 e, grazieall’opera dell’alter Plato, la melanconia verrà d’ora in poi considerata perantonomasia la «malattia dei letterati».
112 I saggi
1 A.Solerti,Vita di Torquato Tasso, vol. I,La vita,Torino-Roma,Loescher,1895,p.215.Per unabibliografia sul “meraviglioso” e “diabolico” tassiano si legga G. Baffetti, Rassegna tassiana(1987 – 1998), in «Lettere italiane», 3, 1998, pp. 416-445.2 E. Raimondi, Rinascimento inquieto,Torino, Einaudi, 1994, p. 173.3 Il concetto deriva dallo pseudo-Aristotele dei Problemata (XXX, 1) il quale tenta di giusti-ficare il binomio genio-follia alla luce della scienza razionale dopo aver unificato la nozionepuramente medica della melanconia e la concezione platonica del furore.4 Ficino, associando Democrito alla coppia Platone-Aristotele scrive: «Democritus, et Plato, etAristoteles asserant,melancholicos nonnullos interdum adeo ingenio cunctos excellere,ut nonhumani, sed divini potius videantur», in Marsilii Ficini ... Opera ..., Basilea, 1576, vol. I, De vitatriplici libri tres, L. I, c. 5, p. 497. E nell’epistola De divino furore scrive, citando Democrito ePlatone, «non arti modo a studio, sed et multo magis divino illo furori», ibid., p. 612.5 Marsilio Ficino (1433-1499). Filosofo neoplatonico,umanista. Fondò l’Accademia platonica.Tradusse gli Inni attribuiti a Orfeo e Omero, la Teogonia di Esiodo, le Argonautiche di Apol-
9
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 112
È quindi il filosofo neoplatonico a rilanciare la figura dell’uomo modernominacciato da un’interna scissione. Il Tasso, dal canto suo, ha saputo con-segnare al mondo e alla storia, come benissimo ha ricostruito Bruno Basi-le,6 l’immagine di un artista che, proprio come Empedocle, Maraco, Socra-te,Platone,Lucrezio, avrebbe elevato il proprio ingegno e le personali dotiartistiche grazie all’influenza di Saturno e all’azione della malinconia.In una lettera del 1589 indirizzata al medico Giovann’Antonio Pisano, è lostesso poeta avanzando la richiesta di veratro, a suggerire un’analogia fraDemocrito (curato da Ippocrate7 appunto con il veratro) e se stesso. IlTasso accredita così la propria immagine di poeta affetto da morbus sacerin maniera non molto dissimile da Democrito, il filosofo “folle” per eccel-lenza della Grecia classica:
Ma essendo stata opinione d’alcuni, che la distillazione del capo sia la prin-cipal cagione de l’infermità, non posso trapassar con silenzio quel che scri-ve Ippocrate a Democrito: «Veratro helleborato eos, quibus de capite distil-lat rheuma». E benchè ciò sia detto con alcuni avvertimenti e con alcunecondizioni; a me, nondimeno, molto piacerebbe l’esser purgato co ’l veratro,sì perchè questo è antichissimo medicamento, sì per gli eroi e per gli filoso-fi che similmente furono medicati.8 Per conclusione addurrò quel dettod’Ippocrate ne le Epistole: «Totus homo est morbus, et sui auxilii servus.»Io son tutto infermità:e se debbo esser servo del mio aiuto,di chi sarò servo?Sinora son di me stesso, ed a me stesso comando.9
113Fabio Giunta
lonio Rodio, le opere di Platone, Plotino, Porfirio, Dionigi l’Areopagita e il Corpus Hermeti-cum. Cercò di conciliare cristianesimo e paganesimo, filosofia e religione. Scrisse una Theo-logia platonica dove si espone l’idea della natura intermedia dell’uomo che, trovandosi alcentro dell’universo, è arbitra di ascenderne e discenderne i gradi.6 B. Basile, Poëta melancholicus.Tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso, Pisa, Pacini,1984.7 Ippocrate (460 a.C. c.ca – 377 a.C. c.ca). Il medico che pose le basi della medicina scientifi-ca. Le sue opere portarono al superamento della medicina sacerdotale e magica e all’avventodi una scienza medica fondata sull’osservazione e sul ragionamento. Pervenne inoltre alla for-mulazione della cosiddetta dottrina umorale, destinata a influenzare le concezioni della pato-logia fino ai nostri giorni. Le opere di Ippocrate, della sua scuola e dei suoi seguaci, scritte indialetto ionico, furono raccolte per la biblioteca di Alessandria in un Corpus hippocraticumche consta di cinquantatré scritti in settantadue libri. La prima edizione latina del Corpus fustampata a Roma nel 1525; quella del testo greco a Venezia, nel 1526, da Aldo Manuzio.8 Interessante leggere a questo proposito una bella pagina di Piero Camporesi che in tono quasidivertito scriveva: «L’elleboro,erba fatata nella cultura pagana,oggetto di attenti cerimoniali apo-tropaici durante la raccolta, considerata “medicina sacra” da Areteo, rimedio elettivo contro lapazzia, erba liberatrice e purificatrice, ritenuta unico argine al dilagare della mostruosità elefan-tiaca (o lebbrosa), riacquista un particolare favore nella “medicina santa” della Controriformarilanciata proprio dai nuovi dottori di quella medicina cristiana che in Battista Codronchi avevaavuto un teorico rigoroso. [...] Proprio negli stessi anni [’90 del XVI secolo], il “melanconico” e“frenetico”Tasso che dalla “caverna del niente”entrava ed usciva assiduamente, unto d’unguen-to populeon, sciroppato di papavero, di “diacatholicon”, infuso di “hiera”, euforizzato, e confor-tato dal pharmacopola di corte,visitato da folletti e dialogante dottamente con spiriti aerei,consfolgoranti messaggeri celesti,alzava un inno alla farmacopea magica a sfondo psicotropo e allu-cinogeno», in La carne impassibile, Milano, Garzanti, 1994, pp. 147-148.9 Le Lettere di Torquato Tasso, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853-1855, IV, (n.1139), p. 212. Ma altri brevi cenni topici a Ippocrate e Democrito li troviamo in altre due let-tere di qualche anno più avanti. Si tratta della n. 1422 («Sono soggetto a molti mali che mi
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 113
Il riferimento all’irrisione democritea ci rimanda a una precedente letteratassiana del 1 ottobre 1587 scritta a Scipione Gonzaga10 nella quale il Tassodescrive la propria condizione:
Io son poco sano, e tanto maninconico, che sono riputato matto da gli altri eda me stesso, quando non potendo tener celati tanti pensieri noiosi, e tanteinquietudini e sollecitudini d’animo infermo e perturbato, io prorompo inlunghissimi soliloqui; li quali se sono da alcuno ascoltati (e possono esser damolti), a molti son noti i miei disegni, e quel ch’io speri, e quel ch’io deside-ri. La medicina de l’animo è la filosofia, con la quale io mi medico assai spes-so. Laonde comincio a rider di tutti i miei infortuni, e di tutti i disfavori ch’ioricevo: che più? Rido ancora de la mala opinione c’hanno gli uomini di me, ede la mia passata sciocchezza, con la quale io la confermai: ma questo riso ècosì vicino al furore, ch’ho bisogno di veratro, o d’altro sì fatto medicamen-to che risani il corpo ripieno di cattivi umori, e purghi lo stomaco, dal qualeascendono al cervello alcuni vapori che perturbano il discorso e la ragione.11
Tasso ride dei suoi “infortuni” e “disfavori” e della sua “passata sciocchez-za”. Ed è proprio questo riso che ci fa pensare al filosofo folle che ridevadella stoltezza degli uomini quasi come la derisione del mago d’Ascalona:«e di me stesso risi e de le fole / che già cotanto insuperbir mi fèro».12 Malo stesso riso induce infine quel “furore”che lo spingerà a richiedere delledosi di veratro. In effetti Tasso riesce in questo modo a includere in sé econcentrare due personaggi: il Democrito “ridens” che schernisce lameschina e presuntuosa incompiutezza dell’umano agire e l’Eraclito“flens” divenuto egli stesso folle dopo il pianto per la pazzia del mondo.Ma veniamo ora alla convinzione che il Tasso nutriva circa le cause occultedella sua sofferenza atrabiliare. È nella famosa lettera del 18 ottobre 1581 aMaurizio Cataneo che la componente diabolica filtrata dall’elemento magi-co fa il suo ingresso nell’epistolario tassiano. Il poeta lamenta due tipi di dis-turbi. Quelli «umani», consistenti in «grida di uomini, e particolarmente didonne e di fanciulli, e risa piene di scherni, e varie voci d’animali» e «strepi-ti di cose inanimate». E i disturbi «diabolici» che invece constano di «incantie malìe», dove persino i topi «paiono indemoniati». Ma soprattutto, dichiarail poeta, «mi pare d’esser assai certo, ch’io sono stato ammaliato: e l’opera-zioni de la malia sono potentissime». Così potenti da risuonargli nelle orec-chie «voci» nelle quali distingue « i nomi di Pavolo,Giacomo,Girolamo,Fran-
114 I saggi
gravano qual più qual meno; e posso conchiudere con Ippocrate, che homo totus sit mor-bus», p. 123, Roma, 12 novembre 1592) e della n. 1452 («... quantunque io impazzi comeDemocrito», p. 145, Roma, 10 aprile 1593).10 Scipione Gonzaga (1542-1593). Cardinale e letterato. L’imperatorie Massimiliano gli con-ferì il titolo di principe dell’Impero; Sisto V lo creò patriarca di Gerusalemme e cardinale.Fondò a Padova l’accademia degli Eterei; fu amico e protettore del Tasso, che lo volle tra irevisori del suo poema.11 Lettere…, cit., III, (n. 899), p. 263.12 Gerusalemme Liberata, XIV, 46, 3-4.13 Lettere, II, (n. 190), p. 161-162.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 114
cesco,Fulvio e d’altri, che forse sono maligni e de la mia quiete invidiosi».13
Una lettera del 1583 al celebre medico Girolamo Mercuriale14 mostracome la sofferenza causata da questi disturbi, dopo due anni, si sia aggra-vata. La descrizione tassiana sembra più dettagliata ma al contempo disor-dinata e convulsa. Il Tasso sa di essere infermo sebbene «l’infermità mianon è conosciuta da me» e neppure «la cagione del mio male». Ma su unacosa non nutre dubbi: «io ho certa opinione di essere stato ammaliato». Etra gli effetti di questa malia il Tasso ricorda i «tintinni ne gli orecchi e nela testa, alcuna sì forti che mi pare di averci un di questi orioli da corda» el’impressione che molto spesso «parlino le cose inanimate».15
In una lettera del 16 giugno del 1584, rivolgendosi a don Angelo Grillo, glirivela che Agostino Mosti, il priore di Sant’Anna, è il mandante dei maghiche lo hanno ammaliato:
perciochè dee sapere, ch’io sono stato ammaliato; ed egli [Agostino Mosti]ha tenuto mano co’ maghi.16
Il rapporto del Tasso con la magia, che ormai abita la sua vita, è divenutodisperatamente abituale, come se si trattasse dell’odiosa e insofferenteconvivenza con un compagno molesto. Leggiamo in data 10 novembre1585, la sua cronaca destinata al cugino Enea Tasso:
... le cose peggiorano molto;perciochè il diavolo,co’l quale io dormiva e pas-seggiava, non avendo potuto aver quella pace ch’ei voleva meco, è divenutomanifesto ladro de’ miei danari, e me gli toglie da dosso quand’io dormo, edapre le casse, ch’io non me ne posso guardare. [...]E prego Vostra Signoria che m’avvisi d’averli ricevuti,e che faccia ufficio per-ch’io esca di mano del diavolo co’ miei libri e con le scritture, le quali nonsono più sicure de’ danari.17
Il Tasso, quasi Armida che «con gli spirti anco favella / sovente, e fa con lorlungo soggiorno»18, passeggia e dorme col suo “diavolo”. Dalla lettera siricava inoltre che i due hanno avuto una lite e che per ritorsione, il dia-volo, gli sottrae di notte i “danari” e il timore del furto si estende anche aisuoi libri e alle sue carte. La breve descrizione del diavolo tassiano ha giàqualcosa di quel genio familiare di cui parlerà pure il Manso.19 Ma soprat-
115Fabio Giunta
14 Girolamo Mercuriale (1530-1606). Medico notissimo e cultore dell’opera ippocratea (Cen-sura et dispositio operum Hippocratis, 1583). Primo medico di Ferdinando I di Toscana.Curò a Vienna l’imperatore Massimiliano II. Fu autore della De arte gymnastica (1569), nellaquale avvalorò la ginnastica come terapia. Scrisse inoltre opere di pediatria, balneoterapia,malattie della pelle, tossicologia.15 Lettere, II, (n. 244), p. 237.16 Ivi, (n. 288), p. 277.17 Ivi, (n. 437), p. 460.18 Gerusalemme Liberata, XIV, 54, 5-6.19 Gianbattista Manso (1560-1645). Letterato napoletano; fondò l’Accademia degli Oziosi;amico e protettore di Tasso del quale scrisse una Vita (1621). Il Tasso gli dedicò uno dei suoidialoghi: Il Manso o Dell’Amicizia.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 115
tutto questo diavolo è la prefigurazione del “folletto”che con i suoi dispet-ti tanto farà disperare il Tasso il quale, infatti, circa un mese dopo, ci infor-ma che nella sua camera «c’è un folletto c’apre le casse e toglie i danari,benchè non in gran quantità».20
L’agire di questo folletto si concretizza in qualche furtarello. Si può forsevedere in questo caso la conoscenza della cultura magica del poeta poichéquella del furto è un’operazione che si inscrive coerentemente nel ruolo efra gli “uffici”del folletto rinascimentale che raramente offende in altro modo.Il folletto appartiene ancora al folclore e alla cultura magica del Cinquecen-to. Si può leggere, come esempio, nel Palagio de gl’incanti di Strozzi Cico-gna,che i folletti «molte volte fanno alcune burle a gl’uomini senza però nuo-cerli od offenderli in conto alcuno»21.E in un’altra pagina si legge che «ingan-nano in diversi modi gli spiriti,et particolarmente i Foletti,et familiari,la natu-ra humana».22 Una descrizione più estesa arriva da un noto conoscitore dispiriti ed esorcismi molto noto a Bologna,Girolamo Menghi23 da Viadana,chenel suo Compendio dell’arte essorcistica scrive che i folletti
pochissimo possono nuocere, e offendere; ma solo si pigliano piacere neltempo di notte in far alcuni strepiti, e rumori, e alcuna volta attendono a farburle, e giuochi, e altre cose da scherzo, le quali spesse volte sono da alcuniudite, e viste, come appare in molti luoghi, e case; le quali sono disturbate dacerti romori la notte, e ancho molte volte il giorno fatti da’ Demoni, comefanno gettando hora pietre,e travagliando gli uomini col loro sbattere,e pari-mente quando appaiano certi fuochi accesi, e altre delusorie operationi.24
La stessa definizione viene assegnata da uno studioso moderno: «Le irre-quietezze e le burle dei folletti, per quanto bizzarre, irritanti, erano in fondoinnocue».25
Nella lettera del 25 dicembre del 1585 all’amico Maurizio Cataneo il Tassotorna a lamentarsi ancora del folletto il quale, oltre a rubargli i “danari”,«mette tutti i libri sottosopra: apre le casse: ruba le chiavi, ch’io non me neposso guardare».26 Nella stessa lettera il poeta confida all’amico un desi-derio o una necessità:
116 I saggi
20 Ibid. ??????, A Scipione Gonzaga – Roma, (n. 448), p. 460.21 S. Cicogna, Palagio de gl’incanti, et delle gran meraviglie de gli spiriti, et di tutta laNatura,Vicenza, EDITORE????, 1605, p. 288.22 Ivi, p. 307.23 Girolamo Menghi (1529-1609). Predicatore francescano dell’Osservanza a Bologna. Famo-so ed esperto esorcista del suo tempo. Operò prevalentemente a Bologna. Sugli esorcismiscrisse: Flagellum daemonum (Bologna, 1577), Fustis daemonum (Bologna, 1584), Reme-dia probatissima in malignos spiritus expellendos (Bologna, 1579) e, in italiano, Compen-dio dell’arte esorcista (Bologna, 1579).24 G. Menghi, Compendio dell’arte essorcistica, et possibilità delle mirabili, et stupendeoperationi delli Demoni, et de’ Malefici, Bologna, EDITORE???, 1576, p. 10.25 O.Franceschini,L’esorcista, in A.A.V.V.,Medicina erbe e magia,Milano,EDITORE????,1981,p.100.26 Lettere, II, p. 475 (n. 454).
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 116
Vostra Signoria dee sapere ch’io fui ammalato, né fui mai risanato; e forse homaggior bisogno de l’essorcista che del medico, perch’il male è per artemagica.27
Ma la richiesta non deve sorprendere poiché quelli del Tasso sono ancoratempi in cui l’esorcista tende ad confondersi con il medico ed entrambi(più spesso il primo) conoscono il potere e le virtù delle erbe e dellepozioni e tutti quei rimedi che in grado di scacciare uno spirito maligno.È nuovamente il Tasso, circa un anno dopo, a presentare la stessa richiestaall’amico Scipione Gonzaga:
Sono infermo, e l’infermità non è da giuoco, né senza pericolo. Lande avreibisogno di medico e di confessare, e forse di chi scongiurasse i spiriti, edincantasse la fantasima.28
Ma torniamo al 30 dicembre del 1585. In una nuova lettera, il Tasso, forni-sce qui altri elementi circa «que’ miracoli del folletto». Riferendosi, infatti,alle ultime due lettere speditegli da Maurizio Cataneo gli scrive che:
l’una è sparita da poi ch’io l’ho letta, e credo che se l’abbia portata il follet-to, perchè è quella ne la quale si parlava di lui: e questo è un di que’ miracolich’io ho veduto assai spesso ne lo spedale; laonde son certo che sian fatti daqualche mago.29
Gli viene però il dubbio che tutto questo parlare di maghi e folletti possaapparire come una sua occulta frequentazione illecita. È per questo moti-vo che scrive, nella stessa lettera, di non avere «alcuna familiarità» col «dia-volo» o «co’ suoi maghi» i quali possono agire solo sull’immaginazioneumana. E in questo si fa assistere dalle citazioni del platonico Ficino e del-l’aristotelico Alessandro d’Afrodisia.30 Dopo un accenno alla finzione poe-tica dello spirito del Messaggiero, scritto solamente per «ubidire al cennod’un principe», ribadisce solennemente:
Iddio sa ch’io non fui né mago né luterano giamai; né lessi libri eretici o dinegromanzia, né d’altra arte proibita.31
117Fabio Giunta
27 Ibid.28 Lettere, III,p.56 (n.654). L’ultima espressione ricorda lo stratagemma di monna Tessa: «Egliè la fantasima, della quale io ho avuta a queste notti la maggior paura che mai s’avesse [...];io per me non mi terrò mai salva né sicura se noi non la ’ncantiamo [...]. Ben la so io incan-tare», in Boccaccio, Decameron,VII, 1 (corsivo mio).29 Lettere, II, p. 477 (n. 456).30 Alessandro d’Afrodisia. Filosofo della scuola peripatetica che professò la dottrina aristotelicaad Atene fra il 198 e il 211 d.C. È noto per essere fra i maggiori commentatori di Aristotele. Cirimangono i commentari al I libro degli Analitici primi, alla Topica, alla Metereologia, al Desensu, ai libri I-V della Metafisica). Particolare influsso esercitò sul pensiero posteriore la suainterpretazione del concetto aristotelico dell’intelletto, esposta nei due libri De anima. Taliinterpretazioni saranno riprese nel Rinascimento e specialmente da Pietro Pomponazzi.31 Ibid. ?????????, p. 478. Nella lettera del 17 maggio 1580 al marchese Giacomo Buoncompa-
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 117
Dopo un veloce accenno ai «miracoli del folletto» comincia a elencare laserie di «spaventi notturni» che lo atterriscono.Vede delle «fiammette nel’aria» o addirittura «faville» che escono dai suoi stessi occhi, «ombre de’topi» e «strepiti spaventosi». Ecco poi come dalle visioni si passa alle allu-cinazioni sonore quando «ne gli orecchi» sente «fischi», «titinni», «campa-nelle» e un rumore simile a «orologi da corda». La descrizione visionariatermina con l’immagine magnifica della «gloriosa Vergine» con Gesù inbraccio,entrambi avvolti da «un mezzo cerchio di colori e di vapori».Visio-ne che Tasso attribuisce agli effetti della frenesia senza escludere peraltrol’intervento divino. Egli torna però poi a parlare delle «cagioni» della suafrenesia che individua in quelle «confezioni» che aveva mangiato circa treanni prima.Ricorda inoltre che la stessa malìa «fu rinnovata un’altra volta»:
S’io non m’inganno, de la frenesia furono cagioni alcune confezioni32 ch’iomangiai tre anni sono; da le quali cominciò questa nuova infermità, che s’ag-giunse a la prima, nata per simil cagione; [...] Da poi la malìa fu rinnovataun’altra volta:nè v’hanno fatto alcuna provisione,come non fecero la prima.[...] e la qualità del male è così maravigliosa, che potrebbe facilmente ingan-nare i medici più diligenti; onde io la stimo operazione di mago. E sarebbeopera di pieta cavarmi di questo luogo,dove a gli incantatori è conceduto difar tanto contra me senza timor di castigo, o perchè abbiano molto favor da’principali, o perchè il signor duca non creda ad alcuna mia parola.33
Il Tasso mette al corrente delle malie subite anche la sorella Cornelia quan-do il 14 novembre del 1587 la informa del proprio stato di salute:
Signora sorella, il mio male è veramente incurabile,e cresciuto con l’età,con-fermatosi con l’usanza, e con la simulazione de gli uomini; i quali non hannovoluto risanarmi, ma ammaliarmi.34
Prima di procedere oltre è necessario ricordare che,ancora nel Cinquecento,subire un incanto ed avere frequentazioni con gli spiriti non erano ritenutinecessariamente sintomi di pazzia. Il Tasso era considerato folle dai suoi con-temporanei semplicemente perché si riteneva che le sue disgrazie fossero dinatura fisiologica e non magica.Tutti erano convinti che Tasso fosse sconvol-to da una malinconia frenetica. Ma solo il Tasso, oltre a ciò, credeva di essere
118 I saggi
gno il Tasso, ripetutamente, si avvale del binomio luterano-ebreo per spiegare, nella confes-sione all’inquisitore e in una lettera all’imperatore, che aveva avuto solo «alcune opinioni de’luterani e de gli ebrei» e non che «sia stato luterano o ebreo», in Lettere, II,p.80 (n.133).Dopocirca cinque anni Tasso teme maggiormente di, evidentemente, passare per mago che perebreo.32 Secondo il dizionario del Battaglia la confezione è la «manipolazione (per lo più accurataed esperta) di sostanze medicinali, di dolciumi, di confetture; il prodotto stesso»; per il Tom-maseo-Bellini si tratta di «composizione medecinale di varii ingredienti, fatte con mele o conzucchero a modo di conse confettate; ed ha la consistenza d’un molle lattovaro» (per “latto-varo” si intenda l’electuarium).33 Lettere, II, pp. 480-481 (n. 456).34 Lettere, IV, pp. 8-9 (n. 920).
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 118
stato ammaliato. Singolarmente, nel corpo del poeta convergevano così, e sisovrapponevano, coesistendo, due interpretazioni della follia corrispondentia due differenti eziologie.Da un lato, la nosologia medico-scientifica intende-va le frenesie, le bili nere e i deliri come i sintomi della corruzione umoraledi un individuo. Dall’altro, un folclore magico, largamente radicato nel tardoCinquecento anche nelle classi colte e complicato,nel caso del Tasso,da unadiscreta cultura di demonologia ermetico-platonica, che autenticava le visio-ni, l’esistenza di esseri soprannaturali, gli entusiasmi e gli invasamenti.
La malinconia e il demonio
In una lettera a Lorenzo Malpiglio del luglio del 1586, a proposito della revi-sione della Gerusalemme, il Tasso comunica di voler cambiare il «nome de’demoni» gentili con quelli letti in «un picciol libretto,ma pieno di molta dot-trina, il quale è intitolato:“Nuovo discorso de l’arme e lacci de’demoni, ridot-to in forma d’arte; dal reverendo don Giulio Candiotti di Sinigaglia, archidia-cono de la santa Casa di Loreto”».35 L’opera parla delle nove tentazioni o«armi» o «lacci» usati dal demonio per portare dalla sua parte le anime degliuomini. Ogni «laccio» ha il suo «suggeritore» maligno che il Candiotti accura-tamente annota e descrive. Sono proprio i nomi dei suggeritori a catturarel’attenzione del Tasso: Lucifero, Sathan o Sathanasso, Belial o Berith, Asta-roth o Veemoth, Leviathan, Belphegor, Belgebub, Asmodeo o Belsephon,Mammona.36 Oltre ai suggerimenti lessicali che il volume poteva fornire alpoeta ci si chiede se Torquato non pensasse al proprio caso personale quan-do leggeva di Belgebub «che è detto prencipe delle mosche»37 assieme ai suoiseguaci (i «suggeritori» cioè del «laccio» della presunzione) che «tentano ancoi peccatori, quando si ritirano, ò vogliono ritirarsi da peccare, per la difficul-tà, che vi si sente, e che non sopportino patientemente i pesi, e l’opere spiri-tuali, facendo ancora miracoli apparenti diabolici,strigonerie,maleficij, incan-ti, e altre cose simili, con l’aiuto, e concorso di quei tali, che ciò fanno».38 Si
119Fabio Giunta
35 Lettere, II, p. 556 (n. 532).36 «Alcuni demoni, specie quelli di grado più elevato, venivano indicati per nome, possede-vano una personalità distinta, e presiedevano a certi peccati. Sulla materia non esisteva nem-meno una forma vaga di accordo, e tutta la questione poteva diventare terribilmente confu-sa quando i demonologi si riferivano al Diavolo (cioè Satana) usando il nome di uno dei capidei demoni, come Belzebù, Leviatano,Asmodeo, Belial o Behemoth, oppure quando declas-savano Satana o Lucifero (o entrambi) su un piano di semplice parità coi suoi subalterni.Taleconfusione non sorprende, giacché la fonte di questi nomi era la Bibbia o i libri apocrifi del-l’era precristiana, in cui i vari nomi venivano usati indifferentemente. La stessa confusione siritrova non solo nell’opera di demonologi, ma anche nei resoconti delle streghe sui sabba, incui spesso non si riesce a capire se il Signore della cerimonia, spesso descritto come un ani-male cornuto, fosse il Diavolo oppure uno dei suoi principali demoni», in B.P. Levack,La cac-cia alle streghe, Bari, EDITORE????, 1988, p. 36.37 «Belzebù era ritenuto “comestor muscarum”, “princeps muscarum”, il sovrano dellemosche-streghe, delle vetule rencagnatae,“magnamosche”», in P. Camporesi, Il pane selvag-gio, Bologna, EDITORE????, 1980, p. 200.38 Novo et breve discorso de l’armi e lacci de’ demoni, ridotto in forma d’arte dal R. Don
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 119
aggiunga pure che il testo del Candiotti si sofferma sulla malinconia.E anchequesto è tema che sappiamo riguardava e interessava il Tasso. Si legge infattinel Novo discorso, a proposito delle quattro cause della disperazione,che «laquarta causa è la troppa tristitia o malinconia;onde sono alcuni,che per natu-ra o per mal habito entrano in tanta malinconia,che mai non stanno di buonavoglia. E questa malinconia pigliano anche molte volte, et non fanno perchécausa.Questi tali piangono,penano,e stanno malinconici non altrimente,chese loro fossero accadute tutte le disgratie del Mondo: E questo è quello, chedice Salomone, Nella tristitia, e malinconia è gettato lo spirito, dicendo nel-l’Ecclesiastico, sarà gettato nel profondo della disperatione».39 Siamo quindiarrivati, grazie al Candiotti, al tema della malinconia come accesso privilegia-to del Maligno, la via psicologica, per insidiare l’anima dell’uomo.Già nel famigerato manuale deomonologico del 1486 Malleus malefica-rum, redatto dai domenicani Heinrich Institor40 e Jacob Sprenger,41 si leg-geva di come il diavolo potesse vessare con maggiore intensità l’uomocon una predisposizione alla malinconia, anche se non era comunqueescluso un intervento demoniaco sulla potenza cognitiva dell’uomo tra-mite un’alterazione degli umori e, di conseguenza, delle percezioni, alpunto di stravolgere la potenza nutritiva, sensitiva e appetitiva.Tale stra-volgimento poteva avvenire tramite immagini di apparizioni fantastichederivanti dalla memoria stessa della vittima afflitta dal male atrabiliare.Il medico e filosofo Johann Wier,42 allievo di Agrippa von Nettesheim,43 noncredeva, in linea con il Canon episcopi, alle meravigliose avventure e ai volinotturni confessati dalle streghe, ma li spiegava come pure visioni o alluci-
120 I saggi
Giulio Candiotti da Sinigaglia; Dottore dell’una, et dell’altra legge, Archidiacono della S.Casa de Loreto,Ancona, EDITORE????, 1581, (D 9 v – D 10 r).39 Ivi, C 4 r.40 Heinrich Institor (1430-1505).Teologo domenicano. Inquisitore su tutta la Germania supe-riore (1479), ebbe nel 1484 poteri speciali da Innocenzo VIII per combattere la stregoneriaassieme a Jacob Sprenger con il quale scrisse il Malleus maleficarum (1486),manuale inqui-sitoriale per la repressione della stregoneria. Nel 1500 fu nominato nunzio e inquisitore inBoemia e Moravia.41 Jacob Sprenger (1436-1495).Teologo domenicano; professore di teologia a Colonia, inqui-sitore generale per la Germania, ricordato come tale nella celebre bolla del papa InnocenzoVIII Summis Desiderantes Affectibus del 5 dicembre 1484 contro la stregoneria. Redasseassieme a Heinrich Institor il notissimo manuale inquisitoriale Malleus maleficarum (1486).Fondò in Germania la Confraternita del Rosario (1475).42 Johann Wier (1515-1588).Tedesco protestante, medico e filosofo erasmiano. Dopo aver stu-diato a Bonn presso il celebre Cornelio Agrippa di Nettesheim divenne primo medico al servi-zio del duca Guglielmo III di Jülich-Clèves-Berg. Scrisse il trattato De praestigiis daemonum etincantationibus ac veneficiis (1563) in cui affrontava il rapporto tra gli uomini e i demoni. Ungrande successo ebbe un compendio del suo vasto trattato,De lamiis (1577),il quale suscitò lar-ghi consensi e duri attacchi, il più noto dei quali quello di Jean Bodin che nella sua Démono-manie des sorciers (1580) lo accusò di stregoneria e complicità col demonio.43 Cornelio Agrippa (1486-1535). Medico, filosofo, e astrologo tedesco. Ebbe vita agitata eavventurosa: più volte in Francia e in Spagna, insegnò (1515) nell’università di Pavia; per lesue dottrine magiche e cabalistiche fu più volte condannato dalla chiesa. Le sue opere prin-cipali sono: De occulta philosophia (1510), difesa della magia considerata come scienzasuprema,e De incertitudine et vanitate scientiarum (1527),critica violenta di tutte le scien-ze contemporanee.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 120
nazioni provocate da sostanze psicotrope. Nel De praestigiis daemonumsostiene che l’individuo malinconico risulta più indifeso di altri a fronte all’as-salto del Demonio. E in uno scritto di poco posteriore, il De Lamiis, il medi-co tedesco ribadiva lo stesso concetto ponendo ancora una volta l’accentosulle grandi capacità della vis imaginativa.Il Tasso parla ancora delle origini del suo male nella lettera a Giovann’Anto-nio Pisano44 in cui descrive le due «specie di malinconia» e cioè una «pernatural temperamento» e l’altra «per mal nutrimento»;ma ne esiste «una terzaspecie ancora, la cui origine cominciò da lo stomaco con alcune mormora-zioni torbide, e con esalazioni fumose, per le quali l’intelletto fu da crudeleobumbrazione offuscato. Nè le dirò per malìa e per incanto s’accrescesse lamia fiera malinconia, per non parer simile a gli altri furiosi». La doppia ezio-logia, fisiologia e magica, è confermata ancora una volta. Dall’epistolarioemerge, inoltre, la ricerca di una “oggettistica” magica da parte del poeta. Sitratta di utensileria magico-sacrale che, se non è in grado di guarirlo, puòalmeno, spera il Tasso, proteggerlo da ulteriori o ennesimi incantamenti.
Chincaglieria magica e formule sacre
Le lettere non ci offrono una testimonianza ricca circa la fede tassiananegli amuleti. Si può comunque partire dalla “manna di Sant’Andrea”.Bruno Basile ha messo in relazione il sonetto del Tasso Alla manna delglorioso apostolo sant’Andrea, erroneamente finita fra le “Rime sacre”,con una lettera del poeta a Scipione Gonzaga del 13 settembre 158345
nella quale si parla della «scatolina» di manna di sant’Andrea inviatagli dal-l’amico. Sembra che secondo gli antichi, scriveva Piero Camporesi,46 daicorpi delle vergini defunte e dai cadaveri dei santi sgorgassero «liquorimedicamentosi e balsami beati», le “manne” appunto. E molto famosa fuquella di S.Andrea morto in epoca neroniana. Da un’altra lettera del Tassoricaviamo poi che Scipione Gonzaga abbia esaudito le richieste dell’ami-co inviandogli due ampolle della sacra manna che al Tasso saranno suffi-cienti «per ogni infermità».47
Ma del desiderio di oggetti magici testimoniano ancora due curiose lettere adon Angelo Grillo risalenti alla primavera del 1588. Nella prima si legge:
il pezzo de l’unicorno mi fu dato; ma tolto poi con modo più insolito assai,e quasi direi maraviglioso, s’io non avessi veduti altri simili miracoli, se l’hoperduto, quando potea giovarmi, io n’ho minor maraviglia de l’arte.48
121Fabio Giunta
44 Lettere, IV, pp. 210-211 (n. 1139).45 Lettere, II, p. 244 (n. 256). Ma si veda l’articolo di B. Basile, Tasso e la manna di Sant’An-drea, in «Filologia e critica», XIX, Roma, EDITORE????, 1994, pp. 142-145.46 La carne impassibile, Milano, EDITORE????, 1994, citato dal Basile.47 Lettere, II, p. 249 (n. 260).48 Ivi, IV, (n. 960), p. 39.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 121
Mentre nelle successiva viene rinnovata una richiesta:
Scrissi a Vostra Paternità l’altra settimana; in questa non so scriverle di nuovoma la prego che mi mandi un altro pezzo di alicorno, e m’avvise del modod’usarlo.49
Ma si legga pure la richiesta audace del Tasso a Eleonora de’ Medici:
ma veramente le sarei più obligato se mi donasse un rubino ed una perlalegata in oro: perchè s’avenisse mai ch’io dovessi prender moglie, non mimancherebbono con la sua grazia anella da sposarla: e senza questa occasio-ne, sarebbono quasi un remedio a la maninconia.50
L’oggetto però che ci interessa maggiormente è la croce d’oro chiesta alsegretario di papa Gregorio XIV,Dario Boccarini, in una lettera del 9 marzo1591:
ardisco di pregar Vostra Signoria, che m’impetri da la sua liberalissima manouna croce d’oro, vacua, smaltata del naturale, piena di reliquie, o d’orazionicontra i maligni spiriti, e licenza (se la licenza è onore o dignità) di portarlane la cappa o nel saio.51
Ai tempi del Tasso non era raro portare indosso o intorno al collo delle“sacre scritte” a scopo di esorcistica protezione. Tale ambigua credenzamagico-sacrale,non essendo propriamente ortodossa, era oggetto di dibat-tito da parte dei teologi. Basti solo pensare, ad esempio, che AmbrogioVignati, nel suo Elegans ac utilis tractatus de haeresi, dedica al problemala quaestio III An suspendere divina verba ad collum sit illicitum.52 IlVignati sostiene la liceità religiosa ed efficacia pratica dei divina verba. Eaggiunge che anche le reliquie dei santi riescono, con la medesima effica-cia, a proteggere dagli incantesimi. Proprio quello che chiedeva il Tassoquindi: reliquie e “sacre parole”. Vignati, raccomanda solamente, parafra-sando S. Tommaso, di prestare attenzione affinché questi “divina verba”non siano formule che provochino, seppure involonatariamente, l’evoca-zione di creature soprannaturali di oscura natura.Della duratura credenza nella parola taumaturgica, inoltre, era già testimo-ne un testo assai poco benevolo nei confronti di qualsiasi tipo di magiacome il Malleus maleficarum nel quale si poteva leggere:
hodie literati et sacrae theologiae doctores reperientur, qui infirmos visitan-tes similia verba (carmina e exorcismi) aegrotis applicant: et non solumdaemoniaci.53
122 I saggi
49 Ivi, (n. 961), p. 39-40.50 Lettere,V, (n. 1453), p. 146.51 Ivi, (n. 1326), p. 45.52 A.Vignati, Elegans ac utilis tractatus de haeresi, 1581, p. 14 b.53 H. Institoris - J. Sprenger, Malleus maleficarum, X v b.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 122
Più avanti, lo stesso Malleus, chiarisce meglio il senso dell’affermazionedella liceità di alcune parole che avviene «quando sit aliquod opus et vir-tute religionis christianae, ut ubi quisquis vellet infirmo subvenire per ali-quam orationem et benedictionem per verba sacra».54 Occorre solamenteche si rispettino sette condizioni55 dopo di che
Carmina et exorcismi liciti et hi qui practicant possunt dici exorcistae autincantatores liciti.56
Sul potere della parola si è confrontata pure la raffinata razionalità aristoteli-ca di Pietro Pomponazzi57 il quale, respingendo interpretazioni sovrannatu-rali e interventi demonici,riconduce i meravigliosi effetti della vis verborumalla più “naturalistica” virtù delle cose. Leggiamo allora cosa nel De incanta-tionibus il Pomponazzi scriveva sulla “potenza”delle parole:
Ad nonam autem dubitationem respondetur, et primo ad illud quod diciturde verbis et carminibus quod quamvis Voces primo et per se non immutentnisi auditum, per accidens tamen et secundario mirabiles effectus habentproducere et praecipue mentes humanas immutare.58
E forse il campo semantico potrebbe estendersi alla “potentia carminis”usata dalle streghe di cui parla Paolo Grillandi59 che «tendunt ad hominumnecem & destructionem».60
Tasso sicuramente era molto affascinato da questo aspetto del linguaggio.Lo testimoniano ancora le letture del Bodin61 o di Olao Magno.62 E lo rive-
123Fabio Giunta
54 Ivi, X vi a.55 Le sette condizioni che esporrò sinteticamente sono: 1) che le parole non riguardino l’in-vocazione dei demoni; 2) che le formule religiose non contengano nomi ignoti; 3) che nonsiano dette falsità; 4) e non siano dette cose vane; 5) che non venga meno la divina riverenza;6) che si abbia rispetto delle Sacra Scrittura; 7) che comunque ci si affidi alla volontà divina.56 Ibid.???????????????57 Pietro Pomponazzi (1462-1525). Scolaro dell’Achillini a Padova, dove si addottorò in medi-cina (1487) e dove fu professore di filosofia naturale, passò all’università di Ferrara e suc-cessivamente a quella di Bologna dove restò fino alla morte.A Bologna pubblicò (1516) il Deimmortalitate animae, opera in cui veniva negata l’immortalità dell’anima. Da ricordareanche il De naturalium effectuum admirandorum causis, sive de incantationibus liberdove le operazioni magiche venivano sottratte all’influenza dei demoni.58 Petrus Pomponatius, De naturalium effectum causis sive de Incantationibus, Hildes-heim-New York, 1970, copia anastatica tratta da Opera ?????????????????, Basilea, 1567, p. 84.59 Paolo Grillandi (1490-?). Giurista di Castiglion Fiorentino (Toscana); fu uditore delle causecriminali prima a Roma e poi nella diocesi di Arezzo. Pubblicò (1536) un volume di cinqueTractatus su argomenti disparati del diritto penale. Uno di questi fu il De sortilegiis eorum-que poenis, scritto fra il 1524 e il 1527.60 Tractatus universi juris, Duce et Auspice Gregorio XIII, vol. XI, Pars. II, p. 382 a 1.61 Jean Bodin (1530-1596). Politico, economista e magistrato. Il suo nome è principalmentelegato a Les six livres de la République (1576), nei quali pone, con grande rigore giuridico,le basi teoriche dello «Stato di diritto» e fissa il concetto di «sovranità» come summa legi-busque soluta potestas.Da ricordare inoltre la sua Démonomanie des sorciers (1580) in cuisostiene e corrobora le idee del Malleus maleficarum.62 Olao Magno (1490-1557). Ecclesiastico e umanista svedese. In qualità di legato pontificioattraversò il nord della Svezia. Fu poi nominato arcivescovo di Uppsala. Nel 1555 pubblicò
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 123
la, in parte, quel ricorso alle «potentissime parole» da parte di alcuni per-sonaggi della Gerusalemme. Ma le “magie” tassiane non finiscono qui.
Il “santo” spirito del Tasso
Testimone di un’allucinazione o «inganno della fantastica virtù» del Tassofu Giovan Battista Manso, che nella Vita ci racconta che non solamente ilfolletto veniva a trovare il nostro poeta:
A queste noie che gli dava il folletto, o pure a lui pareva che gli desse, s’ag-giunsero alcune apparizioni ch’egli stimava d’avere d’un altro spirito assaisimile a quel ch’egli finse nel Messaggiero.63
Uno spirito dunque «in forma d’un giovanetto assai somigliante a quellach’egli nel Messaggiero descrisse» appare al Tasso nonostante la smentita dalui stesso scritta nella lettera al Cataneo del 30 dicembre 1585.64 È così che,rispetto alle genesi del Messaggiero, uno spirito «assai diverso dal folletto»del Tasso «molto tempo dapoi cominciò ad apparirgli».65 Continua ancora ilManso cercando di rassicurare il lettore sulla natura di questo spirito:
questo suo spirito non è cattivo, conoscendosi da mille contrasegni, i qualisono il favellargli di cose religiose e divote e ’l persuadergliele, e oltre a ciòil nominare i santissimi nomi di Giesù e di Maria, il riverir le croci e le reli-quie de’ santi, com’egli medesimo afferma, e più di ogni altra cosa la conso-lazione è ’l conforto che gli lascia quando da lui si diparte, contraria a quel-lo che sogliono i rei spiriti fare.66
A questo punto, prima di licenziare definitivamente il Manso, occorre ricor-dare quella pagina in cui sembra trasparire un comprensibile imbarazzo pie-toso del letterato napoletano nel vedere il Tasso alle prese col suo spirito:
egli, rivolto lo sguardo verso una finestra,e tenutolovi buona pezza fitto, sì cherappellandolo io nulla mi rispondeva, alla fine:“Ecco (mi disse) l’amico spiritoche cortesemente è venuto a favellarmi; miratelo, e vedrete la verità delle mieparole”. Io drizzai gli occhi colà incontanente, ma per molto ch’io gli aguzzas-si, null’altro vidi che i raggi del sole, che per gli vetri della finestra entravanonella camera.E mentre io andava pur con gli occhi attorno riguardando e nien-te scorgendo, ascoltai che Torquato era in altissimi ragionamenti entrato conchi che sia; percioché quantunque io non vedessi né udissi altri che lui, non-dimeno le sue parole, or proponendo e or rispondendo, erano quali si veggo-no essere fra coloro che d’alcuna cosa importante sono a stretto ragionamen-
124 I saggi
l’Historia de gentibus septentrionalibus nel quale vengono descritte i costumi e le creden-ze magico-religiose degli Svedesi.63 G. B. Manso, Vita di Torquato Tasso, cit., p. 115.64 Il Tasso, come già abbiamo letto, vi parla del Messaggiero come di un dialogo scritto solo«per ubidire al cenno d’un principe», in Lettere, II (n. 456).65 G. B. Manso, Vita di Torquato Tasso, cit., p. 115.66 Ivi, p. 117.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 124
to; e da quelle di lui agevolmente comprendeva con lo ’ntelletto le altre chegli venivano risposte, quantunque per l’orecchio non l’intendessi.67
Che uno spirito non si manifestasse a tutti non era però un concetto nuovo.Ne dà testimonianza un autore come Gianfrancesco Pico68 (il cui dialogo Lastrega è già stato per altri motivi correlato al Tasso autore del Messaggiero)69
fondandosi sulla teoria dello spiritus phantasticus.70 Ma forse la demonolo-gia colta del Messaggiero ha anche lo scopo di dimostrare come il contattodel Tasso con lo “spirito gentile”non sia dovuto alla sua malinconia.Sono state fin qui suggerite alcune potenziali linee di contatto, ancora ingran parte da verificare, che Tasso ha potuto intrattenere con le credenzepopolari (rafforzate talvolta dalla stessa manualistica inquisitoriale).Il Tasso vede e riconosce le forze oscure del cosmo e della magia popola-re sebbene non gli sia estranea una vis razionalistica che si sforza di inscri-vere gli effetti singolari del “meraviglioso” nella logica di un ordine natu-rale. E in questo sforzo gnoseologico non è escluso il corpo il quale con isuoi umori, le alterazioni e combustioni diventa il conduttore principale.Bisognerebbe quindi rivedere l’idea di follia del Tasso. Crederlo pazzo poi-ché convinto di convivere con un folletto o di aver subito un incantosarebbe un errore di prospettiva storica in quanto si trattava di depositatecredenze di un’epoca che in parte, visto il successo di maghi e fatucchie-re, residualmente, è ancora la nostra.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/3giunta.html.
125Fabio Giunta
67 Ivi, p. 119.68 Gianfrancesco Pico (1469-1533). Signore di Mirandola;nipote del più famoso Giovanni delquale scrisse una Vita. Seguace del Savonarola. Sostenne, contro il Ficino, l’impossibilità difondare la fede cristiana sulla filosofia antica. Sua opera principale fu l’Examen vanitatisdoctrinae gentium et verittis disciplinae christianae (1520) nella quale attaccò i sistemifilosofici degli antiche e soprattutto la filosofia artistotelica.Scrisse inoltre il dialogo Strix sivede ludificatione daemonum (1523), opera tradotta in italiano nel 1524 da Leandro Alberti epubblicata a Bologna con il titolo di Libro della strega o Delle illusioni del demonio.69 E. Raimondi, Poesia come retorica, MANCA?????????????????70 I protagonisti del dialogo si chiedono perché il demonio in forma «di passera» sia visibile soloalla strega. Spiega Dicaste: «ma perché questa presente imagine del demonio sia vista solamen-te dalla Strega, io ne darò la cagione all’amicizia che ha con esso lui, per la quale si fa, che nonsolamente gli occhi, ma ancora la potenza imaginativa, per un certo abito s’indirizzi nell’ama-to», in G. Pico, La strega ovvero degli inganni de’ demoni, Milano, EDITORE????, 1864, pp. 68-69. Si fanno degli esempi citando Aristotele e Plinio. Chiede poi Apistio: «Si può dunque crede-re senza biasimo (come dicono), che si vegghino qualche volta spiriti buoni e cattivi senzacorpo da quelli che stanno per morire, i quali non sian visti da altri?».«Perché no?» risponde Fro-nimo «Avendolo creduto tanti uomini famosi, e scrittolo ancora agli altri?», ivi, p. 70.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 125
I giovani e la scienza antica: tra rigore numerologico e calore naturaleMatteo Martelli
“Aritmologia” della giovinezza
La riflessione scientifica antica inserisce la giovinezza all’interno di com-plesse tassonomie concernenti le varie fasi della vita umana e basate su dif-ferenti presupposti teorici.Tuttavia, a prescindere dalle diversità che analiz-zeremo, i testi in questione sono accomunati dal medesimo approccio spe-culativo nei confronti della realtà: essi, infatti, assumono un punto di osser-vazione che si dilata alla ricerca di leggi universali, applicabili a tutti i feno-meni naturali. Si allacciano così rapporti reciproci tra piani ontologici colli-manti, interferenze e associazioni che inseriscono nelle maglie di un sistemaolistico anche l’essere umano con le sue peculiarità. È possibile distinguerealmeno due impianti concettuali nella trattazione delle diverse età dell’uo-mo, entrambi testimoniati dal variegato e ricchissimo insieme di operemediche e scientifiche, indicato generalmente come Corpus Hippocrati-cum.1 Una prima classificazione è marcata da un preciso impianto mate-matico che si sviluppa intorno al numero sette. Nel trattato Sulle ebdoma-di2 abbiamo una sezione che recita:
Così anche la natura umana ha sette stagioni, che noi chiamiamo età: bambi-no, fanciullo, adolescente (meirákion), ragazzo (neanískos), uomo, anziano,vecchio.3 Si è bambini fino ai sette anni e alla comparsa dei denti; si è fanciul-
126 I saggi
1 L’edizione di riferimento degli scritti ippocratici è stata curata da E.Littré,Oeuvres complètesd’Hippocrate, I-X, Paris, EDITORE????, 1839-1861. Si può consultare una versione digitale del-l’opera nel sito della Bibliothèque interuniversitaire de médicine all’indirizzo:http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/hipp_vf.htm. Nel presente contributo citoabbreviando con Littré,seguito dall’indicazione del volume in numero romano e da quella dellepagine in numero arabo.2 Si tratta di un’opera suddivisa in 53 capitoli, di cui i primi undici sviluppano una cosmolo-gia su base numerologica,mentre i rimanenti trattano delle febbri e delle malattie acute, inda-gandone le cause e le terapie e rivelando un impianto concettuale più vicino alla teoriaumorale. La datazione di questo trattato non è sicura: per una rapida ed esaustiva panorami-ca delle posizioni dei vari studiosi si veda J. Mansfeld, The Pseudo-Hippocratic Tract PeriEbdomadon, Ch. 1-11, and Greek Philosophy,Assen,Van Gorcum, 1971, pp. 16-31, secondoil quale il nostro scritto risalirebbe all’età ellenistica. M. L. West, The Cosmology of ‘Hip-pocrates’, De Hebdomadibus, in «CQ», XXI, 1971, pp. 365-388, pensa, invece, al V sec. a.C.3 Nella traduzione dei vari termini indicanti le diverse fasi della vita umana ho seguito F. Roma-no,Giamblico.Summa pitagorica,Milano,Bompiani,2006,p.911. La terminologia antica su que-sto argomento è molto ricca e complessa, spesso legata alle diverse classi di età ed ai vari siste-mi sociali ed educativi.Per una succinta,ma precisa,introduzione a queste problematiche,si vedaA. Schnapp, L’immagine dei giovani nella città greca, in G. Levi, J.-C. Schmitt, Storia dei giova-ni. I.Dall’antichità all’età moderna,Bari, Laterza,1994,pp.3-53. Rimangono, inoltre, fondamen-
10
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 126
li fino alla produzione del seme,a due volte sette anni;si è adolescenti fino allacrescita della barba, a tre volte sette anni; si è ragazzi fino al completo svilup-po di tutto il corpo, a quattro volte sette anni; si è uomini fino a quarantanoveanni, sette volte sette anni; si è anziani fino a cinquantasei anni, sette volte ottoanni; da questo momento in poi si è vecchi.4
Nei capitoli precedenti l’autore aveva classificato in base allo stesso criteriogli strati del mondo naturale,gli astri, i venti e le stagioni;dopo il nostro para-grafo passerà al corpo umano,all’anima,ecc.L’intento,come afferma lo stes-so testo,5 è quello di mostrare la natura del mondo e dell’uomo in una visio-ne complessiva. In tale Weltanschauung la vita umana si uniforma alla strut-tura del reale e solo uno slittamento semantico ci conduce, senza soluzionidi continuità, dalle stagioni del mondo a quelle dell’esistenza. La giovinezzaè definita in base a pochi elementi fisiologici: sino alla soglia dei trent’anniil corpo si sviluppa nella sua interezza, appropriandosi dei segni della matu-rità – quali la barba, assai diffusa anche a livello iconologico quale contras-segno dell’uomo adulto6 – e della capacità riproduttiva.Tali linee interpre-tative si conservano, con lievi alterazioni ed interessanti marginalia, anchein altri testi che testimoniano la medesima ripartizione settenaria.7 Censori-no (De die nat. XIV 3) ribadisce la semplice suddivisione aritmetica,8 insi-stendo tuttavia sulla criticità del momento di passaggio tra una ebdomade e
127Matteo Martelli
tali i lavori di A.Brelich,Paides e parthenoi,Roma,Edizioni dell’Ateneo,1969;W. Jaeger,Paideia:la formazione dell’uomo greco,Milano,Bompiani,2003;H. Jeanmaire,Couroi et Courètes.Essaisur l’éducation spartiate et les rites d’adolescence dans l’antiquité hellénique, Lille, Bibliothè-que universitaire, 1939. Sulla figura del neanískos e sul suo rapporto con il meirákion, si con-sulti, inoltre, E. Cantarella, «Neaniskoi». Classi di età e passaggi di «status» nel diritto ateniese,in «MEFRA», CII, 1990, pp. 37-51. Ringrazio il dott. Stefano Caciagli per gli utili suggerimenti.4 La traduzione è stata fatta sul testo stabilito da M.West, The Cosmology..., cit., p. 369, par. 5(sono riprodotti solo i primi undici capitoli). Per l’edizione completa si veda W. H. Roscher,Die Hippokratische Schrift von der Siebenzahl in ihrer vierfachen Überlieferung, Pader-born, EDITORE???, 1913 (rist. New York, EDITORE???, 1967). La tradizione di quest’opera èpiuttosto complessa: per intero essa è conservata solo in una traduzione latina tramandatadai codici Ambros.Lat.G 108 (Littré IX,pp.433 ss.) e Parisinus Lat.7027 (Littré VIII,pp.634ss.). Un estratto greco dei primi quattro capitoli è trascritto alla fine del Parisinus Gr. 2142(Littré IX, pp. 433 ss.); il quinto capitolo (di cui il codice riporta solo l’inizio), invece, è notoper tradizione indiretta grazie al De Opificio mundi (105, 1-12) di Filone, al Perì dekádos(pp. 13s. Heiberg) di Anatolio e ai Theologoumena Arithmeticae (pp. 55s. De Falco) delloPseudo-Giamblico.Abbiamo, infine, un commento arabo al testo (fino al ventesimo capitolo)conservato nel codice Monac.Arab. 802 e pubblicato, con traduzione in tedesco, da G. Berg-strässer, Pseudogaleni in Hippocratis de Septimanis commentarium ab Hunaino Q.F.ara-bice versum, Leipzig-Berlin,Teubner, 1914 (CMG XI 2, 1).5 Cfr. M.West, The Cosmology..., cit., p. 271.6 Per una ricca analisi della pittura a figure nere e a figure rosse in relazione all’educazionedei giovani e del rapporto fra “amante” (erastés), solitamente dipinto con la barba, e “amato”(erómenos), si veda A. Schnapp, L’immagine..., cit., pp. 24-35.7 Per uno studio esaustivo dei diversi testi che presentano un evidente legame con la nostrasezione di Sulle ebdomadi e dei loro rapporti reciproci, si consulti J. Mansfeld, The Pseudo-Hippocratic..., cit., pp. 156-204.8 Censorino è testimone di vari sistemi numerologici per la classificazione delle età dell’uo-mo.Ad esempio, cita Varrone che suddivide la vita umana in cinque periodi di quindici anniciascuno,escluso l’ultimo.Dai quindici anni ai trenta si è adolescenti (adulescentes),dai tren-ta ai quarantacinque anni si è giovani (iuvenes).
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 127
l’altra (XIV 7-9).Ogni sette anni la natura deve varcare la soglia attraverso laquale avviene qualche cambiamento: per questo, i settimi anni sono detti“climaterici”.9 Secondo gli astrologi, ci informa ancora Censorino, sarebbe-ro particolarmente pericolosi tre momenti: il ventunesimo anno – data diinizio, secondo lo Pseudo-Ippocrate,della giovinezza – il quarantaduesimo eil sessantatreesimo.Tale approccio, legato ad una visione del numero che nescioglie, almeno in parte, la lucidità adamantina, diventa caratteristico dellaproduzione neopitagorica di età imperiale: la matematica non è soltantoespressione di un puro razionalismo, ma fa propri elementi che vantanoun’origine orientale e rimandano a scienze liminari, quali l’astrologia e lamantica.10 Ne troviamo un esempio paradigmatico nell’opera intitolata Teo-logia aritmetica, che è stata tramandata nel novero degli scritti di Giambli-co. Una lunga sezione di questa derivante dall’opera del matematico Nico-maco di Gerasa, è dedicata all’illustrazione di tutte le qualità peculiari delnumero sette. Ne proponiamo di seguito l’incipit:
Il numero 7 è detto “foraggiere” (ageleia) dal fatto che la sua composizione èstata raccolta ed è contenuta in modo uniforme, giacché è assolutamenteindissolubile, tranne che nella sua parte omonima [1/7],11 oppure DAL FATTO
CHE TUTTE LE COSE HANNO PORTATO A COMPIMENTO OGNI PRODOTTO NATURALE PER
MEZZO DEL 7 ????????,12 o piuttosto – ragione ben più pitagorica – perché anchei più illustri tra i Babilonesi, sia Ostane sia Zoroastro,13 chiamano le sfere cele-sti propriamente “greggi” (agelai).14
La paretimologia che sta alla base del passo, che interpreta il termine age-leia – usato in genere come epiteto di Atena e reso con “predatrice”– comese derivasse alla parola “gregge” (agelï), con la quale i saggi orientali indica-vano le sfere celesti,15 è introdotta per evidenziare in modo ancora più chia-
128 I saggi
9 Tale termine, secondo Gell. III 10, 9, sarebbe di origine caldaica e indicherebbe un momen-to decisivo e critico per il destino o la salute umana. Si veda, in proposito,V. Fontanella, Cen-sorino. Il giorno natalizio, Bologna, Zanichelli, 1992, p. 74, n. 2.10 A partire dall’età ellenistica, secondo l’analisi compiuta da J. Bidez e F. Cumont, Les mageshellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaps d’après la tradition grecque, Paris, Les Belles Let-tres, 1938, si sarebbero affermate varie leggende riguardanti il debito di alcuni pensatori, inprimis Democrito e Pitagora, nei confronti del vicino ed estremo oriente (Egitto, Persia,India).Queste si sarebbero ampliate nei secoli successivi, ricomparendo in numerosi testi deiprimi secoli d.C. e associando le figure di tali pensatori a varie scienze occulte, soprattuttola magia, l’astrologia e l’alchimia. La letteratura sull’argomento è piuttosto ampia: per un’agi-le analisi del declino del razionalismo classico in età imperiale e dei rapporti tra cultura grecae vicino oriente, si rinvia a A.-J. Festugière,La révélation d’Hermès Trismégiste, Paris, Les Bel-les Lettres, 1944, in particolare alle pp. 1-44.11 Si fa qui riferimento al fatto che il 7 è un numero primo.12 Il maiuscoletto è mio.13 Il presente estratto è stato pubblicato anche da J. Bidez e F. Cumont, Les mages..., cit., II,p.283, fr.10. I due studiosi ritengono piuttosto difficile stabilire con sicurezza quanto, in que-sta sezione, derivi effettivamente da tradizioni orientali.14 Traduzione tratta da F. Romano, Giamblico..., cit., p. 913. Sul problema dell’attribuzionedella Teologia aritmetica, che si presenta come un centone di estratti da Anatolio e Nico-maco di Gerasa, si vedano le pp. 41-49.15 Si vede notare che nelle righe successive del testo ([Iambl.] Theol. ar. p. 57 De Falco), l’au-
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 128
ro che la realtà,sia nei cieli sia nel mondo sublunare,regola i propri processidi generazione sul numero sette. Esso viene chiamato anche “fortuna”(tychï) o “momento opportuno”(cairos), ed alla potenza di questa grandez-za si affida la sfera lunare, il cui influsso agisce su ogni elemento naturale: suquesto l’oceano regola le maree, gli animali – ad esempio i molluschi dimare, quali i ricci o i mitili, che hanno un rapporto simpatetico con l’astro– e gli uomini i processi di crescita e di sviluppo.16 Ogni evoluzione biolo-gica si organizza intorno al numero sette: i semi germogliano sulla terra alsettimo giorno, il seme affluisce nell’utero per sette volte e, dal momentodella nascita, la settima ora è il momento più critico, nel quale si stabiliscese il neonato sopravvivrà o meno. Quindi Nicomaco aggiunge:
[...] a tre volte 7 mesi cominciano (scil. i bambini) ad articolare la voce e farei primi tentativi di parlare [...].A due volte 7 anni entrano nella pubertà e cosìcome al compimento dei primi 7 anni erano in grado di articolare ogni formadi discorso verbale, poiché sono appunto 7 per natura anche le voci sempliciidonee a questo scopo, allo stesso modo ora cominciano ad articolare il dis-corso interiore, grazie al quale il vivente è già razionale, poiché sono appunto7,secondo molti filosofi, i sensi che concorrono all’esercizio della facoltà razio-nale [...]; e presso i Babilonesi prima di questa età non possono né esercitarele azioni di culto né partecipare della loro sapienza sacerdotale [...]. E poichénell’età successiva ai quattordici anni è possibile anche avere figli e sostituirea se stessi un altro uomo perché si compia l’ordine cosmico, giustamente ipoeti stabiliscono che la misura più giusta di una generazione è quella dei 30anni [...]: anche in virtù della perfezione del numero 3 la successione genera-zionale si completa per mezzo di 3 uomini: padre, figlio e nipote. In generalenel terzo settenio l’uomo compie la sua crescita in lunghezza,nel quarto in lar-ghezza e non gli resta da fare nessun’altra crescita: 28, infatti, è numero per-fetto.17 Nel quinto settenio, in virtù del manifestarsi dell’armonico numero35,18 finisce anche ogni crescita di vigore fisico.19
129Matteo Martelli
tore insiste sul fatto che il termine “gregge”(agel?) è legato al termine “angelo”(aggelos),poi-ché soltanto un gamma separa le due parole. Le sfere celesti non solo sono presiedute cia-scuna da un angelo, ma esse stesse «fanno la guardia all’universo e lo mantengono nella suacontinua ed eterna stabilità» (F. Romano, Giamblico..., cit., p. 913).16 Cfr. [Iambl.] Theol. ar. pp. 56-71 De Falco; traduzione italiana in F. Romano, Giamblico...,cit., pp. 916s.17 La perfezione del 28 è già stata spiegata in vari passi precedenti: questo numero ([Iambl.]Theol. ar. p. 54 De Falco), infatti, nasce dalla somma delle prime sette grandezze, ovvero1+2+3+4+5+6+7 = 28; inoltre ([Iambl.] Theol. ar. p. 59 De Falco), può essere consideratocome il prodotto dalla moltiplicazione del 7 con il 4 (numero scudiero del 7), ed i suoi fat-tori sono 1, 2, 4, 7, 14 (cf. F. Romano, Giamblico..., cit., p. 971 n. 411). Infine ([Iambl.] Theol.ar. p. 62 De Falco) un’ultima interpretazione rimanda alla scomposizione di 28 in 13+33: inumeri cubici erano in genere detti “limitanti”, poiché comprendono le tre dimensioni checreano lo spazio reale. In questo senso il numero 28 determina la tridimensionalità delle cose(cfr. F. Romano, Giamblico..., cit., p. 971, n. 416).18 Sulle proporzioni armoniche ed il loro rapporto con il numero 35, si veda [Iambl.] Theol.ar. p. 51 De Falco = F. Romano, Giamblico..., cit., pp. 905s. e [Iambl.] Theol. ar. p. 63 De Falco= F. Romano, Giamblico..., cit., p. 921.19 F. Romano, Giamblico..., cit., pp. 924s.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 129
Proprio nell’età tra i 28 anni ed i 35, specifica infine Nicomaco, le legisla-zioni delle migliori città costringono i cittadini a fare il servizio militare,e gliatleti raggiungono le migliori prestazioni. Si assiste, in definitiva, ad unaripartizione dell’intera vita umana, nella quale si mescolano il rigore di unarigida suddivisione per settenari, considerazioni sulla natura mistica deinumeri, alcune osservazioni erudite sulle consuetudini dei popoli orientalied, infine, richiami all’organizzazione socio-politica delle città greche. L’uo-mo diventa membro attivo della società quando la sua capacità intellettivasi è pienamente formata (a partire dai 14 anni).Tra il quarto ed il quinto set-tenario, inoltre, raggiunge la massima espressione fisica, tanto che in questoperiodo l’autore ripone alcune delle attività fondamentali dell’essereumano:egli, infatti,si garantisce una discendenza e si dedica all’esercizio fisi-co, ovvero all’atletica e all’arte della guerra, discipline strettamente inter-connesse nel mondo antico.20 Ogni passaggio significativo è marcato daspiegazioni squisitamente pitagoriche, che inseriscono i momenti salientidella vita in una sovrannaturale griglia aritmetica, fatta di sezioni auree e ten-denze, per così dire, cabalistiche.Proseguendo questa rapida carrellata di speculazioni matematiche, si puònotare che Teone ribadisce i cambiamenti fisiologici già individuati in Sulleebdomadi: i denti crescono nella prima ebdomade, il seme nella seconda ela barba nella terza. Come Nicomaco, egli suddivide la crescita del corpo indue momenti:quella in altezza avviene nella quarta ebdomade e quella in lar-ghezza nella quinta. Si assiste, in definitiva, ad un allungamento del periododi crescita fino ai trentacinque anni,ponendo una certa attenzione al quintosettenario.Tra i 14 ed i 28 anni, invece, i nostri testi registrano semplici tra-sformazioni biologiche,che lasciano il giovane in una situazione ancora mag-matica e priva di precise connotazioni. Si potrebbe forse parlare di un perio-do di gestazione, che porterà i suoi frutti solo alla soglia della maturità. Infi-ne, Calcidio, nel XXXVII capitolo del Commento al Timeo, dopo aver ricor-dato che per i Pitagorici il numero sette è il più conforme alla natura, scrive:
Così è pure durante il secondo settennio di vita che,conformemente alle leggidella natura, inizia per entrambi i sessi il periodo della pubertà, col raggiungi-mento della capacità di procreare e generare. Durante il terzo settennio appa-re sulle guance dei giovani la prima lanugine della barba nascente, nel quartosettennio si completa il processo di accrescimento corporeo,nel quinto la gio-vinezza raggiunge la piena perfezione del suo sviluppo. L’uso e l’esperienzainsegnano poi che anche i processi patologici seguono un’evoluzione caratte-rizzata da un rapporto col numero sette e di ciò tratta Ippocrate sia in nume-rosi contesti dedicati all’argomento [...], sia,ovviamente,nei libri da lui espres-samente dedicati alle ebdomadi.21
130 I saggi
20 Si veda, a riguardo, il divertente dialogo di Luciano di Samosata, Anacarsi, disponibile inlingua italiana nell’edizione di P.Angeli Bernardini, Luciano.Anacarsi o sull’atletica, Porde-none, Biblioteca dell’immagine, 1995.21 Traduzione tratta da C. Moreschini, Calcidio. Commentario al Timeo di Platone, Milano,Bompiani, 2003, pp. 179s.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 130
Ritroviamo un approccio ideologico sostanzialmente omogeneo. Il limenestremo della giovinezza si sposta in avanti, scandendo le tappe fondamen-tali nello sviluppo dell’essere umano,fino alla sua completa espressione cor-porea:la giovinezza raggiunge la sua piena vitalità proprio nella quinta ebdo-made, ovvero tra i 28 ed i 35 anni.È forse arrivato il momento di chiederci in quale direzione ci conduca que-sta “aritmologia” della giovinezza, che cerca di delimitare, con calcoli preci-si, una fase per definizione liminare della vita umana. Innanzi tutto, l’oscilla-zione delle suddivisioni numeriche crea un campo dai confini imprecisati,un locus ancora vitale che sfugge ad una rigida griglia geometrica.Assistia-mo, in definitiva, ad un gioco dialettico tra phúsis e nómos, chiarito conacume da Serres, nel commento al passo erodoteo (II 109) che descrive gliagrimensori egiziani alle prese con la misurazione delle terre dopo l’inon-dazione del Nilo: «Lavorando la valle con le sue acque, il diluvio riporta laterra al disordine, al caos dell’origine, al tempo zero, esattamente alla natu-ra, al senso che questo termine assume se si vuol dire che le cose si prepa-rano a nascere; la misura corretta la riordina e la fa rinascere alla cultura,almeno nel senso agricolo».22 Misurare con precisione [justesse] è un attodi giustizia [justice] che stringe la natura nelle maglie della scienza e deldiritto. Sebbene il dato fisiologico sembri dominante nei testi appena ana-lizzati,alcuni di essi evidenziano lo stretto rapporto tra le fasi della vita scan-dite aritmeticamente e le corrispettive funzioni sociali.Varrone (Censorin.De die nat. XIV 1) afferma che il termine iuvenis deriva dalla capacità delgiovane di giovare (iuvare) allo stato nell’esercizio delle armi. Nicomaco,come abbiamo visto, evidenzia l’importanza del raggiungimento della matu-rità sessuale per poter continuare la discendenza, e mette in relazione laforza fisica, tipica della quinta ebdomade, con l’attività atletica ed il serviziomilitare. Bisogna, infine, almeno sottolineare come molte delle nostre fonti,accanto alle notizie analizzate,ricordino la celebre elegia di Solone,che divi-de la vita umana in dieci periodi di sette anni:
Ciascuno quindi nel quarto settennio raggiunge l’apice della sua forza,con la quale sogliono gli uomini far prova del loro valore.Nel quinto poi opportuno giunge il tempo, per l’uomo, di porre mente allenozze,nonché di cercare dei figli che diano un futuro alla stirpe (vv. 7-10).23
Sebbene sia difficile trovare paralleli stringenti tra tali suddivisioni e l’orga-nizzazione sociale ateniese, secondo Musti, se fino al terzo settennio avevadominato un dato naturalistico-fisiologico,dal quarto «cominciano ad impo-
131Matteo Martelli
22 M. Serres, Le origini della geometria, Milano, Feltrinelli, 19952, pp. 253s.23 Traduzione tratta da C. Neri, La lirica greca, Roma, Carocci, 2004, p. 139. Sul passo si vedaanche il commento di M. Noussia (concernente, tra l’altro, la discussione sull’autenticità del-l’elegia) in H. Maehler, M. Noussia, M. Fantuzzi, Solone. Frammenti dell’opera poetica, Mila-no, BUR, 2001, pp. 315-325.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 131
starsi altre categorie non collegate esclusivamente con il dato fisico.La forza(ischús) è infatti qui inquadrata in un contesto di categorie morali (o fisico-morali),essendo messa in gioco l’areté».24 E le medesime considerazioni val-gono per il passaggio dal semplice sviluppo di una virilità sessuale allanecessità del matrimonio. Il dato matematico non scandisce semplicemen-te la vita umana secondo un criterio naturale ed obiettivo,ma costruisce unimpianto inevitabilmente ideologico. D’altro lato, però, le linee di separa-zione tra un’età e l’altra vibrano della vitalità che genera una trasformazionee costituiscono, di conseguenza, un momento di criticità. Lo stesso numerosette si tinge di colori mistici, richiamando le forze generatrici della realtàche solo il saggio, dai contorni vagamente orientali, riesce a conoscere. Lagiovinezza sembra calcolata all’insegna di un continuo processo di crescitae di cambiamento che, inevitabilmente, sfugge ad una rigida ratio aritmeti-ca, recando memoria della natura naturans nella sua più esplicita vitalità.
Calore, secchezza ed umidità
Accanto a tale approccio matematico e quantitativo, è possibile individuaredue coppie di qualità contrapposte, caldo-freddo e umido-secco, che costi-tuiscono le coordinate privilegiate per la descrizione della realtà in nume-rosi testi medici e scientifici. Esse disegnano i poli di un tracciato interpre-tativo sovrapponibile a vari piani dell’essere: la spiegazione cosmologica,quella embriologica, il susseguirsi delle stagioni e delle età dell’uomo, la teo-ria umorale e la conseguente nosologia.Sebbene i trattati ippocratici mostri-no una pluralità di posizioni a volte contrastanti, in alcune opere si delineauna volontà di sistematizzazione che lega le quattro qualità agli umori edalle stagioni.Polibo in Sulla natura dell’uomo25 procede alle seguenti ripar-tizioni: sangue, caldo-umido, primavera; flegma, freddo-umido, inverno; bilegialla, caldo-secco, estate; bile nera, freddo-secco, autunno. Quale postooccupa la giovinezza all’interno di queste strutture?
Bisogna infatti sapere che l’uomo è al massimo del proprio calore il primogiorno di vita, al massimo della freddezza l’ultimo; di necessità infatti il corpoche s’accresce e sviluppa le proprie forze è caldo; ma quando il corpo inco-mincia la sua decadenza, scivolandovi senza sforzo, diventa più freddo; esecondo questo schema, poiché il primo giorno quanto mai s’accresce l’uo-mo, altrettanto sarà caldo, e l’ultimo giorno, poiché quanto mai decade, altret-tanto necessariamente sarà freddo (Littré VI, p. 65).26
132 I saggi
24 D. Musti, La teoria delle età e i passaggi di status in Solone. Per un inquadramentosocioantropologico della teoria dei settenii nel pensiero antico, in «MEFRA», CII, 1990, p. 19.25 Oltre all’edizione di Littré VI,pp.32-69, si veda J. Jouanna,Hippocrate.La nature de l’hom-me, Berlin,Teubner, 1975 (CMG I 1, 3). Una traduzione italiana con commento è consultabi-le in M.Vegetti, Opere di Ippocrate,Torino, Utet, 19762, pp. 429-451.26 Traduzione tratta da M.Vegetti, Opere di Ippocrate, cit., p. 451. Per un’interpretazione inparte differente, si veda J. Jouanna, Hippocrate..., cit., pp. 200s., con relativo commento.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 132
Così scrive ancora Polibo nel XII capitolo della sua opera. Si tratta di un’i-dea piuttosto spontanea che probabilmente deriva dalla contrapposizionetra il calore del corpo vivo e la freddezza del cadavere. Essa viene ribaditain altri trattati medici27 ed emerge con chiarezza all’interno del CorpusAristotelicum: «La vita si accompagna dunque necessariamente alla con-servazione di questo calore, e ciò che si chiama morte è la sua estinzione»(Aristot. Iuv. 469b).28 In tale sistema bipolare, di cui sono dati con preci-sione gli estremi, la giovinezza appare sempre spostata verso il punto d’i-nizio e viene concordemente definita calda. Essa si lega alla nascita dellavita, al calore che alimenta il rifiorire della natura, perpetuandone ancora,in qualche modo, l’afflato iniziale.Se non sono possibili fraintendimenti nella coppia caldo-freddo, il sistemamostra qualche incertezza nel momento in cui si inseriscono le altre duecoordinate. I testi, infatti, oscillano nel definire la giovinezza ora calda eumida, ora calda e secca. Del resto, già Lloyd29 notava come questa coppiadi qualità contrapposte non rientrasse con precisione all’interno della ripar-tizione dicotomica tra elementi positivi ed elementi negativi tipica dellamentalità arcaica. Egli, assieme ad altri studiosi,30 ha evidenziato l’associa-zione umidità-vita e secchezza-morte già nei testi omerici, insistendo sull’e-spressione dieròs brotós, “uomo umido”, utilizzata nell’Odissea (VI 201)per indicare l’essere vivente.31 Inoltre, gli antichi interpretavano il terminealíbas,“morto”, come “privo di umidità” (schol. in Od. VI 201; Eust. in Od. I149,17;Hesych.a 2986 Latte).32 Tale idea, secondo Thivel, è presente anche
133Matteo Martelli
27 Si veda, ad esempio, Aforismi I 14: «Gli esseri che crescono hanno moltissimo calore inna-to, dunque, hanno bisogno di moltissimo nutrimento, altrimenti il corpo deperisce. I vecchi,invece, hanno poco calore: per questo, dunque, hanno bisogno di poco combustibile. Infattiessi sono spenti da una quantità eccessiva. Per questo i vecchi non hanno le febbri cosìacute: infatti il loro corpo è freddo» (Littré IV, p. 466).28 La citazione è tratta dall’operetta Della giovinezza e della vecchiaia, della vita e dellamorte, della respirazione nella traduzione di D. Lanza. Cfr. D. Lanza, M. Vegetti, Opere bio-logiche di Aristotele,Torino, Utet, 19962, p. 1209. Nella stessa opera, poco prima, si afferma-va: «Tutte le parti e tutto il corpo degli animali possiedono un calore naturale innato: perciòmentre vivono risultano essere caldi, mentre l’opposto sono alla fine e stanno per essere pri-vati della vita» (p. 1208). Questo trattatello, assieme ad altri sei, appartiene ad una raccoltaintitolata Parva Naturalia, secondo la classificazione fatta da Egidio Romano nel XIII sec.Perun’introduzione a queste opere si veda, oltre a D. Lanza, M. Vegetti, Opere..., cit., pp. 1045-1048, l’edizione francese di R. Mugnier, Aristote. Petits traités d’Histoire naturelle, Paris, LesBelles Lettres, 1965.29 G. E. R. Lloyd, The Hot and the Cold, the Dry and the Wet in Greek Philosophy, in «JHS»,LXXXIV, 1964, pp. 92-106. Sul valore di tali categorie in ambito antropologico, si veda ancheM. M. Sassi, La scienza dell’uomo nella Grecia antica,Torino, Bollati Borlinghieri, 1988, inparticolare le pp. 81-127.30 Si veda, ad esempio, R. B. Onians, Le origini del pensiero europeo intorno al corpo, lamente, l’anima, il mondo, il tempo e il destino, Milano,Adelphi, 1998, pp. 244-341.31 Sul rapporto umidità-vita sono molto interessanti, seppure più tarde e nate da diverse sug-gestioni, le considerazioni di Porfirio: si veda, a proposito, L. Simonini, Porfirio. L’antro delleninfe, Milano,Adelphi, 1986, in particolare il cap. 10 (pp. 50-51), con relativo commento (pp.112-129).32 Altri esempi vengono riportati da R. B. Onians, Le origini..., cit., p. 307 e G. E. R. Lloyd, TheHot..., cit., p. 101.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 133
nei trattati del Corpus Hippocraticum che, sebbene non aderiscano a rigidischemi, «suppongono un passaggio graduale dalla nascita alla morte, conpredominanza di caldo e di umido nell’infanzia e nella giovinezza (l’umidoessendo più importante per le donne), equilibrio nell’età adulta, ed invasio-ne progressiva del freddo e del secco nella vecchiaia.La morte arriva per dis-seccamento».33 Nel primo capitolo del trattato Sulla natura delle donneviene detto che quelle giovani hanno più sangue (associato al calore) e sonopiù umide, mentre quelle anziane sono più secche ed hanno meno sangue(Littré VII, p. 312). Sebbene tale testimonianza sia spiegabile anche conside-rando le qualità della natura femminile, essa comunque rimanda alla posi-zione di chi vede nella giovinezza una stagione umida della vita. La stessaopinione è sostenuta anche all’interno del Peripato, che sembra associare ilcalore e l’umidità a questo periodo dell’esistenza (cfr. ad esempio Aristot.Probl. 876a 15s., 961a 2-5).D’altro canto, sempre Polibo, nel capitolo XVII di Sulla natura umana,34
sostiene che per i corpi giovani è più conveniente una dieta molle edumida,data la secchezza tipica di quest’età.Inoltre, l’autore del trattato Sulladieta, dandoci un quadro completo delle quattro età dell’uomo,afferma nelcapitolo XXXIII:
Le età prese separatamente hanno queste caratteristiche: il fanciullo è unamiscela di umido e caldo, poiché da questi è composto ed in questi è cresciu-to: dunque ciò che è vicinissimo alla nascita è più caldo e più umido e cresceil più possibile; allo stesso modo ciò che viene subito dopo. Il giovane è unamiscela di caldo e secco; caldo perché l’afflusso di fuoco prevale sull’acqua;secco perché l’umido dell’infanzia si è consumato, in parte per l’accresci-mento del corpo, in parte per il movimento del fuoco, in parte a causa degliesercizi (Littré VI, pp. 510-512).35
In relazione all’umidità si delinea, in sostanza, un quadro contrapposto aquello evidenziato dal trattato Sulla natura delle donne o dal Corpus Ari-stotelicum. Se il calore continua ad essere presente nel giovane, secondo
134 I saggi
33 A.Thivel,Cnide et Cos? Essai sur les doctrines medicales dans la Collection hippocratique,Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 270. È opportuno notare che sia Polibo che l’autore di Sulladieta definiscono la vecchiaia fredda ed umida,costituendo un’eccezione rispetto al resto delCorpus Hippocraticum e rispetto ai Presocratici, ad Aristotele e a Galeno. Sulla questione siveda, ad esempio, S. Byl, La vieillesse dans le Corpus hippocratique, in F. Lasserre, Ph. Mudry,Formes de pensée dans la Collection hippocratique. Actes du IVe Colloque internationalhippocratique (Lausanne, 21-26 septembre 1981), Genève, Droz, 1983, pp. 88s.34 Questa sezione, secondo la Littré, farebbe parte di un trattato intitolato Sulla dieta salu-bre distinto dall’opera di Polibo Sulla natura dell’uomo che,nell’edizione della studiosa, ter-mina al cap.XV (allo stesso modo in M.Vegetti,Opere di Ippocrate, cit.).Nell’attribuzione delpasso a Polibo abbiamo seguito, invece, la posizione di J. Jouanna che non accetta tale distin-zione e vede i capitolo di Sulla dieta salubre come parte integrante di Sulla natura del-l’uomo. Si veda J. Jouanna, Hippocrate..., cit., pp. 19-38.35 Nella traduzione si è seguito il testo edito da R. Joly, Hippocrate. Du régime, Paris, LesBelles Lettres, 1967. Su quest’opera si veda inoltre Id., Recherches sur le traité pseudo-hip-pocratique Du régime, Paris, Les Belles Lettres, 1960.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 134
queste ultime teorie l’elemento umido appare consumato dall’azione delfuoco e dal regime di vita adottato. Si tratta di un’oscillazione legata, verosi-milmente, alle difficoltà nello stabilire una demarcazione netta e precisa trafanciullezza, adolescenza e giovinezza. Si può notare, inoltre, che nei testi incui appare più forte l’adesione ad una classificazione quadripartita, proba-bilmente un’esigenza teorica impone di differenziare infanzia e giovinezzainsistendo sulla coppia umido-secco,data l’evidente conservazione del calo-re in entrambe. In tale sistema gli stessi criteri servono a definire primaveraed estate. Rimane tuttavia una consapevolezza, drammatica nella sua ovviaconstatazione: alla circolarità dei ritmi della natura si oppone la linearitàdella vita umana. Ogni stagione dell’esistenza appare irripetibile e, dunque,tanto più preziosa nelle sue peculiarità. La giovinezza, associata alla vitalitànaturale ed al binomio primavera-estate, conserva il sapore di un momentounico anche in testi caratterizzati da una certa obiettività scientifica.All’in-terno del Corpus Hippocraticum si tramanda memoria del detto: «Il fioriredell’età possiede ogni grazia, tutto il contrario il declino» (Littré IX, p. 270).
Prestanza fisica e coraggio, tra palestre e campi di battaglia
Già in Omero il calore era associato ad elementi positivi: Lloyd36 ricordacome il verbo iaíno fosse utilizzato sia per indicare l’acqua che bolle (Od.X 358s.) o la cera che si scioglie al fuoco (Od. XII 175s.), sia per descriverel’animo che si rallegra (Od. XV 379). Al contrario, «freddi» (kruerós okruóeis) erano detti,ad esempio,l’Ade (Hes.Op.153),la paura (Il. XXIV 524)o il pianto (Il. IX 2).Tali categorie si ritrovano anche nei testi scientifici perdescrivere la giovinezza ed alcune caratteristiche che la contraddistinguo-no.Al calore corporeo si lega la bellezza del giovane dalla pelle liscia ed uni-forme. Nei Problemi aristotelici si afferma:
Perché chi è intirizzito dal freddo diventa livido? Non sarà perché il sangue sicoagula per il freddo e coagulandosi diventa scuro, in quanto viene a manca-re il calore? Il bianco, invece, è il colore del fuoco. Perciò nei vecchi soprat-tutto la carne allividisce, perché ha pochissimo calore (887b 10-14).37
La mancanza di calore non solo fa comparire chiazze nel corpo dell’an-ziano, contrapponendolo all’avvenenza tipica della giovinezza (Probl.890a 18-22), ma lo rende meno capace di cicatrizzare e riassorbire i lividi.Ad una considerazione di carattere puramente estetico38 segue una con-
135Matteo Martelli
36 G. E. R. Lloyd, The Hot..., cit., p. 11, n. 34.37 Traduzione di M. F. Ferrini, Aristotele. Problemi, Milano, Bompiani, 2002, p. 131.38 Ancora a metà strada tra estetica ed empiria sta,ad esempio, l’osservazione secondo la qualei cani giovani hanno denti bianchi e acuminati, mentre i vecchi li hanno neri e smussati (Ari-stot. HA 501 b 12-14). Per alcuni rimedi contro gli inestetismi della vecchiaia testimoniati dalCorpus Hippocraticum, si veda S. Byl, La vieillesse dans le Corpus..., cit., p. 95, n. 82.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 135
statazione pragmatica, i cui legami con le attività proprie della giovinezzadiventano più evidenti:
Perché l’orecchio sinistro si rimargina in genere più velocemente una voltaperforato? [...] Forse perché ciò che è a sinistra è più umido e più caldo e perqueste sue qualità cicatrizza meglio? Per lo stesso motivo la cicatrizzazioneavviene nelle piante verdi;e anche le ferite nei giovani cicatrizzano meglio chenei vecchi (Probl. 960b 40-961a 5).39
Le capacità rigenerative dei tessuti, sintomo evidente di una maggiore vita-lità, sono proprietà molto utili nell’esercizio delle armi e negli allenamentiin palestra, tipici dell’età giovanile. Lividi, ferite e lussazioni, infatti, eranopiuttosto frequenti non solo in guerra, come ci si può facilmente aspettare,ma anche negli esercizi e nelle competizioni sportive. In questo senso cioffre numerose testimonianze Galeno, descrivendo vari casi di infortunianche gravi che non sempre, nonostante il vigore dell’età, si risolvevanopositivamente.40 Del resto, prescindendo dalle qualità fisiche proprie dellagiovinezza, anche l’ambizione e il coraggio, comunemente associati al calo-re e ad un temperamento sanguigno, portavano ad affrontare prove difficilie pericolose. Nei Problemi si dice più volte che sono coraggiosi coloro chehanno una natura calda,codardi quelli che la possiedono fredda (909 b 12s.,910 b 1s.). In base ad un criterio di “simpatia per contrasto”, si sostiene chechi nasce in regioni fredde sviluppa più calore e possiede, di conseguenza,più coraggio: così nella Politica assume tinte etnografiche il passo in cui ipopoli delle regioni fredde e dell’Europa sono detti pieni di energia e impa-vidi (1327 b 23-24). Un criterio analogo regola la classificazione degli ani-mali sanguigni nel trattato Le parti degli animali: il toro e il cinghiale dalsangue denso (dominano, infatti, le fibre terrose) e caldo si distinguono perl’indole ardente e il temperamento impetuoso (650b 33-651a 5). Sono, delresto, celebri le parole della Retorica (1389a 3–b 18) con cui Aristoteledescrive il carattere dei giovani che sempre bramano di essere i primi e diottenere la vittoria.Gli fa eco Plutarco che,nel trattato Sulla virtù etica, sot-tolinea il germogliare dell’elemento passionale dalla carne come da una radi-ce (451a 3-7): i giovani sono ardenti e audaci per l’abbondanza e il calore delsangue (450f 2s.). Inoltre, lo stesso autore, nell’opera Se la politica si addi-ce agli anziani, ammonisce che «è conveniente che i servitori di Ares sianogiovani e al culmine del loro vigore» (789c 11s.) e nella Vita di Silla (VI 3)ricorda che il valore guerriero esige giovinezza e forza.41
136 I saggi
39 Traduzione di M. F. Ferrini, Aristotele..., cit., p. 477. Per il valore della contrapposizionedestra-sinistra, si veda G. E. R. Lloyd, Right and Left in Greek Philosophy, in «JHS», LXXXII,1962, pp. 56-66.40 Si veda D. Gourevitch, I giovani pazienti di Galeno. Per una patocenosi dell’Imperoromano, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 49-60 e 62-64.41 Notizie tratte da S. Byl, Plutarque et la vieillesse, in «LEC», XLV, 1977, pp. 107-123.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 136
Ubriachezza e capacità intellettuali
Se i giudizi positivi sulla prestanza fisica dei giovani ricorrono con una certaomogeneità all’interno dei trattati analizzati, la situazione si complica consi-derandone le doti intellettuali e conoscitive. A livello fisiologico, secondoNicomaco di Gerasa,42 il ragazzo matura tutte le capacità verbali e argo-mentative a partire dai 14 anni.Tuttavia, l’esercizio di tali attività in età gio-vanile non è presentato in modo uniforme dagli antichi, che spesso affron-tano l’argomento mischiando osservazioni di carattere più marcatamentefisiologico a considerazioni, per così dire, psicologiche. In più occasioni Ari-stotele accosta la giovinezza ad uno stato d’ebbrezza: secondo la Retorica(1389a 8-11), i giovani sono pieni di speranza poiché, come gli ubriachi,sono di temperamento caldo e non hanno ancora avuto esperienza di moltedelusioni. Nell’Etica Nicomachea (1154b 10-12) ritorna il paragone in rela-zione allo sviluppo fisico: nella giovinezza gli uomini, a causa della crescita,sono caldi come ubriachi e tale periodo,di conseguenza,risulta piacevole.43
Del resto, l’accostamento tra calore e piacere, già presente, come abbiamovisto, anche in Omero, persiste nella letteratura scientifica successiva e saràpiù volte sottolineato nel Corpus Aristotelicum:
Il calore nelle parti con cui ragioniamo e speriamo nel futuro ci metteinvece di buon umore. Il motivo per cui tutti gli uomini hanno la ten-denza a bere fino ad ubriacarsi è che il vino bevuto in grande quanti-tà rende fiduciosi: è lo stesso effetto della giovinezza sui ragazzi, per-ché i vecchi sono privi di speranza mentre i giovani ne sono pieni(Probl. 954b 39-955 a 5).44
L’estinzione improvvisa di tale calore – mette in guardia l’autore – generadepressione e spinge a gesti estremi e inaspettati come il suicidio. Nel casodell’ubriachezza, del resto, si tratta di un calore indotto dall’esterno, il cuivenir meno genera uno stato morboso. Per la giovinezza, invece, tale stadiosembra continuativo, direttamente connesso a ragioni fisiologiche e umora-li che determinano un carattere. Sebbene si rischi una sclerotizzazione cheirrigidirebbe il discorso in giudizi troppo sommari, il paragone mantieneuna vitalità germinativa. La logica del trattato scientifico antico, che spessoprocede per analogia associando diversi elementi del reale,amplifica questo
137Matteo Martelli
42 Si tratta del passo citato nel primo paragrafo: cfr. F. Romano, Giamblico cit., pp. 924s.43 Un ulteriore esempio del rapporto tra buona speranza e vino si trova nell’Etica Eudemea(1229 a 19-21): «Un’altra specie è quella conforme a speranza ed in base alla quale affronta-no i pericoli sia coloro che hanno spesso avuto fortuna sia gli ubriachi, poiché il vino fa spe-rare bene gli uomini» (trad.di L.Caiani, in L.Caiani, F.Adorno,Etiche di Aristotele.Etica Eude-mea, Etica Nicomachea, Grande Etica,Torino, Utet, 1996, p. 116).44 Traduzione di M. F. Ferrini, Aristotele..., cit., p. 445. Il passo in questione è tratto da Probl.XXX 1, in cui è affrontato il problema del temperamento melanconico. In proposito si vedaanche la traduzione con commento di C.Angelino,E. Salvaneschi,Aristotele. La “melancolia”dell’uomo di genio, Genova, Melangolo, 1981: ivi una bibliografia essenziale.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 137
raffronto, inserendolo in una complessa trama di teorie e spiegazioni. È undato comunemente accettato che il vino introduca nel corpo calore e umi-dità, come viene più volte ribadito in tutta la terza sezione dei Problemi,dedicata interamente a quest’argomento. Le medesime qualità caratterizza-no anche il temperamento dei giovani, tanto che l’autore afferma che costo-ro, essendo caldi e umidi, non amano il vino poiché non sentono la neces-sità di assumere una sostanza che possiede le loro medesime caratteristiche(872a 2-8).Viene addirittura affrontato un problema diuretico, seguendo lamedesima logica: i giovani, se ubriachi,a letto sono più incontinenti dei vec-chi,poiché la loro natura è già umida e il calore non riesce a consumare l’ec-cesso di liquidi assunti con il vino (876a 15-25). In tali strutture interpreta-tive, l’umidità, nella sua ambivalenza, spesso era sentita come la causa dialcuni deficit tipici dell’età giovanile. Un’eccessiva fluidità della naturarende i giovani privi di memoria, poiché le immagini non si fissano su unsupporto mobile e sempre cangiante (Aristot. Mem. 450a 30-451a 11): l’e-nergia del giovane, dunque, legata al cambiamento e alla trasformazionetipici della sua età, non giova allo sviluppo delle doti mnemoniche. Se, delresto, l’umidità era associata all’ebbrezza, seguiva di necessità che chi eracontraddistinto da questa qualità non riusciva a trattenere i ricordi.Un fram-mento eracliteo rammenta (22 B 117 D.-K. = 55 Diano):
uomo ubriaco un fanciullo lo guida: il piede gli vacilla e non sa dovemettere il passo: egli ha umida l’anima.45
Inumidito dal vino, l’uomo smarrisce la strada, dimentica i punti di riferi-mento maturati con l’esperienza e ritorna bambino. Egli perde, infatti, l’acu-tezza e la sottigliezza dell’anima secca, «di tutte la migliore e più saggia» (22B 118 D.-K. = 56 Diano).46 Il semplice dato fisiologico si arricchisce di unamarcata valenza psicologica, spesso presente anche nei testi di Aristotele: ilgiovane non ha sufficientemente vissuto e,di conseguenza,guarda il mondocon fiducia e forse con illusione, perché privo di saggezza. In tale prospetti-va anche il calore, associato ad elementi positivi quali il coraggio e la spe-ranza, ribalta le proprie valenze:
Perché gli abitanti delle regioni calde sono più intelligenti di quelli deipaesi freddi? Sarà per la stessa ragione per cui i vecchi sono più saggidei giovani? Gli uni, infatti, a causa del freddo dei luoghi in cui vivono– poiché la loro costituzione li restringe – sono molto caldi sì da asso-migliare a chi ha troppo bevuto, e non amano apprendere ed indaga-
138 I saggi
45 Seguiamo la traduzione di C. Diano, G. Serra, Eraclito. I frammenti e le testimonianze,Milano, Mondadori, 1993, p. 29.46 Traduzione di Diano, Serra, Eraclito..., cit., p. 29. Per gli effetti “umidificanti” dell’ubria-chezza e la fortuna del motivo si veda I.Dionigi,Lucrezio.Le parole e le cose,Bologna,Patron,20053, pp. 157-163.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 138
re,ma hanno coraggio ed ottimismo,mentre gli abitanti dei paesi caldisono sobri,perché di costituzione fredda (Aristot.Probl.910a 26-32).47
Sembrerebbe delinearsi, in sostanza, un quadro che ricalca la contrappo-sizione, sedimentata nell’opinione comune, tra l’ardore dei giovani e lasaggezza degli anziani. I primi, animati dalla vitalità della natura che nedetermina la crescita, sono meno inclini all’indagine sistematica e allapacata riflessione di chi ha molto vissuto. Simili considerazioni riemergo-no in un testo, attribuito dalla tradizione a Democrito,48 che segna gli inizidella letteratura alchemica greca. L’autore, infatti, polemizza aspramentecon i giovani che,mossi da impazienza,cercano di applicare le antiche tec-niche metallurgiche senza avere prima intrapreso uno studio metodicodegli elementi e delle loro proprietà:
Dunque, miei compagni nella profezia, io so che voi non siete inpreda al dubbio, ma pronti allo stupore: conoscete, infatti, la potenzadella materia. I giovani, invece, si troveranno totalmente impotenti ediffidenti verso lo scritto, poiché non conoscono la materia, nonsapendo che i discepoli dei medici, quando vogliono preparare unfarmaco benefico, non si accingono a farlo con slancio dissennato,ma sperimentando dapprima quale ingrediente sia caldo,quale ingre-diente, congiunto a questo, si mischi in modo proporzionato, qualesia freddo, o umido, o quale sia la sua proprietà [...]. Costoro (i gio-vani), invece, volendo preparare la cura per l’anima e il riscatto daogni miseria con impeto privo di riflessione e raziocinio, non siaccorgeranno che saranno impotenti.49
Le nature proprie degli ingredienti, che si celano dietro la molteplicità dellamateria utilizzata, possono essere individuate e utilizzate solo grazie adun’indagine approfondita della realtà, basata anche sull’analisi degli scrittiche trattavano dell’argomento.A prescindere dalla valenza in parte misticadel termine “natura” (physis), il passo è connotato da un atteggiamento percosì dire razionalista, che vede nell’accurata “ricerca di laboratorio” e nel-l’attento studio dei testi le basi per riuscire nella difficile scienza alchemica.
139Matteo Martelli
47 Traduzione tratta dall’edizione critica con traduzione e commento di G. Marenghi, Aristo-tele. Problemi di medicina, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1965.Troviamo un passo ana-logo anche in Probl. 956b 40-957a 2: «In questo sembra consistere anche la scienza, nel fer-mare l’anima; perché non è possibile percepire né pensare se l’anima è in movimento e sisposta. Per questo i bambini, gli ubriachi e i folli sono incapaci di ragionare: per la grandequantità di calore [...]» (M. F. Ferrini, Aristotele..., cit., p. 457).48 Si tratta, naturalmente, di una falsa attribuzione: l’opera, infatti, risale verosimilmente al I-IIsec. d.C. Sulla questione si veda, ad esempio, M. Berthelot, Les origines de l’alchimie, Paris,1885, pp. 145 ss. e Festugière, La révélation..., cit., I, pp. 224 ss.49 La traduzione è stata condotta sul testo greco edito da M. Berthelot e C.-E. Ruelle, Collec-tion des anciens alchimistes grecs, Paris, 1888, pp. 46s., leggermente rivisto in base ad unanuova collazione dei principali testimoni manoscritti.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 139
I giovani non mostrano di possedere la giusta attitudine, travolti dall’impa-zienza e dall’ansia di ottenere risultati facili e immediati.Allontanandoci, tuttavia, da cliché sulla cui fortuna sarebbe inutile dilungar-si, si deve notare che un tale impianto ideologico non è pienamente solidoe compatto, lasciando così lo spazio per fratture e ribaltamenti.Ancora i Pro-blemi (955b 9-956a 10) si domandano perché i giovani apprendano piùvelocemente degli anziani, offrendo, in questo caso, una risposta piuttostointuitiva: da giovani impariamo più rapidamente perché privi di qualsiasiconoscenza. Con l’aumentare dell’esperienza non possiamo più apprende-re come prima, ma dobbiamo attenerci a ciò che già sappiamo. Il trattatopseudo-ippocratico Sulla dieta (XXXV 8-11 = Littré VI 518-523) descrivevari stadi dell’intelligenza dell’anima secondo il grado di supremazia delfuoco sull’elemento acquoso.Ad un primo livello, la mente è celere e le sen-sazioni rapide, capaci di seguire il movimento delle particelle che ci colpi-scono tramite gli organi sensoriali.Ad un secondo livello, essa mantiene lestesse caratteristiche, ma perde in stabilità.Ad un terzo, invece, se il calorediventa eccessivo a causa di una malattia (ad esempio un’infiammazione delsangue) o per costituzione, l’individuo rischia di impazzire a causa dell’ec-cessiva velocità dell’anima. Sebbene non sia possibile una perfetta sovrap-posizione tra fuoco e calore e tra acqua e umidità,50 una simile descrizionesembra, in ogni modo, rivalutare il ruolo del caldo anche in ambito gnoseo-logico. In Sulla dieta leggiamo, infatti:
Quando l’acqua esercita un’influenza (dynamis) più debole ed il fuocoè caratterizzato da una mescolanza pura,una tale anima, in un corpo insalute, sarà intelligente e pronta a percepire velocemente le particelleche la colpiscono, senza essere più volte perturbata (XXXV 8).51
Il calore, dunque, che tutti i testi scientifici considerano come una qualitàpropria della giovinezza, rende l’anima veloce come lo sfavillare dellafiamma: essa, se supportata da un corpo in salute, è subito pronta ad adat-tarsi alle sollecitazioni che provengono dall’esterno, senza, tuttavia,esserneperturbata. Queste parole dell’anonimo autore di Sulla dieta potrebberoessere incluse nelle Lezioni americane di Calvino,come ulteriore esempiodi rapidità di spirito e intelligenza. Considerando, inoltre, che nel suddettotesto medico il giovane è considerato “secco”– avendo già consumato, conla crescita e l’esercizio, l’umidità tipica solo della fanciullezza – si potrebbededurre che costui possiede le qualità per una conoscenza immediata dellecose: la velocità, generata dal calore giovanile, tiene il ritmo delle sensazio-ni, del continuo mutare del mondo fenomenico. Se il ragazzo non raggiun-ge ancora la chiarezza adamantina della logica o la saggezza maturata gra-
140 I saggi
50 A ciascuno dei due elementi, infatti, sono associate due qualità: calore-secchezza al fuocoe freddo-umidità all’acqua.51 Traduzione condotta sul testo edito da R. Joly, Hippocrate..., cit., p. 32.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 140
zie alle esperienze di una vita, esso conserva e alimenta la curiositas peruna realtà viva e screziata. Nella consapevolezza dell’impossibilità di rico-struire uno schema che comprenda la pluralità delle posizioni analizzate,sembrerebbe comunque lecito affermare che i giovani non appaiono esclu-si da ogni capacità intellettuale. Possono forse valere come parole di con-gedo le intense frasi con cui Borges descrive la giovinezza di Omero,primache la cecità lo iniziasse al mondo della memoria:
Non aveva mai indugiato nei piaceri della memoria. Le impressioniscivolavano su di lui, momentanee e vivide; il carminio di un vasaio,la volta celeste carica di stelle che erano anche dèi, la luna,dalla qualeera caduto un leone, la politezza del marmo sotto i polpastrelli sensi-bili, il sapore della carne di cinghiale, che gli piaceva addentare amorsi bianchi e secchi, una parola fenicia, l’ombra nera di una lanciasulla sabbia gialla, la vicinanza del mare o delle donne, il vino densola cui asprezza mitigava il miele, potevano riempirgli totalmente l’a-nima. Conosceva il terrore, ma anche la collera ed il coraggio, e unavolta fu il primo a scalare un muro nemico.Avido, curioso, impreve-dibile, senz’altra legge che il piacere e l’indifferenza del momento,andò per la diversa terra e contemplò, su questa o quella sponda delmare, le città degli uomini e i palazzi.Nei mercati affollati o ai piedi diuna montagna dalla vetta incerta, sulla quale ben potevano abitare isatiri, aveva ascoltato complicate storie, che aveva accettato comeaccettava la realtà, senza indagare se fossero vere o false.52
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/percor-si/5martelli.htm
141Matteo Martelli
52 J. L. Borges, L’Artefice, trad. it. di T. Scarano, Milano,Adelphi, 1999.
004 Franzoni 2-11-2007 14:57 Pagina 141
Addio giovinezza! Analisi di un topos crepuscolareIvan Rivalta
Chi del crepuscolarismo s’interessi tanto da frequentarne anche i minorie i minimi facilmente potrà notare come quei giovani poeti – pressochétutti – una volta almeno abbiano compianto la fine della loro giovinezza,con termini simili e analoghe riflessioni, laddove abbiano tentato di espri-mere, oltre ai lamenti, le cause del loro precoce sfiorire. Né mancano, inquegli stessi anni, pagine simili in opere d’autori estranei al crepuscolari-smo: vi doveva dunque essere una più diffusa ragione, dietro questo sen-tirsi così repentinamente vecchi, al di là delle singole vicissitudini biogra-fiche e dell’appartenenza ad una certa “scuola”.Purtuttavia, anche restringendo l’analisi ai soli crepuscolari, sarebbe trop-po ingenuo ridurre questo fenomeno ad una posa o ad una moda passeg-gera, se davvero ogni movimento letterario è l’espressione di un più pro-fondo movimento spirituale, come a tal proposito scriveva già il Petronio,uno dei primi studiosi del crepuscolarismo:
Accadeva in fondo quello che accade ad ogni generazione, in cui alcune formedi poesia predominano e vengono ripetute dai più,un poco dietro l’influsso dichi per loro mezzo ha saputo raggiungere l’arte o più semplicemente la fama,un poco perché una comune disposizione spirituale fa sentire quelle formecome le più adatte all’estrinsecazione del proprio stato d’animo: si formanocosì quelle che noi chiamiamo scuole o movimenti letterari, ma che in realtàsolo difficilmente e solo fino ad un certo punto sono letterari, ché per lo piùsono invece l’eco e il riflesso di movimenti spirituali, i quali determinano nonsolo la scelta dei temi, ma persino ciò che si suole chiamare la tecnica.1
Scopo di questa indagine è analizzare le origini storiche, i modelli lettera-ri e – sia pur solo per un breve tratto – l’evoluzione di un tema così fre-quente e caratteristico.Per delineare un primo quadro di quell’epoca, e soprattutto della “condizio-ne giovanile”d’allora,si leggeranno con profitto le parole di un poeta che fuper certi versi precursore del crepuscolarismo:Arturo Graf. Egli, dedicandoai suoi allievi una raccolta d’aforismi – coll’auspicio che,di tutti i libri da luiscritti proprio quello fosse “il meno inutile”– così scriveva nel 1908:
Voi siete tristi e non sapete perché.Se non è gioconda la giovinezza,quale altraetà della vita potrà esser gioconda? La vostra giovinezza è come una pianta cui
142 I saggi
1 G. Petronio, I crepuscolari, Firenze, Sansoni, 1937, pp. 5-6.
11
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 142
siano contrarii il clima e il suolo.Voi siete tristi della tristezza di questa nostraciviltà cupa e feroce, non meno infesta ai giovani che ai vecchi.Ai vecchi, cuigià natura scema il vigore,essa, la civiltà, col tumulto della sua foga incalzante,con l’asprezza de’ suoi congegni, con l’oppressione della sua congerie, nega ilriposo, mozza il respiro, affretta la morte.Ai giovani ruba la giovinezza, scerpail fior della vita.Voi sentite di morire alla giovinezza prima ancora d’averla assa-porata.L’anima vostra si oscura e si sfredda,non avete più né tempo,né voglia,di sognare e d’amare. Prima coloro che vi misero al mondo, poi coloro che viammaestrano, non vi sanno parlare d’altro che della necessità di tirare al gua-dagno, di assicurarsi un posto, di buttar via le illusioni, e di far presto. Prende-te in avversione la casa e la scuola. Chiedete una parola di vita, e non l’uditeda nessuna parte. Le religioni, con voci di oracoli spenti, con richiami di mitimorti, vi parlano un linguaggio che voi non potete più intendere. La filosofiadiscute alla vostra presenza un numero stragrande di cose che non vi giovanoe non v’importano, e si scorda di dirvi come e perché dovete vivere, quale siail senso e il valor della vita. La scienza vi ammonisce che mondo fisico emondo morale soggiacciono a una stessa necessità, eterna e ineluttabile, chetutto si riduce a meccanismo,che voi medesimi non siete se non automi,e chenon vi sono valori nel mondo, ma soltanto fatti e leggi. L’arte, da ultimo, vidichiara che essa ha da attendere a sé e non a voi; che nulla essa ha da sparti-re con gli altri interessi umani. Se volete, senza che altri vi soccorra, misurarele vostre forze, penetrare in voi stessi, conoscervi, il tempo vi manca, o l’in-quietezza vi turba, o il frastuono v’assorda.Vi affacciate a questa scena del mondo,e quale spettacolo vi si offre? Uno spet-tacolo voi non sapete se più doloroso, o più laido, o più grottesco. Cercate didarvi ragione di ciò che vedete,e non ci riuscite.Chiedete a voi stessi se la civil-tà abbia per iscopo di esaltare l’umana natura ovvero di deprimerla. Imparate aconoscere la terribile schiavitù del libero cittadino, l’atroce miseria del popolosovrano. Vi sentite avvinghiati, premuti, travolti; e in quella che date tutte levostre forze alla comune opera interminabile, che, pure essendo comune, ètutta tramata di rivalità e di conflitti; e mentre vi logorate nella cotidiana faticadel fare, disfare, rifare; vi avvelena l’anima un dubbio amaro, se non pure ladisperata certezza,della inutilità dell’opera vostra e dell’altrui e di ogni possibi-le opera. Sentite che la macchina immane che abbiam costruita ci stritola; chele cose prodotte a giovamento delle persone affogano le persone:e nella età incui più dovrebbe parer lieta la vita, molti di voi desiderano di non essere nati.2
Una prima, autorevole, conferma dell’attendibilità di questa analisi vieneaddirittura da un testo scientifico, opera di quel Paolo Mantegazza che fuil primo antropologo d’Italia: costui, già nel 1887 – dunque vent’anniprima di Ecce homo – pubblicò un saggio intitolato Il secolo nevrosico, incui analizzava gli effetti del vivere moderno sul sistema nervoso,primo deiquali il pessimismo, per cui tutti – ma i giovani in particolare – divengonoscettici e si perdono d’animo.3
143Ivan Rivalta
2 A. Graf, Prefazione a Ecce Homo.Aforismi e parabole, Milano,Treves, 1908 (ora in Confes-sioni di un maestro, Novara, Interlinea, 2002, pp. 166-172).3 Cfr. P. Mantegazza, Il secolo nevrosico, Pordenone, Studio Tesi, 1995, pp. 53-54 e 73-74.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 143
Nel compianto sulla fine della giovinezza potremmo dunque fissare unaprima distinzione, tra ciò che riguarda la decadenza fisica e quanto invecedebba riferirsi alla perdita dell’entusiasmo, alla sfiducia nel futuro ed in sestessi. Ma tale distinzione non sarà mai netta e decisiva, sempreché sia veroquello che, per l’appunto, si legge negli aforismi di Arturo Graf: «Se l’animatua invecchia innanzi tempo,invecchierà innanzi tempo anche il tuo corpo».4
Ma per comprendere come il passo citato esprimesse appieno la condi-zione giovanile d’un secolo fa, basterebbe la testimonianza di Carlo Calca-terra, che fu in quegli anni allievo del Graf e, per così dire, condiscepolodi Gozzano. Nell’introduzione ad una sua nota raccolta di saggi, ConGuido Gozzano e altri poeti, il Calcaterra si servì appunto di quelle stes-se parole del suo antico maestro,5 per far comprendere ai lettori i dubbi,le amarezze e i disinganni di un’intera generazione.L’invettiva d’Arturo Graf, pur così accessa, coglie nel segno e trova con-ferma nel successivo giudizio dei critici. A ben vedere, i suoi strali sonorivolti non tanto verso la civiltà “cupa e feroce” (nella cui analisi concor-dava sostanzialmente col Mantegazza) quanto verso quelle fonti ideali dacui si attendeva invano una “parola di vita”: religione e filosofia, scienza edarte. Certo la crisi del positivismo e il rifiuto della poesia decadente ebbe-ro in quegli anni un valore determinante – e tanto più dovettero averloper un poeta che si rivolgeva ai suoi discepoli – ma altri hanno invece insi-stito sulla natura storica e sociale di quello smarrimento:
In fondo i crepuscolari documentano ambiguamente, esauritosi il ciclodell’“imperialismo” crispino, e prima dell’avventura libica, la caduta di ognifiducia nei destini di quella “nuova Italia”che ora doveva scontrarsi con pro-blemi economico-sociali prima trascurati. E se certo migliorarono le condi-zioni di vita della media e piccola borghesia e di alcuni ceti operai, da partedelle classi egemoni mancò una nuova proposta di miti in grado di surroga-re la fine delle idealità romantico-risorgimentali [...].Al di qua dell’azione, e come tagliati fuori dai moti e dai conflitti reali dellastoria, i crepuscolari vivono la loro delusione esistenziale e storica di picco-li borghesi in negativo, in una condizione limbale di indecisione e di accidia,tra adesione e negazione della quotidianità.6
Allo stesso modo Umberto Bosco e Nino Tripodi insistevano sulla crisi deivecchi partiti7 e sulla desolante politica italiana tra Otto e Novecento;crisiche faceva sentire ancor più stridente il contrasto della realtà d’allora cogliideali della poesia carducciana.8 Al di là dei sistemi filosofici e dei movi-
144 I saggi
4 A. Graf, Ecce homo..., cit., p. 163.5 C. Calcaterra, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna, Zanichelli, 1944, pp.VIII-IX.6 G. Savoca, M.Tropea, Pascoli, Gozzano e i crepuscolari, Bari, Laterza, 19761 (19855), p. 91.7 Cfr. U. Bosco, Dal Carducci ai crepuscolari, in Realismo romantico, Caltanissetta-Roma,Sciascia, 1959, pp. 213-214.8 Cfr. N.Tripodi, I crepuscolari, Milano, Edizioni del Borghese, 1966, pp. 10-12.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 144
menti letterari forte era dunque l’incidenza della vita quotidiana,con tuttele sue ipocrisie e le sue piccole miserie.Non tutti i testi, però, lasciano trasparire il fastidio dell’autore per la socie-tà in cui vive; alcuni parrebbero compiangere, molto più semplicemente,la fine della giovinezza – la sua fine “biologica”– senza riferimenti esterni:è il caso del testo più celebre di questa rassegna, I colloqui [I] di GuidoGozzano, la lirica che apre e dà il nome all’intero volume del 1911:
Venticinqu’anni!... Sono vecchio, sonovecchio! Passò la giovinezza prima,il dono mi lasciò dell’abbandono!
Un libro di passato, ov’io reprimail mio singhiozzo e il pallido vestigioriconosca di lei, tra rima e rima.
Venticinqu’anni! Medito il prodigiobiblico... guardo il sole che declinagià lentamente sul mio cielo grigio.
Venticinqu’anni... Ed ecco la trentinainquietante, torbida d’istintimoribondi... ecco poi la quarantina
spaventosa, l’età cupa dei vinti,poi la vecchiezza, l’orrida vecchiezzadai denti finti e dai capelli tinti.
O non assai goduta giovinezza,oggi ti vedo quale fosti, vedoil tuo sorriso, amante che s’apprezza
solo nell’ora triste del congedo!Venticinqu’anni!... Come più m’avanzoall’altra meta, gioventù, m’avvedoche fosti bella come un bel romanzo!9
Venticinqu’anni! Ecco il termine della “giovinezza prima”, su cui il poetainsiste qui e anche altrove, sia parlando in prima persona (come In casadel sopravvissuto10) sia celandosi dietro la figura di Totò Merumeni, ilquale a sua volta “ha venticinque anni”.11
145Ivan Rivalta
9 G. Gozzano, I colloqui [I], in I colloqui, vv. 1-22.10 Cfr. G. Gozzano, In casa del sopravvissuto, vv. 43- 48: «“Mah! Come l’io trascorso è buffo epazzo! / Mah…” – “Che sospiri amari! Che rammenti?” / “Penso, mammina, che avrò tostoventi- / cinqu’anni! Invecchio! E ancora mi sollazzo / coi versi! È tempo d’essere il ragazzo /più serio, che vagheggiano i parenti”».11 G. Gozzano, Totò Merumeni, in I colloqui, cit., vv. 17-20.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 145
I colloqui avevano, però, un precedente illustre, poiché la stessa situazio-ne, ma più cupamente disperata che malinconica e lieve come in Gozza-no, si trovava già nel Praga di Desolazioni,12 il componimento con cui ilpoeta nel 1864 volle chiudere la raccolta Penombre (anche in questocaso, dunque, una posizione “forte” all’interno del volume):
Il marchio aspetto delle bianche chiome,a cinque lustri errando nella vita,vecchio come una quercia e affranto comeun sibarita,13
Sempre nello stesso volume, pubblicato a venticinque anni, torna in alme-no altri due passi questo presagio – dunque non occasionale – sulla pre-coce fine della giovinezza: in Dama elegante il poeta ricorda «la noia cheprecede gli anni»;14 mentre così si legge nei versi A Vittor Hugo:
O giovinezza che già muti nome,una pura armonia spirami ancora,un inno alato! Pria che il verno dal cor salga alle chiome,prima che tutta la mia bionda auroram’abbia lasciato!
Dammi per poco ancor la vaga aureola che han presa i disinganni;il coraggio, la fede, e le vertigini dei miei vent’anni!
Fammi ancor bello, fammi ancor buonocome nei lieti dì che il cor sbocciavadai primi versi;toglili al buio, ove sepolti sono,e un inno sol redimerà la ignava vita che persi!15
146 I saggi
12 Che Gozzano conoscesse bene le opere del Praga stanno ad attestarlo i molti luoghi simi-li, tra i quali forse il più notevole è la dichiarata vergogna d’essere poeta, vero e propriotopos crepuscolare che già si riscontrava nei versi dello scapigliato: «Tanta vergogna mi mor-deva il cuore / d’esser poeta» (Rivolta, in Penombre, vv. 19-20). La vicinanza dei due autoriè, per altri versi, già da tempo nota alla critica: cfr. G. Scarsi, Gozzano e gli scapigliati, inAA.VV.,Guido Gozzano.I giorni, le opere,Firenze,Olschki,1985,pp.220-222.Anche la socie-tà in cui si trovarono a vivere presentava sostanziali analogie, pur essendo il Praga più vec-chio d’oltre quarant’anni e cresciuto si può dire in pieno Risorgimento. La sua Milano, infat-ti, all’indomani della seconda guerra d’indipendenza appariva sostanzialmente distaccatadalla vita nazionale e dai generosi ideali d’allora, tutta “intesa alla moneta”(per dirla con Goz-zano) o, meglio, al “biglietto di banca” (per dirla col Praga). Cfr.A. Romanò, Introduzione a E.Praga, Tavolozza e Penombre, Bologna, Cappelli, 1963, pp. 5-6.13 E. Praga, Desolazioni, in Penombre, vv. 1-4 (corsivo mio).14 Id., Dama elegante [Costei, la bionda dagli occhi procaci], in Penombre, v. 11.15 Id., A Vittor Hugo, in Penombre, vv. 5-20.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 146
Ma Praga non sembra considerare il decadimento fisico: egli attende anco-ra il «marchio delle bianche chiome» giacché la noia in lui «precede glianni» e il «verno» che gli opprime il cuore non è ancora salito ad incanu-tirgli il capo; ed infine, proprio nelle ultime strofe di Desolazioni, inveiscecontro «un odiato involucro ventenne» che ancor trattiene in vita «un’ani-ma di cento anni».16 La coincidenza tra i due poeti si direbbe allora casua-le, limitata alla fatidica età di venticinque anni: Praga lamenta piuttosto lasua insoddisfazione d’artista per una meta non raggiunta, per tutti i disin-ganni che gli han tolto il «coraggio» e la «fede» (son parole sue) di poterlaraggiungere ancora, quella meta.Riprendendo però la lettura di Desolazioni vi si può ravvisare, per Goz-zano, la fonte di un’altra possibile reminiscenza, ispirata dai versi in cuiPraga accennava alla causa del suo rammarico per il passare degli anni;rammarico determinato dalla lunga e vana attesa di un suo non megliospecificato ideale, che il poeta chiama «fantasma»:
e lo sa Iddio se la mia perla fina,questa infelice giovinezza mia,profanò la sua luce adamantinaper bieca via!
Lo sa Iddio se ho vegliato al mio gioiello,se mai vil senso l’anima mi punse;vissi aspettando il mio fantasma belloche mai non giunse17 [...]
Ma non sono forse queste le parole di Totò Merumeni, il quale, appunto,«sognò per anni l’amore che non venne»? L’interpretazione del “fantasma”di Praga semplicemente come amore sarebbe certo restrittiva; ma quelloche più importa, e che avvicina le due poesie, è il comune destino di unagiovinezza trascorsa nell’attesa – fiduciosa ma forse troppo inerte – di unbene che non sarebbe mai giunto. La suggestione, anzi, era ancor più anti-ca, e la si trova espressa in termini difficilmente equivocabili già nelResponso, compreso nella precedente Via del rifugio:
Come una sorte trista è sul mio cuore, immagine(se vi piace l’immagine un poco secentista)
d’un misterioso scrigno18 d’ogni tesoro grave,ma ne gittò la chiave l’artefice maligno [...]
147Ivan Rivalta
16 Id., Desolazioni, in Penombre, vv. 41-42.17 Id., Desolazioni, in Penombre, vv. 5-12 (corsivo mio).18 L’immagine del cuore come uno scrigno chiuso deriva invece da un altro poeta ben cono-sciuto da Gozzano, Lorenzo Stecchetti: «Il mio cuore è uno scrigno di velluto / che con settesigilli è sigillato» (L. Stecchetti, Il mio cuore, in Adjecta, vv. 1-2, corsivi miei).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 147
Se al cuore che ricusa d’aprirsi, una divotaRechi la chiave ignota dentro la palma chiusa,
per lei che nel deserto farà sbocciare i fiori,saran tutti i tesori d’un cuore appena aperto [...]
Nel cuore senza fuoco già l’anima è più stanca,più d’un capello imbianca, qui, sulla tempia, un poco.
Ogni sera più lunge qualche bel sogno è fatto:aspetta il cuore intatto l’amore che non giunge.19
Qui l’attesa era ancora in atto – il verbo è al presente – ma, in compenso,i primi segni dell’invecchiamento sembrano aver già fatta la loro compar-sa. Al di là di questa variazione, possiamo comunque tracciare una lineache da Praga vada fino a Gozzano: individuati il punto d’arrivo e il puntodi partenza, restano da tracciare alcuni punti intermedi.Sicuramente noto a Gozzano perché anch’egli torinese, Enrico Thovez inmolti versi giovanili aveva prima di lui mostrata una certa affinità conPraga,20 intrecciando nuovamente quei due temi che già si trovavano unitinei versi del poeta scapigliato.Thovez pubblicò il suo Poema dell’adolescenza nel 1901, quand’egliaveva già superata la trentina, ma lo aveva in gran parte composto tra idiciotto ed i ventiquattro anni.21 Ricorre in lui, fin quasi all’ossessione, ilcompianto sulla prematura fine della giovinezza: «Me non ventenne giàopprime la sconsolata vecchiaia»22 e per questo giunge fino ad invocare lamorte, dal cui desiderio neppure il pensiero della madre potrebbe disto-glierlo (mentre si ricorderà come Gozzano, nel giorno esatto del ventesi-mo compleanno, pubblicasse in rivista la sua Laus Matris, che si chiudeproclamando la propria gioia di vivere e l’anelito ad una impossibileimmortalità).Anche il tema dell’attesa (attesa dell’amore, attesa casta e quasi religiosa)ricorre spesso nel poema: «E mi chiedevo: verrà l’amore? Troverò mai / l’a-nima che mi comprenda in questi aneliti?».23 Domande alle quali lo stessopoeta, più avanti, darà la sua sconsolata risposta: «Son vecchio. Passano glianni. Io lotto, gemo ed aspetto. / Sento che scendo una china donde più
148 I saggi
19 G. Gozzano, Il responso, in La via del rifugio, vv. 35-64.20 Per inciso si noti come il titolo di Fantasma accomuni tre componimenti del Poema del-l’adolescenza, a cominciare da quello con cui s’apre l’opera: nei primi due casi il termineallude alla donna invano amata, mentre nel terzo si riferisce alla morte: Praga, come s’è visto,aveva designato collo stesse termine l’oggetto della sua lunga attesa.21 Cfr. C. Calcaterra, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna, Zanichelli, 1944, p. 145.22 E.Thovez, Notte d’estate, in Il poema dell’adolescenza, v. 5. Cfr. anche Veglie, v. 7: «Ed iod’un tratto mi vidi, mi sentii vecchio per sempre».23 Id.,Sul ponte, in Il poema dell’adolescenza, vv.17-18.Cfr. anche la chiusa di Grido in Apri-le, che termina al v. 5 col grido «Mi manca l’amore!»; nonché Il giorno, v. 17: «Son anni edanni che spasimo, che agogno d’essere amato».
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 148
non tornerò / [...] / e sogno, palpito, e attendo l’amore che non verrà».24
Come Totò Merumeni, il quale – ripetiamolo – «sognò per anni l’Amoreche non venne».Questo tema dell’attesa è a sua volta un piccolo topos crepuscolare25 dicui si trovano attestazioni anche molto diverse: può essere appena accen-nato, circoscritto ad un episodio minimo, come nella Domenica di Moret-ti, dove «l’amante pieno d’ardore, / che attese presso una chiesa / si logo-rò nell’attesa / tutto il suo giovane cuore»;26 oppure ispirare il titolo e l’ar-gomento di un’intera poesia. È il caso dell’Attesa di Corazzini:
Come due dolci bocche ansiose, preseA un tratto da la febbre di baciarsi,Attendono l’union soave, acceseDal desiderio; come umani arsi
Di sete, con le braccia al ciel protese,Attendono con rabbia stanca, sparsiPer il deserto, con le membra offeseDa un sole ardente, di che dissetarsi;
Come ogni foglia attende il suo fioreCome ogni fiore attende il suo fruttoCome ogni notte attende il suo sole;
Così, così col cuore che mi duoleNell’attesa, dimentico di tutto,Così, così t’attendo, dolce amore!27
Tornando ai versi di Enrico Thovez possiamo osservare altri elementi chelo avvicinano a Gozzano, giacché al semplice lamento sulla fine della gio-vinezza si aggiunge il rimpianto di non essere vissuto, così come in Goz-zano la «non assai goduta giovinezza» viene assimilata ad «un bel romanzoche non fu vissuto»:28
Sono già un vecchio. Lo sento al passo grave, allo stanco palpito tardo del cuore irrigidito: discendo
149Ivan Rivalta
24 Id., Ansie, in Il poema dell’adolescenza, vv. 1-2 e 11 (corsivo mio). Cfr. anche L’autunno,v. 17.25 Ma se ne può forse scorgere la traccia anche nella Canzone d’Aprile di Giovanni Pascoli:«Ogni anno a te grido / con palpito nuovo. / Tu giungi: sorrido; / tu parti: mi trovo / due lagri-me amare / di più» (vv. 13-18). Il poeta vi si rivolge al cuculo, il cui arrivo segna l’inizio dellaprimavera, la stagione degli amori. Dietro vi era già, prima di Pascoli, una piccola tradizioneletteraria; ma egli mostra d’attendere “ogni anno” la sua venuta, foriera di speranze poi sem-pre deluse: se per un estremo pudore egli non dice nulla d’esplicito, l’interpretazione restacomunque agevole.26 M. Moretti, Domenica, in Poesie scritte col lapis, vv. 29-32.27 S. Corazzini, L’attesa.28 G. Gozzano, I colloqui [I], in I colloqui, v. 23.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 149
incontro all’ombra: mi fascia già gli occhi, e non sono vissuto.E sono ancora un fanciullo! E l’anima ha ancora da aprirsi, e tutto è qui chiuso l’ardore puro, lo spasimo di tenerezza, e non uno dei miei sogni ho raggiunto!29
Tuttavia il caso di Gozzano è molto più complesso, perché termina nellacontrapposizione già pirandelliana30 tra “vivere” e “vedersi vivere”, chemanca affatto nel giovane Thovez:31 per lui resta sempre centrale il pro-blema dell’amore, del grande amore sognato nell’adolescenza, ingenuo equasi estraneo alla passione erotica. Nel poema, a seconda degli stati d’a-nimo, egli esalta o ripudia questa suo antico orgoglio di serbarsi «puro eleale»;32 ma alla fine respinge sempre i facili piaceri:
Ho atteso in vano per anni: per tanto tempo ho sdegnato di prosternare il mio sogno alla bassezza del mondo,misero, solo, ho vissuto superbo del mio deserto [...] è troppo tardi, perché nel folle errore ho profuso tesori di tenerezza in struggimenti, in inutili spasimi, perché son vecchio; e il tempo non torna più.33
Questo lo avvicina ancora una volta ad Emilio Praga che in Libreria, dopola confessione d’aver anch’egli «libato al calice / dei godimenti umani» escla-ma «O maledetta, inutile / se tutta è qui la vita!».34 E a ben vedere neppureStecchetti,gaio cantor dei teneri peccati,aspirava al solo appagamento dellavoluttà,quando scriveva versi come questi: «Io mi volea l’amore / non la lus-suria al fianco, / io ci volevo un core / sotto al tuo seno bianco».35
Sorprende allora un poco vedere come – sia pur in un solo passo – Thovezaccusi proprio l’amore del suo repentino invecchiarsi; ma non si tratta, inquesto caso, di un effetto degli stravizi, bensì del dolore per esser stato
150 I saggi
29 E.Thovez, Nel bosco, in Il poema dell’adolescenza, vv. 1-5. Cfr. anche Rimembranze, vv. 1-5: «Come fu austera la nostra adolescenza! Trascorse / arida e grave, deserta di tenerezza e digioia, / in un oblio solitario.Trascorse tutta in attesa di un puro bene lontano, di un premiodegno del nostro / santo fervore di vita; perennamente delusa».30 La sua più celebre formulazione si legge nella novella La carriola, data alle stampe nel1929; tuttavia la tematica del “vedersi vivere” era già presente nel primo dei Dialoghi tra ilGran Me ed il piccolo me, pubblicato in rivista già nel 1895: Pirandello precede pertantoGuido Gozzano, che scriveva attorno al 1910.31 È però notevole vedere come egli annoveri tra le cause del suo precoce sfiorire il fattostesso d’essere poeta (e forse in questo potrà cogliersi il segno di quel ricorrente rifiuto dellapoesia e del nome stesso di poeta, comune a tanti crepuscolari): «Veniva stretta al mio fian-co, a testa china, tacendo. / Vedevo i piccoli piedi vicini ai miei sulla neve. / Mormorò piano:vorrei essere anch’io poeta. - / Oh, non dir questo, le dissi, non sai che cosa vuol dire: / nonsai che angoscie, che febbre, e come accorcia la vita!» (Colloqui, in Il poema dell’adole-scenza, vv. 23-26, corsivo mio).32 E.Thovez, Sulla neve, in Il poema dell’adolescenza, v. 18. Cfr. anche L’autunno, vv. 15-16.33 Id., Nell’ombra, in Il poema dell’adolescenza, vv. 8-10 e 18-20. Cfr. anche Aneliti e L’erro-re: «Fu così grande l’errore! Fu così dolce respingere / ogni lusinga non degna, serbarsi intat-ti all’atteso / austero sogno!» (vv. 9-11).34 E. Praga, Libreria, in Tavolozza, vv. 108-109 e 122-123.35 L. Stecchetti, T’ho fatto il precettore, in Postuma, vv. 5-8.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 150
lasciato, che lo ha reso (ancora una volta) «un vecchio inutile e vile».36
Se il Thovez, nato nel 1869, si sentiva già vecchio a neppur vent’anni, unaltro poeta ben più illustre di lui aveva detto lo stesso, ma per la ragioneopposta.Gabriele D’Annunzio,nel primo di due sonetti apparsi sulla «Cro-naca Bizantina» del 1° Maggio 1883 così spiegava la ragione del suo pre-coce deperimento:
Non più dentro le grige iridi smortelampo di giovinezza or mi sorride.La giovinezza mia barbara e fortein braccio de le femmine si uccide.37
D’Annunzio, insomma,al contrario degli altri non aspettò molto;ma invec-chiò prima: al di là di quanto veridico sia l’autobiografismo dannunziano,torna a delinearsi, in questo parallelo tra due poeti ventenni, l’antitesi trainvecchiamento fisico ed invecchiamento spirituale, che s’era già intravi-sta con Gozzano e Praga.Tuttavia, in questo percorso che va dalla scapigliatura al crepuscolarismo,D’Annunzio dev’essere menzionato per un testo ben più noto, compresonel Poema paradisiaco (opera il cui influsso sulla poesia crepuscolare èrisaputo): O Giovinezza! Composto nel 1890, nell’architettura del Poemavenne poi collocato nell’Epilogo, ancora una volta per il valore di bilancioche assume la riflessione sullo scorrere del tempo:
O Giovinezza, ahi me, la tua coronasu la mia fronte già quasi è sfiorita.Premere sento il peso de la vita,che fu sì lieve, su la fronte prona.
Ma l’anima nel cor si fa più buona,come il frutto maturo. Umile e ardita,sa piegarsi e resistere; ferita,non geme; assai comprende, assai perdona.
Dileguano le tue brevi ultime auroreo Giovinezza; tacciono le rivepoi che il tonante vortice dispare.Odo altro suono, vedo altro bagliore.Vedo in occhi fraterni ardere vivelacrime, odo fraterni petti ansare.38
Anche questo sonetto come l’altro scritto a vent’anni sembra avere un’ori-gine tutta letteraria, forse derivata da modelli francesi; ma se l’immagine
151Ivan Rivalta
36 E.Thovez, Amici [II], in Il poema dell’adolescenza, v. 3. Cfr. anche Miseria, v. 6.37 G. D’Annunzio, Sed non satiatus, in Intermezzo, vv. 1-4.38 Id., O Giovinezza!, in Poema paradisiaco.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 151
della corona ed il tema della bontà trovano riscontro nel Journal intime diFrédéric Amiel, l’apostrofe alla giovinezza avrebbe un immediato prece-dente nei versi del Praga A Vittor Hugo: «O giovinezza che già muti nome,/ una pura armonia spirami ancora, / un inno alato!»39 Del resto D’Annun-zio stesso,nel primo capitolo del libro secondo del Piacere, trattando delloSperelli poeta, scrive che «quasi sempre, per cominciare a comporre, egliaveva bisogno d’un’intonazione musicale datagli da un altro poeta».Va detto, inoltre, che della propria giovinezza sfiorita s’era già rammarica-to anche lo Stecchetti:
Amico mio, se il fato in me riposeQualche forza d’ingegno, or m’ è fuggita;La giovinezza mia giace sfiorita,Giace e visse un mattin come le rose.40
Alla luce di questi versi il sonetto dannunziano sembra quasi una risposta:Stecchetti, nella sua simulata disperazione,41 si sentiva ormai privo d’ogni«forza d’ingegno»;mentre D’Annunzio già dalla seconda quartina si riscuo-te, «sa piegarsi e resistere», come dice della propria anima. Certo nonbastano questi pochi elementi per stabilire una derivazione diretta, néD’Annunzio pare il tipo da voler alludere ad autori come Praga e Stec-chetti. Comunque sia, più che per i possibili modelli, O Giovinezza! sisegnala per il costante influsso esercitato sui poeti crepuscolari.Cominciamo allora da Giulio Gianelli, che in due distinte liriche, com-piangendo la fine della giovinezza, mostrò di ricordarsi le parole del Vate.La prima fu pubblicata in rivista nel 1907, all’età di ventisette anni, quantine aveva D’Annunzio ai tempi del sonetto incriminato:
O giovinezza, spirito giocondo,ch’oggi ti sfiori nel dolor del mondo,dalla viltà che stagna,d’una scossa ti svincola, guadagna il culmine ch’è tuo, e colà, dea solitaria, dissolviti ma crea.42
Si nota anche in Gianelli l’apostrofe iniziale alla giovinezza, l’uso del verbosfiorire in riferimento ad essa e, quel che più conta, l’esortazione a “svin-colarsi”ed a “creare”, in cui emergono di nuovo – come di riflesso – i versi
152 I saggi
39 E. Praga, A Vittor Hugo, in Penombre, vv. 5-7.40 L. Stecchetti, A Raffaele Belluzzi, in Postuma, vv. 5-8.41 È abbastanza noto il giudizio che dello Stecchetti e della sua credibilità di malato diedeGozzano (che malato era veramente) in una lettera a Giulio De Frenzi del 28 Giugno 1907(cfr. G. Gozzano, Poesie e Prose, Milano, Garzanti, 1961, p. 1254).42 G. Gianelli, Carità, in Poesie, vv. 1-6. Di questo stesso concetto troviamo qualche velatoaccenno anche in Pascoli, nell’esortazione rivolta ad una giovane: «Prega! Pregate che sfiori-sca il fiore, / che il bello passi ma che lasci il buono» (I filugelli, in Nuovi poemetti, I VIII 6-7).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 152
del Praga A Vittor Hugo, dove il poeta chiedeva alla giovinezza d’ispirargliancora «una pura armonia [...], / un inno alato»43 (anche se là quello cheviene chiesto non appare come il frutto d’una maturazione, bensì comeuna capacità propria degli anni giovanili, che minaccia di venir meno col-l’andar del tempo: qualcosa da recuperare dal passato, anziché da conse-guire nel futuro).Anche l’immagine della “corona di giovinezza” viene puntualmente ripre-sa da Gianelli, tramutata però in un serto di spine (e le spine altro nonsono che le precoci rughe del poeta):
Questa ruga, che tristezza!questa mia precoce ruga!Pare un segno di confine,giovinezza! Par l’aculeo d’un serto che s’annunzia, di spine.44
Anche i poeti che del sonetto dannunziano non mostrano puntuali remi-niscenze compiangono la fine della giovinezza partendo sempre da un’a-postrofe. Carlo Vallini pubblicò nel 1907, a ventidue anni, il poemetto Ungiorno; e proprio nella sesta sezione (intitolata L’amore) si leggono que-ste parole, che il poeta rivolge a una donna:
O donna, la mia giovinezza è forse un tramonto: ogni giorno,qualcosa non fa più ritorno,qualche idolo nuovo si spezza,Non si spezza, no: si dissolve col tempo, non si sa come:non ne rimane che il nomee un po’ di misera polvere.Il tempo sgretola, annulla regolarmente entro mequello che trova, finchénon ne rimanga più nulla.45
Ancor più precoce di lui, Nino Oxilia pubblicò nei Canti brevi del 1909un sonetto in cui lamenta l’aridità poetica (e non sentimentale) dei suoiventun anni, rivolgendosi prima al suo passato, poi alla madre:
Addio, passato, sogni, tenerezza! nulla di voi mi resta. In labirinto me ne vo senza voi. Dal fato spinto non cerco più la via della saggezza.
153Ivan Rivalta
43 E. Praga, A Vittor Hugo, in Penombre, vv. 6-7.44 G. Gianelli, Stigmate, in Poesie, p. 120, vv. 1-6.45 C.Vallini, Un giorno,Torino, Einaudi, 1967, p. 84.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 153
Chi cantò in me ora tace, forse estinto per sempre. Io non ò più la giovinezza,Non ò più nulla fuorché la certezza che non avrò mai nulla.Amen. Son vinto.
O mamma, non mi giova aver vissuto,o mamma, non mi giova aver soffertoe neppure mi giova ora morire
se pure l’estro mio s’è fatto muto,se quello che pensai non lo so dire,se il mio cuore s’è fatto già deserto.46
Carlo Chiaves, torinese come Gianelli,Vallini ed Oxilia, nel Richiamo pub-blicato a venticinque anni in Sogno e ironia verseggia addirittura il pro-prio dialogo colla giovinezza morente, cui si rivolge come si sarebbe rivol-to ad un’amante: davvero un’amante «che s’apprezza / solo nell’ora tristedel congedo», per dirla con Gozzano (che forse da questi versi trasse lanota immagine dei Colloqui, dati alle stampe l’anno seguente):
La gioventù declina: pure, arrivata a l’estremopasso, si volge e dice: — Oh! non lasciarmi morire!tendimi ancora la mano, ch’io possa teco venire!vedrai quant’altra strada insieme percorreremo! —
Chiama con voce lenta, con voce triste, profonda,prega con fissi gli occhi e con le mani protese:Io penso: «Quale amante, quale altra un giorno mi chiesemercé con simil voce, che vela l’oblio e circonda?
— Mia gioventù — rispondo — non fosti buona e non sei;non è dunque ventura che tu per sempre scompaia?forse con altra luce sarà la vita più gaia,forse: per quale insano amore ti richiamerei?».Tacqui: ed a poco a poco reclinò il capo, smarrita,ella, e s’avviò piangendo verso la soglia fatale.Allora, dentro al cuore, mi sorse un terribile male,una tristezza immensa, più vasta di tutta la vita.
Pensai: «Dunque più fosca sarà la vita domani? più incerto ancora il fato che mi sovrasta e minaccia?».Ell’era su la soglia, ed io le tesi le braccia,io la chiamai tremando: «Mia giovinezza, rimani!».Pronta tornommi a canto. «Tu dunque ancora mi vuoi?».
154 I saggi
46 N. Oxilia, Addio, passato, sogni, tenerezza!, in Canti brevi. Nino Oxilia fu anche autore,con Sandro Camasio, della celebre commedia Addio giovinezza!, dove però la giovinezza èquella dei laureandi che al termine degli studi si accingono, loro malgrado, ad integrarsi nellasocietà borghese.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 154
«Sì! sì! ti voglio, intendi? Oh! non lasciamoci ancora!Meglio il tuo lume torbo, lo sguardo che mi addolora,ma ch’io conosco bene. Rimani ancora, se puoi!
Fin che potrai! poi, quando l’ora verrà, che a le porte il mio destin mi tragga, senza mercé di ritorno,fuggi, ma ch’io non senta, ch’io non lo sappia, e d’attornoal cor duri il bagliore dei sogni, fino a la morte!».47
Ultimo in ordine di tempo a riprendere O Giovinezza! – e a riprenderladirettamente, fino a citarne i primi due versi – fu Marino Moretti con Lacorona di giovinezza. La poesia si legge nella raccolta Diario senza ledate, comprensiva di versi scritti dal 1926 in avanti ma pubblicati soloquarant’anni dopo, nel volume mondadoriano di Tutte le poesie:
È Gabriele, è sempre lui che invitacon la vocetta sua che non perdona.O Giovinezza, ahimè, la tua coronasu la mia fronte è già quasi sfiorita.
Non doveva sfiorire anche la mia,fiori, fronde, poesiae sfiorir presto?Ma alcunché di domestico e fedelerestava in me, non più di Gabriele.se oggi torno giovane e m’arrestoin mezzo a tante tante cose care.Ma com’è bello poetare!Come son nato per questo!48
Dopo tanti giovani che per cause anche molto diverse si sentivano già vec-chi, ecco un uomo di mezza età che dice di tornar giovane, che sembraanzi stupirsi di come proprio non siano sfiorite assieme la sua giovinezzae la sua poesia. Senza volerne discutere, ora, il valore artistico, nei versi diMoretti vediamo come la fede nell’arte potesse redimere questa genera-zione di sfiduciati; o, se non proprio la fede nell’arte, più in generale lafede nelle proprie azioni, perché dalla fede nelle proprie azioni risorgevala fede nella vita e nella stessa giovinezza.Fu questo il caso di Vallini e di Oxilia, entrambi volontari nella GrandeGuerra, entrambi Ufficiali ed entrambi decorati al Valor Militare. Della lororitrovata fierezza abbiamo testimonianza nelle poesie composte al fronte:del primo ricordiamo l’ode Per un’altezza; del secondo, che era stato –come s’è visto – uno dei più precoci lamentatori della giovinezza finita,
155Ivan Rivalta
47 C.Chiaves,Richiamo, in Sogno e ironia.Considerazioni analoghe si riscontrano anche neiversi Ad un compagno di scuola.48 M. Moretti, La corona di giovinezza, in Diario senza le date.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 155
abbiamo una vera e propria palinodia di quel suo poco virile lamento:
Mentre si fonde in armonia squisitala grazia di tutta la natura,e in ogni cosa stelo creaturasi risveglia lo spirito di vita,
giovinezza che a me parve finitaappena posseduta, dall’oscurameditazione ecco si leva pura,del suo male inguaribile guarita49
Egli che aveva scritto «Non mi giova aver vissuto / o mamma, non mi giovaaver sofferto / e neppure mi giova ora morire»50 più avanti,nello stesso com-ponimento, afferma che «Vivere giova tra padre e fratelli. / La vita è buona achi la morte veda».51 Questi versi sembrano anche contrapporsi a due cele-bri emistichi di Gozzano: quello in cui si domanda «Giova che si viva?»52 equello dove si afferma che «Buona è la morte».53 Del resto, l’intera poesia diOxilia si chiude dichiarando «l’infinita / felicità d’esistere nel mondo!».54
Anche Gozzano, a suo modo, scrisse una “palinodia” dopo lo scoppio dellaguerra: certo egli, già minato dalla tisi, non avrebbe potuto neppur volendoprendervi parte;purtuttavia nell’agosto del 1915 sentiva bene che «nessunasorte è triste / in questi giorni rossi di battaglia: / fuorché la sorte di coluiche assiste...».55 Sentimento sincero e ben comprensibile da parte di chi,solo pochi anni prima,si doleva «d’essere nato troppo tardi» ed avrebbe pre-ferito «vivere al tempo sacro del risveglio, / che al tempo nostro mite e son-nolento!»:56 una dichiarazione in cui – scriveva Sanguineti – «pare ricono-scersi, in qualche modo, il lamento di un’intiera generazione di poeti».57
Gozzano, che non poteva vivere in sé questa metamorfosi, la fece vivere alprotagonista di alcune sue novelle,Tito Vinadio:
Aveva trent’anni e la solitudine non gli pesava.Aveva perduta la madre diecianni prima; ed era rimasto solo, senza parenti, non ricchissimo, ma agiatoabbastanza per l’ozio indipendente; un poco artista e sognatore, abbastanzaintelligente per godere della vita senza annoiarsi mai; morta la madre avevalasciato la città di provincia, si era stabilito a Genova, poi a Roma, a Napoli;poi a Genova ancora.Aveva viaggiato molto, si era molto divertito, ma sem-pre con il senso della giusta misura, da buon epicureo un poco scettico che
156 I saggi
49 N. Oxilia, Secondo intermezzo, in Gli orti, vv. 7-14.50 Id., Addio, passato, sogni, tenerezza!, in Canti brevi, vv. 9-11.51 Id., Secondo intermezzo, in Gli orti, vv. 58-59.52 G. Gozzano, La signorina Felicita, in I colloqui, v. 366.53 Id., L’analfabeta, in La via del rifugio, v. 155.54 N. Oxilia, Secondo intermezzo, in Gli orti, vv. 69-70.55 G. Gozzano, La bella preda, in Poesie sparse, vv. 54-56.56 Id., Torino, in I colloqui, vv. 39-42.57 E. Sanguineti, Guido Gozzano. Indagini e letture,Torino, Einaudi, 19661 (19754), p. 16.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 156
sapeva godere d’un eguale piacere nel palpare una stoffa per un suo vestitoe nel leggere un bel libro, nel sedersi a mensa e nel sedere a teatro, nel fareun viaggio e nel ghermire una donna. E dieci anni erano passati così, tutta lagiovinezza prima, senza una nube, immune da passioni profonde, salva daagguati di giuste nozze.Tito Vinadio sapeva che nulla al mondo vale la liber-tà materiale e morale, la coscienza intatta nel corpo sano; ed equilibrava lasua vita sulla teoria del massimo piacere col minimo sforzo. Era un buonragazzo, figlio del suo tempo, senza ideali e senza mète.58
Tito Vinadio, per quanto venga descritto come un «buon epicureo un pocoscettico», presenta più d’una somiglianza con Totò Merumeni, caratterizzatoda «tempra sdegnosa, / molta cultura e gusto in opere d’inchiostro, / scarsocervello,scarsa morale,spaventosa / chiaroveggenza»:aspetti che fanno di lui«il vero figlio del tempo nostro»,59 proprio come vien detto di Tito Vinadio.Il suo arruolamento stupisce dunque una zia «di molto riguardo»,verso cuiil nipote sente il dovere d’una spiegazione:
– Ma! chi l’avrebbe detto? come ti sei deciso? È incredibile, col tuo caratte-re! L’ultima volta, un anno fa, eri qui al principio della guerra europea e ciscandalizzavi con la tua indifferenza... dicevi d’essere un...– Un internazionalista, un cittadino della Terra, ricordo, zia, ed oggi sonovolontario.– Tito volontario.Avrei creduto qualunque cosa,che tu prendessi moglie,cheti facessi frate...– Dici bene, zia. Si è convertiti alla patria come si è convertiti all’amore o allafede... È una cosa che non si può dire, una evoluzione interiore che nonavvertiamo che a trasformazione completa. Non si crede in nulla, non sisente nulla. E un bel giorno si crede e si sente. È giunta l’ora.Alcuni trovanoin fondo al loro scetticismo la donna, altri Dio, altri l’arte, altri il guadagno,infiniti ideali opposti per sopportare la vita fino alla morte. Io ho trovato laPatria, una cosa come un’altra alla quale voler bene.60
Questa è forse la miglior conferma di quanto scriveva Umberto Bosco,secondo il cui giudizio la generazione di Gozzano non aveva «nulla in cuicredere;eppure un disperato bisogno di credere».61 Anche altri autori, checrepuscolari non erano, trovarono in fondo al proprio scetticismo uno diquegli opposti ideali elencati da Tito Vinadio.Si prenda Saba, ad esempio, che fu anche accostato – suo malgrado – al
157Ivan Rivalta
58 G. Gozzano, Un addio, in I sandali della diva.Tutte le novelle, Milano, Serra e Riva, 1983,p. 287. In una precedente novella si leggeva invece questa riflessione: «A trent’anni si ricor-dano i venti con lo strazio della giovinezza che non si rassegna a morire.E forse in nessun’etàdella vita è tanto triste volgersi indietro» (L’eredità del volontario, in I sandali della diva.Tutte le novelle, Milano, Serra e Riva, 1983, p. 269).59 Id., Totò Merumeni, in I colloqui, vv. 17-20.60 Id., Un addio, in I sandali della diva.Tutte le novelle, cit., p. 291.61 U. Bosco, Dal Carducci ai crepuscolari, in Realismo romantico, Caltanissetta-Roma, Scia-scia, 1959, p. 214.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 157
crepuscolarismo; si prenda una delle sue liriche più famose, A miamoglie, risalente agli anni 1909-1910, e se ne legga la penultima strofa:
Tu sei come la rondineChe torna in primavera.Ma in autunno riparte;e tu non hai quest’arte.Tu questo hai della rondine:le movenze leggere;e questo che a me, che mi sentiva ed eravecchio, annunciavi un’altra primavera.62
Sapendo che il poeta si sposò a venticinque anni, ne ricaviamo che a quel-l’età anch’egli si sentiva già vecchio, fintantoché l’amore per la sua donnanon gli annunciò «un’altra primavera».63
Risalente a quello stesso periodo,ma ben diverso, il caso di Papini,giacchéper lui il problema dell’amore fu del tutto marginale e quasi inavvertito.64
Egli aveva trentun anni quando pubblicò Un uomo finito: titolo ed operasono autobiografici;ma è noto come l’autore,negli ultimi due capitoli,vogliapoi smentirlo: «Il titolo di questo libro è sbagliato:poco male.Qui dentro c’èun uomo ch’è disposto a vender cara la sua pelle e che vuol finire più tardiche sia possibile».65 Cionondimeno, in tutte le pagine precedenti è diffusal’ansia per l’avanzare dell’età: l’autore afferma d’essere giunto «a metà dellavita probabile, dopo parecchie prove e una lunga quarantena di solitudi-ni»;66 ed un intero capitolo, La fine del corpo, è dedicato alla preoccupataanalisi della propria decadenza fisica, in particolare all’indebolimento dellavista,col presagio della cecità che da vecchio lo avrebbe effettivamente col-pito. Giunge perfino – proprio lui! – a definirsi «un povero poeta sentimen-tale».67 Altrove giudica «non più giovani» gli uomini di trenta e quarant’annidi fronte ai «veri giovani», ai «freschi giovani» di vent’anni;68 e rimpiange losfuggire della propria giovinezza.69 Teme una misera fine, eppure lo riscuo-tono da questo timore la consapevolezza di avere un’opera da compiere ela volontà di lasciare il proprio segno:
Ma prima di arrivare a codesta fine voglio empire di fiato tutte le trombe del-l’universo ed eseguire tutti i mandati e compiere tutte le mie vendette elasciare scritte ed incise le mie parole e le mie volontà. Ho appena princi-
158 I saggi
62 U. Saba, A mia moglie, in Il Canzoniere, vv. 73-76.63 Un’altra riflessione sulla giovinezza si legge nei versi della Serena disperazione, scritti trail 1913 ed il 1915, dove la «prima giovanezza» viene definita come l’età «che poco fa, che atutto fare aspira», affermando ancora una volta lo squilibrio fra le semplici aspirazioni e leopere compiute (Dopo la giovanezza. La vista d’una palma giovanetta, v. 13).64 Cfr. G. Papini, Un uomo finito, Firenze,Vallecchi, 1956, p. 151.65 Ivi, p. 325.66 Ivi, p. 310.67 Ivi, p. 145.68 Ivi, p. 103.68 Ivi, pp. 215 e 220.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 158
piato. Il bambino nasce a nove mesi ma l’uomo comincia a trent’anni. Ilfiore è fiorito ma il frutto ha da maturare, avanti di marcire.70
Tanta sicurezza ben dimostra come l’aver trovata una fede,sia essa nei desti-ni della Patria (Oxilia,Vallini) o nell’amore per una donna (Saba) o nella pro-pria missione d’artista e d’intellettuale (Moretti, Papini), potesse finalmenteaffrancare da quello strato di prostrazione, da quella «malattia della volontà»così comune – come s’è visto – nei giovani del primo Novecento.71
In una più serena visione della vita anche i termini della giovinezza sem-brano allora dilatarsi e andar ben oltre i venti o venticinque anni prescrit-ti da tanti poeti, fino ai quaranta almeno.L’elogio della quarantina è – strano a dirsi – un altro piccolo topos crepu-scolare. Un primo accenno, riferito alla bellezza femminile, si può coglie-re nello stesso Gozzano di Un’altra risorta: il poeta, raggiunto per via dauna donna che da molto non rivedeva, ma alla quale un tempo dovetteessere legato, osserva che «La quarantina la faceva bella, / diversamentebella»72 (e qualche bella quarantenne s’incontra anche nelle sue prose:basti citare Il bel segugio).Ma il vero elogio della quarantina si trova in autori come Moretti, chequando scrisse Contento di me sembrava già proiettarsi tranquillamenteverso i novanta e passa anni da lui vissuti:
Il buon umore è cosadi felicità estrema.Dirò su questo temaciò che non dissi in prosa.
Io son quasi contentodi me questa mattina.Lodo la quarantinache fuga ogni tormento.
Le piccole virtùsciamano nei traslochi.Quarant’anni son pochi,c’è chi ne ha di più.
159Ivan Rivalta
70 Ivi, p. 322 (corsivo mio). Cfr. anche pp. 323-324.71 S’è preferito circoscrivere l’indagine ad un periodo ben definito; la propensione a compian-gere anzi tempo la fine della giovinezza era comunque diffusa anche prima, specie in pienoRomanticismo, come attesta quella satira del Giusti intitolata Il giovinetto. Personalmente ilGiusti collocava il limite della giovinezza verso il «mezzo del cammin di nostra vita» come sidesume dal sonetto I trentacinque anni e da una lettera alla marchesa D’Azeglio (G. Giusti,Epistolario, Firenze, Le Monnier, 1932-1956, vol. II, p. 332).Attorno a quell’età sembrano poiconcordare anche Svevo e Pirandello, se possiamo interpretare in chiave autobiografica (e ledate di composizione lo consentono) rispettivamente l’incipit di Senilità (un bilancio dei tren-tacinque anni di Emilio Brentani) e la prima pagina della novella Prudenza, che si legge tra iRacconti aggiunti di Novelle per un anno (Milano, Mondadori, 19624, vol. II, p. 1055).72 G. Gozzano, Un’altra risorta, in I colloqui, vv. 40-41.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 159
Siamo abbastanza scaltrinoi senza macchia d’orge;e infine ci s’accorgeche son bravi anche gli altri.
Le piccole virtùspengon gli ultimi fuochi.Cinquant’anni son pochi,C’è chi ne ha di più.
Qui viviamo, si sa,come l’uso c’insegna,bene o male, all’insegnadell’insincerità.
Le piccole virtùmirano ai coprifuochi.Sessant’anni son pochi,c’è chi ne ha di più.
Or decido ne’ mieianni forse più ingratid’immaginare gratis,per amor degli dei;
e comunque non c’èaltra via per l’artista;io son quasi ottimistaoggi, non so perché.
Le piccole virtùnon ci fanno più fiochi.Settant’anni son pochi,c’è chi ne ha di più.
(...e ottanta anche son pochi,c’è chi ne ha di più, molti di più...)
Il buon umore è cosadi felicità estrema.Qualche volta lo frenacolui che si riposa.73
Ancor più convinte appaiono le parole di Moretti se davvero, come sidirebbe, vogliono polemicamente alludere a due distinti modelli: I collo-qui di Gozzano e Il corvo di Arturo Graf. Nel primo il poeta, rammarica-tosi d’aver già venticinque anni,paventava nell’ordine «la trentina / inquie-
160 I saggi
73 M. Moretti, Contento di me, in Diario senza le date (corsivi dell’Autore).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 160
tante», «la quarantina / spaventosa» e, subito dopo, «l’orrida vecchiezza»;74
mentre nel secondo, rivolgendosi al corvo del titolo, si riflette sulla longe-vità della sua specie:
Ho udito dir che i tuoi pariCampano cento e più anni:Per centomila malanni!Io non v’invidio, miei cari.
Io non v’invidio, davvero.Quel brutto numero centoMi fa tremar di spavento:Avrei più caro un bel zero.
Cento son troppi, compare,Comunque l’uom la rattoppi:Cento son troppi, son troppi,E la metà può bastare.
E può bastare anche il quarto,Oppure il terzo.A che scopo,Di’, rimanersene dopoCome una merce di scarto?75
Un altro elogio della quarantina si legge nella Lanterna di Diogene diAlfredo Panzini, autore che, ancor vivente, fu definito poeta crepuscolarein prosa.76 Descrivendo la partenza di quel celebre viaggio che lo avreb-be portato, in bicicletta, da Milano a Bellaria, egli si compiace di ritrovarsi,non senza sua sorpresa, ancor giovane in corpo ed in spirito sulla sogliadei quarant’anni:
Molto più fortunata di me, la bicicletta aveva trovato un meccanico chefermò qualche vite, rinnovò i pneumatici, e lubrificò i congegni. Per noi,
161Ivan Rivalta
74 G. Gozzano, I colloqui [I], in I colloqui, vv. 10-15.75 A. Graf, Il corvo, in Le rime della selva. Canzoniere minimo, semitragico e quasi postu-mo, vv. 25-44 (corsivi miei). L’iterata affermazione «cento son troppi» avrà suggerito il ritor-nello di Moretti, per il quale invece «son pochi» sia quarant’anni che cinquanta, sessanta ecosì via. Che il poeta di Cesenatico conoscesse i versi del Graf lo provano alcune citazionivere e proprie tratte dalle Rime della selva e contenute nel Diario senza date (da Al musco-lo incontentabile in Perché picchi?; da Al novo giorno nel Mattino e da Parole d’artista inNoi di dopo).Tali citazioni sono frutto di una lettura “tardiva”di quell’opera, come avverte lostesso Moretti in una nota all’edizione mondadoriana di Tutte le poesie.76 «Può il Panzini, anzi, classificarsi l’anti-D’Annunzio per la linearità dell’arte sua, per la castaesilità della dizione, per il suo spirito provinciale. La sua prosa tardò ad affermarsi appuntoper la singolarità dolorosamente e ingenuamente introspettiva dello scrittore, per il deside-rio lancinante di guardarsi allo specchio, di essere estimatore di piccole, viete, dolci cosefamiliari, le “buone cose di pessimo gusto” dello spirito, spesso così inutili, che egli però haavuto il merito di renderci interessanti. Da questo punto di vista,Alfredo Panzini rientra fra icrepuscolari: è il poeta crepuscolare in prosa» (G. Mormino, Alfredo Panzini, Milano, Mon-dadori, 1930, p. 72; corsivo mio).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 161
creature di Dio,non esistono pezzi di ricambio. I pneumatici una volta invec-chiati, tali rimangono, né il mercante vende olio per lubrificare le ossa indu-rite. Noi, sventuratamente, abbiamo l’età dei nostri pneumatici, cioè dellenostre arterie, e non c’è laboratorio che le rinnovi.Ciò è molto sconfortante: vale tuttavia a spiegare un’altra causa della miacontentezza quando mi accorsi che il pedale rispondeva bene all’impulso,che le case andavano indietro e la verdura della campagna veniva avanti. [...]Quando, finalmente, l’incubo delle case disparve, disparve la gente densa, evidi (oh, meraviglia, come di oasi al navigante del deserto!) le alte siepi diacacie coi bianchi grappoli odorosi,e sentii le acque mormoranti per il verdepiano lombardo, una freschezza forte e giovane mi alitò nel cuore. E mi rifio-rì nella memoria il ricordo della gioia che inebriava i miei quindici anniquando pur di luglio, nelle vacanze, lasciavo quel regio domicilio coatto chefu per me il collegio.La differenza tra allora ed ora era tutt’al più questa,che allora il mondo,mate-riale prendeva stupende proporzioni eroiche; i malfattori abitavano quasitutti in carcere; e mi pareva impossibile che un uomo, fornito di grave aspet-to e di rispettabile barba, non avesse dovuto avere dentro anche un’intelaia-tura di ferro, come gli eroi di Gualtiero Scott, il mio autore preferito.Più tardi mi venni persuadendo che in commercio è più usato il cartonedipinto. Me ne accorsi un poco per volta, eppure anche ora me ne duole.
*Dunque mi congratulai con me stesso di avere conservato in su la soglia deiquarant’anni alcune facoltà illusorie della adolescenza, per le quali il mondoappare molto giovane e ridente.Si,è molto bene conservare nel lago del cuore una goccia d’acqua non inqui-nata, un po’ di infantile freschezza di spirito per cui si assaporano le umiliingenue cose, nel modo medesimo che uno stomaco sano fa trovare sapori-te le rusticane vivande.Io perciò sentivo in quel principio del viaggio il caro fiore della giovinezzaolezzare ancora sul mio dispregio del mondo,come un cespo di viole a cioc-che sparge la sua chioma odorosa sopra un cumulo di miserande ruine.77
Panzini,nato nel 1863,era coetaneo del D’Annunzio;ma oltre alla classe nien-t’altro sembra accomunarli.Anche l’atteggiamento del Vate verso la quaranti-na è del tutto differente.Egli,che s’era detto vecchio a vent’anni per scherzoe a ventisette anni per letteratura, a quarant’anni, nel giorno esatto del com-pleanno celebrò sul serio, in una sua favilla, le Esequie della giovinezza:
Bisogna dunque che io imbalsami alfine il cadavere della giovinezza, chefasciato di bende io lo chiuda tra quattro assi e ch’io lo faccia passare perquella porta, ove lo spettro della vecchiaia è apparso tra i battenti socchiusie con un cenno quasi familiare m’ha augurato il buon giorno. È apparso escomparso. Nulla sembra mutato, in me, fuori di me. Non sento alcuna dimi-nuzione vitale, se spio le mie arterie i miei muscoli i miei polmoni il mio cer-
162 I saggi
77 A. Panzini, La lanterna di Diogene, in Sei romanzi fra due secoli, Milano, Mondadori,19548, pp. 10-12.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 162
vello.Tuttavia so che lo spettro abominevole è ora nascosto in qualche ango-lo della casa, dentro un di quegli armadi tarlati, dietro quel mucchio di car-tapecore, forse tra quell’oriuolo da polvere e quel cero lacrimoso, nell’om-bra perfida. È il nuovo ospite. Scacciarlo non potrò; ma domani forse lodimenticherò vestendomi di quell’acciaio che ogni mattina suol fabbricarmiil mio coraggio; ché ogni mattina, come Alfonso di Ferrara, ei fabbrica «unbonissimo acciaio».Ma stamani m’ha abbandonato. È la peggiore delle tristezze per un combat-tente. L’ho provata due o tre volte nella vita; e, se la preghiera mi giovasse e seio fossi per pregare il mio dio,non gli domanderei se non di risparmiarmela.78
E lo scritto prosegue più che nel rimpianto della giovinezza passata, nelpensiero costante della morte; come se fosse proprio “l’altra meta” (perdirla con Gozzano) ad inquietar D’Annunzio.Ma non vorrei terminare con una nota così lugubre: preferisco porre qui,a conclusione, il più bell’elogio della quarantina che io conosca, scritto daLuigi Orsini. Egli non fu precisamente un crepuscolare, ma era tra i piùcari amici del Panzini (altrimenti non poteva essere: entrambi romagnoli,entrambi poeti, entrambi allievi del Carducci79 ed entrambi insegnanti aMilano). Pertanto, dopo aver citato Panzini, non sarà fuori luogo citareanche «il suo amico poeta Gigino»:80
Quarant’anni. L’età più bella. Bisognerebbe dire al tempo: fermati lì. I ven-t’anni sono per lo più scipiti,perché privi di quel tanto d’interiorità che insa-pora la vita. L’esercizio fisico attrae e distrae verso forme di attività esterna.Non parliamo poi dell’amore.A quell’età non ci si pensa, o ci si pensa poco.Se si ha la morosa è perché bisogna averla, altrimenti non s’è uomini.Ma più si cammina con gli anni e più le cose mutano. I fiori prendono unaltro colore, le nuvole un’altra forma, l’amore un altro gusto. Gli occhi vedo-no più chiaro, il sentimento più fondo, il pensiero più lontano.E anche il palato ci ha la sua parte: buona cucina, buon sigaro, buona com-pagnia acquistano un’importanza sempre maggiore fra i piaceri terreni. Eanche un po’ di poesia, forse: che non fa male.81
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/5rivalta.htm.
163Ivan Rivalta
78 G. D’Annunzio, Esequie della giovinezza, in Faville del maglio (ora in Prose di ricerca,ecc., Milano, Mondadori, 1950, vol. II, p. 532).79 In verità Orsini fu allievo di Carducci come Gozzano sarebbe poi stato allievo di Graf:disertava le lezioni di giurisprudenza pur d’ascoltarne la parola.80 A. Panzini, Il viaggio di un povero letterato, in Sei romanzi fra due secoli, Milano, Mon-dadori, 19548, p. 147.81 L. Orsini, I tre sentimentali, in Itinerari Romagnoli, Milano, Editrice Albore, 1948, p. 95.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 163
Le funzioni della fisiognomica da Della Porta a LombrosoLucia Rodler
L’interesse per la fisiognomica nasce da una curiosità per così dire filosoficacirca il nesso tra corpo e anima, esteriorità e interiorità, che costituisce unodei processi di tematizzazione più complessi della cultura occidentale. Biso-gna anzitutto prestare attenzione alla teoria della percezione,così come sug-gerito tra gli altri da Rudolph Arnheim e Ernst Gombrich.1 Si comprende allo-ra che l’occhio non registra tutti i dati visivi,ma ne seleziona alcuni sulla basedi uno schema mentale che riconosce gli elementi più semplici (nel senso dimarcati, che risaltano con evidenza) e stabili (uno sbadiglio mi sfugge, unaserie di sbadigli no). Questo per un’esigenza di economia percettiva. La per-cezione infatti ha bisogno di organizzarsi subito in comprensione utile allasopravvivenza. Perciò ognuno interpreta i dati che ha selezionato partendoda sé: non per caso nelle Lezioni americane, alla voce Visibilità, Italo Calvi-no si diceva convinto che «la nostra immaginazione non può che essereantropomorfa».2 Ecco allora che la selezione operata dall’occhio sul corpo diuna persona che sta di fronte risponde al bisogno di attribuire un sensocoerente a ciò che circonda. E poiché difficilmente si accetta di avere sba-gliato,Gombrich ha parlato di un vero e proprio «pregiudizio fisiognomico».Con questa base teorica diviene possibile individuare una serie di funzio-ni che la fisiognomica ha svolto nel corso della sua storia plurisecolare eche rispondono al bisogno di economia e coerenza, nel senso di un domi-nio sulla complessità del reale che riporti l’ignoto al noto (è economicoche ogni fisionomia nuova venga ricondotta entro schemi precostituiti), el’invisibile al visibile (è coerente che ogni carattere-anima possa essereconosciuto attraverso i segni del corpo). Si cerca così in ogni modo di evi-tare lo spaesamento dinanzi al nuovo, reso inoffensivo attraverso una seriedi schemi di riconoscimento ben collaudati.Per illustrare quanto detto conviene fare riferimento al trattato che Giam-battista Della Porta ha edito nel 1586 e ampliato nel primo Seicento. Sitratta di un testo di letteratura comparata, anche per quanto riguarda laricezione europea dell’opera. Il titolo latino è De humana physiognomo-nia, quello italiano Della fisonomia dell’uomo.3 È un’opera di sintesi del
164 I saggi
12
1 Cfr. R.Arnheim, Il pensiero visivo. La percezione visiva come attività conoscitiva,Torino,Einaudi, 1974; E. H. Gombrich, A cavallo di un manico di scopa. Saggi di teoria dell’arte,Torino, Einaudi, 1971.2 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane,Torino, Einaudi, 2002, p. 101.3 Cfr. G. B. Della Porta, Della fisonomia dell’uomo, Parma, Guanda, 1988.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 164
pensiero classico-medievale sull’uomo, il suo aspetto fisico e il carattere,che comprende anche la chiromanzia e l’astrologia.Rispetto alle fonti,nonci sono elementi nuovi, se non una certa preoccupazione circa l’affidabi-lità della fisiognomica: se l’uomo finge – si chiede Della Porta che è ancheautore di testi teatrali – la fisiognomica è in grado di smascherarlo? Anchedi là dalla simulazione, per Della Porta resta vero che un carattere puòcambiare nel tempo, con l’età. Come Socrate del quale si diceva che avevasaputo modificare un temperamento predisposto al vizio (che corrispon-deva al suo aspetto fisico deforme) attraverso l’esercizio quotidiano dellavirtù. Non sempre perciò i belli sono buoni, e i brutti cattivi.Questi problemi (la finzione del comportamento, la trasformazione delcarattere) non incidono sul successo della fisiognomica che risponde a unbisogno innato di orientamento nel mondo, soddisfatto a mio avviso sottoquattro punti di vista che corrispondono alle quattro funzioni della fisio-gnomica aristotelico-dellaportiana:1. Chiamo la prima funzione previsionale o temporale, perché la letturadel corporeo utilizza le competenze della medicina prognostica e dell’a-strologia per dominare il tempo. Già i babilonesi, gli arabi e poi Pitagora eTolomeo cercavano di indovinare il futuro; Della Porta propone anchedelle terapie alchemiche e dunque scientifiche per sanare i difetti psicofi-sici, a garanzia di un futuro eticamente migliore.2. La seconda funzione è quella topografica o spaziale, perché la lettura delcorporeo tenta di connettere ordinatamente ogni presenza terrena entro ilsistema degli elementi-umori-temperamenti per semplificare la compren-sione del reale.Anche in questo caso Della Porta prende le mosse dal mondogreco,in cui la fisiognomica era legata alla medicina degli “umori”e dei “tem-peramenti”, nata con Ippocrate (un medico un poco più vecchio di Aristo-tele).È noto che la sistemazione della materia avvenne nel II secolo d.C.,gra-zie a Galeno che definì lo schema dei temperamenti sulla base dei quattroelementi che si credeva costituissero la realtà (acqua,aria,terra,fuoco).Gale-no assicurava di avere derivato questi dati dall’osservazione, dall’esperienzamedica. Questo schema più o meno identico restò valido sino alla fine delCinquecento. E anche chi manifestò qualche perplessità verso la fisiogno-mica (ad esempio Leonardo da Vinci) finì poi con accettarla perché questoschema medico-fisiognomico permise di ordinare le forme visibili, evitandola sensazione di spaesamento dinanzi a corpi nuovi e sconosciuti.3. Chiamo la terza funzione simbolica o paradigmatica, volendo usare unacategoria linguistica, perché la congettura sul corpo-carattere diviene giu-dizio di valore secondo alcuni paradigmi che caratterizzano la culturaoccidentale. È una funzione assai importante dal punto di vista letterario:la fisiognomica studia il rapporto tra esterno e interno, tra corpo e carat-tere. Si muove dunque tra valori estetici (bellezza) e valori etici (bontà),cercando di organizzare un discorso coerente che colleghi questi fattori.Come spiega Della Porta, sin dal mondo antico, in ambito platonico e poistoico, il corpo viene sottoposto a giudizio: alcune parti vengono giudica-
165Lucia Rodler
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 165
te migliori di altre, in particolare – attraverso un’analisi di tipo simbolico– ciò che sta in alto sarebbe più nobile di ciò che sta in basso. Così nelcorpo umano la testa e il volto (e in esso soprattutto gli occhi) esprime-rebbero l’anima.Tra un bel volto e un bel corpo, bisognerebbe preferiredunque il primo caso, perché mostrerebbe un buon carattere. A questoproposito – passo dunque a considerare l’interiorità – l’ideale greco, e poioccidentale, è basato sul concetto di medietà, di ragionevolezza. Ciò signi-fica che il carattere migliore è quello che vince l’irrazionalità dell’istinto,evita gli eccessi, e si comporta in modo equilibrato. Questa è la kaloka-gathia greca che ritroviamo nello studio caratterologico di Teofrasto e,dopo molti secoli, in quello di La Bruyère. Per meglio definire un modellodi medietà psico-fisica la fisiognomica ha elaborato un criterio di con-fronto fra uomo e animale (che a mio avviso definisce la quarta funzione):quando un uomo presenta un aspetto simile, troppo simile, a un animale,sembrando deforme, significa che in lui prevale l’aspetto irrazionale delcomportamento, quello più lontano dalla medietà. Questo tipo di uomo èda evitare.4. E dunque si può definire la quarta funzione analogica o sintagmatica,perché la congettura sul corpo-carattere combina giudizi su uomini e ani-mali, differenziati solo da un grado diverso di complessità psicologica(solo gli uomini infatti possono fingere). Jurgis Baltrusaitis ha parlato inquesto caso di aberrazione, analizzandone gli sviluppi nell’ambito figura-tivo della caricatura.4 Ma anche la letteratura si avvale di questa funzioneanalogica, ad esempio nel genere letterario della favola esopica che, nellateoria di Gotthold Eprhaim Lessing, risulta strettamente legata alla fisio-gnomica zoomorfica.Queste quattro funzioni a volte sono presenti in uno stesso autore (è ilcaso del Della Porta); a volte una prevale sull’altra (basta pensare a Lessingteorico della favola). Spesso la letteratura registra la prevalenza della fun-zione simbolica in base alla quale il corpo viene considerato un ostacoloche copre la scoperta dell’interiorità. Conoscere sé significa rimuovere ilsoma a favore della psiche. Conoscere gli altri significa osservare la loroanima attraverso una «finestra sul cuore» (secondo il topos attribuito aSocrate da Vitruvio) allestita appunto dalla fisiognomica che però su que-sta strada entra decisamente in crisi.Non per caso nell’Italia seicentesca siscrivono solo semplici rifacimenti di Della Porta. Certo, l’accento sull’in-teriorità posto dalla religione controriformista non rende facile un’indagi-ne naturalistica sul corporeo. E così occorre attendere Cesare Lombrosoper avere un dibattito sulla leggibilità del corporeo a livello europeo,men-tre nel XVIII secolo il centro della riflessione si sposta in Germania.I protagonisti sono il pastore protestante zurighese Kaspar Lavater e il docen-te di fisica dell’Università di Göttingen Georg Lichtenberg: il primo scriveun’opera sulla fisiognomica tradizionale, recuperando Aristotele e Della
166 I saggi
4 Cfr. J. Baltrusaitis, Aberrazioni. Saggio sulla leggenda delle forme, Milano,Adelphi, 1983.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 166
Porta, intitolata Frammenti fisiognomici (1775), apprezzata tra gli altri daBalzac; il secondo attacca il pensiero di Lavater in numerosi scritti nei qualinega alla fisiognomica la possibilità di conoscere l’interiorità dell’uomo attra-verso l’analisi dell’aspetto esteriore.5 Come ricorda Hans Blumenberg, perLichtenberg la fisiognomica è una disciplina fondata sul pregiudizio: a segui-re le regole di Lavater, si rischia di impiccare i bambini prima che abbianocommesso qualsiasi colpa, solo sulla base del loro aspetto fisico.6
Colpisce il fatto che, con Lavater, la fisiognomica sia divenuta un vero feno-meno sociale, anche grazie all’uso delle silhouettes, i profili del corpo susfondo bianco, per i quali Lavater inventa anche una macchina, una sorta distrumento fotografico che permette di fissare i profili delle persone.Da tuttaEuropa gli giungono disegni, silhouettes, incisioni, di persone che voglionoconoscere il loro carattere. Filosofi e scrittori lo vanno a trovare ammirati(Goethe, ad esempio). Ma proprio questo entuasismo preoccupa Lichten-berg che sottolinea il fatto che l’uomo finge, si maschera, nasconde le suedeformità fisiche e psichiche. E questi meccanismi di finzione dovrebberoessere analizzati.Così Lichtenberg propone di sostituire la fisiognomica conla patognomica, cioè lo studio delle passioni transitorie che deformano icorpi nelle varie circostanze della vita. È un sogno antico (già Aristotele,poiDella Porta ne avevano parlato). Il fatto è che la complessità della patogno-mica impedisce di giungere a regole chiare e semplici come quelle dellafisiognomica. Lichtenberg ha un’abbondante produzione critica nei con-fronti di Lavater, mentre risulta meno ricca a sua parte costruttiva.Sembra facile dire che Lichtenberg ha ragione. Bisogna però rinunciare aintepretare ciò che vediamo.E ciò non è possibile.Abbiamo infatti bisognodella fisiognomica come orientamento nel nostro essere uomini sociali. Lapatognomica è faticosissima: presuppone un’attenzione capillare ai detta-gli che un volto presenta in tutti gli attimi in cui lo osserviamo. E non cifornisce alcun sistema di riferimento sicuro: non ci sono misure del cra-nio, non c’è proporzione del volto e del corpo, cui fare riferimento.Tuttosi gioca sull’interazione, sull’incontro tra me e un altro che devo analizza-re presuppondendo anche la sua finzione.Se la fisiognomica si basa sul risparmio della fatica percettiva e garantisceuno schema di riferimento sicuro, la patognomica moltiplica il dispendiopsichico e giunge al relativismo (perché l’occhio dell’osservatore è sem-pre in qualche modo affetto da pregiudizi, mentre il corpo dell’osservatoè in contnuo cambiamento). Lo scontro tra Lavater e Lichtenberg è moltoimportante anche per il discorso sulle funzioni della fisiognomica. In que-
167Lucia Rodler
5 Cfr. J. K. Lavater, La fisiognomica, Roma, Atanor, 1988; Id., Frammenti di fisiognomica,Roma,Theoria, 1989; G. C. Lichtenberg, Osservazioni e pensieri,Torino, Einaudi, 1975; Id., Loscandaglio dell’anima. Aforismi e lettere, Milano, Rizzoli, 2002; J. K. Lavater, G. C. Lichten-berg, Lo specchio dell’anima. Pro e contro la fisiognomica. Un dibattito settecentesco,Padova, il Poligrafo, 1991.6 Cfr. H. Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Bolo-gna, Il Mulino, 1984.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 167
sto caso propongo di adottare il punto di vista della critica letteraria. Lava-ter sostiene infatti che il fisionomo è un poeta perché è capace di espri-mere attraverso le parole la verità del carattere e l’armonia del cosmo,chesfuggono alla vista della maggior parte delle persone. Lichtenberg condi-vide questa opinione, ma la condanna in nome della scienza: accusa infat-ti Lavater di scambiare dei ritratti inventati con delle descrizioni vere, dicostruire dei personaggi adatti alla letteratura senza osservare chi gli sta afronte. Per Lichtenberg bisogna distinguere quella che, sulle orme diFreud, il critico italiano Giovanni Bottiroli ha di recente definito «rappre-sentazione di parola» (un reale stereotipato, veicolato dai luoghi comunidel linguaggio) e la «rappresentazione di cosa» (un reale altro, inatteso,non etichettabile con parole abituali).7 Lichtenberg accusa perciò Lavaterdi proporre una teoria della rappresentazione che svolge una funzionediegetica (per parlare in termini di critica letteraria), raccontando ciò cheun uomo può diventare; ad essa Lichtenberg vuole sostituire una teoriadell’espressione, che si occupa solo di ciò che un uomo è in ogni deter-minata situazione, sulla base funzione mimetica della patognomica.Il romanzo ottocentesco che nasce proprio per raccontare storie com-piute con un inizio e una fine, con personaggi riconoscibili perché sem-plificati,utilizza la fisiognomica lavateriana.Balzac ne è un esempio, anchese non semplice. Sembra infatti di capire che dal punto di vista della teo-ria letteraria Balzac sostenga la capacità mimetica della patognomica (miriferisco all’introduzione a Facino Cane, 1836) per poi applicare invecegli schemi fisiognomici nella descrizione dei personaggi. E anche qui nonsempre in modo meccanico: il romanzo La vieille fille (1836) è una veradiscussione sulla fisiognomica.8
Ma nell’Ottocento si sviluppa anche una settima funzione della fisiogno-mica, quella sociale, a proposito della quale risultano utili i suggerimentidi Jean Baudrillard sul «delitto perfetto» che il linguaggio avrebbe com-piuto ai danni del corporeo.9 Essa interessa soprattutto i secoli dellamoderna sensibilità, dal Sette al Novecento, nei quali il discorso psicofisi-co ha teso alla sovrapposizione di analisi naturale e culturale, codicedescrittivo e normativo, ai fini di un controllo collettivo del comporta-mento. Il caso italiano più importante da questo punto di vista si trovaverso gli anni Ottanta dell’Ottocento con l’antropologia criminale di Cesa-re Lombroso, un medico militare che comprese la necessità dell’analisifisiognomica dei corpi durante le visite di leva fatte ai giovani soldati. Nelsuo testo più famoso, L’uomo delinquente (1876) lo studio dell’aspettoesteriore dell’uomo permette di riconoscere la predisposizione a com-
168 I saggi
7 Cfr. G. Bottiroli, Teoria dello stile, Firenze, La Nuova Italia, 1997.8 Cfr. H. de Balzac, La Comédie humaine, Paris, Gallimard, 1977,VI, pp. 1019 (Facino Cane),e ivi, IV, pp. 813-935 (La vieille fille).9 Cfr. J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Milano, RaffaelloCortina, 1996.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 168
mettere crimini.10 È evidente l’importanza sociale di questo pensiero:sostenendo che il corpo condiziona l’anima, si limita la libertà dell’uomoe si discrimina una parte della società, quella degli esseri fisicamente sfor-tunati. Questo pericolo era già stato segnalato da Lichtenberg.La ricerca lombrosiana risulta particolarmente interessante perché è natadall’incontro di un uomo del Nord Italia (Lombroso è nato a Verona) con larealtà arretrata del Sud, dove era appunto medico militare. Il mondo crimi-nale si confonde dunque con quello delle fisionomie altre, selvagge, stra-niere. E questo pregiudizio di natura etnica può essere verificato ancheoggi, dal momento che viviamo per la prima volta in un mondo “multifac-ciale”,per il quale non abbiamo strumenti adeguati di interpretazione.Bastapensare alla difficoltà di leggere i tratti somatici delle altre razze, distin-guendo ad esempio i volti dei cinesi da quelli dei giapponesi; o le fisiono-mie dei neri. Non solo in Italia, da qualche decennio questa incapacità pro-voca un crescente disagio, perché genera insicurezza, almeno ad ascoltareillustri sociologi come Zygmunt Bauman o Alessandro Dal Lago.11 Sappia-mo o crediamo di sapere interpretare lo sguardo di simpatia o minaccia diun europeo, ma ci sentiamo impauriti dinanzi a volti che parlano un altrolinguaggio. Vorremmo dunque uno schema semplice come quello dellafisiognomica dei temperamenti. Dimentichiamo però che lo sguardo fisio-gnomico è fatto di pregiudizi (parola di Gombrich), e che non ci permettemai di conoscere qualcosa di nuovo,ma ci costringe a riconoscere gli sche-mi nei quali siamo cresciuti. Da tempo l’argomento ha interessato gli studipostcoloniali e interculturali e l’imagologia di Hugo Dyserinck,Daniel-HenriPageaux, Benedict Anderson e Joep Leerssen.12 Ma c’è ancora spazio perl’approfondimento della questione sotto il profilo fisiognomico.Questa ricerca permetterebbe tra l’altro di verificare la permanenza dellafisiognomica nel mondo contemporaneo. Sembra di capire che a livello altola nascita della psicoanalisi ha determinato la crisi della fisiognomica comescienza. Fisiognomica e psicoanalisi considerano infatti fondamentale il rap-porto tra esterno e interno,ma in modo quasi opposto, almeno per tre moti-vi: 1) la fisiognomica osserva e giudica attraverso lo sguardo, l’occhio indi-ziario che osserva alcune tracce e ricostruisce un’identità psicosomatica; lapsicoanalisi è fondata sull’ascolto,sulla comprensione delle parole;2) la fisio-gnomica,anche nella più recente versione lombrosiana,afferma che il corpocondiziona l’anima, cioè che un uomo fatto in un certo modo ha molto pro-babilmente un dato carattere;per la psicoanalisi invece i turbamenti psichicisi impongono al corpo, e non per caso si parla nel linguaggio comune disomatizzazione, cioè di incarnazione dei problemi della psiche; 3) la fisio-
169Lucia Rodler
10 Cfr. C. Lombroso, Delitto, genio, follia. Scritti scelti,Torino, Bollati Boringhieri, 1995.11 Cfr. Z. Bauman, Il disagio della postmodernità, Milano, Bruno Mondadori, 2002;A. Dal Lago,Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli, 1999.12 Cfr. N. Moll, Immagini dell’“altro”. Imagologia e studi interculturali, in A. Gnisci (a curadi), Letteratura comparata, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 185-208.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 169
gnomica azzarda previsioni psicofisiche, affermando che un dato corpo avràun dato destino (anche se tanto l’antica astrologia quanto la moderna antro-pologia criminale parlano solo di inclinazione); la psicoanalisi è fondata inve-ce su un metodo regressivo, guarda all’indietro, sino all’infanzia.Naturalmente il fallimento della fisiognomica è legato anche allo sviluppodelle scienze naturali, sempre più specialistiche, contro la natura enciclo-pedica della fisiognomica. Basta pensare alla scoperta dei microbi dellafine dell’Ottocento.Cosa può dire la fisiognomica a questo proposito? Puòparlare di carattere?Ma nell’immaginario collettivo, cioè a livello medio-basso le cose sonodiverse. Direi che fino agli anni Cinquanta del Novecento resta vera l’ideache il corpo condiziona il comportamento, essendo entrambi fattori lega-ti alla natura. Proprio questa ipotesi ha giustificato tra l’altro i pregiudizirazziali. Dopo la seconda guerra mondiale, si fa lentamente strada l’ideache il corpo sia modificabile; molti fattori contribuiscono a questo nuovomodo di concepire il corporeo, tra cui lo sviluppo degli studi medici, lemigliori condizioni economiche, la volgarizzazione della psicoanalisi, concui abbiamo imparato a non vergognarci della fisicità.Ecco allora che dedi-chiamo moltissima attenzione al corporeo: non solo con la palestra o lamoda, ma con la chirurgia plastica, le diete possiamo diventare ciò chevogliamo, o crediamo di volere. Dal punto di vista dell’osservazione, sem-bra che abbia avuto ragione Lichtenberg; nel secondo Novecento la pato-gnomica è stata più importante della fisiognomica. Il corpo viene osser-vato come fattore culturale,simbolico,più che naturale.Non si giudica unapersona solo per il suo aspetto fisico, ma anche per la cura che ha di sestessa, per il modo di fare, insomma per la patognomica.Questo però ci ha reso più insofferenti verso le forme di diversità: dinan-zi a un corporeo da plasmare vorremmo vedere sempre rispettati unaserie di pregiudizi di tipo estetico-culturale elaborati dall’Occidente. Pertrovare una verifica, è sufficiente leggere i settimanali maschili e femmini-li e le brochures dei cosmetici che costituiscono una sorta di paralettera-tura con molte indicazioni fisiognomiche che rispondono, a livello divul-gativo, al bisogno di mettere in relazione i dati somatici con quelli inte-riori. Concludo rammentando che questa necessità corrisponde all’esi-genza di dominare ciò che ci circonda, evitando la sensazione di spaesa-mento che coglie dinanzi al nuovo.Lo sguardo fisiognomico è infatti capa-ce di collocare ogni nuova fisionomia entro uno schema di interpretazio-ne e di giudizio che aiuta a riconoscere il nuovo attraverso il vecchio, manon a conoscere il nuovo di per se stesso.Questa sua funzione limitata,matranquillizzante costituisce precisamente la ragione della secolare fortunadella fisiognomica.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/3rodler.htm.
170 I saggi
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 170
La spazzatura gradita a Italo Calvino. Un breve percorso tra i rifiuti de ‘Lapubelle agréée’Andrea Severi
Delle faccende domestiche, l’unica che io disimpegni con qualche compe-tenza e soddisfazione è quella di mettere fuori l’immondizia. L’operazione sidivide in varie fasi: prelievo della pattumiera di cucina e suo svuotamentonel recipiente più grande che sta nel garage, poi trasporto del detto reci-piente sul marciapiede fuori della porta di casa, dove verrà raccolto daglispazzini e vuotato a sua volta nel loro autocarro.1
Chi parla è l’Italo Calvino “eremita” a Parigi, borghese pater familiasdimesso e fuori ruolo (in un’epoca ormai di fine del patriarcato, siamonella metà degli anni Settanta) in una palazzina unifamiliare o pavillon aridosso della cité.Scritto tra il 1974 e il 1976 e pubblicato per la prima volta su «Parago-ne/Letteratura» nel febbraio del 1977, La poubelle agréée – questo saggioscritto da un «antropologo dei gesti quotidiani carichi di un valore assolu-to», in «quegli anni parigini, che erano anche gli anni di Lévi-Strauss, e diBarthes e di Foucault»2 – confluì poi in «quella straordinaria narrazioneautobiografico-saggistica» (Milanini) rappresentata dai «Passaggi obbligati».Afflitto – secondo il più classico dei cliché che grava sugli intellettuali –da una paralizzante inettitudine nella vita che si svolge in cucina e che sibasa «su un ritmo musicale, su una concatenazione di movimenti comepassi di danza» dove a farla da padrone sono le mani femminili dellamoglie e della figlia (spartito dove la pur buona volontà dello scrittore nonpuò che tradursi in movimenti «stonati e torpidi», con conseguente inevi-tabile umiliazione), Calvino trova finalmente il suo momento, se non pro-prio di gloria, di felice inserimento all’interno del ciclo domestico, dopol’ultimo pasto della giornata, quando «sparecchiata la tavola, l’ultimo ossoo buccia o crosta è scivolato giù dalla liscia superficie dei piatti» e la tem-pesta comincia ad abbattersi sui piatti sporchi in provvisorio esilio infondo al tunnel della lavastoviglie.«Questo è il momento per me d’entrare in azione». È una sorta di riscattoquotidiano, di rivincita quella che sta dietro lo smaltimento delle «scorie»
172 I saggi
1 I. Calvino, La poubelle agréée, in Romanzi e racconti, vol. III, p. 59-79. Qui si cita da p. 59.2 C. Bologna, Per una filologia degli scarti, dei dislivelli, delle fratture, su www.filologia-sarda.eu/pubblicazioni/alghero2003/04.pdf.
13
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 172
domestiche, umile operazione priva, a tutta prima, della benché minimadignità. Eppure la meticolosità con cui Calvino compie ogni operazione,la giustificazione di ogni gesto che il lettore ha modo di apprezzare intutta la sua calcolata premeditazione, fanno già presagire che qualcosa dimolto importante stia sotto a questo “rito” quotidiano:
Ecco che già scendo le scale reggendo il secchio per il manico a semicer-chio, attento a che non dondoli tanto da ribaltare il carico. Il coperchio disolito lo lascio in cucina: scomodo accessorio, quel coperchio, che male sidestreggia tra il compito di nascondere e quello di levarsi di mezzo appenac’è da buttare dentro della roba.3
È la «rappresentazione quasi fotografica, spassionata, meticolosa di coseconcrete e familiari (i piatti, il lavastoviglie, il secchio di plastica, il bidonedi zinco, il cartoncino e l’autocarro degli spazzini, le pagine accartocciateo coperte di cancellature)».4
Nel travaso dei rifiuti dalla pattumiera di cucina color verde pisello alla piùgrande poubelle del garage di color «grigio-verde scuro da uniforme mili-tare», e nel trasporto di questa fuori dalle mura casalinghe – a favorire l’in-tervento dei netturbini – Calvino si sente «primo ingranaggio d’una cate-na d’operazioni decisive per la convivenza collettiva», riconoscendo la sua«dipendenza dalle istituzioni senza le quali morrei sepolto dai miei stessirifiuti nel mio guscio d’individuo singolo, introverso e (in più d’un senso)autista». «La poubelle è lo strumento per inserirmi in un’armonia, per ren-dermi armonico al mondo e rendere il mondo armonico a me». La pou-belle agréée, dunque,ci spiega Calvino,non è solo un termine tecnico perindicare la pattumiera conforme ai regolamenti prefettizi, quella prescrit-ta dalle leggi municipali affinché, di un certo uniforme colore (verdescuro), col coperchio ben chiuso e di plastica, non risulti di danno a nes-suno dei sensi, vista,olfatto e udito.Questa poubelle finisce per essere gra-dita, cara, anche perché, a dispetto del suo contenuto, o forse proprio acausa di esso, permette di assolvere un compito di grande valore sociale.C’è un pactum ben stabilito e vitale per la collettività dietro l’aggettivoagréée: non è quindi solo un fatto di autostima o di considerazione all’in-terno del nucleo familiare, la possibilità di inserirsi o meno lodevolmentein un concerto di azioni domestiche e di far recuperare scampoli di cre-dibilità alla periclitante immagine del pater familias («È per essere io pri-vatamente agréé che sto manovrando la pubblicamente agréée pattumie-ra, agréé io nel contesto casalingo, nella tacita distribuzione dei ruolidomestici,nell’orchestrazione della suite quotidiana della sussistenza fami-liare»); è invece l’aspetto sociale che finisce per prevalere su quello pret-
173Andrea Severi
3 I. Calvino, La poubelle agréée, cit., p. 60.4 C. Milanini, Introduzione a I. Calvino, Romanzi e racconti, cit., vol. III, pp. XI-XXXIII; qui sicita da p. XXXI.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 173
tamente individuale-familiare, quando, per interpretare l’espressione “pou-belle agréée”, il francese lascia spazio all’inglese:
È il verbo inglese to agree che invade il campo: è per rispettare un agree-ment,un patto concordato per mutuo consenso delle parti,che io sto posan-do questo oggetto su questo marciapiede, con tutto ciò che implica l’usointernazionale della parola inglese.5
Un agreement con la città, sotto il quale sta la necessità non solo di libe-rarsi fisicamente di una mera quantità di scarti che impedirebbe alla vita diproseguire, ma anche di rapportarsi con quel processo di smaltimento deirifiuti che risulta in qualche modo consustanziale alla vita stessa, in unasorta di tensione tra vita e morte, nuovo e vecchio, tra ciò che si scarta eciò che rimane. Raggiunta questa consapevolezza filosofica (d’altronde acolpire in questo scritto, «nel breve giro d’una confessione signorilmenteautoironica [...] è la quantità di considerazioni personali, sociologiche, filo-sofiche che vi sono condensate»)6 ecco che da contratto sociale il ciclo dienlèvement des ordures assurge persino al grado di rito purificatorio:
Il portare fuori la puobelle va dunque interpretato contemporaneamente(perché così lo vivo) sotto l’aspetto di contratto e sotto quello di rito [...]rito di purificazione, abbandono delle scorie di me stesso, non importa se sitratta proprio di quelle scorie contenute nella poubelle o se quelle scorierimandano a ogni altra possibile mia scoria, l’importante è che in questo miogesto quotidiano io confermi la necessità di separarmi da una parte di ciòche era mio, la spoglia o crisalide o limone spremuto del vivere, perché neresti la sostanza, perché domani io possa identificarmi per completo (senzaresidui) in ciò che sono e ho. Soltanto buttando via posso assicurarmi chequalcosa di me non è stato ancora buttato e forse non è né sarà da buttare.7
C’è bisogno, è vero, di una separazione netta tra ciò che è da gettare, daallontanare, e ciò che invece va conservato e tenuto nel circolo vitale. Masolo prendendo coscienza di ciò che stiamo espellendo per sempre dainostri confini riusciamo, valorizzando l’atto deiettivo, a caricare ciò cheresta di un surplus di senso e di sostanza («La poubelle agréée: gradita inprimo luogo a me, ancorché non gradevole; come è necessario gradire ilnon gradevole senza il quale nulla di quel che ci è gradito avrebbe senso»).Il discorso di Calvino, partito da semplice resoconto diaristico della vitadomestica,conosce a tratti impennate gnomiche che sconfinano nel campoontologico («Il buttar via è la prima condizione indispensabile per essere,perché si è ciò che non si butta via»), fatte salve,a brevissima distanza,escur-sioni nel campo del comico-basso corporeo.Ma qui l’inserzione scatologica,
174 I saggi
5 I. Calvino, La poubelle agréée, cit., p. 64.6 C. Milanini, Introduzione, cit., p. XXX.7 I. Calvino, La poubelle agréée, cit., p. 65.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 174
oltre ad una funzione umoristica, serve per collegare macrocosmo e micro-cosmo, la funzione di espulsione dei rifiuti domestici, nel grande ventredella città, e quella della propria defecazione, che, lasciando liberi gli inte-stini, consente una reale ispezione del proprio autentico essere:
La soddisfazione che provo [buttando via i rifiuti casalinghi] è dunque ana-loga a quella della defecazione, del sentire le proprie viscere sgombrarsi, lasensazione almeno per un momento che il mio corpo non contiene altroche me, e non vi è confusione possibile tra ciò che sono e ciò che è estra-neità irriducibile.Maledizione dello stitico (e dell’avaro) che temendo di per-dere qualcosa di sé non riesce a separarsi da nulla, accumula deiezioni e fini-sce per identificare se stesso con la propria deiezione e perdervisi.8
Bisogna liberarsi di una parte di noi per poter dare sempre spazio a nuoveforme, alla nuova vita – dice Calvino – come, sull’esempio del raccontoFunes o della memoria di Borges, possiamo ricavare che è proprio loscarto della memoria, l’oblio, a innestare il pensiero. Calvino utilizza lametafora del rito purificatorio: «l’enlèvement des ordures ménagères puòessere anche visto come un’offerta agli inferi, agli dei della scomparsa edella perdita, l’adempimento di un voto (ecco ancora il contratto). Il con-tenuto della poubelle rappresenta la parte del nostro essere e avere chedeve quotidianamente sprofondare nel buio perché un’altra parte delnostro essere e avere resti a godere la luce del sole, sia e sia avuta vera-mente». E questo rito di purificazione quotidiana diventa anche modo diesorcizzare la morte,di allontanare il più possibile quel momento in cui ciidentificheremo a pieno con quelle scorie prima solo da noi prodotte:
Questa quotidiana rappresentazione della discesa sottoterra, questo funeraledomestico e municipale della spazzatura, è inteso in primo luogo ad allonta-nare il funerale della persona,a rimandarlo sia pur di poco,a confermarmi cheancora per un giorno sono stato produttore di scorie e non scoria io stesso.9
Per questo gli ufficiali di questo quotidiano “rito di purificazione”, i nettur-bini, coloro che impediscono che la nostra città si trasformi in un «infettolatamaio», sono definiti da Calvino «emissari del mondo ctonio», «carontid’un al di là di carta unta e latta arruginita», ma pure «angeli [...] annuncia-tori d’una salvezza possibile al di là dello sfacelo d’ogni produzione e con-sumo,affrancatori dal peso dei detriti del tempo,neri e grevi angeli della lim-pidezza e leggerezza». E non importa qui sottolineare l’importanza che que-sto valore, la “leggerezza” appunto, ricopre nella poetica dell’autore delleLezioni americane. Qui interessa soprattutto rilevare come Calvino, pochianni prima, avesse già parlato nei medesimi termini dei netturbini nella sua“città invisibile” dove l’assillo dello smaltimento dei rifiuti è posto come il
175Andrea Severi
8 Ivi.9 Ivi, p. 66.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 175
tratto peculiare dei cittadini. Stiamo parlando della città di Leonia (anche seil tema del rifiuto e dello scarto è centrale anche per la città di Moriana e diClarice),dove «gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito dirimuovere i resti dell’esistenza di ieri è circondato d’un rispetto silenzioso,come un rito che ispira devozione,o forse solo perché una volta buttata viala roba nessuno vuole più averci da pensare» (nostro il corsivo).Nel saggio La poubelle agréée la figura dell’angelo della spazzatura servea Calvino per far virare il discorso dal suo iniziale approccio antropologi-co verso considerazioni di tipo economico-sociale e, più in generale, poli-tico. Da un punto di vista meramente classista, il borghese Italo Calvinoproduttore di rifiuti e gli éboueurs che «affiorano dalle nebbie del matti-no» per smaltirli («i Nordafricani – un po’ di baffi, uno zuccotto in capo; o– quelli dell’Africa nera – solo il bulbo degli occhi che rischiara il visoperso nel buio») appartengono a due mondi nettamente distinti:
Il mio rapporto con la poubelle è quello di colui per il quale il buttar viacompleta o conferma l’appropriazione, il contemplare la mole delle bucce,dei gusci, degli imballaggi, dei contenitori di plastica riporta la soddisfazionedel consumo dei contenuti, mentre invece l’uomo che scarica la poubellenel cratere rotante del carro ne trae la nozione della quantità di beni da cuiè escluso, che gli arrivano solo come spoglia inutilizzabile.10
È proprio nel circolo di produzione e smaltimento dei rifiuti che la socie-tà consumistica mostra il suo volto deteriore: negli attori del processodeiettivo si perpetua la logica e l’ingiustizia che ogni divisione classistadella società porta con sé. Eppure, quando, come scrive ancora Calvino, ilprocesso industriale di «produzione e distruzione» si rivela per quello cheè, ovvero un «sistema che inghiotte gli uomini e li rifà a propria immaginee somiglianza»,non importa più tanto chi ora riempia i cassonetti e chi orali svuoti, perché visto che la «piramide sociale continua a rimescolare lesue stratificazioni etniche», si può star certi che «l’essere stato assuntocome spazzino è il primo gradino d’una ascesa sociale che farà anche delparia di oggi un appartenente alla massa consumatrice e a sua volta pro-duttrice di rifiuti, mentre altri usciti dai deserti “in via di sviluppo” pren-deranno il suo posto a caricare e scaricare i secchi».In questa nuova dimensione in-umana perde tutta la sua “aura”, assieme conla sua dimensione sociale e ontologica,il ciclo di smaltimento dei rifiuti.Nonè più possibile il compimento del ciclo vitale che invece era proprio delprocesso agricolo, dove «ciò che era sepolto nella terra rinasceva»: nell’etàdel consumismo dove spadroneggiano i contenitori in plastica, i rifiuti cre-scono in maniera direttamente proporzionale al ciclo di produzione, secon-do equilibri e dosaggi stabiliti dal “dio Capitale”, non più garantiti dalla“madre”Terra:«Inutilmente rovesciamo,io e lo spazzino,la nostra oscura cor-
176 I saggi
10 Ivi, p. 69.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 176
nucopia, il riciclaggio dei residuati può essere solo una pratica accessoria,che non modifica la sostanza del processo. Il piacere di far rinascere le coseperiture (le merci) resta privilegio del dio Capitale che monetizza l’animadelle cose e nel migliore dei casi ce ne lascia in uso e consumo la spogliamortale». Ragione per cui la poubelle, a conti fatti, finisce per essere “gradi-ta” non più al municipio, non più al produttore di rifiuti che sente l’utilitàsociale e quasi “esistenziale” dell’operazione che sta svolgendo, ma «piùancora all’anonimo processo economico che moltiplica i prodotti nuoviusciti freschi di fabbrica e i residui logori da buttar via, e che ci lascia met-ter mano solo a questo recipiente da riempire e svuotare, io e lo spazzino».Ennesima,dolorosa presa di coscienza dell’alienazione dell’uomo moderno,o capitolo dell’alienazione narrato sub specie immunditiae. In un sorta dicomico ribaltamento, sembra quasi che siano diventati i rifiuti (o meglio, lemerci-rifiuti, tanto per sintetizzare il ciclo) i fruitori della poubelle,e gli esse-ri umani – nella doppia versione di riempitori e svuotatori – i semplici ese-cutori materiali, automi diligenti di un processo eterodiretto.Ad una sorta di trionfo dei rifiuti, di mondo capovolto (anche se in quellamaniera da fiaba eroicomica propria delle Cosmicomiche), del resto, siassiste anche nei due racconti inclusi ne La memoria del mondo e altrestorie cosmicomiche che hanno a che fare col tema della spazzatura. Maqui, al contrario che nella Poubelle, i rifiuti, lo scarto, il “vecchio” brutto eda buttare hanno ancora un ruolo di ribaltamento sovversivo, che aiutal’uomo a ritrovare un senso dell’umano, non a cancellarlo.Nel racconto Le figlie della luna, il Giorno del Ringraziamento del Con-sumatore, lungo le strade di Manhattan, sfilano da una parte il corteo delCliente Soddisfatto,organizzato da un grande magazzino per dar modo allasua clientela di «manifestare la propria gratitudine verso la Produzione chenon si stancava di soddisfare ogni suo desiderio»; dall’altra, invece, unaLuna scrostata ed ammuffita guida un corteo di macchine massacrate, discheletri di camion, che si arrichisce pian piano di persone, soprattuttonegri e portoricani di Harlem. Quando si incontrano è la sfilata degli scar-ti, dei rifiuti, dei relitti (e derelitti) a inglobare quella del Nuovo e del Con-sumo, come in algebra il segno negativo ha la meglio su quello positivo:
A Madison Square una sfilata incrociò l’altra: ossia ci fu un solo corteo. «IlCliente Soddisfatto», forse per una collissione con la puntuta superficie dellaLuna, scomparve, si trasformò in un cencio di cauciù [...] Non si capiva piùquali fossero le vecchie [macchine] e quali le nuove: le ruote storte, i para-fanghi arrugginiti erano mescolati con le cromature lucide come specchi,con le verniciature di smalto.E dietro al corteo le vetrine si ricoprivano di ragnatele e di muffa, gli ascen-sori dei grattacieli si mettevano a cigolare e a gemere, i cartelloni pubblici-tari ingiallivano [...] La città aveva consumato se stessa di colpo:era una cittàda buttar via che seguiva la Luna nel suo ultimo viaggio.11
177Andrea Severi
11 Ora in I. Calvino, Romanzi e racconti, vol. II, pp. 1193-1205; qui si cita da p. 1203.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 177
Nel racconto I meteoriti invece, ambientato su una Terra «ancora piccola»che «si poteva spazzare e spolverare tutti i giorni», il vecchio narratore eprotagonista Qfwfq divorzia dalla moglie Xha, fautrice dell’ordine e dellapulizia costante, per risposarsi con la ragazza Wha, che si sente perfetta-mente a suo agio nel disordine, e tra i rifiuti e gli scarti che non smaltiscecostruisce il suo habitat. Ma nella chiusa del racconto, dopo averle perseentrambe, Qfwfq deve ammettere che «basterebbe riaverle tutte e dueinsieme un solo momento per capire».12 C’è insomma una complementa-rietà tra il disordine dei rifiuti ammucchiati e l’ordine conseguente al lorosmaltimento: tra questi due stati contrastanti si crea una tensione irrisoltae latrice di un senso nascosto.Quel senso che riesce a sprigionare la creazione artistica, al termine diun’estenuante battaglia tra minute da gettare e bella copia, tra errori e cor-rezioni, tra appallottolamenti e riscritture, seguendo un processo di suc-cessive elaborazioni reso possibile grazie all’eliminazione del superfluo,dell’inessenziale. Scrive Calvino al termine de La poubelle agréée:
Scrivere è dispossessarsi non meno che il buttar via, è allontanare da me unmucchio di fogli appallottolati e una pila di fogli scritti fino in fondo, gli unie gli altri non più miei, deposti, espulsi.13
E poco prima aveva detto:
Questi miei pensieri che leggete sono quanto s’è salvato di decine di fogliappallottolati nel cestino.14
Il prodotto letterario è dunque ciò che rimane al termine di lunghi pro-cessi di eliminzione di rifiuti, di scarto, di superfuo, in una concezione delfare artistico in continuo “levare”, in continua sottrazione da una materiamuta. E non è un caso che l’articolo di Calvino finisca proprio con l’esibi-zione (che ad altri scrittori potrebbe apparir sconcia) degli appunti pre-paratori buttati giù dall’autore e servitigli come “scaletta”, le scorie dellascrittura primigenia che è stata eliminata, dando in questo modo i suoifrutti.Questo rovesciare sul tavolo di lavoro il cestino contenente le bozzedi scrittura e lasciare che esse mettano fine alla sua fatica rappresenta ungrande omaggio ai rifiuti e al potenziale creativo implicito in ogni loroconsapevole,“ragionata” deiezione. Nell’atto artistico, dunque, l’uomo cheha sperimentato la propria alienazione nella catena di smaltimento collet-tiva può tornare ad essere consapevole padrone del proprio privato pro-cesso di eliminazione.
178 I saggi
12 Ivi, pp. 1206-1215; qui si cita da p. 1206 e da p. 1215.13 I. Calvino, La poubelle agréée, cit., p. 79.14 Ivi, p. 70.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 178
Tema della purificazione delle scorie il buttar via è complementaredell’appropriazione ????????????????inferno d’un mondo incui nonfosse butatto ???????????? via niente si è quel che non si butta viaidentificazione di se stessi spazzatura come autobiografia soddisfa-zione del consumo defecazione tema della materialità, del rifarsi,mondo agricolo... ??????CONTROLLARE TUTTA LA CITAZIONE15
Arriviamo dunque a capire che c’è una stretta affinità tra le motivazionidel pater familias che ogni sera elimina la spazzatura dalle mura di casae quelle dello scrittore che lavorando quotidianamente a espellere le sco-rie della scrittura arriva – a volte nel corso di anni – a licenziare finalmenteun testo definitivo e soddisfacente.Tuttavia, se i moventi si possono met-tere a confronto, altrettanto non si può fare coi risultati: il Calvino agens,ovvero il Calvino netturbino domestico, viene schiacciato dal cumulo deirifiuti, prendendo coscienza del processo di alienazione in atto nel siste-ma consumistico; il Calvino auctor, al contrario, alla fine trionfa, domi-nando i rifiuti prodotti dalla propria scrittura e portando così a termine ilsaggio (anche se, con l’autoironia che gli è propria, l’autore fa aleggiare ilsospetto di una “vittoria di Pirro”).Così che nel finale Calvino deve ammet-tere, analizzando il diverso tipo di assimilazione di ciò che si salva dalledue poubelle:
Capisco ora che avrei dovuto cominciare il mio discorso distinguendo ecomparando i due generi di spazzatura domestica, prodotti della cucina edella scrittura, il secchio dei rifiuti e il cesto della carta straccia.16
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6severi.htm.
179Andrea Severi
15 Ivi, p. 79.16 Ivi, pp. 78-79.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 179
‘Giovinezza’ di Montale: una lettura di «Falsetto»Riccardo Stracuzzi
iovinezza non rinverde,anco fugge più che ’l sole.
(B. Giambullari)1
1. Stando all’estensiva partizione temporale in cui Lonardi inscrive l’itine-rario delle maniere poetiche montaliane,2 si può asserire che le parole-motivo inerenti alla cosmografia della “giovinezza”, o della “gioventù”,3
tendono a polarizzarsi intorno agli estremi dell’opera: ossia nel poeta gio-vane degli Ossi di seppia, e nel vecchio di Satura e dei libri che seguono;è raro, invece, individuare quelle parole-motivo nelle scritture delle Occa-sioni e della Bufera. Su ciò danno sicuro ragguaglio, anzitutto, i repertorilessicografici procurati da Savoca,4 da cui traggo alcuni lemmi secondouna selezione che, evidentemente, non si pretende completa:
*Adolescente (femm.): una occorrenza in Poesie disperse e inedite, nel sot-totitolo o rubrica degli Accordi (Sensi e fantasmi di una adolescente), serie
180 I saggi
1 [Che nessuno ami costei], vv. 7-8, in Rime inedite o rare, con intr., nn. e indice generale ditutti i componimenti editi e inediti per cura di I. Marchetti, Firenze, Sansoni, 1955, p. 190.2 «Diciamo anzi a proposito di questa “carriera” in poesia che dura da sessant’anni, da “Merig-giare”che è del ’16 (ma è proprio vero?) al Quaderno che va fino al ’77, che qui molto gros-solanamente la divideremo in tre spezzoni cronologici: del poeta giovane, dell’adulto, delvecchio»; «il giovane e il vecchio, diversamente dall’adulto, quanto sono il primo in quasi-assenza di privato, il secondo in quasi-rapina del medesimo, intrattengono il loro dialogol’uno prevalentemente con il cosmo tutto intero, l’altro con una folla di ombre e memoriedesultorie e sempre più causali, ma entrambi in assenza della divina Coadiutrice degli eroiviaggiatori, entrambi in assenza di ogni magica mediazione». G. Lonardi, Il Vecchio e il Gio-vane e altri studi su Montale, Bologna, Zanichelli, 1980,pp.105 e 106. La distinzione, e anzi-tutto il ragionamento che la sottende, sono utili quantomeno per evitare che – se davveroentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem – il numero delle maniere di Montalefinisca per coincidere con il numero dei suoi libri. Su quest’ultima via, invece, mi sembra simettano R. Luperini, Storia di Montale, Roma-Bari, Laterza, 20053, pp. 233-254; e F. De Rosa,Scansioni dell’ultimo Montale, in Montale e il canone poetico del Novecento, «Atti delleGiornate di studio su Montale (Pontignano-Siena 23-25 maggio 1996)», a cura di M. A. Gri-gnani, R. Luperini, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 47-72. Dal lato opposto, pare che Montalestesso abbia cercato di accreditare l’immagine d’un suo itinerario essenzialmente bipartito:si legga Le reazioni di Montale (1977), in Eugenio Montale, a cura di A.Cima, C. Segre,Mila-no,Bompiani, 19962, alla p.180: «Io vedo una certa continuità tra i primi tre libri [...]; nei suc-cessivi c’è come il rovescio della medaglia, l’apertura del retrobottega». L’esegesi dell’autorenon va presa naturaliter per vera, né essa è garantita contro l’equivoco più o meno di quel-la dello studioso; e però, tra un Montale soltanto doppio, e uno addirittura quadruplo o quin-tuplo, sarà ragionevole individuare una stazione mediana.3 Entrambi gli astratti, come si vedrà, figurano nel dizionario montaliano.4 Si veda ora il comprensivo G. Savoca, Vocabolario della poesia italiana del Novecento,Bologna, Zanichelli, 1995.
14
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 180
di poesie composte tra il 1916 e il 1920, pubblicate su «Primo tempo» nel’22 insieme con Riviere, ma poi escluse dagli Ossi in volume, a causa del«senso generale» e dell’«ingenua pretesa di imitare gli strumenti musicali».5
*Adolescente (masc.):una occ., in Ossi di seppia: «Rammento l’acre filtro cheporgeste / allo smarrito adolescente, o rive», Riviere, vv. 18-19, OV p. 99.*Adolescenza: due occ.; in Satura: «Uscito appena dall’adolescenza / permetà della vita fui gettato / nelle stalle di Augìa», Botta e risposta I II, vv. 1-3,OV p. 277; e in Poesie disperse e inedite: «Anch’io sovente nella mia rustica /adolescenza levantina», Lettera levantina (1923), vv. 60-61, OV p. 774.*Fanciulla: 2 occ. (esclusa quella del Quaderno di traduzioni); nelle Occa-sioni: «Forse nel guizzo argenteo della trota / controcorrente / torni anchetu al mio piede fanciulla morta / Aretusa», L’estate, vv. 5-8, OV p. 169; e in Dia-rio del ’71 e del ’72: «Ma allora non ti ricordai, ero giovane / e mi credevopadrone della mia sorte / [...] Potevo / chiedere allora del tuo pensionato, /vederne uscire le fanciulle in fila, / trovare un tuo pensiero di quando eri /viva e non t’ho pensato. [...]», Il lago di Annecy,vv.4-5 e 9-13,OV p.438 (nellaquale registriamo anche un’occorrenza di *Giovane che aggiungiamo alsuccessivo elenco).*Fanciullo: una occ., nel Quaderno di traduzioni (che escludo) e 11 negliOssi: Falsetto, v. 29, OV p. 12 (ma ci tornerò); Caffè a Rapallo, v. 16 ed Epi-gramma, v. 1, OV pp. 15-16; Ma dove cercare la tromba..., v. 3, OV p. 22; Lafarandola dei fanciulli sul greto..., v.1,OV p.43; «io che sognava rapirti / le sal-mastre parole / in cui natura ed arte si confondono, / per gridar meglio la miamalinconia / di fanciullo invecchiato che non doveva pensare», Potessi alme-no costringere... (Mediterraneo VIII), vv. 6-10, OV p. 58; Flussi, vv. 1, 22, 28, OV
p. 74; «[...] Penso allora / alle tacite offerte che sostengono / le case dei viven-ti; al cuore che abdica / perché rida un fanciullo inconsapevole»,Crisalide, vv.77-80, OV p. 87; «Erano questi, riviere, i voti del fanciullo antico / che accantoad una rósa balaustrata / lentamente moriva sorridendo», Riviere, vv. 34-37, OV
p. 102 (il quale segue l’occ. di uno “smarrito adolescente”citata supra).*Giovane (agg.): una occ. nella Bufera («Giovane stelo tu crescevi; e io alrezzo / delle tregue spiavo il tuo piumare», Anniversario, vv. 7-8, OV p. 264);tre occ. in Satura («una zuffa di piume soffici, due becchi giovani / arditi einoffensivi», Xenia II 12, vv. 7-8, OV p. 308; «[...] e intanto tu eri fuggita / conun buon topo d’acqua di me più pronto / e ahimè tanto più giovane. [...]»,Tardivo ricettore di neologismi..., vv. 5-7, OV p. 389; e Due prose venezianeI v. 28, OV p. 391); tre occ. nel Diario del ’71 e del ’72 («Fu quello il nostrolago, poche spanne d’acqua, / due vite troppo giovani per essere vecchie, /e troppo vecchie per sentirsi giovani», Sorapis, 40 anni fa, vv. 23-25)6 eancora tre occ. nel Quaderno di traduzioni.*Giovane (masc.): due occ. nelle traduzioni, mentre le restanti cinque tuttecollocate nel Montale “vecchio”: in Satura (Xenia I 13, v. 1, OV p. 293); nel
181Riccardo Stracuzzi
5 Così il poeta in una lettera a Spagnoletti dell’agosto 1960: si cita da E. Montale, L’opera inversi, ed. critica a cura di R. Bettarini, G. Contini,Torino, Einaudi, 1980 (d’ora in avanti OV),pp. 865 e 1166-1167. Qui, e nel seguito, corsivi e sottolineature sono miei se non diversa-mente segnalato.6 Savoca registra la seconda occ. (v. 25) nella categoria “sostantivo masc.”: cfr. Savoca, Voca-bolario della poesia italiana del Novecento, cit., p. 429; il che, evidentemente, è un errore.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 181
Diario del ’71 e ’72 («Tuorli d’un solo uovo entrano i giovani / nelle pale-stre della vita», Il negativo, vv. 1-2, OV p. 419, insieme con quella citata dian-zi);nel Quaderno di quattro anni («Hic manebimus se vi piace non proprio/ ottimamente ma il meglio sarebbe troppo simile / alla morte (e questapiace solo ai giovani)»,Al mare (o quasi),vv.30-32,OV p.603);e in Altri versi(Una visitatrice, v. 5, OV p. 682).*Giovinetto (agg.): due occ., e partitamente una negli Ossi di seppia: «e cheil tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia / schietto come la cimad’una giovinetta palma...»,Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua lim-pida..., vv. 11-12, OV p. 30; e una in una lirica già menzionata delle Occasioni:«L’ombra crociata del gheppio pare ignota / ai giovinetti arbusti quando radefugace», L’estate, vv. 1-2, OV p. 169.Da ultimo i due astratti:*Gioventù: cinque occ., di cui almeno quattro eloquenti per le circostanzesemantiche: nella Bufera («Il canto delle strigi, quando un’iride / con inter-messi palpiti si stinge, / i gemiti e i sospiri / di gioventù, l’errore che recinge/ le tempie e il vago orror dei cedri smossi»,Nel sonno, vv.1-5, OV p.192);nelDiario del ’71 e del ’72 («[...] Ma ero pazzo / e non di te, pazzo di gioventù,/ pazzo della stagione più ridicola / della vita. [...]», Annetta, vv. 31-34, OV p.490;e «Scoprimmo allora che cos’è l’età. / Non ha nulla a che fare col tempo,è qualcosa che dice / che ci fa dire siamo qui,è un miracolo / che non si puòripetere.Al confronto / la gioventù è il più vile degli inganni», ancora Sora-pis, 40 anni fa, vv. 26-30, OV p. 502); e nel Quaderno di quattro anni (inOltre il breve recinto di fildiferro, v. 9, OV p. 617).*Giovinezza: sette occ., dalle quali escludiamo la prima (da Falsetto, per cuiampiamente infra) e le due dal Quaderno di traduzioni; ne restano quat-tro, così disposte: una in Ossi di seppia («forse il nostro cammino a non tóc-che radure ci addurrà / dove mormori eterna l’acqua di giovinezza»,Noi nonsappiamo quale sortiremo..., vv. 3-5, OV p. 56); una in Poesie disperse editee inedite, ancora dalla serie giovanile degli Accordi («Stamane, mia giovinez-za, / una fanfara in te squilla, / voce di bronzo che immilla / l’eco, o disper-de la brezza»), Ottoni, vv. 1-4, OV p. 772); due nel Quaderno di quattro anni(in L’educazione intellettuale, v. 8, OV p. 511 e in Morgana, v. 1, OV p. 625).
Il repertorio, ancorché imperfetto, è sufficientemente diffuso per definirei limiti del motivo della “giovinezza”in Montale,ovvero per avvertirla sottoil rispetto di una ripresa di tópoi tradizionali e di una formulazione tema-tica che, in termini rematici, sembra non troppo riformulare il motivo.Intanto si avverta che la maggiore frequenza delle parole-motivo nellecompagini poetiche estreme non va giudicata casuale. Essa verosimilmen-te illustra la scarsa acquisizione, da parte di Montale, del motivo in sé. Conil che si dice che il riuso del motivo è in effetti enfatico negli Ossi, diun’enfasi già negativa, tuttavia, attinta da un nichilismo più o meno con-tingentista; e invece ironico o sottovalutativo nelle scritture da Satura inpoi; un uso, in altri termini, che è categoricamente oppositivo in fatto disegno semantico, ma permanente quanto all’identificazione ideologica.L’esemplare rappresentativo costituito dalla figura di Esterina varrà ad illu-strare meglio questi appunti.
182 I saggi
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 182
2. Primo personaggio, almeno tra quelli nitidamente disegnati, a compariresulla scena degli Ossi,7 l’Esterina di Falsetto,ossia l’«equorea creatura / che lasalsedine non intacca», è colei che il soggetto enunciante della lirica contem-pla – si direbbe a distanza di sicurezza – avanzare sopra un trampolino pro-teso verso il mare, esitare un istante, felice nella condizione giovanile e nellasolare quinta marina in cui muove,per poi tuffarsi tra i flutti del proprio dio.
Esterina, i vent’anni ti minacciano,grigiorosea nubeche a poco a poco in sé ti chiude.Ciò intendi e non paventi.Sommersa ti vedremo 5nella fumea che il ventolacera o addensa, violento.Poi dal fiotto di cenere usciraiadusta più che mai,proteso a un’avventura più lontana 10
183Riccardo Stracuzzi
7 Se si eccettua l’attante-ombra evocato in funzione puramente passiva nella inaugurale In limi-ne, e identificabile solo entro la ricca tessitura verbale e pronominale del componimento, taloratanto concitata da mettere in risalto l’istanza del livello perlocutivo: «Godi se il vento», «Il frulloche tu senti», «vedi che si trasforma», «Se procedi t’imbatti / tu forse nel fantasma», «Cerca unamaglia rotta», «tu balza fuori, fuggi!» «Va, per te l’ho pregato», «ora la sete / mi sarà lieve» (vv. 1,6, 8, 11-12, 15, 16, 17 e 18. Cfr. OV p. 3). Esso fungerebbe da chiave anticipata di quella inclina-zione neostilnovistica, qui solo prefigurata, che soggiace alla poetica montaliana nelle Occasio-ni e in parte della Bufera. Così interpretano comunemente gli esegeti, anche sulla scorta delparallelo con Crisalide (vv.71-75) e con Casa sul mare (vv.24-37),sempre negli Ossi (OV pp.85-87 e 91-92). E così infatti le glosse recenti: cfr. T.Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi diseppia, Roma, Carocci, 2001, pp. 25-28; ed E. Montale, Ossi di seppia, a cura di P. Cataldi e F. d’A-mely, Milano, Mondadori, 2003, pp. 5-6. L’attante-ombra, altrimenti, sarebbe da identificare neldestinatario stesso del messaggio verbale, ed In limine sarebbe allora una vera e propria allo-cuzione al lettore, come vuole G. Contini, Pour présenter Eugenio Montale (1946), ora in Unalunga fedeltà.Scritti su Eugenio Montale,Torino,Einaudi,1974,p.68. Isolata,a quanto mi costa,la lettura di B. Porcelli, Una lettura di “Riviere” e anche di “In limine”, in «Lettere Italiane», LII,2000,n.4,pp.611-623,che prospetta una partizione simbolico-dialogica degli attanti per cui l’in-vito alla fuga, e dunque alla salvezza, non perverrebbe dal poeta o, per dir meglio, dal locutorecui si attribuisce discorso nel resto del libro, bensì da un locutore (qui locutrice) che parlereb-be in quest’unico caso. Ciò, da un lato spiegherebbe più economicamente perché la funzionesalvifica sia affidata,qui,all’attante portatore del desiderio e non all’oggetto di esso,in sottile con-traddizione con ogni schema stilnovistico ove,giocoforza,è il visiting angel a esplicare tale fun-zione (ma si mediti su questa osservazione: «Di qui, anche, lo statuto potenzialmente ambiguodel tu, e il fatto che un’evidente proiezione dell’autore come l’Arsenio della lirica omonimapoteva ricoprire almeno in parte [...] funzioni analoghe a quelle che, in altre liriche degli Ossi(per esempio,Casa sul mare),erano tipicamente delegate alla donna»:cfr.P.V.Mengaldo,La «Let-tera a Malvolio», ora in La tradizione del Novecento. Seconda serie,Torino, Einaudi, 20032, p.255, corsivo dell’autore). D’altro lato, vedere nel locutore di In limine la donna: a) impliche-rebbe il ravvisare in questi versi una specie di hapax drammatico nella poesia montaliana, se sieccettuasse ovviamente Voce giunta con le folaghe della Bufera o le tre Botta e risposta diSatura, ove però l’interferenza dialogica ha statuto peritestuale, impressa com’è nel titolo e nelritrovato tipografico (i trattini in apertura e chiusura del segmento in cui interviene la voce altruio le virgolette): vd.R.Bettarini,Sacro e profano, in Montale e il canone…, cit.,p.43 ed E.Testa,Un saluto a Montale, ivi,p.438;b) deciderebbe dell’esistenza di una sorta di esprit de systèmeneostilnovistico già nel “giovane”Montale,di contro ai tratti che suggeriscono invece di una pro-gressiva evoluzione; e c) costringerebbe alla ricerca di nuove e tortuose delucidazioni dei versidi Crisalide e di Casa sul mare cui si accennava dianzi.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 183
l’intento viso che assembral’arciera Diana.Salgono i venti autunni,t’avviluppano andate primavere;ecco per te ritocca 15un presagio nell’elisie sfere.Un suono non ti rendaqual d’incrinata broccapercossa!; io prego siaper te concerto ineffabile 20di sonagliere.
La dubbia dimane non t’impaura.Leggiadra ti distendisullo scoglio lucente di salee al sole bruci le membra. 25Ricordi la lucertolaferma sul masso brullo;te insidia giovinezza,quella il lacciòlo d’erba del fanciullo.L’acqua è la forza che ti tempra, 30nell’acqua ti ritrovi e rinnovi:noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo,come un’equorea creaturache la salsedine non intaccama torna al lito più pura. 35
Hai ben ragione tu! Non turbaredi ubbie il sorridente presente.La tua gaiezza impegna già il futuroed un crollar di spalledirocca i fortilizî 40 del tuo domani oscuro.T’alzi e t’avanzi sul ponticelloesiguo, sopra il gorgo che stride:il tuo profilo s’incidecontro uno sfondo di perla. 45Esiti a sommo del tremulo asse,poi ridi, e come spiccata da un ventot’abbatti fra le bracciadel tuo divino amico che t’afferra.
Ti guardiamo noi, della razza 50di chi rimane a terra.8
La lirica costituisce il quarto “pezzo” della sezione Movimenti, e infatti alvocabolario musicale appartiene il titolo,evidentemente piegato a una meta-
184 I saggi
8 Falsetto, in Ossi di seppia, OV pp. 11-12.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 184
foresi più indiretta o più mediata che non sia, per esempio, nel precedenteCorno inglese (unico residuo della già citata serie giovanile degli Accordi) onel successivo Minstrels.9 Qui la “voce di testa”, che il cantante maschileimpiega per imitare il timbro femminile, definirà a un primo livello la melo-dia ironica e bonaria su cui si modula il ritratto di Esterina: melodia cui con-corrono anche le frequenti assonanze, consonanze e rime baciate, o comun-que prossime (nUBE: chiUDE; pavENTI: vENTO: violENTO; usciRAI: mAI; lontANA:DiANA; primavERE: sfERE: sonagliERE; rintOCCA: brOCCA; brULLO: fanciULLO; crea-tURA: pURA; futURO: oscURO; spALLE: ponticELLO; strIDE: s’incIDE; brACCIA: rAZZA;t’affERRA: tERRA). Più puntualmente, a un secondo livello, il “falsetto” potràanche significare il doppio movimento di immedesimazione/distanziamentoche il locutore stabilisce con l’oggetto femminile del suo discorso.E infatti la stessa sequenza argomentativa del discorso che la poesia costi-tuisce si muove in una sorta di andare e venire del fuoco; una disconti-nuità, cioè, nella quale sono accostati due tipi enunciativi tra loro bendiscernibili: la definizione e il racconto, inteso quest’ultimo in sensominimo, in quanto racconto di gesti. Cosicché, pur entro l’andamentoassertivo del discorso e l’esteriore indistinzione del tempo verbale (il pre-sente), il discrimine cadrà sul tempo che regola il rapporto tra enuncia-tore ed enunciazione: tempo pregresso all’enunciazione, nel primo tipo;e invece coincidente nel secondo.La prima strofe del componimento (vv. 1-21) fornisce al destinatario deldiscorso, infatti, informazioni circa una figura di donna sulla quale nulla èsaputo: si tratta insomma di una sorta di prolessi definitoria o interpreta-tiva che accompagna una descrizione morale («Esterina, i vent’anni timinacciano / grigiorosea nube che a poco a poco in sé ti chiude. / Ciòintendi e non paventi») con una epitome gnomica prima («Sommersa tivedremo / nella fumea che il vento / lacera e addensa, violento. / Poi dalfiotto di cenere uscirai / adusta più che mai» ecc.), e poi con un auspicio(«Ecco per te rintocca / un presagio nell’elisie sfere. / Un suono non tirenda / qual d’incrinata brocca» ecc.). La tonalità del fraseggio è ottenu-ta per via di metafore preziose e ironiche di derivazione classica o neo-classica, in cui si rincorrono il registro alto («grigiorosea nube»; «adusta»,«l’arciera Diana», «elisie sfere»), gli écarts nel linguaggio umile («i vent’an-ni», «qual d’incrinata brocca», ma qui si noti l’inversione combinata con illessico corsivo; «concerto ineffabile / di sonagliere»), l’anfibologia («sal-gono i venti autunni, t’avviluppano andate primavere») e i rinvii citatò-ri («l’intento viso che assembra», dal topico “occhi intenti”).10
185Riccardo Stracuzzi
9 Il quale ha per esergo «da C.Debussy»,e incipit decisamente in medias res: «Ritornello, rim-balzi / tra le vetrate d’afa dell’estate. / Acre groppo di note soffocate, / riso che non esplode/ ma trapunge le ore vuote / e lo suonano tre avanzi di baccanale / vestiti di ritagli di gior-nali, / con istrumenti mai veduti» ecc. Cfr. OV p. 14.10 Vd. e.g. il leopardiano: «Che gli occhi al suol tuttora intenti e fissi» (Il primo amore v. 4); eil D’Annunzio di Maia XIX vv. 270-271: «E tu m’assempri l’iddia / parrasia»).Traggo gli esem-pi da T.Arvigo, Guida alla lettura…, cit., p. 44.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 185
Al tipo della definizione, eminentemente povera di valori denotativi, cheoccupa l’intera prima strofe, fa seguito nella seconda strofe (vv. 22-35) unacommistione dei due tipi:dopo il v.22 («La dubbia dimane non t’impaura»),che ha funzione di compedio e di ripresa del già detto, segue il segmentodescrittivo-narrativo dei soli vv. 23-25 («Leggiadra ti distendi / sullo scogliolucente di sale / e al sole bruci le membra»); da ciò procede – per media-zione di una similutidine («Ricordi la lucertola / ferma sul masso brullo; teinsidia giovinezza, / quella il lacciòlo d’erba del fanciullo») – un nuovo seg-mento di definitorio (vv. 30-35), anch’esso di raffinata costituzione ironica:gnóme fornita di iterazioni, vale a dire di parallelismi anaforici e di paro-nomasia («L’acqua è la forza che ti tempra, / nell’acqua ti ritrovi e ti rin-novi»); similitudine sacrale con voci lessicali umili di contro alle neoclassi-che («noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo, / come un’equorea crea-tura / che la salsedine non intacca / ma torna al lito più pura»).La terza strofe (vv. 36-49), poi, si apre sul modo in cui chiudeva la prece-dente, onde l’assenso anche esclamativo del locutore, non senza arrière-pensée ironica, e quindi distanziante nei confronti dell’istanza morale cheabita Esterina, così come il discorso riflessivo è venuto appurando (vv. 36-41): «Hai ben ragione tu! Non turbare / di ubbie il sorridente presente. /La tua gaiezza impegna già il futuro» ecc.; a ciò segue un secondo seg-mento descrittivo-narrativo, più esteso di quello precedente (vv. 42-49), etuttavia piegato come prima a una patente intenzione ironica, sicché rile-vano le nobilitanti perifrasi («ponticello / esiguo» e «tremulo / asse» per“trampolino”, «gorgo che stride» per “mare che ondeggia rumoroso” e«t’abbatti fra le braccia / del tuo divino amico che t’afferra» per “ti tuffi nelmare e ti ci immergi”) e la suspense ecfrastica ottenuta per analogia («iltuo profilo s’incide / contro uno sfondo di perla») e per similitudine («ecome spiccata da un vento»).La quarta e terminale strofe (vv. 50-51), da ultimo, costituisce la massimasintesi speculare dell’avvicendamento tipologico sinora descritto e, inquesto modo, si configura quale chiave anche tonale dell’intera poesia: aun primo segmento descrittivo-narrativo («Ti guardiamo noi, [...]») cheprosegue quello su cui si chiude la strofa precedente, si congiunge un seg-mento definitorio («[...] della razza / di chi rimane a terra»), in questounico caso qualificativo del locutore, attraverso l’identificazione – lettera-le non meno che metaforica – di un tipo umano cui egli asserisce di appar-tenere.Alla virtuosistica binarietà discorsiva dei due versi brevi (novena-rio e settenario), fa del resto complemento un preciso abbassamento diregistro («guardare», «razza», «rimanere a terra») che raddoppia l’effetto bra-chilogico, e colloca in explicit quella immagine desublimante, e scabraessa stessa, che funge da vera somma del discorso.Una volta riprodotta orizzontalmente la trama enunciativa di cui è costrui-ta Falsetto, avvertiamo che i due tipi enunciativi isolati, quello definitorioe quello narrativo, possono essere latamente ascrivibili ai componentiargomentativi del tema e del rema. Il secondo, nel suo effetto commen-
186 I saggi
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 186
tante, sarà da identificare nel tipo definitorio, il quale ha nella poesia ruolopreponderante e inaugurale; mentre il primo, ridotto a posizione subalter-na, coinciderà con il minimo di racconto attraverso cui il personaggio diEsterina ci è offerto in quanto “figura”della giovinezza.11 Non dovrà attrar-re il nostro sguardo, in modo particolare, l’inversione per cui il topic segueal comment con esito referenziale ridotto al minimo: in ciò, verosimil-mente, si misura la jakobsoniana funzione poetica del linguaggio.12 Sem-mai, è la forma che il comment acquista nel discorso a suscitare maggio-re interesse: come se la strategia essenzialmente dilatoria, ovvero divina-toria, similitudinaria, icastica ecc., che il discorso implica, tendesse a ruo-tare su un solo fulcro constatativo («Esterina, i vent’anni ti minacciano», «teinsidia giovinezza») e sull’atteggiamento di Esterina a ciò connesso («Ciòintendi e non paventi», «La dubbia dimane non t’impaura», «Hai ben ragio-ne tu! Non turbare / di ubbie il sorridente presente»).
3. Ha fatto scuola l’asserzione di Sanguineti secondo cui Falsetto debbacollocarsi in puntuale discendenza da Invernale di Gozzano:13 Esterina,dunque, sarebbe una rilettura dell’audace pattinatrice gozzaniana.
«… cri… i… i… i… icch»… l’incrinatura
il ghiaccio rabescò, stridula e viva.«A riva!» Ognuno guadagnò la rivadisertando la crosta malsicura.«A riva! A riva!...» un soffio di paura 5disperse la brigata fuggitiva.
«Resta!» Ella chiuse il mio braccio conserto,le sue dita intrecciò, vivi legami,alle mie dita. «Resta, se tu m’ami!»E sullo specchio subdolo e deserto 10soli restammo, in largo volto aperto,ebbri d’immensità, sordi ai richiami.
187Riccardo Stracuzzi
11 La figura, in effetti, è la concrezione processuale di una fictio; così G. Genette in Métalp-se. De la figure à la fiction, Paris, Seuil, 2004, pp. 16-17: «les noms fictio et figura, ancêtresde nos fiction et figure, dérivent tous deux de ce verbe, dont ils désignent plutôt, dans lamesure où l’on peut distinguer leur dénotations, le premier l’action, le second le produit, oul’effet de cette action».12 Penso specialmente alla nota definizione: «La funzione poetica proietta il principio d’e-quivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa algrado di elemento costitutivo della sequenza». R. Jakobson, Linguistica e poetica, in Saggi dilinguistica generale, Milano, Feltrinelli, 20024, p. 192.13 «Questa donna (la mulier fortis secondo Pancrazi) che in Gozzano non ha nome, troveràfinalmente, e non passeranno neppure troppi anni, in Montale, un nome: è l’Esterina appun-to, di Falsetto; quell’Esterina (mulier fortis anch’essa, infatti, e per uguali titoli) colta, comel’anonima figura dei Colloqui, in una situazione sportiva,di sportivo coraggio,donna che nonpaventa e che si butta in acqua». E. Sanguineti, Da Gozzano a Montale (1954), in Tra libertye crepuscolarismo, Milano, Mursia, 19902, pp. 33-34. Invernale uscì in rivista su «La Lettura»nel gennaio del 1910, per essere ristampata l’anno dopo nella compagine dei Colloqui.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 187
Fatto lieve così come uno spetro,senza passato più, senza ricordo,m’abbandonai con lei, nel folle accordo, 15di larghe rote disegnando il il vetro.Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro...dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo...
Rabbrividii così, come chi ascoltilo stridulo sogghigno della Morte, 20e mi chinai, con le pupille assorte,e trasparire vidi i nostri voltigià risupini lividi sepolti...Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più forte...
Oh! Come, come, a quelle dita avvinto, 25rimpiansi il mondo e la mia dolce vita!O voce imperïosa dell’istinto!O voluttà di vivere infinita!Le tue dita liberai da quelle dita,e guadagnai la ripa, ansante e vinto... 30
Ella sola restò, sorda al suo nome,rotando a lungo nel suo regno solo.Le piacque, alfine, ritoccare il suolo;e ridendo approdò, sfatta le chiome,e bella ardita palpitante come 35la procellaria che raccoglie il volo.
Non curante l’affanno e le ripresedello stuolo gaietto femminile,mi cercò, mi raggiunse tra le filedegli amici con ridere cortese: 40«Signor mio caro, grazie!» E mi protesela mano breve, sibilando: – Vile! –14
Anche di là dal mero sfondo sportivo (il pattinaggio da un lato, dall’altro ilnuoto), gli accostamenti possibili sono in tutto tre, benché specifici: li dis-pongo qui uno in seguito all’altro: i. «“... cri...i...i...i...icch”... l’incrinatura /il ghiaccio rabescò, stridula e viva» (Invernale vv. 1-2) � «T’alzi e t’avan-zi sul ponticello / esiguo, sopra il gorgo che stride» (Falsetto vv. 42-43); ii.«“A riva!”Ognuno guadagnò la riva / disertando la crosta malsicura» e «Ledita liberai da quelle dita, / e guadagnai la ripa, ansante, vinto...» (Inver-nale vv. 3-4 e 29-30) � «Ti guardiamo noi, della razza / di chi rimane a
188 I saggi
14 G. Gozzano, Poesie. «La via del rifugio», «I colloqui», «Le farfalle» e «Poesie sparse», a curadi E. Sanguineti,Torino, Einaudi, 1973, pp. 100-102. Bàrberi Squarotti, però, eccepisce circa lalezione dell’onomatopea in incipit, per ragioni metriche, e legge …cri…i…i…i… ‹i…› icchin luogo di …cri…i…i…i…icch: cfr. Id., Poesie, a cura di G. Bàrberi Squarotti, Milano, Rizzo-li, 19884, p. 147.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 188
terra» (Falsetto vv. 50-51); iii. «Le piacque, alfine, ritoccare il suolo; / eridendo approdò, sfatta le chiome, / e bella ardita palpitante come / laprocellaria che raccoglie il volo» (Invernale vv. 33-36), sequenza da cuiprocederebbe, previo processo d’inversione, � «Esiti a sommo del tremu-lo asse, / poi ridi, e come spiccata da un vento / t’abbatti fra le braccia/ del tuo divino amico che t’afferra» (Falsetto vv. 46-49).Non c’è dubbio che la prossimità sia considerevole; e i recenti commentato-ri hanno accolto quella che Sanguineti ha avanzato con presunzione di evi-denza assoluta,ma che resta, in verità, una congettura.15 E tale rimane anchedopo aver menzionato il pur importante articolo su Gozzano che Montalepubblica tre anni prima di quello sanguinetiano, nel quale è detto, tra l’altro,che «i suoi versi più belli (e sono molti) cantano ma non cantano liricamen-te come i versi migliori del D’Annunzio e del Pascoli, e più che cantare rac-contano, descrivono, commentano», giacché «egli era nato per essere uneccezionale narratore o prosatore in versi»;nel che è facile scorgere una sortadi volontario autoritratto,non privo di una presa di distanza però,se poi vi siaggiunge:«un verso che sia anche prosa è il sogno di tutti i poeti moderni daBrowning in poi;è il sogno che torni ad essere possibile quell’integrità di stileche fa di Dante e Shakespeare i più nuovi e i più attuali poeti.Ora, il verso diGozzano non è di questa natura; è un verso parnassiano, e tutti i poeti par-nassiani (non vedo eccezioni) sono soprattutto dei prosatori in verso».16
Ciò considerato, merita ascoltare anche l’opinione del più fiero avversa-tore della congettura sanguinetiana, e cioè Sergio Solmi, il quale nel 1957scrive che «l’Esterina di Falsetto può lontanamente arieggiare la cardarel-liana Adolescente (anche quest’ultima una sorta di energica ripresa medi-tativa e gnomica sul disfacimento della sensualità dannunziana)»; e, annidopo, in una lettera a Caretti, che Cardarelli «ci affascinava, direi, in modosproporzionato [...]. Basti pensare a Esterina di Montale e raffrontarla conAdolescente (Montale non disconosceva il rapporto, mentre non c’entranulla il Gozzano dell’Invernale, come vorrebbe il Sanguineti)».17
189Riccardo Stracuzzi
15 Decisamente persuasi, su questo,Cataldi e d’Amely, in E.Montale,Ossi di seppia, cit., p.18;persuasa ma più circospetta, invece,T. Arvigo, Guida alla lettura..., cit., pp. 42-44, la qualepropone una serie di altri testi a riscontro:Adolescente di Cardarelli (sulla scia di Solmi) dellaquale si dirà oltre; il Proust delle Jeunes filles en fleur; il Linati di Portovenere; e, in funzionepiù marginale, Zanella e Poliziano, su indicazione di F. Bausi, Una donna di Montale: «Este-rina», in «Studi italiani»,VI, 1994, 2, pp. 119-128.16 E. Montale, Gozzano, dopo trent’anni (1951), ora in Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, Milano, Mondori, 1996, t. I, pp. 1274-1275.Assai restrittivo circa imeriti e la novità della scrittura di Gozzano è anche il modo con cui Montale avanza l’argo-mento, notoriamente caro a Sanguineti, dell’“attraversamento di D’Annunzio”: «egli [scil.Gozzano] fu il primo dei poeti del Novecento ad attraversare D’Annunzio per approdare aun territorio suo, così come, su scala maggiore, Baudelaire aveva attraversato Hugo [...]. Ilrisultato fu certo più modesto: un album di vecchie stampe che resterà, nel primo Novecen-to, come Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand resterà nel primo Ottocento francese» (ivi,p. 1279; i corsivi, qui e sopra, sono dell’autore).17 Il primo passo è estratto da S. Solmi, La poesia di Montale (1957), ora in G. Pacchiano (acura di), La letteratura italiana contemporanea, Milano,Adelphi, 1992, t. I, p. 372; il secon-do è cit. in G. Ioli, Montale, Roma, Salerno, 2002, p. 67.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 189
Ora, una volta accostate Adolescente e Falsetto, possiamo rilevare unnumero di congiunture tematiche non inferiore di quelle viste in Gozza-no, e anzi superiore; a patto, tuttavia, di voler ammettere nel testo monta-liano una specie di “trattamento” del possibile modello.
Su te, vergine adolescente,sta come un’ombra sacra.Nulla è più misteriosoe adorabile e propriodella tua carne spogliata. 5Ma ti recludi nell’attenta vestee abiti lontanocon la tua graziadove non sai chi ti raggiungerà.Certo non io. Se ti veggo passare 10a tanta regale distanza,con la chioma scioltae tutta la persona astata,la vertigine mi si porta via.Sei l’imporosa e liscia creatura 15cui preme nel suo respirol’oscuro gaudio della carne che appenasopporta la tua pienezza.Nel sangue, che ha diffusionidi fiamma sulla tua faccia, 20il cosmo fa le sua risacome nell’occhio nero della rondine.La tua pupilla è bruciatadel sole che dentro vi sta.La tua bocca è serrata. 25Non sanno le mani tue biancheil sudore umiliante dei contatti.E penso come il tuo corpodifficoltoso e vagofa disperare l’amore 30nel cuor dell’uomo!
Pure qualcuno ti disfiorerà,bocca di sorgiva.Qualcuno che non lo saprà,un pescatore di spugne, 35avrà questa perla rara.Gli sarà grazia e fortunail non averti cercatae non sapere chi seie non poterti godere 40con la sottile coscienzache offende il geloso Iddio.
190 I saggi
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 190
Oh, sì, l’animale saràabbastanza ignaroper non morire prima di toccarti. 45
E tutto è così.Tu anche non sai chi sei.E prendere ti lascerai,ma per vedere come il gioco è fatto,per ridere un poco insieme. 50Come fiamma si perde nella luce,al tocco della realtài misteri che tu promettisi disciolgono in nulla.Inconsumata passerà 55tanta gioia!Tu ti darai, tu ti perderai,per il capriccio che non indovinamai, col primo che ti piacerà.Ama il tempo lo scherzo 60che lo seconda,non il cauto volere che indugia.Così la fanciullezzafa ruzzolare il mondoe il saggio non è che un fanciullo 65che si duole d’essere cresciuto.18
Ecco un elenco di questi punti: i. «Su te, vergine adolescente, / sta comeun’ombra sacra» (Adolescente, vv. 1-2) � «Esterina, i vent’anni ti minac-ciano, / grigiorosea nube / che a poco a poco in sé ti chiude» (Falsetto,vv. 1-2: si noti la comune sede incipitaria delle due immagini); ii. «e abitilontano / con la tua grazia / dove non sai chi ti raggiungerà» (Adole-scente, vv. 7-9) � «Ti guardiamo noi, della razza / di chi rimane a terra»(Falsetto, vv. 50-51); iii. «[...] Se ti veggo passare / a tanta regale distanza, /con la chioma sciolta / e tutta la persona astata, / la vertigine mi si portavia» (Adolescente, vv. 10-14) � «il tuo profilo s’incide / contro uno sfon-do di perla» (Falsetto, vv. 44-45, ove la blanda descrizione di un’altera bel-lezza in Cardarelli è tramutata, da Montale, in un disegno di concisionequasi numismatica); iv. «La tua pupilla è bruciata / del sole che dentro vista» (Adolescente, vv. 23-24) � «e al sole bruci le membra» (Falsetto, v. 25);v. «Gli sarà grazia e fortuna / il non averti cercata / e non sapere chi sei /e non poterti godere / con la sottile coscienza / che offende il gelosoIddio» (Adolescente, vv. 37-42) � «t’abbatti fra le braccia / del tuo divino
191Riccardo Stracuzzi
18 Adolescente comparve una prima volta in rivista, nel fasc. speciale di «Lirica» del Natale1913, per essere poi ristampata nel volume Prologhi del 1916 insieme con altre tredici liri-che e con sedici prose: cfr. V. Cardarelli, Opere, a cura di C. Martignoni, Milano, Mondadori,1981, pp. 9-10 e 1007.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 191
amico che t’afferra» (Falsetto, vv. 48-49; anche qui un procedimento difocalizzazione tropica:dal generico paganesimo di Cardarelli,unito all’ideadi una appartenenza tradita, sino all’identificazione montaliana, sottopostapoi a funzionalizzazione narrativa, di una speciale divinità marina); vi.«Come fiamma si perde nella luce / al tocco della realtà / i misteri che tuprometti / si disciolgono in nulla» (Adolescente, vv. 51-54), che in bloccoriecheggia in � «ecco per te rintocca / un presagio nell’elisie sfere. / Unsuono non ti renda / qual d’incrinata brocca / percossa!; io prego sia / perte concerto ineffabile / di sonagliere» (Falsetto, vv. 15-21), così come lagnóme che conclude il segmento vii. «Tu ti darai, tu ti perderai, / per ilcapriccio che non indovina / mai, col primo che ti piacerà. / Ama iltempo lo scherzo Á che lo seconda, Á non il cauto volere che indugia»(Adolescente, vv. 57-62), è rivalutata nell’assenso ironico montaliano �«Hai ben ragione tu! Non turbare / di ubbie il presente. / La tua gaiezzaimpegna già il futuro / ed un crollar di spalle / dirocca i fortilizi / deltuo domani oscuro» (Falsetto, vv. 36-41).
4. Messi in luce alcuni fatti testuali – i quali permettono un’approssima-zione di Falsetto tanto a Invernale quanto ad Adolescente – credo si possagiungere ad una identificazione di compromesso: le osservazioni di San-guineti e di Solmi non sono tali da escludersi vicendevolmente; anzi, giu-stamente bilanciate, e commisurate all’analisi di tipologie enunciativeabbozzata sopra, le due segnalazioni possono farsi complementari. E ciònon tanto in vista di una pretta registrazione degli influssi subìti dal “gio-vane” Montale, il che resterebbe conquista alquanto estrinseca; bensì perla delineazione di un certo modo di appropriazione di un motivo e dellaconseguente riformulazione tematica.Dapprima, si potrà confrontare l’uno e l’altro ipografo in rapporto almedio successivo costituito da Falsetto; e si vedrà così che gli spunti trat-ti da Gozzano sono in realtà assai pochi, ma abbastanza precisi (con qual-che specifico ritorno lessicale), laddove la materia recuperata da Carda-relli offre una più ampia gamma di oggetti tematici, ognuno dei quali èperò meno nitido e invece sottoposto a un forte trattamento (inversionecronologica, specificazione tropica, condensazione, trattamento narrativodello gnomico ecc.). D’altro canto, mentre Adolescente è assai prossimaalla lirica di Montale per il tono meditante-riflessivo, risolto nella secondanel più secco tipo definitorio, ma in sostanza adibito alla medesima rifor-mulazione di un canonico ubi sunt; Invernale, invece, risulterà prestarealla poesia montaliana una specie di occasione narrativa, dotata per giun-ta di quel retrotesto ironico che il lettore,però,deve meno constatarvi cheimmettervi. La squadrata novelletta psicologica che Gozzano offre conInvernale, infatti, è recuperabile alla poetica anti-dannunziana – ovveroalla critica di una piccola-borghesia dagli ardori velleitari – solo per via diuna esteriore posizione di contiguità con altri versi dei Colloqui. In sestessa, la poesia è priva di significativi effetti di contro-determinazione o
192 I saggi
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 192
di antifrasi,19 a meno di non inquadrare sotto questo rispetto l’onomato-pea dell’incipit – «... cri... i... i... i... icch» o «... cri... i... i... i... i... icch» che sia– in ragione del suo evidente ammicco a Dante (Inf. XXXII, 30). Sicché,finalmente, lo spunto ironico che da Gozzano giunge a Montale è davvero“parnassiano”in senso narrativo,e quest’ultimo lo riprende soltanto per lafacile cornice discorsiva che fornisce. L’audace pattinatrice di Gozzano,per giunta, non è significativamente attinta dai segni di “giovinezza”; altroè lo schema figurale: evidentemente la spericolata eroina dannunziana,agonistica e assetata di un thanátos debolmente erotico; schema qui nonsottoposto a evidente processo demistificatorio, e comunque poco perti-nente all’immaginario montaliano.Il modello più fruttuoso per Falsetto, dunque, è proprio Adolescente diCardarelli: sia riguardo alla questione del motivo della “giovinezza” in sé,sia riguardo al modo tematico del riuso, da trattare tanto più precisamen-te quanto più esso è rilevante ideologicamente. Donde la spiegazione delperché Montale recuperi da Cardarelli un numero maggiore di “argomen-ti” rispetto a Gozzano, e però li sottoponga a una maggiore manipolazio-ne. Sembra di poter rintracciare, in piccolo e in termini sincronici, qual-cosa di simile a quello che Lonardi sostiene, in grande e in termini dia-cronici, quando argomenta circa la presenza di Leopardi in Montale; e undiagramma che accosti funzionalmente Cardarelli a Leopardi non è, contutta evidenza, fortuito.Tale presenza, infatti, si configura quale “basso con-tinuo” e non sempre in termini di ritagliabile ripresa di luoghi specifici:«per la funzione-Leopardi bisognerebbe parlare non di un segmento tem-porale, ma di una durata abbastanza continua e diffusa, da riuscire pro-prio per questo meno soddisfacentemente esemplificabile per emersioniesemplari [...]: comunque una durata meno esposta, meno generalmentevisibile nei segni vivi o di folte presenze di lessico e rima, o di altri consi-stenti modi affini di impaginazione poetica, e insomma più tenace e con-tinua quanto più, sostanzialmente, coperta».20
Nel caso specifico, infatti, la pietra angolare ideologica su cui poggia ladeclinazione montaliana del motivo della “giovinezza”,qui e negli altri luo-ghi dei quali si dirà brevemente, è proprio da Cardarelli estratta o, meglioe con rapida anticipazione, da altri che Cardarelli a sua volta riprende e
193Riccardo Stracuzzi
19 Nel che si può forse scorgere la troppo univoca funzionalizzazione simbolica e ideologicacon cui Sanguineti, e alcuni successivi interpreti, hanno uniformato in poetica novatrice laprassi scrittoria non sempre risolta di Gozzano; insomma, estenderei all’intera écriture goz-zaniana ciò che Contini – nella Letteratura dell’Italia unita (1861-1968), Firenze, Sansoni,1983, p. 636, evidentemente alludendo polemicamente ad alcune annotazione di RenatoSerra (cfr. Le lettere, introduzione, revisione testuale e commento di U. Pirotti, Ravenna,Longo, 1989, pp. 128-33) – asserisce circa una sopravvalutazione della sua perizia metrica. Diuna difficile situazione di Gozzano tra Otto e Novecento, discute ampiamente N. Lorenzini,specialmente nel quinto paragrafo (Valutazione critica) del suo «I colloqui» di Guido Goz-zano, in A.Asor Rosa (diretto da), Letteratura italiana. Le Opere, vol. IV, Il Novecento, t. II,L’età della crisi,Torino, Einaudi, 1995, pp. 168-72.20 G. Lonardi, Il Vecchio e il Giovane..., cit., p. 96 (corsivo dell’autore).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 193
riformula. La constatazione a partire dalla quale l’intero ritratto morale diEsterina trova i suoi termini – e anzitutto l’angolatura attraverso cui la figu-ra è vista, ossia quella che, con spedito carrello all’indietro, il distico fina-le rivela – coincide con la minaccia e con l’insidia della “giovinezza”.21
Sotto questo rispetto, l’incipit di Adolescente e di Falsetto andranno dav-vero rivisti in colonna, per apprezzare come l’ombra sacra che gravitasulla vergine (e anonima) adolescente di Cardarelli si trasformino, pereffetto di una metafora più riccamente plasmata, nella grigiorosea nubeche minaccia Esterina, ove i vent’anni di quest’ultima configuranoinsomma la soglia climaterica varcata la quale la giovinezza non sarà più:«Tu ti darai, tu ti perderai», avrebbe detto Cardarelli.La rilettura quasi membro a membro si chiude qui, però; giacché in seguitoMontale, a parte una serie di ridotte riprese di dettaglio, elabora e attenuaciò che la poesia di Cardarelli, alquanto querula,predica apertis verbis dellaminaccia e dell’insidia.22 Sicché le strofi seconda e terza di Adolescente –occupate da un’estesa profezia circa la perdita della verginità, e chiuse dauna stereotipata sentenza trimembre: a) «Ama il tempo lo scherzo / che loseconda, / non il cauto volere che indugia»; b) «Così la fanciullezza / fa ruz-zolare il mondo»;c) «e il saggio non è che un fanciullo / che si duole di esse-re cresciuto» – sono riprese in due luoghi di tenore decisamente antifrasti-co, benché in fondo non meno sentenzioso: «Un suono non ti renda / quald’incrinata brocca» ecc., e «Hai ben ragione tu!», con quello che segue.
5. Falsetto non è l’unica poesia degli Ossi a fornire materiale significanteper una inquirente lettura del motivo della “giovinezza” in Montale: altritesti potrebbero essere convocati, ed essi confermerebbero, credo, l’istan-za di una equivalenza rematica fissa: tema della “giovinezza” uguale“minaccia”,“insidia” e così via. Uno sguardo sul Montale da Satura in poi,invece,condurrebbe soprattutto a equazioni differenti, del genere di: temadella “giovinezza” uguale “inganno” o “derisione”.23
È il caso, per esempio, dello «smarrito adolescente» di Riviere che inclinaal cupio dissolvi, ovvero all’estasi di reificazione: «Dolce cattività, oggi,riviere / di chi s’arrenda per poco / come a rivivere un antico giuoco /non mai dimenticato. / Rammento l’acre filtro che porgeste / allo smarri-to adolescente, o rive»; «Oh allora sballottati / come l’osso di seppia dalleondate / svanire a poco a poco; / diventare / un albero rugoso od una
194 I saggi
21 Termini ideologicamente determinati che mancano,et pour cause, in Invernale di Gozzano.22 E, tanto per dire, il tema erotico, quasi pre-nabokoviano, della perdita della verginità ses-suale come perdita di purezza misteriosa, come appannamento morale.23 Il che, in ultima analisi, descriverebbe un certo discrimine temporale: un prima e un dopoper i quali la “giovinezza” e “minaccia” per chi è giovane; mentre è “inganno” e “derisione”(ossia “minaccia” in qualche modo mandata a effetto) per chi giovane non lo è più. Di dis-crimine temporale si deve dire, si badi bene, e non biografico: perché i due compossibilisemantici tendono a convivere già negli Ossi, così come commisti si ripresenteranno daSatura in poi.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 194
pietra / levigata dal mare [...]» (Riviere, vv. 14-19 e 26-31, OV p. 101). Ed èil caso, inoltre, delle Poesie per Camillo Sbarbaro, collocate nella sezioneMovimenti degli Ossi, come Falsetto, e da essa separate solo da Minstrels.Lo Sbarbaro di Montale, com’è noto,è un «estroso fanciullo»;ma più anco-ra che l’apposizione qualificativa,24 conterà la precisa opposizione di“maledettismo” (strofi prima e seconda) e “stupor” fanciullesco (strofiterza, quarta e quinta) su cui è congegnata Caffè a Rapallo, primo mem-bro delle Poesie per Camillo Sbarbaro appunto; opposizione ripresa poiin absentia, per così dire, da Epigramma, secondo membro, che è tuttaoccupata dal tema fanciullesco. E infatti, dinanzi all’«estroso fanciullo» che«piega versicolori / carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia», illocutore si indirizza alle cure del «galantuomo che passa», perché «col suobastone raggiunga la delicata flottiglia» che rischia di perdersi, e la «guidia un porticciolo di sassi» (cfr. OV pp. 15-17). Nel che si rivede appaiata la“giovinezza” e la “minaccia”, qui ironicamente incarnate dal pericolosodestino che corrono i giovani versi di Sbarbaro.Né si dovrebbe sottovalutare, ancora, il tardivo episodio del ritorno di Annet-ta, nell’omonima lirica del Diario del ’71 e del ’72, e quindi assai fuori dagliOssi,ormai.Vi si vedrebbe come il locutore stigmatizzi con inclemenza quasigiansenistica il «genio / di pura inesistenza», l’«agnizione / reale perché assur-da», ossia la stessa Annetta così come gli appare, epifania della “giovinezza”(«stagione più ridicola / della vita») ormai trascorsa; anzi, precocementemorta: «Ma allora eri già morta / e non ho mai saputo dove e come».Vi sivedrebbe, insomma, che la “giovinezza”è per Montale da irridere perché, misi passi la piatta parafrasi,il tempo è un’illusione:non ad altro esito,del resto,giunge la gnóme laboriosa che chiude il componimento:«[...] Durare potreb-be essere / l’effetto di una droga del creato,/ in un medium di cui non si ebbemai / alcuna prova» (Annetta, vv. 41-43, 39-40 e 45-48, OV p. 491).25
Di là da una rassegna dei possibili luoghi montaliani che potrebbero esse-re fruttuosamente esplorati al fine di reperirvi ulteriori testimonianze ditale moraleggiante isotopia, credo rivesta maggior interesse ridare unaveloce occhiata all’elenco, procurato in apertura, dei lessemi intorno ai
195Riccardo Stracuzzi
24 Tuttavia ribadita in una pagina del 1967; vd. E. Montale, Ricordo di Sbarbaro, ora in Ilsecondo mestiere..., cit., t. II, p. 2866: «Poi un giorno qualcuno [...] mi presentò un giovanedi corta statura,piuttosto rubicondo,niente affatto somigliante al Des Esseintes di Huysmans,e mi disse: questo è Sbarbaro. Ho detto: un giovane, ma tra noi correvano otto anni e que-sto mi riempiva di soggezione» (Sbarbaro era nato nel 1888, Montale otto anni dopo).25 Vd. anche La storia, Il big bang dovette produrre... e Quartetto («Non credo al tempo, albig bang, a nulla / che misuri gli eventi in un prima e un dopo», vv. 12-13): le prima in Satu-ra (OV p. 315) e le altre in Altri versi (OV pp. 643 e 700). Circa il luogo di Annetta in cui illocutore lamenta «il solo mio delitto / che non so perdonarmi» (vv. 30-31), ossia l’uccisionedi un passero,ha una perspicace spiegazione G.Lonardi in Il fiore dell’addio.Leonora, Man-rico e altri fantasmi dl melodramma nella poesia di Montale, Bologna, Il Mulino, 2003, p.247: asserisce lo studioso che qui non si piange tanto l’uccisione di un animale, ma il fattoche il locutore «ha scontato la morte di quello che l’uccello-anima rappresenta: la morte (chenon è mai pacifica) dell’anima stessa divinamente giovane e intatta di lui giovane e inno-cente» (corsivi nel testo); ancora, la “minaccia mandata a effetto”.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 195
quali circola la riproposta tematica della “giovinezza” in Montale;più anco-ra che ai nudi lessemi, lo sguardo dovrà essere rivolto ai dintorni aggetti-vali, o latamente complementari, di essi. Ecco un nuovo elenco, più selet-to: a) dagli Ossi: «La farandola dei fanciulli sul greto / era la vita che scop-pia nell’arsura. / [...] Nell’età d’oro florida sulle sponde felici / anche unnome, una veste, erano un vizio» (La farandola dei fanciulli sul greto...,vv. 1-2 e 7-8, OV p. 43); «[...] al cuore che abdica / perché rida un fanciulloinconsapevole» (Crisalide, vv. 79-80, OV p. 87); «smarrito adolescente»(Riviere v. 19, OV p. 99); «Erano questi, / riviere, i voti del fanciullo antico /che accanto a una rósa balaustrata / lentamente moriva sorridendo» (ivi,vv. 34-37, OV p. 102); b) dalle Occasioni e dalla Bufera: «torni anche tu almio piede fanciulla morta / Aretusa» (L’estate, vv. 7-8, OV p. 169); «i gemitie i sospiri / di gioventù, l’errore che recinge / le tempie e il vago orror deicedri smossi / dall’urto della notte [...]» (Nel sonno, vv. 3-6, OV p. 192);26 c)da Satura in poi: «una zuffa di piume soffici, due becchi giovani / arditi einoffensivi» (Xenia II 12, vv. 7-8, OV p. 308); «[...] ero giovane / e mi cre-devo padrone della mia sorte» (Il lago di Annecy, vv. 4-5, OV p. 438); «[...]Al confronto / la gioventù è il più vile degli inganni» (Sorapis, 40 annifa, vv. 29-30, OV p. 502); «Hic manebimus se vi piace non proprio / ottima-mente ma il meglio sarebbe troppo simile / alla morte (e questa piace soloai giovani)» (Al mare (o quasi), vv. 30-32, OV p. 603).
6. Il caleidoscopio delle associazioni, come si vede, è abbastanza avaro: la“giovinezza” è più che altro smarrimento, morte, illusione, vizio, errore,inconsapevolezza,ridicolaggine, inganno.Nel che si vede una delle ragio-ni, non la più pregevole però, per cui a Montale si attribuisce giustamentela funzione di ultimo classico della poesia italiana nel Novecento: e cioè lasua tendenza a recuperare,e a nuovamente enunciare,tópoi addirittura mil-lenari della tradizione lirica in Occidente. In questa specifica circostanza, iltópos sarà quello dell’«ubi sunt», ovvero dell’«où sont les neiges d’antan» diVillon (e ovviamente del leopardiano: «Or dov’è il suono / di que’ popoliantichi? or dov’è il grido / de’nostri avi famosi,e il grande impero / di quel-la Roma, e l’armi, e il fragorio / che n’andò per la terra e l’oceani?», in Lasera del dì di festa, vv. 33-37) ecc., per il quale però si potrebbe trovare uncapo determinato nelle caduche fuvlla?????? di Mimnermo. Esso giunge aMontale per mille mediazioni, ovviamente; ma probabilmente rilevante è ilruolo di Leopardi in questo senso e,nel caso di Esterina,dell’ulteriore attua-lizzazione fornita da Cardarelli con Adolescente.
196 I saggi
26 Qui l’accostamento sintattico tra “gioventù”ed “errore”è manifestamente estrinseco, ma lamera contiguità, in quanto fenomeno del significante, non è da sottostimare; Isella rinvia, per«errore che recinge / le tempie», a Inf. III, 31: «Ed io ch’avea d’error la testa cinta»: vd. E. Mon-tale, Finisterre (versi del 1940-42), a cura di D. Isella,Torino, Einaudi, 2003, p. 13, ma è diffi-cile ignorare l’attrazione semantica del petrarchesco «giovenile errore», transitato per giuntanel titolo della sezione che apre I colloqui di Gozzano e, prima, nel «giovanile error chem’abbandona» di Leopardi (Alla sua donna, v. 37).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 196
Lonardi giudica che il v.22 di Falsetto («La dubbia dimane non t’impaura»),con il quale si apre la seconda strofe della poesia, dipenda in qualchemodo dal leopardiano «assai contenta / di quel vago avvenir che inmente avevi» (A Silvia vv. 11-12).27 Ora, benché il verso di Montale siaatteggiato a una maniera citatoria quasi caricaturale, tale da renderlo assairisaltato anche in contesto tutt’altro che colloquiale o umile, il parallelorisulta alquanto dubbio.28 Non è dubbio, d’altronde, il denso numero diriprese leopardiane, queste fornite di tangenze formali ben più positiva-mente giustificabili, che Lonardi identifica in Barche sulla Marna (nelleOccasioni, OV pp. 173-174), nell’Annetta del Diario del ’71 e del ’72 (OV
p. 490-491) cui abbiamo fatto cenno dianzi, e in altre poesie.29 E infatti ilrecentissimo commento di Francesca Ricci al Diario del ’71 e del ’72 con-ferma ampiamente il forte intrico tra Annetta da un lato, e dall’altro i duecapolavori leopardiani della “giovinezza” come illusione e come morte(insidia, inganno ecc.): A Silvia e Le ricordanze.30
Circa il motivo della “giovinezza”, e anzitutto circa la non troppo distesaelaborazione tematica che Montale vi impone,credo si possa dire che Leo-pardi funziona quale sineddoche della tradizione lirica in genere,piuttostoche come preciso suggeritore di un “argomento” o dell’altro.31 E a Carda-
197Riccardo Stracuzzi
27 G. Lonardi, Il Vecchio e il Giovane..., cit., p. 89.28 Dubbio non in quanto improbabile: la congettura spunto di Lonardi è anzi, e come di con-sueto,da meditare;ma in quanto sorretto da tangenze solamente semantiche,e non anche danitide rispondenze formali.29 Ivi, pp. 86-100. Ma vd. anche G. Lonardi, Leopardismo.Tre saggi sugli usi di Leopardi dal-l’Otto al Novecento, Firenze, Sansoni, 19902, pp. 57-62, 127-133 e passim.30 F. Ricci, Guida alla lettura di Montale, Diario del ’71 e del ’72, Roma, Carocci, 2005, pp.321-329, ove si rintracciano tangenze anche con la leopardiana Aspasia.31 Si deve riguardare, in questo senso, il Leopardi lirico più noto: quello di Nelle nozze dellasorella Paolina («Poi che del patrio nido / i silenzi lasciando,e le beate / larve e l’antico error[...]», vv. 1-3); dell’Ultimo canto di Saffo («[...] Me non asperse / del soave licor del doglioavaro / Giove, poi che perir gl’inganni e il sogno / della mia fanciullezza», vv. 62-65); delSogno («[...] ma sconsolata arriva / la morte ai giovanetti, e duro è il fato / di quella spemeche sotterra è spenta»; «Giovane son, ma si consuma e perde / la giovinezza mia come vec-chiezza», vv. 31-33 e 51-52); di Alla sua donna («ed io seggo e mi lagno / del giovanil errorche m’abbandona; / e per li poggi, ond’io rimembro e piagno / i perduti desiri, e la perduta/ speme de’ giorni miei [...]», vv. 36-40); della Vita solitaria, dove quasi si legge una parafrasidei ciò che Esterina «intende e non paventa» («[...] Era quel dolce / e irrevocabil tempo, allorche s’apre / al guardo giovanil questa infelice / scena del mondo, e gli sorride in vista / diparadiso. [...]»); di Al conte Carlo Pepoli («fortunato colui che la caduca / virtù del caroimmaginar non perde / per volger d’anni; a cui serbare eterna / la gioventù nel cor diederoi fati», vv. 111-114); di A Silvia («O natura, o natura, / perché non rendi poi / quel che pro-mettesti allor? perché di tanto / inganni i figli tuoi?», vv. 36-39); dell’intera sesta strofe delleRicordanze (vv.119-135);del Sabato del villaggio («Godi, fanciullo mio;stato soave,/ stagionlieta è cotesta. / Altro dirti non vo’; ma la tua festa / ch’anco tardi a venir non ti sia grave», vv.48-51, in cui si vede una certa vicinanza al discorso della citata In limine di Montale); diSopra un basso rilievo antico sepolcrale («Piacqueti che delusa / fosse ancor dalla vita / laspeme giovanil [...]», vv. 58-60); del Tramonto della luna («tal si dilegua, e tale / lascia l’etàmortale / la giovinezza. In fuga / van l’ombre e le sembianze / dei dilettosi inganni; e vengonmeno / le lontane speranze, / ove s’appoggia la mortale natura»; «Ma la vita mortale, poi chela bella / giovinezza sparì, / non si colora / d’altra luce giammai, né d’altra aurora», vv. 20-26e 63-65); e del secondo frammento da Simonide («Ma stolto è chi non vede / la giovanezzacome ha ratte l’ale, / e siccome alla culla / poco il rogo è lontano», vv. 16-19).
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 197
relli, poi, la cui influenza su Montale non vorrei che sembrasse qui soprav-valutata, pertiene una funzione di sineddoche della sineddoche: di meroattualizzatore, in altri termini. Ponendo mente al fatto che Leopardi puòessere tenuto per uno dei grandi formalizzatori – e liquidatori, quindi32 –di tanti motivi lirici della tradizione occidentale, esiste qualche ragioneper stimare che la poesia di Montale, sotto questo rispetto ovviamente,costituisca una sorta di arretramento ideologico nella configurazione delpersonaggio lirico.33 Negli Ossi, infatti, «la drammaticità implicita neltempo non nasce già dal suo contenuto che [...] può essere variamenteatteggiato al pianto o al riso, bensì dall’invalicabile istantaneità e caducitàinerente agli oggetti [scil. quali correlati della condizione del soggetto],che succedendosi gli uni agli altri vengono a formare una vera legge di dis-solvimento temporale». Il che, nel Montale “vecchio” non potrà che addi-venire a una proiezione dell’io nel cosmo: «Storia, vita, tempo: tutto èmesso in forse sotto il segno dell’illusorietà e della indecifrabilità».34
Ciò vale, lo si accennava in apertura, per il primo e per il terzo Montale;meno per quello delle Occasioni o della Bufera, ove ogni oggetto temati-co – e quindi anche quelli della “giovinezza” e del “tempo” – risulta sotto-posto a un trattamento assai più articolato e straniante. Basterebbe, perassicurarsene, rinviare al mottetto Non recidere, forbice, quel volto (OV, p.150; il testo è databile al 1937), che Manzotti e Zampese analizzano sottil-mente in quanto esemplare illocutivo della “richiesta negativa”, e special-mente di una richiesta negativa di cui il testo celebra l’ineluttabile falli-mento. Il carattere esplicitamente dialogico, o di apostrofe, delle duerichieste ai vv. 1 e 3; l’aspetto impersonale e direi quasi vanamente uma-
198 I saggi
32 Penso alla «cultura centonaria» leopardiana, «ovviamente trascesa» e «tuttavia neoclassica-mente presente», di cui dice G. Contini nella Letteratura dell’Italia del risorgimento (1789-1861), t. I, Firenze, Sansoni, 1986, p. 279; poi in Id. (a cura di), Antologia leopardiana, ivi,1988,p.1;ma ovviamente anche alla «tecnica della citazione occulta» che verosimilmente svi-luppa – e sublima in metodo – i modi giovanili dell’apprendistato leopardiano alla letteratu-ra, ossia il «lavoro a incastro, a collage di varie fonti»; cito, come prima, da M. Corti, Introdu-zione a G.Leopardi,«Entro dipinta gabbia».Tutti gli scritti inediti, rari e editi (1809-1810),a cura di M. Corti, Milano, Bompiani, 1972, p. XIV.33 E proprio nel senso di una involuzione ideologica, dunque, mi permetto di tradurre unappunto di L. Blasucci, Persorso di un tema montaliano: il tempo, in Gli oggetti di Montale,Bologna, Il Mulino,2002,p.96: «Tra Leopardi e Montale non sono passati invano né Bergson néJung.Del resto lo stesso negativo montaliano si precisa in questa lirica [Fine dell’infanzia] noncome il dolore inflitto al vivente da una natura materialisticamente intesa, ma come uninganno metafisico, come la messa in crisi di ogni principio di conoscibilità».34 I due brani sono estratti dal notevole E. Graziosi, Il tempo in Montale. Storia di un tema,Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 20 e 141. L’autrice ritiene che «dell’antistoricismo monta-liano si è forse più sorriso che discusso, dando per scontato che sia tutt’uno con quel suopreteso rifiuto reazionario di un mondo storico con l’urgenza delle sue scelte politiche.Eppure i riscontri non già col contingentismo di Boutroux e di Bergson, la cui problematicasembra essere limitata agli Ossi, bensì col grande pessimismo di Schopenhauer, di cui Mon-tale stesso ha confessato di essere lettore, sono di netta evidenza» (p. 140).Tuttavia, non ècerto che riferirsi alle confesse letture di uno scrittore – a quelle letture, insomma, che nonsi inferiscano analiticamente, e anzitutto materialisticamente, dall’analisi suoi testi – sia suf-ficiente per attribuire statuto di argomento filosofico a quella che sembra essere un’opinio-ne dello scrittore.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 198
nizzato del destinatario dell’atto illocutivo (la forbice); il disporsi delle duerichieste nella forma di una “ripetizione” e di una “intesificazione” condot-te sulla prima dalla seconda, la quale trasporta il fuoco del discorso dall’a-zione del “recidere”alle sue conseguenze, e con ciò prepara il lettore all’e-nigma dei tre enunciati assertivi che costituiscono la seconda strofe; l’am-bigua trasformazione figurale per cui, tacitamente, al v. 5 («Un freddocala... Duro il colpo svetta») la “forbice” pare quasi trasformarsi in una“accetta” – nominata tuttavia nella prima stesura del mottetto – evidente-mente per via del mediatore semico costituito dalla “lama” (anch’essa nonnominata, se non in termini impliciti in quanto parte della “forbice”); lamistione analogica che la figura del “giardiniere” finisce per patire configure simboliche – le Parche, ovviamente – del tempo e, perciò, dellamorte:35 questi procedimenti attestano, anche al fondo del mottetto, l’a-zione significante di enunciato che assegna al tempo il ruolo di esecutoredoloroso della morte e della fine, dinanzi al quale il locutore esperisce, edichiara di esperire, l’istanza illusoria/delusoria del desiderio.Tuttavia taleenunciato è qui ricavabile solo per difetto di interpretazione lineare, ciòche comporta la quasi-cancellazione ovvero la sublimazione ideologicadell’enunciato; il quale da tòpos – com’era nelle poesie degli Ossi e comesarà in quelle del terzo Montale – perviene ora a verità testuale compiu-tamente elaborata.Anche questo, insomma,è il segno della difforme vicen-da diacronica di una scrittura, quella montaliana, che non tanto si svilup-pa o evolve, bensì muove attraverso un itinerario ricorsivo e obliquo.Contini ha asserito che il «primum di Montale sta molto più addietro»rispetto agli scrittori suoi coetanei, i quali «non derogano alla dominanteeminentemente letteraria della tradizione italiana»; il primum, allora, sta-rebbe «in un minimo di tollerabilità del vivere». Lo stesso Contini, tuttavia,aveva precedentemente stimato che la poesia di Montale «naît au termed’une véritable saturation culturelle».36 Se ne può desumere, in ultima ana-lisi, che la tollerabilità del vivere – in cui risiederebbe l’istanza psicologi-ca originaria della poesia montaliana – è internamente intessuta di quellasaturazione culturale che è anche intimità alla dominante eminente-mente letteraria della tradizione italiana.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/5stracuzzi.htm.
199Riccardo Stracuzzi
35 Per tutto ciò vd. E. Manzotti, L. Zampese, Strumenti linguistici per l’analisi del testo poe-tico, Firenze, Le Monnier (in corso di stampa).36 G. Contini, Montale e «La Bufera», nel primo caso; e, nel secondo, Pour présenter Euge-nio Montale; entrambi, ora, in Una lunga fedeltà..., cit., pp. 82 e 64.
005 Rivalta 2-11-2007 14:58 Pagina 199
Interviste
Marc Augé«Contemporaneità impossibile» e «iniziazione negativa»Intervista di Donatella Allegro e Federico Condello
In una pagina famosa della sua Retorica, Aristotele offre un quadrocaratterologico della giovinezza che stupisce per la sua piena aderenzaai clichés che la letteratura o il senso comune, pur in epoche diverse,usano attribuire ai «giovani». Si tocca forse qui una qualche sorta di“costante” umana? Quali sono i limiti e la consistenza di questa pre-sunta “costante”? Ed è lecito parlare in astratto, oggi, dei «giovani»?
L’espressione «giovinezza» è senz’altro troppo ampia: è evidente che esi-stono diverse «giovinezze», e che le distinzioni di classe, d’origine, di posi-zione geografica corrispondono a situazioni estremamente diverse. Quan-do si parla di «giovinezza», del resto, si ha spesso in mente una particolareforma di giovinezza: i giovani delle scuole, i giovani delle periferie, e viadicendo, in una grande varietà di situazioni sociali.Tutte le affermazioniche pretendono di affrontare la giovinezza in generale toccano una que-stione molto delicata e complessa.Tuttavia, credo si possa dire che oggi,pur in àmbiti differenti, esiste uno scarto generazionale ben più sensibileche in altre epoche: uno scarto tra coloro che vengono chiamati «giovani»– diciamo le persone fino ai trent’anni – e i membri della precedentegenerazione.Tale cesura generazionale sussiste perché i più giovani, oggi,crescono in un mondo fortemente tecnologizzato, che incide in manieraben più sistematica rispetto alle precedenti generazioni. La diversa forma-zione dà luogo quasi a una diversa “cosmologia”. Il divario è ancor più mar-cato, credo, in situazioni sociali specifiche quali sono quelle delle popola-zioni immigrate, dove si avverte in misura maggiore la cesura fra i genito-ri – che spesso parlano a stento la lingua del paese d’arrivo, spesso sonoanalfabeti – e i loro figli scolarizzati, che appartengono a un altro sistema.È questa differenziazione generazionale che costituisce un tratto perti-nente per parlare della giovinezza attuale. Inoltre, dal punto di vista stori-co, un forte elemento di differenza si può cogliere rispetto alla generazio-
15
006 Interviste 2-11-2007 14:58 Pagina 201
ne del ’68. I giovani attuali non si riconoscono più nella generazione deiloro genitori, più o meno associati al ’68: a grandi linee, dal punto di vistasociologico, essi sono più conservatori, più romanticheggianti – si pensialla musica di massa, al fenomeno dei grandi concerti – e questo fa sì cheessi rappresentino una rottura rispetto allo spirito più individualista e piùrivoluzionario, dal punto di vista dei costumi, della generazione prece-dente. Del resto, quest’ultima è a sua volta mutata. Si tratta di un fenome-no generale che interessa, credo, l’intera Europa.
A suo avviso, che cosa è mutato, dagli anni Settanta a oggi, per ciò checoncerne la classificazione in diverse classi di età, e le pratiche o le con-venzioni che regolano tale classificazione? Siamo forse di fronte a unacrisi o a un mutamento significativo delle tradizionali suddivisioni inclassi d’età?
In apparenza è accaduto qualcosa di paradossale, benché il paradosso siamolto minore di quanto si pensi. La vita si è allungata,oggi il numero deglianziani è aumentato, ma l’ideale rimane quello della giovinezza. I giovani,da parte loro, si trattengono più a lungo in famiglia, in media lasciano ilfocolare domestico molto più tardi, e l’infanzia si è prolungata. D’altraparte, questa giovinezza in cerca di se stessa rappresenta l’ideale che gliadulti intendono prolungare: di qui tutta l’importanza riconosciuta allacura del corpo, che va dall’estetica a bisogni molto più fondamentali. Sulversante lavorativo, c’è una vecchiaia che arriva molto precocemente: unlavoratore licenziato a cinquant’anni non riesce a trovare un nuovoimpiego, ed è quindi già classificato tra gli anziani.Abbiamo una serie dicontraddizioni che bisogna confrontare, ponendole l’una accanto all’altra.Si propone di ritardare l’età pensionabile, ma si è spesso disoccupati benprima di quell’età. La giovinezza è contemporaneamente un oggetto d’in-comprensione e un ideale estetico e ideologico. Sono questi i dati cheandrebbero raggruppati per comprendere alcune delle contraddizioni delnostro tempo.
Quale posizione occupa la divisione in classi d’età rispetto ad altreforme di classificazione, come il sesso o la classe sociale? La divisionein classi d’età riveste forse una maggiore importanza, nella sensibilitàcomune?
Se si parla dei sessi, in regola generale, si può dire che l’opposizione digenere, nella sua forma più netta, è ormai diminuita, benché esistano delleeccezioni. Oggi tuttavia la qualificazione di «giovane» è in genere assimila-ta ad altre categorie della popolazione: i marginali, gli immigrati. Quandosi vuol parlare, con maggiore o minore preoccupazione, dell’inquietudine
202 Interviste
006 Interviste 2-11-2007 14:58 Pagina 202
degli immigrati, si menziona la «giovinezza». Espressioni correnti come«giovani delle periferie», «giovani dei quartieri disagiati», «giovani emargi-nati» – che hanno i loro equivalenti in quasi tutte le lingue d’Europa –sono espressioni relativamente recenti. Nel diciannovesimo secolo – pertornare molto all’indietro – si parlava di «classi pericolose». Oggi, in effet-ti, c’è spesso una marcata tendenza a sostituire la terminologia generazio-nale alla terminologia di classe: quando si dice «i giovani dei quartieri dis-agiati» o «i giovani delle periferie», ci si riferisce in realtà ai giovani dellaclasse popolare o ai giovani disoccupati di una certa area urbana. C’è latentazione di riattualizzare – a dispetto di altre classificazioni – le catego-rie di tempo e di luogo: di tempo in termini di generazioni, e di luogo inriferimento allo spazio compartimentato degli agglomerati urbani.
In effetti si registra oggi una particolare problematizzazione della «gio-vinezza», un continuo fiorire di “discorsi” (nell’accezione foucaultianadel termine) che tentano di circoscrivere, dal punto di vista sociologico,psicologico, assistenziale, ecc., la «giovinezza», che evidentemente faproblema.
Sì, la giovinezza fa problema: quel che resta da capire è perché la catego-rizzazione in termini d’età intervenga per evocare problemi che nonriguardano l’età. Credo si possa parlare – per usare un’espressione forseeccessiva – di una certa “paura” della giovinezza: fascinazione e al con-tempo paura, per tornare a quel che si diceva prima. Essa è legata a nume-rosi fattori, e in particolare alla situazione del mercato lavorativo. I ragazziche si attardano presso le loro famiglie – talvolta si vive con i genitori finoa trent’anni – lo fanno perché non trovano mezzi sufficienti per rendersiautonomi. In questa condizione essi mantengono lo statuto di «ragazzi»,mentre i genitori invecchiano e, all’arrivo dei giovani, si trovano a lorovolta minacciati sul piano lavorativo. Anche qui agisce lo scarto tra legenerazioni, che non sono cresciute nello stesso sistema educativo e nonintrattengono lo stesso rapporto con la tecnologia in tutte le sue nuovefunzioni; c’è sempre più bisogno di personale con una formazione speci-fica,e, in un certo senso,noi viviamo in un’epoca in cui la giovinezza appa-re diversa come mai in passato: dotata di competenze e di finalità diverse.Ecco qui l’ambiguità: bisogna restare giovani – è un imperativo, quasi unaquestione di sopravvivenza, anche economica – e di qui sorge la fascina-zione per la giovinezza; ma di qui viene anche la paura, perché la giovi-nezza costituisce un mondo che espelle gli anziani: un mondo in cui lagenerazione precedente non si riconosce e fatica a trovare il suo posto.Che cosa significa “essere contemporanei”? Significa condividere i valoridi un’epoca, o di una “non-epoca”, e ciò presuppone che vi sia un certonumero di valori condivisi.È probabile che oggigiorno ci troviamo in un’e-poca in cui la nozione di “contemporaneità” risulta difficile, proprio per-
203Donatella Allegro e Federico Condello
006 Interviste 2-11-2007 14:58 Pagina 203
ché non si condividono di fatto né lo stesso tempo né gli stessi valori. Per-sone appartenenti a epoche diverse vivono oggi nella stessa epoca.
Tornando alla sovrapposizione di «giovani» e fasce sociali emarginate,una certa “marginalizzazione” sembra essere fondamentale nella stes-sa idea di giovinezza: essa è posta spesso al di fuori della società, allaquale può accedere solo tramite un preciso sistema d’iniziazione. Èancora legittimo inquadrare la giovinezza in questi termini?
Qui il problema si complica;è vero che in tutte le società “tradizionali”a noinote esistono riti che permettono di demarcare i momenti di frontiera, tral’infanzia e l’adolescenza, tra l’adolescenza e l’età adulta. Credo che questefrontiere si siano in parte sbiadite, e che oggi i riti d’iniziazione abbianomeno importanza; di qui la confusione di cui abbiamo parlato. Il fatto che igiovani restino molto a lungo nella cerchia familiare mostra che la frontierasi è spostata; non accade più che si lascino i propri genitori a un’età preci-sa.Altri riti più formalizzati, dal più netto carattere sociale, sono scomparsiin molti paesi d’Europa: basti pensare al servizio militare. Il servizio militareha rappresentato un grande rito di passaggio tra la giovinezza e l’età adulta.Ora è scomparso, o è stato sostituito da un servizio civile, o da un serviziopiù breve: in ogni caso da qualcosa che non ha più la nettezza di una demar-cazione di frontiera. I riti di passaggio, in forma religiosa, militare o civile,implicavano l’accoglimento e l’integrazione dei giovani nella classe degliadulti.Oggi tutto è più diluito,poco marcato.Più in generale,non esiste piùuna frontiera netta tra la vita studentesca e la vita professionale,né tra la clas-se dei «giovani» e quella degli adulti. Quindi, per quanto concerne la «mar-ginalità» della giovinezza, essa si è in parte smarrita: e la si ritrova soltantomarcandola altrimenti;per questo la giovinezza diviene oggetto di inquietu-dine e può essere assimilata ad altri fenomeni: la violenza, i piccoli gruppi digiovani che formano circoli chiusi, le attività esotiche del fine settimana, evia dicendo. Di qui la valenza a volte dispregiativa assunta dal termine «gio-vinezza», perché la si trova solo là dove la si può identificare, e la si identifi-ca in un certo luogo estraneo o particolare;da ogni altro punto di vista, inve-ce, essa è una categoria molto più difficile da isolare.
Nella protesta che anima periodicamente i giovani della scuola o dell’u-niversità si coglie anche la nostalgia per un sistema iniziatico tradizio-nale?
Sì, nel senso che l’università è stata in un certo senso un modello d’inizia-zione, quando ancora essa prevedeva gradi diversi e progressivi e si aveva-no delle carriere tipo dal punto di vista delle lauree.Oggi, in Francia, il bac-calauréat gioca ancora, in parte, questo ruolo, anche se con questo nome
204 Interviste
006 Interviste 2-11-2007 14:58 Pagina 204
si intendono oggi esami di natura molto diversa, dal più classico al più tec-nico. Qui c’è ancora qualcosa che si ripete in modo rituale; semplicemen-te, si tratta di un rituale che ha perso in parte il proprio valore, perché se èvero che il baccalauréat è una condizione assolutamente necessaria, nonè più una condizione sufficiente. In altri termini, se non lo si supera si èrigettati ai margini, e se lo si supera non si è raggiunta alcuna meta:è ormaiuna sorta di iniziazione negativa. Chi non ce la fa è costretto a ricomincia-re, o a cercarsi un piccolo mestiere: è come escluso dal percorso. Ma quel-li che ce la fanno – e sono la maggioranza, perché è un esame che oggisuperano quasi tutti – non hanno ottenuto nulla, per il momento. Alloraalcuni restano nel sistema universitario, che in effetti conserva, con la lau-rea, l’aura del sistema iniziatico. Ma anche qui si riscontrano numeroseambiguità, perché si sa che il sistema iniziatico non dà sbocco ad alcunaposizione nella società: né la laurea, né il master, né il dottorato assicuranoautomaticamente una posizione. In altri termini, rimane la forma dell’ini-ziazione,ma non è più una forma efficace,e dunque essa perde anche il suopotere simbolico. La cosiddetta crisi dell’università – se ne parla molto, inFrancia – non sta solo nel fatto che l’università non abbia uno sbocco diret-to sul mondo professionale, ma anche nel fatto che non si dia più un lega-me tra il potere simbolico che attribuisce la laurea e il potere effettivo cheattribuisce l’impiego. In altre parole,c’è una perdita sul versante simbolico,perché il potere simbolico è ormai vuoto.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/auge.htm.
205Donatella Allegro e Federico Condello
006 Interviste 2-11-2007 14:58 Pagina 205
Marc AugéBricolage, riciclaggio e riproduzionesocialeIntervista di Donatella Allegro e Federico Condello
Le nozioni di “rifiuto” e di “riciclaggio” evocano innanzitutto, in prospet-tiva antropologica, il concetto lévi-straussiano di “bricolage”. Si tratta diun concetto ancora utile e fecondo? È ancora attraverso un continuo“bricolage” di codici e di simboli che la nostra società riproduce la pro-pria identità, garantisce la propria continuità?
Credo lo si possa affermare nella misura in cui si comprende che il nododella questione è sapere come una società si riproduce. È vero che l’et-nologia ha spesso affrontato il problema lavorando su piccoli gruppi,dovei fenomeni sono più visibili e ancor più spettacolari: se osserviamo un pic-colo gruppo umano, per esempio, in area saheliana, o in qualsiasi altraregione, ciò che degno di nota è il fatto che esso si riproduca in quantogruppo e continui ad esistere come tale. Oggi gli etnologi sono talvoltasorpresi nell’osservare la ricostituzione di gruppi che si ritenevano scom-parsi. E perché le vediamo ricomparire? Avviene grazie al favore di unapolitica governativa che distribuisce le terre soltanto ai gruppi etnica-mente costituiti in minoranze autoctone.Molti amerindi,meticciati da unaparte e dispersi dall’altra, sono tornati a raggrupparsi, a riqualificarsi comegruppo etnico, reinventando dei riti, ricostruendo dei villaggi, per ottene-re il diritto alla terra. Ciò significa che abbiamo visto un certo numero dipersone abbandonare i loro quartieri per raggiungere zone rurali o stra-niere; ciò implica evidentemente tutto un arsenale di riti, di ricomposi-zioni, eventualmente anche un ritorno alla lingua d’origine per favorire laricostituzione del gruppo. Certamente c’è dell’arbitrarietà in tutto questo,anche se si riproducono dei riti cosiddetti “tradizionali”, anche se i turistivengono a visitare tali gruppi quali esemplari dell’antica vita degli ame-rindiani.Tutto questo può forse prestarsi a essere caricaturizzato o deriso,ma sappiamo che, dopo tutto, è sempre così che si sono costituiti i grup-pi: inventando dei rituali, dei simboli d’identità, delle relazioni tra i popo-li, che permettono di radicarsi in un territorio e di riprodursi in quantogruppo. Dunque, possiamo dire che la nozione di bricolage è in effettimolto utile: oggi possiamo verificarla e capire meglio, retrospettivamente,come essa sia stata a fondamento della sopravvivenza di un certo numerodi cosmologie e di gruppi.
206 Interviste
16
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 206
E nel dominio della letteratura, esiste secondo lei qualche forma pecu-liare di bricolage imputabile fra l’altro alla lunga durata dei codici lette-rari e al loro carattere conservativo?
Certamente, il termine può essere utilizzato anche in questo àmbito, forse indue sensi: nel senso a cui lei si riferisce, e cioè a causa del carattere conser-vatore e prolungato di un certo numero di generi, che richiedono l’applica-zione di determinate regole;e l’applicazione di tali regole passa sempre attra-verso una sorta di dominio umano del linguaggio che le applica alla formaletteraria; e in questo senso si può parlare di bricolage. Poi, va considerata laletteratura nella sua evoluzione, e in particolare tutte le trasformazioni deigeneri:per esempio il passaggio dalla tragedia al dramma borghese,dall’epo-pea al romanzo alla novella, e via dicendo; la creazione di un nuovo genereavviene sempre tramite il riferimento a un genere preesistente, che si trattadi ridefinire, di scomporre e ricomporre, in senso molto letterale; e credo sipossa dire, senza esagerare, che sia l’attività letteraria in sé sia la storia dellaletteratura evidenziano un continuo ricorso a pratiche di bricolage.
Secondo lei, nel processo di bricolage culturale che, attraverso gli ulti-mi due secoli, ha portato alla società attuale, esiste qualche tipo di“rifiuto” che non è possibile riciclare; qualcosa, in termini di pratiche oconvenzioni sociali, assolutamente escluso e irrecuperabile, o almenopresunto tale?
È vero che l’evoluzione accelerata della nostra società potrebbe dar creditoa questa ipotesi,ma io non ricorrerei alla metafora del “rifiuto”;a dire il vero,ho l’impressione che tutto possa essere riciclato, comprese le cose peggio-ri. Non sono sicuro che esistano degli “insegnamenti”della Storia.Al contra-rio, esistono numerose sostanze che avvelenano il sangue: tossine che nonsi manifestano quando l’organismo è in salute, ma che possono riapparirealla minima debolezza. Non credo che noi siamo usciti definitivamente nédalle esperienze totalitarie, né dal razzismo. Non dico che non ci sia muta-mento sociale, ma siamo organismi carichi di tossine, e se qualcosa va male– per esempio la disoccupazione, la situazione economica, l’improvviso gua-starsi delle relazioni tra i paesi – queste tossine possono tornare ad agire.
Un tratto tipico della globalizzazione capitalista è il continuo riciclaggiodelle tradizioni e dell’identità, e con esso – o contro di esso – il frequen-te “ritorno alle origini”, vere o presunte, sia in prospettiva reazionariache in prospettiva apparentemente progressista.
La globalizzazione produce numerosi fenomeni di rivendicazioni identita-rie e culturali, che intendono presentarsi talvolta come forme di opposi-
207Donatella Allegro e Federico Condello
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 207
zione alla globalizzazione – ma non sempre – e che molto spesso si dannosotto forma di immagini caricaturali, funzionando a beneficio della globa-lizzazione stessa.Ho l’impressione che ci sia un certo numero di temi,pre-sentati come “locali”, che sotto molti aspetti giustificano l’ideologia glo-bale nel suo insieme; tutte le affermazioni identitarie, etniche, religiose –o supposte tali – rilevano in parte di questa logica ambivalente.
Su un piano diverso, esiste oggi una certa ossessione per lo spreco, perl’eccesso della consumazione, e, di conseguenza, un appello continuoalla misura, al consumo moderato e al riciclaggio. Viviamo oggi in unasorta di potlach sistematico e, al tempo stesso, di terrore diffuso delpotlach?
Sì, è la contraddizione della nostra epoca: oggi siamo effettivamente giuntialla perfetta realizzazione di quella che viene chiamata “società dei consu-mi”; l’espressione ha anticipato la realtà,visto che oggi viviamo in una socie-tà di iper-consumazione: tutto si consuma, comprese le idee, i modelli poli-tici, i modelli sociali; tutto si consuma e tutto può essere definito oggetto diconsumo, compresi i nostri strumenti di comunicazione: tutto. Di conse-guenza viviamo in una continua, enorme attività, e chi ne è escluso aspira aparteciparvi. Naturalmente, in questo pianeta del consumo c’è anche chinon consuma, o chi consuma molto poco: e allora può essere a sua voltaconsumato, specialmente dal turismo internazionale, in una sorta di canni-balismo. Certamente tutto questo ingenera contemporaneamente vertiginee paura. Da una parte, vertigine d’iper-consumazione: basta guardare alleguerre che si svolgono in ogni angolo del pianeta, guerre a cui è collegatoun considerevole traffico di armi e munizioni,che sono per definizione benidi consumo che si consumano molto rapidamente; si pensi poi alle difficol-tà di vendita che interessano certi prodotti, a causa della concorrenza deiprezzi, e quindi ai mercati assistiti e alla distruzione massiccia delle derrate,nel momento in cui intere popolazioni muoiono di fame.Per quanto riguar-da la paura, ecco la questione posta dagli ecologisti, il fatto che noi consu-miamo e distruggiamo il nostro pianeta, e tutte le inquietudini che riguar-dano la stessa atmosfera che ci circonda; le Cassandre ecologiste sono sem-pre più numerose, e tutto sommato le loro sono considerazioni effettiva-mente giustificate. Di qui l’ossessione per il riciclaggio, per lo smaltimentodei rifiuti, che vanno dagli oggetti quotidiani alle scorie atomiche dellenostre grandi centrali. Certamente per le generazioni che verranno questasarà una delle più grandi questioni tecnico-scientifiche da affrontare: comegestire o come far sparire i rifiuti? Ma questo non sarà che l’aspetto mate-riale della questione,e non si sa bene come intervenire alla radice:per esem-pio come ridurre le emissioni di gas nell’atmosfera. C’è una specie di con-traddizione tra la vertigine del potere e della forza economica e la diffusapreoccupazione per la sopravvivenza delle generazioni a venire. Qui, anco-
208 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 208
ra una volta, c’è un contrasto tra i giovani e gli adulti. E c’è una tensione, o,meglio una sorta di contraddizione tra gli interessi del presente e gli inte-ressi di coloro che verranno dopo di noi.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/auge2.htm.
209Donatella Allegro e Federico Condello
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 209
Valerio MagrelliIl corpo difettoso Intervista di Nicola Bonazzi
Il corpo è un tema molto presente nella sua opera, già dal titolo dellasua seconda raccolta Nature e venature. Da dove nasce la decisione didedicare un’intera opera al corpo?
In effetti mi sono divertito a inserire dei richiami ad altri miei testi concitazioni di versi o prose, già presenti in Esercizi di tiptologia del ’92. Èevidentemente un tema che mi è sempre appartenuto. In un testo di Natu-re e venature, per esempio, parlo delle viti infisse nell’osso, e le paragonoa un sistema di accordatura dei pianoforti – per altro ho suonato a lungopianoforte. Insomma ho voluto ribadire, evidenziare questi legami. L’ideadel libro nasce in verità intorno al ’90, dunque non si tratta di una sceltacronologicamente successiva a Didascalie per la lettura di un giornale,del 1999; è stato piuttosto un lungo sedimentarsi. Inizialmente dovevanoessere libri diversi, ma alla fine, secondo un movimento che mi appassio-na molto nel suo svolgersi, il lavoro ha finito per inglobare materiali su tretemi differenti: l’infanzia, la malattia e il viaggio. La difficoltà è stata quelladi creare questa triangolazione nel segno del corpo.
Il corpo nella società contemporanea è spesso un corpo esibito in sensoedonistico, narcisistico, laddove invece nel suo libro è un corpo malato...
Difettoso.
...difettoso. Nella quarta di copertina si citano Ballard, Cronenberg,Bacon... Mi chiedevo però se altri riferimenti possibili fossero la poesiabarocca o surrealista, per quel tanto di macabro di cui a volte si compiace.
Nel primo caso senz’altro, addirittura attraverso la citazione di una poesiadi Nature e venature c’è un omaggio a Ciro di Pers. Sul surrealismo sonopiù perplesso. Alcuni autori sono per me fondamentali, per primoMichaux, o certi eterodossi come Artaud e Ponge, amo meno Breton macerti testi li trovo smaglianti, Nadja per esempio; però c’è qualcosa, nelsurrealismo, che mi ha sempre insospettito... Il senso esclusivo del grup-po, soprattutto, lo trovo molto invecchiato e lontano: Eluard,Aragon sonoautori per me letteralmente inerti. Piuttosto sono stato molto suggestio-
210 Interviste
17
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 210
nato dalle arti figurative: Giacometti, in questo senso, è un riferimentomolto importante.
Il titolo del suo libro, Nel condominio di carne, rimanda a un’idea dicorpo che si abita ma non ci appartiene, qualcosa che è “altro” da noi.C’è come la necessità di una fuga, di una liberazione da questo involu-cro, inteso evidentemente in senso platonico.
L’idea della veste, del soma, del carcere è molto presente nel testo. Il tito-lo, in realtà, è venuto fuori dopo una serie di tentativi piuttosto numerosi,nel desiderio di mettere a fuoco questa disparità molto stridente tra ilsenso materiale, ma anche glorioso del corpo, e una sua quotidianitàmiserrima, che ho sempre paragonato a quella di un inquilino. Dopo l’u-scita del libro mi sono ricordato di un testo di Ora serrata retinae, la miaprima raccolta, in cui parlavo di un soggetto che abita il suo cervello“come un tranquillo possidente”; era già presente, cioè,quest’idea di spos-sessamento che è propria anche del Condominio; là c’era un possidenteche abitava uno spazio mentale, le terre del cervello per dir così; qui c’èinvece un inquilino: è subentrato un senso di precarietà che credo sia ilsegno più forte di un avvenuto cambiamento.
Tornando ai riferimenti citati nella quarta di copertina: si tratta di autori,quasi tutti, appartenenti all’area anglosassone. Secondo lei manca unatradizione, almeno recente, sul tema del corpo nella letteratura italiana?
Da un lato sì, perché i richiami alla body-art o al cyborg provengono perl’appunto da fuori, è come una nuova tradizione rappresentata da autoricome Ballard o Elleroy. Devo dire che pur non essendone un estimatore,li ho sentiti immediatamente vicini. Detto questo credo che la letteraturaitaliana abbia anche momenti di straordinaria attenzione al corpo. È suffi-ciente pensare a Moravia, il Moravia di Agostino per esempio, talmentepieno di carnalità che mi sembra eccessivo parlare di una distanza dellanostra letteratura recente da certe tematiche. Diciamo piuttosto che quel-lo che ci arriva da fuori è una forma diversa di discorso sul corpo, media-to in primis dall’insegnamento di Foucault. Credo tuttavia che il tema delcorpo sia stato molto presente nell’ambito italiano,magari secondo moda-lità meno appariscenti, più dissimulate. Penso anche ai film Pasolini, chehanno una forza che il narratore e il poeta forse hanno perso.
Le cito una poesia di Nature e venature: «Sentirsi male sembra voler dire/ che il dolore impedisce / l’ascolto di se stessi. / La malattia conduce ilsuo corpo lontano, / troppo distante per essere udito”.
211Nicola Bonazzi
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 211
Si tratta di una poesia intraducibile, un gioco di parole. Partendo da quelbisticcio cercavo di spiegare una sensazione, ovvero che il dolore costi-tuisce uno schermo, un ostacolo all’ascolto di sé. Mi rendo conto solo orache il mio ultimo libro pare sostenere il contrario.
Appunto. È un cambio di prospettiva.
Resta però questa idea dell’ascolto, di una sensazione uditiva associata aldolore. Non a caso ho inserito nel libro una citazione di Leriche, un medi-co francese, che dice che «la salute è il silenzio degli organi».
Questo esercizio assiduo di autoanalisi, di ascolto del corpo, comportauna fatica di qualche tipo?
No, direi il contrario. Per me la scrittura, almeno questo tipo di scrittura, èsempre una liberazione.Almeno si dà parola alla fatica vera, alla sofferen-za. Giocare finalmente con questi materiali è un modo per salvarsene. Inun libro che ho scritto per ragioni accademiche su Joubert, un autoreminore del Settecento francese, ho inserito come esergo una citazione diQueneau, per me bellissima: «De tous les coups du sort j’ai su faire unefable / le moins deviens le plus, consolante inversion» (Da tutti i colpi delfato ho saputo trarre una favola, il meno diventa più, consolante inversio-ne). Ecco, io ho sempre di fronte l’immagine della scrittura come una spe-cie di ruota del judo, per cui la forza dell’avversario viene usata control’avversario. Molti scrittori sono come dei grandi judoka del linguaggioche riescono a sfruttare l’ostilità del reale per trasformarla in scrittura, perribaltare il meno in più. Mi piacerebbe pormi in questa schiera: in questomodo non c’è fatica, c’è anzi risarcimento.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/3magrelli.htm.
212 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 212
Mario Rigoni SternNemico: una parola assente Intervista di Elisabetta Menetti
«Il nemico è una parola che non uso. Nel Sergente nella neve la parola“nemico” non c’è: parlo di “russi”, dico “loro” ma “nemico” mai. Per mequelli non erano nemici: quando ero in Grecia o sul fronte francese o inRussia non li consideravo nemici. Il nemico bisogna conoscerlo, bisognasapere cosa ti ha fatto. Il nemico è uno che ti ha offeso o uno che ti hafatto del male. Ma loro non mi avevano fatto niente, non mi avevano offe-so e allora la parola nemico nei miei libri non c’è».
L’assenza di una parola è segno di una poetica. Nei racconti di Mario Rigo-ni Stern il silenzio del nemico svela una dimensione umana e disegna icontorni di un immaginario. Per uno scrittore, che dei ricordi di guerra hafatto uno dei fulcri della propria scrittura, il nemico non esiste.Per l’uomodi neve, che ha raccontato la drammatica ritirata di Russia dei soldati ita-liani (e tedeschi), il dialogo con l’altro inizia con rispetto, generosità ecomprensione. Il nemico, mi dice, è un «termine relativo»: il suo significa-to cambia «a seconda delle prospettive». Durante la guerra in Albania peresempio i nemici «erano quelli che ci avevano mandato a fare la guerra»,come aveva già ricordato in un’altra occasione.
Ai nemici si può chiedere permesso: durante la ritirata di Russia (Il ser-gente nella neve) il sergente maggiore Rigoni chiede di entrare in un’i-sba, si siede a tavola e condivide con i russi una zuppa. È un momentorallentato, di magica sospensione.
È stata una cosa naturale in quanto non erano nemici:erano persone che sta-vano mangiando perché avevano fame e io sono entrato a chiedere del ciboe me lo hanno dato.Una cosa molto semplice da spiegare.Me lo ha fatto nota-re un mio amico che era insegnante in un liceo e che leggeva ogni anno (allafine del quarto anno) il Sergente e che si è accorto di una cosa molto sem-plice.Si è accorto che ho scritto: «Busso ed entro». Il fatto sta in quel “busso”,perché io ho chiesto di entrare come si fa in una casa di un vicino o di unapersona comune:si bussa e si chiede il permesso.E dal momento che si chie-de il permesso uno non entra per far del male o per far violenza.Se entra chie-dendo permesso entra per essere ospite. Loro lo hanno capito. Sono entratosolo per chiedere qualcosa:ho chiesto da mangiare.E la signora,una giovanesposa russa, ha preso un mestolo di minestra dalla stessa pignatta dove man-giavano i russi e me lo ha dato. Ho ringraziato, ho salutato e sono uscito.
213Elisabetta Menetti
18
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 213
In quella pagina Elio Vittorini ha voluto aggiungere qualcosa: qualcheriga di spiegazione. Eraldo Affinati nella prefazione ai “Meridiani” hadefinito quelle frasi come alcune «note di jazz in un coro alpino». Tutta-via lei ha sempre voluto mantenere la versione redazionata da Vittorini.
Sì è rimasto così: il Sergente è quello. Così è nato e così rimane.
La memoria mette ordine negli avvenimenti realmente accaduti. Questonuovo ordine è il racconto: qualcosa di diverso da ciò che è accaduto.Nel ricordare i volti o i corpi dei soldati con i quali si è scontrato checosa è cambiato e cosa è riuscito a conservare?
Abbiamo i cinque sensi che ci aiutano a ricordare una immagine o unasensazione. Ha presente l’inizio del Sergente? «Ho ancora nel naso. Hoancora negli occhi»: nessuna situazione è ripetibile in maniera precisa dacome è avvenuta però ci sono delle cose che abbiamo recepito in quelmomento e che possiamo stimolare nei ricordi in maniera il più possibileprecisa ricordando gli odori, un suono o una musica o uno sguardo. Se nesarà accorta anche lei. Se sente una cosa in particolare e che l’ha colpitain un modo particolare, che i suoi sensi hanno recepito, anche lei ritornaimmediatamente nel momento in cui l’ha vissuto.
Nella premessa all’edizione Einaudi del 1965 del Sergente nella nevescrive che «in guerra, quando sembra che tutto debba crollare e mori-re, un gesto, una parola, un fatto è sufficiente a ridare speranza e vita».Bisogna guardare al proprio nemico con generosità e umanità?
Ma, ripeto,qual è il nemico? Alla parola nemico preferisco dire “quello cheti è di fronte” e che ti può essere avversario. Ma anche io sono a mia voltaun nemico: la parola nemico è abbastanza relativa. I nemici sono uominisimili a noi: anzi hanno qualcosa in più di noi. Nel caso di guerra, dovesiamo andati noi in quegli anni dal 1940 al 1945 loro avevano qualcosa inpiù: difendevano la loro terra ed erano dalla parte della ragione. Noi pote-vamo essere loro nemici.Mentre loro erano nostri nemici nel senso che cisparavano, ma giustamente anche, non crede?
Nei suoi racconti si vive attraverso le sue parole la forza dei sentimen-ti: l’angoscia dell’attesa, la presenza misteriosa dell’altro e la paura.
Ho provato paura rare volte: si può avere apprensione ma la paura invece èuna cosa tremenda che ti fa perdere il senso della ragione.E io nella mia vitadi paura durante la guerra l’ho provata solo due volte: una prima volta sul
214 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 214
fronte occidentale sulle Alpi e una seconda volta in Russia quando ha spara-to la katiuscia.Perché anche quando mi trovavo in momenti difficili l’impor-tante era non perdere la testa. Perché è quando si perde la testa che suben-tra la paura.E quando subentra la paura si può morire in malo modo.Mentrese uno è cosciente riesce a ragionare: la paura non entra dentro il suo animo,ma non entra neanche quello che stupidamente chiamano eroismo. L’eroi-smo in realtà è vincere la paura. I gesti eroici non hanno senso.
La generosità e il coraggio di un gesto rispettoso proprio in un momen-to in cui la violenza o la disperazione sembrano essere le uniche via d’u-scita: è un invito a riabilitare se stessi attraverso gli altri?
Ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare i conti con noi stessi oltre checon il prossimo. E in tutte le esperienze drammatiche della vita: la guerra,la prigionia ma anche una crisi economica di una famiglia o un incidenteo una malattia. Ci sono degli esami di coscienza che ti portano di frontead una realtà e devi essere capace di capire. Ho imparato una cosa: biso-gna saper chiedere con le dovute maniere senza violenza.Tornando a quelfatto della ritirata di Russia è molto semplice e chiaro.C’erano alcuni,qual-che raro italiano, ma spesso molti tedeschi che quando entravano inun’isba tiravano un calcio alla porta e buttavano una bomba a mano.E i nostricompagni se non buttavano la bomba a mano entravano e cercavano da man-giare in maniera violenta:non uccidevano ma aprivano con dispetto i cassettidi qualche tavolo, guardavano se c’era qualche cosa da mangiare in manierasgarbata. Ma per me è stato diverso: quando ero bambino mia madre mi hainsegnato che davanti ad una porta chiusa si chiede il permesso.
Il finale del Sergente nella Neve: un’altra magica sospensione. La scrit-tura è come una cantilena, che incanta. In attesa del treno per l’Italiaviene ospitato in un’isba di «gente giovane e semplice». Il sergentemaggiore Rigoni, stremato, si sistema una «cuccia» sotto la finestra.Una mamma culla con dolcezza un neonato: canta, parla «armoniosa-mente» con le sue amiche, sussurra per non disturbare quel ragazzostanco e svuotato. La voce di quella giovane donna, che si contrapponeal rumore della guerra, è come una medicina: «la voce della ragazzaera piana e dolce in mezzo a quel rumore». Quella mamma culla il suobambino e culla anche lei, che è come un bambino.
Questa è la prima volta che vengo letto così: la mamma cullava il bambino edio ero come quel bambino.Venivo curato da quella donna che cantava.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/menetti_int_rigonistern.htm.
215Elisabetta Menetti
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 215
Edoardo SanguinetiLa terra è un inferno globalizzato Intervista di Riccardo Bonavita
Iniziamo con una domanda rivolta, prima che al poeta-saggista, al San-guineti professore. Perché oggi i lettori di Dante, soprattutto gli studen-ti, preferiscono l’Inferno, perché questo spazio di pene e sofferenze haaffascinato e continua ad affascinare più che gli altri luoghi immagina-ri dell’universo dantesco?
Nel Novecento, se incominciamo dagli studiosi, sono stati fatti dei tentati-vi di rivalutazione del Purgatorio, e anche del Paradiso, che era la canti-ca meno “affabile” e più lontana dagli interessi del mondo moderno. Noiviviamo in un mondo sostanzialmente laico e anche chi è religioso nonporta certo quella stessa quantità e qualità di interessi teologali che eranopresenti in Dante. Quindi l’abbassamento di simpatia verso il Paradisoappartiene tipicamente al mondo moderno: non è un caso se appunto giànel Settecento, un’età ampiamente secolarizzata, si ravviva l’attenzioneper i grandi episodi infernali. Finalmente, l’età romantica ha guardato allefigure infernali come figure drammatiche, appassionate e passionali, intutto il senso vivo di questa parola; al paragone quelle purgatoriali, conqualche eccezione, e quelle paradisiache appaiono più fredde, congelate.Gli studenti rispecchiano questa tendenza più generale, e i professori stes-si, anche se magari tentano di riequilibrare le cose, finiscono per spingerenella stessa direzione.Poi forse c’è un effetto di eccessiva saturazione: studiare per tre anniDante vuol dire accogliere con un certo interesse ed entusiasmo la primafase, di incontro e di scoperta, dopo di che nasce una certa sazietà. Unasorte che peraltro, probabilmente, toccherebbe a qualunque testo sevenisse distribuito in tre anni, orientato verso una lettura pressoché inte-grale e per di più tramato di una serie di elementi culturali che si fannosempre più densi a mano a mano che si procede.Il mondo moderno, infine, sembra particolarmente appassionato alle sto-rie del male assai più che alla contemplazione del bene. Il romanzo è fon-damentalmente colorito dal dolore, dalla sofferenza, da tormenti, da con-traddizioni: la sottile felicità paradisiaca è molto lontana da noi.
Passiamo a un argomento più leggero: alla fine del Baldus, Teofilo Folen-go immagina un inferno speciale, destinato esclusivamente ai poeti, per-ché sono bugiardi e inventano favole. Chiusi in una zucca vuota, vengono
216 Interviste
19
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 216
sottoposti all’estirpazione di tanti denti quante sono le bugie che hannoscritto o cantato. E lei come immaginerebbe l’inferno dei poeti?
Mah, in fondo il Folengo era modesto, moderato: i poeti dicono più bugiedi quanti denti abbiano in bocca, quando li hanno... E credo che la penapiù terribile che si possa pensare in un inferno che abbia naturalmente laprevedibile durata dell’eternità sia quella di costringere i poeti a leggereininterrottamente le loro opere per sempre, e a vedere che effetto produ-ce su di sé la propria scrittura replicata, studiata e meditata sino in fondo.Ecco, credo che questa potrebbe essere la pena più terribile che si possaimporre loro.
E quello dei politici?
Per i politici è più difficile... credo che “politico” sia una categoria troppocomplicata per poterla esaurire.Pensiamo al modello dantesco da cui siamopartiti: bene o male i poeti vanno tra gli spiriti magni e quindi finiscono inun inferno poco “infernale”, privilegiato. Invece non c’è una vera e propriacategoria che comprenda gli uomini politici di per se stessi, mentre incon-triamo i tiranni, o i violenti. E credo che sia giusto attenersi a questo crite-rio: probabilmente non è possibile pensare a un inferno politico in quantotale.Credo sia da distinguere tra le forme diciamo di colpa,di peccato;e poibisogna anche non essere indotti da una posizione di diffidenza preconcet-ta nei confronti dei politici – come nemmeno dei poeti,peraltro.Ci sono deipolitici che meritano di andare, se non proprio in Paradiso – che mi parecosa ormai ardua da raggiungersi – almeno almeno in Purgatorio...
Avevo pensato di sviluppare il nostro itinerario proprio in questa direzio-ne: e quindi le chiedo di operare queste opportune distinzioni: dovesituerebbe alcuni politici contemporanei nel sistema di pene e ricom-pense dell’aldilà dantesco? Partirei da Silvio Berlusconi, in parte perchéè l’attuale capo del Governo, e in parte perché, a suo modo, è una figu-ra che vi si presta in modo particolare, dato che, avendo costruito la suapolitica soprattutto sulle fantasie e i fantasmi della cultura di massa, èentrato nell’immaginario collettivo del nostro paese.
Credo che ci sarebbero almeno due luoghi che potrebbero contenderse-lo.Da un lato il girone dei bugiardi,perché incarna precisamente una poli-tica di propaganda, di miti, di sogni. Quindi lo vedrei tra i menzogneri pereccellenza, i propagandisti e i pubblicitari, per i suoi spot. E dall’altro latolo collocherei tra gli avari, nel senso medievale della parola, cioè gli avididi beni, coloro che sono orientati esclusivamente all’accumulazione dellericchezze. Credo che potrebbe equamente dividersi per l’eternità: un
217Riccardo Bonavita
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 217
anno in un girone, un anno nell’altro, così si renderebbe giustizia ai dueaspetti che mi paiono fondamentali della sua personalità.
Più che per una vuota e rituale “par condicio”, è per riservarle il gustodi condurre una critica interna al mondo della sinistra, a cui lei appar-tiene, che le chiederei dove porrebbe Massimo D’Alema...
D’Alema, anche se l’espressione è molto dura, potrebbe essere messo tra itraditori, nel senso che, uomo di sinistra – che avrebbe dovuto essere disinistra – in realtà ha svolto una politica estremamente contraddittoriarispetto alle prospettive e alle esigenze attuali di un partito che voglia dav-vero collocarsi a sinistra. Quindi se a gestire l’inferno fossi io, uomo chepensa che per essere di sinistra sia necessario mantenere una posizionecoerente con il materialismo storico,dunque richiamarsi in qualche modoalla tradizione marxiana,D’Alema finirebbe tra i traditori.Traditore però inquesto caso non vorrebbe dire propriamente colui che agisce con inten-zioni perfide, ma colui che si dimostra infedele a quei principi ai qualicomunque avrebbe dovuto attenersi.
Traditore degli amici, quindi...
Sì, traditore degli amici, diciamo così.
E visto che anche Dante indicava la propria posizione all’interno del suosistema, se Sanguineti dovesse entrare nel mondo di Dante, dove si col-locherebbe?
Non so... Non è che abbia una così buona opinione di me da non saperedove mettermi, ma sono ovviamente incerto nell’autodefinirmi. Alla finfine penserei ai lussuriosi,non tanto perché la mia condotta di vita sia par-ticolarmente scomposta ma perché l’erotismo è parte molto forte dellemie esperienze, del mio immaginario.
Quindi punirebbe l’«inibito pornografo»...
Sì, l’«inibito pornografo». D’altra parte quella è la definizione che ho datodel poeta in generale, con molta ironia, anche nei confronti di me stesso,perché mi mettevo in causa pure io.
Nell’epoca che – con un termine ormai comune – viene detta della “glo-balizzazione”, predomina un solo modello universalmente riconosciuto
218 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 218
per la produzione di beni e l’organizzazione della società, che tende adavvicinare i luoghi, a renderli sempre più simili tra loro. Esiste ancorauno spazio reale che potremmo immaginare come il luogo dell’infernoper eccellenza?
Alla luce delle considerazioni sullo stato attuale delle cose, potrei dire chel’inferno è la terra. È un inferno globalizzato. Per lo meno nel senso dei«dannati della terra», che oramai occupano la maggior parte dello spaziodisponibile. Cosa evidentemente non del tutto nuova, perché gli squilibridi condizioni sociali, umane, culturali, materiali tra privilegiati ed emargi-nati hanno accompagnato tutta la storia. Però, mancando la globalizzazio-ne, il nesso tra privilegiati e non era meno diretto, e in certe zone quasiinesistente.Voglio dire, naturalmente, che nelle “zone calde” della storia ilconflitto fra sfruttatore e sfruttato era senz’altro forte ma che per secoli,per millenni probabilmente, coloro che vivevano nel Sud America, inOceania, in Africa erano al di fuori del moderno rapporto di sfruttamento,le loro condizioni potevano essere – come si diceva – primitive. Certo,anche al loro interno esisteva spesso una dialettica sfruttatore-sfruttato,ma questo rapporto non era così sistematico. I fenomeni di conquista, dicolonizzazione, eccetera, hanno avviato il processo di globalizzazione.Oggi il problema del giorno è questo.Detto questo, vorrei però precisare che ho un’opinione favorevole alla glo-balizzazione,nel senso che penso fosse un processo inevitabile,necessario eprevedibile, in quanto compimento e fase suprema (come si sarebbe dettouna volta) dell’imperialismo,o impero del capitalismo.Adesso il vero proble-ma è affrontarlo, e come si vede i privilegiati della terra non si curano dellesue contraddizioni:proprio in questi giorni si svolge a Roma la riunione dellaFAO, da cui tutte le grandi potenze si può dire che siano del tutto assenti,mentre ci sono solo i paesi poveri a esprimersi e protestare contro l’assolu-to non mantenimento delle promesse, del resto già deboli e poco risolutive.Quindi direi che l’inferno ormai viene a coincidere con la terra,non per sem-pre – credo – ma certo, in questa fase, in modo pressoché totale.
A questo proposito ci si può ricollegare ad una sua celebre raccolta,Purgatorio de l’Inferno. I critici ne parlano, con una formula che ormai èentrata – per così dire – nei manuali di storia letteraria, come di un testodove lei esplora nel linguaggio, attraverso il linguaggio, la perdita di sé,la riduzione a cosa, ovvero a qualcosa di inconoscibile: l’alienazione.Nell’alienazione lei legge, o vi leggeva quando ha dato al suo libro que-sto titolo, la forma moderna della dannazione infernale?
Io avevo in mente un superamento dell’immagine di caos che era nel mioprimo testo, cioè in Laborintus, che metteva in scena il disordine radicaledel mondo e lo smarrimento in una condizione alienata. Nel Purgatorio del’Inferno prospettavo invece una possibile via d’uscita, politicizzando sem-
219Riccardo Bonavita
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 219
pre più le questioni, che prima erano eminentemente orientate in una con-dizione anarchica e rivoltosa. Cercavo di sviluppare la ribellione al caos inmodo più politicamente concreto e specifico, storicamente determinato equindi come necessità di rivoluzione.Il titolo – che ha sapore dantesco – erarubato a Giordano Bruno che accenna a un’opera da lui scritta che però oè perduta o era stata appena progettata,e di cui appunto non resta altro cheil titolo. Quindi era possibile caricarlo di qualunque significato, anche per-ché il contesto non rende neppure possibile ricostruire con chiarezza i con-tenuti possibili di quell’ignota opera bruniana.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/archivio/sanguineti_prima.htm.
220 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 220
Edoardo Sanguineti«Io è un altro», uno slogan per la lotta al narcisismoIntervista di Riccardo Bonavita
Ora potremmo evocare, per introdurre la seconda parte del nostro per-corso, dedicata alle figure dell’alterità, un celebre “motto” di Jean-PaulSartre. Nel finale di Huis clos (A porte chiuse), che è un dramma ambien-tato in un inferno tutto mentale, il protagonista grida: «L’enfer, c’est lesautres!» (L’inferno sono gli altri!). Lei sottoscriverebbe questo parados-so esistenzialista?
No,in sostanza no.È una frase molto suggestiva e non a caso è diventata cele-bre, ma si potrebbe sostituire con la frase “l’inferno siamo noi”.Voglio direche il rischio è che poi la sua interpretazione, magari decontestualizzata,come succede per tutte le frasi celebri, diventi una specie di via di fuga difronte alle responsabilità e alle condizioni reali del mondo, facendo credereche sia il rapporto con gli altri che crea problemi,mentre l’io sarebbe in qual-che modo suscettibile di salvezza, nella sua integrità o nel suo isolamento, ocose simili. Quindi no, io credo che si potrebbe rispondere che l’infernosiamo noi, nel senso in cui non rispondiamo adeguatamente a delle possibi-lità e a delle esigenze, a degli imperativi, che possiamo porre a noi stessi.
Uno spettro si aggira nei salotti buoni dell’Occidente, sia quelli giorna-listici che quelli dell’immaginario di massa: il fondamentalismo. Che, inquanto assolutamente inaccettabile e incomprensibile, rappresenta unadelle figure più forti dell’alterità assoluta, in particolare quando è incar-nata da un personaggio come Osama Bin Laden, che è diventato quasipiù un mito mediatico che una persona reale. Ma il fondamentalismo, inquesto Occidente dei Bush e delle Oriana Fallaci, dei Bossi e dei Le Pen,è davvero “altro”, totalmente “altro”?
Ecco, qui è il caso di pensare a «l’inferno sono gli altri!». Siamo tutti più omeno, (“tutti” è un pò eccessivo), siamo tutti in qualche modo dei “fonda-mentalisti”, che accusano gli altri di esserlo. Ognuno di noi ha delle tavoledei valori che considera universali e perenni e accusa gli altri di essere aldi fuori della retta via e delle posizioni coerenti, rigorose, che occorrereb-be assumere. Io penso che potenzialmente si debba avere un’idea univer-sale di democrazia.Vedo nello sviluppo della globalizzazione, accanto agliorrori che comporta naturalmente lo sviluppo capitalistico,anche una base
221Riccardo Bonavita
20
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 221
necessaria per sviluppare davvero un discorso «genericamente umano».Questo è un compito che viene però sabotato da queste realizzazioni stes-se, nel senso che ora domina una forma peculiare di integralismo: l’inte-gralismo della democrazia borghese capitalistica, fondata sullo sfruttamen-to del lavoro, e sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, che sta svi-luppando in questa direzione non universale né umana tutte le sue possi-bilità tecnologiche, in una nuova organizzazione multinazionale. A cui sireagisce protestando con i movimenti “No-logo” e “No-global” e via dicen-do, che sono il germe poi di una protesta che è auspicabile superi certenostalgie spesso regressive verso un mondo pre-globalizzazione e davverosi sforzi di procedere oltre, al di là della globalizzazione capitalista.A quel punto nasce anche la critica del nostro integralismo, voglio dire diquello che viene praticato effettivamente a casa nostra.Al momento attua-le certo si presenta un conflitto molto drammatico tra – appunto – un’ef-fettiva egemonia borghese e un’egemonia potenziale che si va manife-stando nel cosiddetto fondamentalismo islamico. Devo dire che nel fon-damentalismo islamico io sento il rischio, molto, molto forte, del fascinopericoloso che può esercitare un atteggiamento terribilmente nostalgiconei confronti di un mondo anteriore – appunto – alla globalizzazione, unmondo strutturato religiosamente, con dei valori ben definiti. I valori laicisono certamente più plastici, perché permettono – almeno potenzial-mente – un dialogo più effettivo, e anche una dialettica più concreta, datoche il capitalismo – come diceva Marx – produce il proletariato,cioè il suoantagonista, il soggetto potenziale della sua completa trasformazione o delsuo superamento. Marx infatti polemizzò contro quegli aristocratici“regressivi” che avevano altre posizioni, anche di tipo socialista, e che «cel’hanno con la borghesia» – diceva – «ma solo perché produce comuni-smo». Così diceva Marx, sostenendo quindi che nello sviluppo borghese èimplicito contemporaneamente un elemento di contraddizione internamolto forte. Nell’Islam, nella cultura e nella società islamica nel suo com-plesso, questo processo generatore di contraddizioni è molto più debole.Sono gli ultimi religiosi, noi siamo certamente più laici. C’è qualcosa diarcaico. Ieri è apparsa una notizia – sto parlando dell’11 giugno del 2002– su tutte le reti televisive, su di un ordigno atomico abbastanza primitivoche comunque, per quello che si dice e si sa (e posto che sia vero) era invia di preparazione a Chicago, per opera di un cittadino americano con-vertito all’Islam. Evidentemente anche all’interno dell’America stessa cisono degli integralisti che si convertono alla versione fondamentalista del-l’Islam perché affascinati da un mondo compatto, compatto nelle suenostalgie e nel suo arcaismo. Bene o male noi siamo riusciti, seppure aprezzo di mille confusioni e ritardi (è un problema che non si è mica risol-to una volta per sempre – e del resto non esistono problemi risolti unavolta per sempre) a riconoscere che altro è un diritto religioso, altra cosaè un diritto giuridico o della società in generale; nel fondamentalismo isla-mico, invece, la congiunzione è pressoché perfetta.
222 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 222
Molte delle critiche che gli vengono rivolte sono però assolutamente “Fal-laci”, è proprio il caso di dirlo. Penso a una questione molto banale: noievidentemente proviamo orrore per istituzioni arcaiche come la lapida-zione, il taglio della mano e via dicendo, però l’Impero del mondo praticatranquillamente, tra i tanti suoi orrori, la sedia elettrica e altre forme di ese-cuzione capitale.A noi pare che sia imperdonabile che uno sia lapidato,mentre, se viene ucciso con la corrente elettrica... oserei dire che sonoorrende questioni di gusti!Tuttavia occorre pure riconoscere che è molto difficile superare un impe-rativo religioso, mentre si può arrivare più facilmente a farlo per via laica,dicendo «combattiamo contro la pena di morte in assoluto»; se questa inve-ce è prevista dalla tradizione religiosa come un dovere fondamentale, effet-tivamente opporvisi diventa molto più difficile. Insomma, in certe posizio-ni islamiche c’è una dimensione arcaica, che si trova molto spesso nellerivendicazioni di autonomia di popoli emarginati, che hanno ragione dicombattere contro sfruttamento e colonialismo,ma spesso nel farlo si ripie-gano sopra le loro tradizioni, comprese quelle religiose. È quello che, peresempio, mi lasciava molto perplesso nelle rivendicazioni del Chiapas, incui si ripropongono forme arcaiche di comunismo, o degli indiani d’Ame-rica che pretendono sia rispettata la sacralità di una data montagna. Sobenissimo che si fanno cose altrettanto terribili per mantenere Gerusalem-me o Betlemme come luoghi sacri, però nella moderna cultura occidenta-le forse siamo più vicini, malgrado tutto, a dire che altro è quello che inte-ressa alla Chiesa cattolica o alla comunità dei religiosi ebraici o altro è quel-lo a cui noi possiamo guardare su un terreno propriamente politico –pur-ché non vincano gli integralismi nostri. Certo poi tutti i popoli si credonol’ombelico del mondo, e questo è difficilissimo da superare...
Una figura dell’altro nell’Europa di oggi è anche l’immigrato. Molto eva-nescente nella sua realtà sociologica – ci sono immigrati di ogni tipo –e contemporaneamente fissato in forti stereotipi nei media e nell’im-maginario. Secondo lei questa alterità può rappresentare una risorsaper la scrittura?
Mah, su questo ho dei dubbi. Certamente il rimescolarsi delle culture edelle lingue ormai è un fenomeno di grandissima portata e credo che, perquante chiusure si possano proporre, non si potrà comunque cancellare.Non è più possibile tornare indietro rispetto a certi fenomeni, che però,più che sulla scrittura, agiscono sul costume e sulla lingua. Quello checomunque – mi sembra – rimane assolutamente tipico della globalizza-zione è il fatto che globalizzazione vuol dire soprattutto occidentalizza-zione. E vuol dire occidentalizzazione perchè vuol dire egemonia dellaborghesia, del capitalismo, ecc. Il dominio dell’Occidente è connesso,come mi piace dire,alla “invenzione”della borghesia.Cioè:che cosa è man-
223Riccardo Bonavita
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 223
cato all’Islam per mantenere i suoi domini in età contemporanea? Unaborghesia. Per fare un esempio: perché è più arcaico e debole l’integrali-smo islamico, nella sua possibilità di sviluppo storico? Perché è pre-bor-ghese. Basta aprire la televisione e vedere tutti i popoli della terra che siconfrontano nel gioco del calcio, chiedersi cosa è oggi uno stadio, e con-siderare la mitologia che ormai ha pressoché invaso il mondo, per cui icinesi o i giapponesi sono affannati a tifare quanto gli americani, tutte cul-ture che erano fondamentalmente estranee alla tradizione del calcio.Insomma i principali fenomeni della cultura di massa occidentale diven-tano globalizzati. In questo contesto,certo,noi possiamo divertirci a gusta-re certe coloriture etniche nella moda, nel modo di mangiare, in certi ele-menti anche di linguaggio che vengono assorbiti.Tutto questo però man-tiene la tradizione di un’egemonia che prende quello che le serve e respin-ge tutto quello che non è compatibile. Basta pensare a una politica comequella dei MacDonald’s che è proverbiale come forma di planetarizzazio-ne del costume: dopo la spinta, economicamente urgente, tesa a imporreuno standard unificato, adesso si punta molto sulla localizzazione deigusti, gestiti comunque all’interno di un’egemonia globale. Sono insommadelle avvedute concessioni, che permettono però di mantenere fortemen-te stabili dei metodi omogenei di produzione e consumo dei cibi, e un’i-dea di cosa vuol dire mangiare insieme che rispondono in tutto e per tuttoal modello occidentale. Che poi si possa prendere qualcosa... Gli occiden-tali hanno sempre preso tutto quello che serviva loro, basta pensare atutto quello che era arrivato in età moderna dall’America come cibo eso-tico (la patata, il mais, il pomodoro ecc.) e che è diventato per noi un ali-mento assolutamente fondamentale; ma questo non vuol dire che noisiamo rimasti davvero influenzati dal mondo culturale che si trovavaoltreoceano: noi abbiamo solo depredato gli altri di quello che ci servivae ne abbiamo fatto altre cose.
Vorrei concludere con una domanda letteraria “pura” – se mai è possi-bile concepire una domanda letteraria davvero “pura”. «Io è un altro» èun ossimoro che condensa in sé una delle principali rivelazioni dellamodernità letteraria. Le vorrei chiedere di interpretare o commentare lacelebre frase di Rimbaud in un’epoca, quella contemporanea, in cui siparla di postmoderno, di fine della modernità o, con una formula forsepiù felice, di crisi della modernità.
Io l’ho sempre letta in una maniera che può essere arbitraria e non ha nes-suna intenzione filologica. Anche qui la frase celebre diventa un “reperto”che poi assume una sua autonomia; del resto, Rimbaud doveva conoscerela stessa proposizione elaborata da Gérard de Nerval... Ma la sua afferma-zione per me assume un significato ulteriore: designa la capacità di nonsentirsi proprietari del proprio io. Il modello borghese di soggetto è un
224 Interviste
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 224
modello fondato sulla proprietà privata: questa cosa è mia, io sono mio.Questo atteggiamento, con ogni evidenza, rappresenta un progresso sulpiano storico rispetto a un io che non era in grado di sentire la propriaautonomia. Io mi vanto molto di aver scritto una poesia che è l’apologiadella carta d’identità, un documento che, certo, immette all’interno di uncontrollo sociale ma rappresenta un fenomeno di progresso di fronte allaesistenza labile che prima potevano avere i soggetti: è vivo? È morto?Quando è nato? Oggi possiamo essere angosciati di fronte all’ipercontrol-lo e infatti nasce la reazione di chi pretende il diritto alla privacy e viadicendo, mentre in un prossimo futuro saremo pieni di impronte digitaliobbligatorie, probabilmente, per tutti e per sempre, però in germe nellacarta d’identità c’è la conquista di un io libero, autonomo, insomma, comesi dice, del soggetto. Un progresso ulteriore rispetto a questa conquista èl’idea di espropriare,da questa religio possessiva che ha svolto il suo ruolostorico, l’idea dell’io. «L’io è un altro»: cioè è un soggetto che può guar-darsi, vivendo – come a me piace dire – in terza persona, non pensandosiappunto come il centro dell’universo, radice chiusa all’interno di se stes-sa, ma piuttosto come un vivente che assiste alla propria storia, la elabora,la progetta senza avere una sostanza determinata, come un luogo di espe-rienze dove l’io sperimenta se stesso molto più che possedersi. Insomma,l’io deteriormente proprietario è tutto appoggiato sulla frase:“lei non sachi sono io, ma con chi crede di parlare”. Che è come dire:“ma sa quantisoldi ho io, sa quanto sono in una posizione di privilegio”, in ultima istan-za è una manifestazione del privilegio di classe, dell’appartenenza ad unmondo naturalmente molto contagioso che crea un modello che poitende a generalizzarsi. Per molta parte, ripeto, questa forma di soggettivitàha un momento progressivo, di rivendicazione del sé, ma mi pare che oral’interesse stia appunto nel superarlo, e nel pensarsi come uno dei tantiche sono al mondo, cercando di gettare sopra se stessi uno sguardo chevenga dal di fuori. Senza abbandonarsi a quella sorta di implosione dellasoggettività che invece mi pare anche molto frequente – non a caso negliultimi decenni la sociologia, particolarmente americana, che naturalmen-te è più sensibile a certi problemi che si vengono manifestando, parlavadel narcisismo come del male della nostra epoca. Dire «Io è un altro» è unmodo di progettare una lotta antinarcisistica.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/per-corsi/sanguineti_seconda.htm.
225Riccardo Bonavita
007 Interviste_02 2-11-2007 14:58 Pagina 225
Mercanti, viaggiatori e stranieri. Un percorso iconografico attraverso il DecameronRita Boschi
All’interno delle tematiche del Decameron, il tema della Fortuna sembraessere intimamente legato al viaggio e la seconda giornata dove, sotto il reg-gimento di Filomena, «si ragiona di chi,da diverse cose infestato, sia oltre allasua speranza riuscito a lieto fine» è quindi la giornata delle avventure di viag-gio. Nella lenta progressione ascensionale «a principio horribilis et fetidus,in fine prosperus desiderabilis et gratus» che porta le novelle dalle nefan-dezze di Ciappelletto nella prima giornata alla virtù di Griselda che conclu-de la decima, infatti,non è ancora entrato pienamente in gioco l’Ingegno (IIIgiornata) e qui l’uomo che si pone in viaggio, essenzialmente il mercante, èin balia della Fortuna, di un disegno superiore sconosciuto, sovraumano. Levicissitudini della Fortuna portano questi mercanti nelle città più note dellaFrancia, della Provenza, della Borgogna e delle Fiandre (II 3, 8 e 9) e delleIsole Britanniche (II 3 e II 8),ma anche in Spagna (II 7) e Germania (II 1),seguendo le tracce dei traffici e delle navigazioni delle compagnie mercanti-li italiane. Le novelle più interessanti e articolate, dove il viaggio è la veraessenza della narrazione, hanno come sfondo il Mediterraneo, spazio perico-loso e infido, dove tutto può succedere. Così ci vengono offerti quadriambientali dei famosi porti della Morea (II 7), le isole e i pirati del Mediter-raneo Orientale (II 4 e 7) e Occidentale (ancora II 7) e luoghi misteriosicome Tunisi e Alessandria sulle coste dell’Africa (II 6, 7 e 9) dove le ragio-ni del mercatare s’incontrano, e si scontrano, con le ragioni della fede.Un aspetto della poetica boccacciana che può suscitare grandi suggestio-ni e aprire ampi spazi didattici è la figurabilità e la natura “prevalente-mente icastica, caratterizzante, gestuale” delle sue narrazioni. I temi e gliintrecci che si svolgono lungo tutto il percorso decameroniano sono carat-terizzati continuamente da gesti allusivi o simbolici, pieni di sovrasenso.Come afferma Vittore Branca nell’Introduzione al Boccaccio visualizzato,era naturale che questo carattere figurativo delle narrazioni boccacciane
21
Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 227
sfociasse nel corpus di illustrazioni, massiccio e variamente articolato, checostituisce l’oggetto attorno cui ruota la sua opera sopracitata.Seguiremo, pertanto, un tracciato di lettura di alcune novelle cercando dicogliervi i punti nodali attraverso le visualizzazioni che ne vengono fattein opere figurative coeve alla prima diffusione del Decameron in Italia ein Francia. Anticipiamo fin da ora che le visualizzazioni del Decameron,per quanto riguarda la sua parte narrativa, si fermano alla metà del XVsecolo. Dopo questa data prevalgono infatti illustrazioni convenzionali:ritratto idealizzato dell’autore, rappresentazione della brigata, capoletteradecorati o ritratto del re o della regina a inizio giornata.Al centro di quasi tutti i racconti campeggia comunque la figura del mer-cante intraprendente,che non disdegna di praticare talvolta la pirateria, giu-stificata se ai danni degli infedeli; che si gioca il tutto per tutto in una sortadi roulette contro la Fortuna e che mette in campo tutto il suo Ingegno pertrionfare contro avversità, nemici e falsi amici. Landolfo Rufolo (II 7) e, alnegativo,Ambrogiuolo da Piagenza (II 9) ne sono gli esempi più notevoli.
Landolfo Rufolo
L’assoluta centralità della figura del mercante appare chiaramente se siconsidera che la maggioranza dei ritratti contenuti nell’unico manoscrittosicuramente autografo del Decameron appartengono all’ambiente merca-tantesco. Nell’Hamilton 90,1 copiato e illustrato dal Boccaccio stesso, visono 16 ritratti a mezzo busto di altrettanti personaggi delle novelle, pro-babilmente di sua stessa mano, dove la stretta connessione delle figurecon il testo è dimostrata dalla presenza di richiami testuali entro il con-torno del busto e dalla scelta dei personaggi illustrati, che valgono qualiritratti psicologici incarnanti lo spirito stesso della novella.Tra i vari ritratti quello di Landolfo Rufolo è forse il più espressivo (f. 16v).Mostra il viso volto verso sinistra, il capo parzialmente coperto dal cap-pello acquerellato in ocra,come la veste.Nonostante il disegno sommario,più nello stile di un odierno fumetto che un vero e proprio ritratto, sia l’e-spressione del viso che l’inclinazione del buffo copricapo lasciano intuirela natura avventurosa e arrogante di questo mercante salernitano cherischia tutti i suoi beni per ben due volte: la prima armando tutta a suespese una nave per portarla in un mercato lontano, a lui sconosciuto; laseconda vendendo tutto sottocosto col miraggio di rifarsi delle proprieperdite praticando la pirateria ai danni dei Turchi.Nelle raffigurazioni successive della novella di Landolfo, sia che apparten-gano a codici miniati del XIV e del XV secolo, sia che si tratti della xilo-
228 Percorsi didattici
1 Hamilton 90 (B) ora a Berlino, Staatsbibliothek – Preussischer Kulturbesitz, scritto a Firen-ze nel settimo decennio del XIV secolo in littera textualis su due colonne con postille inter-lineari e marginali di più mani, compresa quella del Boccaccio.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 228
grafia che accompagna la prima edizione a stampa del Decameron, ilmomento scelto per essere rappresentato è quello del più drammatico“rivolgimento di fortuna”, con il naufragio di Landolfo al largo dell’isola diCefalonia, il soccorso prestatogli dalla donna sulla spiaggia di Corfù quan-do egli vi arriva aggrappato alla misteriosa cassa e la partenza di Landolfo,nuovamente ricco, per ritornare in patria.Se si osserva l’illustrazione al f. 44r del manoscritto copiato da Lodovico diSalvestro Ceffini, datato dallo stesso copista al 1427 e miniato in ambientefiorentino,2 la scena del naufragio di Landolfo sulla spiaggia di Corfù è vistada un punto di vista rialzato, la classica “prospettiva a volo d’uccello” piut-tosto arcaica,e la vignetta mostra Landolfo in mare che si sorregge alla famo-sa cassa mentre, sulla spiaggia, si trovano due donne (una di esse lava ipanni); sullo sfondo una città cinta da mura. La visualizzazione del codiceCeffini comprende 115 acquerelli monoscenici a colori: non solo uno perciascuna novella,ma due per VIII 9,un ritratto dell’autore in cathedra,quat-tro alla Introduzione, cinque alla conclusione delle giornate I, II,V,VI, IX euna è dedicata al ritorno della brigata a Firenze. Questo manoscritto è ilDecameron di provenienza italiana che offre la più ampia e completa illu-strazione del testo: si tratta di un vero e proprio programma illustrativo con-cepito per lettori non letterati,avidi di trame e vicende appassionanti. Il pro-gramma iconografico fu piuttosto noto e ripreso nei tempi immediatamen-te successivi, in Italia e anche in Francia,e,sicuramente,era conosciuto dagliillustratori della prima edizione a stampa.3
In essa, con un certo appiattimento prospettico, i tre momenti del ritro-vamento dell’esanime Landolfo abbarbicato alla cassa, il soccorso presta-togli dalla donna che lo trascina verso la sua casa e la partenza di Landol-fo dall’isola a bordo di una nave sono posti senza soluzione di continuitàdall’alto al basso e le onde del mare sono schematicamente tratteggiatesulla superficie della cassa cui si aggrappa Landolfo, entrambi rappresen-tati integralmente, ma solo per metà affioranti tra i relitti della nave.A prescindere dalla qualità delle raffigurazioni, la cosa da notare è comun-que la concordanza con cui si sceglie di rappresentare questo momentocruciale della vicenda, in cui Landolfo, da giovane sconsiderato e arrogan-te che, ansioso di tornare alla propria patria, non si cura di nascondere le
229Rita Boschi
2 Il Decameron Ceffini, ms. It 63 della Bibliothéque Nationale de France, porta la data del1427 contestualmente alla firma del copista che, secondo M. G. Ciardi Duprè, ne fu ancheuno dei cinque miniatori. Si tratta quindi di un “copista per passione”e non di mestiere, vistoche si tratta di un mercante operante nella Compagnia dei Bardi. Il manoscritto è il Deca-meron di provenienza italiana che offre la più ampia e completa illustrazione del testo.3 La prima edizione a stampa del Decameron fu pubblicata a Venezia nel 1492 dal De Gre-gori per le cure di Girolamo Squarciafico. Contiene 104 xilografie, una per ciascuna novella,più: il ritratto ideale del Boccaccio, ripetuto due volte,nell’Introduzione e nella Conclusione;la raffigurazione della lieta brigata; due miniature dove la brigata è presieduta rispettiva-mente da una regina (ripetuta sette volte) e da un re (ripetuta tre volte). Di questa edizionesi conservano quattro sole copie, ma le tavole in legno sono state riutilizzate, con qualcheerrore e cambiamento dell’ordine, per altre due edizioni (Manfrino da Monferrato,Venezia1498 e Bartolomeo de’ Zani,Venezia, 1504).
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 229
proprie ricchezze: «E pauroso della mercatantia, non s’mpacciò d’investi-re altramenti i suoi denari,ma con quello legnetto col quale guadagnati gliavea, dato de’ remi in acqua, si mise al ritornare». Giunto nell’Egeo, incap-pa in due navi genovesi di ritorno da Costantinopoli ed è proprio la suaimprudenza a condannarlo perché quelli lo riconoscono e «... già per famaconoscendol ricchissimo, sì come uomini naturalmente vaghi di pecuniae rapaci, a doverlo avere si disposero». Il piano dei genovesi riesce e Lan-dolfo è derubato di tutte le ricchezze e fatto prigioniero.Sembra tutto per-duto quando, mentre è prigioniero su una delle due navi genovesi, la For-tuna si fa viva di nuovo sotto forma di una tempesta che fa naufragare lenavi. «... e Landolfo, ancora che molte volte il dì davanti la morte chiamataavesse, seco eleggendo di volerla più tosto che di tornare a casa sua pove-ro come si vedea, vedendola presta n’ebbe paura...». Finito in mare, siaggrappa prima a una tavola che galleggiava non lontano e poi a una cassa;dopo due giorni in mare, finalmente approda sull’isola di Corfù.È interessante notare come Boccaccio descrive la scena:
[...] Il quale [giorno] venuto, guardandosi egli da torno, niuna cosa altro chenuvoli e mare vedea e una cassa la quale sopra l’onde del mare notando tal-volta con grandissima paura di lui gli s’appressava, temendo non quella cassaforse il percotesse per modo che gli noiasse; e sempre che presso gli venia,quanto potea con mano, come che poca forza n’avesse, la lontanava. Ma,come che il fatto s’andasse, avvenne che, solutosi subitamente nell’aere ungroppo di vento e percosso nel mare, sì grande in questa cassa diede e lacassa nella tavola sopra la quale Landolfo era, che, riversata, per forza Lan-dolfo lasciatola andò sotto l’onde e ritornò suso notando, più da paura cheda forza aiutato, e vide da se molto dilungata la tavola; per che, temendo nonpotere ad essa pervenire, s’appressò alla cassa la quale gli era assai vicina, esopra il coperchio di quella posto il petto, come meglio poteva, colle brac-cia la reggeva diritta.
La novella appartiene alla seconda giornata: è la Fortuna la signora incon-trastata delle vicende narrate, per cui l’ignaro Landolfo tenta di allontana-re la cassa e solo un’ondata più forte delle altre, che l’allontana dall’asse dilegno su cui stava, gli fa afferrare quella che si rivelerà la soluzione di tuttii suoi problemi.Negli altri manoscritti miniati che seguono cronologicamente, e cheappartengono tutti all’area francese e fiamminga,4 nonostante il variare
230 Percorsi didattici
4 Il Decameron fu tradotto in francese da Laurent de Premierfait tra il 1411 e il 1414 grazieallo spazio e ai fondi messi a disposizione dal ricchissimo mercante Bureau de Dammartin,originario di una località vicina al villaggio di Premierfait nella diocesi di Troyes, divenutonobile e valletto del re e finalmente tesoriere di Francia dal 1411 al 1413. Il manoscritto è ilms Pal. Lat 1989 della Biblioteca Apostolica Vaticana, copiato e miniato a Parigi. Non cono-scendo l’italiano, Premierfait si servì di una traduzione latina di Antonio da Arezzo e questodiede luogo ad alcune interpretazioni errate del testo originale. Non sembra, invece, cheabbiano causato significative varianti iconografiche, almeno per quanto riguarda le icono-grafie prese in oggetto.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 230
del numero dei particolari rappresentati e con più o meno articolazionedella scena,gli elementi essenziali della scena sono ridotti, rispetto al codi-ce Ceffini, ai due estremi, con la cancellazione della scena intermedia (ladonna che trascina Landolfo in casa sua).Lo schema è quindi bipartito: Landolfo sulla cassa raggiunge la riva aiuta-to dalla donna; Landolfo, ripresosi, sale sulla nave che lo riporterà a casacon il sacco in cui ha nascosto le gemme in spalla.Secondo questo schema è articolata la miniatura appartenente al Decame-ron dell’Arsenal5 che, per la presenza di due donne, una che lava i panni el’altra che aiuta Landolfo, sembra ricollegabile al codice Ceffini: a sinistra ladonna che raccoglie il naufrago e la sua cassa, a destra – i due momentiseparati dal promontorio sul quale si colloca la città – il momento della par-tenza di Landolfo, che sale sulla nave tenendo sulle spalle il suo sacco. Lafigura dell’uomo che sale sulla nave appare identica alla precedente, anchese la presenza di un altro uomo, riccamente vestito, sulla soglia della casafa pensare che si tratti di un facchino al servizio di Landolfo.Nel primo manoscritto francese del Decameron, prototipo per la successi-va visualizzazione di area francese,6 si trova l’iconografia semplificata dellavicenda di Landolfo, dove la scena centrale del codice Ceffini scompare esi ha la giustapposizione delle scene iniziale e finale, come nella vignetta alf.43v.In essa troviamo:la donna che trascina a riva Landolfo aggrappato allacassa,anche se la resa pittorica lo fa sembrare piuttosto in procinto di allon-tanarsi da riva sospingendola, sulla sinistra; sulla destra, il momento dellapartenza di Landolfo è fissato, secondo la tradizione, dall’immagine di luiche sale sulla passerella della nave con il sacco dei gioielli in spalla. La resadel paesaggio è del tutto convenzionale e scabra, quasi lunare.Convenzionale nella resa del paesaggio appare anche la miniatura cheaccompagna la novella di Landolfo (f. 57r) nel Decameron conservato allaÖsterreichische Nationabibliotek di Vienna.7 In essa i particolari narrativisono ancora più essenziali:nessun accenno prospettico tenta di rendere cre-dibile la visuale del mare e gli alberelli che affondano le loro radici nella cor-
231Rita Boschi
5 Decameron nella traduzione in francese di Laurent de Premierfait, Parigi, Bibliothéque del’Arsenal, ms 5070. Databile al secondo quarto del XV secolo (tra il 1430 e il 1450), è illu-strato con un centinaio di miniature di diverse mani, ma tutte di area fiamminga (Grammonte Amiens). Sotto alcune immagini sono conservate delle indicazioni per il miniatore scrittein olandese a riprova dell’origine fiamminga di quest’ultimo.6 Il manoscritto del Decameron, traduzione in francese di Laurent de Premierfait,Città del Vati-cano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms Pal. Lat 1989 è stato miniato a Parigi tra il 1414 e il1419 dal Maestro della Cité des Dames.Vi sono una miniatura per ogni novella e ogni minia-tura è suddivisa in due scene che rappresentano i momenti salienti del racconto del Boccac-cio. Le miniature sembrano ispirarsi a un precedente codice miniato italiano, forse proprio ilcodice Ceffini o uno dei manoscritti da questo derivati.Quello che è certo, invece,è che il suoprogramma iconografico è divenuto la linea-guida dei manoscritti miniati successivi.7 Ms. 2561 della Österreichische Nationabibliotek di Vienna. Copia del Decameron nella tra-duzione in francese di Laurent de Premierfait. Il manoscritto, copiato e illustrato in Francianel secondo quarto del XV secolo contiene 100 miniature, sovente in composizioni biparti-te, secondo il modello iconografico fissato dal manoscritto dell’Arsenal.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 231
nice inferiore della miniatura sono anche più piccoli di quelli che si trova-no sui due promontori che delimitano la prima parte della vicenda, illustra-ta a destra,mentre le stelline dorate che punteggiano il cielo blu non hannoalcun legame con la narrazione,dove i due momenti sono ambientati di gior-no.Per quanto riguarda la concordanza dell’iconografia con il testo,poi,è danotare a sinistra la posizione di Landolfo, completamente fuori dall’acqua, ela forma della cassa,che pare un tavolino (forse per consentire alla donna diavvolgere la sua cordicella a uno dei piedi).Sulla destra dell’illustrazione,nelmomento della partenza di Landolfo da Corfù,inoltre,il castello di prua dellanave in partenza scompare dietro la lingua di terra che divide le due scene,mentre l’appoggio di Landolfo sulla passerella della nave appare alquantoprecario. Un dubbio che non mi è stato possibile risolvere riguarda, invece,la posizione della donna nella parte destra della miniatura: la sua somiglian-za con la soccorritrice di Landolfo – soprattutto il copricapo – mi ha fattopensare a una collocazione “erronea” della sua figura sulla nave, e questosarebbe in linea con le precedenti miniature che ripetevano la sua presen-za alla partenza di Landolfo, ma non è da escludere che si possa trattare diuna personificazione della Fortuna, che finalmente accoglie e accompagnaLandolfo nell’ultima parte del suo viaggio.
Ambrogiuolo da Piacenza
Un altro significativo esponente della classe mercantile si trova nella novel-la nona della seconda giornata: Ambrogiuolo da Piacenza, prototipo dellaspavalda spregiudicatezza “lombarda” che non indietreggia davanti a nullapur di raggiungere i suoi scopi.8 Rispetto alla precedente novella, le visua-lizzazioni di II 9 sono più variate e i momenti individuati come salienti con-cordano soltanto per la parte finale della novella, mentre per gli antefatti, viè un’oscillazione tra la scommessa nell’osteria parigina, l’inganno della cassaai danni di Zinevra e il momento in cui la donna sta per essere uccisa.Veroè che, dal momento che la storia di Zinevra è stata assunta dalla borghesiafiorentina come paradigmatica, vero exemplum di virtù muliebre e fedeltàconiugale, per questa novella possediamo anche un’iconografia più com-plessa, tratta da un cassone nuziale fiorentino, databile al 1400 circa.9
In esso, all’interno di una cornice, vi è una narrazione continua distinta intre momenti, che rappresentano gli antefatti: da sinistra a destra abbiamola rappresentazione della riunione di mercanti nell’osteria di Parigi; lascena cittadina entro la quale si consuma l’inganno della cassa data in
232 Percorsi didattici
8 La Lombardia era intesa come Italia settentrionale. Cfr. I 1 le figure dei due ospiti di Ciap-pelletto.9 I cassoni nuziali, nei quali venivano custoditi abiti e dote, erano solitamente in numero di duee presentavano il fronte, se non anche i lati, decorati a pastiglia e smalto. Il cassone in oggetto,dipinto da Giovanni Toscani, è ora ad Edimburgo, National Gallery of Scotland (n. 53) raffigurasoltanto la prima parte della novella;purtroppo,quello con cui faceva coppia è andato perduto.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 232
custodia a Zinevra; i movimenti furtivi di Ambrogiuolo nella camera delladonna, con un’ulteriore suddivisione in tre momenti distinti.Vediamo inprogressione i singoli momenti:
Erano in Parigi in uno albergo alquanti grandissimi mercatanti italiani, qualper una bisogna e qual per un’altra, secondo la loro usanza; e avendo unasera fra l’altre tutti lietamente cenato, cominciarono di diverse cose a ragio-nare; e d’un ragionamento in altro travalicando, pervennero a dire delle lordonne, le quali alle lor case avevan lasciate. E motteggiando cominciò alcu-no a dire: – Io non so come la mia si fa, ma questo so io bene, che quandoqui mi viene alle mani alcuna giovinetta che mi piaccia, io lascio stare dal-l’un de’ lati l’amore il quale io porto a mia mogliere, e prendo di questa quaquel piacere che io posso.
Entrati in argomento durante un desinare in una locanda parigina, Berna-bò da Genova sostiene l’assoluta fedeltà e onestà della moglie; contro lasua convinzione argomenta un altro mercante,Ambrogiuolo da Piagenza.Si giunge a una scommessa: cinquemila fiorini d’oro contro mille cheAmbrogiuolo, tempo tre mesi, ritornerà a Parigi con le prove che la mogliedi Bernabò gli ha ceduto.Troviamo la rappresentazione della riunione deimercanti nella parte più a destra della fronte del cassone: in un ricco inter-no, si noti i drappi appesi alle pareti, alcuni personaggi stanno attorno aun desco; al di là della tavola vi sono cinque personaggi che osservanoquello che sta avvenendo e la loro gestualità enfatizzata serve per espri-mere la concitazione della discussione che ha portato alla scellerata deci-sione.Da sinistra giunge un servo con carta e calamaio per fissare gli estre-mi della scommessa tra Bernabò (a destra, vestito di nero) e Ambrogiuolo(seduto a sinistra, vestito di rosso).Subito dopo,Ambrogiuolo si reca a Genova e non tarda a rendersi contoche Bernabò ha detto il vero,ma non demorde e, visto che l’impresa appa-re irrealizzabile, escogita una truffa e riesce a far introdurre una cassa,nella quale si nasconde, nella camera da letto della moglie di Bernabò. Lascena occupa la parte centrale del pannello e si compone di diversimomenti trai quali la contrattazione con l’amica di famiglia e il momentoin cui questa bussa alla porta di Zinevra per introdurre la cassa. La narra-zione passa poi ancora a destra, dove si trova la visualizzazione di ciò cheavviene nella camera di Zinevra durante la notte:
Rimasa adunque la cassa nella camera e venuta la notte, all’ora che Ambro-giuolo avvisò che la donna dormisse, con certi suoi ingegni apertala, cheta-mente nella camera uscì, nella quale un lume acceso avea. Per la qual cosaegli il sito della camera, le dipinture e ogni altra cosa notabile che in quellaera cominciò a ragguardare e a fermare nella sua memoria. Quindi, avvicina-tosi al letto e sentendo che la donna e una piccola fanciulla, che con lei era,dormivan forte, pianamente scopertola tutta, vide che così era bella ignudacome vestita, ma niuno segnale da potere rapportare le vide, fuori che unoch’ella n’avea sotto la sinistra poppa,ciò era un neo d’intorno al quale erano
233Rita Boschi
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 233
alquanti peluzzi biondi come oro; e, ciò veduto, chetamente la ricoperse,come che, così bella vedendola, in disiderio avesse di mettere in avventurala vita sua e coricarlesi allato. Ma pure, avendo udito lei essere così cruda ealpestra intorno a quelle novelle, non s’arrischiò; e statosi la maggior partedella notte per la camera a suo agio,una borsa e una guarnacca d’un suo for-ziere trasse e alcuno anello e alcuna cintura, e ogni cosa nella cassa suamessa, egli altressì vi si ritornò, e così la serrò come prima stava; e in questamaniera fece due notti, senza che la donna di niente s’accorgesse.
La stessa scena, con Ambrogiuolo che scopre Zinevra dormiente, è al fol.78r del ms. It. 63, ora alla Bibliothèque Nationale di Parigi.10
La miniatura si trova in testa allo specchio di scrittura e vede Ambrogiuo-lo che, nella camera di Zinevra, sta per scoprirla. La stanza è rappresenta-ta come una scatola aperta, la cui visuale non si combina affatto con quel-la del monumentale letto in cui giace la donna; la cassa in cui si nascon-deva Ambrogiuolo, poi, non sembra avere alcuno spessore.Le miniature apparenenti ai manoscritti successivi, mostrano una spiccatapreferenza, come antefatto, per la scena dell’introduzione della cassa conte-nente Ambrogiuolo nella casa di Zinevra: si noti che nelle miniature seguen-ti Ginevra si occupa costantemente del medesimo lavoro femminile; inoltre,l’accento è messo sull’elemento della cassa (parallelismo tra la cassa chenasconde Ambrogiuolo e la cassa che contiene i doni del sultano).Iconograficamente molto simili sono, pertanto, le visualizzazioni di areafrancese, sia per quanto riguarda la prima scena, sia per quanto riguarda laseconda: f. 71v del ms. Pal. Lat 1989 della Biblioteca Apostolica Vaticana,11
f. 84r del ms. 5070, Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi,12 f. 90v del ms.2561, Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, f. 97v del ms. Fr.12421, Bibliothèque Nationale di Parigi.Tra l’immagine del ms. Pal. Lat. 1989 e quella del ms. 5070 dell’Arsenal, lesomiglianze sono talmente nette da far riconoscere una derivazione diret-ta: la scena è bipartita, con a sinistra la scena nella quale la cassa è porta-ta in un interno aperto e Zinevra mostra ai piedi un arcolaio per la tessi-tura; sulla destra è rappresentato il momento conclusivo della narrazione,che chiameremo sinteticamente “il giudizio del soldano”.Ma riprendiamo il filo della novella: dopo aver fraudolentemente vinto lascommessa,Ambrogiuolo scompare dalla narrazione e si consuma la tra-gedia familiare: Bernabò ordina l’omicidio della moglie; la donna scampa,ma deve fuggire, in abiti maschili, e prende il nome di Sicurano.Troviamol’unica raffigurazione di questo momento della novella nelle xilografie del-l’edizione De Gregori.13 Sulla sinistra è rappresentato il servitore di Ber-nabò con una spada in mano, mentre Zinevra in ginocchio lo supplica di
234 Percorsi didattici
10 Vedi nota 2.11 Vedi nota 6.12 Vedi nota 5.13 Vedi nota 3.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 234
salvarle la vita. Si discosta leggermente anche l’iconografia del secondoriquadro, leggermente anticipata rispetto alle altre, in quanto mostra unmomento antecedente la formulazione, e l’esecuzione, del giudizio: l’am-bientazione è un interno e, nei nomi indicati, Zinevra è ancora Sicurano.Assunta questa nuova identità maschile, Zinevra è finita ad Alessandria d’E-gitto,presso il soldano,ed è qui,nell’Oriente islamico che i fili del destino deitre protagonisti principali tornano ad intrecciarsi e si ha il “rivolgimento dellaFortuna”che domina l’intera giornata di narrazioni decameroniane.Incaricata di allestire una fiera internazionale a San Giovanni d’Acri, Gine-vra/Sicurano incontra Ambrogiuolo, che ancora si vanta della beffa fatta alcredulo Bernabò ammettendo, anzi, di essere al corrente del supposto, tra-gico, epilogo: «ed egli, che più tosto sé della sua bestialità punir dovea chelei d’aver fatto quello che tutte le femine fanno, da Parigi a Genova tor-nandosene, per quello che io abbia poi sentito, la fece uccidere». Com-prendendo la dinamica dell’inganno, la donna prepara la sua contromossae fa venire ad Alessandria lo stolido marito e, riuniti entrambi i suoi accu-satori alla presenza del soldano, obbliga alla confessione Ambrogiuoloprima dello svelamento della propria identità.Si è qui nel punto nodale della vicenda, quando l’azione passa nelle manidel soldano:
Il soldano appresso comandò che incontanente Ambrogiuolo in alcuno altoluogo della città fosse al sole legato ad un palo e unto di mele,né quindi mai,infino a tanto che per sé medesimo non cadesse, levato fosse; e così fu fatto.Appresso questo, comandò che ciò che d’Ambrogiuolo stato era fosse alladonna donato; che non era sì poco che oltre a diecimilia dobbre non vales-se;ed egli, fatta apprestare una bellissima festa, in quella Bernabò,come mari-to di madonna Zinevra, e madonna Zinevra sì come valorosissima donna,onorò, e donolle che in gioie e che in vasellamenti d’oro e d’ariento e chein denari, quello che valse meglio d’altre diecemilia dobbre.
Riprendiamo ora le miniature di f. 90v del ms. 2561, Österreichische Natio-nalbibliothek di Vienna,14 f. 97v del ms. Fr. 12421, Bibliothèque Nationale diParigi.15
Anche in questo caso è possibile istituire un rapporto diretto tra le minia-ture, pur se si nota un influsso della precedente tipologia sulla miniaturaappartenente al ms. Fr. 12421: nell’episodio dell’entrata di Ambrogiuolonascosto nella cassa, anziché la rappresentazione simbolica dell’arcolaio ai
235Rita Boschi
14 Vedi nota 7.15 Ms. Fr. 12421 della BNF di Parigi.Versione in francese del Decameron, nella traduzione diLaurent de Premierfait. Miniato in due momenti diversi: nel secondo quarto del XV secolo ealla fine del XVII per i fogli 69, 245, 258-62, 372, 409, 412, 416-21, 423-48. I fogli rifatti nelXVII secolo hanno miniature in stile con l’epoca del rifacimento e riguardano le illustrazio-ni delle novelle II 6,V 9,VI 1, 2, 3, 4, IX 1, X 5, 7, 8, 9, 10; le miniature quattrocentesche s’i-spirano a quelle del ms. Arsenal, ma anche al manoscritto della Österreichische. Il mano-scritto fu un regalo del duca di Gloucester al cugino, conte di Warwich.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 235
suoi piedi, come nelle due precedenti, Zinevra è mostrata mentre lavoracon esso. Nella miniatura dell’Österreichische, inoltre, la scena appareribaltata e il facchino che porta la cassa entra da destra.Sull’altro lato,dovela narrazione si conclude con il risarcimento di Bernabò e Zinevra, conte-stualmente alla punizione di Ambrogiuolo, si può notare l’assenza dei tafa-ni sul corpo di Ambrogiuolo, che pare un poco un san Sebastiano.Più convenzionale appare, invece, la miniatura del ms. Fr. 12421 che, puraccogliendo il motivo di Zinevra che tesse, nella parte destra riprende laconsueta articolazione dello spazio, anche se isola Ambrogiuolo sulla destrariservando ai due sposi il posto d’onore al centro della scena. Ma, e il Boc-caccio lo dice chiaramente, nemmeno Bernabò è un personaggio positivo,al pari di Ambrogiuolo. In diversi punti della novella, per bocca di diversipersonaggi, sia interni che esterni alla narrazione, traspare il giudizio del-l’autore sul mercante genovese: nella perorazione di Zinevra al soldano,dopo il suo svelamento, la donna dice: «“Signor mio, io sono la misera sven-turata Zinevra, sei anni andata tapinando in forma d’uom per lo mondo, daquesto traditor d’Ambrogiuol falsamente e reamente vituperata,e da questocrudele e iniquo uomo [Bernabò] data ad uccidere ad un suo fante e a man-giare a’lupi...”»;nell’introduzione alla novella seguente,quella di Paganino daMonaco,Dioneo dirà «“Belle donne,una parte della novella della reina m’hafatto mutar consiglio di dirne una, che all’animo mio era, a doverne un’altradire; e questa è la bestialità di Bernabò...”»; lo stesso Ambrogiuolo, narrandodella scommessa, parla della bestialità di Bernabò.Personaggi positivi appaiono, invece, la bella e saggia Zinevra, non a casoassunta ad exemplum dell’amore e della fedeltà coniugale, e il soldanoche, al contrario del marito, s’adopera affinché i danni subiti dalla donnavengano prestamente risarciti: «Il soldano [...] la verità conoscendo, consomma laude la vita e la constanzia e i costumi e la virtù della Zinevra, infi-no allora stata Sicuran chiamata, commendò. E, fattili venire onorevolissi-mi vestimenti femminili e donne che compagnia le tenessero, secondo ladimanda fatta da lei, a Bernabò perdonò la meritata morte» e poi «Appres-so questo, comandò che ciò che d’Ambrogiuolo stato era fosse alla donnadonato; che non era sì poco che oltre a diecimilia dobbre non valesse; edegli, fatta apprestare una bellissima festa, in quella Bernabò, come maritodi madonna Zinevra, e madonna Zinevra sì come valorosissima donna,onorò, e donolle che in gioie e che in vasellamenti d’oro e d’ariento e chein denari, quello che valse meglio d’altre diecemilia dobbre».
Messer Torello e il Saladino
La figura del soldano, severo giudice certo, ma anche uomo in grado disuperare i propri pregiudizi di genere molto meglio del genovese Berna-bò, richiama immediatamente alla mente un’altra novella del Decameron,quella di Torello e il Saladino, appartenente alla decima e ultima giornata,
236 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 236
immediatamente prima della conclusione di Griselda. Siamo in tutt’altratemperie: la decima giornata segue il comando di Panfilo, che richiedenovelle che parlano «di chi liberalmente o vero magnificamente alcunacosa operasse intorno a’ fatti d’amore o d’altra cosa», ma è ancora unanovella che parla di mercanti, di viaggi in Oriente e di quel nuovo con-cetto borghese di “nobiltà dello spirito”che fa sì che messer Torello di Stràda Pavia rivaleggi con il leggendario Saladino.16
La vicenda appare illustrata da una coppia di cassoni nuziali fiorentini,databili al 1400 circa,che si sono conservati entrambi.La prima parte dellanovella è illustrata dal cassone ora al Museo del Bargello di Firenze.17 L’in-dividuazione del soggetto come Decameron X 9 risale al 1919 per operadi Tancred Borenius; a lui si deve anche l’aver riconosciuto il pendant diquesto cassone.Nel primo cassone,quello del Bargello,vi sono tre formelle polilobate,conla narrazione che procede da sinistra a destra. Le scene sui fianchi, moltorovinate, mostrano una donna tra due uomini. Sulla fronte, da sinistra adestra: messer Torello di Strà da Pavia, ricco cittadino del luogo, accoglie ilSaladino travestito da mercante; la moglie di messer Torello offre ricchidoni agli ospiti che si stanno congedando; partenza di Torello per la cro-ciata, quando riceve dalla moglie l’anello e la promessa di non rimaritarsiprima di un anno, un mese, un giorno.La narrazione procede nel cassone gemello, ora in collezione privata, dicui si conosce solo una riproduzione fotografica in b/n.18 Vi sono le mede-sime tre formelle polilobate racchiuse da una decorazione in pastigliadorata; la narrazione procede da sinistra a destra: il Saladino libera Torello,che non ha ancora riconosciuto, dalla prigione di Alessandria d’Egitto e loaccoglie presso di sé come falconiere;Torello, barbuto e vestito all’orien-tale, si risveglia dopo il viaggio sul letto magico nella chiesa di san Pieroin Ciel d’oro di Pavia, alla presenza dell’abate e di due monaci esterrefat-
237Rita Boschi
16 Salah ed-din (1137-1193) sultano del Cairo (Babilonia), riconquistò Gerusalemme nel1187. Di lì a pochi anni la Cristianità si mobilitò nella fallimentare terza crociata, alla qualeparteciparono anche l’imperatore Federico Barbarossa (trovandovi la morte) e il re d’In-ghilterra Riccardo Cuor di Leone. La figura del Saladino godette di un singolare favore nellafantasia popolare e nella letteratura medioevale d’Occidente. Boccaccio lo volle come pro-tagonista di due novelle: questa (X 9) e quella di Melchisedech giudeo (I 3). Non si tratta,invece, dello stesso soldano della novella precedente che, dal momento che Acri è in manoai musulmani, si colloca cronologicamente dopo il 1291.17 Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. N. 160. Il cassone, attribuito al Maestro di Carlodi Durazzo (Francesco di Michele, autore di una tavola raffigurante appunto la conquista diNapoli avvenuta nel 1381 ad opera di Carlo III di Durazzo), ha una fronte dipinta a temperaraffigurante in tre formelle polilobate l’inizio della novella IX 9 con protagonisti Torello e ilSaladino.Eseguito in ambito fiorentino attorno al 1400 circa, fu acquisito nel 1897 dal Museodel Bargello insieme ad altri arredi provenienti dallo Ospedale di santa Maria nuova.18 Maestro di Carlo di Durazzo, 1400 circa,Venezia, collezione privata. Se ne hanno notizie inquanto fu acquistato nel 1939 dal conte Vittorio Cini per il castello di Monselice. È il forzierereso noto dal Borenius che vi riconobbe il compagno di quello conservato al Bargello, raffigu-rante la prima parte della novella di X 9. Dopo essere stata nel, ora è in collezione privata.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 237
ti. Sul letto compaiono la corona, regalo del Saladino per la moglie di Torel-lo, e due vasi pieni di monete; la moglie di Torello,Adalieta, durante il ban-chetto dato in occasione delle sue seconde nozze, riconosce e abbracciail marito reggendo la coppa nella quale il marito ha fatto scivolare l’anel-lo da lei ricevuto il giorno della partenza per la terra santa. Le condizionidella pittura a tempera sembrano peggiori, rispetto a quelle del cassoneora al Bargello, ma l’iconografia è ancora riconoscibile.I sei episodi illustrati nel cassone, comunque, riassumono perfettamente losvolgimento della narrazione, che si articola appunto su due cicli gemelli:– il viaggio del Saladino travestito da mercante nelle terre d’Occidente, chedetermina l’incontro con messer Torello che subito gli offre ospitalità;– fatto prigioniero durante la crociata,Torello diventa il falconiere del Sala-dino, senza che questi lo riconosca;– la generosità di quest’ultimo si estende anche all’accoglienza della mogliedi lui ed entrambi fanno a gara per rendere confortevole il viaggio di queimercanti sconosciuti;– riconosciutolo, il Saladino lo riempie di doni facendolo diventare quasiun suo pari. La magnanimità del Saladino si spinge fino a procacciare aTorello i servizi di un negromante per farlo ritornare a Pavia;– la partenza di Torello per la crociata che ne determina il capovolgimen-to di ambientazione;– con il ritorno a casa, in tempo per scongiurare le nuove nozze della suaamata sposa Adalieta, la magnanimità di Torello viene premiata.Nelle miniature dei codici, generalmente la novella di Torello è illustratapiù sinteticamente: nel Decameron Ceffini19 la miniatura è una monosce-nica che raffigura il momento conclusivo della vicenda con Torello, bar-buto e con il turbante (secondo da sinistra) che siede alla mensa delleseconde nozze della moglie, raffigurata con la corona in capo e la coppa,nella quale è nascosto l’anello che darà luogo al riconoscimento.In area francese20 prevalgono le visualizzazioni a due scene contigue, eallora viene scelto un episodio da ciascuna delle due parti che compon-gono la narrazione, come nell’esempio al f. 312v del ms.Pal. Lat 1989 dellaBiblioteca Apostolica Vaticana, dove la scelta privilegia il momento in cuiil Saladino riceve i doni dalla moglie di Torello, per la prima parte, mentrela seconda parte della narrazione vede messer Torello che fa ritorno sulletto magico. Medesima scelta nel ms. 5070 dell’Arsenal di Parigi, mentrela descrizione del ms. Fr. 12421 della BNF di Parigi sembra riportare l’at-tenzione sul banchetto finale durante il quale Torello fa la sua ricomparsae si fa riconoscere.
238 Percorsi didattici
19 Vedi nota 2.20 Non si possiedono le riproduzioni di tali miniature relativamente alla novella di Torello edel Saladino. Le informazioni del caso sono desunte dalle schedature che accompagnano ilsaggio di Brigitte Buettner, Il commercio di immagini: i mercanti, i Rapondi e il Boccac-cio in Francia, vol. III del Boccaccio visualizzato a cura di V. Branca.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 238
Bipartita è, infine, la xilografia appartenente alla prima edizione a stampadel Decameron21 dove troviamo, a destra, il volo del letto magico, signifi-cativamente sostenuto da piccoli demoni, mentre il momento convivialetra Torello e il Saladino, accomunato ai suoi due compagni dallo stranocopricapo, è posto sulla sinistra.Sembra esserci una singolare oscillazione nell’iconografia tra Torello e ilSaladino: se nella miniatura del Decameron Ceffini Torello appare con unturbante in testa e barbuto,concordemente al testo che recita: «[il Saladino]comandò che a messer Torello, il quale era già forte, fosse messa in dossouna roba alla guisa saracinesca, la più ricca e la più bella cosa che mai fossestata veduta per alcuno, e in testa alla lor guisa gli fece una del le sue lun-ghissime bende ravvolgere».La raffigurazione del Saladino oscilla, invece, tragli attributi “saracineschi”dei primi riquadri del cassone del Bargello e quel-li generici dell’uomo di potere della seconda parte del cassone,nel riquadroin cui il Saladino fa uscire Torello dal carcere di Alessandria.Il copricapo, simile a una tiara vescovile, è lo stesso che ritroviamo nelleminiature del giudizio del soldano relative alla novella di Ambrogiuolo22
ma anche nella miniatura che, nel ms. Pal. Lat 1989 della Biblioteca Apo-stolica Vaticana, visualizza la novella di Tito e Gisippo, di ambientazioneclassica.23 Sembrerebbe, quindi, che l’attenzione dei primi visualizzatoridel Decameron sia tutta concentrata sulle dinamiche del potere e dellaricchezza, delle rivendicazioni a uno status di nobiltà dello spirito daparte dei ricchi mercanti mentre, al contrario, sembra accolta l’istanza delBoccaccio sulla sostanziale parità delle tre grandi religioni monoteiste o,meglio ancora, sulla sostanziale trasversalità di pulsioni dell’animo umanoquali la generosità, la lungimiranza, la fedeltà e la riconoscenza.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/for-mazione/boschi.htm.
239Rita Boschi
21 Vedi nota 3.22 Il riferimento è alle illustrazioni al f. 71v del ms. Pal. Lat 1989 della Biblioteca Apostolica Vati-cana (vedi nota 6) e al f. 84r del ms. 5070, Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi (vedi nota 5).23 La novella di Tito e Gisippo (X 8) è dichiaratamente ambientata nell’antica Roma. ScriveBoccaccio «Nel tempo adunque che Ottavian Cesare,non acnora chiamato Augusto,ma nellouficio chiamato triumvirato lo ’mperio di Roma reggeva ...» datando la vicenda tra il 43 e il30 a.C., come precisa Branca. La miniatura del codice Vaticano che accompagna la novella, èbipartita e mostra, nella parte destra, il momento del giudizio di Gisippo davanti al pretoreMarco Varrone, rappresentato con il medesimo copricapo delle precedenti.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 239
Medusa e le altre. Lo sguardo della donna e l’occhio del poeta tra mito e letteraturaMara Ferroni
Il presente percorso propone un excursus storico-letterario per verificarecome sia stata recepita, accolta e diversamente codificata in tòpos lettera-rio l’immagine dello sguardo della donna come veicolo del passaggio diAmore e come strumento che irretisce e annichila l’uomo e in particola-re il poeta.L’analisi di una “struttura microtestuale profonda”1 come può essere untòpos poetico per cercare di individuarne le implicazioni e il significatonei diversi brani ed opere presi analizzate, è una modalità possibile perl’insegnamento della letteratura, utile per una didattica letteraria che siconfiguri come breve, non perché temporalmente ridotta, ma perché sin-teticamente comprendente l’essenzialità degli autori e dei testi esaminati.Secondo il principio didattico che vede nella lectio (di origine medievale) lapresa in esame e la disanima di diversi brani reciprocamente legati al fine diaprire un confronto e un paragone tra questi e la vicenda personale di ognu-no, tra l’esperienza unica dell’allievo e del maestro,possiamo dire che riflet-tere sullo sguardo dell’altro attraverso l’elaborazione di un tòpos diventa,contenutisticamente e metodologicamente, occasione di lettura di sé. Dalpunto di vista del contenuto ci offre la possibilità di percepire noi stessi nel-l’altro,di vederci rispecchiati nei suoi bisogni e nelle sue domande,nei suoitentativi di risposta, interpretandone uguaglianze e diversità. Dal punto divista più strettamente metodologico, propone come centrale la dinamicadel paragone e del confronto e permette di comprendere in modo più sot-tile permanenze e mutamenti, sfumature ed evidenze.Ragionare sulla comunicazione per veduta, in particolare su quella amo-rosa, e verificare come tale immagine sia stata topicamente costruita ecodificata nella nostra letteratura, diventa per noi e per i nostri alunni sti-molo e occasione per partecipare empaticamente e simpateticamente allapropria e all’altrui esperienza: sentirsi riconosciuti pupille nelle pupille, inconformità all’etimologia stessa di questo termine che descrive l’uomocome la “piccola bambolina”, letteralmente pupilla, che si rispecchia nel-l’occhio dell’altro.
240 Percorsi didattici
1 Si veda Didattica Breve delle discipline umanistiche all’indirizzo http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer http://www.irreer.it/db/dbfra1.html, paragrafo 8 Distillare la letteratura.
22
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 240
Uno sguardo antropologico
Già la grecità arcaica, alla base dell’immaginario occidentale, ha codificatol’idea dello sguardo femminile come strumento di seduzione. È nel mitogreco che trova altresì rispondenza il concetto del pericolo insito nellosguardo femminile. È una figura mitica quella che incarna la possibilità diannichilimento per l’uomo: Medusa, il mostro dai connotati femminili, cheTeseo, eroe portatore della razionalità, è costretto a decapitare, per riusci-re a bloccarne l’effetto malefico. Medusa ha tratti specificatamente fem-minili, gli autori ce la descrivono essenzialmente come mostro dalle sem-bianze di donna, per cui già nel racconto mitico è contenuto un implicitoparagone tra la pericolosità del mostro e la sua natura prettamente fem-minile.Vogliamo partire da questo racconto mitologico poiché esso testi-monia la longevità antropologica della paura insita nel cuore dell’uomoper lo sguardo femminile.Per rappresentare l’impatto emotivo del mito e suggerire la virulenza dellafascinatio di Medusa, ci si può servire della forte rappresentazione cara-vaggesca.Nel dipinto di Caravaggio, la figura dipinta concentra negli occhitutta la potenza espressiva del quadro, ed è proprio lo sguardo straniato espaventato ciò che immediatamente colpisce l’osservatore. Così anche ilVernant, nel saggio più famoso che è stato scritto su questa figura mitolo-gica, conferma che Medusa «è tutta mostruosa, ma concentra negli occhila sua arma fondamentale».2
Ciò che è interessante è il fatto che, paradossalmente, anche nel quadro,lo sguardo del mostro è così spaventato che finisce per essere non tantoil suo, quanto quello di colui che contempla l’occhio di Medusa.Anche questo concetto è paragonabile con quanto Vernant dice, a propo-sito di Medusa e di colui che la osserva: «Fissare Medusa è perdere nel suoocchio, la vista, trasformarsi in pietra dura ed opaca. Per il gioco dell’in-cantesimo, colui che guarda è strappato a se stesso, privato del suo pro-prio sguardo, investito e invaso della figura che lo fronteggia».Arma fondamentale di distruzione per la Gorgone è quindi lo sguardo. LaGorgone ha due tratti caratteristici, la frontalità e la mostruosità.Per impie-trire, la Gorgone deve essere frontale rispetto all’osservatore, per avvol-gerlo in pieno con il suo potere malefico, mentre ha tratti somatici e ico-nografici totalmente mostruosi.Viene descritta con la testa larga a mo’ dileone, con occhi sbarrati e sguardo fisso e penetrante, la chioma invece èanguicrinita mentre le orecchie sono ingrandite.Nel mito della Gorgone si cela il primo nucleo di un’antropologia dellagestualità: lo sguardo e l’occhio hanno un indubbia potenzialità di impat-to e modificazione del reale. Guardare negli occhi Medusa provoca una
241Mara Ferroni
2 J. P.Vernant, La morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’Antica Grecia, Bologna, Il Mulino,1988, p. 41.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 241
metamorfosi, incrociare il suo stesso sguardo anche solo per un millesimodi secondo implica il rinunciare a se stessi. Perdersi nell’occhio della crea-tura gorgonica è trasformarsi in pietra insensibile e incapace di razionali-tà. Come in un incantamento, colui che guarda Medusa non ha più poteresu di sé, privato di uno sguardo che egli possa definire proprio.3
Secondo il mito,nell’età dell’Oro la donna non esisteva.E non esisteva nem-meno la Morte. Con la creazione della donna, da Pandora in poi, l’età del-l’Oro si è dissolta. Peraltro anche nella cultura ebraica è una donna a cau-sare la fine dell’Eden. Questo viene irrimediabilmente a dire che, mitologi-camente, femminilità e morte sono nate insieme. Già in Esiodo4 troviamol’idea che esista una complicità tra le forze notturne della donna e le dotidi seduttrice che la donna ha insite nella sua natura. Si sente nell’elementofemminile una forza che, emergendo dai suoi occhi umidi come quelli divacca e dal suo sguardo,è in grado di infiacchire o addirittura paralizzare lavirilità dell’uomo. Sono i tratti di Medusa presenti naturalmente in ognidonna che agiscono come arma annichilente, propriamente di morte,secondo le bellissime parole di Alcmane: «Attraverso il desiderio che scio-glie le membra ella ha uno sguardo più dissolvente di Sonno e Morte».5 Quila donna, pur avendo valenza gorgonica, utilizza non più l’arma dellamostruosità,bensì,al contrario,quella di una sconvolgente e seducente bel-lezza. Infatti, la donna che nell’epica greca maggiormente è simbolo di ciòè Elena,“assassina di uomini”, il cui epiteto più ricorrente è boopis, lette-ralmente dagli occhi di vacca, ossia grandi e languidi, capaci di creare unlago in cui l’uomo annega. Proprio alla bellezza dei suoi occhi, Ecuba eAndromaca imputano la colpa della distruzione di Troia.6
Nella mitologia, poi, sono tanti i mostri alati, dal petto e dal volto di donnache, a partire dall’età arcaica, i Greci e i Romani hanno rappresentato sulleloro tombe perché facessero la guardia ai defunti, impedendo la profana-zione del sepolcro. Questi mostri sono rappresentati con artigli da rapacee volto inequivocabilmente femminile.L’iconografia della Gorgone in grado di fermare i nemici poteva poi essereistoriata sulle loriche dei generali romani, secondo l’uso mitico che fu giàdella dea Atena, a protezione della vita del soldato e come arma contro inemici. Un esempio di scultura romana locale proveniente dalla coloniaromana di Bononia, è il bellissimo busto di supposta datazione neroniana
242 Percorsi didattici
3 Riporto per il loro fascino le parole esatte del Vernant, La morte negli occhi, cit.: «La pos-sessione: portare una maschera è cessare di essere se stessi e incarnare, per il tempo dellamascherata la potenza dell’Aldilà che si è impadronita di te, di cui tu mimi la facci, gestisci lavoce. La faccia di Medusa è una maschera; questa figura produce l’effetto di una mascherasemplicemente guardandoti negli occhi. È il tuo sguardo che è preso nella maschera. Quan-do tu fissi Medusa, è lei che fa di te quello specchio, dove, trasformandoti in pietra, ella guar-da la sua orribile faccia e riconosce se stessa nel doppio, nel fantasma che tu sei diventatodopo aver affrontato il suo occhio».4 Esiodo, Le Opere e i Giorni, I, vv. 80-105.5 Estratto da F. M. Pontani (a cura di), I Lirici greci,Torino, Einaudi, 1969.6 Eur., Hec., 442-443.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 242
posto all’entrata del Lapidarium del Museo Civico Archeologico di Bologna.Sono anche altri i settori culturali del mondo antico che ripropongonocome fondamentale l’elemento dello sguardo e dei messaggi che tramitel’organo visivo si veicolano. Gli ambiti di riferimento sono tre:– retorica – eros – magia Retorica. Nella società antica greco-romana, la comunicazione, in partico-lare quella che si propone espliciti fini persuasivi, è vista come una siner-gia di fattori fisici e mimici che si rivelano essenziali ai fini di una corret-ta comprensione e incisività del linguaggio.In ambito retorico, agli occhi è riconosciuto un ruolo fondamentale. L’o-ratore deve manifestare la capacità di atteggiare il volto, tenendo alti eseveri gli occhi, guardando dritto nelle pupille i giudici: lo sguardo bassoo continuamente ondivago è sentito come sintomo di paura e viltà.Nel DeOratore, Cicerone fa pronunciare a Crasso un elogio del potere espressi-vo dell’occhio:
Ma tutto sta nel viso, e nel viso, gli occhi hanno un ruolo di primo piano [...]i gesti infatti significano l’animo e il volto è l’immagine dell’anima, gli occhine sono le spie: questa è l’unica parte del corpo che possa assumere tantiatteggiamenti diversi, quanti i moti dell’animo. Attraverso gli occhi – guar-dando fisso o con dolcezza, minacciosamente o con gioia – esprimiamo isentimenti dell’animo, in maniera conforme al tenore del discorso. La natu-ra ci diede gli occhi per significare i nostri stati d’animo, per cui, nel gestire,dopo la voce conta il volto (vultus) ed esso è dominato dagli occhi.7
Emerge già da questo brano la metafora dell’occhio come specchio del-l’anima e suo muto linguaggio, che avrà grande fortuna anche nei secoli avenire. L’occhio è visto come porta sul cuore umano, come il più vicinoall’anima fra tutti gli organi di senso.Eros. La retorica si lega all’ambito dell’innamoramento e quindi, dell’eros,con una parola, estremamente significativa anche per il nostro campod’indagine:persuasione.Nel mondo antico,Persuasione è una divinità verae propria. In greco è chiamata Peitho, è una dea che afferisce alla sferaamorosa e fa parte del corteo di Afrodite. Risulta interessante il suo epite-to di riconoscimento e identificazione, ossia “dal dolce sguardo”. Il suocampo d’azione privilegiato è infatti la seduzione e le sue arti sono, quin-di, negli occhi. C’è un collegamento ineluttabile, anche nella cultura anti-ca, tra la seduzione e l’utilizzo che una donna fa del proprio sguardo neltentativo di avvincere a sé un uomo.8
243Mara Ferroni
7 Cic., De Orat., III, 221-223.8 Interessante, a questo proposito l’espressione usata da Alc., fr. I,20-21 Davies: «Le Grazie stil-lano amore di sotto le loro ciglia» e quella usata invece da Ibico, fr. 287 1,2 Davies che defi-nisce Eros come colui che esercita la sua arte di seduzione «attraverso lo sguardo languidodelle nere iridi».
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 243
Il gioco di seduzione di Peitho è descritto spesso in termini di malia, difascinazione che vince e abbatte le difese della mente e in cui le parole nonhanno alcuno spazio. Quindi possiamo dire che anche nell’antichità all’oc-chio, come si diceva nell’introduzione al capitolo secondo, è riconosciutouna funzione di significazione che è anche capacità di azione sul reale.Magia. Il concetto appena esposto potrebbe essere estrinsecato nel ter-mine latino fascinum o fascinatio, che per noi rimanda immediatamenteall’ambito erotico. Letteralmente, associato al termine greco baskanìavuole indicare l’idea di “guardare storto”, guardare con invidia e quindigettare la malasorte. È l’atto che, nelle culture popolari, è stato definitocome “malocchio”.Un sottile filo rosso collega la fascinazione prodotta dallo sguardo dell’in-namoramento a quella causata dal malocchio. I due elementi sono visticome poli estremi di un vasto spettro di stati d’animo. Nell’immaginarioantico sono sentiti entrambi come una sorta di incantesimo. Nelle Que-stioni Conviviali Plutarco, proponendo una disamina razionale dellabaskania, la descrive come un fenomeno misterioso che si configura intermini di rovina e di morte e che si accanisce con virulenza particolaresu bambini, ma anche sugli adulti e che trova il suo veicolo fondamentalenello sguardo di certi individui. L’occhio, in questo contesto, pare essereclassificato come essere animato, come un oggetto misterioso e terribileche si cerca di non nominare o che si nomina in infiniti modi, per esor-cizzarne il timore con la carica apotropaica dell’eufemismo.A livello arti-stico questo concetto torna in alcune rappresentazioni, per lo più suoggetti da collocare in ambito domestico, come amuleti di prevenzionecontro il malocchio.
Fenomenologia d’amore
Abbiamo visto, finora, un’introduzione generale concernente lo sguardo el’impatto che l’occhio ha sul reale a livello comunicativo; ora il nostro dis-corso deve restringersi all’ambito che maggiormente ci interessa, ossiaquello amoroso.Come accennato, già nel mondo antico l’innamoramento, al pari delmalocchio, doveva anche essere percepito dagli antichi come una sorta diincantesimo e ciò che è più importante una sorta di stregoneria mediatadallo sguardo. In particolare abbiamo cercato di mettere in luce il fattoche, fin dall’antichità, il mito ha codificato questo importante aspetto dicollegamento tra lo sguardo femminile e l’effetto d’annichilimento del-l’uomo che provoca.Ma come avveniva questo passaggio, quali erano gli elementi di ricono-scimento? In termini fenomenologici, insomma, come nasceva il senti-mento amoroso? Quale funzione concreta svolgevano gli occhi? Per la trat-tazione di questo passaggio abbandoniamo il riferimento unico all’anti-
244 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 244
chità, ma, a partire da essa, cominciamo il percorso culturale che ci por-terà alla disanima del tòpos letterario.Restringendo quindi l’ambito da prendere in esame, vogliamo considerarequale rilievo ha avuto, a partire dalla classicità, la nascita del sentimentoamoroso. In particolare è interessante analizzare alcuni brani filosofici e let-terari che si occupano di descrivere la fenomenologia d’amore, ossia l’in-sieme degli elementi visibili e percepibili che si manifestano nel momentoin cui il sentimento amoroso entra nel cuore dell’uomo. Come si vedrà, gliocchi rivestono sempre un ruolo da protagonista.Tuttavia, tra i diversi testi,esistono differenze che vale la pena evidenziare, così anche da mettere inrisalto lo scarto culturale tra l’antichità e il mondo medievale.Il primo brano da cui si deve partire per una riflessione su questi argo-menti, anche in contesto scolastico, è necessariamente il brano del Fedroplatonico, in cui il filosofo si occupa di definire la natura del sentimentoamoroso e quindi anche il suo manifestarsi e il progressivo svolgersi.Dalla lettura di Platone ricaviamo l’idea della percezione visiva degli occhidell’oggetto amato come flusso di luce ignea per cui l’amore pare quasiessere descritto come un imbevimento. Significativo poi il fatto che, pocoprima, nell’opera, Platone abbia definito l’amore come manìa, una sorta difollia, obnubilamento razionale, che si può tradurre come “patologia dellavisione dell’oggetto amato”.Il primo oggetto di contemplazione per l’anima è il Bello, dalla cui vista sca-turisce tutto il godimento e la realizzazione dell’individuo. L’eros è risveglia-to ogniqualvolta l’amante abbia la visione di un oggetto del mondo sensibileche incarni l’idea di Bellezza.A riprova di questo legame tra amore e visionesi può citare anche Plotino,il quale,nelle Enn.III 5,3 arriva ad ipotizzare un’e-timologia per Eros, la cui denominazione poteva derivare “dal fatto che egliottiene la sua esistenza dalla visione”. Dalla filosofia greca passiamo ad esa-minare le differenze che si manifestano, relativamente a questi concetti, conil passaggio al mondo medievale, per tracciare quelle linee generali su cui siinnesterà il discorso poetico e l’esame del tòpos letterario. Il testo scelto è ilDe Amore di Cappellano, teorizzazione indispensabile, soprattutto a livelloscolastico, per capire il background culturale che arriverà a informare di séanche la poetica letteraria successiva. Il brano riguarda ancora una volta ladescrizione dei primi istanti della comunicazione amorosa. Il brano di Cap-pellano apre collegamenti anche con quanto visto per Platone.I due testi collimano senz’altro nel punto in cui si spiega l’origine fisica emateriale della scintilla d’amore, nell’istante in cui i due sguardi si incro-ciano; peraltro il volgarizzamento riportato per il testo del Cappellano usail latinismo per veduta che, con la funzione logica del mezzo, intende sot-tolineare proprio la funzione degli occhi come concreto veicolo d’amore.Nonostante ciò, tra i due autori emergono alcuni punti di divergenza o didifferenza. Laddove infatti il filosofo greco parla indistintamente di ogget-to di amore, Cappellano si concentra invece, in modo conforme ad unanuova mentalità e moralità sconosciuta al mondo classico, sull’amore pro-
245Mara Ferroni
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 245
dotto da una visione specificatamente femminile, ribadendo due volte –«ch’abia altra natura» e «quando altri vede alcuna» – il concetto.Ma nella teorizzazione dell’autore medievale c’è un elemento tipico diquesta società, completamente originale rispetto al testo platonico. Si trat-ta dell’idea che, al momento in cui l’occhio dell’uomo incontra lo sguardodell’amata, ne segua poi un altro tutto interno all’amante, il cui elementocaratterizzante è il «pensero». La tradizione poetica medievale riprendecioè la suggestione platonica e la sua concezione amorosa: l’amore nasceda «veduta forma che si intende», come scriverà Cavalcanti, e gli occhisono effettivamente principale strumento di fascinazione, tuttavia essaintroduce un elemento nuovo: è necessario un continuo processo diimmaginazione all’interno dell’animo dell’amante. Per cui possiamo direche «la psicologia medievale concepisce l’amore essenzialmente comeun’avventura immaginativa e la seduzione dell’oggetto d’amore comepotere di insediarsi stabilmente nell’immaginario mentale del sedotto».9
Agamben ha definito con una formula questa caratteristica della mentali-tà medievale, come «carattere fantasmatico dell’amore».10
Argomenti simili e simili argomentazioni si trovano anche in altri testi che,pur usando forme letterarie non propriamente trattatistiche, si propongo-no comunque di dare delle definizioni. Interessante, da questo punto divista, Jacopo da Lentini per l’introspezione psicologica, di interiorizzazio-ne e intellettualizzazione dell’esperienza amorosa che propone. Dalla let-tura del testo emerge ancora una volta la lezione del Cappellano: l’amorederiva dal guardare. L’atto della vista è la fonte del «piacimento» e del«nutricamento» dell’immaginazione. Il centro dell’attenzione, però, si spo-sta ora sul cuore e sui processi interiori del poeta. I termini tramite cui egliesprime il suo stato d’animo rappresentano i sintomi tipici della malattiad’amore,diagnosticata dalla medicina e dalla psicologia medievali:pallore,tremore,debilitazione,perdita di coscienza.L’immagine della donna diven-ta oggetto di contemplazione mentale o sogno di felicità paradisiaca,anche se si tratta di un paradiso ancora tutto terrestre.In Jacopo da Lentini emerge anche un’altra caratteristica della vista: l’oc-chio è uno specchio sul quale resta impressa l’immagine dell’amata e dalquale essa giunge al cuore e si incide nell’anima. Grazie alla metaforaocchi-specchio l’immagine della donna viene così sempre più a perdere lesue reali connotazioni e si trasfigura in un’immagine psichica, contempla-ta attraverso un occhio interiore,quello del poeta.Torna quindi l’idea, tuttamedievale, che concepisce l’amore come avventura immaginativa, che,solo apparentemente sembra evitare la concretezza del gesto amoroso, eche vede la seduzione dell’oggetto d’amore come potere di insediarsi sta-bilmente nell’immaginario del sedotto.Tuttavia, il poeta siciliano si serve
246 Percorsi didattici
9 A. Carotenuto, Riti e miti della seduzione, Milano, Bompiani, 1994, pp. 133-135.10 J. Agamben, Stanze. La parola e il fantsma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi,1954, p. 57.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 246
della seconda quartina per fare una puntualizzazione. Il testo, nel puntoche ci interessa, suona così: «Ben è alcuna fiata om amatore / sanza vede-re so’ ’namoramento / ma quell’amor che strigne con furore / dalla vistadegli occhi ha nascimento». Il poeta fa un esplicito riferimento ad una teo-rizzazione dell’amore presente nella mentalità e nella cultura del suotempo, ossia il cosiddetto amor de lohn. L’espressione, così come coluiche la ha elaborata formalmente, Jaufrè Rudel, è provenzale.La puntualizzazione del siciliano pare quasi essere una presa di posizione,di disaccordo e di distacco rispetto a questa teoria e proprio per ribadirel’importanza della vista nel processo amoroso. Da Lentini infatti dice cheil furore, cioè l’elemento che connota il vero amore, può nascere solo gra-zie allo sguardo della donna e alla vista dello stesso da parte del poeta.Sulla trattazione poi del termine furore torneremo più avanti. Comunque,secondo le parole del poeta siciliano, la differenza tra l’amore che si svi-luppa nell’amante per la fama dell’oggetto amato e l’amore che nasce dallamediazione della vista si snoda proprio in questo concetto.Là abbiamo unamore che trova la sua realizzazione anche nella fisicità tangibile dell’a-mata e nella realizzazione del desiderio, qui invece un amore spiritualeche i critici stessi hanno infatti avuto difficoltà ad interpretare in modosicuro, proprio per l’ambiguità concettuale sottesa. Infatti un elementoproprio dell’amor de lohn, oltre che l’eterna lontananza, è anche laperenne irraggiungibilità dell’oggetto amato.L’innamoramento a distanza è un tòpos tipico della società cortese che siritrova anche nell’epica tedesca.Nel Niebenlungenlied la vicenda prende lemosse proprio per il desiderio di Sigfrido di vedere Crimilde, della quale siè innamorato per la continua rinomanza e fama della sua bellezza. Questomotivo tematico passerà poi nella fiaba europea nella quale il principe gene-ralmente si innamora di una donna la cui bellezza è esaltata dalla fama.Per quanto riguarda poi il discorso sulle varie trattazioni e teorizzazioni chesono state fatte sulla fenomenologia e sul nascere dell’amore, l’ultimo branoda esaminare è tratto dal Bestiario d’Amore di De Fournival.La natura di que-sti testi tipicamente medievali quali potevano essere i bestiari ci induce a col-locarli nell’ambito delle trattazioni teoriche, per il carattere di pseudoscien-tificità che essi si proponevano.La notazione biografica secondo la quale l’au-tore del bestiario, De Fournival, fosse un chirurgo, può supportare l’afferma-zione precedente ed essere d’aiuto nella comprensione del testo.I due animali su cui si concentra la riflessione che ci interessa sono ilcorvo e il leone.Per quanto riguarda questo passo si può sottolineare come,per acquisizionedella medicina del tempo,esistesse una via di collegamento preferenziale tragli occhi e il cervello identificato come la parte razionale del corpo dell’uo-mo. Il concetto sotteso al brano è che Amore cattura sì l’uomo per la vista,come fa il corvo sull’uomo morto, ma oltre a ciò gli estrae anche il cervello,lo lobotomizza, lo priva delle sue facoltà mentali. Dobbiamo lasciare inombra, per ora, questo concetto, ma sarà ampiamente ripreso più avanti.
247Mara Ferroni
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 247
Ecco quindi che con la fine della lettura del Bestiario e con le testimo-nianze citate si sono create le premesse concettuali e culturali per passa-re ad esaminare come il concetto della fenomenologia amorosa sia codifi-cato nelle immagini e nei topoi nell’ambito poetico.
Dalla fenomenologia alla nascita del tòpos poetico
a) Trovatori. La presa in esame dell’orizzonte culturale e letterario dei tro-vatori e quindi dell’idea, forse troppo stereotipata dai manuali, di AmorCortese, è fondamentale per la comprensione dell’evoluzione dell’imma-gine poetica di cui si vuol parlare, ossia lo sguardo della donna.La lettura di due brani potrebbe essere interessante. Il primo è un testomolto rappresentativo dell’ambito culturale cortese, pubblicato general-mente sui manuali scolastici, ossia Quando vedo l’allodoletta muovere diBernard de Ventadorn; il secondo invece è un brano poetico molto menoconosciuto che ha peraltro la particolarità di essere stato composto dauna di quelle nobildonne che nel XII secolo si davano all’esercizio poeti-co come trovatrici. Si tratta de L’Amore vrai della Contessa di Dio.Il testo del Ventadorn, laddove dice precisamente «da quando mi ha lasciatoguardare nei suoi occhi», che si potrebbe parafrasare con “da quando mi haregalato il suo sguardo”, è ripreso specularmente dal brano della trovatricequando ella, al verso 9, dice «Come vorrei una sera tenere / il mio cavaliere,nudo, tra le braccia / ch’egli si riterrebbe felice / se solo gli facessi da guan-ciale / che ne sono più incantata / di quanto Fiorio da Biancifiore / io glidono il mio cuore, il mio amore, la mia ragione, i miei occhi e la mia vita».L’immagine che emerge da questo confronto è quella degli occhi e dellosguardo come la ricompensa che la donna concede all’uomo in cambiodel suo omaggio, secondo le dinamiche ritualistiche così caratterizzanti estrutturali della società feudale.Gli occhi quindi, lo sguardo,e tutto quello che a ciò è sotteso,ossia la con-cretizzazione dell’amore, sono il premio, la ricompensa, il domnei, che ladonna concede al poeta in cambio del suo omaggio. In ciò trova rispon-denza l’idea del rapporto tra uomo e donna nell’amor cortese come rap-porto di vassallaggio tra la domna-feudatario e il poeta-vassallo.A testimonianza di ciò si può citare un passo di Koehler: «Come prima sipretendeva dal signore che egli ricompensasse i suoi servitori con unfeudo, ora la domna deve ricompensare con la considerazione sociale(onor) – e quindi anche col saluto veicolato in primis dall’atteggiamentodegli occhi – il servizio d’amore. In un joc partit, Lanfranco Cigala sostie-ne che per molti è più importante il prestigio sociale ottenuto con il ser-vizio d’amore che il compimento stesso dell’amore».11
248 Percorsi didattici
11 E. Koehler, Sociologia della “fin’amor”. Saggi trobadorici, Padova, EDITORE???, 1976, pp. 8-9.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 248
In conclusione si può dire che, nella codificazione del tòpos da parte deitrovatori provenzali, gli occhi della donna non sono solo veicolo d’amore,ma vera e propria ricompensa d’amore che l’amata concede al poeta eprimo passo di quel rituale di corteggiamento così rigido e preciso secon-do i dettami delle corti provenzali del XII secolo che da questo prendevaappunto il nome di amor leial.Emergono anche altri elementi a cui si può accennare. Un primo elemen-to d’interesse è la presenza,di cui si è già parlato,dello specchio.Lo sguar-do della donna è paragonato ad uno specchio in cui il poeta ha avuto, inun primo tempo, il permesso di guardare. Ma ora la nobildonna lo rifiutae all’amante, sconsolato, non resta che ritirarsi, rinunciando all’amore ealla fiducia verso le donne.Ciò che gli rimane è una sconfitta in quanto oltre all’amore, ha perdutoanche se stesso,dal momento che,per dirla con il Fournival, l’amata,comeun corvo, gli ha sottratto prima gli occhi e poi il cervello.A testimonianzadi ciò, si può citare il verso in cui il poeta dice «Da quando mi sono guar-dato in te, o specchio, non sono stato più mio», paragonando se stesso aNarciso. Sul questo mito dell’antichità si tornerà in seguito.b) Poeti siciliani.Anche la poetica siciliana mostra diversi e interessantiesempi del motivo dello sguardo della donna che provoca l’amore del-l’uomo. Oltre al testo già preso in esame di Jacopo da Lentini, un altroimportante documento in cui gli occhi della donna sono paragonati aduno specchio nel quale l’uomo si guarda fino a perdersi risulta essere ilcomponimento redatto da Stefano Protonotaro, particolarmente rappre-sentativo per la peculiarità dell’originale facies linguistica. Il titolo è Pirmeu cori alligrari.In questa poesia ritroviamo l’episodio aneddotico, peraltro già presentenei bestiari medievali, della tigre che, intenta nell’atto di rimirarsi super-bamente in uno specchio che i cacciatori le hanno dato per ingannarla,non si accorge che gli uomini le sottraggono i tigrotti. Ella, assalita da un’e-norme dolcezza per il proprio autocompiacimento, si distrae e, dimenticadi quanto le sta intorno, permette ai cacciatori di rapirle i cuccioli.A livello lessicale, si può notare che il termine usato dal Protonotaro èmiraturi, derivato dal provenzale mirador, che darà origine anche all’in-glese mirror. Il termine è compreso all’interno del campo semantico cheimplica proprio l’idea del guardare iterativamente, ripetutamente fino aperdersi nell’immagine come stregati.L’episodio paradigmatico serve al Protonotaro per creare una similitudinetra l’azione della tigre che si perde nella contemplazione di sé nello spec-chio e l’uomo che si perde nello specchio rappresentato dagli occhi delladonna.12 Nella cultura occidentale lo specchio è un simbolo ricorrente
249Mara Ferroni
12 Riporto la parafrasi del testo del Protonotaro estratta da AA.VV.,Dal testo alla storia, dallastoria al testo. Manuale di letteratura italiana, t. 1A,Torino, Paravia, 1999: «Quando io laguardo, mi pare di sentire la dolcezza che sente la tigre quando si guarda nello specchio, la
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 249
dell’immaginario letterario ed iconografico. Lo specchio ha due valenze:1. Rinvia al fascino ambiguo del doppio, della riproduzione fedele che èanche però una realtà illusoria, perfettamente congruente, ma priva dispessore. È strumento di conoscenza imperfetta.13
2. Rinvia al peccato di ùbris, di tracotanza, di presunzione di sé. Nella ico-nografia medievale lo specchio è proprio visto come lo strumento utiliz-zato dalle donne per prepararsi alla seduzione, tanto che in alcune rap-presentazioni medievali dell’episodio omerico delle Sirene di Ulisse, aqueste creature bellissime vengono messi tra le mani non tanto strumen-ti musicali, quanto specchi. In questo caso l’iconografia vuole alludere alleparvenze che ingannano i sensi, seducono gli occhi e irretiscono gli uomi-ni nelle maglie del peccato.Un mito ricorda entrambi questi due significati dello specchio. È il mito diNarciso, raccontato dalle bellissime pagine di Ovidio.14 Il racconto dell’e-pisodio di Narciso testimonia essenzialmente la fallacità della conoscenzadi se stessi e della realtà circostante dovuta alla mediazione dei sensi,anche quello della vista.15
c) Stilnovismo.Abbiamo visto come nei poeti precedentemente analizzati iltòpos dell’amore che nasce dallo sguardo della donna come specchio per ilpoeta era, al tempo stesso, strumento di annichilimento razionale e di per-dita di individualità. Passando all’analisi dello Stilnovismo, si può notarecome anche in questa scuola poetica sia presente la stessa immagine.Concentrando la nostra attenzione, in particolare, su uno dei più notipoeti afferenti alla scuola poetica che Dante definirà del dolce Stilnovo,ossia Guido Cavalcanti, vediamo come l’idea dello sguardo femminile checattura l’uomo esista, ma possa assumere anche altre caratteristiche. L’oc-chio dell’amata provoca nel poeta una perdita razionale, eppure suscitaanche sintomi propri della sofferenza carnale. Lo sguardo della donnaviene, in diverse occasioni,paragonato ad un dardo che ferisce il corpo delpoeta e provoca in lui dolore e male fisico. L’imbevimento da parte delpoeta della vista dell’amata entra in lui come un cancro e lo distrugge. Leparole chiave più caratteristiche e ricorrenti diventano sbigottimento, tre-more, lacrime, sospiri. L’amore è descritto come passione dei sensi. Infat-
250 Percorsi didattici
quale si vede portare via molto crudelmente i suoi piccoli che essa ha nutrito. Ma così bellole sembra mirarsi dentro uno specchio che dimentica di seguirli,così m’è dolce vedere la miadonna: ché guardandola dimentico ogni altro mio interesse, sì che subito mi ferisce il suoamore, con una ferita che aumenta sempre».13 Per la cultura occidentale, così connotata dall’esperienza del Cristianesimo, può essereinteressante quanto detto da S. Paolo, a proposito del Paradiso: «Ora vediamo oscuramente,come attraverso uno specchio, allora invece vedremo distintamente, faccia a faccia», Corin-zi, IV, 26-28.14 Ov., Metam., III, 370-500.15 Cfr. J.P.Vernant,Op.Cit., 2001???????,pp.115-116: «Il riflesso di Narciso e lo specchio di Dio-niso raffigurano entrambi la tragedia del ritrovamento impossibile di sé; il desiderio di riunir-si a se stessi presuppone al tempo stesso che ci si allontani da sé, che ci si sdoppi e ci si alie-ni [...] Se faccio di me come Narciso, invece di pormi come un altro, nella mia ipseità, devofarmi altro dall’interno, devo vedermi trasfigurato in un altro».
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 250
ti la vista, come diceva anche il bestiario, è insieme all’udito uno dei sensifondamentali: la natura dell’amore è violenta e sensuale tanto che il poetapensa che essa discenda direttamente dagli influssi di Marte.Il testo del Cavalcanti preso in esame è il sonetto Voi che per gli occhi mipassaste ’l core.Vedi anche il testo di Guinizzelli. La tematica centrale delcomponimento è incentrata sulla descrizione degli effetti dell’innamora-mento sul poeta o per meglio dire, nel nostro contesto, gli effetti causatidallo sguardo della donna. La bellezza della donna esercita il suo influssosull’anima sensitiva dell’uomo. Cadendo in balia dell’anima sensitiva, l’a-more che è in origine luminoso perde la sua qualità e diventa forza oscu-ra che esclude ogni dominio razionale.Da qui scaturiscono gli effetti scon-volgenti dell’amore sul soggetto che ama: esso appare come una forza chedistrugge fisicamente.Nel testo si susseguono immagini di violenza distruttiva e l’impianto poe-tico si basa sull’idea dell’amore allegoricamente rappresentato come unavicenda bellica. Il dolore e la sofferenza provati a causa degli occhi dell’a-mata portano quasi ad un desiderio di annichilimento che ricorda un’e-sperienza di trance mistica.Ma,mentre l’annullamento proprio della misti-ca religiosa provoca effetti di gioia e di ebbrezza,16 l’esperienza amorosacavalcantiana sembra sfociare solo nella disperazione.Lessicalmente troviamo un’insistenza ripetuta su termini aspri e intensi,quasi tesi a visualizzare l’esperienza fisica di dolore. Per meglio approfon-dire questi aspetti insiti nella poetica di Cavalcanti è illuminante la letturadel mito virgiliano di Orfeo ed Euridice.17
Le due facce dello sguardo amoroso che dagli occhi della donna veicolal’amore all’uomo, la faccia che provoca furor e quella che provoca soffe-renza e dolore, si ritrovano nella subita dementia con cui Virgilio descri-ve il gesto terribile di Orfeo che conducendo fuori dell’Ade la sposa untempo morta non si trattiene e, per un’insana follia, si volta per guardarla,contravvenendo al comando impostogli.La lettura del brano delle Georgiche di Virgilio testimonia come in un solosguardo sta la colpa di Orfeo; la punizione di Proserpina si applica proprionell’istante in cui gli occhi dei due amanti s’incrociano anche per un soloistante, provocando la fine del loro amore.Orfeo è un poeta, ma fallisce. È significativo che colui che gli antichi rite-nevano il sommo poeta, lo sciamano che colloquiava con la divinità tra-mite l’ispirazione poetica, cioè Omero,“Colui che non vede”, celasse nelsuo nome il segreto della vera conoscenza.d) Dante. Dante e Cavalcanti erano amici. Più giovane l’uno, più maturol’altro, ma comunque amici. Come in un normale rapporto di amicizia
251Mara Ferroni
16 Si può creare un confronto tra la visione dell’annullamento provocato in Cavalcanti dallavisione della donna amata e l’annullamento proprio della mistica cristiana i cui effetti di gioiasono ben rintracciabili nel concetto di esmesuranza tipico della poetica e della religiositàdi Iacopone da Todi.17 Virg., Georg., IV, vv. 453-527.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 251
dobbiamo pensare che parlassero, dialogassero, litigassero, si scambiasse-ro le opinioni le idee che nascevano in loro, leggessero vicendevolmentei versi e i tentativi poetici l’uno dell’altro.Proprio come in molte amicizie, però, i punti di vista e le rispettive Wel-tanschauungen erano profondamente diverse. Il criterio di interpretazio-ne della realtà, l’accettazione o meno della presenza religiosa e infine laconcezione dell’amore e dell’elemento femminile non arrivavano allemedesime conclusioni. Inserendo questo dato nel nostro percorso, dob-biamo concludere che anche il punto di vista sullo sguardo femminile sibasa su presupposti teorici differenti.Per l’analisi di Dante è stata scelta la lettura e il commento della Vita Nuova,testo-itinerarium in cui Dante, secondo la definizione di Singleton, descri-ve le diverse fasi dell’innamoramento per Beatrice. Quella che maggior-mente ci interessa ai fini di questo percorso è la fase iniziale. Essa prende lemosse dal saluto di lei, la cui potenza espressiva doveva essere, presumibil-mente, concentrata negli occhi e nello sguardo più che nella parola. In unasocietà come quella medievale, infatti, dove l’elemento gestuale più chequello orale o scritto, dove la ritualità, più che l’interpretazione personale,segnalavano l’esistenza di una disciplina dei comportamenti che potevacontribuire a riformare l’uomo interiore,18 dobbiamo pensare che Beatriceabbia concentrato tutta la sua espressività nell’atteggiamento del vultus.La lettura della Vita Nuova si può soffermare principalmente su alcunicapitoli scelti, nei quali l’elemento dell’occhio femminile può fungere dapunto di vista per ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda amo-rosa di Dante per Beatrice. I capitoli della Vita Nuova che ci interessanosono: III, X, XI, XVIII, XXXXVII.Il primo incontro del poeta con «quella ch’è sul numero delle trenta» pareaffine, nella concezione degli spiriti,19 a Cavalcanti. Nella fase iniziale delrapporto amoroso, che costituisce la vicenda tematica della Vita Nuova,la fenomenologia amorosa segue i presupposti stilnovistici. Gli occhi delpoeta significano l’amore: «Dicea Amore,però che io portava nel viso tantede le sue insegne che questo non si povria ricovrire».20 Ma il percorso diDante, nell’elaborazione di una propria visione del sentimento amoroso,va oltre rispetto a quello dell’amico Cavalcanti.Chiave di volta per il suo cambiamento è la negazione del saluto da partedi Beatrice. Ella abbassa lo sguardo ed elimina la possibilità di una comu-nicazione, anche silenziosa. La negazione dell’occhio di Beatrice è vissutada Dante come obbligo a dover fare a meno del dato sensibile.21 La beati-
252 Percorsi didattici
18 J. C. Schmitt, Op. Cit ??????, pp. 6-7.19 Cfr. D.Alighieri, Vita Nuova, a cura di M. Colombo, Milano, Feltrinelli, 1993, cap. XI, 2, 3.20 D.Alighieri, Vita Nuova, cit., cap. IV, 2.21 Ivi, cap. XVIII, 4: «Madonne, lo fine de lo mio amore fue già lo saluto di questa donna, forsedi cui voi intendete, e in quello dimorava la beatitudine, ché era fine di tutti li miei desiderii.Ma poi che le piacque di negarlo a me, lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutala mia beatitudine in quello che non mi puote venir meno».
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 252
tudine da allora in poi, afferma Dante, consisterà in «quelle parole chelodano la donna mia».22
Dante ha oltrepassato la concezione del rapporto amoroso che era statapropria dei trovatori. Lo sguardo dell’amata non è più la ricompensa tipi-ca dell’amore trobadorico. Gli occhi del poeta che fissano lo sguardo diBeatrice non sono quelli fisici, bensì quelli del cuore e della mente. Il suoguardare la donna non è effetto dell’humanitas,23 ma della caritas, ossiala capacità di riconoscere Dio nell’uomo.L’amore per Beatrice trova appagamento in Dante grazie alla descrizionedella bellezza di lei, caratterizzata essenzialmente dalla luminosità degliocchi. Da essi, però, non ci si attende cenno di risposta. La lettura diDonne ch’avete intelletto d’amore testimonia ciò.Questo concetto è esplicato ai versi 51-56 della medesima canzone, doveDante dice: «De li occhi suoi, come ch’ella li mova, / escono spirti s’amoreinflammati / che feron gli occhi a qual che allor la guati, / e passan sì che ’lcor ciascun retrova / voi le vedete Amor pinto nel viso, / là ’ve non potealcun mirarla fiso». In questa strofa sono molte le riprese cavalcantiane: ilverso 51 «De li occhi suoi, come ch’ella li mova», tiene presente l’espressio-ne «O Deo che sembra quando li occhi gira», mentre le parole che indicanola ricomparsa del tòpos che stiamo analizzando riprendono il verso di Caval-canti «Voi che per gli occhi mi passaste ’l core».Tuttavia in questo contestoesistono delle differenze. In Dante vengono infatti eliminati gli accennidistruttivi e guerreschi presenti nel sonetto del Cavalcanti. L’accento rima-ne maggiormente posto sulla bellezza dello sguardo,più che sugli effetti cheprovoca. Ciò è evidenziato anche dall’inversione, che collocando il termine“occhi” in posizione incipitaria gli conferisce un maggior risalto.A questo passaggio corrisponde, quindi, anche una riconciliazione dellafrattura interiore che l’amore originava in Cavalcanti, secondo la defini-zione ossimorica di Eros glukupikros presente in Saffo.24
Utile per il tema che ci interessa la lettura del capitolo XXXVII, brano chesolitamente le antologie scolastiche, per evidenti ragioni antologiche, nonriportano. In questo passo Dante apre un colloquio significativo in primapersona con i suoi occhi, ammonendoli con «L’amaro lagrimar che voifaceste / oi occhi miei, con così lunga stagione».25 Beatrice è ormai mortae Dante è irretito dallo sguardo di un’altra donna. Il poeta percepisce que-sta comunicazione, seppur muta, come un tradimento a Beatrice e, depre-cando la vanitas delle sue pupille, imputa agli occhi di essere veicolo sen-sibile di un amore tutto terreno e, implicitamente, mette distanza tra unosguardo sensuale e uno sguardo spirituale che è quello che egli deve a
253Mara Ferroni
22 Ivi, XVIII, 6.23 Per il concetto di humanitas, faccio riferimento ad A.Traina, Humanitas, in Comoedia.Antologia della Palliata, Padova, CEDAM, 1969, pp. 9-19.24 Saf, Fr. 130 V.25 If., II 45-48.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 253
Beatrice. Questo sguardo spirituale è l’arma che la divinità ha concesso aDante, nuovo Perseo, per decapitare ancora una volta l’occhio di Medusache annichilisce e fa peccare.Beatrice quindi non ha più uno sguardo umano. I suoi occhi che «lucevanpiù di una stella» si appoggeranno pietosi su Dante, smarrito nel labirintodel peccato, e lo porteranno alla conoscenza di Dio, termine ultimo esupremo della verità e della felicità.Ma un’altra santa, insieme alla Madonna, vuole la salvezza di Dante, unasanta a cui il poeta, secondo un passo del Convivio,26 doveva essere devo-to: è santa Lucia, semanticamente connessa alla luce e all’illuminazionedella verità, tanto che allegoricamente la figura di Lucia è interpretatacome la rappresentazione della Grazia Illuminante, che schiarisce lamente con gli occhi della fede.Le tradizioni martirologiche la connettono alla protezione dell’organodella vista. Non per nulla ella viene quasi sempre rappresentata con unpiattino su cui tiene i suoi occhi o con un fiore i cui petali sono pupille.L’iconografia è simbolica, ma il messaggio pare essere molto chiaro: Luciaè vigile, controlla i suoi occhi e quelli di chi si affida a lei.Mi pare di potere affermare quindi che l’occhio, evidentemente strumentodi conoscenza sensibile,debba per Dante essere sorvegliato,staccato da sé.Torna il desiderio che era già stato di Narciso,cioè quello di separarsi da sestesso. La vera conoscenza in fondo si nutre proprio di ciò, cioè del mette-re distanza tra il soggetto che conosce e l’oggetto che si vuole conoscere.e) Petrarca. La quantità di materiale che Petrarca offre riguardo al temache ci siamo prefissati è ingente. I testi del Canzoniere in cui compare laparola “occhi” o altri termini della medesima area semantica sono moltis-simi e testimonianza di ciò è, in particolare, la presenza delle tre canzonidefinite appunto dai critici “canzoni degli occhi”.Il nostro itinerario attraverso Petrarca si concentra essenzialmente sullalettura del Canzoniere e prende le mosse dal sonetto III, in cui il poetadescrive il momento in cui è stato colpito dall’amore per Laura. È il gior-no del Venerdì Santo, giorno di passione, in cui la cristianità piange lamorte corporale di Cristo. I fedeli piangono, ma il poeta non partecipa alcomune dolore. Nell’esigenza propria della cultura medievale di dare unsignificato particolare a ciò che è universale, la coincidenza tra l’innamo-ramento e il giorno tragico per la religione cristiana suggerisce il signifi-cato attribuito da Petrarca alla sua personale storia d’amore: un travia-mento morale, caratterizzato da un prolungato oscuramento della divini-tà, «un primo giovenile errore», che implica con il verbo “errare”, la pre-senza di un percorso delirante, letteralmente fuori dal solco, un vagabon-dare che non si connota mai veramente come pellegrinaggio perché lameta appare e scompare a intermittenza.
254 Percorsi didattici
26 Conv., III IX 15-16.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 254
Laddove Dante si rappresenta come «uscito fuor della pelago alla riva»,27
Petrarca amerà definirsi nave in tempesta alla ricerca di un saldo porto,trovato, almeno apparentemente, soltanto alla fine del Canzoniere ai vv.66-71 della Canzone alla Vergine.28
Nel componimento III, la cui forma metrica è quella di un sonetto, i versiche egli usa per descrivere il momento dell’innamoramento, cioè il 3 e 4,sono significativi: «quando i’ fui preso, et non me ne guardai, chè i be’vostri occhi, donna, mi legaro». Il motivo riprende il tòpos tematico di cuiabbiamo parlato, e l’ascendenza immediata è stilnovista. La metafora insi-ta nel verbo legare connota, ancora una volta, gli occhi dell’amata comelaccio che, letteralmente, irretisce il cuore e la mente del poeta.Petrarca,come Perseo e come già Dante,vede la sua Medusa in compagniadi Amore ma, al contrario degli altri due, si trova di fronte a lei senza armie senza strumenti di difesa poiché al poeta «tempo non parea da far ripa-ro contra colpi d’Amor». È inerme e i versi 9-11 ci confermano ciò: «Tro-vommi Amor del tutto disarmato / et aperta la via per gli occhi al core, /che di lacrime son fatti uscio et varco». Nelle orecchie di Petrarca risuonasenz’altro il motivo cavalcantiano visto precedentemente e il tòpos secon-do le sfumature presenti già in Jacopo da Lentini.Ecco che gli occhi sono quindi a pieno titolo corresponsabili dell’inna-moramento di Petrarca, esperienza umana che egli sente in perenne con-trasto con quella religiosa. Rispetto, infatti, ai precedenti poetici, in Petrar-ca si avverte una rottura tematica. In primo luogo la figura del soggetto èrappresentata come autentica complessità psicologica. L’io si presentacome frantumato, sempre costretta a dialogare con se stesso, a rivolgersi,a dividersi nelle voci discordi dei propri desideri e delle proprie intenzio-ni. Un significativo esempio di contrasto di questo tipo è presente nelsonetto LXXXIV laddove il poeta inscena una diatriba tra lui stesso e i suoiocchi. Nel dialogo egli prende le parti del cuore che, a suo dire, non haavuto colpa nell’innamoramento per Laura, ma ha subito lo smacco degliocchi responsabili di aver aperto quell’uscio e quel varco tramite cuiAmore ha raggiunto il cuore e vi ha preso dimora.Il sonetto inscena un vero e proprio tribunale e nel testo compaiono leparole giudicii, biasmo, ed infine la parola-chiave colpa. L’amore per Lauraè percepito come colpa, come traviamento, delirio, Laura e la sua personafisica sono avvertite come ostacolo alla salvezza e la figura femminile non è,come accadeva in Dante, mezzo per il raggiungimento del divino.È significativo, ai fini del percorso che abbiamo intrapreso, che il primoelemento che connota Laura come presenza fisica concreta seppur eva-nescente nei tratti descrittivi siano proprio gli occhi. Si veda la lettura delsonetto XC.
255Mara Ferroni
27 If., I 23.28 Canz.,Op.Cit.????,CCCLXVI,vv.66-69,73:«Vergine chiara et stabile in eterno,/ di questo tem-pestoso mare stella, / d’ogne fedel nocchiero fidata guida, [...] Ma pur in te l’anima mia si fida».
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 255
È un elemento di assoluta novità quello che Petrarca introduce in questotesto rispetto alla tradizione poetica a lui precedente. Le donne angelodello Stilnovismo e la stessa Beatrice non avrebbero potuto mostrare l’in-vecchiamento perché fisse in una dimensione atemporale. Laura invece èsottoposta al fluire del tempo e noi lo avvertiamo con i versi 3-4: «e ’l vagolume oltra misura ardea / di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi». L’oc-chio interessato a questo deperimento è proprio quello della donna.Il tòpos che ci interessa quindi pare subire una rottura, una brusca inver-sione di tendenza che ci testimonia come la figura di Laura sia terrena ecome i suoi occhi siano il veicolo per farci comprendere ciò. Laura è chiu-sa nell’orizzonte del suo sguardo, nell’orizzonte di quei micidiali specchiche le sono propri, e dallo scontro tra il desiderio e la sua irrealizzabilitàsi crea quel sentimento che Petrarca nel Secretum definirà quiddam inex-pletum, che non gli permetterà mai un reale compimento e una realizza-zione della sua esistenza.Dopo la morte di Laura,anche il fantasma del suocorpo continuerà ad attrarre il poeta.Per mostrare l’angoscia suscitata nel poeta dalla perdita del corpo fisico diLaura, si può porre l’attenzione sull’utilizzo dell’aggettivo soave del sonet-to CCLXVII. Questo attributo deriva dal verbo latino suadere ed appartie-ne quindi al campo semantico che riguarda l’attirare a sé, il convincere.Ritorna dunque il richiamo alla divinità Peitho che, non per nulla, era unadea del corteggio di Afrodite e aveva un epiteto significativo:“dal dolcesguardo”.Con la morte di Laura l’amore del poeta non si estingue, ma subisce unatrasformazione: è un’immagine mentale e comincia ad esserci la presa dicoscienza riguardo alla vanità e alla caducità della bellezza terrena. Comese togliesse il velo, Petrarca offre, nell’ultimo componimento del Canzo-niere, consacrato dalla tradizione come Canzone alla Vergine, il giudiziofinale sull’esperienza amorosa. Il poeta infatti invoca la Vergine comemodello unico di femminilità, deprecando il proprio sbandamento versola donna che egli definisce al v. 111 «Medusa».29
Il percorso ritorna, come in una sorta di ringcomposition, all’elemento dacui aveva preso le mosse. Il maldestro tentativo petrarchesco di ricom-porre il mosaico dei fragmenta della sua anima fallisce sotto l’occhiomostruoso della Gorgone, divenuto ormai lo sguardo stesso del poeta.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/for-mazione/3ferroni.html.
256 Percorsi didattici
29 Per la definizione di Laura come Medusa, cfr. S.Agosti, Gli occhi e le chiome, Milano, Fel-trinelli, 1993, pp. 17-18.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 256
I corpi e le cose. Sensualità barocca edestasi mistica Roberto Fiorini
La sensualità barocca
Tutta la cultura del Barocco è caratterizzata dall’emergere decisivo dellasfera dell’esperienza. Questo si spiega in parte come contraccolpo del par-ticolare tipo di rapporto con il mondo che l’indagine scientifica va affer-mando – nel suo frugare dentro la realtà e ritagliare le cose nella loro esten-sione sensibile, inscritta nello spazio e nel tempo. D’altra parte, la messa indiscussione dei modelli precedenti di spiegazione dei fenomeni naturali –ma anche di quelli sociali, economici e più in generale antropologici – chela cultura Barocca va operando, conferisce un’importanza nuova e diversaall’esperienza diretta, non mediata da schemi ideologici o religiosi o esteti-ci preordinati, ma anzi esposta e aperta curiosamente al mondo.Tale rin-novato significato dell’esperienza si rivolge per un verso all’esterno delsoggetto – in una realtà che si spalanca misteriosa e ingannevole, mastraordinariamente ricca di stupefacenti novità. Per altro verso invece –anche per l’azione profonda che la Controriforma opera all’interno del sog-getto, scuotendone la coscienza e acuendone il senso di responsabilità peril peccato – una nuova importanza viene ad assumere l’interiorità del sog-getto: nel “profondo del cuore”, nei suoi spazi sempre più bui e sconosciu-ti mano a mano che l’uomo del Seicento vi spinge lo sguardo, si vannoricercando le tracce di una divinità che pare avere abbandonato il Cielo eil Libro, per ritrarsi nelle pieghe più intime e umbratili della coscienza.Centro, limite e discrimine di questo duplice versante dell’esperienza –quello diretto verso l’ambiente esterno e quello rivolto al mondo interio-re – è il corpo con i suoi sensi. Di tale rapporto tra esteriorità e interiori-tà la pelle e i sensi – quasi porte e soglie tra le due sfere dell’esperienza– sono allo stesso tempo il punto di incontro, lo strumento e il criterio diindagine. Con i sensi il corpo barocco sprofonda nella realtà, percepen-dola nella sua densità carnosa e interrogandone il senso sfuggevole eapparente. Con i sensi la cultura barocca s’immerge nell’interiorità del-l’immaginario e della coscienza a percepire l’emozione e la passione intutte le loro sfumature ed ambiguità, ma anche a sperimentare i segni deldivino e i modi della sua presenza.Tale sensualità, infatti, si spinge a descrivere, rappresentare ed esprimereanche l’esperienza del sacro. I corpi dei religiosi sono percorsi dall’emo-zione dell’estasi; i corpi dei martiri sono esibiti nella loro nudità sofferen-te,mentre vengono feriti, lacerati e sottoposti ai più feroci supplizi; i corpi
257Roberto Fiorini
23
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 257
dei santi, tra schiere di angeli semivestiti, vanno ad affollare soffitti, paretie absidi di chiese e cappelle. Il linguaggio figurativo e letterario del classi-cismo si piega a rappresentare questa nuova sensibilità. In tale trasfigura-zione del classicismo – di cui il Marino è forse il più consapevole espo-nente, ma che investe tutta la cultura Barocca, almeno fino agli anni Tren-ta del Seicento – tutta la vicenda evangelica della Passione di Cristo, adesempio, viene messa in contatto con il mito classico e la sua grandepotenza immaginaria. Ne vengono accentuati gli aspetti patetici, ma nesono anche declinate tutte le risonanze sensuali. Così, mentre la pittura“realistica” di Caravaggio cerca il divino nei corpi – il gesto delle mani, lepieghe della pelle, gli sguardi – la pittura “classicista” di Guido Reni rein-terpreta la classicità con una nuova sensibilità per la luminosità della pellee per il patetismo silenzioso dei gesti, coniugando iconologia classica econtenuto religioso.La stessa sensualità investe gli oggetti della realtà di tutti i giorni: bicchie-ri, orologi, strumenti musicali, candele, libri, frutta, cacciagione – tutte lerappresentazioni della vanità del tempo che passa – trascorrono dallenature morte e dalle vanitates (rappresentazioni allegoriche della vanitàdella vita) dentro alle pitture dei grandi maestri fiamminghi, come anchenei testi dei grandi mistici secenteschi. Costoro interrogano gli oggettinella semioscurità degli interni in cui quotidianamente e ordinariamentesi trovano, cogliendoli nei silenzi profondissimi da cui paiono sorgere ecui ancora sembrano alludere,mentre si offrono allo sguardo pensoso cheli percorre. La dimensione nascosta della realtà, la sua evidente eppuresfuggevole ragione d’essere – quel resto lontano dell’origine delle cose,che si rivela quasi dileguando proprio al mostrarsi degli oggetti nella loronudità – scopre in tal modo la dimensione mistica del mondo, in bilico trapresenza e assenza, tra attimo ed eternità, tra nulla e qualcosa. Il Baroccocoglie anche questa dimensione della realtà: gli oggetti, percepiti attraver-so i sensi e realisticamente rappresentati,diventano silenziosi depositari diun’enigmatica verità, prossima al divino.
Il corpo barocco e i sensi
Il Barocco fatica a vedere e definire oggetti fermi entro un realtà compat-ta.Tende invece a vedere e rappresentare oggetti in movimento continuonello spazio e in metamorfosi costante nel tempo.Allo stesso modo, l’ideadi corpo che emerge dalla letteratura barocca pare essere quella di uncorpo in movimento o colto nel momento di una metamorfosi. È il caso diun gruppo marmoreo quale Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini, oggialla Galleria Borghese di Roma, in cui movimento e metamorfosi sono mol-tiplicati nella percezione stessa dello spettatore, coinvolto e “incorporato”nell’opera: egli viene indotto a seguire il gruppo con gli occhi, ma anchecon il suo corpo stesso, muovendosi intorno alla scultura, in modo tale da
258 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 258
venirne lentamente scoprendo un lato “frontale” – da cui Dafne appareancora una fanciulla dalla pelle liscia e giovane – e un lato “posteriore”(evi-dentemente successivo anche in ordine di tempo) in cui la fanciulla, chenella sua fuga pare ora andare allontanandosi dallo spettatore,è ormai rico-perta di placche legnose,mentre le sue dita vanno oramai germogliando inirsuti ramoscelli di alloro. Si tratta di una visione già cinetica: una sorta dicinematografia ante litteram, esaltata dal virtuosismo (e dalla sottesa anti-tesi) che deriva dal fatto di trovarsi di fronte ad una materia per definizio-ne immobile e dura come il marmo – ma che pure viene piegata e quasiimpastata con la luce in evidenti effetti di grande sensualità,cogliendo d’al-tra parte l’attimo (concepito solo come figura-culmine del passaggio edella tensione tra opposti) che immobilizza la fanciulla nelle forme dell’al-bero e ne rapprende la pelle d’alabastro in opache scaglie legnose.Ma il corpo barocco appare metamorfosato e messo in movimento anchead un livello ulteriore.Proprio il tipo di percezione sensoriale che il Baroc-co evidenzia è del tutto particolare. Gilles Deleuze ha perfettamentedescritto questo tipo di percezione nell’opera di un grande pittore delNovecento come Francis Bacon, nel saggio Logica della sensazione, sot-tolineandone peraltro il valore per così dire teoretico, fondato sulla geo-metria degli spazi e dei piani sensoriali. Proprio nel Barocco si trova l’ar-cheologia di questa percezione,anche in questo caso,come vedremo, lega-ta alla dimensione della geometria e del calcolo matematico, per esempionell’opera di Leibniz o di Pascal. In genere, nella cultura del Barocco ècome se il corpo fosse immerso nella realtà e da essa fosse attraversato inentrambe le direzioni: dall’esterno verso l’interno e dall’interno verso l’e-sterno. È come se attraverso i sensi esso si liquefacesse nella realtà, pro-trudendosi e insinuandosi dentro le sue pieghe – e viceversa accogliesseil mondo esterno dentro di sé, facendosi penetrare da esso attraverso lesoglie dei sensi. La carne barocca si espande nella realtà fino a dove giun-gono i sensi e viene trafitta e percorsa dalle sensazioni fino all’interno delcorpo. Si potrebbe forse dire che attraverso l’esperienza barocca dei sensisi pone in evidenza una percezione precedente a quella del corpo fisico:una percezione immaginaria della realtà, in cui tutte le sensazioni – vista,udito, tatto, odorato – vanno a confluire e sovrapporsi. Si tratta, certo, diuna percezione immaginaria, ma pure sensualissima, per cui il soggettopuò vedere con la bocca e baciare con gli occhi – in cui, cioè, la protru-sione della vista dentro la realtà esterna (incursione che peraltro il Sei-cento viene perfezionando con l’ausilio di strumenti ottici meccanici)può rovesciarsi nella intrusione della realtà esterna nell’interiorità, attra-verso la bocca o le orecchie.È una dimensione in cui il “vicino”(il momen-to del baciare) e il “lontano”(il momento del vedere o dell’udire) non sonopiù luoghi reali, ma luoghi di un immaginario geometrico – che purehanno tutta la rilevanza di luoghi fisici, legati all’esperienza.Più precisamente, questa idea del corpo si presenta come un intreccio traattività e passività: attività di indagine sul mondo (protrusione sulle cose)
259Roberto Fiorini
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 259
e passività delle sensazioni (disposizione ad essere percorsi e invasi dallesensazioni esteriori). Si tratta di un intreccio che trova la sua massimaintensità nel rapporto amoroso – come è ovvio.E immagine di questo rap-porto complesso tra interiorità ed esteriorità e tra attività e passività è, ingenerale, proprio la nudità stessa – la pelle scoperta ed indifesa con cui sifa esperienza delle cose, ma anche superficie lieve ed esposta in cui siprova la passività e la esposizione del corpo all’esterno. Più in particolare,in due altre immagini si traduce tale stretto rapporto tra interiorità ed este-riorità, sensazione e passività: la ferita e lo svisceramento. Si tratta di dueimmagini che avevano già una tradizione ben definita all’interno dell’im-maginario sia letterario sia mistico e che il Barocco – per il tramite inge-gnoso del concetto – svolge e varia in tutte le sue implicazioni. La distin-zione tra homo interior e homo exterior ha una tradizione che risale allateologia paolina, ripresa poi da Agostino e posta a fondamento della distin-zione tra esteriorità sensitiva ed animale (“homo exterior dicitur quodhabemus commune cum animalibus”, Quaestiones in epistulam adRomanos, q.158) ed interiorità angelica (“homo interior quod communepossidemus cum angelis”, ibidem). La ferita e lo svisceramento evocanouna osmosi tra le due aree, un ambito di indecidibilità tra umano e inu-mano, tra angelico e animale, la cui soglia è la sensazione interpretatacome passività e consunzione: l’uomo si assottiglia fino a farsi spaziomobile di attraversamento e consunzione.Si apre un nuovo spazio di inter-pretazione dell’umanesimo, che caratterizzerà a fondo la “modernità”.
Il corpo mistico
L’estetica di MarinoL’autore che con maggiore lucidità e consapevolezza mira a fare conver-gere il piano dell’esperienza mistica – vale a dire dell’esperienza direttadella divinità – e quello dell’esperienza letteraria è certo GiovanbattistaMarino. La sua poetica punta, da una parte, a mettere in contatto i varisensi tra loro, cercando di evocare la sostanza irrapresentabile e meta-morfica che sta alla base di ogni immagine, come di ogni suono, come diogni percezione tattile – e che insieme attraversa ogni visione,ogni canto,ogni sensazione. D’altra parte, egli mira a trasfigurare il classicismo,mutuandone temi, immagini, situazioni, modi – ma reinterpretandoli attra-verso una sensibilità moderna completamente diversa da quella antica, inquanto marcatamente sensuale e centrata sulle emozioni, per cui quelleimmagini “classiche” rimangono come una sorta di riserva e serbatoio disenso in cui cercare ispirazione. È l’esperienza del soggetto moderno,insomma, a dare senso alle figure mitologiche della classicità, così come aquelle testamentarie ed evangeliche. È la parola poetica moderna a riela-borare quei modelli e trasformarli in esperienza per il soggetto moderno:quei modelli, in sé, non hanno più alcun significato precostituito. Questa
260 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 260
sorta di sincretismo culturale ed estetico porta Marino ad incrociare con-sapevolmente temi ed immagini classici con temi ed immagini biblici edevangelici:è il motivo per cui la figura di Adone – proprio come eroe inno-cente della “passività”– viene avvicinata a quella di Cristo, attraverso tuttauna serie di rimandi e di precisi segnali. L’incontro tra temi cristiani e temiclassico-pagani avviene soprattutto nel nome della sensibilità erotica,anche appoggiandosi alla preesistenza di un lessico spesso comune sia allalirica amorosa, sia a quella mistica – per la coincidenza di “conoscere” e“amare”, implicita nella teologia cristiana. L’esito è una sorta di dispiega-mento di un erotismo in cui convergono comportamento, religione edarte e che trova nella poesia e nella musicalità del verso il suo centro uni-ficatore – come nel poeta il suo massimo realizzatore. Negli stessi anni, lamedesima tendenza a fare convergere figurazioni classiche e temi religio-si è comune anche ad un pittore come Nicolas Poussin, della cui sensibi-lità artistica Marino fu grande estimatore e delle cui opere fu avveduto col-lezionista. Entrambi operano una trasfigurazione della classicità eroica inuna sensibilità moderna, per molti versi del tutto antieroica, ovvero di uneroismo martirologico della follia, del dolore, dell’eccesso insensato.
L’esperienza misticaIl convergere del piano mistico e di quello letterario sono facilitati nelBarocco dal fondersi delle immagini e dei temi comuni alle due letteratu-re. D’altra parte proprio l’esperienza dei sensi e del corpo si pone cometerreno di incontro delle due sfere di esperienza: quella del divino e quel-la dell’interiorità.Il Concilio di Trento, nel tentativo di sottrarre il testo biblico alla deriva diinterpretazioni e di traduzioni che l’età moderna squadernava, impone lasparizione fisica della Bibbia. L’Indice di Paolo IV, nel 1559, aveva proibitoil possesso e la lettura di ogni testo biblico in volgare. L’Indice del 1580proibisce non solo la traduzione, ma anche la parafrasi o la trasposizionepoetica di passi della Sacra Scrittura. Nell’Indice di Clemente VIII del1596, il divieto si estende anche ai sommari e ai compendi.Alla pubblica-zione degli Indici segue la repressione, con la confisca puntuale e siste-matica dei testi trovati in chiese e monasteri.In tal modo, l’esperienza del divino si stacca dalla lettura del libro e si spo-sta nella esperienza quotidiana della preghiera. «Tace il libro, parlano icorpi», per citare Carlo Ossola. Si cercano così proprio sulla carne le testi-monianze della Grazia: corpi denudati, piagati – colpiti dalla violenza edalla dolcezza amorosa del divino. Sono corpi che sperimentano la vio-lenza dell’irrompere del divino, nell’essere “fogliati”o scorticati – secondoun’immagine mistica che è già figurata nel Marsia di Dante (Paradiso I).Sono corpi su cui il detto biblico Verbum caro factum est (“La parola èdiventata carne”, Giovanni, 1, 14), si fa esperienza diretta, per cui Dio puòscriverli quei corpi, incidendo la pelle o il cuore con inchiostro di sangue,come fossero pagine di un libro; o tesserli come tele, trapassandoli con
261Roberto Fiorini
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 261
aghi di dolore e trapuntandoli di perle – come in un peircing ante litteram– per rinnovarli, rivestirli, abbellirli e ornarli (come sostiene il mistico fran-cese Jean Joseph Surin nella lettera «à la Mère Jeanne des Anges, ursuline,à Loudun», del 29 luglio 1659).Di nuovo, si tratta di un corpo comunque reso passivo di fronte alla poten-za della divinità, i cui effetti sul fedele sono espressi attraverso le azionimetaforiche “fisiche” e corporee dell’“invadere”, “bruciare”, “incidere”,“ferire” e “risanare dolcemente”. È una passività che giunge fino all’anni-chilimento,alla riduzione a nulla,alla morte mistica come annullamento inDio.E proprio il tema del nulla assume ora un’importanza del tutto nuova.Dio sparisce dal cielo, scacciato dal progredire del telescopio; sparisce dalmondo, scacciato dalla ricerca scientifica; sparisce dal Libro, il quale vienesottratto dai provvedimenti controriformisti. Si ritrae dunque nell’interio-rità, in quel luogo intimo in cui non può arrivare la coscienza,né la memo-ria,né la parola.E in quella interiorità profonda,nella semioscurità di quel-la cripta della mente, illuminata dalla luce sovrannaturale del divino, con-serva tutta la potenza sensuale che la “realtà”gli ha sottratto. E, d’altronde,che Dio sia nulla rispetto al mondo, nulla di ciò che sensibilmente è, divie-ne un’idea ammissibile: la mistica – in quanto esperienza del divino –diviene l’esperienza di un desiderio e di una mancanza assoluti.
I. Il corpo barocco ed i sensi
Il Barocco sviluppa un tipo di esperienza dei sensi del tutto particolare. Lametafora e le altre figure retoriche cessano di essere solo un modo di dis-porre il testo sulla pagina, o di renderlo più efficace, per diventare unmodo di percepire il mondo, di farne esperienza. La trovata ingegnosa, lacosiddetta arguzia o acutezza, attraverso la metafora,diventa un modo diconoscere il mondo, una modalità dell’esperienza. Si tratta di un’espe-rienza in cui i sensi hanno un rilievo straordinario: la percezione sensibi-le, attraverso l’elaborazione ingegnosa e retorica, si confonde con l’espe-rienza immaginaria. Il corpo pare liquefarsi nella realtà – allargando lasfera dell’interiorità a tutto lo spazio raggiunto dai sensi e aprendo ilcorpo ad essere attraversato, percorso, trafitto e imbevuto dalle sensazio-ni.“Ferita” e “svisceramento” traducono in immagine questo tipo di espe-rienza di apertura e liquefazione del corpo dentro alla realtà, lo scambioimmaginario di interiorità ed esteriorità.Proviamo a leggere alcuni esempi poetici che possano testimoniare que-sto tipo di esperienza dei sensi, del corpo e della carne.
1.1 Giovanbattista Marino – da La Galeria, AngelicaNella seconda parte della sezione della Galeria dedicata ai “ritratti didonne” – tra i ritratti di donne “belle, impudiche e scellerate” – troviamo,al n. 5, il ritratto di Angelica. Si tratta del personaggio dell’Orlando Furio-
262 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 262
so, di Ludovico Ariosto, la quale, dopo lungo fuggire vari cavalieri innamo-rati, è infine caduta innamorata lei stessa del giovane saraceno Medoro,ferito e da lei medicato. Il poeta immagina che sia il ritratto stesso di Ange-lica a parlare e descrivere il suo innamoramento,con un sottile gioco argu-to e concettoso sul tema della piaga d’amore.Il testo è tratto da G. Marino, La Galeria, a cura di M. Pieri, Padova, Livia-na, 1969.Il componimento si compone di due ottave di endecasillabi.
[5] ANGELICA1 Il fido annel,1 che per virtù d’incanti2
d’involarmi3 a le viste ebbe valore,4
m’ascose agli occhi de’ sagaci5 amantima non del cieco e più sagace Amore.Errai fra l’armi e fra gli armati6 erranti,or di me fanciul nudo7 è vincitore;tal che ferita8 da l’altrui ferita,9
per dar vita a chi muor, perdo la vita.
2M’assido a lato al giovane Africano,di crudo feritor Medica pia.10
Ei con gli occhi m’uccide,11 io di mia manodi curar il suo mal tento ogni via.Mentre la piaga sua chiudo e risano,sento aprirsi nel cor la piaga mia.Io languisco d’amor, di duolo ei langue:12
m’asciuga il pianto, e io gli asciugo il sangue.
La situazione di sensuale erotismo è moltiplicata dal gioco retorico e con-cettoso delle antitesi. La donna, bianca e cristiana, è seduta a fianco delcorpo nudo, esposto ed indifeso del giovane africano – nero e musulma-no – ferito e quasi privo di sensi. La virtù dell’anello, capace di sottrarla
263Roberto Fiorini
1 Il fido annel: il fidato anello (magico, con il quale Angelica poteva sparire alla vista).2 per virtù d’incanti: in virtù di incantesimi.3 involarmi: sottrarmi, rubarmi.4 valore: capacità, virtù.5 sagaci: attenti, accorti.6 armati: cavalieri.7 fanciul nudo:Amore, ma anche Medoro, che, ferito, è sottoposto alle cure della donna.8 ferita: (participio passato) trafitta, piagata.9 da l’altrui ferita: dalla piaga di un altro (Medoro).10 di crudo feritor Medica pia: pietosa curatrice di colui che spietatamente (crudo) mi haferita.11 m’uccide: perché mi fa innamorare.12 Io languisco...ei langue: io mi consumo per amore, egli per dolore perde le forze. Il versoè un chiasmo* i cui termini medi sono in rapporto di antitesi* (d’amor/di duol).Al contrarioil verso seguente sarà strutturato su un parallelismo*.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 263
alla vista degli «armati erranti», non può nulla di fronte alla vista “interio-re” di Amore. Così, mentre cura la ferita del «fanciul nudo», sente lo sguar-do del giovane aprirgli nel cuore la ferita d’amore: alle armi belliche sisostituisce il tagliente potere della vista,capace di ferire il cuore.Ma è pro-prio la caratteristica di “esposizione”, di languido abbandono del giovanea “ferire” l’interiorità della donna («ferita da l’altrui ferita»), a farla innamo-rare. All’atto di curare da parte della donna, corrisponde specularmentel’atto di ferire da parte del giovane – anche se in effetti,dei due,è la donnache agisce («io di mia mano di curar il suo mal tento ogni via») mentre ilgiovane, di nuovo, è oggetto esclusivamente passivo («la piaga sua chiudoe risano», «di duolo ei langue»).Dove fallirono tanti «armati» cavalieri,è pro-prio la sola, inerme nudità del giovane ferito (dietro la quale si profila lanudità del dio Amore, pronto a scagliare i suoi dardi) a sedurre la donna eferirne il cuore profondo. Quello che è rilevante, è il fatto che il nucleodella tensione poetica – generatore della macchina concettosa delle anti-tesi incrociate – si incentra sulla opposizione tra interiorità ed esterioritàdell’esperienza dello sguardo (come rapporto di guardare e di mostrarsi,di nascondere e di vedere, attraverso le soglie progressive delle armature,delle vesti e della pelle), mentre la risonanza interiore ed erotica dell’attodel guardare viene ricondotto al campo metaforico della ferita,come espe-rienza di ulteriore ed estremo oltrepassamento della soglia ultima dellapelle: apertura, esposizione, svuotamento, mancanza. La esperienza delcorpo come “perdita” e “mancanza” è sottolineata dalla ripetizione delverbo “asciugare”, all’ultimo verso, rivolto agli ummori del pianto e delsangue: secrezioni del corpo preso e dominato dalla passione, quasiespressione del suo svuotarsi ed esporsi alla sofferenza ed alla mancanza.
1.2 Giacomo Lubrano – da Scintille poetiche, xxviiUna serie di sonetti, all’interno della raccolta intitolata Scintille poetiche,è dedicata al baco da seta, considerato come emblema di una “moralità”,vale a dire di una considerazione morale. Il verme e la sua vicenda dimetamorfosi, che da vilissimo ed abietto animale lo trasforma in pregiatae splendida seta, viene volta a volta a significare il valore dello spiritoumano, che si svincola dalla miseria e dalla nullità della carne; la vanitàdegli abbigliamenti umani, prodotti con lo strazio dei nudi vermi; la posi-tiva industriosità che spinge ad affaticarsi per arricchirsi interiormente enon per accumulare beni.In tutti i sonetti dedicati al “verme setaiuolo” un posto centrale ha la figu-ra dello “svisceramento” e il conseguente gioco concettoso che si stabili-sce nel mettere in relazione la pochezza e la ripugnanza della esterioritàcorporale del verme e la ricchezza del suo esprimersi in fili di seta (ric-chezza, che di volta in volta può assumere il significato allegorico di fede,poesia,preghiera,canto,coscienza,ecc.). Il tormento che la tecnica di pro-duzione della seta infligge al corpo del verme – tecnica che prevede labollitura dei bozzoli – diventa allegoria dei tormenti dell’anima, per acce-
264 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 264
dere alla salvezza. Nel caso che prendiamo ad esempio, il poeta realizzauna prosopea*, figura retorica per cui si introduce a parlare una cosa per-sonificata (in questo caso il verme stesso) o un personaggio storico.Riportiamo il testo da G. Lubrano, Scintille poetiche, a cura di M. Pieri,Ravenna, Longo, 1982.Il metro è il sonetto con schema ABBA,ABBA, CDC, DCD.
XVIProsopopea
Arte13 è la mia vita: tesso e ritesso14
le viscere spremute in bave d’oro:15
né pur del chiuso boccio ove dimorom’è di volar al fin sempre concesso.16
Salendo in sù17 di vil ginestra,18
[appressole rovine al mio serico lavoro.19
Così filando i giorni,20 arso mi moro:21
Parca, Prefica insiem, tomba a me stesso.22
Povero23 già serpendo in verdi prati,gustai d’erboso suol dolci le brine,24
senza l’ira temer d’incendii ingrati.25
Ricco crebbi a l’insidie, a le rapine.26
265Roberto Fiorini
13 Arte: l’arte, l’artificio tecnico della tessitura.14 tesso e ritesso: intesso continuamente.15 le viscere... d’oro: le mie interiora spremute nei fili («bave») chiari e lucenti (del bozzolo,da cui si otterrà la seta).16 né pur...concesso: e non mi è sempre concesso di volare via (come farfalla) dal chiuso boz-zolo («boccio») dove io faccio la mia dimora. Di norma il verme viene ucciso, immergendo ilbozzolo nell’acqua bollente, per ottenere la seta.17 Salendo in su: crescendo.18 di vil ginestra: da («di») una misera ginestra.Variante della credenza che voleva il vermenascere dalla polvere. La ginestra è simbolo della umiltà, come la polvere.19 appresso...lavoro: avvicino («appresso») la fine («le rovine») al mio lavoro di costruzionedella seta («serico»).20 filando i giorni: passando i giorni a filare. Ma i giorni e il tempo sono l’oggetto della fila-tura: il verme è animale temporale, come l’uomo.21 arso mi moro: finisco per morire bruciato (tra i bollori delle acque, che mi trasformeran-no in seta).22 Parca, Prefica insiem, tomba a me stesso: essendo a me stesso allo stesso tempo Parca,Prefìca e tomba. La Parca è la figura mitologica che presiede al destino umano, filando, tes-sendo e recidendo il filo della vita di ogni uomo. Prefica è la donna che piangendo canta ilamenti funebri. Il verme è Parca a se stesso, in quanto si procura la morte con il suo lavoro;è Prefica a se stesso in quanto piange il suo destino di morte, come sta facendo con questestesse parole, con questo canto – dentro al proprio bozzolo che è anche la propria “tomba”.23 Povero: nudo, esposto, umile.24 dolci le brine: «l’erba fresca, bagnata di rugiada» (M. Pieri). Nella parola «brine» è insita l’i-dea un’idea di freschezza, che si oppone in modo antitetico al calore del fuoco che attendeil verme alla conclusione della sua vita.25 senza...ingrati: senza temere il furore di irriconoscenti fuochi.Sono i fuochi che fanno bol-lire le acque in cui il verme sarà gettato e sono detti «ingrati» perché spietatamente irrico-noscenti del docile e instancabile lavoro del piccolo verme.26 Ricco...rapine: sono cresciuto fino a diventare ricco (per la mia dote di seta), per essere
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 265
Apprenda27 l’Uom da me, che avari i FatiPiù corrono a spogliar chi ha d’oro il crine.28
Il verme condivide con l’uomo l’umiltà e la povertà della sua condizione,ma soprattutto il suo essere sottoposto al tempo («filando i giorni»). L’e-sperienza dell’essere immerso nella incessante vicenda del tempo, nellametamorfosi di tutte le cose che esso porta con sé, si traduce nell’imma-gine di essere «tomba» a se stessi.L’immagine della “tomba vivente”– varia-zione del corpo come sepolcro dell’anima – riprende la polarità tra inte-riorità ed esteriorità che è implicita nella immagine dello svisceramento,dello “spremere” le viscere in fili lucenti – quasi il verme secernesse unaluminosità interiore, che contrasta con lo squallore del corpo, sottopostoal tempo («appresso le rovine») e al suo destino di accrescimento e morte(«salendo in su», «filando i giorni», «crebbi»). Una medesima concretezzamaterica, per il tramite della elaborazione retorica, trasforma in esperien-za dei sensi il passare del tempo e l’“esprimersi” della vita interiore delverme/uomo.
1.3 Nicolas Poussin – Martirio di S. ErasmoIl dipinto appartiene al periodo romano del grande pittore francese Nico-las Poussin (1594-1665) ed è datato al 1628. Il martirio orribile del santo– il suo evisceramento – è rappresentato in tutta la sua efferatezza, ma lascena è ispirata ad una compostezza generale – pur nella agitazione deimovimenti – orientata alla imitazione dei modelli classici. Il martire è statosvestito dei suoi abiti vescovili, che giacciono in primo piano, per terra. Lasua nudità viene offesa ulteriormente, il suo corpo ancora più profonda-mente violato e orrendamente sventrato nel supplizio, che egli sopportacon fermo eroismo.
1.4 Gianlorenzo Bernini – Plutone e ProserpinaIl particolare appartiene al gruppo marmoreo raffigurante il ratto di Pro-serpina da parte del dio degli Inferi, Plutone. Fu scolpito nel 1621-1622 daGian Lorenzo Bernini (1598-1680) per il cardinale Scipione Borghese, perla sua villa di campagna – dove ancora oggi si trova (Galleria Borghese diRoma).Nel particolare è evidente la sensualità con cui Bernini rende la vio-lenta stretta di Plutone sulla pelle morbida e luminosa della giovane fan-ciulla. Rappresentare il movimento, la morbidezza della carne, la delicatez-za luminosa della pelle, in una materia immobile e dura come il marmo –
266 Percorsi didattici
destinato ai tradimenti e alle spoliazioni (della tecnica umana, che trarrà da me la seta).«Ricco» è in antitesi con «Povero» del v. 9. Da povero stava nei freschi prati. Crescendo,aumenterà il suo valore e la sua preziosità, fino ad essere gettato nell’acqua bollente, ed esse-re ridotto in seta.27 Apprenda: tragga un insegnamento. È la “moralità”.28 che avari...crine: l’uomo apprenda da me (il fatto che) il destino avido e insaziabile («avarii Fati») più s’affretta («corrono») a depredare («spogliare») chi ha i capelli d’oro – vale a direchi è ricco fino ai capelli oppure, forse meglio, chi ha in sé più bellezza e giovinezza.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 266
sviluppando, quindi, un’implicita antitesi* – fa parte della poetica di Berni-ni. Qui l’opposizione è moltiplicata dal contrasto tra la giovanile vitalitàdella fanciulla e l’età matura di Plutone, signore delle ombre, del buio e deimorti: la sua presa rapinosa e sensuale nei confronti della giovane fanciul-la (come le dita si immergono nella carne, flettendone e piegandone lasuperficie di luce) assume un significato profondamente perturbante.
II. Il corpo mistico
A. L’estetica di MarinoLa poetica di Marino si propone consapevolmente come un tentativo ditradurre i temi classici e quelli cristiani in una esperienza di totale coin-volgimento dei sensi, attraverso l’uso della poesia e della retorica. All’in-terno di questo progetto poetico, un posto speciale occupa l’inserimentonella sua poesia di temi, lessico ed esperienze tratte dalla teologia e dallamistica. Molti elementi si colgono nell’Adone, la cui medesima figura assu-me i caratteri di passività dell’eroe disarmato ed innocente.Ma questo pro-posito è evidentissimo nelle Dicerie sacre.
2A.1 Giovanbattista Marino – dalla Lira, cxlviSi capisce meglio il senso del brano precedente comparandolo con un madri-gale assai importante,compreso nella terza parte della Lira (1614), la raccol-ta di tutti i componimenti poetici del Marino.Si tratta del madrigale cxlvi,chenon era sfuggito all’attenzione di Baltasar Gracián,che ne L’Arte dell’ingegnolo prende ad esempio di perfetto concettismo, per l’alto contenuto teologi-co che in esso è racchiuso, nel rapido volgere di pochissimi versi. In esso ilpoeta si rivolge alla piaga del costato di Cristo, che chiama, con espressionedesunta dal linguaggio mistico, «piaga dolce d’amore».Leggiamo il madrigale cxlvi, da G. B. Marino, Opere, Milano-Napoli, Ric-ciardi, 1968.
Piaga dolce d’amoreGià tu piaga non sei,Ma bocca di quel coreChe parla ai sensi miei:E quante in te consperseSon stille sanguinose,Tanto son per mio ben lingue amorose.29
Per il fatto di essere riconosciuta come «piaga dolce d’amore», la ferita delcostato si rivela come la bocca del cuore di Cristo. Il cuore di Cristo – in
267Roberto Fiorini
29 E quante...lingue amorose: e quante sono le gocce di sangue cosparse su di te, o ferita,tante sono le lingue che parlano ispirate da amore per me.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 267
quanto egli è Parola di Dio fattosi carne – parla all’uomo in modo sensibi-le. E le gocce di sangue che stillano dalla ferita diventano lingue che dico-no parole d’amore per l’umanità. La ferita è dunque bocca perché rivelaciò che è dentro al cuore di Cristo.Come la bocca, la ferita si fa tramite trainteriorità ed esteriorità. Il concetto espresso e il linguaggio sono i mede-simi del contesto mitico-erotico della morte di Adone.
2A.2 Giovanbattista Marino – da Dicerie Sacre, Diceria secondaNel 1614 – lo stesso anno dell’edizione del terzo libro della Lira – sonoedite a Torino le Dicerie sacre. Nelle tre orazioni che compongono l’opera,Marino affronta i temi evangelici e le questioni teologiche. Le tre orazionivertono infatti sulla Sacra Sindone (la Diceria prima), sulle sette paroledette da Cristo in croce (la Diceria seconda) e sul Cielo (la Diceria terza).In realtà, le Dicerie sono anche molto di più che semplici orazioni sacre,estendendosi ad un vero e proprio tentativo di allargare il discorso ad unareinterpretazione del ruolo delle arti e della poesia: la Diceria prima portainfatti come titolo La pittura, mentre la Diceria seconda è dedicata a Lamusica. In esse, dunque, trova spazio quel medesimo progetto poetico cheMarino avrebbe perfezionato con le raccolte della Galeria – dedicata alladescrizione di opere di pittura e scultura – e della Sampogna, dedicata piùgeneralmente al rapporto tra poesia e musica. Ma nelle Dicerie quel pro-getto si collega saldamente alla materia religiosa e teologica.Nella Diceria seconda,Marino imposta il proprio lungo discorso,come unapartitura musicale, a commento delle sette parole di Cristo in Croce. Il cul-mine del discorso è forse nella parte conclusiva della orazione sacra, la quar-ta, dedicata all’ultima parte della passione del Cristo e al rapporto tra lui eMaria,ai piedi della Croce. Il tema principale è quello dell’amore che unisceGesù, Giovanni e la Madonna e, in particolare, il figlio alla madre.Leggiamo alcuni passi dalla quarta parte della Diceria seconda. È ilmomento culminante della Passione e gli occhi della madre piangenteincrociano quelli morenti del figlio.L’edizione da cui traiamo il testo è G. Marino, Dicerie sacre e La strage degl’innocenti, a cura di G. Pozzi,Torino, Einaudi, 1960.
Sono gli occhi messaggeri d’Amore, son porte della mente, son balconi del-l’anima, sono specchi che rappresentano l’imagine del cuore, son libri in cuisi leggono gli interni affetti, son penne che non di lontano, ma presenti scri-vono lettere amorose, son lingue che parlano senza favella:30 ma sono anchestromenti musici che si accordano tra gli amanti. O che musica fanno gliocchi di Cristo con quelli di Maria mentre si mirano! O che armonia fannogli occhi di Maria con quelli di Cristo mentre s’incontrano! Sguardi efficaci,sguardi loquaci, anzi eloquenti, che tacendo ragionano, nel silenzio s’inten-dono, commuovono senza parole, persuadono senza argomenti e dialogan-
268 Percorsi didattici
30 favella: parola favella.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 268
do reciprocamente fra se stessi con una mutola facondia,31 fanno quasi unabella muta di madriali32 a due. Chi ha giamai veduti quinci e quindi oppostiil Sole e ’l Girasole, quello in Cielo questo in terra, quello con raggi questocon foglie, l’uno all’altro rivolgersi:che se quello sorge questo s’apre:se quel-lo poggia33 questo s’inalza; se quello tramonta questo s’inchina;contempli insimil atto la madre pendere dal figlio pendente: la quale se già al levante delsuo natale34 fu piena di gioia, al meriggio della sua vita visse lieta e beata, ahimisera che ora all’occaso35 della sua morte trabocca di mortal dolore! [...] Chi vide mai due specchi l’uno di fronte all’altro, che con vicendevoli rifles-si ripercuotono questo a quello i medesimi oggetti, consideri, né più némeno, la madre e ’l figlio: il figlio su la croce, la madre a pié della croce, ilfiglio patisce, la madre compatisce, muore il figlio, tramortisce la madre, lan-guisce il figlio, spasima la madre, e con dolcissimo cambio di tenerezze sidànno e rendono insieme colpi e risposte d’affettuosi sentimenti. [...] Ma per meglio dire, chi sentì mai due liuti in conforme proporzione di con-sonanza accordati, che per occulta virtù di simpatia,36 mentre l’uno è sona-to, l’altro senza esser tocco37 risponde, imagini tale appunto il figlio e lamadre, in ugual tenore d’amorosa angoscia concordi, che nella passione enella compassione l’un l’altro si rispondono scambievolmente. Si vagheggia-no gli occhi, si scontrano gli sguardi, si riflettono i voleri, s’abbracciano gliaffetti, si communicano i cuori. [...]S’una spina fora le tempie al figlio, è uno strale che trappassa il cuore allamadre. S’un chiodo punge la palma al figlio, è un pugnale che trafige il cuorealla madre. Se la lancia ferisce il fianco al figlio, è un fulmine che saetta ilcuore alla madre.Né solo con gli sguardi fanno gli occhi questa musica dolo-rosa, ma con le lagrime ancora. O lagrime armoniche tra gli occhi rugiadosidi due anime innamorate!
Lo straziato rapporto amoroso – i «colpi e risposte di affettuosi sentimen-ti» – tra Gesù in croce e la Madonna ai suoi piedi viene reso da Marino conla virtuosistica elaborazione di esperienze sensoriali incrociate l’una sul-l’altra e quasi sempre impostate sulla figura retorica della antitesi. Lacomunicazione tra i due avviene attraverso gli occhi, che lasciano vedereciò che sta dentro il cuore di ciascuno. Si tratta di una comunicazionemusicale, anche se muta (di qui la serie degli ossimori, figure a loro voltadella antitesi), per il fatto che essa è sommamente armonica.Vista e uditosi incrociano anche negli esempi: gli specchi, che si riflettono reciproca-mente; i liuti, consonanti per prossimità. La comunicazione profonda («si
269Roberto Fiorini
31 mutola facondia: muta eloquenza. Questo è l’ultimo di una serie di ossimori e antitesi.32 muta di madriali: serie di madrigali. Il madrigale era una forma di poesia cantata a piùvoci.33 poggia: scende.34 al levante del suo natale: all’alba della sua nascita. Inizia la metafora continuata che equi-para Gesù al sole e Maria al girasole.35 occaso: tramonto.36 per occulta virtù di simpatia: per nascosto potere di accordo reciproco.37 tocco: toccato.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 269
communicano i cuori») avviene attraverso la messa in tensione dei sensi,che vibrano concordi come messi in risonanza musicale reciproca. Il rap-porto d’amore tra il figlio morente e la madre, tra Gesù in croce e laMadonna, è di fatto – come la musica – capace di muovere profondamen-te gli affetti e toccare il cuore. La compartecipazione dell’ascoltatore èbasata sulla medesima profonda commozione:è la parola del poeta, in que-sto caso, a concertare le emozioni e a muovere gli affetti con il flusso rit-mico della sua musicalissima prosa.
2A.3 Caravaggio – Incredulità di San TommasoIl quadro di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) si trova a Pot-sdam. È datato 1602-1603.Tommaso è più che incredulo: pare quasi cieco.La sua cecità è fisica – nell’occhio fisso, allucinato e quasi perso nel vuoto,pur nello sforzo di vedere e toccare e quasi insinuarsi dentro alla ferita permeglio vedervi l’interno. Ma allo stesso tempo la sua è una cecità spiritua-le – causata dalla sua scarsa fede. Il gesto di Cristo pare quasi sforzare e vin-cere la debolezza dell’apostolo, guidandogli le dita (e l’occhio) a penetrar-gli la ferita – mentre con l’altra mano scosta la tunica, per mostrare il pettoferito.Tutta la composizione è costruita sulla tensione dei corpi, piegati equasi chini verso il corpo di Cristo – con le teste degli apostoli e di Cristoraggruppate al centro della composizione e gli sguardi di tutti convergentisulla ferita. Il corpo di Cristo assorbe la luce, che proviene dal lato sinistrodella composizione – che nel quadro è completamente occupato dalla suafigura.La tunica di Cristo ha lo stesso colore chiaro e la stessa morbida con-sistenza della pelle; i capelli non scendono sul viso di Cristo, solo perchésono trattenuti dall’orecchio – ma s’appoggiano scomposti al collo,mentrela testa è piegata ad accompagnare con attenzione e cura il gesto ingenuoma terribile di Tommaso.Alla luminosità e alla seminudità di Cristo corri-sponde per contrasto – sul lato destro della composizione – il gruppo degliapostoli, coperti nelle loro vesti e nei loro mantelli, che hanno i toni piùscuri e opachi. La figura di Cristo ha, insomma, un’evidenza del tutto “reali-stica”, fino a risentire del peso (i capelli che ricadono, lo sforzo nell’alzarela mano di Tommaso);eppure, lo sforzo visivo dell’apostolo nel vedere e nelcredere, il suo sguardo perduto nel vuoto, paiono attestare la cecità deisensi: è l’evidenza della carne il mistero più profondo.
2A.4 Nicolas Poussin – Lamento di Venere su AdoneIl dipinto di Nicolas Poussin (1594-1665) è del 1628 ed è conservato aCaen, in Francia. Rappresenta il momento culminante della vicenda d’a-more tra Venere e Adone. La scena è assai composta e i gesti di Veneresono ispirati ad una dignità classica. Il contesto è quello di una natura sub-lime, immersa nell’ultima luce del tramonto. Si noti la postura di Adone,abbandonato sensualmente al sonno della morte.
270 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 270
2A.5 Nicolas Poussin – Compianto di CristoIl dipinto è del 1627 e si trova all’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.Precede di un anno il Lamento di Venere su Adone e i punti di contattocon quel dipinto sono numerosi. In primo luogo la disposizione di Cristoè la medesima, seppure rovesciata: di essa colpisce soprattutto la medesi-ma posizione delle gambe, leggermente divaricate, e la testa rovesciata inun abbandono estremo. In secondo luogo la seminudità di Cristo appareevidentemente simile a quella di Adone: anzi essa è ancora più accentua-ta, abbassandosi il lenzuolo bianco a scoprire il ventre fino all’inguine. Interzo luogo gli amorini piangenti sulla destra della composizione sono imedesimi che accompagnano i gesti di Venere. Il dolore della Vergine,invece,è più pateticamente sottolineato:non asperge il corpo del figlio (loha già fatto, e le brocche sono abbandonate in basso a sinistra), ma siabbandona ad un gesto di disperazione, quasi svenendo di dolore (e lamano si abbandona sul petto del figlio, esanime). Anche la scenografia èsimile: in un esterno, tra oggetti desunti dall’archeologia classica (il carronel Lamento, il sepolcro nel Compianto), mentre differente è la luce: untramonto che investe di luce la scena nel quadro conservato a Caen, unaluce piatta e cinerea in quello di Monaco.
B. L’esperienza misticaL’esperienza erotica e l’esperienza mistica condividono un medesimo les-sico e tematiche assai vicine. Comune ad entrambe le esperienze è la cen-tralità del corpo e dei sensi, oltre ad un particolare ricorso agli strumentidella retorica nella descrizione del rapporto con la divinità – inattingibileoggetto del desiderio dell’anima.
2B.1 Juan de la Cruz – da Canzoni fra l’anima e lo SposoSpesso il rapporto tra Dio e l’anima assume nel linguaggio mistico levalenze di un rapporto amoroso, più precisamente quello del rapporto tragli sposi o i promessi – come si è già visto nella conclusione del sonettodi Donne.Tale rapporto ha un referente biblico nel Cantico dei cantici etrova particolare sviluppo in gran parte dei testi di mistici. Un particolarerilievo a questa tematica è dato, alla fine del XVI secolo, dal mistico spa-gnolo Juan de la Cruz (1542-1588).Anche nella sua opera poetica, consi-derata come espressione dell’esperienza mistica avuta durante l’estasi, ilrapporto amoroso tra l’anima e Dio oscilla tra la violenza della ferita (odella piaga da ustione) e la dolcezza della carezza d’amore che ristora.Di Juan de la Cruz leggiamo alcune strofe dalle Canzoni fra l’anima e loSposo, in cui si immagina che la Sposa – l’anima – dopo una affannosaricerca, ritrovi lo Sposo – Cristo – e insieme a lui prefiguri le gioie dellaloro unione d’amore.Il testo è tratto da J. de la Cruz, Poesie, a cura di G.Agamben,Torino, Einau-di, 1974. Tale edizione non riporta i “commenti spirituali” che l’autoreappose in un secondo momento ai suoi cantici.
271Roberto Fiorini
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 271
SPOSAPerché, se m’hai ferito38
il cuore, poi non l’hai guarito? E se me l’hai rubato,perché poi te ne sei andato e il bottino con te non hai portato?39 45Spegni le mie ansie perché nessuno basta ad appagarle;fa’ che ti vedano i miei occhi,perché sei la loro luce e solo per guardarti mi son cari. 50Svelati e uccidimi,visione di bellezza;guarda: io ho pena d’amor, che non si cura se non con la presenza e la figura. 55O fonte di cristallo,se nello specchio delle tue sembianze40
in un lampo sorgessero gli occhi desiderati che nel mio ventre41 porto disegnati! 60Distoglili,Amato:io spicco il volo.42
SPOSOVoltati, colomba:43
il cervo ferito sul vertice si mostra44 65e la brezza del tuo volo lo rinfresca.
SPOSAIl mio Amato: le montagne,la solitudine delle valli boscose,le isole meravigliose,i fiumi fragorosi, 70il fischio dei venti innamorati.La notte placata prossima al risveglio dell’aurora,
272 Percorsi didattici
38 ferito: facendomi innamorare.39 e il bottino...portato: lasciandomi qui sola con il cuore strappato.40 se nello specchio delle tue sembianze: il testo spagnolo ha si en esos tus semblantes pla-teados – “se in quei tuoi sembianti argentati”.41 nel mio ventre: dentro di me; ma l’espressione è estremamente forte e “corporea”.42 io spicco il volo: è il volo mistico dell’anima verso l’oggetto del suo desiderio.43 colomba: l’identificazione della sposa come colomba è citazione del Cantico dei Cantici,2, 14.44 il cervo ferito...si mostra: l’identificazione dell’amato come un cervo è citazione del Can-tico dei Cantici, 2, 17 – «ritorna, o mio diletto, somigliante alla gazzella o al cerbiatto, soprail monte degli aromi».
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 272
la musica taciuta,la solitudine sonora, 75la cena che ristora ed innamora.Il nostro letto fiorito è circondato da tane di leoni,sotteso di porpora,scolpito nella pace, 80di mille scudi d’oro incoronato.Incalzando la tua tracciale ragazze ti cercano a un tocco di favilla,a un aromatico vino, 85soavi di balsamo divino.Nella più interna segreta45
dell’Amato ho bevuto, e quando ne usciiin tutta la campagna più nulla riconobbi 90e perduto era il gregge, che pascevo.Là mi aprì il suo petto e m’insegnò un’aromatica46 scienza;tutta a lui nell’atto mi donai, senza riserve: 95là gli promisi di essere sua sposa.La mia anima si è votata con tutti i miei tesori al suo servizio:e non ho più greggi 100né altro uffizio;ormai solo in amore è il mio esercizio.
Oltre alle tematiche tipiche della mistica – la relazione amorosa tra l’ani-ma e Dio («mi donai senza riserve», v. 95); la ferita d’amore («se m’hai feri-to», v. 41); l’esposizione dell’interiorità («Là mi aprì il suo petto», v. 92) – ilbrano presenta una caratteristica particolare.Nelle due strofe tra i versi 67e 76 viene descritto l’Amato, come esso viene percepito nel momento del“volo” mistico verso di lui, da parte dell’anima fattasi colomba. La perce-zione dell’Amato è riportata ad una serie di situazioni,che mettono in lucealmeno tre caratteristiche essenziali dell’esperienza dell’anima.In primo luogo, soprattutto nella prima strofe, la percezione interiore del-l’anima è rapportata a contesti di carattere naturale («montagne», «valliboscose», «isole meravigliose», «fiumi fragorosi», «venti innamorati»), daiquali emerge generalmente un suono indistinto, come una voce inartico-lata: «i fiumi fragorosi / il fischio dei venti innamorati». Nel commento spi-
273Roberto Fiorini
45 segreta: cella, stanzetta.46 aromatica: gustosa, saporita. «Aromatica scienza» è in un certo senso un ossimoro*: ritor-na il riferimento al senso del gusto per significare l’esperienza interiore immediata del divi-no. Conoscere, amare e “gustare” sono la stessa esperienza.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 273
rituale alle Canzoni, Juan stesso precisa la natura di tale effetti acusticicome «un suono e voce spirituale» – vale a dire un suono che è già voce,che parla e dice, quindi, pur fermandosi prima dell’articolazione in parola(quella che si definisce generalmente come “glossolalìa”.In secondo luogo, la percezione acustica di tali suoni si precisa, nellaseconda strofe, come «solitudine sonora» (v. 75): espressione estremamen-te allusiva, che suggerisce di cogliere quei suoni nella contemplazionesolitaria del loro sorgere dal silenzio, del loro porgersi isolato alla medita-zione solitaria. È una solitudine comune alla interiorità dell’anima (appun-to, «la solitudine sonora» del v. 75), come alla realtà esterna («la solitudinedelle valli boscose», v. 68) – che si precisa al verso 74 («la musica taciuta»)come sostanza musicale: di nuovo, voce inarticolata che, senza parole,parla al cuore.In terzo luogo, la percezione dell’anima al momento decisivo del volomistico non è quella di una intensificazione della percezione sensoriale,ma, al contrario, di un suo indebolimento: una percezione notturna, quie-ta – della calma profonda che precede il «risveglio dell’aurora».Nel commento, Juan spiega il motivo di questa silenziosa solitudine not-turna: «e così lo spirito in questa contemplazione sta nella solitudine ditutte le cose, privato di tutte quelle e come nudo, e non acconsente a séniente altro che la solitudine in Dio». La notte è dunque immagine del farsiopaco della percezione delle cose, del loro scivolare verso l’inconsistenza,di fronte all’emergere dell’Amato: da quel silenzio prorompe il rumoredella sua voce – «voce immensa», «voce infinita» secondo le parole del com-mento – ma pure inarticolata e indistinta come quella del fragore delleacque fluviali. Di fronte ad essa lo spirito sta come annichilito e “nudo” epercepisce il rapporto con l’Amato non nella luce chiara e trasparente delgiorno – come un’esperienza evidente e razionalmente esprimibile – manella opacità della notte, nel silenzio solitario della contemplazione muta,attraverso un’esperienza sensoriale rarefatta e assoluta – pura e preceden-te ad ogni significato determinato – espressa attraverso l’ossimoro* della“musica taciuta” (musica callada, v. 74), della “musica silenziosa”.
Jean Josef Surin – dalle LettereL’opera del padre gesuita francese Jean Joseph Surin (1600-1665) è statastudiata a fondo nella splendida opera di Michel de Certeau, La favolamistica. Fu di fatto un mistico, ossessionato da un tale terrore di essereposseduto dal demonio, da ridursi a comportamenti ritenuti folli dai suoistessi confratelli. Le sue opere principali sono il Catechismo spirituale(1659), i Fondamenti della vita spirituale (1667) e i Cantici spirituali(1660). Rimane anche una fitta corrispondenza, edita da Michel de Cer-teau nel 1966. Da questa, leggiamo due passi, citati anche da Mino Berga-mo nel suo L’anatomia dell’anima, Bologna, Il Mulino, 1991: il primo ètratto da una lettera datata 1630, in cui Surin illustra gli insegnamenti cheegli ha potuto ricavare da un giovane assolutamente privo di istruzione,
274 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 274
ma illuminato nella sua innocenza da un sapere divino, tanto che Surinpensa possa essere un angelo – come dice Bergamo «emerso misteriosa-mente dalle profondità del non sapere»; il secondo è tratto da una letteradatata 1632, in cui l’autore rievoca la santità della vita di una donna cheaveva conosciuto,Marie Baron.Entrambe le figure sono contraddistinte dauna esperienza particolare della interiorità, per esprimere la quale si fariferimento a figure della esperienza corporea.I testi si trovano in J. J. Surin, Coerrespondance, a cura di M. de Certeau,Parigi, Desclée de Brouwer, 1966, pp. 140 e 142. La lettera del 1632 vieneriportata e commentata a fondo nel capitolo VII L’illetterato illuminato,in M. de Certeau, Fabula mistica. La spiritualità religiosa tra il XVI e ilXVII secolo, Bologna, Il Mulino, 1987.
Jean Josef Surin – dalle Lettere (1630)
Ciò che ho trovato di particolarmente notevole nel ragazzo è una prudenzaammirevole e una straordinaria efficacia nelle parole. Mi disse che la lucesovrannaturale che Dio versa in un’anima gli fa vedere tutto quello che essadeve fare in modo più chiaro ed evidente di quanto la luce del sole mostri glioggetti sensibili, e che la moltitudine di cose che scopre all’interno è moltopiù grande di tutto ciò che è nella natura corporea; che Dio con tutta la suagrandezza abita e si fa sentire nel cuore puro, umile, semplice e fedele.
AnalisiIl giovane ignorante e illetterato, casualmente incontrato come una visita-zione angelica, nella sua disarmata semplicità, insegna e mostra una viainteriore alla visione, l’esperienza di una luce differente rispetto a quelladel sole.Tale luce è letteralmente “versata” dentro il soggetto – come unliquido, di cui il corpo è il vuoto recipiente rispetto alla potenza («gran-deur») divina. Così interiorità ed esteriorità si rovesciano nuovamentel’una nell’altra.Tale esperienza non è nulla di raffinato ed elitario: essa èuna esperienza immediata del cuore – «puro, umile, semplice e fedele» –esperienza ingenua e spontanea propria di un giovane privo di qualunqueerudizione, ma gettato nella vita e nel corpo. E si sottolinea che si tratta diun giovane: la sapienza del cuore non è più legata all’accumulo di saggez-za proprio della maturità e della vecchiaia.Tutto nel fanciullo pieno di sag-gezza assume le caratteristiche dello “straordinario”: tanto sublimi e mera-vigliose sono le sue parole quanto ugualmente di estrema semplicità egrossolanità sono i gesti, i modi e l’abbigliamento. Se è un angelo («crede-vo fosse un angelo») si tratta dunque di un angelo che abita il mondo, checompare e scompare dopo poco, effimero e fugace come qualsiasi cosa almondo – come l’Angelus Novus di Klee e Benjamin. E la indecisa appar-tenenza – all’eternità del divino o all’attimo dell’incontro, alla sfera ange-lica o alla miseria del mondo, alla luminosità interiore della fede o allosquallore esteriore delle vesti – riverbera sulla ambiguità della esperienzadel protagonista, indecisa e perplessa tra la meraviglia per una manifesta-
275Roberto Fiorini
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 275
zione del divino o l’esperienza terrena di una seduzione. In modo non dis-simile, Pier Paolo Pasolini rappresenta nel Vangelo secondo Matteo l’e-sperienza della chiamata di Gesù agli apostoli impegnati a correre lungole rive del lago, come incontro dei loro corpi e dei loro sguardi sorpresinell’aprirsi del riso. Ma il tramite attraverso il quale Pasolini guarda quel-l’esperienza è senza alcun dubbio il Caravaggio riletto da Roberto Longhi,le cui lezioni egli aveva frequentato negli anni bolognesi.
Jean Josef Surin – dalle Lettere (1632)
Ella diceva che la mattina, al suo risveglio, si trovava come in un paese stra-niero. Le sembrava di non essere più di questo mondo, e di sentirsene comebandita e esiliata nella sua interiorità, come in una solitudine profonda chele presentava degli spazi vasti, in cui nascondersi agli occhi degli uomini.Quella sola parola di “interiore” la rapiva fuori di se stessa.
Analisi Come ha notato Mino Bergamo nel saggio citato, nel brano risulta eviden-te il fatto che interiorità ed esteriorità si scambiano e si oppongono: lainteriorità perde i connotati di luogo “chiuso” e limitato, per acquisirequelli di luogo vasto e aperto («spazi vasti»). Lo spazio interiore perdeanche le caratteristiche di interiorità, per definirsi meglio come luogoesterno («fuori di se stessa»). D’altronde, in quello spazio interiore sappia-mo (dalle parole del fanciullo angelico) potere esserci una grande molti-tudine di cose, molto maggiore di quella che la luce del sole ci svela nellospazio esterno. Lo spazio interiore è insomma uno spazio infinito come èinfinito Dio, la cui insondabile profondità confina con quella del cuore. Lacondizione interiore del mistico è dunque quella di “estraneo” al mondo,pur continuando ad appartenervi. Il contatto interiore con Dio coincidecon una paradossale condizione di “esteriorità” al mondo («bandita e esi-liata nella sua interiorità», «rapita fuori di se stessa»): l’interiorità è, insom-ma, una esteriorità rispetto al mondo esterno, una esteriorità raddoppiata,l’“esterno dell’esterno”. E la figura del bando – l’istituzione medievale chesanciva per legge l’esteriorità del soggetto al consesso civile, pur conti-nuando a rimanere in vita – sancisce questa condizione di estraneità edappartenenza al medesimo tempo.
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/for-mazione/03fiorini.htm.
276 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 276
“Di ogni cosa resta un poco”. Letteratura e restoMagda Indiveri
[...]Farafarafara,Tarataratara,Paraparapara,Laralaralara!
Sapete cosa sono?Sono robe avanzate,non sono grullerie,sono la ... spazzaturadelle altre poesie.1
All’altezza dell’ultimo anno delle scuole superiori, lo studente si trova apassare dalle parole alate di D’Annunzio ai giochi linguistici dei futuristi;e poiché in fase adolescenziale l’ironia è qualità rara, per ragioni di matu-razione e di autocoscienza, è facile che il «lasciatemi divertire» di Palazze-schi non venga sentito nella sua forza eversiva e dissacrante, ma piuttostocome scherzo fine a se stesso,addirittura banale,visto dal pianeta del post-moderno che ben conosce la lingua di scarto della pubblicità. Frustoli diparole, che sono cugini prossimi delle parole dimezzate e corrotte deimessaggi delle chat e dei telefonini.Un motivo in più allora per fermarsi un po’ su questo tema dei residui,degli scarti,con l’obiettivo di far percepire (insegnare a leggere e ad amarela letteratura ha in primo luogo questa finalità: capire qualcosa di più delnostro umano) il profondo valore etico dell’uso letterario del resto.Non oltre, poiché anche questo percorso vuole essere un frammento, unascheggia, un «compossibile».
1. Resto, avanzo
«Resto» è la prima parola e l’ultima del complesso libro di Jacques Derri-da Glas. Un libro in realtà mal definibile, che non inizia e non chiude. Inun foglio che Derrida aveva aggiunto, non numerato, all’edizione origina-le, la domanda è posta senza mezzi termini:
277Magda Indiveri
1 A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire, in Poesia italiana del novecento, a cura di E. Sangui-neti,Torino, Einaudi, 1971, I, p. 357.
24
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 277
Che cosa resta del sapere assoluto? della storia, della filosofia, dell’economiapolitica,della psicoanalisi,della semiotica,della linguistica,della poetica? Dellavoro, della lingua, della sessualità, della famiglia, della religione, dello Statoecc.? Che cosa resta, nel dettaglio, del resto?2
Un testo per molti versi indecifrabile, che non potrà naturalmente entrarenel corredo delle letture di classe, ma che nel sommerso della cultura deldocente prima di diventare lezione (giustappunto un resto, anche pernoi), può lanciare bagliori acutissimi. Perché l’infinito scialo di ciò cheogni giorno non comprendiamo, o dimentichiamo, oggi e nella stratifica-zione dei secoli, non è inerte ma agisce fortemente su di noi.Nel 1978 (ma degli stessi anni era il testo di Derrida) il filosofo Jean Baudril-lard dava del “resto”una definizione chiarissima, che mette in campo un po’tutti gli elementi da cui partire per una riflessione ed una prima discussione:
Il resto è diventato oggi il termine forte. È sul resto che si fonda una nuovaintelligibilità. Fine di una certa logica delle opposizioni distintive in cui il ter-mine debole funzionava come termine residuale. Oggi tutto si capovolge. Lastessa psicoanalisi è la prima grande teorizzazione dei residui (lapsus, sogni,ecc.). Non è più un’economia politica della produzione a dirigerci, ma un’e-conomia politica della riproduzione, del riciclaggio – ecologia e inquinamen-to – un’economia politica del resto.Tutta la normalità è rivista oggi alla lucedella follia,che non era che il suo resto insignificante.Privilegio di tutti i resti,in tutti i campi, del non-detto, del femminile, del folle, del marginale, dell’e-scremento e del rifiuto in arte, ecc. Ma questo non è ancora che una sorta diinversione della struttura,di ritorno del rimosso come tempo forte,di ritornodel resto come sovrappiù di senso, come eccedenza (ma l’eccedenza non èformalmente diversa dal resto, e il problema del dispendio dell’eccedenza inBataille non è diverso da quello del riassorbimento dei resti in una economiapolitica del calcolo e della penuria: solo le filosofie sono differenti).3
Nella sua accezione complessa, sia negativa (scarto, immondezza, residuo,maceria) sia positiva (resto, rimosso, eccedenza, sovrappiù, alone, scia),Palazzeschi “incendiario” coglie i termini della questione a tal punto chesu «Lacerba» tiene una rubrica intitolata Spazzatura. E in un colpo solo,componendo nel 1910 una poesia fatta di «robe avanzate», ricicla il D’An-nunzio delle stirpi canore («i miei carmi son prole / delle foreste...»)4 e l’o-nomatopeico Pascoli degli scilp...vitt...videvitt...dib dib bilp bilp.5
Si comporta in qualche modo come i bambini che amano giocare conrimasugli e avanzi. Non è un osservatore qualsiasi a notarlo, ma il grande
278 Percorsi didattici
2 J. Derrida, Glas, Milano, Bompiani, 2006.3 J. Baudrillard, Quand on enlève tout, il ne reste rien, in «Traverses», 11, maggio 1978, pp.12-15 [trad. it.V. Cuomo, Quando si toglie tutto, non resta niente, in www.kainos.it, n. 4/5,2004].4 G. D’Annunzio, Le stirpi canore, Alcyone, Torino, Einaudi, 1995.5 G. Pascoli, Dialogo, Myricae, Tutte le poesie, Roma, Salerno editrice, 1991.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 278
Walter Benjamin che per il saggio su L’opera d’arte nell’epoca della suariproducibilità tecnica o per le riflessioni sulla storia non dovrebbe man-care per approfondire lo studio del Novecento. Qui è in una scrittura afo-ristica, particolarmente lucida:
È che i bambini sono portati in misura notevole a frequentare qualsiasi luogodi lavoro in cui si opera visibilmente sulle cose. Si sentono attratti in modoirresistibile dai materiali di scarto che si producono nelle officine, nei lavoridomestici o di giardinaggio, in quelli di sartoria o di falegnameria. Nei pro-dotti di scarto riconoscono la faccia che il mondo delle cose rivolge proprioa loro.A loro soli. In questo essi non riproducono tanto le opere degli adul-ti quanto piuttosto pongono i più svariati materiali, mediante ciò che gio-cando ne ricavano, in un rapporto reciproco nuovo, discontinuo.6
Emerge il concetto di riuso creativo: gli scarti dei manufatti e degli ogget-ti trascinano con sé un assemblaggio, una energia ri-creativa diversa, chemette in moto la fantasia (Gianni Rodari ne è stato maestro), instaura rap-porti nuovi, in una parola produce invece che riprodurre. È il proliferaredei ready-made; il «trionfo della spazzatura».
2. Poesia e fogna
È naturalmente la linea montaliana, poi ripresa da Andrea Zanzotto, quellache del residuo fa la sua chiave interpretativa. Ogni docente ha ben chia-ro in quali testi di Montale, anche cronologicamente, far rimarcare questapresenza. Un riepilogo della questione è ben tracciato in un articolo diZanzotto stesso risalente al 1966, da cui estrapolare alcuni capoversi(tenendo ben fermo quanto sia importante in classe segnalare il legametra poeti, e come gli uni interpretino gli altri, in forma critica oltre chenella citazione interna ai testi).
La scoria, il detrito, il residuo, riscontro di certo modo del vivere che sentese stesso come ab-iezione, costituiscono un tema che percorre tutta l’operadi Montale e che è stato messo in rilievo fin dalle prime chiose a Ossi di sep-pia, titolo emblematico che gli si riconnette. [...]Inizialmente però in queste figure predominano elementi come la maceriae la breccia, che nella loro asprezza,nel loro taglio, alluderebbero a una qual-che forma di sicurezza, di resistenza. [...] Questo tipo di detrito presenta una specie di nettezza originaria connatura-ta alla pietra, una durezza da monumentum, e talvolta un certo vigore cro-matico, conditi di salinità; e il sale è ciò che conserva, che è in rapporto conil perdurare in una forma di «salute». [...]Si fanno avanti, in seguito, altre immagini; i resti, organici, e non, divengonopiù sporchi,più limacciosi. Lungo Le occasioni e La bufera e altro, anche se
279Magda Indiveri
6 W. Benjamin, Cantiere, in Strada a senso unico,Torino, Einaudi, 2006, p. 11.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 279
perdurano presenze come la «grana di zucchero» o la «polvere di vetro», inuna fermentazione di luminosità febbrile, l’opaco e il terreno-magmaticoprevalgono a rapprendere, a invischiare le tensioni improvvise degli «ogget-ti», appesantiscono le volute maiestatiche dei ritmi.7
Dai residui puliti, dunque, simboleggiati dagli ossi di seppia, Montale vaverso una poetica diversa che dieci anni prima, con il suo saggio L’Innonel fango del 1953, Zanzotto gli avrebbe suggerito. Dopo dieci anni disilenzio poetico e di attività critica e giornalistica molto intensa, dal 1964fino al 1971 Montale compone i testi di Satura, che sono una pesante con-danna morale della società successiva al boom economico.Il destino del poeta è adattarsi al trionfo della spazzatura. Dove la poesia èfogna, non si possono usare che materiali di reimpiego, riciclandoli e col-locandoli su uno stesso piano, a contatto con la cronaca, la divulgazione,l’informazione; un materiale rosicchiato o sperperato. La poesia sopravvi-ve rasoterra, in una modalità di «musica bassa».8
In Satura è la sezione Xenia, dedicata alla moglie, quella più frequentatain classe.Vale la pena soffermarsi anche su altro.La suite in otto parti Dopo una fuga racconta l’incontro del poeta conuna giovane donna che per «troppo amore della vita» rischia di perdersi;si susseguono la visita alla clinica in cui è ricoverata, la sua fuga in Indo-nesia, una gita fatta insieme a Sant’Anna. Proponiamo alla lettura proprioquesto testo (VI):
Quando si giunse al borgo del massacro nazista,Sant’Anna, su cui gravita un picco abrupto,Ti vidi arrampicarti come un capriolofino alla cima accanto a un’esile polaccaE al ratto d’acqua, tua guida, il più stambecco di tutti.Io fermo per cinque ore sulla piazzaenumerando i morti sulla stele, mettendomicidentro ad honorem ridicolmente.A seraci trasportò a sobbalzi il fuoribordodentro la Burlamacca,una chiusa di sterco su cui scaricaacqua bollente un pseudo oleificio.Forse è l’avanspettacolo dell’inferno.I Burlamacchi, I Caponsacchi... spettridi eresie, di illeggibili poemi.La poesia e la fogna, due problemimai disgiunti (ma non te ne parlai)9
280 Percorsi didattici
7 A. Zanzotto, Sviluppo di una situazione montaliana (Escatologia-Scatologia), in Fanta-sie di avvicinamento, Milano, Mondadori, 2001.8 R. Luperini, Storia di Montale, Bari, Laterza, 1986, pp. 195 ss.9 E. Montale, Dopo una fuga VI, in Satura II, Tutte le poesie, Milano, Mondadori,ANNO???, p.398.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 280
Si noterà come tutta la gita si fonda sulla visita di resti:quelli umani della guer-ra («i morti sulle stele»), quelli materiali della discarica (sterco, acqua bollen-te), quelli poetici (Caponsacchi è personaggio di un poema di Browning). Iriferimenti a poeti del passato (compaiono, negli altri testi della suite, ancheShakespeare e Keats) servono a straniarne la presenza, a veicolare l’idea chela poesia come era concepita in passato non ha più ragione d’essere («spet-tri...illeggibili poemi»). Resti, appunto, emersioni, nella discarica: detriti insie-me a frammenti preziosi. È la poetica di chi vive, come dice Luperini, «asse-diato dalle cose» che oramai hanno perso la loro ragion d’essere; un «cantodelle scorie» molto vicino ai testi di Zanzotto stesso.
3. Il partito preso delle cose inutili
Di quanti oggetti inutili è colma la poesia del Novecento? Dal XIX secoloin poi il numero delle cose “svuotate” aumenta in una misura e un ritmoprima sconosciuti, poiché il progresso tecnico pone continuamente fuoricorso dei nuovi oggetti d’uso. I correlativi oggettivi della modernità diven-tano le cose inutili perché rotte, scompagnate, inceppate.Accozzaglia di oggetti;cose inutili o invecchiate o insolite,decadute,desuete,derelitte, in privazione di funzionalità: è interessante la confessione di Fran-cesco Orlando,che in apertura di un suo importante saggio rivela la passionegiovanile per gli oggetti desueti, tanto da tenere un quaderno di passi lettera-ri con elenchi di questo tipo,in enumerazione caotica.Da quel quaderno pro-venne la sua predilezione letteraria e una lunga e approfondita ricerca.10
Valerio Magrelli (per citare uno dei poeti dell’ultima generazione chedovrebbe entrare in un canone della contemporaneità) popola le sue poe-sie di meccanismi rotti in cui «dentro qualcosa balla»; di tazze con le crepe;di cocci, di vasi infranti, di armi difettose, di paesaggi di rovine, dove persi-no i volti sono «consumati a guardarli».11 L’arsenale di merci che era ilmondo di Marx, a partire dal nostro Gozzano, attraverso scrittori francesicome Robbe Grillet o Ponge,diventa cumulo variopinto di inutilità,cui perònon si sa rinunciare,ed anzi,se ne fa oggetto di poesia,quasi a voler far assur-gere l’impoetico all’altare del suo riscatto.«What’s that? / An egg?». Con un uovo entra nell’agone poetico nel 1930Samuel Beckett.12
E Giovanni Raboni in una poesia breve sui gusci d’uovo richiama le paro-le di Zanzotto, ma eleva anche un inno alla grazia della vita breve:
La tenerezza del guscio d’uovoDolcemente svuotato con la boccaE ornato con paesaggi lontani
281Magda Indiveri
10 F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura,Torino, Einaudi, 1994, p. 3.11 V. Magrelli, Poesie (1980-1992) e altre poesie,Torino, Einaudi, 1996.12 S. Beckett, Poesie, a cura di G. Frasca,Torino, Einaudi, 2006, p. 5.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 281
Siamo in molti a pensare che non c’èModo di imballarlo come si deveUn oggetto così fragile, così breve e così C’è poco da sperareNella salvezza del guscio d’uovo.13
Un oggetto insalvabile: le cose che proliferano nella poesia contempora-nea condividono la fragilità ma al tempo stesso non vogliono sparire,arrendersi alla distruzione. Portano con sé un residuo, un guscio, inutilema comunque irrinunciabile. Chiedono di vivere ancora un poco, purnella loro inutilità, come lo chiedono le leopardiane mummie risvegliate,oh, solo per un quarto d’ora, nello studio di Ruysch («che fu quel puntoacerbo / che di vita ebbe nome?»).Il medesimo concetto è svolto dal maggior poeta di lingua portoghese insie-me a Pessoa, il brasiliano Carlos Drummond de Andrade (1902 -1987), inter-prete della corrente del modernismo. La sua lunga poesia Residuo è statatradotta da Antonio Tabucchi. La poesia è giocata sul semplice meccanismodell’elenco e della ripetizione. Di tutto è rimasto un poco, e all’inizio è sulpoco che batte l’accento, e si oscilla dai sentimenti (paura, tenerezza) allecose fragili (rose, veli, polvere); poi però vince piuttosto l’idea che qualco-sa è rimasto: dalla categoria del grande (il ponte bombardato) a quella delpiccolo (il piattino rotto),fino a quella dell’umano (un tratto del viso),e dun-que c’è come una consolazione che cresce,fino al riconoscimento che restaqualcosa di noi, una traccia, una scia, una goccia. Resta qualcosa negli even-ti storici, (e si pensi alla montaliana «rete a strascico» della storia), l’odore oil profumo della memoria,qualcosa sotto alle grandi cose, ai fenomeni natu-rali, ai monumenti, alla morte, qualcosa che nel rovesciamento finale ècomunque minimo come un bottone o repellente come un topo.14
4. Le parole sono resti
Sarà importante, nella lettura contrastiva di originale e testo tradotto, facen-do risorsa della non conoscenza del portoghese per puntare l’attenzionesugli aspetti fonici e visivi, far notare come anche nell’operazione di tradu-zione si abbia a che fare con un resto,qualcosa che esubera o manca rispet-to al testo di partenza. Cosa resta, cosa si trasporta?Non appaia peregrino usare, per lanciare questa riflessione, la frase finaledel recente film 21 grammi:
Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istantedella morte tutti perdano 21 grammi di peso,nessuno escluso.Ma quanto c’è
282 Percorsi didattici
13 G. Raboni, A tanto caro sangue, Milano, Mondadori, 1988.14 C. Drummond de Andrade, Sentimento del mondo, Torino, Einaudi, 1987, prefaz. di A.Tabucchi.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 282
in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo, quei 21 grammi?Quanto se ne va, con loro? Quanto si guadagna?
Sarà allora necessario tornare indietro nel percorso a ricercarlo, questoresto. Si analizzi Palazzeschi, come nelle parole privilegia i suoni e ne fagioco linguistico, assemblaggio fonico; si leggano poi le note d’autore concui Eugenio Montale accompagna Dopo una fuga:
Sono noti i Burlamacchi, famiglia di protestanti italiani che si rifugiarono inSvizzera (credo a Ginevra) negli anni della Controriforma. Il Caponsacchi,prete che rapì una malmaritata, è l’eroe del poema di Browning The Ringand the Book. Solo ragioni di numero e di suono, quel giorno, mi indusseroad associare questi due nomi.15
Ragioni di numero e di suono,più che di concetto:come a dire che la poe-sia partecipa di una dose di sussidiarietà, di aleatorietà. Nel discorso per ilconferimento del Nobel Montale difende la poesia proprio perché “inuti-le”. La parola poetica si caratterizza dunque nel suo farsi scarto, residuo,nel suo definirsi per differenza rispetto all’omogeneità totalizzante; è unmondo che si crea espellendosi; si leggano per questo le riflessioni di VitoBonito al termine del suo saggio Il canto della crisalide.16
Le parole sono resto, scia, alone. Risonanza. Sopravvivono a se stesse comelacerti, citazioni, frantumi. Si pensi all’intenzione dichiarata di Benjamin, allacui base c’è una radicata convinzione teorica, di costruire un libro di solecitazioni.Consapevolezza che ogni cosa scritta è resto di altro.Come c’è unapersistenza dell’immagine retinica,anche le parole hanno una vita postuma.Si potrebbe riportare l’immagine suggestiva del Cantico dei cantici: «Il giar-dino è sprangato ma ne escono acque e odore. La porta dell’anima è chiusama ogni tanto appare un filo di luce, una lettera passa sotto la porta».17
Vita postuma e residuale ma anche autonoma: se le parole si destano dinuovo come le mummie leopardiane, scelgono loro dove stare, e più spes-so si tratta di luoghi di scarto, margini di fogli, biglietti, scartafacci; è quelche sostiene Montale nella poesia Le parole.
5. Resti di carta
E se questo resto si perde? Se arriva deviato o non arriva? Angoscia necessa-ria nel mestiere dell’insegnante, il fattore “incomprensione”, perché mantie-ne vigili e realistici. Tra le nostre lezioni possiamo sicuramente ascrivereanche «dead letters», quelle lettere smarrite su cui il Bartleby di Melville si
283Magda Indiveri
15 E. Montale, cit.???????, p. 1120.16 V. Bonito, Una luce spoglia di ogni cosa: la realtà, la poesia, l’immondizia, in Il cantodella crisalide – Poesia e orfanità, Bologna, Clueb, 1999.17 G. Ceronetti (a cura di), Il Cantico dei Cantici, Milano,Adelphi, 2005, p. 133.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 283
incaponisce rifiutandosi un po’ alla volta di vivere. Cartoline postali, rifacen-doci ancora a Derrida, che non sappiamo se e come giungeranno.Intermittenze, più che messaggi sensati, frantumi che sono più un levareche un mettere, resti cartacei.L’umiltà del messaggio mai definitivo e com-pleto. Si potrebbe allora proporre la figura reale – non si tratta solo di unpersonaggio letterario, ma della sua incarnazione – di Robert Walser; dellasua “scrittura residuale”, “laterale”, del suo tenersi lontano dall’evidenzadel mondo; di come amasse scrivere su frammenti di carta. ErmannoCavazzoni in un intervento che figura tra altri presentati a un convegnodel 2000 sul grande scrittore svizzero, morto il giorno di Natale del 1956,sa porre molto bene la questione:
Mi viene da pensare questo: che è come, da parte di Walser, un “mettersi alservizio” della carta. Cerco di spiegare cosa intendo: scrivere su un fogliettogià usato significa non scomodare un foglio nuovo, che probabilmente, perWalser, appare prodotto apposta per lui, come suo strumento,dove lui possascrivere le sue idee, quindi come qualche cosa che si asservisce a Walser: ilfoglio viene (mi piace la parola) scomodato; viene cioè messa in piedi unamacchina produttiva, una produzione cartaria apposta per questa modestaattività, come se l’estro scrittorio di Walser comandasse implicitamente allabella carta pulita di stare lì ai suoi ordini ad aspettare subordinatamente diessere scritta. Lo straccio di foglio, invece, è già nato per qualcos’altro, nonè stato scomodato per lui. Vedevo che ci sono anche dei piccoli pezzi didocumenti, dichiarazioni dei redditi, ad esempio, usati appunto per scrivercisopra, e poi foglietti stracciati, con l’angolo rotto; ecco, tutto questo fa sì chela scrittura perda quell’enfasi che di fronte al foglio bianco tendenzialmenteavrebbe. E diventa uno scrivere approfittando delle cose avanzate, non siscomoda nulla, sono cose che sarebbero finite, che sarebbero state buttatevia:Walser si mette al loro servizio.18
I frammenti di carta simbolicamente rappresentano pezzi di vita chepotrebbero disperdersi e sparire; la loro destinazione più comune è ilfuoco, e il prodotto della combustione è la cenere – resto per eccellenzaletterario e al tempo stesso umano. Un pezzetto di carta può celare persempre un pezzo di vita, ma può anche salvarlo (cosa si perde? Cosa siguadagna?). È necessario leggere a questo punto la toccante testimonian-za del poeta Attilio Bertolucci riguardo ad un suo allievo fucilato alla finedella guerra e al pezzetto di carta «blu da zucchero» ritrovato tra le suecose: la trascrizione di una poesia di Bertolucci stesso che il giovane avevavoluto portarsi con sé al momento dell’arresto: residuo di un residuo arappresentare una vita.Resti allora che danno un qualcosa in più, ai quali conviene prestare atten-zione perché è in quelli che vibra, a tratti, il senso più vero.
284 Percorsi didattici
18 E. Cavazzoni, Sulla Carta, in Per Robert Walser, www.zibaldoni.it.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 284
Il percorso può finire con la voce Brandelli scritta da Erri de Luca, poeta eromanziere, per un singolare libretto-dizionario intitolato Alzaia. Dalle sueparole impariamo che ammesso ci sia una salvezza, e ammesso che siamo ingrado di insegnarne la strada, essa non può che risiedere in un resto.
Sergio Quinzio pubblicò nel 1980 Dalla gola del leone, un piccolo libro dipensieri di incandescente dolore. Il titolo viene da un verso del profeta Amos(3, 12) che traduco “Così ha detto Iod/Dio, come scipperà il pastore dabocca del leone due zampe o una parte d’orecchio, così saranno scippati ifigli d’Israele”. Quinzio chiama questa salvezza:“misera e paradossale”. Cosase ne fa un pastore di questi magri rimasugli strappati a gran fatica dalle fauciaffamate della belva? Il suo gesto non è vano. Deve riportare indietro unsegno: il capo di bestiame a lui affidato non è andato perduto per sua incu-ria ma per una razzia, alla quale ha opposto le sue forze. Senza questo segnoil padrone può chiedergli conto della perdita e addebitargliela. Il verso diAmos racconta che una gran parte della vita di ognuno finisce divorata daltempo senza lasciare traccia.Ma colui che ha avuto in affido la vita può strap-pare al niente qualche brandello, dimostrando al padrone di essersi battutoper salvare qualcosa. Per misero e paradossale che sia quel rimasuglio, essoè la prova che quel brandello salvato dipendeva da ognuno e che esso eratutto il nostro frutto. Era la nostra resistenza alla parola hèvel, che Qohéletmette a consuntivo della sua indagine sulla vita:“Il tutto è hèvel”. Gerolamola tradusse vanitas.Altri hanno tentato parole diverse. Io leggo in hèvel spre-co e contro la spreco c’è il brandello rischioso del pastore di Amos.19
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/for-mazione/06indiveri.htm.
285Magda Indiveri
19 E. De Luca, Brandelli, in Alzaia, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 20.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 285
Inferni e mondo contemporaneo Carlo Varotti
Proponiamo un breve percorso dedicato alla rappresentazione “infernale”del mondo contemporaneo. Non abbiamo l’ambizione di catalogare inmaniera sistematica o particolarmente ricca tipologie e forme. Soltantoproponiamo la lettura di alcuni testi corredati di un agile apparato che for-nisca indicazioni didattiche concrete.Abbiamo escluso dalla scelta molti possibili testi di natura filosofica, pole-mica, teologica o quant’altro. Non ci interessava infatti documentare unastoria della rappresentazione dell’inferno tra modernità e contemporanei-tà,ma proporre alcuni esempi concreti di narrazione, individuando la riuti-lizzazione di elementi dell’immaginario collettivo per rappresentare even-ti o situazioni di grande (spesso traumatico) impatto emotivo sull’osser-vatore contemporaneo.Abbiamo perciò limitato il nostro lavoro alla selezione di alcuni testi nar-rativi, che ci consentono di mettere in rilievo non tanto generiche indica-zioni tematiche, ma modalità concrete di costruzione del testo.In particolare leggeremo alcune pagine (Manzoni; Malaparte; Buzzati) incui la rappresentazione dell’inferno cristiano – depositatasi nella memoriacollettiva attraverso una plurisecolare tradizione folklorica e letteraria –fornisce un paradigma di rappresentazione della realtà. Il paradigma infer-nale diviene allora il mezzo che rende visibile (e “dicibile”) l’orrore; o unachiave straniante che svela un “inferno” quotidiano smarritosi nella bana-lità di una condizione di vita alienata.
Alcuni dati preliminari
Il passaggio dell’inferno da luogo reale della punizione divina a metaforadi una certa realtà storico-sociale presuppone la crisi nella credenza del-l’inferno. Il trasferimento dell’inferno da realtà oltremondana a rappre-sentazione di una condizione terrena e storica è uno degli aspetti del pro-cesso di secolarizzazione che segna l’età moderna.La messa in discussione dell’inferno e della sua esistenza è un tratto carat-teristico del pensiero dei philosophes illuministi, ma è già presente neilibertini e in un geniale anticipatore del pensiero illuminista come PierreBayle (seguiamo alcune indicazioni contenute in G. Minois, Piccola storiadell’Inferno, Bologna, Il Mulino, 1995; ed. orig. 1994).A questo proposito sipotrebbe utilmente leggere la voce Inferno nel Dizionario filosofico diVoltaire. Il filosofo francese, che contro la tesi leibniziana della terra come
286 Percorsi didattici
25
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 286
“il migliore dei mondi possibili”aveva fatto attraversare al suo Candido piùdi un “inferno”mondano (non ultimo quello della Lisbona distrutta dal ter-remoto: evento che fu uno dei traumi del secolo), nel Dizionario proponeuna razionale eziologia dell’inferno, trovandone la genesi in quel bisognoumano di giustizia terrena che continuamente l’esperienza storica elude.Nel corso dell’Ottocento la rappresentazione dell’inferno e delle sue crea-ture diventa un elemento ricorrente in letteratura e in poesia. Quantomeno si crede nell’inferno (quale predicatore penserebbe di dissuadere ilmale minacciando le fiamme eterne...) tanto più si afferma la tendenza afare della rappresentazione dell’inferno la condizione stessa dell’uomo: lasua angoscia esistenziale o l’esito necessario del dispiegamento distrutti-vo delle sue passioni.Tramontate le visioni tradizionali di pene eterne, i bui antri lacerati daipianti e “guai” dei dannati cessano di parlare alla coscienza moderna:meglio, cessano di esprimere con forza il principio della proibizione edella paura per la sanzione morale.Il diavolo zoccolato e cornuto (dopo aver per secoli popolato gli incubinotturni di pii credenti e peccatori) non può che fare la sua comparsa inun contesto straniante; che sarà, di volta in volta, archeologico recuperodella tradizione folklorica, ironico viaggio nell’area magico-naive dell’in-fanzia, oppure figura simbolica, archetipo aperto alla molteplicità delleinterpretazioni, tanto più efficace quanto più sfuggente e molteplice ne èla figura, polisemico il linguaggio.L’Ottocento si apre con la ricca galleria di diavoli della letteratura tedescaromantica. Ma sono tutti veramente (verrebbe da dire con Faust) “poveridiavoli” (arme teufel). Si tratti di un diavolo degno di abitare una favolainfantile (come nello Schlemihl di Von Chamisso); o dei diavoli “pertur-banti”di alcuni racconti di Hoffmann; siamo comunque di fronte a un uni-verso “fantastico”, che presuppone di necessità una visione razionale delmondo, che ha bandito da sé il meraviglioso e il miracolo. Oppure è undiavolo che – come il Mefistofele di Goethe – è destinato a perdersi in unlabirinto di complessità che anche per lui,creatura sovrumanamente dota-ta, è sfuggente e inafferrabile.Il diavolo e l’inferno sembrano dunque sopravvivere solo nello spazioriservato e artefatto della letteratura fantastica. Ma in realtà il paradigmainfernale conserva una grande forza simbolica e rappresentativa.Assistia-mo però a un interessante mutamento di prospettiva, per cui la rappre-sentazione tradizionale dell’inferno fornisce un paradigma descrittivo nongià del mondo “infero”, ma del mondo tout court.Relegato dunque il diavolo della tradizione, come si diceva, alla dimensio-ne straniante della favola o del recupero folclorico, il “paradigma inferna-le” viene trasferito nel quotidiano, diviene misura del quotidiano, rappre-sentazione della società contemporanea.
287Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 287
Renzo agli inferi
Nella sua prima avventura milanese Renzo incontra una Milano in rivolta.Nel romanzo manzoniano Renzo è l’eroe itinerante: percorre le strade delmondo (dal borgo a Milano; da Milano al bergamasco; dal bergamasco aMilano ecc.), incontrando avventure, ma anche compiendo una sua per-sonale parabola di crescita. In un saggio uscito ormai da alcuni decenni,Girardi (Renzo agli inferi, in Manzoni reazionario, Bologna, Cappelli,1972) osservava che Renzo compie nei Promessi sposi una descentio adinferos che ha molti punti di contatto (e altrettante significative differen-ze) rispetto alle descentiones compiute da eroi archetipici (Ulisse, Enea eDante). La discesa infernale di Renzo è connotata dal suo essere di naturaintimamente cristiana. È cioè un’esperienza in cui il contatto diretto conl’errore e il traviamento morale conferma e rafforza la sostanza morale ereligiosa della persona. Renzo – anche se coinvolto nell’esperienza “infer-nale” della città rivoluzionaria – conserva intatta infatti la sua strutturamorale, trasformando così l’esperienza del tumulto in un fattore di realecrescita interiore.La realtà sociale e il mondo cittadino in rivolta vengono descritti da Man-zoni utilizzando forme e modelli descrittivi desunti dalla rappresentazio-ne dell’inferno. Ci limitiamo a segnalare (e non ad approfondire) il signifi-cato ideologico della scelta manzoniana che di fatto propone una sorta diidentificazione tra rivoluzione e inferno: in ottemperanza a un progettopolitico-ideologico connotato in senso liberale e moderato.Il passo è tratto dal cap. XIV del romanzo. È la sera del giorno di San Mar-tino, segnato dall’assalto ai forni e alla casa del Vicario di provvisione.Renzo ha appena tenuto una piccola orazione in una strada traendo unsuo bilancio di quella giornata memorabile. Ora è tardi: occorre pensare aun ricovero per la notte.
“Chi è di questi bravi signori che voglia insegnarmi un’osteria, per mangiareun boccone, e dormire da povero figliuolo?” disse Renzo.“Son qui io a servirvi, quel bravo giovine,” disse uno, che aveva ascoltataattentamente la predica, e non aveva detto ancor nulla.1
“Conosco appunto un’osteria che farà al caso vostro; e vi raccomanderò alpadrone, che è mio amico, e galantuomo”.2
“Qui vicino?” domandò Renzo.“Poco distante,” rispose colui.La radunata si sciolse; e Renzo, dopo molte strette di mani sconosciute, s’av-viò con lo sconosciuto, ringraziandolo della sua cortesia.
288 Percorsi didattici
1 «disse...nulla»: è l’agente di polizia incaricato di trovare un colpevole da affidarealla giustizia.2 «conosco... galantuomo»: lo sbirro allude al tribunale, dove intende condurreRenzo per affidarlo alle mani della giustizia.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 288
“Di che cosa?”diceva colui:“una mano lava l’altra, e tutt’e due lavano il viso.Non siamo obbligati a far servizio al prossimo?” E camminando, faceva aRenzo, in aria di discorso, ora una, ora un’altra domanda.“Non per sapere ifatti vostri; ma voi mi parete molto stracco: da che paese venite?”“Vengo,” rispose Renzo,“fino, fino da Lecco”.“Fin da Lecco? Di Lecco siete?”“Di Lecco... cioè del territorio”.“Povero giovine! per quanto ho potuto intendere da’ vostri discorsi,3 ven’hanno fatte delle grosse”.“Eh! caro il mio galantuomo! ho dovuto parlare con un po’ di politica,4 pernon dire in pubblico i fatti miei; ma... basta, qualche giorno si saprà; e allo-ra... Ma qui vedo un’insegna d’osteria; e, in fede mia, non ho voglia d’andarpiù lontano.”“No,no;venite dov’ho detto io,che c’è poco,”disse la guida:“quinon istareste bene”.“Eh, sì;” rispose il giovine:“non sono un signorino avvezzo a star nel cotone:qualcosa alla buona da mettere in castello,5 e un saccone, mi basta: quel chemi preme è di trovar presto l’uno e l’altro.Alla provvidenza!” Ed entrò in unusciaccio, sopra il quale pendeva l’insegna della luna piena.“Bene;vi condurrò qui,giacchè vi piace così,”disse lo sconosciuto;e gli andòdietro.“Non occorre che v’incomodiate di più,”rispose Renzo.“Però,”soggiunse,“sevenite a bere un bicchiere con me, mi fate piacere”.“Accetterò le vostre grazie,” rispose colui; e andò, come più pratico delluogo, innanzi a Renzo, per un cortiletto; s’accostò all’uscio che metteva incucina, alzò il saliscendi, aprì, e v’entrò col suo compagno.Due lumi a mano,pendenti da due pertiche attaccate alla trave del palco, vi spandevano unamezza luce. Molta gente era seduta, non però in ozio, su due panche, di quae di là d’una tavola stretta e lunga, che teneva quasi tutta una parte dellastanza: a intervalli, tovaglie e piatti; a intervalli, carte voltate e rivoltate, dadibuttati e raccolti; fiaschi e bicchieri per tutto.Si vedevano anche correre ber-linghe, reali e parpagliole, che, se avessero potuto parlare, avrebbero dettoprobabilmente: – noi eravamo stamattina nella ciotola d’un fornaio, o nelletasche di qualche spettatore del tumulto, che tutt’intento a vedere comeandassero gli affari pubblici, si dimenticava di vigilar le sue faccendole pri-vate. – Il chiasso era grande. Un garzone girava innanzi e indietro, in fretta ein furia, al servizio di quella tavola insieme e tavoliere: l’oste era a sedere suruna piccola panca, sotto la cappa del cammino, occupato, in apparenza, incerte figure che faceva e disfaceva nella cenere, con le molle; ma in realtàintento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. S’alzò, al rumore del saliscen-di;e andò incontro ai soprarrivati.Vista ch’ebbe la guida,– maledetto! – dissetra sé: – che tu m’abbia a venir sempre tra’ piedi, quando meno ti vorrei! –Data poi un’occhiata in fretta a Renzo, disse ancora tra sé: – non ti conosco;ma venendo con un tal cacciatore, o cane o lepre sarai: quando avrai detto
289Carlo Varotti
3 «da’ vostri discorsi»: allude ai discorsi fatti per strada da Renzo, nei quali il mon-tanaro lamentava le troppe ingiustizie che i deboli e i poveri sono costretti a sub-ire da parte dei potenti.4 «con un po’ di politica»: restando sulle generali.5 «mettere in castello»: mangiare.
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 289
due parole, ti conoscerò.– Però,di queste riflessioni nulla trasparve sulla fac-cia dell’oste, la quale stava immobile come un ritratto: una faccia pienotta elucente, con una barbetta folta, rossiccia, e due occhietti chiari e fissi.
Proposte di lavoro
Un’analisi del brano potrebbe essere affidata agli allievi stessi, attraversouna lettura guidata che li aiuti a individuare aspetti linguistici, immagini osituazioni riconducibili alla rappresentazione della realtà “infernale”.Ad esempio:
Lo sbirro provocatoreLo sbirro provocatore (che poi denuncerà Renzo) ha visto nel giovane uncapro espiatorio ideale (forestiero;montanaro ingenuo).Le parole con cui sipresenta allo sprovveduto provinciale offrendogli aiuto sono un insieme diipocrisia e untuosa cortesia («sono qui io a servirvi,quel bravo giovine»).Unaprofferta di aiuto che ricorda l’interessata disponibilità del diavolo tentatore.Alla figura dello sbirro risponde, a conclusione del brano, quella dell’oste.La sua espressione è immobile e impenetrabile, ma sopratutto conservaconnotati luciferini. Ha una «barbetta» che – oltre a essere connotatocaratteristico del diavolo – è «rossiccia», con allusione al motivo folcloricoche attribuisce al colore rosso doppiezza e malvagità (il rosso “malpelo”).
La Luna pienaAll’inferno allude il nome stesso dell’osteria (la Luna piena), attraverso l’i-dentificazione della mitologia tra regina degli inferi e luna stessa (attra-verso la divinità dalla triplice forma di Proserpina/Diana/Luna). Un’identi-ficazione mediata con ogni probabilità dal ricordo di un notissimo luogodantesco (la profezia di Farinata, in Inferno X, 79 ss.: «Ma non cinquantavolte fia raccesa / la faccia de la donna che qui regge»).
L’«usciaccio»L’«usciaccio» che separa come una soglia simbolica l’osteria, immette in unmondo “infero” caotico («chiasso»; il senso di disordine che appare dalladescrizione),immerso nell’oscurità («mezza luce»),che si connota come unasorta di mondo in cui tutti i valori della civile convivenza sono rovesciati. Èinfatti un luogo popolato di ladri e di biscazzieri (come rivelerebbero, sepotessero parlare, le monete che corrono sul tavolo), che nelle pagine suc-cessive del romanzo interpreterà sistematicamente le parole di Renzo sullagiustizia in senso diametralmente opposto al loro reale significato.
Il delirio collettivoNel delirio collettivo della città in rivolta si iscrive lo scontro sistematicotra apparenza e realtà che caratterizza tutta la discesa “infernale”di Renzo.
290 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 290
Essa vive nel parlare allusivo del mefistofelico aiutante, le cui parole sonointessute di doppi sensi («Conosco appunto un’osteria che farà al casovostro;e vi raccomanderò al padrone,che è mio amico,e galantuomo»:chedesigna il palazzo di giustizia e il bargello).Ma soprattutto si situa nel grot-tesco incontro tra il mondo eticamente rovesciato dei ladri dell’osteria“infernale” e il solido mondo morale di Renzo.Il conflitto che scoppia tra il valore delle parole che Renzo adotterà perillustrare il suo bisogno di vera giustizia, e il senso con cui quelle paroleverranno accolte dai divertiti e occasionali ascoltatori, prefigura simboli-camente un conflitto che riguarda l’intera città in rivolta, nella quale ilsistematico rovesciamento di diritti, doveri e valori, l’ha trasformata in unasorta di generale inferno dell’ambiguità e dell’incertezza.Si potrebbe assegnare agli allievi il compirto di leggere l’intero capitoloXIV, individuando le argomentazioni adottate da Renzo nei discorsi tenutiall’osteria della Luna piena. Un’analisi delle reazioni dei presenti alle sueparole potrebbe condurre alla preparazione di una sorta di griglia in cuiindicare il senso attribuito a determinate parole da Renzo, e quello attri-buito alle stesse parole dai malavitosi presenti nell’osteria.
Curzio Malaparte, La pelle
Uscito contemporaneamente in Francia e in Italia nel 1949, il romanzo diMalaparte racconta la Napoli del 1943 e 1944.Occupata dalle truppe allea-te la città conosce un abisso di degradazione e umiliazione umana. Il para-digma infernale domina l’intero romanzo,come fosse il solo capace di ren-dere conto di una dimensione straniata e perversa, sconvolta in ogni fon-damento morale e civile.Allo stravolgilmento della realtà in una dimensione “altra”, da aldilà infer-nale, risponde la ricerca costante del raccapricciante, lo scandalo dell’o-sceno. Siamo di fronte a un inferno penetrato nelle pieghe del quotidiano,che ha informato di sé ogni aspetto dell’esistenza,ogni possibile valore. Lamercificazione del corpo e la svendita della dignità, in una Napoli fameli-ca e affollata, divengono così il simbolo di un’Europa degradata, lacerataterra di conquista.Nella prima pagina del romanzo, Malaparte parla della «terribile folla...squallida, sporca, affamata, vestita di stracci», che convive con i soldati vin-citori che «urtavano e ingiuriavano in tutte le lingue e in tutti i dialetti delmondo». Un babelico sovrapporsi di corpi e voci dissonanti, che rammen-ta il primo affacciarsi dell’Inferno allo sguardo e all’udito di Dante, appe-na intrapreso il viaggio nell’aldilà (Inferno III, 22 ss.):
Quivi sospiri, pianti e alti guairisonavan per l’aere sanza stelle,per ch’io al cominciar ne lagrimai.
291Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 291
Diverse lingue, orribili favelle,parole di dolore, accenti d’ira,voci alte e fioche, e suon di man con elle
«Diverse lingue» e «orribili favelle» si mescolano in una confusione domi-nata dalla violenza, fisica («urtavano») e verbale («ingiuriavano»).Ma il paradigma di una descensio ad inferos, che trasforma la Napoli “libe-rata” in una terra di morti viventi fornisce un’esplicita chiave di letturapoche righe più sotto (dunque ancora nell’incipit del romanzo), quandoal capitano Malaparte, ufficiale dell’esercito italiano aggregato agli alleati,viene presentata la compagnia che dovrà comandare (C.Malaparte,Opere,a cura di L. Martellini, Milano, Mondadori, 1997, pp. 969-970):
... il sergente gridò:“Compagnia, attenti!”. Lo sguardo dei soldati si appesan-tì su me con un’intensità dolorosa, come lo sguardo di un gatto morto. Leloro membra si irrigidirono, scattarono sull’attenti. Le mani che stringevanoi fucili erano bianche, esangui: la pelle floscia pendeva dalle dita come lapelle di un guanto troppo largo.Il colonnello Palese prese a parlare, disse:“Vi presento il vostro nuovo capi-tano...” e mentre parlava io guardavo quei soldati italiani vestiti di uniformitolte ai cadaveri inglesi, quelle mani esangui, quelle labbra pallide, quegliocchi bianchi. Qua e là, sul petto, sul ventre, sulle gambe, le loro uniformierano sparse di nere chiazze di sangue.A un tratto mi accorsi con orrore chequei soldati erano morti. Mandavano un pallido odore di stoffa ammuffita, dicuoio marcio, di carne seccata al sole. Guardai il colonnello Palese, anch’egliera morto. La voce che usciva dalle sue labbra era umida, fredda, viscida,come quegli orribili gorgoglii che escono dalla bocca di un morto se gliappoggi una mano sullo stomaco.
Proponiamo la lettura di una pagina in cui il paradigma dantesco apparecon chiarezza, per altro esplicitamente (anche se genericamente) richia-mato nel testo.
La sera del 25 luglio del 1943, verso le undici, il Segretario della regia Amba-sciata d’Italia a Berlino,Michele Lanza,se ne stava adagiato in una poltrona pres-so la finestra aperta, nel piccolo appartamento da scapolo di un suo collega.Faceva un caldo soffocante, e i due amici, spenta la luce e spalancata la fine-stra, sedevano nella stanza buia fumando e discorrendo fra loro.Angela Lanzaera partita per l’Italia con la bambina alcuni giorni innanzi, a trascorrer l’e-state nella sua villa presso il lago di Como. (Le famiglie dei diplomatici stra-nieri avevano lasciato Berlino ai primi di luglio,per fuggire non tanto il caldoafoso dell’estate berlinese, quanto i bombardamenti, che ogni giorno si faca-vano più duri.) E anche Michele Lanza, come altri funzionari dell’Ambascia-ta, aveva preso l’abitudine di passar la notte in casa, ora di questo ora di quelcollega, per non rimaner solo, chiuso in una stanza, durante le ore notturne,fra tutte le più lente,e per dividere con un amico,con un essere umano, l’an-goscia e i pericoli dei bombardamenti.Quella sera Lanza era in casa del suo collega, e i due amici sedevano al buio
292 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 292
parlando della strage di Amburgo. I rapporti del Regio Console d’Italia inAmburgo narravano fatti terribili. Le bombe al fosforo avevano appiccato ilfuoco a interi quartieri di quella città, facendo un gran numero di vittime.Finqui nulla di strano, anche i tedeschi sono mortali. Ma migliaia e migliaia d’in-felici, grondanti di fosforo ardente, sperando di spegnere in quel modo ilfuoco che li divorava, s’erano gettati nei canali che attraversavano Amburgoin ogni senso, e nel fiume, nel porto, negli stagni, perfino nelle vasche deigiardini pubblici, o s’eran fatti ricoprir di terra nelle trincee scavate, perimmediato rifugio in caso d’improvviso bombardamento, qua e là nelle piaz-ze e nelle strade: dove, aggrappati alle rive e alle barche e immersi nell’ac-qua fino alla bocca,o sepolti nella terra fino al collo,attendevano che le auto-rità trovassero un qualche rimedio contro quel fuoco traditore. Poiché ilfosforo è tale che si appiccica alla pelle come una viscida lebbra, e bruciasolo al contatto dell’aria.Non appena quei disgraziati sporgevano un bracciofuor della terra o dell’acqua, il braccio si accendeva come una torcia. Perripararsi dal flagello,quegli sciagurati erano costretti a rimanere immersi nel-l’acqua o sepolti nella terra come dannati nell’Inferno di Dante. Squadre disoccorso andavano da un dannato all’altro, porgendo bevande e cibo, attac-cando con funi alla riva gli immersi perché abbandonandosi, vinti dalla stan-chezza, non annegassero, e provando ora questo, ora quell’unguento: mainvano, poiché nel mentre ungevano un braccio, o una gamba, o una spalla,tratti per un istante fuor dell’acqua o della terra, le fiamme subito si risve-gliavano simili a serpentelli accesi, e nulla valeva ad arrestare il morso diquella terribile lebbra ardente.Per alcuni giorni Amburgo offri l’aspetto di Dite, la città infernale. Qua e lànelle piazze,nelle strade,nei canali,nell’Elba,migliaia e migliaia di teste spor-gevano fuor dell’acqua e della terra, e quelle teste, che parevano mozze dallamannaia, livide dallo spavento e dal dolore, muovevan gli occhi, aprivan labocca, parlavano. Intorno alle orribili teste, conficcate nel selciato delle stra-de o galleggianti alla superficie delle onde, andavano e venivano notte egiorno i familiari dei dannati, una folla smunta e lacera, che parlava a vocebassa, quasi per non turbare quella straziante agonia: e chi portava cibo,bevande, unguenti, chi un cuscino da metter sotto la nuca del loro caro, chi,seduto accanto a un sepolto, gli dava sollievo al viso con un ventaglio con-tro il calore del giorno, chi gli riparava la testa dal sole sotto un ombrello, ogli asciugava la fronte madida di sudore, o gli umettava le labbra con un faz-zoletto bagnato, o gli ravviava i capelli con un pettine, e chi, sporgendosi dauna barca, o dalla riva del canale o del fiume, confortava i dannati aggrappa-ti alle corde e dondolanti sul filo della corrente.Bande di cani correvano quae là abbaiando, lambivano il viso dei padroni interrati, o si buttavano a nuotoper soccorrerli.Talvolta alcuni di quei dannati, presi dall’impazienza, o dalladisperazione, gettavano un alto grido, tentando di uscire fuor dell’acqua odella terra, e por fine allo strazio di quella inutile attesa: ma subito, al con-tatto dell’aria, le loro membra avvampavano, e zuffe atroci si accendevanotra quei disperati e i loro familiari, che a pugni, a colpi di pietra e di basto-ne, o con tutto il peso del proprio corpo, si sforzavano di rificcar nell’acquao nella terra quelle terribili teste.I più coraggiosi, e pazienti, erano i bambini: che non piangevano, non grida-vano, ma volgevano intorno gli occhi sereni a mirar l’orrendo spettacolo, esorridevano ai familiari, con quella meravigliosa rassegnazione dei bambini,
293Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 293
che perdonano l’impotenza degli adulti, e hanno pietà di chi non può aiu-tarli. Non appena scendeva la notte, nasceva intorno un bisbiglio, un sussur-ro, come di vento nell’erba, e quelle migliaia e migliaia di teste guatavano ilcielo con occhi accesi di terrore.Al settimo giorno fu dato l’ordine di allontanare la popolazione civile dai luo-ghi, dove i dannati eran sepolti nella terra, o immersi nell’acqua. La folla deiparenti si allontanò in silenzio, sospinta con dolcezza dai soldati e dagli infer-mieri. I dannati rimasero soli. Un balbettio spaurito, uno stridor di denti, unpianto soffocato, uscivan da quelle orribili teste affioranti dall’acqua e dallaterra lungo le rive dei canali e del fiume, nelle strade e nelle piazze deserte.Per tutto il giorno quelle teste parlaron fra loro, piansero, gridarono, con labocca a fior di terra, facendo smorfie, orrende, mostrando la lingua agli shu-pos di guardia ai crocicchi, e pareva che mangiassero il terriccio, e sputas-sero i sassi. Poi scese la notte: e ombre misteriose si aggiravano intorno aidannati, si curvavan su loro, in silenzio. Colonne di autocarri con i fari spen-ti giungevano, sostavano. Si alzava da ogni parte uno strepito di zappe e dibadili, uno sciacquio, i tonfi sordi dei remi nelle barche, e grida subito soffo-cate, e lamenti, e schiocchi secchi di pistola.
Proposte di lavoro
Nella pagina di Malaparte si incrociano molteplici suggestioni riconduci-bili al modello dantesco.La condizione degli sventurati colpiti dalle bombe al fosforo richiama ana-loghe situazioni dantesche: almeno l’immersione nel sangue dei violenti(canto XII); l’immersione nella pece bollente dei barattieri (canti XXI-XXII).Un operazione sul testo potrebbe essere proposta come individuazione di unrapporto intertestuale con il modello dantesco, individuandone la presenzain uno strato più profondo, linguistico-lessicale, che non sia quello genericodella situazione descritta o la semplice individuazione di campi semanticiche rinviano al tema della dannazione e della sofferenza (verrà subito notatoche i colpiti sono chiamati 7 volte “dannati”: la prima volta in diretta associa-zione con l’Inferno dantesco: «erano costretti a rimanere immersi nell’acquao sepolti nella terra come dannati nell’Inferno di Dante»).Come si diceva, l’insegnante potrebbe proporre un’indagine sul lessicoimpiegato da Malaparte, attraverso l’uso di semplici strumenti informaticidi ricerca sui testi (pensiamo alla LIZ, ma l’offerta della rete è, ormai, piut-tosto varia).Il lavoro potrebbe essre utile per mettere in rilievo la complessità dei mec-canismi allusivi: un circuito di forme, richiami, sedimentazioni della memo-ria, in cui si situa la complessità di ri-uso della lingua letteraria e i tasselli sucui sono costruite le forme dell’immaginario.Attraverso un’operazione chelascia spazio al lavoro individuale di ricerca, lo studente è messo a contattocon l’idea di profondità o spessore storico del codice letterario.
294 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 294
Abbiamo individuato alcuni esempi (ma un lavoro attento, magari di grup-po, potrebbe moltiplicarli):
«Stridor di denti»In Dante compare tre volte il termine “strida”. Due casi sono interessanti:a. Inf. V, 35: «quivi le strida, il compianto, il lamento»; che associa strida e(com)pianto; il passo di Malaparte dice: «uno stridor di denti, un piantosoffocato».b. Inf. XII, 102: «dove i bolliti facieno alte strida». Qui il termine “strida” èassociato a una situazione vicina a quella descritta da Malaparte: i “bolliti”sono i tiranni immersi in un fiume di sangue bollente («Or ci movemmocon la scorta fida / lungo la proda del bollor vermiglio, / dove i bollitifaceano alte strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio...»).
Il capo separatoLe «orribili teste» che affiorano dall’acqua o dal terreno sembrano «mozzedalla mannaia».Nell’infernale dimensione straniata esse sembrano una vitapropria, quasi mostruose realtà artificialmente separate dal corpo («Pertutto il giorno quelle teste parlaron tra loro»). Dietro l’immagine sono rav-visabili numerose suggestioni dantesche. Da Gerione che affiora nel buio,e che sembra giungere “a pezzi” (Inf. XVII, 8: «sen venne, e arrivò la testae ’l busto»).Ma pensiamo soprattutto ai corpi lacerati dei seminatori di dis-cordie, nella nona bolgia, e all’invenzione della testa retta col braccio dalsuo legittimo proprietario, il poeta Bertran de Born (Inf. XXVIII, 129: «levòil braccio alto con tutta la testa / per appressarne le parole sue»).La degradazione della condizione umana (fino alla rabbia impotente efurente del “mangiare il terriccio”e “sputare i sassi”), appare fissata – nelleultime battute del racconto – in quel “mostrare la lingua”: gesto impoten-te e disperato che richiama l’episodio degli usurai: «qui distorse la boccae di fuor trasse / la lingua, come bue che il naso lecchi» (Inf. XVII, 74-75).
Dino Buzzati, Viaggio agli inferni del secolo
Il breve testo di Buzzati (pubblicato nel 1966) potrebbe occupare unposto significativo all’interno del percorso che stiamo costruendo. Il pro-cesso di trasferimento dell’inferno nella dimensione laica della realtà sto-rica è qui piegato fino ad ottenere effetti grotteschi.In questo caso all’inferno è tolta persino la dimensione della tragedia: nonpiù metafora capace di rendere dicibile la disumanità feroce del male nellastoria, l’inferno diventa allora, semplicemente, l’espressione di una quoti-dianità deprivata di ogni senso.Lo scrittore attua una sorta di processo inverso rispetto a quello consta-tato in Malaparte. Non siamo di fronte ad una realtà trasformata in visioneapocalittica: capace quindi di esprimere l’orrore di una tragedia universa-
295Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 295
le. L’eccezionalità grandiosa del male cessa di essere mistero tremendo.Non c’è più il muto stupore dell’uomo posto di fronte all’immobilità di undestino che lo coinvolge come singolo e come parte dell’umanità, queldestino feroce e inflessibile, muto come una sfinge: mistero, appunto, chepuò – grazie alla potenza comunicativa di cui ancora è dotato – dare corpoe voce all’indicibile.L’inferno stesso diventa piccola cosa, fagocitato nell’abisso insulso dei gesti,dei doveri, delle abitudini snaturate di una grande città contemporanea.La storia – Il protagonista, che si chiama “Buzzati” e di mestiere fa il gior-nalista, viene convocato dal direttore del giornale, che gli affida un ghiottoservizio: andare a vedere com’è l’inferno, la cui porta è stata per caso tro-vata da due operai durante gli scavi della metropolitana. Una volta entratonell’aldilà, scopre un mondo esattamente uguale alla Milano (o a una qual-siasi altra città) contemporanea. Il protagonista si stupisce semmai peralcuni usi e costumi particolari.Ad esempio la festa di metà maggio (chia-mata “Entrümpelung”) in occasione della quale si buttano via tutte le cosevecchie, esseri umani compresi. Il protagonista assorbe velocemente com-portamenti e istinti del luogo: guida una veloce auto sportiva assumendoatteggiamenti agressivi nei confronti di chiunque incontri; sulla sua auto sisente «più giovane e più forte». Il racconto si chiude con l’acquisto – daparte di alcuni speculatori edilizi – di un bellissimo giardino che la pro-prietaria, una vecchia aristocratica, aveva sempre rifiutato di vendere.
“Caro Buzzati per caso non vorrebbe farmi una bella inchiesta sui lavoridella metropolitana?”“...politana?” feci eco, sbalordito.Accese una sigaretta dopo averne offerta una.“Nei lavori della metropolitana” disse “avrebbero trovato... un operaio uncerto Torriani... per caso, nel corso degli scavi... dalle parti di Sempione. ...beh, insomma...”Io lo guardavo, io cominciavo a spaventarmi.Chiesi:“ Che cosa dovrei fare?”.Lui proseguì:“Per caso... durante gli scavi sotterranei di Milano... dice di avertrovato... aver trovato per caso...” sembrava esitasse, imbarazzato.“Per caso...” incoraggiandolo.“Trovato per caso” mi fissò terribilmente “... io stesso stento a crederlo...”“Direttore, mi dica...” Non ne potevo piú.“La porta dell’inferno, dice di aver trovato... una specie di porticina”.Si narra che personaggi grossi e fortissimi, di fronte a ciò che massimamen-te avevano desiderato nella vita, quando si presentò tremarono, diventandomacilenti, piccoli e meschini.Eppure io chiesi:“E si può entrare?”“Dicono”.“L’inferno?”“L’inferno.”“Gli inferni?”
296 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 296
“Gli inferni”.Ci fu un silenzio.“E io?”“Non è che una proposta... una semplice proposta... mi rendo contoanch’io...”“Nessun altro è al corrente?”“Nessuno”.“Noi come l’abbiamo saputo?”“Combinazione. La moglie di quel Torriani è figlia di un nostro vecchio spe-ditore”.“Era solo quando ha fatto la scoperta?”“No, c’era un altro”.“E quest’altro ha parlato?”“Sicuramente no”.“Perché?”“Perché l’altro è entrato a curiosare. E non ha fatto piú ritorno”.“E io dovrei...?”“Ripeto, una semplice proposta... In fin dei conti, di queste faccende lei nonè uno specialista?”“Da solo?”“Meglio. Da solo darà meno nell’occhio. Bisogna arrangiarsi. Lasciapassarenon esiste. E il nostro giornale, di là, non ha nessuna conoscenza. Che noi sisappia, almeno”.“Niente Virgilio?”“No”.“Ma quelli là come faranno a capire che io sono un semplice turista?”“Arrangiarsi. Quel Torriani dice... lui ha appena dato una occhiata di là... diceche in apparenza è tutto come qui da noi,e gli uomini sono di carne ed ossa,mica come quelli di Dante.Vestiti come noi. E dice che è una città come lenostre con luce elettrica e automobili dimodoché confondersi mimetizzarsisarà abbastanza facile, ma in compenso difficile sarà farsi riconoscere perforestieri...”“Dico: e allora dovrei farmi arrostire?”“Sciocchezze. Chi parla più di fuoco? Le ripeto: tutto in apparenza è comequi, comprese le case e i bar i cinema i negozi. Proprio il caso di dire che ildiavolo non è poi cosí...”“E... e il compagno di quel Torriani allora perché non è tornato?”“Chissà... potrebbe essersi smarrito... potrebbe non aver più trovato il pas-saggio per rientrare... potrebbe anche averci trovato gusto...”“Poi un’altra cosa:perché proprio a Milano e in tutto il resto dei mondo no?”“Non è vero. Pare anzi che ce ne siano parecchie di queste porticine, parec-chie in ogni città, solo che nessuno le conosce... o nessuno ne parla...Comun-que lei ammetterà che giornalisticamente sarebbe un colpo formidabile”.“Giornalisticamente... Ma chi ci crederà? Bisognerebbe documentarsi. Porta-re almeno delle fotografie...”Annaspavo. Mi rendevo conto che la famosa porta stava aprendosi. Nonpotevo decentemente rifiutare, sarebbe stata una diserzione ignobile. Ma, mifaceva paura!“Senta, Buzzati, non anticipiamo le cose. Neanch’io sono poi del tutto per-
297Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 297
suaso. Ci sono parecchi punti oscuri, a parte l’inverosimiglianza complessi-va... Perché non va a parlare con quel Torriani?”Mi porse un foglio. C’era l’indirizzo.(D. Buzzati, Il colombre e altri cinquanta racconti, Milano, Mondadori,1966, pp. 388-91)
Proposte di lavoro
I meccanismi di “riduzione”Dietro il viaggio agli inferi che si prospetta c’è naturalmente l’archetipodantesco (qui esplicitamente richiamato con il riferimento all’assente Vir-gilio); ma altre, e più interessanti, sono le concrete possibilità di lavoro cuila pagina si presta.Si potrebbe ad esempio mettere in risalto il sistematico processo di “ridu-zione” della realtà rappresentata, analizzando alcune soluzioni di scritturautilizzate dall’autore.Vediamo alcuni casi:– diminutivi. Non si tratta solo di diminutivi veri e propri («porticina»), maanche di termini che sottraggono ogni possibile grandezza all’ipotesi delviaggio: l’operaio che non ha fatto ritorno è entrato «a curiosare»;Torrianiha «dato un’occhiata di là». Il linguaggio ricorre a termini che sembranovoler escludere ogni eroicizzazione linguistica dell’esperienza, per trasfe-rirla nella dimensione del chiacchiericcio quotidiano, con la forza omolo-gante e banalizzante delle espressioni di cui è intessuto.– Il processo di deroizzazione è ottenuto anche attraverso il richiamo all’e-sperienza di un quotidiano burocratico-aziendale, che evoca la dimensio-ne parcellizzata e anonima del lavoro nelle società industruali avanzate.Nel brano che abbiamo proposto compare la figura di uno «speditore»dipendente del giornale;nel capitolo successivo sarà il «perito industriale»Torriani, l’«ingegner Roberto Vicedomini» ecc.– Il processo di “riduzione” dell’esperienza trova espressione – su di unpiano intertestuale – nel confronto con l’archetipo narrativo dantesco. Ilviaggio nell’aldilà generava in Dante dubbi dolorosi («io non Enea nonPaulo sono»). Né poteva essere altrimenti, prospettandosi un’esperienzatotale e assoluta: un viaggio cioè nel profondo della propria coscienza diuomo e di credente, lungo un percorso di crescita morale e religiosa cheporterà quasi a identificare Dante con l’umanità intera.Alla grandezza delviaggio dantesco fanno riscontro dubbi legati alla banale gestione di unviaggio («bisogna arrangiarsi»; «lasciapassare non esiste»). È significativoche Buzzati si senta (e auspichi anzi tale ruolo) soltanto «un semplice turi-sta» (versione banalizzata e consumistica del viaggiatore, ridotto a fretto-loso “consumatore” di chilometri, monumenti, pacchetti tutto-compreso).– Destino/casualità. Se il viaggio dantesco deriva da un preciso disegno deldestino,che lo colloca (non diversamente dai viaggi precedenti di Enea e diPaolo) in un compiuto progetto teleologico, il viaggio di Buzzati è domina-
298 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 298
to dalla casualità («per caso...durante gli scavi sotterranei di Milano...dice diaver trovato... aver trovato...per caso»; si è avuta notizia della cosa per «com-binazione»).Anche questo particolare va iscritto nei processi di “riduzione”dell’eroico del viaggio ultraterreno alla dimensione banale del quotidiano.
Un mondo come il nostroIl sistematico meccanismo di riduzione dell’esperienza eroica del viaggioultraterreno risponde a una ragione strutturale essenziale: tra mondo con-temporaneo e mondo infernale l’omologazione è pressocché totale. Nonintervengono neppure meccanismi metaforici di identificazione tra le duerealtà, che – semplicemente – coincidono.Il motivo ricorre nella conclusione del racconto (pp. 450-51):
... a me stesso che ci sono stato, non è ben chiaro se l’Inferno sia proprio dilà, o se non sia invece ripartito fra l’altro mondo e il nostro. Considerandociò che ho potuto udire e vedere,mi domando anzi se per caso l’Inferno nonsia tutto di qui, e io mi ci trovi ancora, e che non sia solamente punizione,che non sia castigo, ma semplicemente il nostro misterioso destino.
Ma è presente già in uno dei primi capitoli, segnalato dalla perfetta coin-cidenza fisica e visiva tra Inferno e mondo metropolitano contemporaneo(pp. 404-405):
Guardai intorno.Esattamente la stessa scena descritta dal Torriani: in cui nonc’era niente, a prima vista, di infernale e diabolico.Tutto anzi assomigliavaalle nostre esperienze quotidiane, più ancora: non c’era nessuna differenza.Il cielo era il cielo grigio e bituminoso, che conosciamo fin troppo bene,fatto di fumo e di caligini, e di là dal funesto strato si sarebbe detto non cifosse il sole bensì una lampada smisurata, una squallida lampada come lenostre, un gigantesco tubo al neon, tanto le facce degli uomini risultavanolivide e stanche.Anche le case erano come le nostre, ne vedevo di vecchie e di modernissi-me, dai sette ai quindici piani in media, né belle né brutte, come le nostremolto abitate, con quasi tutte le finestre accese, dietro le quali si scorgevanouomini e donne seduti al lavoro.Rassicurante il fatto che le insegne dei negozi e i manifesti pubblicitari eranoscritti in italiano e riguardavano gli stessi prodotti che giornalmente prati-chiamo.La strada pure non aveva nulla di straordinario. Solo era interamente stipatadi automobili ferme, come appunto aveva descritto il Torriani.Le automobili non erano ferme perché desiderassero restare ferme o perordine di un semaforo.Esisteva un semaforo infatti a una quarantina di metri,e stava dando luce verde. Le macchine erano semplicemnete intasate per ungigantesco ingorgo che può darsi si propagasse all’intero corpo della città,non potevano andare né avanti né indietro.Nell’interno delle automobili ferme stavano le persone, per lo più uominisoli.Anch’essi, non sembravano ombre bensì individui in carne ed ossa. Conle mani sul volante, immobili, sulle facce pallide una ottusa atonia come per
299Carlo Varotti
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 299
effetto di stupefacenti. Essi non potevano uscire neppure se avessero volu-to, tanto le macchine erano serrate le une sulle altre. Guardavano fuori, attra-verso i finestrini, guardavano lentamente, con espressione di, anzi senza nes-suna espressione. Ogni tanto qualcuno toccava il clacson, emetteva un fle-bile colpetto, senza fiducia, così, neghittosamente. Pallidi, svuotati, castigati evinti. E più nessuna speranza.
L’identità («non c’era nessuna differenza») tra Inferno e quotidiano con-temporaneo è affermata con insistenza dal sistematico ricorso alla simili-tudine:“come le nostre” è formula che ricorre tre volte nel giro di pocherighe.Trattandosi di un mondo non “altro”, non diverso, rispetto a quello dell’e-sperienza quotidiana, il viaggiatore-Buzzati ricorre insistentemente al“noi”. La deroicizzazione dell’esperienza “infernale” che, abbiamo visto, ècaratteristica del viaggio da lui compiuto, comporta anche l’assenza del-l’eroe-individuo, protagonista di un’avventura conoscitiva la cui eccezio-nalità comporterebbe la solitudine dell’eroe.Al viaggiatore dell’incredibile che deve continuamente fare appello allafiducia del lettore (“preparati ad ascoltare cosa inaudite”;“sembra incredi-bile eppure è esattamente ciò che ho visto...”), proponendo un’esperien-za che è rottura e alterità rispetto all’esperienza del lettore, Buzzati sosti-tuisce un viaggiatore che coincide con l’insieme dei suoi lettori: sta rivi-vendo le stesse esperienze; sta vedendo lo stesso sole, è immobilizzatonello stesso ingorgo in cui si trovano i suoi lettori.
Una possibile lavoro sull’intero raccontoNatura/artificio – Nelle poche battute dell’ultimo brano citato troviamouna contrapposizione tra elementi della natura ed elementi artificiali,caratteristici del mondo “infernale”. Il sole sembra «una lampada smisura-ta», un «tubo al neon».Si potrebbe proporre una lettura integrale del racconto di Buzzati, e indi-viduare come il tema della contrapposizione natura/artificio sia in essopresente, lavorando su due piani:a) come esso si leghi a fattori strutturali del racconto.Si consideri ad esem-pio come l’ultimo capitolo racconta la sofferta vendita di un giardino daparte di un’anziana aristocratica.b) La verifica sul piano lessicale (e nel ricorso a locuzioni, a immagini,similitudini ecc.) della presenza della contrapposizone tra naturale e arti-ficiale come rapportabili a una contrapposizione di fondo tra “naturale”(positivo) e “artificiale” (negativo).
Per la consultazione dei link correlati: http://www.griseldaonline.it/for-mazione/corso_1.htm.
300 Percorsi didattici
008 Percorsi didattici 2-11-2007 14:59 Pagina 300
Indice generale di Griseldaonline 2002 – 2007a cura di Donatella Allegro
Numero I – InferniMarzo – Ottobre 2002
Gian Mario Anselmi,Editoriale, http://www.griseldaonline.it/archivio/edi-toriale_1.htm
Elisabetta Menetti, Griselda, o l’enigma di Giovanni Boccaccio,http://www.griseldaonline.it/archivio/Chi_Griselda.htm
I Percorsi di Griselda
Roberto Mussapi, Inferni, mari, isole, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/archivio/mussapi.htm
Emilio Pasquini, L’Inferno di Dante Alighieri. Intervista di ElisabettaMenetti, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/pasquini.htm
Simone Rambaldi, Le rappresentazioni dell’Oltretomba nella pitturaromana antica, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/rambal-di.htm
Edoardo Sanguineti, La terra è un inferno globalizzato. Intervista di Ric-cardo Bonavita, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/sanguine-ti_prima.htm
Microscopie
Riccardo Bonavita, Morte, materia, riso: l’inferno secondo Leopardi,http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/bonavita.htm
Piero Camporesi, Le «fetide fogne», http://www.griseldaonline.it/percor-si/archivio/Inferno_PieroCampo.htm
Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 301
Elide Casali, Opere di Piero Camporesi, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/archivio/scheda_opere_camporesi.htm
Ippolita Checcoli, Gli illustratori italiani tra naturalismo e simbolismo.L’edizione Alinari della Commedia,http://www.griseldaonline.it/percor-si/archivio/checcoli.htm
Ivano Dionigi,L’inferno è qui.Un esempio di lettura lucreziana (rer. nat.3, 978-1023), http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/dionigi.htm
Lorenza Miretti, Viaggio agli Ipogei. Un futurista all’inferno,http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/miretti.htm
Alberto Natale, Percorsi infernali in Piero Camporesi, http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/archivio/Natale_Inferni_Camporesi.htm
Alberto Natale, Una nota sul metodo di ricerca di Piero Camporesi,http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/Natale_nota.htm
Camillo Neri, L’inferno, fuor di metafora. Seneca e gli altri: le Frontiereinfernali della poesia di José Bergamín, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/archivio/neri.htm
Luigi Weber,Risvegliarsi nell’inferno della Storia.Purgatorio de L’Infernodi Edoardo Sanguineti, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archi-vio/weber.htm
Formazione e didattica
Nicola Bonazzi, Un altro inferno: l’epopea di Gilgamesh, http://www.gri-seldaonline.it/formazione/epopea_gilgamesh.htm
Carlo Varotti, Un percorso didattico: inferni e mondo contemporaneo,http://www.griseldaonline.it/formazione/corso_1.htm
I percorsi iconografici
Ippolita Checcoli,Le immagini di Gerione,http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/checcoli_gerione.htm
Ippolita Checcoli, Le illustrazioni della Commedia Alinari, http://www.griseldaonline.it/foto/pages/ScanImage01_jpg.htm
Ippolita Checcoli,Le immagini per Edoardo Sanguineti, http://www.gri-seldaonline.it/foto/pages/ScanImage01_jpg.htm
Ippolita Checcoli, Le mappe dell’inferno, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/checcoli_mappe.htm
Roberto Mussapi, Inferni, mari, isole, http://www.griseldaonline.it/foto/mussapi/mussapi1_tuffatore.htm
Simone Rambaldi, Le rappresentazioni dell’oltretomba nell’anticaRoma, http://www.griseldaonline.it/foto/rambaldi/foto_Ramb1.htm
302 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 302
Le letture
Alberto Bertoni, Inferni quotidiani. Con una scelta di poesie da Letterestagionali, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/bertoni_scac-chi.htm
Gianni Celati, Come fanno. Una riflessione poetica inedita, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/celati.htm
Gianni D’Elia, L’itagliana commedia, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/archivio/delia.htm
Francesco Guccini, Gli inferni metropolitani. Intervista di Nicola Bonaz-zi, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/bonazzi_guccini.htm
Salvatore Jemma, La scelta dell’inferno, la sua ripetizione. Con una scel-ta di poesie da Decisioni – Plenilunio di novembre, 28-36, http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/jemma.htm
Massimo Vaggi (traduzione di), La favola del ciabattino (in italiano),h t tp : / /www.gr i se ldaon l ine . i t /percor s i / a rch iv io /va gg i .h tmMassimo Vaggi (traduzione di), La fola dal zavateñ (dialetto bolognese),http://www.griseldaonline.it/percorsi/archivio/zavaten.htm
Numero II – L’altroNovembre 2002 – Ottobre 2003
Gian Mario Anselmi, Editoriale. Perché l’altro?, http://www.griseldaonli-ne.it/editoriale_2.htm
Chi è l’Altro? L’arcipelago delle identità
Matilde Callari Galli, Lo sguardo dell’antropologo, http://www.grisel-daonline.it/callari_galli.htm
Remo Ceserani, Letteratura e alterità, http://www.griseldaonline.it/cese-rani.htm
Carlo Galli, L’Altro in prospettiva politica, http://www.griseldaonline.it/galli_carlo.htm
I percorsi di Griselda
Gian Mario Anselmi, Il tedesco degli ‘altri’ al tramonto delle identità occi-dentali. Una lingua transnazionale, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/anselmi.htm
Alessandro Guetta, La letteratura israeliana tra Oriente e Occidente,http://www.griseldaonline.it/percorsi/guetta.htm
303Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 303
Guido Guglielmi, La ‘critica della critica’, http://www.griseldaonline.it/percorsi/Guglielmi_critica_della_critica.htm
Guido Guglielmi, Verità e finzione romanzesca, http://www.griseldaonli-ne.it/percorsi/Guglielmi_romanzo.htm
Roy Menarini, Gli Alieni e il cinema: ossessioni americane,http://www.griseldaonline.it/percorsi/menarini_roy.htm
Edoardo Sanguineti, «Io è un altro», uno slogan per la lotta al narcisi-smo. Intervista di Riccardo Bonavita, http://www.griseldaonline.it/percor-si/sanguineti_seconda.htm
Federica Visani, La figura dell’Altro nelle commedie musicali di GrigorijAleksandrov Vrag ne dremlet!, http://www.griseldaonline.it/percorsi/visani.htm
Microscopie
Guelfo Ascanelli, Don Chisciotte e l’insostenibile invadenza di AlonsoQuijano. Ovvero l’umoristica comprensione dell’altro dentro di sé,http://www.griseldaonline.it/percorsi/ascanelli.htm
Nicola Bonazzi, Ebreo dopo. Angelo Fortunato Formiggini tra utopia edisinganno, http://www.griseldaonline.it/percorsi/ bonazzi_formiggi-ni.htm
Federico Condello, Messinscene dell’altro nel simposio greco arcaico,http://www.griseldaonline.it/percorsi/condello.htm
Susanna Ghazvinizadeh, «Un vero inglese dalla testa ai piedi, o quasi»:l’‘Altro ibrido’ nell’Inghilterra di Hanif Kureishi, http://www.griseldaon-line.it/percorsi/Ghazvinizadeh.htm
Franco La Polla, A tale of two cities. La città di Batman, http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/lapolla.htm
Elisabetta Menetti, Meraviglioso, mirabile, strano: l’altro nelle novelle diMatteo Bandello, http://www.griseldaonline.it/percorsi/menetti_bandel-lo.htm
Alberto Natale, Il Cuore dell’Alterità. Percorsi paralleli in Jack London eJoseph Conrad, http://www.griseldaonline.it/percorsi/natale1.htm
Andrea Neri, Tiziano Sclavi: un profilo bio-bibliografico, http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/sclavi_neri_biografia.htm
Andrea Neri, Tutto quello che la letteratura considera ‘altro’ ma non hamai osato leggere. Tiziano Sclavi fra narrativa e fumetto,http://www.griseldaonline.it/percorsi/neri.htm
Neil Novello, L’alterità come replica dell’identità. La Divina Mimesis diPier Paolo Pasolini, http://www.griseldaonline.it/percorsi/Novello.htm
304 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 304
Piero Pieri, Il codice di Perelà di Palazzeschi. L’altro del fumo, l’oltre del-l’uomo, http://www.griseldaonline.it/percorsi/pieri.htm
Simone Rambaldi, Alterità etinica e conquista: lo straniero nell’arteromana, http://www.griseldaonline.it/percorsi/rambaldi_secondo.htm
Francesca Ricci,L’altro in poesia:appunti su Mario Luzi,http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/ricci_luzi.htm
Federica Zullo, L’Impero e l’Altro. Contaminazioni e paranoia in alcuniracconti di Rudyard Kipling, http://www.griseldaonline.it/percorsi/zullo.htm
I percorsi iconografici
Rita Boschi, Mercanti, viaggiatori e stranieri. Un percorso iconograficoattraverso il Decameron, http://www.griseldaonline.it/formazione/boschi.htm
Federico Condello,Messinscene dell’altro nel simposio greco arcaico – Ilpercorso iconografico, http://www.griseldaonline.it/foto/condello/con-dello_ill1.htm
Simone Rambaldi,Alterità e conquista: lo straniero nell’arte romana – Ilpercorso iconografico, http://www.griseldaonline.it/foto/Rambaldi_2/rambaldi_album_1.htm
Formazione e didattica
Silvia Battaglia, Gli specchi deformanti: creare per rovinare, rovinare percreare, http://www.griseldaonline.it/formazione/battaglia.htm
Alberto Bertoni, Appunti per un corso di scrittura poetica,http://www.griseldaonline.it/formazione/bertoni.htm
Rita Boschi, Mercanti, viaggiatori e stranieri. Un percorso iconograficoattraverso il Decameron, http://www.griseldaonline.it/formazione/boschi.htm
Maria Raffaella Cornacchia, La prospettiva dei vinti sull’‘imperialismo’romano, http://www.griseldaonline.it/formazione/cornacchia_ivintiaro-ma.htm
Maria Raffaella Cornacchia, L’Altro al di sotto del 35° parallelo. Unromanzo inedito in Italia: Le Cercle des Tropiques di Alioum Fantouré,http://www.griseldaonline.it/formazione/cornacchia_fantoure.htm
Marta Guerra, François Hartog, Memoria di Ulisse, http://www.grisel-daonline.it/formazione/guerra.htm
Ugo M. Olivieri, I sommersi e i salvati. Appunti su canone e memoria,http://www.griseldaonline.it/formazione/olivieri.htm
305Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 305
Lorella Spinello, Della fuga e dei vagabondaggi, http://www.griseldaon-line.it/formazione/spinelli.htm
Carlo Varotti, Medea/Medee, http://www.griseldaonline.it/formazione/medea_index.htm
Carlo Varotti, Un percorso didattico sul tema dell’altro. Decameron: lanovella di Melchisedec e delle tre «anella», http://www.griseldaonline.it/formazione/varotti.htm
Le letture
Silvia Albertazzi, Wonderwall (Don’t Cry For Me, Argentina),http://www.griseldaonline.it/percorsi/albertazzi.htm
Horea Garbea, Funghi al pomodoro. Traduzione italiana di GabrielaLungu, http://www.griseldaonline.it/percorsi/garbea.htm
Francesco Guccini, Casina di Plauto, http://www.griseldaonline.it/Casi-naAttoPrimo.pdf
Dan Lungu, Il viaggio. Traduzione italiana di Gabriela Lungu,http://www.griseldaonline.it/percorsi/Lungu.htm
Luiz Nazario, Le piazze della pazzia. Traduzione italiana di José Pessoa,http://www.griseldaonline.it/percorsi/nazario.htm
Tiziano Sclavi, L’altro sono io. Intervista di Andrea Neri, http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/sclavi_neri.htm
Raffaella Zuccari, Una commedia per Pàvana, http://www.griseldaonli-ne.it/zuccari_casina.pdf
Numero III – Il corpoNovembre 2003 – Ottobre 2004
Gian Mario Anselmi, Editoriale. Il corpo, http://www.griseldaonline.it/edi-toriale.htm
Vita Fortunati, Descrizioni e concettualizzazioni del corpo,http://www.griseldaonline.it/3fortunati_franceschi.html
Valerio Magrelli, Il corpo difettoso. Intervista di Nicola Bonazzi,http://www.griseldaonline.it/3magrelli.htm
I percorsi di Griselda
Soro Bakary, Le drame rituel africain, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/3bakary.htm
306 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 306
Marco A. Bazzocchi, Il corpo parla, http://www.griseldaonline.it/percor-si/3bazzocchi.htm
Federico Condello, Corpus loquens.Marchi, ferite e tatuaggi (e altri pro-memoria) in Grecia antica, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3con-dello.htm
Claudio Franzoni, Corpo e immagini. L’apparente ambiguità del gesto,http://www.griseldaonline.it/percorsi/3franzoni.htm
Fabio Giunta, Ammalato? Ammaliato! Il corpo incantato di TorquatoTasso, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3giunta.html
Nicola Zuccherini, Fisico da narratore. Il corpo nel teatro degli ‘attoriche raccontano’, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3zuccherini.html
Lucia Pasetti, Un corpo per due. Il doppio e la grammatica dell’assurdo,http://www.griseldaonline.it/percorsi/3pasetti.htm
Federica G.Pedriali,L’Olona e il Lambro delle genti. Sulla decidibilità delcorpo in Gadda, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3pedriali.htm
Simone Rambaldi, La rappresentazione del corpo nel mondo romano.Opera d’arte ed elemento della vita quotidiana, http://www.griseldaon-line.it/percorsi/3rambaldi.htm
Microscopie
Gianni Celati, Angelica che fugge. Una lettura dell’Orlando Furioso,http://www.griseldaonline.it/percorsi/3celati.htm
Valentina Fenga, Crash: il corpo come intersezione fra scrittura e imma-gini, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3fenga.html
Jane Freeman, Performing the Bodies of King Lear, http://www.grisel-daonline.it/percorsi/3freeman.htm
Lucia Rodler, Le funzioni della fisiognomica da Della Porta a Lombro-so, http://www.griseldaonline.it/percorsi/3rodler.htm
I percorsi iconografici
Ippolita Checcoli, Il corpo e le sue immagini, http://www.griseldaonli-ne.it/percorsi/3checcoli.htm
Formazione e didattica
Nicola Barilli, Per una traiettoria storica del corpo umano: dal corpo‘ideale’ di Winckelmann al ‘corpo istintuale’ in Wedekind,http://www.griseldaonline.it/formazione/03barilli.htm
Maria Raffaella Cornacchia, Guido da Verona: «romanzatura da coltre e
307Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 307
da confronto intimo». Paraletteratura e intertestualità, http://www.gri-seldaonline.it/formazione/3varotti.htm
Mara Ferroni, Medusa e le altre. Lo sguardo della donna e l’occhio delpoeta tra mito e letteratura, http://www.griseldaonline.it/formazio-ne/3ferroni.html
Roberto Fiorini, I corpi e le cose: sensualità barocca ed estasi mistica,http://www.griseldaonline.it/formazione/03fiorini.htm
Elisa Golinelli, Il corpo e le sue mille forme nel «fantastico mondo» diGiuseppe Pederiali, http://www.griseldaonline.it/formazione/3golinel-li.htm
Ezio Raimondi, L’esperienza letteraria: un dialogo delle culture,http://www.griseldaonline.it/formazione/3raimondi.htm
Le letture
Adrian Popescu, S italica. Presentazione critica e traduzione di GabriellaLungu,
http://www.griseldaonline.it/percorsi/3popescu.htm
Luiz Nazario, Quanto costa? Traduzione italiana di José Pessoa,http://www.griseldaonline.it/percorsi/3nazario.htm
Numero IV – Il nemicoNovembre 2004 – Ottobre 2005
I percorsi di Griselda
Federico Condello, I nomi del nemico: appunti sul lessico classico,http://www.griseldaonline.it/percorsi/4condello.htm
Maria Raffaella Cornacchia, L’impossibile perdono del nemico nella lette-ratura classica. La pietà, la riconciliazione e l’ira in Achille, Odisseo edEnea, http://www.griseldaonline.it/percorsi/4cornacchia.htm
Claudio Franzoni, Strascinare i nemici. Rileggendo Fortini,http://www.griseldaonline.it/percorsi/franzoni_2.htm
Carlo Galli, Sulla guerra e sul nemico, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/4galli.htm
Fabio Giunta, L’«empio Ismen» nemico dei crociati, http://www.grisel-daonline.it/percorsi/ismeno.htm
Andrea Lorenzini, Biobibliografia di Tony Harrison, http://www.grisel-daonline.it/percorsi/Lorenzini_2_biobiblio.htm
308 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 308
Andrea Lorenzini, Si finisce sempre per assomigliare al nemico,http://www.griseldaonline.it/percorsi/Lorenzini_2.htm
Simone Rambaldi, Orrori antichi e contemporanei: Cresila e i ‘nemici’,http://www.griseldaonline.it/percorsi/4rambaldi.htm
Mario Rigoni Stern, Nemico: una parola assente. Intervista di ElisabettaMenetti, http://www.griseldaonline.it/percorsi/menetti_int_rigoni-stern.htm
Maurizio Tarantino, Il ‘nemico di classe’: concetto politico o metafora let-teraria? http://www.griseldaonline.it/percorsi/tarantino.htm
Alessandro Vanoli, La riconquista e l’invenzione dei Mori, http://www.griseldaonline.it/percorsi/4vanoli.htm
Paola Vecchi Galli, Inimicizie letterarie: Dante, Petrarca, http://www.gri-seldaonline.it/percorsi/4vecchi_galli.htm
I percorsi iconografici
Donatella Allegro – Andrea Severi, Il nemico e le sue immagini,http://www.griseldaonline.it/percorsi/4allegro.htm
Claudio Franzoni,Strascinare i nemici.Rileggendo Fortini – Il percorso ico-nografico http://www.griseldaonline.it/percorsi/franzoni_2_img1.htm
Paola Vecchi Galli, Inimicizie letterarie: Dante, Petrarca – Il percorso ico-nografico, http://www.griseldaonline.it/percorsi/4vecchi_galli_img1.htm
Formazione e didattica
Claudia Acquaviva,La Shoah e la memoria,http://www.griseldaonline.it/formazione/04acquaviva.htm
Maria Raffaella Cornacchia, Tra funzione mediatica e verità.Un esempiodi lettura dei quotidiani, http://www.griseldaonline.it/formazio-ne/04cornacchia.htm
Rossella D’Alfonso, Lo straniero che è in noi: L’asino d’oro di Apuleio,http://www.griseldaonline.it/formazione/04dalfonso.htm
Marta Guerra, Il sangue e il nemico: rappresentazioni del conflitto nelCinquecento, http://www.griseldaonline.it/formazione/02guerra.htm
Marzia Pessolano, Nemico e/è straniero. Proposte didattiche per un per-corso letterario, http://www.griseldaonline.it/formazione/04pessola-no.htm
309Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 309
Numero V – Ai giovaniNovembre 2005 – Ottobre 2006
I percorsi di Griselda
Donatella Allegro, Ai margini del potere. La gioventù nella poesia troba-dorica, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5allegro2.htm
Gian Mario Anselmi, Machiavelli e la forza della giovinezza,http://www.griseldaonline.it/percorsi/5anselmi.htm
Federico Condello,Giovinezza, morte e contrappasso:per l’analisi di untopos greco, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5condello.htm
Nuno Júdice, I giovani portoghesi e la poesia. Intervista di VincenzoRusso, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5russo.htm
Nuno Júdice, La parola in movimento. Un dialogo con Stefano Salmi,http://www.griseldaonline.it/percorsi/5russo_link_a.htm
Matteo Martelli, I giovani e la scienza antica: tra rigore numerologico ecalore naturale, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5martelli.htm
Ivan Rivalta, «Addio giovinezza!». Analisi di un topos crepuscolare,http://www.griseldaonline.it/percorsi/5rivalta.htm
Vincenzo Russo, Il poeta collezionista. Breve introduzione a Nuno Júdi-ce, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5russo_collez.htm
Andrea Severi, Ferdydurke di Witold Gombrowicz: l’umanità tra il mitodella giovinezza e l’incubo della maturità, http://www.griselda-online.it/percorsi/5severi.htm
Riccardo Stracuzzi, Considerazioni sulla ‘giovinezza’ in Montale: il casodi Esterina, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5stracuzzi.htm
I percorsi iconografici
Donatella Allegro – Andrea Severi, Ai giovani – Il percorso iconografico,http://www.griseldaonline.it/percorsi/5allegro.htm
Formazione e didattica
Maria Vittoria Sala, I giovani del Ponte della Ghisolfa di Giovanni Testorie Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti: un confronto,http://www.griseldaonline.it/percorsi/5sala.htm
Alberto Sebastiani, Il ‘benessere’ per i giovani ‘nongiovani’ di Don Mila-ni, http://www.griseldaonline.it/percorsi/5sebastiani.htm
Carlo Varotti, La ‘scoperta’ del giovane (parte I), http://www.griseldaonli-ne.it/formazione/05varotti.htm
Carlo Varotti, La ‘scoperta’ del giovane (parte II), http://www.griseldaon-
310 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 310
line.it/formazione/05varotti2.htm
Piccola antologia della giovinezza, http://www.griseldaonline.it/percor-si/5antologia.htm
Numero VI – Rifiuti scarti esuberiOttobre 2006 – Ottobre 2007
Editoriale, http://www.griseldaonline.it/6_editoriale.htm
I percorsi di Griselda
Paolo Albani, Delle correzioni che non finiscono mai e di alcune biz-zarre riscritture, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6albani.htm
Fernanda Alfieri, Il corpo del rifiuto tra eresia e ortodossia, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6alfieri.htm
Marc Augé, «Contemporaneità impossibile» e «iniziazione negativa».Intervista di Donatella Allegro e Federico Condello (parte I),http://www.griseldaonline.it/percorsi/auge.htm
Marc Augé, Bricolage, riciclaggio e riproduzione sociale. Intervista diDonatella Allegro e Federico Condello (parte II), http://www.griseldaonli-ne.it/percorsi/auge2.htm
Nicola Bonazzi, Parodia e scatologia: quando la letteratura prende ingiro se stessa, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6bonazzi.htm
Gianrico Carofiglio, Le crepe sul muro della coscienza. Intervista di Elisa-betta Menetti, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6carofiglio.htm
Ermanno Cavazzoni, Il grande limbo delle fantasticazioni,http://www.griseldaonline.it/percorsi/6cavazzoni.htm
Gianni Celati, La Piazza Universale delle parole secondo Tomaso Garzo-ni, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6celati3.htm
Gianni Celati, Lo spirito della novella, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6celati.htm
Javier Cercas, I ritagli della storia e la memoria dei romanzi. Intervistadi Elisabetta Menetti.Traduzione di Simona Mambrini, http://www.grisel-daonline.it/percorsi/6cercas_it.htm
Francesco Citti – Lucia Pasetti, Un rifiuto della storia: Eliogabalo, l’im-peratore che morì nella cloaca, http://www.griseldaonline.it/percor-si/6citti.htm
311Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 311
Alessandro Di Muro, Paul Auster e i rifiuti. Un percorso attraverso lametropoli postmoderna, http://www.griseldaonline.it/formazione/06di-muro.htm
Giacomo Manzoli, Cos’è il “trash” & cosa è trash? Intervista di MaristellaBonomo, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6bonomo.htm
Enrico Palandri, Inventare, creare e ricreare: scarti della memoria e riusipoetici. Intervista di Elisabetta Menetti, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6palandri.htm
Francesco Pitassio, Il rifiuto e lo sguardo, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6pitassio.htm
Cinzia Ruozzi, Relazioni d’ufficio: la scrittura marginale di Kafka,http://www.griseldaonline.it/percorsi/6ruozzi.htm
Luigi Weber,Rifiuti e gran rifiuti:di una costante crepuscolare nella poe-sia romagnola del Novecento, http://www.griseldaonline.it/percor-si/6weber.htm
Microscopie
Andrea Severi, La spazzatura gradita a Italo Calvino. Un breve percor-so tra i rifiuti de La poubelle agréée, http://www.griseldaonline.it/per-corsi/6severi.htm
I percorsi iconografici
Donatella Allegro, Arte e rifiuti: una (minima) galleria. Presentazione,http://www.griseldaonline.it/percorsi/6allegro.htm
Donatella Allegro, Galleria iconografica, http://www.griseldaonline.it/percorsi/6allegro_img.htm
Formazione e didattica
Alessandro Di Muro, Tra DeLillo e Paul Auster: una breve ricognizionetra i rifiuti,http://www.griseldaonline.it/formazione/06dimuro_delillo.htm
Magda Indiveri, ‘Di ogni cosa resta un poco’. Letteratura e resto,http://www.griseldaonline.it/formazione/06indiveri.htm
Maria Vittoria Sala, La poesia dell’ultimo Montale fra ‘trionfo della spaz-zatura’ e ritorno al passato, http://www.griseldaonline.it/formazio-ne/06sala.htm
312 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 312
Sezioni trasversali ai numeri:
Poeti e scrittori dialogano con Griselda,
http://www.griseldaonline.it/percorsi/5_poeti.htm
Sezione di Informatica Umanistica. A cura di Francesca Tomasi
Alex Agnesini, Isabella Andorlini, Massimo Magnani, Sara Santoro, AnnaMaria Tammaro – Facoltà di Lettere, Università di Parma, Tecnologie digi-tali e ricomposizione dell’antico: papiri, siti archeologici, biblioteche edarchivi digitali. Seminario di Studi, http://www.griseldaonline.it/informa-tica/6sintesi.htm
Dino Buzzetti, L’Informatica Umanistica come disciplina teorica,http://www.griseldaonline.it/informatica/buzzetti.htm
Elisabetta Camandona – Gabriele Poli, Informatica e papiri. Un progettodigitale all’Istituto papirologico ‘G.Vitelli’, http://www.griseldaonline.it/informatica/3camandona.htm
Simona Casciano, Filologia ed informatica: la nuova tecnologia neglistudi filologici, http://www.griseldaonline.it/informatica/casciano.htm
Fabio Ciotti, L’informatica umanistica in Italia: luci e ombre,http://www.griseldaonline.it/informatica/ciotti.htm
Arianna Ciula, Zoom in, zoom out: la paleografia digitale tra sistemainterdisciplinare e analisi dettagliate, http://www.griseldaonline.it/informatica/6ciula.htm
Luca De Nigro, La Bibliografia dei Trovatori e il Web, http://www.grisel-daonline.it/informatica/3denigro.htm
Edoardo Ferrarini, L’informatica umanistica oggi (con una nota al DM18.3.2005), http://www.griseldaonline.it/informatica/5ferrarini.htm
Domenico Fiormonte, Informatica Umanistica: rappresentanza, statutoteorico e rifondazione, http://www.griseldaonline.it/informatica/fior-monte_risposta.htm
Paolo Mastrandrea, Memorandum per il CUN, http://www.griseldaonli-ne.it/informatica/mastrandrea.htm
Angiolo Menchetti,La tecnologia digitale e l’edizione di testi demotici del-l’antico Egitto, http://www.griseldaonline.it/informatica/3menchetti.htm
Tito Orlandi, Proposta: Informatica applicata alle discipline umanisti-che (ovvero: Infomatica umanistica), http://www.griseldaonline.it/infor-matica/orlandi.htm
Marco Passarotti,La lemmatizzazione.Cos’è, perché si deve fare, come iocredo convenga farla, http://www.griseldaonline.it/informatica/3passa-rotti.htm
313Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 313
Massimo Riva, Introduzione ai lavori: Online Resources for the Huma-nities, Brown University, http://www.griseldaonline.it/informatica/4riva.htm
Gino Roncaglia, Informatica Umanistica: le ragioni di una disciplina,http://www.griseldaonline.it/informatica/roncaglia_secondo.htm
Gino Roncaglia, Una laurea inutile? http://www.griseldaonline.it/infor-matica/roncaglia.htm
Mirko Tavosanis, Recensione a Letterature biblioteche ipertesti.A cura diFederico Pellizzi. Introduzione di Ezio Raimondi, Roma, Carocci, 2005,http://www.griseldaonline.it/informatica/6tavosanis.htm
Francesca Tomasi, All’origine della humanities computer science,http://www.griseldaonline.it/informatica/5tomasi.htm
Francesca Tomasi, L’informatica per le scienze umane: radici e prospetti-ve disciplinari. Un seminario alla Brown University (Providence),http://www.griseldaonline.it/informatica/4tommasi.htm
Francesca Tomasi, Studia humanitatis e nuove tecnologie. La scienza del-l’informazione come presupposto metodologico, http://www.griseldaon-line.it/informatica/3tommasi.htm
Comunicato stampa. Esiste anche un’informatica umanistica? Oltre 130docenti scrivono al Ministro Moratti, http://www.griseldaonline.it/infor-matica/fiormonte.htm
In risposta a Piero Citati. Sull’informatica umanistica, http://www.gri-seldaonline.it/informatica/5citati_risp.htm
Materiali di Informatica Umanistica. A cura di Francesca Tomasi
Manuale di informatica umanistica, http://www.griseldaonline.it/infor-matica/manuale.htm
Bibliografia di informatica umanistica, http://www.griseldaonline.it/informatica/bibliografie.htm
Tutorial di supporto, http://www.griseldaonline.it/informatica/diapositi-ve_intro.htm
Risorse on line per la letteratura italiana, http://www.griseldaonline.it/risorse.htm
314 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 314
Griselda – La Repubblica.it1. Speciale Biblioteche
Claudio Bisoni, L’archivio e la disciplina della memoria sono una que-stione di travelling, http://www.griseldaonline.it/repubblica/bisoni.html
Nicola Bonazzi, I monasteri: scrigni del sapere, http://www.griseldaonli-ne.it/repubblica/bonazzi.html
Andrea Campana, Leopardi e l’uomo di internet, http://www.griseldaon-line.it/repubblica/campana.html
Fabio Ciotti, Il progetto Biblioteca Italiana, http://www.griseldaonline.it/repubblica/ciotti.html
Stefano Colangelo, Animali da biblioteca, http://www.griseldaonline.it/repubblica/colangelo.html
Magda Indiveri, Biblioteche scolastiche, http://www.griseldaonline.it/repubblica/indiveri.html
Gino Roncaglia,Wikipedia: enciclopedia universale o miniera di errori?,http://www.griseldaonline.it/repubblica/roncaglia.html
Andrea Severi, L’officina degli umanisti, http://www.griseldaonline.it/repubblica/severi.html
Francesca Tomasi, Biblioteca ‘elettrica’, http://www.griseldaonline.it/repubblica/tomasi.html
Grazia Verasani, La polvere del sapere in casa Leopardi, http://www.gri-seldaonline.it/repubblica/verasani.html
Banche dati online per la letteratura italiana.A cura della redazione diGriseldaonline, http://www.griseldaonline.it/repubblica/banche_dati.html
2. Speciale Alterità
Nicola Barilli, Lo sguardo dell’altro, ovvero la delegittimazione dell’ov-vio, http://www.griseldaonline.it/repubblica/barilli.html
Nicola Bonazzi, L’uomo di fumo e creature altre, http://www.griseldaon-line.it/repubblica/bonazzi_2.html
Andrea Campana, Leopardi, il pavone, la lumaca e l’altro,http://www.griseldaonline.it/repubblica/campana_2.html
Mimmo Cangiano, La paura dell’altro, http://www.griseldaonline.it/repubblica/cangiano.html
Achille Castaldo, L’estraneità delle parole, http://www.griseldaonline.it/repubblica/castaldo.html
Magda Indiveri, L’altro? Dietro la porta, http://www.griseldaonline.it/repubblica/indiveri_2.html
315Donatella Allegro
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 315
Paolo Noto, Tony e Antonio: il doppio di Sorrentino, http://www.grisel-daonline.it/repubblica/noto.html
Eleonora Pinzuti, Primo Levi, il sé o l’altro, http://www.griseldaonline.it/repubblica/pinzuti.html
Michele Righini, Lo straniero e il poliziesco, http://www.griselda-online.it/repubblica/righini.html
Andrea Severi, Luzi in India: il disgusto, il fascino e la memoria lettera-ria, http://www.griseldaonline.it/repubblica/severi_2.html
316 Appendice
009 Appendice 2-11-2007 15:00 Pagina 316