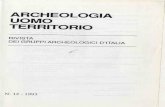Lidar e ricognizioni sul campo: integrazione dati per la ricostruzione della forma urbana di un...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Lidar e ricognizioni sul campo: integrazione dati per la ricostruzione della forma urbana di un...
273
* CNR, IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monu-mentali, Tito Scalo (Potenza); [email protected]
** Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata; [email protected]; [email protected] *** Geocart s.r.l., Potenza; [email protected] **** CNR, IMAA, Istituto di Metodologie di Analisi Am-
bientale, Tito Scalo (Potenza); [email protected]; [email protected]
Nicola MasiNi *, RosaNNa ciRiello
**, isabella MaRchetta **,
aNNibale GuaRiGlia ***, Rossella coluzzi
****, Rosa lasapoNaRa ****
AAerea IV.2010 - V.2011, pp. 273 - 282
On the Reconstruction of the Urban Fabric of the Lost Medieval Village of Monteserico New Results from Aerial Airborne Laser Scanning and Field Survey
Airborne laser scanning (ALS) is an optical measurement technique for obtaining high-precision information about the Earth’s surface including basic terrain mapping (Digital terrain model, bathymetry, corridor mapping), vegetation cover (forest assessment and in-ventory), coastal and urban areas. Recent studies examined the possibility of using ALS in archaeological investigations to depict earthworks, although the ability of ALS measure-ments in this context has not yet been studied in detail.In this paper, the potentiality of ALS in detecting archaeological features is assessed in the hill of Monte Serico (North East of Basilicata) The available archaeological record states a long human activity from the Iron to Middle Ages. The latter period is attested by a castle, a church and several micro-topographic reliefs linked to archaeological traces related to a settlement founded in the early Middle Ages and disappeared around the 15th century.The optical dataset (aerial and satellite imagery from 1994 to 2006) allowed us to dis-cover the medieval site and to reconstruct its urban plan from both the buried and sub-surface remains. However, the detailed identification of the microtopographic reliefs of the medieval village is very difficult due to the intense erosion processes, geomorpho-logical deformations, and the significant presence of chaotic building material.To cope with these drawback we used a Lidar survey which allowed us (i) to obtain a detailed Digital Terrain Model (DTM), (i) to improve the identification of archeologi-cal microtopographic reliefs, (iii) to analyze the geomorphological features and, finally (iv) to better reconstruct and characterize the urban shape.
Introduzione
ALS, acronimo di Airborne Laser Scanning, è una tecnica attiva di telerilevamento che consiste nell’acquisizione ed elaborazione di punti, generati dall’eco di ritorno di im-pulsi laser inviati al suolo da un sensore montato su un aereo o un elicottero. Gli im-pulsi laser sono emessi da una sorgente verso uno specchio, oscillante o ruotante, che riflette l’impulso lungo una direzione ortogonale a quella di avanzamento dell’aeromo-bile. Il raggio laser, dopo aver colpito la superficie, viene nuovamente riflesso verso lo specchio che convoglia il segnale ad un sistema di rilevamento che ne misura il tempo di ritorno. Dal tempo di volo e dall’angolo di emissione si calcola la distanza percorsa dal raggio e quindi la posizione del bersaglio. Il sensore raccoglie anche informazioni sull’intensità di risposta e sul numero di echi prodotti dal singolo impulso inviato, ar-ricchendo il rilievo di informazioni aggiuntive.Grazie all’integrazione del sistema di acquisizione dei dati laser con una piattaforma di navigazione costituita da un sistema GPS di bordo, da stazioni GPS a terra e da un’uni-tà di misura inerziale (IMU), la tecnica lidar consente elevate precisioni nelle misure e quindi nella restituzione di modelli digitali del terreno (DTM) e della superficie (DSM). Per tale ragione il lidar trova una diffusa applicazione per studi di carattere geomorfo-
La ricostruzione della forma urbis del casale medievale abbandonato di Monteserico Nuovi risultati da dati Lidar e ricognizioni sul campo
274 Nicola MasiNi, RosaNNa ciRiello, isabella MaRchetta, aNNibale GuaRiGlia, Rossella coluzzi, Rosa lasapoNaRa
1 Barnes 2003.2 Shell, Roughley 2004; Challis 2006; Corns, Shaw
2008.3 Devereus et al. 2005; Doneus et al. 2008; Crutchley
2008.4 Riguardo ai crop-marks e ad altre tipologie di tracce riferibi-
li a presenze archeologiche sepolte, per quanto riguarda la feno-menologia associata e al metodo di foto lettura e di interpretazio-ne si rimanda a Crawford 1929; Dassie 1978; Wilson 1972; Piccarreta, Ceraudo 2000. Riguardo alla capacità di enfatizza-re marks archeologici su suoli vegetati e non mediante processa-mento di immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione v. Lasaponara, Masini 2007; Masini, Lasaponara 2007.
5 Su tale argomento l’applicazione del lidar per la ricostru-zione della forma urbana di un villaggio abbandonato in età tardomedievale nel sito di Monte Irsi, nei pressi di Irsina (MT) pubblicato da Lasaponara, Masini 2009.
6 Monteserico rientra nel F. 188 - IV SE dell’IGM e forma punto trigonometrico corrispondente a 40° 51’ 15” di latitudi-ne e 3° 42’ di longitudine est dal meridiano di Monte Mario.
7 Quali M. Muscillo (568 m s.l.m.) a ca. 5 km ad O, Ser-ra Castelluccio (516 m s.l.m.) a 4 km a NO, M. della Croce (458 m s.l.m.) e M. Cuculo (445 m s.l.m.) a 4 km a NE,
8 L’intervento, ad opera della dott.ssa Ciriello, direttrice dei Musei Archeologici Nazionali di Melfi e Venosa, rientra delle valutazioni di rischio archeologico in seno alle program-mazioni di archeologia preventiva.
logico e idrogeologico. Inoltre la capacità dei raggi laser di ‘penetrare’ nella vegetazione di aree boscate consente di ottenere modelli digitali del terreno anche in aree densa-mente vegetate che rappresenta il limite oggettivo della Fotogrammetria.Recentemente, da meno di un decennio, il LiDAR è applicato con successo anche in campo archeologico. In particolare, si rilevano applicazione per il rilievo di evidenze archeologiche 1 e per l’individuazione di tracce di micro rilievo relative a strutture se-polte e a trasformazioni culturali del paesaggio, sia su suoli nudi 2 che al di sotto di co-perture boscate 3. L’elevata precisione delle misure consente di analizzare con elevato dettaglio le cosiddette tracce di microrilievo riferibili sia a presenze positive (strutture murarie) che negative (terrapieni riferibili ad antichi fossati) ricoperte da piccoli spes-sori di terreno. A tal riguardo, va detto che specie in presenza di bassa vegetazione (gra-minacee, ecc.), depositi archeologici producono intorno a se modifiche nel contenuto di umidità e di sostanze nutritive nel terreno. Tali modifiche generano i cosiddetti crop-marks, ovvero tracce di accrescimento differenziale delle piante, generalmente visibili con le tradizionali foto aeree e le immagini multi/iperspettrali aeree e satellitari 4. Purtroppo specie in ecosistemi mediterranei, il periodo più favorevole per i crop-marks dura da quindici giorni ad un mese e mezzo, a secondo del tipo di terreno e del clima. Su suoli nudi, la possibilità che le variazioni di umidità e di humus siano visibili ad un’osservazione remota dipende molto dalle condizioni climatiche. La situazione più favorevole è quella di acquisire l’immagine su un suolo irraggiato dal sole dopo una giornata di pioggia.Un altro indicatore di presenze archeologiche sepolte (positive o negative) è l’ombra che i ‘microrilievi’ archeologici generano sul suolo in presenza di luce solare bassa. A tal ri-guardo, va detto che anche l’ombra ha i suoi limiti (!): se da una parte rivela dislivelli di natura antropica, dall’altra può coprire strutture affioranti di interesse archeologico. Inoltre, in quei siti posti su rilievi collinari l’erosione prodotta dal dilavamento delle ac-que meteoriche tende ad ‘appiattire’ i microrilievi, riducendone la loro visibilità attra-verso le ombre. In tali situazioni il lidar può rappresentare una fonte complementare di informazioni 5 a quelle ricavate dal dataset ottico per l’individuazione di tracce archeo-logiche di microrilievo come è stato fatto per lo studio di Monteserico, casale sito nel NE della Basilicata, attestato dall’XI sec. e abbandonato nel XV sec. (fig. 1). L’articolo mostra i primi risultati dell’integrazione tra dati ottici, rilievo lidar e ricogni-zioni sul campo al fine di ottenere una mappa delle features archeologiche che consen-ta di ricostruire il disegno urbano del casale e fornire indicazioni utili per un eventuale progetto di valorizzazione del sito.
Il caso di studio. Monteserico: quadro territoriale e dati storico - archeologici
Monteserico 6 è un rilievo collinare (fig. 1, 3) di altitudine massima 590 m s.l.m. la cui formazione geologica è il frutto di una sequenza stratigrafica costituita da Argille Su-bappenniniche, Sabbie di Monte Marano e Conglomerati di Irsina. Il colle domina un vasto territorio costituito da valli, falsopiani e basse colline 7 solcati da torrenti e fossati le cui acque confluiscono nei fiumi Bradano e Basentello, da cui dista in linea d’aria ri-spettivamente 10 km in direzione SO e 4 km in direzione E.Favorevole all’insediamento umano per la ricchezza d’acqua, la fertilità dei terreni e l’ab-bondante copertura boschiva, la porzione di territorio che interessa Monteserico ha mo-strato un’intensa sequenza di popolamento. La sua posizione a cerniera tra Puglia e Basi-licata, lungo le direttrici viarie e fluviali principali della regione e la sua naturale difendi-bilità, ha reso questi luoghi particolarmente idonei all’insediamento umano sin dall’età del Bronzo. La raccolta di superficie, finalizzata all’imposizione di un vincolo di tutela, ha consentito di individuare una significativa continuità d’uso dell’intero circondario della collina ancora oggi occupata dal castello normanno-svevo e dal suo villaggio (fig. 2) 8. Il territorio mostra, infatti, le prime fasi di frequentazione a partire dall’età del Bronzo con soluzione di continuità fino alla prima romanizzazione, tuttavia solo una ricognizione siste-matica dell’area potrebbe determinare la dinamica del popolamento letta nella diacronia.
1 - Inquadramento territoriale: immagine pancromatica satellitare QuickBird acquisita il 4-07-2004.
275La ricostruzione della forma urbis del casale medievale abbandonato di Monteserico. Nuovi risultati da dati Lidar e ricognizioni sul campo
Attualmente, in riferimento a una recente raccolta di dati di superficie 9, sembra pos-sibile individuare una consistente presenza di siti dell’età del Bronzo alle pendici nord-orientali e nord-occidentali della collina del castello, con continuità d’uso fino alla fase ellenistica. Il dato è supportato anche dalla campagna di scavo realizzata, tra 2003-2004, ad O della collina del castello (fig. 3, 6), che ha messo in luce due fondi di capanna asse-gnati al IX-VIII sec. a.C., due ambienti rettangolari e alcune sepolture arcaiche e una struttura abitativa di IV-III a.C. con relativa necropoli 10. L’occupazione del sito in periodo medievale è testimoniata dalla sola presenza ceramica dilavata, con tutta pro-babilità, dalla sommità della collina. Nel pianoro alle pendici meridionali della collina è segnalata la presenza di una vasta area di necropoli 11 mentre, nell’intero comprensorio, una cesura significativa si avver-te tra il II sec. a.C. e il III d.C. ipotizzata dall’assenza pressoché completa degli indi-catori culturali relativi. La frequentazione riprende, poi, a partire dal IV sec. d.C., testimoniata da frammenti di ceramica tardo-romana del tipo Calle rinvenuti nell’area nord-orientale della collina. Una nuova cesura nel popolamento sembra leggersi tra il VI e l’XI sec. d.C. 12, sebbene molto si discuta sulla presenza di un villaggio altome-dievale in prossimità della chiesa di Santa Maria (fig. 3, B), ubicata proprio sulla col-lina del castello 13. Tuttavia, al momento, nessun rinvenimento restituisce l’evidenza di tale fase di occu-pazione, mentre le testimonianze diventano più consistenti per i secoli immediata-mente successivi. La presenza di ceramica invetriata dipinta in rosso-bruno e verde con stilemi decora-tivi tipici delle produzione di area campana e pugliese, inserisce il contesto di Mon-teserico, tra i secoli XIII-XIV, in un più ampio circuito politico ed economico supportando l’ipotesi che la domus viva una fioritura assoluta a partire dell’età federi-ciana estesa a tutta l’età angioina. Il sito fortificato è documentato a partire dalla prima metà dell’XI sec. sotto il con-trollo normanno, cronologia legata all’episodio bellico del 1041 che vide Normanni e Bizantini scontrarsi in un’area identificabile con la vallata tra Montepeloso e Mon-
9 La raccolta dei frammenti alle pendici del castello è stata effet-tuata, a supporto dei dati di scavo, durante le recenti indagini nel cortile del castello, promosse dalla Soprintendenza per i Beni Ar-cheologici della Basilicata, sotto la direzione della dott. ssa Rosanna Ciriello e seguite sul campo dalla dott.ssa Isabella Marchetta. La lunga campagna è stata inserita in un progetto di restauro e valoriz-zazione del castello di Monteserico voluto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e diretto dagli architetti Car-mela Petrizzi e Luigia Cirigliano.
10 La campagna di scavo è stata effettuata tra il 2003 e il 2004 sotto la direzione della dott.ssa Ciriello. Le indagini sono state affi-date alla dott.ssa Maddalena Sodo. I dati sono stati discussi, in ma-niera preliminare, nelle Giornate di Studio tenute a Matera il 20 -21 Novembre 2007, Ciriello, Sodo, Cossalter 2007, pp. 309-336.
11 Identificata sulla base di rinvenimenti di lastre di copertura tombale e frammenti di ceramica sub-geometrica attribuibile al pe-riodo arcaico. La segnalazione è del dott. Antonio Bruscella, che ha effettuato numerose ricognizioni esplorative nell’area in seno a va-lutazioni di rischio archeologico legate ad opere pubbliche.
12 Secondo la letteratura antiquaria lo scontro tra Longobardi e Bizantini del 929 avvenne nei pressi di Monteserico. In particolare la localizzazione sulla sponda sinistra del fiume Basentello, a NE del castello, è relazionata al rinvenimento in questi luoghi di dodici se-polture allineate. La descrizione che Laccetti fa delle tombe e del corredo associato alle deposizioni fa pensare a tombe a cappuccina assegnabili ai secoli IV-VI come testimonierebbero i braccialetti vi-trei in vetro scuro i braccialetti vitrei in vetro scuro particolarmente diffusi in questi secoli presenti tra gli elementi di corredo. L’episo-dio, quindi, non riceve conferma cronologica da queste deposizio-ni. Per lo scontro tra Longobardi e Bizantini si veda Schipa 1887, fasc. II, p. 231, Fortunato 1902, p. 17; per lo stesso argomento e la descrizione dei rinvenimenti succitati si veda Laccetti 1903, pp. 3-4. Numerose fonti documentarie indirette, al contrario, indivi-duano l’esistenza di un sito abitato presso Monteserico a partire dal XII sec. Si tratta di atto di vendita sottoscritto da un monaco Iohan-nes di Montis Solicole, Le memorie bantine, p. 62, e della conferma di donazione al monastero di Banzi voluta da Roberto di Loretello, sottoscritta da un Thomasius Montis Solicole, publicus notarius, Ughelli 1721, tomo VIII, col. 250. Agli inizi del XII sec. risale pure la permanenza del monaco eremita Guglielmo da Vercelli pres-so Montem Solicolum, Panarelli 2004, p. 8.
13 Bubbico 2003, p. 24.
1
276 Nicola MasiNi, RosaNNa ciRiello, isabella MaRchetta, aNNibale GuaRiGlia, Rossella coluzzi, Rosa lasapoNaRa
14 Annales Barenses, p. 55. 15 Battaglino 2008, p. 125.16 Amato di Montecassino II, c. 26, pp. 88-90. 17 Annales Barenses, p. 55.18 Cfr. nota 8.19 I dati del recente scavo sono ancora in corso di studio ma
riceveranno presto una edizione e sono stati presentati nel 2009 al Convegno di Taranto nella sezione dedicata alle rassegne archeo-logiche regionali. Da un’analisi preliminare è possibile affermare che nella fase di XIII sec. il castello comprendeva il torrione cen-trale con ingresso monumentale a O e la cinta esterna le cui fon-dazioni, venute in luce durante lo scavo, poggiano direttamente sul banco di roccia vergine. A partire da queste, sul fianco orien-tale del castello, attuale ingresso, è documentato un salto di quo-ta (ca. 3 m) che potrebbe identificarsi con un fossato. Il sistema continuo di contrafforti, che si appoggiano lungo la cinta, è inve-ce successivo come dimostra la fossa di fondazione che incide il fondo del fossato stesso. Sull’argomento si veda anche Masini 1996, pp. 79-96; Cinquegrana 1996, pp. 115-132. Il barbaca-ne continuo fu realizzato, con tutta probabilità per contrastare le spinte sui muri di cinta di nuovi ambienti edificati appoggiando-si a questi, in periodo angioino. La sua funzione sarebbe quindi strutturale più che difensiva.
20 Masini 1995.21 A questa data si registra nelle fonti una intensa attività
agricolo-pastorale ma anche la presenza di maestri scalpellini con particolari doti di intagliatori di pietra da essere impiegati nella costruzione del castello di Melfi. Nel settembre del 1279, infat-ti, è attestata la presenza di un tale Bisancius de Montesilicola tra i magistri fabricatores e incisores lapidium della fabbrica melfitana, Sthamer 1914, p. 198. Cfr. pure Masini 2006, pp. 689-753.
22 Pedìo 1983, p. 41. 23 Per una sintesi sulla diffusione della ceramica a doppio
bagno (Double Dipper Ware) si veda il lavoro di Castronuovi, Tagliente 1998, pp. 11-35, con bibliografia.
24 Pedìo 1987, p. 219.25 Cherubino s.d., p. 13; Masini 1995, pp. 219-221.
teserico 14 dove ancora oggi permane il toponimo Serra della Battaglia 15. A quella data, secondo la descrizione del monaco Amato di Montecassino 16, i Normanni erano inse-diati nell’area nord-orientale della Lucania mentre i Bizantini nella zona compresa tra Matera-Irsina-Montescaglioso, ancora in loro possesso, e inter duos montes inierunt con-flictum maximus 17. Inoltre, in base alle sue descrizioni, l’accampamento normanno in Monteserico era cinto da un fossato di difesa.La presenza di un fossato ad E del castello, ampio ca. 7 m, ha ricevuto conferma dal-le più recenti campagne di scavo 18, ma la cronologia di questo sembra assegnabile al-la metà del XIII sec. Gli indicatori culturali mostrano, infatti, una intensa attività nell’area fortificata a partire da questa data 19. Sicuramente, in questa fase, l’insedia-mento comprendeva anche un villaggio di notevole estensione posizionato sul pianoro antistante al castello come testimoniano alcune strutture murarie affioranti ben visibi-li sul terreno e le tracce di microrilievo individuate durante una campagna di archeo-logia aerea nel 1995 20.Nello Statutum de reparatione castrorum, redatto tra 1241 e 1246 per volere di Federi-co II, il castello di Monteserico è annoverato tra le domus, con oneri di manutenzione a carico della popolazione locale. Il borgo, evidentemente, era attivo a questa data e la popolazione destinata a crescere dato che qualche decennio dopo, nel 1277, dai registri della cancelleria angioina si rileva che l’abitato era tassato per la rilevante somma di 22 once e 27 tarì con un totale di 91 fuochi 21. Tale situazione si mantiene stabile almeno fino al 1320, quando i fuochi registrati erano ancora 90 22. Proprio a una frequentazione di fine XIII-XIV sec. riconduce la ceramica di superficie, pur non particolarmente abbondante, raccolta nell’area interessata dai muri in crollo (figg. 2, 4 e 3). Il dato riceve conferma anche dai rinvenimenti nei campi a valle del castello poiché le produzioni di XIII-XV sec. sono largamente documentate indivi-duando una frequentazione densa dell’area fino al tardo XV sec., in accordo il dato della ceramica a doppio bagno nella sua produzione più tarda 23 (figg. 2, 1-3 e 3). Tale cronologia precede di un secolo circa le ultime attestazioni documentarie del borgo che deve annoverarsi tra i numerosi villaggi abbandonati in periodo aragonese 24 e del ca-stello che nel 1501 si presentava dirutum 25.
2
2 - Materiali ceramici medievali raccolti in superficie nella ricognizione esplorativa alle pendici della collina del castello.
3 - Mappatura cronologica e ubicazione delle evidenze archeologiche rilevate dalle ricognizioni esplorative e dagli scavi sistematici. Nelle foto una selezione dei materiali medievali raccolti nelle ricognizioni. Legenda: A castello; B chiesa di S. Maria; 1 versante interessato dall’insediamento medievale: ceramica di XIII-XV secolo; 2 versante orientale sottoposto alla chiesa: frequentazione di età del Bronzo, ellenistica e medievale (ceramica di XIII-XIV sec.); 3 emergenze architettoniche e materiale medievale di XIII-XV sec.; 4 area di materiali dilavati di XIII-XIV sec.; 5 saggi eseguiti nel cortile esterno: evidenze medievali e post-medievali; 6 saggi ad ovest del castello: fasi insediative tra IX e III sec. a.C.
1 2
3 4
277La ricostruzione della forma urbis del casale medievale abbandonato di Monteserico. Nuovi risultati da dati Lidar e ricognizioni sul campo
3
278 Nicola MasiNi, RosaNNa ciRiello, isabella MaRchetta, aNNibale GuaRiGlia, Rossella coluzzi, Rosa lasapoNaRa
26 Masini 1996.27 Lasaponara, Masini 2005.28 Da 30000 a 100.000 pulsazioni al secondo.29 La piattaforma è costituito da un sistema GPS di bordo,
da un’unità di misura inerziale (IMU) e da stazioni GPS a terra. Il GPS di bordo fornisce la posizione, del sensore attra-verso la correzione differenziale fornita dalle stazioni di terra, posizionate su punti noti. Da tale misura dipende la precisio-ne finale di un rilievo laser scan. L’IMU misura con frequen-za di campionamento pari a 256 Hz n durante tutta la dura-ta del rilievo l’assetto di volo del velivolo rispetto ai tre assi ortogonali X, Y e Z.
Sulla base dei dati archeologici a disposizione è difficile poter aggiungere altro sulle di-namiche di popolamento dell’area. La ricerca archeologica è ancora ben lontana dal ri-tenersi esaustiva poiché gli interventi sono stati limitati a ricognizioni esplorative di moderata intensità, finalizzate all’imposizione del vincolo archeologico, e da due sole campagne di scavo sistematico con spazi d’indagine piuttosto ristretti rispetto all’esten-sione del vincolo stesso.Nell’ultimo decennio un supporto è sicuramente venuto dalle indagini non distrutti-ve di telerilevamento che hanno consentito un’ampia lettura dell’intero comprensorio d’interesse. In particolare, sulla base delle foto aeree nadirali e oblique acquisite tra il 1994 e 1996, è stato possibile individuare, sul versante meridionale in falsopiano della collina, una fitta maglia di tracce di microrilievo e strutture murarie affioranti 26. I dati ottenuti sono stati perfezionati, tra 2004 e 2006, mediante l’elaborazione di immagini satellitari QuickBird che ha consentito una migliore caratterizzazione spaziale di que-sta porzione di territorio in cui insiste il sito medievale 27.Nonostante il ricco dataset di immagini a diversa scala e risoluzione spettrale, il rilievo della forma urbana effettuato fino a questo momento non può considerarsi esaustivo, per la difficoltà nell’individuare i microrilievi di interesse archeologico a causa di ma-teriale lapideo in superficie e dei fenomeni erosivi e di creep che interessano proprio il versante meridionale.Pertanto, è stato effettuato il rilievo lidar al fine di: i) georefenziare l’intero record di dati ricavati dal field survey e dall’analisi multitemporale aerea e satellitare delle features ar-cheologiche; ii) ottenere un modello digitale di elevata precisione che consenta di discri-minare meglio le tracce di microrilievo riferibili al disegno urbano dai segni di natura geomorfologica.
Rilievo Lidar a Monteserico
Aspetti tecnologici generali
Il Lidar è una tecnica attiva di telerilevamento basata sull’analisi e l’elaborazione di pul-sazioni nello spettro dell’infrarosso 28 emesse da un laser scanner che può essere mon-tato sia su aereo sia su elicottero. Da ciascuna pulsazione deriverà uno o più echi rifles-si dai vari oggetti incontrati dal raggio lungo il suo percorso (albero, cespuglio, casa, auto, suolo, ecc.). L’ubicazione di ciascun oggetto ‘riflettente’ è ottenuta dall’angolo di emissione del raggio laser, il tempo impiegato tra l’emissione e la ricezione dell’eco di risposta, la posizione dello scanner laser e l’assetto di volo (determinati mediante GPS e il sistema di misura inerziale IMU 29).Attualmente i sistemi laser scanner impiegati rientrano in due tipologie: scanner con-venzionali e scanner full-waveform. I primi ricevono in real time un numero limitato di echi per ciascuna pulsazione laser impiegando detector analogici. Di essi, alcuni rile-vano solo il primo e l’ultimo eco di risposta, altri discriminano fino a 4 echi; in pratica gran parte del segnale si perde e non viene rilevato dal detector. Gli scanner full-wave-form digitalizzano e memorizzano gli impulsi analogici, sia quelli trasmessi sia gli echi multipli raccolti.
Il volo
Il rilievo di Monte Serico è stato effettuato il 18-11-2008 con uno scanner full-wave-form, RIEGL LMS-Q560 della GEOCART srl, installato su elicottero che ha volato con velocità pari a 25.7 m/s ad una quota media di volo rispetto al suolo di 400 m, con angolo di aperture di 60°. L’area ripresa è di ca. 650 ha. Lo scanner ha operato lungo due direzioni S-N ed E-O con divergenza del raggio di 0.5 mrad, pulse repetetion rate di 180.000 Hz e una densità di punti pari a 25 ogni m2. In contemporanea sono state acquisite immagini con camera digitale Digicam H39 da 39 Mpixel.
279La ricostruzione della forma urbis del casale medievale abbandonato di Monteserico. Nuovi risultati da dati Lidar e ricognizioni sul campo
30 Espresso in tempo GPS, il time stamp è il parametro di legame con la traccia di volo per la successiva georeferenzia-zione della nuvola di punti.
31 Entità della riflessione dell’impulso sul bersaglio.32 Shie Qian, Dapang Chen 1996, pp. 181-198.33 In particolare, con la prima classificazione s’impone l’in-
dividuazione di singoli punti o di gruppi di massimo 5 punti caratterizzati dall’essere di 0,50 m più bassi degli altri entro un raggio di 5 m. Nella seconda routine s’impone l’individua-zione di punti isolati, inferiori ad un numero di 25 individuati in un raggio di 2 m, ovvero di punti di errore dovuti, ad esem-pio, a particelle presenti nell’atmosfera, volatili, ecc.
34 Axelsson 2000.35 Si tratta di un algoritmo detto a “Funzioni di più crite-
ri geometrici” ed è basato sulla triangolazione secondo il cri-terio di Delaunay. Si parte da un TIN a maglie ampie costitu-ito da un certo numero di punti detti punti seme (seed points) di cui è verificata l’appartenenza al terreno. Si procede ad uni-re ciascun punto contenuto all’interno dei triangoli con i tre vertici a formare un tetraedro i cui lati formano tre angoli con il piano del triangolo di partenza; affinché il punto in esame venga classificato come Ground è necessario che esso rispetti tre criteri: i) gli angoli formati con il triangolo di base non su-perino il valore dell’ iteration angle, ii) la sua distanza dal trian-golo non superi l’ iteration distance, iii) ed infine i tre nuovi triangoli formati dalle rette che lo collegano con i vertici del triangolo di partenza non abbiano una pendenza superiore a quella inizialmente prefissata. Un altro parametro da definire è “Maximum building size”, che corrisponde alla massima di-stanza a cui possono trovarsi due punti terreno per la presen-za di un edificio. Poiché Monteserico è un’area collinare, non vegetata ma con inclinazioni di rilievo, dopo vari tentativi, sono stati ritenuti idonei i seguenti valori di soglia: Maximum building size = 60; Terrain angle = 88 m; Iteration angle = 10 de-gree; Iteration distance = 1,40 m.
Metodologia di elaborazione: dalla Full Waveform Analysis alle classificazioni
L’elaborazione degli impulsi raccolti viene effettuata mediante una procedura, detta Full Waveform Analysis, che consiste: 1) nella determinazione di una serie di parametri quali il time stamp 30, la distanza e angolo di scansione rispetto al centro del sensore, l’in-tensità di risposta 31, il numero di echi complessivi generati dall’impulso e la posizione dell’eco nella catena; 2) nel processing basato sull’impiego di filtri sul range, angolo di scansione e algoritmi di computazione dell’eco. Per la nostra applicazione è stato impiegato l’algoritmo Gaussian Pulse Estimation im-plementato nel software Terra Scan che procede, attraverso un set di equazioni lineari, a un fitting sul dato campionato stimandone ampiezza e range temporale 32. Dall’ana-lisi della forma d’onda si ottengono solo i punti riferiti al centro di presa dello scanner e quindi privi di informazione geografica. La fase successiva è dunque la georeferenzazione. Attraverso il GPS timestamp ogni pun-to viene riferito alla traccia GPS-IMU e quindi il range e l’angolo di scansione posso-no essere trasformati in coordinate geografiche. Oltre alla posizione del sensore viene tenuto in conto l’assetto dell’aereo e vengono impostati alcuni parametri come l’orien-tamento dello scanner rispetto alla direzione di volo, il datum geografico in cui si ope-ra e i valori angolari di calibrazione dello strumento. Dopo la georeferenzazione, al fine di ottenere un accurato Modello Digitale del Terre-no la nuvola di punti viene elaborata mediante tecniche di filtraggio che consentono di rimuovere in maniera semiautomatica punti non appartenenti alla superficie del ter-reno, ovvero punti corrispondenti a errori grossolani di misura (outliers) tramite una routine di classificazione dei “low point” e dei punti isolati 33. Una volta individuati gli outliers si è proceduto alla definizione del terreno, mediante una routine del program-ma “Classify ground” basato sull’algoritmo di “Densificazione progressiva di TIN” di Axelsson 34. Fondamentale in questa fase è la definizione di alcuni parametri geometri-ci di soglia che dipendono dalle caratteristiche morfologiche del sito 35. Una volta indi-viduati i punti del terreno si procede ad affinare la classificazione individuando i pun-ti: i) Below surface”, ovvero situati al di sotto di una certa soglia nel terreno quali cavi-tà, molto diffusi sulla collina di Monteserico; ii) i punti relativi alla bassa vegetazione. Ulteriori classificazioni riguardano la vegetazione, in funzione dell’altezza che la carat-terizza, e gli edifici. A Monteserico mancando una copertura boscosa non è stata effet-tuata alcuna classificazione della vegetazione. La procedura di classificazione degli edi-fici è basata su criteri di tipo geometrico, per i quali è necessario definire dei parametri geometrici di soglia. Tale classificazione, usualmente complessa in un contesto urbano, non ha comportato grandi difficoltà nel caso di Monteserico poiché nell’area ci sono poche strutture rurali, una chiesetta ed il Castello, tutte ben distanziate fra loro. Inol-tre, l’alta densità di campionamento del rilievo ha permesso non solo di individuare in modo preciso i contorni degli edifici e quindi di individuare la loro impronta sul ter-reno ma ha permesso perfino il rilievo di dettagli.Una volta terminata la classificazione si è realizzato il modello digitale del terreno (DTM), a maglie triangolari irregolari (TIN) di Delaunay passante per i soli punti “ter-reno”, ed il DSM dell’area passante invece per tutti i punti rilevati.
Ortorettifica
A partire dal DTM e dalle immagini acquisite con la camera Digicam H 39 da 39 Mpixel contemporaneamente al rilievo laser, si è proceduto alla realizzazione dell’orto-foto con il software Terraphoto di Terrasolid. Successivamente, utilizzando l’ortofoto è stata effettuata con Global Mapper l’ortorettifica del dataset storico costituito da una foto aerea scattata il 13 - 09 - 1994 e due immagini satellitari QuickBird acquisite il 4 - 07 - 2004 e il 26 - 10 - 2006. La procedura è stata quella di individuare punti omolo-ghi da usare come Ground Control Points dell’ortofoto e dell’immagine da rettificare. Durante tale operazione è stato possibile registrare dal 1994 ad oggi le notevoli varia-zioni nell’uso dei suoli, nel patrimonio costruito, nelle divisioni agrarie e rilevanti ri-maneggiamenti subiti dalla tracce archeologiche di microrilievo.
280 Nicola MasiNi, RosaNNa ciRiello, isabella MaRchetta, aNNibale GuaRiGlia, Rossella coluzzi, Rosa lasapoNaRa
Interpretazione archeologica
L’integrazione del dataset ottico con il DTM tratto dal rilievo scanner mette in evi-denza sul pianoro esposto a S, antistante il castello, una ‘intricata’ maglia di tracce di microrilievo, in buona parte riferibili al tessuto urbano dell’insediamento medievale. I microrilievi, tutti ubicati a S della stradina di accesso al castello, sono costituiti da strutture murarie o di fondazione ricoperte da piccoli spessori di terreno o parzialmente affioranti di altezza variabile da 0,5 a 1 m (fig. 4d, profilo y-y1) rispetto alla quota del suo intorno, costituito generalmente dall’area interna di sedime della costruzione.Laddove le tracce di microrilievo sono ben visibili e non interessate da fenomeni de-formativi di creep del terreno, esse consentono di ricostruire il perimetro di unità abitative. L’interpretazione delle immagini aeree e satellitari e del DTM mette in evidenza tre settori che si distinguono per la morfologia plano altimetrica.Osservando la parte più a S, nella ortofoto del 1994 (fig. 4a), nel RGB QuickBird (fig. 4b) e nel DTM (fig. 4d), si distingue un pattern di tracce che seguono l’andamen-to delle curve di livello assumendo una conformazione radiocentrica. A N del pattern radiocentrico, si osservano nella foto del 1994 (fig. 4a), tracce lineari in direzione S-N intercettate da segni in direzione ortogonale. Osservando il settore occidentale dal DTM (fig. 4d) si individuano altre tracce non visibili dal dataset ottico, tra cui un allineamento in direzione E-O, probabile indizio di viabilità interna (fig. 5, x). Un altro allineamento (fig. 5, y) taglia il pianoro in direzione N-S e continua al di fuori del limite urbano S (fig. 5, a) seguendo un viottolo a mezza costa in direzione SO (fig. 5, w). Il detto limite urbano S è dato da un gradino morfologico di altezza variabile da 8 a 12 m, per una lunghezza totale di ca. 150 m, e caratterizzato da for-mazioni ipogee (fig. 5, C). Il dislivello morfologico (fig. 5, a), nella sua funzione di limite urbano 36, pare congiungersi con il ciglio arrotondato del versante SO (fig. 5, z), lungo il quale poteva svilupparsi un accesso all’abitato vicino al castello, e con il con-torno dell’estremità SE (fig. 5, b2). A quest’ultimo riguardo si richiama all’attenzione un ulteriore dislivello (fig. 5, b1) di ca. 3 m (fig. 5, profilo X-X’), arretrato rispetto a fig. 5, b2, che potrebbe aver rappresentato un altro limite dell’edificato nel settore sud-orientale. Pianificando dei saggi archeologici in zone di elevato interesse sarà possibile definire con più precisione la funzione specifica di una fossa circolare rivestita in muratura, che si ipotizza fossa granaria, di una unità stratigrafica muraria parzialmente in luce ai pie-di del dislivello roccioso, e dei numerosi e diffusi cumuli di pietrame orientati presen-ti nell’intera area e interpretabili come crolli (figg. 4a-d; fig. 5, E).A N della stradina di accesso al castello non si registrano tracce di microrilievo di in-teresse archeologico probabilmente a causa del livellamento antropico del terreno. Il dato sembrerebbe confermato anche dalla quasi totale assenza di materiali ceramici di superficie. Mediante la procedura di classificazione below surface, richiamato nel para-grafo precedente, è stato possibile rilevare, nei pressi della chiesa di S. Anna (figg. 3, D e 5), una cavità (fig. 5, D) che la ricognizione a terra 37 ha verificato essere l’ingresso ad un ambiente ipogeo diviso in due vani e parzialmente obliterato. Anche in questo caso l’esplorazione archeologica potrà meglio definirne la natura dell’ipogeo, che ad una prima analisi sembra antropica.Nel complesso, il DTM da lidar non solo enfatizza segni già rilevabili dai dati ottici, consentendo in particolare una più precisa caratterizzazione spaziale e morfologica, ma evidenzia anche allineamenti tra tracce di microrilievo riconducibili alla presenza di cardini viari non visibili dalle foto aeree e dall’immagine satellitare. La sua funzione specifica in ambito archeologico ha duplice natura: consente una lettura totale ed am-pia del territorio superando il limite della visibilità dovuta alla copertura vegetale e discriminando i segni morfologici e quelli antropici e al tempo stesso consente di pia-nificare, con spazi di tempo più ridotti, le attività archeologiche sul campo. Supporto imprescindibile per l’interpretazione dei segni è infatti l’analisi a terra delle evidenze e la sintesi cronologica di queste così da avere una lettura diacronica del territorio inda-gato preliminarmente dall’alto.
36 Allo stato attuale delle conoscenze nulla è dato sapere della presenza di una cinta muraria in corrispondenza del li-mite urbano S.
37 Ricognizione effettuata in seno alle indagini del 2008-2009.
4 - Analisi comparata della visibilità delle tracce archeologiche di microrilievo tra la foto aerea del settembre 1994 (a), RGB di QuickBird dell’ottobre 2006 (b), foto aerea (c) e DTM da Lidar del settembre 2008.
5 - Interpretazione archeologica sul DTM tratto dal rilievo Lidar.
281La ricostruzione della forma urbis del casale medievale abbandonato di Monteserico. Nuovi risultati da dati Lidar e ricognizioni sul campo
4
5
a cb d
282 Nicola MasiNi, RosaNNa ciRiello, isabella MaRchetta, aNNibale GuaRiGlia, Rossella coluzzi, Rosa lasapoNaRa
Abbreviazioni bibliografiche
Amato di Montecassino : Amato di Montecassino, Sto-ria de’ Normanni volgarizzata in antico francese, ediz. a cura di V. De Bartholomaeis, in Fonti per la Storia d’Italia, 76, Roma 1935.
Annales Barenses : Annales Barenses anonimi ab. An. 605 -1043, in Mon. Germ. Hist, Scriptores, t. V, Hannover 1844.
Axelsson 2000: P. Axelsson, DEM generation from laser scanner data using adaptive TIN models, in In-ternational Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, XXXIII, B4/1, 2000, pp. 110-117.
Barnes 2003: I. Barnes, Aerial remote-sensing tech-niques used in the management of archaeological monuments on the British Army’s Salisbury Plain Training. Area, Wiltshire, UK, in Archaeological Prospection, 10, 2003, pp. 83-91.
Battaglino 2008: M. Battaglino, Aquilina di Monte-serico, Venosa 2008.
Bettelli, De Faveri, Osanna 2008: M. Battelli, C. De Faveri, M. Osanna (a cura di), Prima delle Colonie. Organizzazione territoriale e produzioni ceramiche specializzate in Basilicata e in Calabria settentrionale ionica nella prima età del ferro. Atti delle Giornate di Studio (Matera, 20 -21 novembre 2007), Venosa 2008.
Bubbico 2003: L. Bubbico, L’abitato ed il castello di Monteserico, in L. Bubbico, F. Caputo, Storia, ar-chitettura, restauri ed ambiente in Basilicata, Policoro 2003, pp. 21-38.
Castronuovi, Tagliente 1998: C. Castronuovi, P. Tagliente, Ceramica a “doppio bagno” nel salento, in Quaderni del Museo della ceramica di Cutrofiano, 7, 1998, pp. 11-39.
Challis 2006: K. Challis, Airborne laser altimetry in alluviated landscapes, in Archaeological Prospection, 13, 2, 2006, pp. 103-127.
Cherubino s.d: C. Cherubino, Il testamento di Aqui-lina Sancia di Monteserico (1327), Melfi s.d., p. 13.
Cinquegrana 1996: L. Cinquegrana, Indagini mine-ralogiche sui materiali costituenti il castello di Monte Serico, in Tarsia, 19, 1996, pp. 115-132.
Ciriello, Sodo, Cossalter 2007: R. Ciriello, M. Sodo, L. Cossalter, Ricerche recenti in area medio-bradanica. L’insediamento di Monteserico nella prima età del ferro, in Bettelli, De Faveri, Osanna 2008, pp. 309-338.
Corns, Shaw 2008: A. Corns, R. Shaw, High resolu-tion LiDAR for the recording of archaeological monu-ments and landscapes, in Lasaponara, Masini 2008, pp. 99-102.
Crawford 1929: O.G.S. Crawford, Air Photogra-phy for Archaeologists, Southampton 1929.
Crosilla et al. 2004: F. Crosilla, D. Visintini, G. Prearo, B. Fico, Esperienze di filtraggio, classifica-zione, segmentazione e modellazione di dati spazia-li da rilievo laser aereo, in Bollettino della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, Relazione invitata al convegno annuale della SIFET, Chia La-guna 22-24 settembre 2004, Cagliari 2004.
Crutchley 2008: S. Crutchley, Ancient and modern: Combining different remote sensing techniques to in-terpret historic landscapes, in Lasaponara, Masini 2008, pp. 103-106.
Dassie 1978: J. Dassie, Manuel d’archeologie aerienne, Paris 1978.
Devereux et al. 2005: B.J. Devereux, G.S. Amable, P. Crow, A.D. Cliff, The potential of airborne lidar for detection of archaeological features under woodland canopies, in Antiquity, 79, 2005, pp. 648-660.
Doneus et al. 2008: M. Doneus, C. Briese, M. Fera, M. Janner, Archaeological prospection of forested areas using full-waveform airborne laser scanning, in Journal of Archaeological Science, 35, 2008, pp. 882-893.
Fonseca 2006: C.D. Fonseca (a cura di), Storia della Basilicata. Il Medioevo, Bari-Roma 2006.
Fortunato 1902: G. Fortunato, Il castello di Lagope-sole, Trani 1902 (ediz. 1987).
Laccetti 1903: F. Laccetti, Castel di Mone Serico, in Napoli Nobilissima, XII, fasc. V, 1903, pp. 3-4.
Le memorie bantine : Le memorie bantine. Le memorie del monastero bantino o sai della Badia di Santa Maria di Banzia, ora Banzi; pubblicate dall’ordine del Car-dinale di Sant’Eusebio abate commendatario di essa Badia da Domenico Pannelli suo segretario, edizione curata da P. De Leo, Montescaglioso 1995.
Lasaponara, Masini 2005: R. Lasaponara, N. Masi-ni, QuickBird-based analysis for the spatial characteri-zation of archaeological sites: case study of the Monte Serico Medioeval village, in Geophysical Research Let-ter, 32, 12, 2005, L12313.
Lasaponara, Masini 2007: R. Lasaponara, N. Masi-ni, Detection of archaeological crop marks by using sat-ellite QuickBird, in Journal of Archaeological Science, 34, 2007, pp. 214-221.
Lasaponara, Masini 2008. R. Lasaponara, N. Masi-ni (eds.), Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma 2008.
Lasaponara, Masini 2009. R. Lasaponara, N. Ma-sini, Full-waveform Airborne Laser Scanning for the detection of medieval, in Journal of Cultural
Heritage, 10S, 2009, pp. e78 - e82 (doi:10.1016/ j.culher.2009.10.004).
Masini 1995: N. Masini, Note storico-topografiche e fotointerpretazione aerea per la ricostruzione della “forma urbis” del sito medievale di Monte Serico, in Tarsia, 16-17, 1995, pp. 45-64.
Masini 1996: N. Masini, Il castello normanno - svevo di Monte Serico, in Tarsia, 19, 1996, pp. 79-96.
Masini 2006: N. Masini, Dai Normanni agli Angioini: castelli e fortificazioni della Basilicata, in Fonseca 2006, pp. 689-753.
Masini, Lasaponara 2007: N. Masini, R. Lasapo-nara, Investigating the spectral capability of Quick-Bird data to detect archaeological remains buried under vegetated and not vegetated areas, in Journal of Cultural Heritage, 8, 1, 2007, pp. 53-60.
Panarelli 2004: F. Panarelli, Scrittura agiografica nel Mezzogiorno normanno. La vita di S. Guglielmo da Vercelli, Galatina 2004.
Pedìo 1983: T. Pedìo, La tassazione focatica in Basi-licata dagli Angioini al XVIII secolo, in Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera, IV, 1983, pp. 15-53.
Pedìo 1987a: T. Pedìo, I centri scomparsi, in T. Pedìo, La Basilicata dalla caduta dell’impero romano agli Angioini, Bari 1987, I, pp. 201-219.
Piccarreta, Ceraudo 2000: F. Piccarreta, G. Cerau-do, Manuale di aerofotografia archeologica. Metodo-logia, tecniche e applicazioni, Bari 2000.
Schipa 1887: M. Schipa, Storia del Principato Longo-bardo di Salerno, in Annali della Scuola Normale di Pisa, XII, 1887, fasc. II, pp. 209-264.
Shell, Roughley 2004: C. Shell, C. Roughley, Exploring the Loughcrew landscape: a new airborne approach, in Archaeology Ireland, 18/2, 68, 2004, pp. 22-25.
Shie Qian, Dapang Chen 1996: Shie Qian, Dapang Chen, Joint Time-Frequency Analysis Methods and Applications, Upper Saddle River 1996.
Sthamer 1924: E. Sthamer, Die Verwaltung der Kas-telle im Konigreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou (Erganzungs band I di Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien), Leipzig 1914.
Ughelli 1721: F. Ughelli, Italia Sacra sive de Epi-scopis Italiae, et insularum adiacentium, Venetiis apud Sebastianum Coleti, t. VII, 1721.
Wilson 1982: D.R. Wilson, Air photo interpretation for archaeologists, London 1982.


















![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)