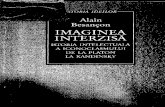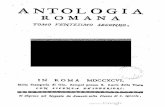Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana
Transcript of Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana
GIOVANNA MANCINI
INTEGRAZIONE ED ESCLUSIONE NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA. DALLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
DELLO STRANIERO ALLA GENERALIZZAZIONE DELLA CONDIZIONE DI “STRANIERO IN PATRIA”:
LE NORME SU CAPACITÀ MATRIMONIALE E FILIAZIONE COME STRUMENTI DELLA FRAMMENTAZIONE
DEGLI STATUS IN ETÀ TARDOANTICA
SOMMARIO: 1. L’integrazione dell’estraneo al populus Romanus. – 2. L’unificazione in una stessa civitas. – 2.1. L’omologazione dei provinciales. – 2.2. Dall’estraneità alla segregazione. – 2.2.1. Gli antecedenti della prima età del principato. – 2.3. L’età tardoantica. – 2.3.1. Iudaei. – 2.3.2. Gentiles. – 2.3.3. Altre cause inedite di repressione di unioni paramatrimoniali. – 2.3.4. Endo-gamia e funzione sociale: tra esclusione del conubium e repressione penale. – 3. Conclusioni. Nell’ambito del progetto di ricerca Politiche di integrazione e vincoli
giuridici: dal quadro generale all’applicazione locale, l’obiettivo che il sotto-gruppo storico si proponeva era quello di offrire terreni di comparazione giuridica diacronica utili ad agevolare la comprensione del complesso rap-porto tra esigenze economiche, assetti valoriali e strumenti di integrazione di culture diverse, ciò al fine di individuare presupposti e vincoli per porre in essere azioni di massima integrazione possibile dell’estraneo alla comu-nità in cui si trovi a vivere.
Lo studio di tali problematiche all’interno dell’esperienza giuridica ro-mana, mostra, a mio avviso, come forme e intensità dell’integrazione dello straniero dipendano certamente, in primo luogo, da fattori economico-sociali e culturali presenti nei due gruppi, quello di appartenenza originale e quello in cui si è accolti, ma anche da un elemento proprio di quest’ul–timo: il suo assetto costituzionale, quello che, in termini moderni, potrem-mo riferire alla forma di stato, se non anche a quella di governo1. Ciò per-ché, in primo luogo, il riconoscimento di diritti all’individuo – se pure non certo a “tutti” gli esseri umani – nei confronti del potere politico, non può non riverberare, sia pure in misura modesta, sulla costruzione concettuale della figura dello stesso estraneo al gruppo; in secondo luogo, è la stessa
1 Non è questa la sede per dibattere sulla correttezza, da punto di vista scientifico,
dell’utilizzazione di categorie moderne – a partire da quella stessa di “Stato” – nella descri-zione di esperienze giuridiche antecedenti la loro formazione; nella consapevolezza del pro-blema, nel testo si cercherà di utilizzare una terminologia il più possibile neutra.
GIOVANNA MANCINI
2
attribuzione di pari diritti almeno sul piano privatistico a dipendere dalla sua compatibilità con la complessiva organizzazione socio-politica.
Da questo punto di vista, nella millenaria esperienza giuridica romana il problema del rapporto di esclusione o integrazione dello straniero si è posto in, almeno, due contesti storico-politici radicalmente diversi, nonché estranei, entrambi, al quadro valoriale dell’età contemporanea che è carat-terizzato sia dall’esistenza di una cittadinanza che – uscita dalla dimensione dell’appartenenza/sudditanza – assume una valenza necessariamente politi-ca, sia dal generale riferimento a “diritti dell’uomo” che travalicano – e in-sieme fondano – lo status di cittadino.
1. L’integrazione dell’estraneo al populus Romanus I Romani si trovano ad affrontare il problema dell’integrazione – e della
contaminazione – giuridica e culturale di individui estranei al loro popolo, non solo nella fase della loro espansione imperiale, caratterizzata dalla di-cotomia tra Romani/dominatori e stranieri/loro sudditi, ma anche in quel-la – che si apre nel 212 d.C. con la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero – in cui la condizione degli individui è unifica-ta dalla comune appartenenza allo stesso populus2.
I meccanismi utilizzati nella prima fase sono caratterizzati essenzial-mente dalla concessione alle comunità politiche vinte di un’autonomia in-terna, quanto alla regolamentazione esclusiva dei rapporti di diritto pub-blico, familiari e di successione, e, insieme, dalla creazione di strumenti di integrazione giuridica, consistenti essenzialmente nel conferimento di uno status particolare ad intere comunità – la latinitas – e, nel campo delle atti-vità economiche e commerciali, nella creazione di istituti comuni a cives e peregrini, lo ius gentium3.
Nell’amministrazione dei territori conquistati, inoltre, al principio – proprio delle esperienze antiche – della personalità del diritto e della con-seguente inaccessibilità per lo straniero degli istituti propri di un’altra co-munità, si affianca quello della territorialità sia del diritto pubblico romano
2 Sulla constitutio Antoniniana, v., da ultimi, Purpura G., Il P. Giss. 40, I, in Ivris Anti-
qvi Historia 5 2013, pp. 73-88 e Marotta V., La cittadinanza romana in eta imperiale (secoli I-III). Una sintesi, Torino, 2009, con esaustivi richiami della letteratura precedente.
3 Su latinitas, ius gentium, nonché forme e strumenti di organizzazione della conquista, la letteratura è amplissima. Per un inquadramento, si vedano, oltre alla Storia di Roma edita da Einaudi, in particolare Sordi M., I rapporti romano-ceriti e l’origine della civitas sine suf-fragio, Roma 1960, Luraschi G., Foedus, ius Latii, civitas, Padova 1979, Humbert M., Mu-nicipium et civitas sine suffragio, Roma 1978, Capogrossi Colognesi L., Cittadini e territorio: consolidamento e trasformazione della “civitas Romana”, Roma 2000. Un quadro efficace di questo profilo nell’età del principato in Jacques F. - Scheid. J., Rome et l’intégration de l’empire (44 av. J.C – 260 ap. J.C.), Paris 1990.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
3
– per la sottoposizione a un medesimo potere di coercizione – sia di quello da applicarsi ai rapporti, sempre più frequenti, tra stranieri.
All’interno dell’impero, esclusivamente chi sia civis Romanus ha, però, guarentigie particolari in relazione all’esercizio del potere di repressione in materia criminale e alla stessa libertà di movimento; diritti di libertà sono concepibili e concepiti esclusivamente in dipendenza della condizione di civis, non di quella di essere umano.
Nelle esperienze antiche, solo all’interno del proprio gruppo si ha pro-tezione dall’esercizio della violenza da parte di altri individui e, in alcuni casi, a ciò si affiancano – nelle città-stato a regime democratico – forme di garanzia contro l’esercizio dispotico del potere politico, si è titolari e veri e propri poteri giuridici. In pace, la tutela della persona stessa dello straniero trova fondamento non in norme giuridiche, ma morali o religiose4; in guer-ra, al contrario, è una norma generalmente accettata e applicata da tutti i popoli – di diritto internazionale, diremmo noi – a sottoporla al potere as-soluto del vincitore, a degradarla dalla condizione di libero a quella di ser-vus.
È solo tenendo presente questo sfondo che si possono intendere appie-no la singolare estensione della capacità inclusiva dei Romani e, insieme, i suoi limiti insuperabili.
Tale propensione era fatta risalire dai Romani stessi all’età immediata-mente successiva alla fondazione della città, alla quale la tradizione annali-stica ripresa da Livio e Dionigi5 riconduce l’accoglienza di intere gentes, nonché di quella massa di soggetti a esse estranei che andò a costituire la plebe urbana.
L’attitudine all’inclusione a pieno titolo di persone originariamente estranee alla civitas e al populus fu anche avvertita dai più accorti avversari di Roma come una delle cause della sua potenza militare6; non riguardò,
4 Questo è il quadro reso dagli scrittori antichi e, in maniera efficacissima, da Polibio
Storie, a cura di D. Musti, voll. 1-7, Milano 2005. Quanto alle ricostruzioni moderne, per un punto di vista in qualche misura differente, si vedano, in particolare, le splendide pagine delle lezioni a Cambridge di Arnaldo Momigliano, raccolte in Lezioni a Cambridge gennaio-marzo 1940, a cura di R. Di Donato, Firenze 1996 e di Giuliano Crifò, Civis. La cittadinanza tra antico e moderno, Bari 2000, né può mancare un rinvio a Wirszubski C. H., Libertas as a Political Idea at Rome During the Late Republic and Early Principate Cambridge 1950.
Per un approccio storico esemplare sulla questione della democrazia antica, v., inoltre – in particolare riferimento, però, alle esperienze greche – Musti D., Demokratìa. Origini di un’idea, Roma-Bari 1995 e Canfora L., La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari 2004. Sul rapporto tra diritti dell’individuo e forme della cittadinanza, mi si permetta di rinviare a Mancini G., Cittadinanza e status negli antichi e nei moderni, Pescara 2000. Spunti di grande interesse sulla storia della cittadinanza, in Costa P., Civitas, Roma-Bari 2000.
5 Cfr. Fascione L., Il mondo nuovo. La costituzione romana nella «Storia di Roma arcai-ca» di Dionigi d’Alicarnasso. Vol. 1, Napoli Jovene 1988, vol. II, Napoli Jovene 1993, pas-sim.
6 Con riferimento agli effetti della manomissione, si veda la lettera di Filippo V di Ma-
GIOVANNA MANCINI
4
infatti, soltanto il momento immediatamente successivo alla fondazione della città. Essa non solo si manifestò nella piena integrazione, tra il V e il IV secolo a. C. dei plebei, originariamente estranei al popolo e alla sua civi-tas7, ma giunse a porre in secondo piano la divisione allora fondamentale tra gli esseri umani, quella tra liberi e schiavi: si pensi al fatto che nell’ordi–namento romano – e solo in esso – lo schiavo affrancato era ammesso a far parte nel populus, con diritto di voto nelle assemblee e i suoi figli con asso-luta pienezza di diritti8. E se poco conosciamo dell’entità dei casi di confe-rimento viritim della cittadinanza, sappiamo però che, compatibilmente con i limiti strutturali propri della città-stato, nella fase iniziale della sua espansione Roma ammise a far parte del suo popolo intere comunità laziali, pur lasciando loro autonomia amministrativa nella forma del municipium9.
Fu, questo, il modo peculiare romano di rispondere a una delle sfide che, in particolare nell’antichità, ciascun gruppo umano deve superare: quella della conservazione della sua consistenza demografica e, anzi – nei limiti imposti dalle capacità di sostentamento offerte dal territorio che si è in grado di controllare – del suo ampliamento. Di qui la necessità di acco-gliere l’estraneo, ma anche quella di regolare i rapporti matrimoniali – e all’interno di culture che escludevano, generalmente, l’endogamia – al fine di favorire filiazione e allevamento della prole, conservando, insieme, l’identità etnica e gli assetti sociali fondamentali.
La necessità di agevolare i rapporti di scambio e, più in generale, eco-nomici con gli stranieri imponendo l’osservanza di regole di comportamen-to la cui violazione avrebbe comportato una condanna pecuniaria, si pose sin dagli inizi dell’espansione romana, tanto che già alla metà del III secolo a. C. fu avvertita la necessità di istituire un magistrato, il praetor peregrinus, con la specifica competenza a ius dicere inter Romanos et peregrinos10. At-traverso il suo editto e l’interpretazione creativa della giurisprudenza, si formò un vero e proprio ius gentium – inteso nel senso di insieme di norme
cedonia agli abitanti di Larissa, ILS 8763, ll. 6-9; sul punto v. in particolare Fraschetti A., A proposito di ex schiavi e della loro integrazione in ambito cittadino a Roma, in Opus 1. 1982 p. 97-101; Finley M., Schiavitù antica e ideologie moderne, tr. it., Bari 1981 p.127 ss.; Cata-lano P., «Civitas Romana». Profondeur sociale et ouverture à l’autre, in Index 23 (1995) pp. 485-497; Buckland W.W., The roman law of slavery, Cambridge 1970, pp. 533 ss.; Sherwin-White A.N., The Roman Citizenship, Oxford 1973, p. 323, sottolinea, da parte sua, il con-trasto tra la liberalita nei confronti degli schiavi manomessi e il rifiuto verso i socii italici.
7 Cfr. Guarino A., La rivoluzione della plebe, Napoli 1975, Serrao F., Classi, partiti e legge nella Repubblica romana, Pisa 1977.
8 Se il libertus godeva esclusivamente dell’elettorato attivo, tale limite non c’era per i suoi figli.
9 Si vedano, in particolare, Sordi, I rapporti cit. e Humbert, Municipium cit., passim 10 Serrao F., La iurisdictio del pretore peregrino, Milano 1954; Gallo F., L’officium del
pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano, Torino 1997.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
5
regolanti i rapporti tra i privati di populi diversi11 – e si giunse all’estensione agli stranieri di istituti e forme proprie dello ius civile romano (si pensi solo alla trasformazione della sponsio in stipulatio, accessibile anche ai non Ro-mani); a esso, tuttavia, restò sempre estraneo il campo dei rapporti familia-ri, sulla base dell’esclusione, di norma, della reciproca capacità matrimo-niale tra individui appartenenti a populi – a società politiche – diversi.
L’espansione imperiale romana, l’affermarsi di una dominazione su nuovi territori e quanti li abitavano, fece inoltre sì che la questione del rap-porto e dell’integrazione tra popoli si ponesse, in una prima lunga fase, non solo in termini di rapporto diseguale tra Romani/dominatori e popoli sot-toposti, ma anche in quelli di integrazione tra i diversi popoli assoggettati, unificati dalla comune sottoposizione all’imperium dei magistrati romani.
Strumento di entrambi fu un diritto unitariamente applicato – dal prae-tor peregrinus a Roma e dai governatori nelle province – a soggetti che, fa-cendo parte di populi, etnie diverse, stabilissero tra loro rapporti di scam-bio economico: lo ius gentium, appunto.
I rapporti familiari (matrimonio, condizione dei figli, successioni), vice-versa, continuarono a essere regolati dagli ordinamenti propri di ciascun popolo, esaltando la condizione di reciproca separatezza; nel quadro, tut-tavia, di alcuni principi universalmente condivisi.
Una norma generalmente applicata da tutti i popoli del bacino medi-terraneo, prevedeva che i figli di una donna ne seguissero la condizione (a partire da quella di appartenenza alla sua etnia12 originaria) se nati al di fuori di un rapporto matrimoniale istituito secondo l’ordinamento giuridi-co del loro padre e seguissero quella di quest’ultimo solo nel caso contra-rio.
Perché ciò fosse possibile, condizione necessaria era costituita dall’esi–stenza della reciproca capacità matrimoniale, del conubium, tra i gruppi ai quali appartenevano la donna e l’uomo: si pensi a una persona schiava e una libera. Nel caso di liberi, che appartenessero a società politiche diver-se, la possibilità di scambio matrimoniale era, però, subordinata anche all’esistenza di accordi tra le stesse – nell’ambito di rapporti paritari – o di concessioni unilaterali da parte, nel nostro caso, di Roma che sin dal II se-
11 Il sintagma ius gentium copre significati diversi: quello indicato nel testo, quello di
diritto che regola i rapporti tra le gentes (gli “stati”), quello di diritto materiale generalmen-te comune a tutte le gentes.
12 Per indicare, nell’esperienza antica, una società a fini generali, che presenti caratteri analoghi a quelli dello Stato moderno anche e soprattutto in termini di strutturazione di un potere di comando e di autonomia, se non di sovranità, nei rapporti con formazioni analo-ghe, utilizzeremo, accanto a populus – che corrisponde, però a una sola delle possibili forme di organizzazione del potere politico – quelli di “stato” e di gruppo etnico/etnia, non, però, nell’accezione di “razza”, ma in quella di “gruppo umano organizzato e accomunato da de-terminati caratteri linguistici e culturali”, non necessariamente fisici.
GIOVANNA MANCINI
6
colo a. C. aveva iniziato a servirsene come strumento di controllo delle co-munità italiche a essa alleate (socii italici e città latine).
In un quadro di norme concepite, presso tutti i popoli antichi, essen-zialmente da un punto di vista maschile, il matrimonio è, infatti, strumento di acquisizione di potere da parte del padre sui procreati, nonché canale preferenziale – anche se non unico – di inserimento dei nuovi nati nella comunità politica di lui e, insieme, tramite di possibile integrazione tra co-munità “statuali”diverse, utile a favorire e rinsaldare alleanze. Ciò spiega la politica romana di controllo sulla possibilità di scambi matrimoniali tra i popoli vinti.
Proprio l’assenza di un quadro valoriale che riconosca pari diritti agli uomini, fa, infatti, sì che nelle società antiche fondamentale strumento di integrazione sia costituito dallo scambio matrimoniale cui si dia luogo tra uomini e donne appartenenti a “stati”, rectius società politiche diverse, o anche, all’interno di queste, a gruppi etnici o sociali diversi.
Da questo punto di vista, le normative relative ai rapporti matrimoniali possono costituire un terreno utile per far emergere forme e motivazioni del succedersi di politiche inclusive o di chiusura13.
2. L’unificazione in un’unica civitas Con l’ammissione alla cittadinanza romana di tutti popoli assoggettati
all’impero, operata da Antonino Caracalla con la constitutio del 212 d. C., cessa, in apparenza, ogni possibile ostacolo anche alla libertà di scelta ma-trimoniale, fatta eccezione per le persone di condizione servile, mentre si rafforza la dimensione territoriale dell’appartenenza e, con essa, una nuova netta distinzione: non più tra “Romani” e appartenenti ai populi assoggetta-ti, ma tra quanti sono fuori dei confini, i barbari, e quanti vivono sottoposti al potere dell’imperatore/dominus, i provinciales, e, in una fase più tarda, tra questi ultimi e i barbari ammessi a vivere all’interno del limes, i gentiles.
Nasce, conseguentemente, la necessità di regolare il rapporto coi bar-bari, ma anche quella di definire regole uniche per popoli con usanze, in particolare matrimoniali, diverse. Si pone, cioè, il problema dell’inte-grazione di individui provenienti da popoli portatori di culture diverse da quella romana attraverso l’omologazione a principi generalmente condivisi
13 Sul fenomeno delle unioni ineguali, sia dal punto vista normativo, sia da quello delle
radici sociali v. Evans Grubbs J., Law and Family in Late Antiquity. The emperor Constanti-ne’s Marriage Legislation, Oxford 1999.
Per un quadro degli sviluppi del diritto matrimoniale dall’età di Costantino ai giorni nostri, si veda Busacca C., Iustae nuptiae. L’evoluzione del matrimonio romano dalle fasi pre-cittadine all’età classica, Milano 2012, pp. 11-49.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
7
dal popolo dominante, in particolare a quelli relativi alla capacità matri-moniale.
2.1. L’omologazione dei provinciales Diocleziano14 vieta la bigamia, già presente negli ordinamenti dei popo-
li sottoposti, punendola con l’irrogazione dell’infamia. Lo stesso divieto dovrà, però, essere reiterato – oltre cent’anni dopo – con esplicito riferi-mento agli Iudaei da Teodosio15. Da Costantino in poi è un ripetersi di di-vieti relativi a nozze tra primi cugini, punite con la morte da Costantino, con una costituzione indirizzata alle popolazioni fenicie16. Pochi anni dopo, Costantino e Costante, escluderanno il conubium con la ex moglie del fra-tello o con la sorella della moglie17, ma qualche decennio dopo Valentinia-
14 C.5.5.2. DIOCL./MAXIM. Neminem, qui sub dicione sit Romani nominis, binas
uxores habere posse vulgo patet, cum et in edicto praetoris huiusmodi viri infamia notati sint. Quam rem competens iudex inultam esse non patietur. DIOCL. ET MAXIM. AA. SEBA-STIANAE. PP. III ID. DEC. DIOCLETIANO A. II ET ARISTOBULO CONSS. (anno 285).
15 C.1.9.7. VALENT./ THEOD./ ARCAD. Nemo Iudaeorum morem suum in coniunc-tionibus retinebit nec iuxta legem suam nuptias sortiatur nec in diversa sub uno tempore co-niugia conveniat. VALENTIN. THEODOS. ET ARCAD. AAA. INFANTIO COM. ORIEN-TIS. D. III K. IAN. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS. (anno 393).
Sugli interventi imperiali tesi a limitare – e in alcuni casi a vietare – l’utilizzazione dell’ordinamento proprio a Giudei, si vedano Gualandi G., Intorno ad una legge attribuita a Valentiniano I, in Studi De Francisci 3, Napoli 1956, pp. 175-225; DE BONFILS G.. Legi-slazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti, in BIDR 90 (1987), pp. 389-438; Rabello A.M., Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ec-clesiastiche e giuridiche, II [Monografie del Vocabolario di Giustiniano, 2], Milano 1988; De Bonfils G., CTh.3.1.5. e la politica ebraica di Teodosio I, in BIDR 92-93 (1989-1990), pp. 47-72; Barone Adesi G., L’età della Lex Dei [Univ. Roma - ‘La Sapienza’ - Pubbl. Ist. Dir. Rom. e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, 71], Napoli 1992; De Bonfils G., Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto [Pubbl. Fac. Giur. Univ. di Bari, 103], Bari 1992.
16 CTh.3.12.1. IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. ad provinciales Foenices. Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur. DAT. PRID. KAL. APR. ANTIOCHIAE CONSTANTIO III ET CONSTANTE II AA. CONSS.
INTERPRETATIO. Quicumque hominum cum fratris filia vel sororis incestam coniunc-tionem se habere crediderit, capitale periculum se noverit incursurum. (anno 342).
Sulla repressione delle unioni incestuose, si vedano Guarino A., Studi sull’incestum, in ZSS 63 (1943), pp. 175-267; Yaron R., Duabus sororibus coniunctio, in RIDA. 10 (1963), pp. 115-136; De Bonfils G., CTh. 3.1.5 e la politica ebraica cit.; Puliatti S., Incesti Crimina. Re-gime giuridico da Augusto a Giustiniano, Milano 2001; Sandirocco L., Matrimoni vietati. Unioni incestuose doppie miste nel Tardoantico, Villamagna (CH) 2011.
17 CTh.3.12.2. [=BREV.3.12.1]. IMPP. CONSTANTINUS ET CONSTANS AA. ET IULIANUS CAESAR AD VOLUSIANUM VICARIUM URBIS. Etsi licitum veteres cre-diderunt, nuptiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitum etiam, post mortem mulieris aut
GIOVANNA MANCINI
8
no dovrà ribadire la norma18, così come Arcadio e Onorio dovranno ripro-porre una serie di divieti: quello di sposare la figlia del proprio fratello o della propria sorella19, la consobrina e la moglie del fratello, anche se la sanzione non sarà più penale – la morte – ma civile, con la negazione del conubium – e conseguente condizione di illegittimi dei figli – l’infamia, la privazione della capacità di testare e donare20.
divortium contrahere cum eiusdem sorore coniugium, abstineant huiusmodi nuptiis universi, nec aestiment, posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari: nam spurios esse convenit, qui nascentur. DAT. PRID. KAL. MAI. ROMA, ARBETIONE ET LOLLIANO COSS.
Interpretatio. Fratris uxorem ducendi vel uni viro duas sorores habendi penitus licentia denegatur; nam ex tali coniugio procreati filii legitimi non habentur.
Il divieto entra in evidente contraddizione con l’obbligo sancito, al contrario, dalle norme giudaiche di sposare la moglie del fratello morto; sul punto v. De Bonfils cit. passim.
18 C. 5.5.5. VALENT./ THEOD./ ARCAD. Fratris uxorem ducendi vel duabus sororibus coniungendi penitus licentiam submovemus, nec dissoluto quocumque modo coniugio. VA-LENTIN. THEODOS. ET ARCAD. AAA. CYNEGIO PP. D... K. DEC. CONSTANTINO-POLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS. (anno 393).
19 Zenone, dopo la riforma di brevissima durata di Basilisco, riproporrà il divieto: C.5.5.9. Zeno. Ab incestis nuptiis universi qui nostro reguntur imperio noverint temperan-dum. Nam rescripta quoque omnia vel pragmaticas formas aut constitutiones impias, quae qui-busdam personis tyrannidis tempore permiserunt scelesto contubernio matrimonii nomen im-ponere, ut fratris filiam vel sororis et eam, quae cum fratre quondam nuptiali iure habitaverat, uxorem legitimam turpissimo consortio liceret amplecti, aut ut alia huiusmodi committerentur, viribus carere decernimus, ne dissimulatione culpabili nefanda licentia roboretur. Zeno A. Se-bastiano PP. (anno 476-484).
20 CTh.3.12.3. [=BREV.3.12.2]. IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. EUTYCHIANO PF. P. Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve vel eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nuptiis funestarit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptionis, careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates: sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur, ut nihil prorsus praedictis, ne per interpositam quidem personam, vel donet superstes vel mortuus derelinquat. Dos, si qua forte solenniter aut data aut dicta aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci no-stri commodis cedat. Testamento suo extraneis nihil derelinquat, sed sive testato sive intestato legibus ei et iure succedant, si qui forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de descendentibus filius, filia, nepos, neptis, pronepos, proneptis, de ascendentibus pater, mater, avus, avia, de latere frater, soror, patruus, amita. Testandi sane ita demum habeat facultatem, ut his tantum personis pro iuris ac legum, quod voluerit, arbitrio relinquat, quas succedere im-perialis praecepti tenore mandavimus; ita tamen, ut hereditate defuncti penitus arceatur, si quis ex his, quos memoravimus, in contrahendis incestis nuptiis participatum atque consilium iniisse monstrabitur, successuro in locum illius, qui post eum gradum proximus invenitur. Id sane, quod de viris cavimus, etiam de feminis, quae praedictorum se consortiis commaculave-rint, custodiatur. Memoratis vero personis non exstantibus, fisco locus pateat. Ad cuius legis nexum et condicionem pertinere iubemus, si qui forte iam dudum ante promulgationem huiu-sce legis illicitis memoratarum nuptiarum sceleribus commaculati quoquo modo latere potue-runt. DAT. VI. ID. DEC. CONSTANTINOPOLI, ARCADIO IV. ET HONORIO III. AA. COSS.
INTERPRETATIO. Post prioris legis sententiam, quae de talibus personis lata est, id praecipit observari, ut districtione legis, supplicio et proscriptione liberi, quisque ille aut sororis
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
9
La coppia imperiale immediatamente successiva – Onorio e Teodosio – deve, però, a quasi cent’anni dalla prima proposizione del divieto da parte di Costantino, ribadire nuovamente la mancanza di conubium con la vedo-va del proprio fratello, estendendola anche al caso di vedovo della sorella21. E il costume di sposare la vedova del fratello morto era tanto fortemente radicato presso le popolazioni orientali da far sì che, nel 475 d. C., dopo oltre cent’anni, l’imperatore Zenone dovesse tornare a ribadire l’invalidità insanabile di matrimoni di tale genere22.
2.2. Dall’estraneità alla segregazione Per altro verso, la privazione della cittadinanza – che nell’età preceden-
te implicava l’esilio dal territorio della città –, divenuta pena nella forma della deportatio, comporta, oltre alla limitazione della libertà di movimento
aut fratris filiam aut certe ulterioris gradus consobrinam aut fratris uxorem sceleratis sibi nup-tiis iunxerit, huic poenae subiaceat, ut de tali consortio separetur. Atque etiam si filios habue-rint, non habeantur legitimi nec heredes, sed infamia sint notatae utrimque personae, ita ut possidere tantum proprias facultates principis beneficio videantur. Ceterum nullum praesu-mant subire contractum, donandi atque testandi facultate summota: sed nec ipsis feminis, quas taliter sortiti sunt, aliquid conferant, et si etiam aliquid tempore nuptiarum sibi dederint, revo-cetur ad fiscum: aut etiamsi filios habuerint, non per suppositam aut per aliam personam aut per commenticiam donationem ad illos quicquam ex eorum facultate perveniat, sed ipsis mor-tuis ad legitimos heredes, quoscumque* gradus admittit, usque ad certum originis locum ab in-testato ipsi succedunt. Testandi etiam eis in his tantum personis, quibus lege concessum est, permissa potestas, ita ut ex his, quos elegerint, scribant heredes, ita tamen, ut, si qui in tali consortio consensum cum his habuisse docentur, hereditate exclusi, aliis in proximo gradu ve-nientibus locum faciant: nam si desunt personae propinquorum, quos ad successionem vocat lex, tunc in eorum facultatibus fiscus accedat.
21 CTh.3.12.4. [=BREV.3.12.3]. IMPP. HONOR. ET THEODOS. AA. AURELIANO II. PF. P. Tanquam incestum commiserit, habeatur, qui post prioris coniugis amissionem soro-rem eius in matrimonium proprium crediderit sortiendam; pari ac simili ratione etiam, si qua post interitum mariti in germani eius nuptias crediderit adspirandum: illo sine dubio insecutu-ro, quod ex hoc contubernio nec filii legitimi habebuntur, nec in sacris patris erunt, nec pater-nam ut sui suscipient hereditatem. DAT. XVII. KAL. IUN. CONSTANTINOPOLI, DD. NN. HONORIO X. ET THEODOS. VI. AA. COSS.
Interpretatio. Quaecumque mulier sororis suae maritum post illius mortem acceperit, vel si quis ex viris, mortua uxore, sororem eius aliis nuptiis sibi coniunxerit, noverint tali consor-tio se esse notabiles, et filii, qui exinde fuerint procreati, ex successione excluduntur, nec inter filios habebuntur.
22 C.5.5.8. Zeno. Licet quidam Aegyptiorum idcirco mortuorum fratrum sibi coniuges ma-trimonio copulaverint, quod post illorum mortem mansisse virgines dicebantur, arbitrati scili-cet, quod certis legum conditoribus placuit, cum corpore non convenerint, nuptias re non videri contractas, et huiusmodi conubia tunc temporis celebrata firmata sunt, tamen praesenti lege sancimus, si quae huiusmodi nuptiae contractae fuerint, earumque contractores et ex his pro-genitos antiquarum legum tenori subiacere nec ad exemplum aegyptiorum, de quibus superius dictum est, eas videri fuisse firmatas vel esse firmandas. ZENO A. EPINICO PP. D. K. SEPT. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LEONIS IUNIORIS. (anno 475).
GIOVANNA MANCINI
10
nel territorio, proprio l’esclusione dalla titolarità di rapporti giuridici con-nessi al diritto di famiglia, restando al deportato accessibili solo quelli rego-lati dallo ius gentium. In un oikuomene abitato da un unico populus, l’esclusione da esso non può assumere altra forma di quella della segrega-zione dal consorzio umano con la privazione dei diritti civili e confisca dei beni. Accanto a questa ne appare, però, come vedremo, un’altra: la segre-gazione all’interno di un corpus, di una parte organizzata e isolata della po-polazione romana.
La produzione normativa imperiale tardoantica non si limita, infatti, a garantire l’applicazione del diritto romano da parte dei nuovi cives: ap-paiono, anche, nuovi divieti e nuove limitazioni della libertà di scelta “ma-trimoniale”, che assumono, spesso, connotazione non meramente civilisti-ca, ma penale.
E se le limitazioni del conubium tra i popoli assoggettati, funzionali alla politica romana di dominio, avevano, tuttavia, fondamento in una norma generale che vedeva nel conubium inter-statuale l’eccezione, non la regola, queste ultime, come vedremo, sembrano rispondere a una logica diversa.
L’età tardoantica segna un momento di chiusura anche su questo ver-sante, con la proposizione di nuove – talora inedite – cause di esclusione dal conubium e il passaggio di quelle su base etnica e religiosa dall’irri-levanza giuridica alla rilevanza penale.
Ciò non accade a caso. Se, come dicevamo, l’unione tra uomo e donna a fini di procreazione è lo strumento necessario per la continuità e la con-servazione del gruppo, le normative a essa relative non possono non ri-spondere più che a logiche di conservazione dell’unità, della specificità cul-turale – mai, comunque, razziale – della società politica stessa, alle esigenze proprie dell’organizzazione sociale e del suo governo.
Tutto ciò in un quadro generalmente segnato, all’interno di una stessa società politica, di uno stesso “Stato”, dalla dipendenza della condizione giuridica del singolo dall’appartenenza all’uno o all’altro dei gruppi nei quali la popolazione e, ove si tratti di un regime democratico, lo stesso po-pulus si articolano: sempre, in primo luogo – e per tutta l’età antica e ben oltre – l’appartenenza alla classe dei liberi o a quella degli schiavi, dei servi, così come – ma con declinazioni differenti a seconda delle società e dei pe-riodi storici – a quella degli uomini o a quella delle donne. A queste distin-zioni fondamentali nel mondo antico, si affianca, con rilevanza variabile a seconda del mutare degli assetti sociali e di quelli istituzionali romani, co-me fonte di disparità di condizione giuridica, l’appartenenza alla classe dei nati liberi, quando non anche a quella di governo, identificata, in quest’età, negli honestiores. Si tratta di scansioni, tutte, possibili e avvertite come “na-turali” nel sentire comune dell’epoca, per l’assenza nell’orizzonte culturale antico di un riferimento, ontologicamente fondato, a quei “diritti del-
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
11
l’uomo”, a quei diritti della personalità23 che postulano la sia pur astratta uguaglianza degli esseri umani, non, certamente, per l’asserita interdipen-denza, ipotizzata da Constant, tra assoluto potere dell’individuo – rectius dell’individuo libero e cittadino – nel corpo collettivo cui appartiene, all’interno del quale esercita la sovranità, e sua assoluta subordinazione a quello stesso corpo24.
2.2.1. Gli antecedenti della prima età del principato Accennavo, in apertura, alla possibile incidenza della stessa “forma di
governo” sulla delineazione degli stessi rapporti giuridici privatistici, Non mi pare, infatti, un caso che, al mutare definitivo della forma di governo repubblicana, con l’instaurazione del principato augusteo, corrisponda un irrigimento normativo sulla capacità matrimoniale delle due classi fonda-mentali quella degli ingenui e quella delle famiglie senatorie che costitisco-no il ceto di governo di quel populus Romanus che, accresciuto demografi-camente dalla concessione nell’89 a. C. della cittadinanza ai popoli italici, è titolare dell’imperium sulle terre e sui popoli del bacino del Mediterraneo che ha sottoposto a sé e tale resta, almeno formalmente, fino al II secolo d. C.
Nelle normative relative al matrimonio, l’uguaglianza – pur se solo formale – dei cives, all’interno della società politica romana, nei rapporti di diritto privato, si incrina, infatti, con l’emanazione delle leges Iulia e Papia Poppaea, che introducono cause di reciproca incapacità legata allo status dei nubendi, sia tra famiglie senatorie e liberti, sia tra ingenui e donne non
23 Cfr. Ferraioli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in La cittadinanza: appar-
tenenza, identtà, diritti, a cura di Zolo D., Bari 1994, p. 265. 24 Constant B., De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, in Oeuvres poli-
tiques, Paris 1874, pp. 258-285 « (La liberté des anciennes) consistait à exercer collective-ment, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté tout entière, à délibérer … à voter … mais en même temps que c’était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admet-taient comme compatible avec cette liberté collective, l’assujettissement complet de l’individu à l’autorité de l’ensemble … Toutes les actions privées sont soumises à une sur-veillance sévère. Rien n’est accordé à l’indépendance individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de l’industrie, ni surtout sous le rapport de la religion … Chez les anciens, l’individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports privés … comme portion du corps collectif, il interroge, destitue… frappe de mort ses magistrats et ses supérieurs, comme soumis au corps collectif, il peut à son tour être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort, par la volonté discrétionnaire de l’ensemble dont il fait partie … Les anciens, lorsqu’ils sacrifiaient l’indépendance (individuelle) aux droits politiques, sacrifiaient moins pour obtenir plus; … le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d’une même pa-trie ». È un’ottica, quella di Constant, che pure a volerla condividere, è applicabile esclusi-vamente a esperienze limitate, nel tempo e nello spazio, di alcune fasi della città-stato, in Grecia e a Roma.
GIOVANNA MANCINI
12
onorabili; incapacità, mancanza di conubium, che fa sì che l’unione matri-moniale – pur se in presenza degli altri presupposti del matrimonium iu-stum – non produca, in quei casi, l’effetto proprio ed essenziale dello stes-so: l’acquisto della patria potestas sui figli in esso nati e il loro inserimento nella famiglia agnatizia del padre, con le relative conseguenze, in particola-re quelle legate alla successione.
Non è, però, solo l’unione potenzialmente produttiva di effetti sul pia-no giuridico a essere regolata, per escluderli nei casi appena visti.
Il diritto dell’età del principato interviene anche su alcune fattispecie di rapporti sessuali considerati in sé e per sé, per vietarli, elevando a crimina comportamenti in precedenza oggetto di semplice riprovazione sociale o di eventuale repressione nell’ambito della disciplina familiare.
Non ci riferiamo alla lex Iulia de adulteriis, in cui non è rilevante l’appartenenza degli adulteri a gruppi sociali diversi25, ma a un senatocon-sulto, a una legge e a due interventi imperiali in materia di rapporti tra donne e schiavi altrui.
Pochi anni dopo lex Iulia, sotto Claudio, è emanato un Senatus Consul-tum che sanziona con la riduzione in schiavitù la donna libera che, dopo tre ingiunzioni del padrone, avesse continuato un rapporto con uno schia-vo altrui; se, invece il padrone del servus avesse acconsentito all’unione, sa-rebbe rimasta libera, ma i figli nati sarebbero stati di condizione servile26. Il SC introduce, dunque, una nuova fonte – di ius civile – di schiavitù per la donna, in assenza di patto, e, ove questo ci fosse stato, una deroga allo ius gentium per il figlio, deroga abolita, però, successivamente dall’imperatore Adriano, che (Gai Inst. 1.84) “ristabilì la regola di diritto delle genti, in modo che quando la donna rimanga libera, partorisca un libero”.
Per il caso in cui, invece, in assenza di patto e in presenza delle tre dif-fide del dominus, la donna, già in stato di gravidanza, ne fosse divenuta schiava, la giurisprudenza romana si affaticò a cercare una soluzione che salvasse, insieme, la norma dello ius gentium – per la quale il figlio di una schiava nasce schiavo – e la norma di diritto civile che, in costanza di giuste nozze, riconduceva la condizione del figlio al concepimento, non alla nasci-ta, concludendo prevalentemente, anche se non unanimemente, che nel se-
25 Anche se, stando alle Pauli Sententiae, l’uccisione dell’adultero colto in flagrante era
consentita al marito solo se si trattava di infami, prostituti, servi: PS.2.26.4. Maritus in adul-terio deprehensos non alios quam infames et eos qui corpore quaestum faciunt, servos etiam, excepta uxore quam prohibetur, occidere potest. Sulla lex Iulia de adulteriis coercedndis, v. Rizzelli G., La lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium e stu-prum, Lecce 1997.
26 Gai Inst. 1.84. Ecce enim ex senatus consulto Claudiano poterat civis Romana, quae alieno servo volente domino eius coiit, ipsa ex pactione libera permanere, sed servum procreare nam quod inter eam et dominum istius servi convenerit, ex senatus consulto ratum esse iube-tur…
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
13
condo caso il figlio sarebbe nato libero, assumendo lo status dell’ex marito della donna.
Vista l’attenzione posta da Senato e giuristi, l’ipotesi che tali unioni si verificassero non doveva essere certo remota, tanto che a regolare in gene-rale la condizione dei nati da liberi e schiavi, era stata anche emanata una legge che regolava diversamente la condizione dei figli, sia in base al crite-rio dell’ignoranza o della consapevolezza da parte del libero della condi-zione servile del partner, sia in base al sesso: da una serva che si fosse unita a un libero che ne ignorasse lo status, sarebbero nati figli liberi, se maschi, schiave, se femmine; da una libera che avesse concepito da uno schiavo che sapeva tale, i figli, anche nell’inerzia del padrone dello schiavo, sarebbero nati schiavi, pur se partoriti da donna libera27. E se Vespasiano aveva abro-gato la prima norma, riconducendo allo stato servile tutti i figli, conforme-mente alla regola iuris gentium, non l’aveva fatto, però, per la seconda, pur se contraria a quella stessa regola.
Sia SC sia legge, sono vigenti – il primo nella modificazione introdotta da Adriano – alla metà del II secolo e si applicano esclusivamente ai Ro-mani (è lo stesso Gaio a dire che “presso i popoli che non hanno una tale legge, il nato segue per diritto delle genti la condizione della madre e per-ciò è libero”)28; la sola differenza certa è data dall’elemento dell’accordo, come mostra il successivo intervento di Adriano che non abroga la legge in questione, ma solo nel caso dell’accordo ristabilisce la norma iuris gentium che vuole che da una libera nasca un libero29.
Tali norme speciali, che, in deroga allo ius gentium (e a quelli che noi definiremmo “principi generali” dello stesso ordinamento romano) stabili-scono conseguenze gravissime sullo status in funzione della riaffermazione della necessità di rapporti esclusivamente endogamici nel gruppo dei liberi,
27 Gai Inst. 1.85. Item e lege … ex ancilla et libero poterant liberi nasci; nam ea lege cave-
tur, ut si quis cum aliena ancilla, quam credebat liberam esse, coierit, si quidem masculi na-scantur, liberi sint, si vero feminae, ad eum pertineant, cuius mater ancilla fuerit. Sed et in hac specie divus Vespasianus inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omni mo-do, etiamsi masculi nascantur, servi sint eius, cuius et mater fuerit. 86. Sed illa pars eiusdem legis salva est, ut ex libera et servo alieno, quem sciebat servum esse, servi nascantur. Itaque apud quos talis lex non est, qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur et ob id li-ber est.
28 Gai Inst. 1.85, in fine. 29 Successivamente, anche per l’intervento delle ideologie stoica e cristiana, si introdus-
sero norme ispirate al favor libertatis; cfr. D.1.5.5. (Marcianus libro primo institutionum). 2. Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt: sufficit enim liberam fuisse eo tempore quo nasci-tur, licet ancilla concepit. Et e contrario si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci. (Nec interest iustis nuptiis concepit an vulgo), quia non debet ca-lamitas matris nocere ei qui in ventre est. 3. Ex hoc quaesitum est, si ancilla praegnas manu-missa sit, deinde ancilla postea facta aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. Et tamen rectius probatum est liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse.
GIOVANNA MANCINI
14
e con un’articolazione per noi inspiegabile30 saranno, come si vedrà poco sotto, aggravate al nascere del dominato.
Quel che rileva è che la preoccupazione del legislatore – che a questo fine si svincola dalla stessa applicazione di norme da secoli comuni a tutti i popoli del Mediterraneo e da secoli applicate a Roma – è, evidentemente, non quella di esacerbare generalmente la distinzione liberi/servi, ma quella di assicurare, per il solo popolo dominante identità e integrità sociale, rego-lando – per i soli Romani e con una sanzione sul piano civile pari alla mor-te – rapporti che avevano evidentemente assunto una certa diffusione. La donna libera che si unisce a uno schiavo, si sottrae, per ciò stesso, alla fun-zione sociale di dare figli ad altri liberi, a contribuire a conservare la forza demografica del populus Romanus; così come l’uomo libero che instauri un rapporto stabile con una schiava si sottrae a quella di procreare liberi in potestate.
2.3. L’età tardoantica Nel 212 d. C. Antonino Caracalla emana la constitutio con la quale dà
omnibus peregrinis qui in orbe terrarum sunt civitatem Romanorum31. Guardata dal punto di vista dei diritti dell’individuo, la Constitutio An-
toniniana segna, in apparenza, il punto di massima integrazione di popoli diversi, con l’attribuzione di diritti eguali a ogni individuo, se libero, a pre-scindere dall’originaria appartenenza; in apparenza, però. Se, infatti, scompare la dicotomia tra popolo (romano)/dominatore e popoli dominati, nascono e si consolidano nuovi privilegi e nuove limitazioni, connessi, tutti, a un particolare status individuale acquisito alla nascita o per vicende suc-cessive.
La società romana si frantuma al suo interno in gruppi sociali che ri-producono in fome nuove le medesime dinamiche di esclusione dell’es-terno al gruppo, in precedenza operanti nei rapporti tra populi.
A ciò si deve aggiungere che il rapporto con i popoli che vivono ai con-fini dell’impero romano, in precedenza marginale, si intensifica e, insieme, si sostanzia, sul piano giuridico, di norme finalizzate a riproporre nei loro confronti, con nuova rigidità, lo schema di esclusione dell’estraneo al gruppo politico, anche una volta che il popolo stesso sia stato accolto nei confini dell’impero.
Da questo punto di vista, il periodo succcessivo all’emanazione della Constitutio Antoniniana presenta particolare interesse perché permette di
30 Quanto su di essa – e più in generale sul regime di appartenenza al pater, ove certo,
dei figli nati dalla donna – possano aver influito le teorie all’epoca correnti su una fisiologia della riproduzione che attribuiva alla femmina un ruolo di mera incubatrice del seme ma-schile, non è questo il luogo per prenderlo in esame.
31 F.I.R.A. I, Florentiae 1968, p. 448.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
15
verificare la persistenza di – e il nascere di nuovi – divieti, limiti, sanzioni, proprio nel momento in cui viene meno il presupposto sul quale si era fon-data la teorica del conubium come prerogativa generalmente connessa all’appartenenza al medesimo populus e capacità solo eccezionalmente ri-conosciuta agli estranei, generalmente in via pattizia o di concessione unila-terale del popolo dominante32.
Proprio in materia matrimoniale, infatti, l’unificazione in un’unica cit-tadinanza dei popoli sottoposti al potere dell’imperatore romano non pro-duce l’effetto “naturale”. Si susseguono, al contrario, da Costantino in avanti leges imperiali recanti divieti matrimoniali tra appartenenti a gruppi non più politici, ma sociali diversi, ben oltre le limitazioni già vigenti in ri-ferimento a senatori e ingenui.
Vediamone i casi. 2.3.1. Iudaei Emerge, in particolare, un’inedita causa, l’appartenenza a un culto reli-
gioso, introdotta da Costante33 relativamente alle addette alle fabbriche imperiali:
CT.16.8.6. IMP. CONSTANTIUS A. Ad Evagrium. Post alia. Quod ad mulieres
pertinet, quas iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas, placet easdem restitui gynaeceo idque in reliquum observari, ne christianas
32 È vero – vicenda dei plebeii a parte – che eccezioni erano state introdotte già con le
leggi Iuliae. Esse, però, configuravano, appunto delle eccezioni e riguardavano esclusiva-mente la classe di governo, in atto o anche potenziale, la conservazione della sua coesione. Il modificato orientamento sugli effetti delle manomissioni – di cui non possiamo qui occu-parci – con la creazione di vincoli alle manumissiones iustae e la creazione di status partico-lari, presumibilmente per la maggior parte dei manomessi, trova la sua giustificazione nella consistenza demografica assunta dal populus Romanus, ancora formalmente protagonista della vita costituzionale romana.
33 Questa costitutio, assieme a quella che vedremo poco avanti è oggetto di approfondi-ta analisi da De Bonfils G., Legislazione ed ebrei nel IV secolo. cit.; v. Bianchini M., Disparità di culto e matrimonio: orientamenti del pensiero cristiano e della legislazione imperiale nel IV secolo d. C., in Serta Historica Antiqua, Roma 1986, pp. 233-246; Rabello A.M., Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo), in Atti Accademia Romanistica Costantiniana, Napoli 1988, pp. 213-224, con inte-ressanti richiami della parallela normativa conciliare coeva (Concilio di Elvira, canone 16), sottolinenado, altresì il fattore economico oltre che religioso che, in questo caso, guida la scelta legislativa (215-216); De Bonfils G., Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo. cit.; Lucrezi F., CTh. 16.9.2: diritto romano cristiano e antisemitismo, in Labeo 40 (1994), pp. 220-234; De Bonfils G., La ‘terminologia matrimoniale’ di Costanzo II: uso della lingua e adattamento politico, in Labeo 42 (1996), pp. 254 ss.
Se il termne consortium alluda a matrimonio o a concubinato, non è, ai nostri fini, mol-to rilevante.
GIOVANNA MANCINI
16
mulieres suis iungant flagitiis vel, si hoc fecerint, capitali periculo subiugentur, DAT. ID. AUG. CONSTANTIO A. II CONS. (anno 339).
L’esclusione del conubium tra Iudaei e Christiani assumerà, poi, con
Valentiniano, quel carattere generale che conserverà in età giustinianea34: CT.3.7.2. [=BREV.3.7.2] IMPPP. VALENTIN., THEODOS. ET ARCAD.
AAA. CYNEGIO PF. P. Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huius-modi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accu-sandum publicis quoque vocibus relaxata. Dat. Prid. Id. Mart. Thessalonica, Theodos. A. II. et Cynegio Coss.35 (anno 388)
Il divieto, che adegua la normativa imperiale ai canoni conciliari36, è,
tuttavia, estraneo alle cause che fino da allora avevano determinato nell’ordinamento romano, la carenza di conubium, legate alla parentela, al-lo status sociale ma mai, fino ad allora, alla religione.
Altre norme avevano, però, contribuito a costruire la comunità giudai-ca come gruppo separato all’interno dell’impero, sia riconoscendone, in parte, l’autonomia giurisdizionale, sia isolandola dal “corpo” dell’impero.
Gli Iudaei sono oggetto di limitazioni nella capacità successoria, indivi-duale e corporativa, già dall’età di Caracalla37. A questa cui si affiancano successivamente il divieto alla comunità ebraica di irrogare sanzioni, pena la morte per vivicombustione, per il passaggio alla religione cristiana da parte di Ebrei38, nonché quello di circoncisione di uno schiavo cristiano,
34 Cfr. C.1.9.6. VALENT./ THEOD./ ARCAD. Ne quis christianam mulierem in matri-
monium Iudaeus accipiat neque Iudaeae christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accu-sandum publicis quoque vocibus relaxata. VALENTIN. THEODOS. ET ARCAD. AAA. CYNEGIO PP. D. PRID. ID. MART. THESSALONICA THEODOSIO A. II ET CYNEGIO CONSS. (anno 388).
Alla bibliografia indicata alla nota precedente, si aggiungano: De Bonfils G., CTh. 3.1.5 e la politica ebraica di Teodosio I, in BIDR. 92-93 (1989-1990, pp. 47-72 e Watson A., Reli-gious and Gender Discriminator: St. Ambrose and the Valentiniani, in SDHI 61 (1995), pp. 313 ss.
35 La constitutio è del 338; questa è la sua Interpretatio nel CTh.: Legis huius severitate prohibetur, ut nec Iudaeus christianae matrimonio utatur, nec christianus homo Iudaeam uxorem accipiat. Quod si aliqui contra vetitum se tali coniunctioni miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri damnantur, persequendos, et accusationem huius criminis non solum pro-pinquis, sed etiam ad persequendum omnibus esse permissam.
36 Il canone 16 del concilio di Elvira. 37 C.1.9.1., ANT. Quod Cornelia Salvia universitati Iudaeorum, qui in Antiochensium ci-
vitate constituti sunt, legavit, peti non potest. ANT. A. CLAUDIO TRYPHONINO. D. PRID. K. IUL. ANTONINO A. IIII ET BALBINO CONSS. (anno 213).
38 C.1.9.3. CONST. Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad dei cultum respexerit ,
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
17
pena la bonorum proscriptio e l’esilio perpetuo39. E, se pure si riconosce lo-ro il diritto di culto, anche il Sabato40, sono, però, loro interdette le digni-tà41.
Nel corso del tardoantico, si delinea complessivamente per loro una si-tuazione di separatezza senza autonomia, in una politica che fu portata a compimento da Giustiniano, con la negazione di ogni forma di competenza giurisdizionale, eccetto quella religiosa. Se infatti, il CTh. riporta una costi-tuzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio – norma confermata dal legi-slatore visigoto – che permette, ove entrambe le parti consentano, lo svol-gimento di giudizi in materia non solo religiosa, ma anche civile tra Ebrei secondo le leggi proprie42, la medesina costituzione è riportata nel Codex di Giustinano in un testo che, per l’elisione di un “non” preclude tale pos-sibilità43.
saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit attemptare, mox flam-mis dedendus est et cum omnibus suis participibus concremandus. CONST. A. AD EUAGRIUM PP. D. XV K. NOV. MURGILLO CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. (anno 315).
39 C.1.9.16. HONOR./ THEOD. Iudaei et bonorum proscriptione et perpetuo exilio damnabuntur, si nostrae fidei hominem circumcidisse eos vel circumcidendum mandasse con-stiterit. HONOR. ET THEODOS. AA. ASCLEPIODOTO PP. D. V ID. APRIL. CON-STANTINOPOLI ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS. (anno 423).
A questi si aggiungano il divieto di diseredare figli e nipoti che si siano fatti cristiani (CTh.16.8.28. Teodosio e Valentiniano, anno 426), quello di acquistare (Costantino, CTh.16.9.1.) – e, come si è visto, circoncidere (CTh.16.9.2. Costanzo anno 339) – schiavi cristiani, ma anche di altre religioni. Onorio e Teodosio, nel 415, concederanno la possibili-tà di acquistare schiavi cristiani, purché si permetta loro di conservare la religione cristiana (CTh.16.9.3.); anche se due anni dopo Onorio ristabilirà il divieto (CTh.16.9.a), ribadito nel 423 (CTh.16.9.5.)
40 C.1.9.14pr.; C.1.9.13, entrambe di Onorio e Teodosio, del 412. 41 C.1.9.18. THEOD./ VALENT. anno 439. 42 CTh.2.1.10. [=BREV.2.1.10]. IIDEM AA. AD EUTYCHIANUM PF. P. Iudaei Ro-
mano et communi iure viventes in his causis, quae non tam ad superstitionem eorum, quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant solenni more iudicia omnesque Romanis legibus infe-rant et excipiant actiones: postremo sub legibus nostris sint. Sane si qui per compromissum, ad similitudinem arbitrorum, apud iudaeos vel patriarchas ex consensu partium, in civili dumta-xat negotio, putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur: eorum etiam sententias provinciarum iudices exsequantur, tanquam ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi. Dat. III. Non. Febr. Constantinopoli, Honorio A. Iv. Et Eutychiano V.C. Coss.
Interpretatio. Iudaei omnes, qui Romani esse noscuntur, hoc solum apud religionis suae maiores agant, quod ad religionis eorum pertinet disciplinam, ita ut inter se, quae sunt hebraeis legibus statuta, custodiant. Alia vero negotia, quae nostris legibus continentur et ad forum respiciunt, apud iudicem provinciae eo, quo omnes, iure confligant. Sane si apud maio-res legis suae consentientes ambae partes, de solo tamen civili negotio audiri voluerint, quod, interveniente compromisso, arbitrali iudicio terminatur, tale sit, quasi ex praecepto iudicis fue-rit definitum.
43 C.1.9.8pr. Grat./ Valent./ Theod. Iudaei Romano communi iure viventes in his causis,
GIOVANNA MANCINI
18
2.2.4.2. Gentiles Altre norme sono emanate, sempre tra la fine del IV e gli inizi del V se-
colo, finalizzate a reprimere – ancora con pena di morte – le unioni matri-moniali tra gentiles44 e provinciales. Col termine gentiles sono designati45 i barbari ammessi a vivere entro dell’impero sia per controllarne i confini46, sia per coltivare terre lasciate incolte dai provinciales47. Insediamenti signi-
quae tam ad superstitionem eorum quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant sollemni more iudicia omnesque romanis legibus conferant et excipiant actiones. 1. Si qui vero ex his communi pactione ad similitudinem arbitrorum apud iudaeos in civili dumtaxat negotio puta-verint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur. 2. Eorum etiam senten-tias iudices exsequantur, tamquam ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi. Grat. Va-lentin. et Theodos. AAA. Eutychiano pp. d. III Non. Febr. Constantinopoli Honorio A. IIII et Eutychiano conss. (a. 398). Cfr: Berger A., CTh. 2, 1, 10 and CI. 1,9,8 pr. A perfect example of an interpolation through cancellation of a ‘non’, in IVRA 10 (1959), pp. 13-23.
44 Nelle nostre fonti, il termine gentiles riveste un triplice significato: quello storico, di appartenenti alle antiche gentes romane; quello religioso, di estranei alla chiesa cattolica; quello, infine, politico, di barbari insediatisi nel territorio romano. In relazione a questi ul-timi due sono emanate norme speciali anche in materia matrimoniale.
45 Come già indicava Gothofredus nel commentario a questa lex: Gentiles erant Barbari, qui Romanis militabant, quique ad Romanos transierunt, et in leges Romanas recepti, seu su-scepti fuerant deditione… di essi sono attestati gentiles Sueuos, Gentiles Sarmatas et Gentiles Taisalos. Quod potremum... testatur per varias Imperii Rom. partes sive provincias dispersi fuere: per Africam, scilicet ut ostendit d. lex1 infr. de terris limitan e d. lex 62 infr, de appellat. per Galliam item, et per Italiam… Erant autem hi gentiles per varias civitate et castra dispersi circa curam fossati et tuitionem limitis occupati. Ideoque quaedam terrarum spatia, seu quidam terrarum modus his administrandus er colendus concedebatur (de terris limitaneis 9), quae terrae alicubi Laeticae dicebantur d.l.9 (ubi de his terris et de Laetis dicam plene ut ad l. 12 inf, de veteranis) ut de foederatis et dedititiis (qui idem cum Gentilibus sunt) ad l. 16 inf. de tyronib, item de colonis homologiis ad tit. de patrociniis vicorum. Sunt enim hi omnes inter se similes. Caeterum ad Gentiles per Galliarum et Italiae limitem, qua Alemannos et Francos respiciebant disperso, h. l. referenda videri possit. Auctor enim est Ammianus Marcellinus, lib. 28 cap. 5. Theodosium ea tempestate (anno 370) Magistrum equitum Alemannos per Rhetias aggressum pluribus casis, quosuqumque caepisser, ad Italiam iussu principis mississe, ubi ferti-libus agris (forte legendum infertilibus: simili errore, quo apud Vospicum in Aureliano) accep-tis, tributarii Padum tum circumvoluerint. Quod si ita est, tum in suscriptione huius legis Va-lentiniane et Valente III, reponendum fuerit, et sic annus 370 adsignandus vitiosam sane esse liquet.
46 CTh.7.15.1. IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. GAUDENTIO VICARIO AFRICAE. Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis atque fos-sati antiquorum humana fuerant provisione concessa, quoniam comperimus aliquos retinere, si eorum cupiditate vel desiderio retinentur, circa curam fossati tuitionemque limitis studio vel labore noverint serviendum ut illi, quos huic operi antiquitas deputarat. Alioquin sciant haec spatia vel ad gentiles, si potuerint inveniri, vel certe ad veteranos esse non inmerito transfe-renda, ut hac provisione servata fossati limitisque nulla in parte timoris esse possit suspicio. DAT. III KAL. MAI. RAVENNA HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS. (409 APR. 29).
47 Si veda per gli Scyri la legge di Onorio e Teodosio: CTh.5.6.3. IDEM AA. ANTHE-MIO PRAEFECTO PRAETORIO. Scyras barbaram nationem maximis Chunorum, quibus se
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
19
ficativi sono presenti in tutto l’impero, in particolare in Africa, Gallia e nell’Italia settentrionale. Si tratta, però, di un’accoglienza che nega ogni forma di integrazione che non sia quella puramente economica. È proprio in relazione a essi che si ritiene sia stata emanata la constitutio48 di Valenti-niano e Valente che punisce con la morte l’unione tra barbari e donne pro-vinciales e tra barbare e provinciales, ripresa, peraltro, nella stessa lex Ro-mana Visigothorum ed esclusa, invece, nel Codex Iustiniani:
CTh.3.14.1. [=BREV.3.14.1]. IMPP. VALENTIN. ET VALENS AA. AD
THEODOSIUM MAGISTRUM EQUITUM. Nulli provincialium, cuiuscumque* ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincia-lis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur. DAT. V. KAL. IUN. VALENTIN. ET VALENTE AA. COSS.
INTERPRETATIO. Nullus Romanorum barbaram cuiuslibet gentis uxorem habere praesumat, neque
barbarorum coniugiis mulieres romanae in matrimonio coniungantur. Quod si fece-rint, noverint se capitali sententiae subiacere.
Il divieto nasce, presumibilmente, a causa del fatto che tali popolazioni avevano conservato strutture politiche autonome, pur se minime, e ciò era avvertito dal governo romano come fonte permanente di pericolo49.
Così come abbiamo visto per gli Iudaei, anche i gentiles sono destinata-ri di norme speciali, che limitano capacità generalmente riconosciute ai
coniunxerunt, copiis fusis imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex prae-dicto genere hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant susceptos non alio iure quam colonatus apud se futuros nullique licere ex hoc genere colonorum ab eo, cui semel ad-tributi fuerint, vel fraude aliquem abducere vel fugientem suscipere, poena proposita, quae re-cipientes alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos insequitur. Opera autem eorum terrarum domini libera utantur ac nullus sub acta peraequatione vel censui ... acent nullique liceat velut donatos eos a iure census in servitutem trahere urbanisve obsequiis addicere, licet intra biennium suscipientibus liceat pro rei frumentariae angustiis in quibuslibet provinciis transmarinis tantummodo eos retinere et postea in sedes perpetuas collocare, a partibus Thra-ciae vel Illyrici habitatione eorum penitus prohibenda et intra quinquennium dumtaxat intra eiusdem provinciae fines eorum traductione, prout libuerit, concedenda, iuniorum quoque in-tra praedictos viginti annos praebitione cessante. Ita ut per libellos sedem tuam adeuntibus his qui voluerint per transmarinas provincias eorum distributio fiat. DAT. PRID. ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI HONORIO VIII ET THEODOSIO III CONSS. (anno 409).
48 Soraci R., Ricerche sui conubia tra Romani e Germani nei secoli IV-VI, 2a ed. amplia-ta, Catania, Muglia, 1974; Bianchini M., Ancora in tema di unioni tra barbari e romani, in Atti Accademia Romanistica Costantiniana, Napoli 1988, pp. 225-249. La constitutio è ripre-sa nel Breviarium per regolare, presumibilmente, in termini di separatezza – mutate le posi-zioni di esercizio del potere politico – il rapporto matrimoniale tra barbari e romani.
49 Sulla condizione dei barbari accolti nel territorio dell’impero, si veda Mirković M., The later roman colonate and freedom, Philadelphia 1997, pp. 85 ss., che sottolinea il fatto che tali popolazioni mantenessero i loro capi.
GIOVANNA MANCINI
20
provinciales, come per il caso dell’impossibilità, per un barbaro, di riscatta-re il figlio venduto50, mentre il legame alla terra51 è condizione condivisa con altri gruppi di popolazione.
Con l’emanazione di CTh.3.14.1, si riproducono sostanzialmente i meccanismi di estraneità, segregazione su base etnica, all’interno di un ter-ritorio controllato da un medesimo potere politico. È, in qualche misura, un ritorno al passato, che ha smarrito, però, ogni motivazione fondata sul
50 FV.34 AUGG. ET CAESS. FLAVIAE APRILLAE. Cum profitearis te certa quantitate
mancipium ex sanguine comparasse, cuius pretium te exsolvisse dicis et instrumentis esse fir-matum, hoc a nobis iam olim praescriptum est, quod, si voluerit liberum suum reciperare, tunc in eius locum mancipium domino dare aut pretium quo valuisset numeraret. Etiamnunc, si a suis parentibus certo pretio comparasti, ius dominii possidere te existimamus. Nullum autem ex gentilibus liberum adprobari licet. SUBSCR. XII KAL. AUG. CONSTANTINO AUG. III CONS. Cfr. Lorenzi C., Si quis a sanguine infantem comparaverit. Sul commercio di figli nel tardo impero, Perugia 2003.
51 CTh.11.24.6pr. IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. AURELIANO PRAE-FECTO PRAETORIO. Valerii, Theodori et Tharsacii examinatio conticiscat, illis dumtaxat sub augustaliano iudicio pulsandis, qui ex Caesarii et Attici consulatu possessiones sub patro-cinio possidere coeperunt. Quos tamen omnes functionibus publicis obsecundare censemus, ut patronorum nomen extinctum penitus iudicetur. Possessiones autem athuc in suo statu consti-tutae penes priores possessores residebunt, si pro antiquitate census functiones publicas et liturgos, quos homologi coloni praestare noscuntur, pro rata sunt absque dubio cognituri. 1. Metrocomiae vero in publico iure et integro perdurabunt, nec quisquam eas vel aliquid in his possidere temptaverit, nisi qui ante consulatum praefinitum coeperit procul dubio possidere, exceptis convicanis, quibus pensitanda pro fortunae condicione negare non possunt. 2. Et quicumque in ipsis vicis terrulas contra morem fertiles possederunt, pro rata possessionis suae glebam inutilem et collationem eius et munera recusent. 3. Ii sane, qui vicis quibus adscripti sunt derelictis, et qui homologi more gentilicio nuncupantur, ad alios seu vicos seu dominos transierunt, ad sedem desolati ruris constrictis detentatoribus redire cogantur, qui si exsequen-da protraxerint, ad functiones eorum teneantur obnoxii et dominis restituant, quae pro his exsoluta constiterit. 4. Et in earum metrocomiarum locum, quas temporis lapsus vel destituit vel viribus vacuavit, ex florentibus aliae subrogentur. 5. Arurae quoque et possessiones, quas curiales quolibet pacto publicatis aput acta provincialia desideriis suis vel reliquerunt vel pos-sidere alios permiserunt, penes eos, qui eas excoluerunt et functiones publicas recognoscunt, firmiter perdurabunt, nullam habentibus curialibus copiam repetendi. 6. Quidquid autem in tempus usque dispositionis habitae a viro illustri decessore sublimitatis tuae ecclesiae venerabi-les, id est constantinopolitana atque alexandrina possedisse deteguntur, id pro intuitu reli-gionis ab his praecipimus firmiter retineri, sub ea videlicet sorte, ut in futurum functiones omnes, quas metrocomiae debent et publici vici pro antiquae capitationis professione debent, sciant procul dubio subeundas. 7. Nequaquam cefalaeotis, irenarchis, logografis chomatum et ceteris liturgis sub quolibet patrocinii nomine publicis functionibus denegatis, nisi quid ex his quae exigenda sunt vel neglegentia vel contemptus distulerit. 8. Metrocomias possidere nostro beneficio meruerunt, et publicos vicos committere compellantur. DAT. III NON. DECEMB. HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS. (anno 415). Sulla costituzione v. Bellomo M., Il diritto di prelazione nel Basso Impero, in Annali storia del diritto 2 (1958), pp. 187-228; Günther R., Coloni liberi und coloni originarii, in Klio 49 (1967), pp. 267-270; Solidoro Maruotti L., Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici, giuristi, impera-tori, Napoli 1989; Giglio S., Il tardo impero d’Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, pa-trocinio, giurisdizione penale, Napoli 1990.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
21
principio della separatezza “statuale”, per attingere unicamente a quella della pericolosità di commistione con gruppi che, anche quando accolti e formalmente sottoposti, mantengono pur sempre una propria organizza-zione interna e costituiscono, perciò stesso, un pericolo per le deboli capa-cità di controllo del potere politico romano.
2.3.3. Altre cause inedite di repressione di unioni paramatrimoniali Prima ancora, però, che l’insieme di norme sopra esaminate fosse stato
emanato, troviamo, già in età costantiniana, interventi tesi a reprimere, sul piano penale, unioni matrimoniali – in alcuni casi paramatrimoniali – in dipendenza dell’appartenenza dei due soggetti a gruppi sociali differenti; gruppi che sono essi stessi creati e definiti da specifiche discipline normati-ve.
Iniziamo dalle unioni paramatrimoniali, quelle in cui la mancanza del conubium è, nelle esperienze antiche, generale e incontrovertibile.
Se tra liberi e servi non può, ovviamente, darsi conubium, unioni di fat-to tra appartenenti alle due categorie avevano, fino all’età di Costantino, costituito oggetto di repressione penale solo nel caso in cui una donna libe-ra si fosse unita a uno schiavo altrui, mentre un comportamento analogo da parte di un libero avrebbe comportato come unica conseguenza l’impos-sibilità di avere come liberi in potestate i figli nati dall’unione con la schia-va.
Con Costantino assistiamo, insieme, a un inasprimento delle sanzioni per il caso in cui sia una libera ad avere un rapporto paramatrimoniale con un servus, anche di sua proprietà, e alla repressione penale delle stesse unioni di liberi con servae, se i primi appartengano a una determinato ceto.
L’imperatore aggrava, infatti, le sanzioni del SC Claudianum, cui ab-biamo già accennato: la donna che si sia unita a uno schiavo altrui è co-munque ridotta – anche in mancanza delle denuntiationes del proprietario – allo stato servile e i figli nascono schiavi52. Anche la relazione – in prece-denza giuridicamente irrilevante – dell’ingenua con un proprio schiavo è sanzionata, dallo stesso imperatore, in questo caso con la condanna a mor-te. La legge si applica retroattivamente, anche se in una pena limitata alla relegatio dalla provincia53; i figli nati dall’unione sono, però, ridotti a una
52 CTh.4.12.1, del 314 e CTh.4.12.4, del 331; cfr J. Evans Grubbs, Law and Family cit.,
264 ss. Costantino fa, comunque, eccezione per le unioni con gli schiavi del fisco: la madre resterà libera, anche se i figli nasceranno latini Iuniani. Il regime del Claudiano sarà ripristi-nato da Giuliano nel 362 (CTh.4.12.5), che manterrà, comunque, il privilegio per le unioni con servi fiscales.
53 CTh.9.9.1. [=Brev.9.6.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone,
GIOVANNA MANCINI
22
condizione di nuda libertas, privati di ogni dignitas, ed esclusi da ogni for-ma di successione ereditaria dalla madre, spettando la sua successione inte-stata a eventuali figli legittimi, o i parenti54.
sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena immi-neat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris socia-tum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis, et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictae successionis heredes. 6. Post legem en-im hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, con-gressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. Iv. Kal. Iun. Serdicae, Constantino A.VII et Constantio C. Coss.
Sul tenore e le finalità dell’originale legge costantiniana, v. Bassanelli Sommariva G., L’uso delle rubriche da parte dei commisari teodosiani, in Atti Accademia Romanistica Co-stantiniana XIV, Napoli 1998, pp. 227 ss.
Sulla norma transitoria in materia di successione dei figli, v. P. Voci, Il diritto ereditario romano Il diritto ereditario romano nell’età del tardo impero 1. Il IV secolo. Prima parte, in IURA 29 (1978), pp. 28-29.
54 CTh.9.9.1. [=Brev.9.6.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. Si qua cum ser-vo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena immi-neat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris socia-tum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis, et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictae successionis heredes. 6. Post legem en-im hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, con-gressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. Iv. Kal. Iun. Serdicae, Constantino A. VII et Constantio C. Coss. Sul punto, v. Navarra M.L., A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana, in AARC 8 (1990), 429 ss., S. Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milano 1996, 69 e nt.94, Evans Grubbs J., Law and Family cit., 273 ss. Il SC Claudianum – la cui applicazione vedremo estesa anche ai mo-
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
23
Ma non solo di questo si tratta: la stessa libertà, nel campo dei rapporti paramatrimoniali, fino ad allora riservata, almeno sul piano giuridico, ai maschi è, per la prima volta, oggetto di repressione.
Nel 319 d. C. Costantino aveva infatti vietato agli appartenenti alla classe dei curiali i rapporti con schiave altrui55. La pena per la donna era la condanna ad metalla, per il curiale la deportazione e, se sui iuris e senza eredi legittimi la confisca del patrimonio. A quest’ultima era, in parte, sog-getto anche il proprietario della schiava, se consapevole del fatto. La moti-vazione costantiniana è legata alla mancanza di conubium, che fa sì che et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur.
L’imperatore interviene così sulla libertà di scelta paramatrimoniale degli stessi maschi, rendendo penalmente rilevante un comportamento, il concubinato, prima lecito e, in alcuni casi, visto come male minore dalla stessa chiesa, ancora aperta al rapporto tra servi/servae e libere/liberi.
netarii e, forse, ai coloni (v. sotto nt. 79 e 103) – sarà, invece, abrogato da Giustiniano: C.7.24.1.
55 CTh.12.1.6 Patroclo. Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servula-rum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum perso-nis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur. Praecipimus itaque, ne decuriones in gremia potentissimarum domorum libidine ducente confugiant. Si enim decurio clam actoribus atque procuratoribus nescientibus alienae fuerit servae coniunctus, et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus et ipsum decurionem in insulam deportari, bonis eius mobilibus et urbanis mancipiis confiscandis, praediis vero et rusticis mancipiis civi-tati, cuius curialis fuerat, mancipandis, si patria potestate fuerit liberatus nullosque habeat li-beros vel parentes vel etiam propinquos, qui secundum legum ordinem ad eius successionem vocantur. Quod si actores vel procuratores loci, in quo flagitium admissum est, fuerunt conscii vel compertum facinus prodere noluerunt, metallo eos convenit implicari. Si vero dominus hoc fieri permisit vel postea cognitum celavit, si quidem in agro id factum est, fundus cum manci-piis et pecoribus ceterisque rebus, quae cultui rustico sustinentur, fisci viribus vindicetur; si vero in civitate id factum est, dimidiam bonorum omnium partem praecipimus confiscari, poenam augentes, quoniam intra domesticos parietes scelus admissum est, quod noluit mox cognitum publicare. Igitur si legis latae die repperietur quisquam patrimonium suum alienasse atque in dominum servulae contulisse, ordini liceat diligenter inquirere, ut ita rei publicae civitatis quod de facultatibus supra dicti fuerit deminutum, in pecunia sarciatur. Dat. Kal. Iul. Aquileiae Constantino A. V et Licinio C. Conss. (1 iul. 319 ). Su questa costituzione, che, in un testo modificato e in diversa collocazione sistematica, è presente anche nel Codex Iusti-nianus (C.5.5.3.), v. Gaudemet J., Constantin et les curies municipales, in Iura 2 (1951), 74-75, nonché Voci P., Il diritto ereditario romano cit., 28 e Gaudemet J., Justum matrimonium, in RIDA 3 (1950), 309-366, 351 ss.
Anche questo intervento di Costantino non dové, però, avere l’effetto voluto, se oltre cent’anni dopo – ma con retroattività di trent’anni – Maiorano obbliga i potentiores presso i quali dei curiali si siano stabiliti, prendendovi moglie, a restituirli alle curie entro un anno (Nov. Mai. 7.1,2,4), pena la confisca patrimoniale per il dominus sciens e pene afflittive per l’actor o il procurator. Il fenomeno delle unioni ineguali, sia dal punto vista normativo, sia da quello delle radici sociali e, anche religiose, è oggetto di disamina da parte di Evans Grubbs J., Law and Family cit., 261-316, che, ovviamente, prende in considerazione anche questa costituzione (279 ss.).
GIOVANNA MANCINI
24
La novità nei casi sopra esposti è data non tanto dalle conseguenze giu-ridiche sul piano privatistico: esse, infatti sembrano rispondere – ma c’erano antecedenti anche nell’età precedente – più che all’applicazione di un criterio generale a obiettivi e conseguenti forme di regolamentazione speciali, quanto dalla nuova rilevanza penale di comportamenti che, come si diceva, erano stati fino ad allora lasciati alla libertà dei singoli e che avrebbero potuto comportare al massimo forme di riprovazione sociale.
Accostando a queste l’insieme di norme costantiniane su ratto e condi-zione della donna, in un recente contributo56, ho cercato di dimostrare co-me esse fossero indirizzate essenzialmente a favorire l’endogamia di ceto dell’ordo decurionum, di quei curiales che costituivano lo strumento essen-ziale di conservazione della vita cittadina e della certezza della riscossione delle imposte imperiali; curiales che appartenevano alla classe degli hone-stiores, al ceto di governo, in senso lato, dell’impero57.
Gli honestiones, godevano di privilegi in materia penale, che riguarda-vano non solo i membri delle curiae58 ma anche le loro famiglie59 e furono estesi ai figli dei veterani60; i milites, erano, peraltro, alla pari dei decurioni,
56 Mancini G., Pro tam magna sui confidentia, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma,
p. 152-190, Sankt Augustin 2011. 57 L’appartenenza alle due classi, degli honestiores e degli humiliores era rilevante, sin
dall’età di Adriano: D.48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.) 11. Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim sciendum est discrimina esse poenarum neque omnes eadem poena adfici pos-se. Nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri. Et si forte huiusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt: sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate eius poena aut permutetur aut liberaretur. Da leggere in connessione con: D.48.19.28pr. (Call. 6 de cogn.), nonché D.48.19.15 (Ven. Sat. 1 de off. proc.) Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est e D.48.19.27.1 (Call. 5 de cogn.) De decurionibus et principalibus civitatium, qui capitale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si quis id admisisse videatur, propter quod relegandus extra provinciam in insulam sit, im-peratori scribatur adiecta sententia a praeside e D.47.14.1.3 (Ulp. 8 de off. proc.), Coll. .11.8.3 (Ulp. 8 de off. proc.), D.48.13.7 (Ulp. 7 de off. proc.) cfr. anche Paul. Sent. 5.4.10.
Tali privilegi riguardavano non solo i membri delle curiae, ma anche le loro famiglie (D.48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.) 12, C.9.47.3 (Ant. A. Geminio) Decurionem in opus publi-cum dari non oportere manifestum est. C.9.47.12, figlie comprese C.9.47.9 (Alex. A. Deme-triano), e furono estesi ai figli dei veterani C.9.47.5 (Ant. A. Senecioni) Honor veteranis etiam in eo habitus est, ut liberi eorum usque ad primum dumtaxat gradum poena metalli vel operis publici non adficiantur, sed in insulam relegentur.
58 Già dalla fine del II secolo, quello dei decurioni/curiales non è più un ordo nel senso di organo della città, ma di gruppo sociale, dal quale sono tratte, anche, le magistrature cit-tadine e che deve curare legatio, difesa in giudizio, tutte le opere e tutti i servizi pubblici, l’amministrazione e l’approvvigionamento dell’annona locale, la ripartizione e riscossione delle imposte e altro ancora, attività che finiscono col ricadere sui componenti la curia. Mi si consenta di riviare sul punto a Mancini G., Pro tam magna cit. passim
59 D.48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.); C.9.47.3; C.9.47.12, figlie comprese C.9.47.9. 60 C.9.47.5.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
25
essenziali alla gestione dell’impero e, non a caso, tra i due gruppi le costitu-zioni stabiliscono un interscambio funzionale61. I curiali sono, dal III seco-lo, un ordine ereditario62, che presenta già difficoltà di ricambio; di qui la produzione, da parte degli imperatori, di misure di vincolo del decurione alla curia della sua città63, inasprite agli inizi del IV secolo64. Costantino adotta una serie di misure al fine di assicurare alle curie un’adeguata dota-zione di uomini e mezzi65, intervenendo sull’ereditarietà delle cariche, sul divieto di sottrarsi a esse, sulla restituzione alle curie stesse di quanti ne siano sfuggiti66, fino alla sanzione definitiva della regola dell’ereditarietà.67. È così che, in relazione alle curie – e all’esercito68 – si afferma per la prima volta il principio di ereditarietà coatta di quelle funzioni, politiche ed eco-nomiche, che appaiano essenziali per la vita della collettività. Parallelamen-te, Costantino emana disposizioni sulle corporazioni professionali, tese, però, a vincolare a esse non tanto le persone, quanto i patrimoni69; in questi
61 CTh.12.1.10; CTh.12.1.11; CTh.12.1.13; CTh.12.1.18.1.; CTh.12.1.19; CTh.12.1.22;
C.10.32.17. 62 D.50.2.7.2 (Paul. 1 sent.) Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi
non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur, cui si aggiunga la catena D.50.2.2.2-7 (Ulp. 1 disputat.); in particolare il primo frammento, in cui è esplicito il riferi-mento allo status e non all’appartenenza alla curia: D.50.2.2.2 (Ulp. 1 disputat).
63 C.10.32.13 .(Diocl. et Maxim. AA. et CC. Proto). Il processo è già avviato in età seve-riana,: D.50.2.1 (Ulp. 2 opin.); D.50.2.2.8 (Ulp. 1 disputat.); D.50.5.1.2 (Ulp. 2 opin.).
64 Il vincolo era determinato dall’origo ma anche dal domicilium: CTh.12.1.5. (Constan-tinus ad Bithynos) (21 luglio 317). Origo e domicilium diversi arrivano a comportare un doppio vincolo: CTh.12.1.12 [=Brev.12.1.2]. Sul domicilium v. Licandro O., Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano. Torino 2004, in partic. pp. 253 ss.
65 Sulle norme per tenere i decurioni legati alle curie: Jones A.H.M., The later roman empire cit., 737-755 e sulle motivazioni e forme di fuga dalle curie, v. Liebeschuetz W., The end of the ancient city, in Rich J. (ed.), The city in late antiquity, London 1992, 7-8.
66 CTh.12.1.10, CTh.12.1.11, CTh.12.1.12, CTh.12.1.13, CTh.12.1.14, CTh.12.1.16, CTh.12.1.17, CTh.12.1.20, CTh.12.1.22 di Costantino, CTh.12.1.25, di Costanzo; cfr. Gaudemet J., Constantin et les curies cit., 45; D. Liebs, Privilegen und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins, in RIDA III s. 24 (1977), 297-351, 337-348.
67 CTh.12.1.1. 68 CTh.12.1.32. Idem AA. ad Hilarianum. Militarium filios, qui gestandis armis idonei
non esse dicuntur, curiis iam iamque tradi oportet. Nam rei publicae incommodum est curias hominum paucitate languescere. Dat. Xvi kal. Sept. Marcellino et Probino conss. (Costanzo e Costante a. 341).
69 De Martino F., Storia economica di Roma antica II, Firenze 1979, 425 ss. Costantino nega, in via di principio, ogni possibilità di esonero a navicularii CTh.13.5.3 (a. 319 o 315) e suarii CTh.14.4.1. (anno 334), ma prevede per i primi “Sed et si quis patrimonium naviculario muneri obnoxium possidet, licet altioris sit dignitatis, nihil ei honoris privilegia, in hac parte dumtaxat, opitulentur, sed sive pro solido sive pro portione huic muneri teneatur. Nec enim aequum est, ut patrimonio huic functioni obnoxio excusato commune onus non omnes pro vi-rili sustineant portione.” (CTh.13.5.3.1.) e per i secondi “Itaque dinoscant facultates proprias suariorum esse obnoxias muneri ac de duobus alterum eligant; aut retineant bona quae sua-
GIOVANNA MANCINI
26
casi è, infatti, ancora assente la previsione del vincolo ereditario alla fun-zione, che vedremo, però agire in età immediatamente successiva.
2.3.4. Endogamia e funzione sociale: tra esclusione del conubium e re-
pressione penale Indirizzate all’estremo opposto della scala sociale, troviamo, infatti in
quest’età, una serie di norme che limitano la libertà anche matrimoniale dei provinciales, istituendo divieti di unioni con soggetti estranei al proprio gruppo sociale; essi in alcuni casi si sostanziano nella privazione del conu-bium – qualificandosi, così, l’unione come contubernium, con le connesse conseguenze civilistiche sulla condizione di coniugi e figli –, in altri, nella sanzione penale della violazione del divieto, anche con pena capitale o ri-duzione allo stato di schiavitù di donne libere.
Nel quadro della riorganizzazione economico-sociale e del mutato or-dine istituzionale e fiscale che segna la fine dell’età dell’espansione romana, uno dei nuovi oggetti di attenzione della produzione normativa è costituito da gruppi sociali che svolgono – spesso organizzati in corpora o collegia70 – alcune funzioni direttamente o indirettamente essenziali alla sopravvivenza delle città, più in generale della società – e delle strutture preposte alla con-servazione dell’unità territoriale dell’impero. Ne abbiamo appena visto un esempio nell’ordo decurionum e nei milites.
L’appartenenza al gruppo professionale o alla corporazione, non è, pe-rò, su base volontaria, come si evince da numerose norme a essi relative, riportate sia nel Codex Theodosianus, sia in quello Iustinianus. L’attività imposta doveva, inoltre, essere spesso insostenibile – o, almeno, meno pro-ficua di altre – tanto che c’erano diffusi e continui tentativi di sottrarsi alla condizione, posti in essere anche da appartenenti a corpora con svolgono funzioni prettamente economiche, evidenti dalle norme che colpiscono quanti li agevolano, accogliendoli presso di sé71.
riae functioni destricta sunt ipsique suario teneantur obsequio aut idoneos quos volunt nomi-nent, qui necessitati idem satisfaciant.” (CTh.14.4.1.), mentre è assente la previsione del vin-colo ereditario alla funzione. Sui collegia nell’economia tardoantica, v. De Martino F., Storia economica cit., 426 ss.; sulla politica normativa costantiniana v. anche Liebs D., Privilegen und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins, in RIDA III s. 24 (1977), 297-351, 337-348.
70 V. anche sotto, nt. 93. 71 La sanzione per chi dà asilo agli opifices imperiali arriva, con Valentiniano e Valente,
fino alla proscrizione, segno dell’insufficienza della multa fino ad allora erogata a contenere il fenomeno (CTh.10.20.6: IDEM AAA. AD MODESTUM. Opifices vesti linteae contexen-dae in usum erogationum nostrarum operam dantes sollicitatos a plurimis esse cognovimus. Igitur et eos, penes quos sunt, et textores ipsos terna auri pondo thesaurorum commodis inferre praecipimus; quin etiam opifices ipsos textrinis linteae vestis vindicari conveniet. Quod si ali-quis detegetur in eadem insolentia permanere et iugiter opificem detinuerit, non iam multam, ut praeterito tempore iusseramus, sed proscriptionem subire debebit. DAT. V KAL. IUL.
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
27
Nel febbraio del 426, Teodosio e Valentiniano emanano una costitu-zione di carattere generale a disciplinare la liberazione dalla propria corpo-razione (corpus) di quanti appartengono per vincolo di sangue (ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentium) all’amministrazione del fisco impe-riale, liberazione possibile solo dando un sostituto approvato dall’am-ministrazione e che non si estende, però, alla loro prole.
Nella constitutio sono esplicitamente indicati come sottoposti a questa condizione i gynaeciari (appartenenti agli opifici imperiali in cui erano im-piegate delle donne, i gynaecia, appunto), quanti lavorano il lino (lintearii), i tessitori (linyfari), gli operai della zecca (monetari), i pescatori di murici (murileguli) e quanti altri si trovino in analoga condizione72.
Già dal 384 era vigente il divieto di sottrarsi al proprio officium anche per i bastagarii (trasportatori di beni del princeps, in generale pubblici)73 ten-tando di passare alla milizia, nonché per gli operai di fabbriche di armi (fa-bricenses), che, come stabiliscono Arcadio e Onorio nel 398, devono essere marchiati perché possano essere riconosciuti in caso di fuga, mentre chi li abbia accolti dovrà essere lui stesso attribuito alla fabbrica74. Già dall’età di
MODESTO ET ARINTHEO CONSS. (anno 372).
72 CTh.10.20.16. IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. ACACIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Si quis ex corpore gynaeceariorum vel linteariorum sive li-nyfariorum monetariorumve aut murilegulorum vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentium voluerit posthac de suo collegio liberari, non quoscumque nec facile in locum proprium, freti dexterae triumphalis absolutione, substituant, sed eos, quos omnibus idoneos modis sub ipsis quodammodo amplissimae tuae sedis obtutibus adprobarint; ita tamen, ut is, qui ab huiusmodi condicione iuxta formam caelitus datam beneficio principali fuerit absolutus, universam generis sui prosapiam in functione memorati corporis permanen-tem cum omnibus eius qui absolvitur rebus obnoxiam largitionibus sacris futuram esse non dubitet. DAT. VII KAL. MAR. CONSTANTINOPOLI DD. NN. THEODOSIO XII ET VA-LENTINIANO II AA. CONSS. (426 FEBR. 23). La costituzione è ripresa, nello stesso testo, nel Codex Iustinianus, C.11.8.13.
73 CTh.10.20.11. IDEM AAA. TRIFOLIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Aeternam fiximus legem, ne umquam bastagariis militiam vel suam deserere liceat vel aliam subreptiva impetratione temptare. Et tribuni, qui scientes huiusmodi milites ad numerum re-ceperint, per singulos bastagarios singulas auri libras fisco cogantur inferre. Et super hoc dedi-mus litteras ad illustres magistros utriusque militiae. DAT. VIIII KAL. AUG. HERACLEAE RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS. (anno 384).
74 CTh.10.22.4. IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. HOSIO MAGISTRO OFFI-CIORUM. Stigmata, hoc est nota publica, fabricensium brachiis ad imitationem tironum infli-gatur, ut hoc modo saltem possint latitantes agnosci: his, qui eos susceperint vel eorum liberos, sine dubio fabricae vindicandis, et qui subreptione quadam declinandi operis ad publicae cuiuslibet sacramenta militiae transierunt. DAT. XVIII KAL. IAN. CONSTANTINOPOLI HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS. (anno 398). Nel 404 gli stessi imperatori puniscono con la multa e la confisca della terra chi li abbia accolti come procuratori o con-duttori della stessa: CTh.10.22.5. IDEM AA. ANTHEMIO MAGISTRO OFFICIORUM. Si quis posthac fabricensem admiserit procuratorem vel cultorem sui praedii detinuerit conducto-remve susceperit, rei, quam contra vetitum fabricensi crediderit iniungendam, proprietate pri-vetur, ea videlicet fiscalibus calculis socianda; ipse vero fabricensis, qui contraxerit legis offen-
GIOVANNA MANCINI
28
Costanzo erano state previste multe per chi avesse nascosto una persona appartenente a un gynaeceum75.
L’appartenenza a una di queste corporazioni – e anche a quelle simili – è, dunque, vincolata ed ereditaria.
Ed è proprio con riferimento a questi corpora che sono emanate norme finalizzate a discplinarne la capacità matrimoniale con estranee – o estranei – a famiglie che del corpus siano già parte.
La conseguenza è, solitamente, la coatta inclusione del partner all’interno del corpus stesso.
Esaminiamo i casi previsti: Se una donna ingenua abbia istituito un contubernium con un gynaecea-
rius, sarà ella stessa astretta alla condizione del marito76. La stessa sorte toccherà alla donna splendidioris gradus che si sia unita a
un monetarius, condannato anch’egli a non modificare mai la sua condizio-ne77. Se, infatti, dopo essere stata ammonita ai sensi del SC Claudianum, per-severerà nella convivenza col monetarius, ella stessa e i suoi figli saranno vin-colati alla condizione del padre78. Se, invece, si tratti di un’originaria o di una colona, il proprietario dovrà immediatamente ricondurla alla terra cui è giu-ridicamente legata, o perderà il diritto di ripeterla successivamente79. La fi-
sam, multa duarum librarum auri feriatur. DAT. III KAL. AUG. CONSTANTINOPOLI HONORIO A. VI ET ARISTAENETO CONSS. (anno 404).
75 CTh.10.20.2. IMP. CONSTANTIUS A. AD TAURUM PRAEFECTUM PRAETO-RIO. Quinque auri librarum multam exigatur, qui mancipium gynaecei, quod celat, non intra kal. Septemb. Prodiderit. DAT. XIIII KAL. APRIL. MEDIOLANO DATIANO ET CEREA-LE CONSS. (anno 358 [357]).
76 CTh.10.20.3. IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD GERMANUM CON-SULAREM. Ingenuae mulieres, quae se gynaeceariis sociaverint, si conventae denuntiatione sollemni splendorem generis contuberniorum vilitati praeferre noluerint, suorum maritorum condicione teneantur. DAT. IIII KAL. IUL. MEDIOLANO VALENTINIANO ET VALEN-TE AA. CONSS. (anno 365).
77 CTh.10.20.1. IMP. CONSTANTINUS A. AD BITHYNOS. Monetarios in sua semper durare condicione oportet nec dignitates eis perfectissimatus tribui vel ducenae vel centenae vel egregiatus. DAT. XII KAL. AUG. GALLICANO ET BASSO CONSS. (anno 317).
78 CTh.10.20.10pr. IDEM AAA. AD HESPERIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Edi-cimus, ne qua mulier spendidioris gradus monetarii adhaerens consortio decus nativae liberta-tis amittat. Quod si quam ab hac praeceptione statutum nostrae perennitatis abduxerit, ea se-cundum auctoritatem senatus consulti claudiani vel legitima admonita conventione discedat vel, si complexui monetarii putaverit inhaerendum, non ambigat se et liberis praeiudicaturam et eius condicioni esse nectendam. Nihilo minus autem et eas, quae ante legem nostram mone-tariis videntur esse coniunctae, placuit praedicto titulo conveniri scientes, nisi interdicta co-niunctione discesserint, mutasse se statum. (anno 380 [379]).
79 CTh.10.20.10.1. Si qua vero originaria seu colona possessionis alienae, ignaro domino seu sciente, monetario adsociabitur, ii conventi mox iuri agrorum debitas personas retrahere festinent vel de cetero sciant repetendi facultatem silentii sui coniventia perdidisse. (anno 380 [379]).
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
29
glia di un monetarius, infine, non potrà unirsi in matrimonio a estranei80. Analoghe regole sono stabilite per quanti sono addetti alla raccolta del-
la porpora, anzi, in questo caso anche l’uomo che prenda come moglie una donna di una famiglia di conchileguli, diverrà egli stesso vincolato alla loro condizione81, mentre i figli della murilegula seguiranno la condizione di lei82.
Anche l’uomo che si unisca alla figlia di un mugnaio o panificatore (pi-stor) sarà egli stesso sottoposto al corpus dei pistores, assumendo i relativi obblighi83. Il patrimonio dei pistores è sostanzialmente vincolato a garantire l’esercizio della funzione, tanto che donazioni sono consentite a figli e ni-poti, proprio perché dovranno a loro volta garantirla iure successionis84,
80 CTh.10.20.10.2. Sed ut monetario nullam necti volumus, ita et monetario patre suscep-
tas prohibemus extraneis copulari. DAT. PRID. ID. MART. AQUILEIAE POST CONSU-LATUM AUXONI ET OLYBRI. (380 [379] MART. 14).
81 CTh.10.20.5. IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. FILE-MATIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Si quis uxorem de familiis conchylegulo-rum acceperit, sciat condicioni eorundem se esse nectendum. DAT. IIII KAL. IUL. TREVIRIS GRATIANO A. II ET PROBO CONSS. (371 IUN. 28) = C.11.8.11.
82 CTh.10.20.15. IDEM A. ET CAES. (IMP. THEODOSIUS A. ET VALENTINIANUS C. ) MAXIMINO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Ii, qui ex filiabus murilegulorum et alienae originis patribus sunt vel fuerint procreati, iura maternae condicionis agnoscant. DAT. VIIII KAL. IUN. THEODOSIO A. XI ET VALENTINIANO CAES. CONSS. (anno 425) = C.11.8.12 La norma ha, peraltro, effetto retroattivo, abolito, però, due anni dopo da altra constitutio che regola anche la condizione di già nati da coloni/adscripti e murileguli nel senso di ricondurli sempre alla condizione paterna. Per il futuro, invece, la condizione di murilegulo, sia essa del padre o della madre, determina la stessa condizione del nato (CTh.10.20.17 IDEM AA. VALERIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Placet, si conchyliolegulorum filiae condicionis alienae nubserint viris, qui ex ipsis fuerint procreati ab eo tempore nexum maternae adscriptionis agnoscant, ex quo promulgatam super hoc cognove-rint legem. De his vero, quos ante eam natos esse constiterit, huiusmodi forma servetur, ut, sive conchyliolegulorum seu adscriptorum progenies fuerit colonorum, paternam tantum con-dicionem sequantur. Si qui vero post legem aut patre conchyliolegulo geniti probabuntur aut matre, memoratae adscriptioni obnoxios se esse non ambigant. DAT. X KAL. APRIL. CON-STANTINOPOLI HIERIO ET ARDABURE CONSS. (anno 427).
83 CTh.14.3.2. IMP. CONSTANTIUS A. AD ORFITUM PRAEFECTUM URBI. Si quis pistoris filiam suo coniugio crediderit esse sociandam, pistrini consortio teneatur obnoxius et familiae pistoris adnexus oneribus etiam parere cogatur. Et quoniam necessarium corpus fo-vendum est, patronos pistoribus constitutos ad altera functionis officia prohibeo devocari cau-dicariorum corpori minime de cetero copulandos, ut aliis necessitatibus absoluti eam tantum-modo functionem liberae mentis nisibus exsequantur. DAT. PRID. NON. IUL. MEDIOLA-NO ARBITIONE ET LOLLIANO CONSS. (anno 355). Norma ribadita quasi vent’anni do-po da Valentiniano, Valente e Graziano: CTh.14.3.14. AD URSICINUM PRAEFECTUM ANNONAE. Si cui pistoris filia nubserit ac postea is eandem dilapidatis facultatibus consortio putaverit eximendam, non alia lege adque ratione eundem ipsum pistoriae necessitati et corpo-ri praecipimus adstringi, quam si eodem munere originis vinculo teneretur. DAT. VIII KAL. MART. TREVIRIS MODESTO ET ARINTHAEO CONSS. (anno 372).
84 CTh.14.3.3.1. In donationibus vero filii excepti sunt et nepotes, eodem loco positis om-nibus, qui qualibet proximitate iunguntur, quibus ideo non dempsimus beneficium largitatis,
GIOVANNA MANCINI
30
mentre successione o donazione in favore dell’estraneo saranno valide solo se questi volontariamente assumerà il compito del pistor85.
Il pistor e i suoi figli sono esclusi, anche, dal conubium con alcune altre categorie di persone e, in caso di violazione, egli sarà deportato, previa ba-stonatura e i suoi beni destinati al panificio, mentre il marito della figlia sa-rà immesso nella corporazione dei pistores86.
Al medesimo vincolo ereditario – per parte di padre o di madre87 – alla funzione sono sottoposti i suarii88 e, come abbiamo visto già da Costantino, i loro patrimoni89. Regime analogo vige per gli appartenenti a delle corpo-razioni cittadine, cui è anche vietato allontanarsi stabilmente dalla propria città: in caso di unione matrimoniale con un’estranea, se si tratta di donna libera, i figli seguiranno la condizione del padre, se di donna di condizione inferiore, quella della madre90.
quia et paneficii necessitatem suscipere successionis iure coguntur. (Valentiniano e Valen-te, anno 364).
85 CTh.14.3.3.2. Haec forma servabitur et in testamentis aut donatione vel novissima vo-luntate, ut in extraneos collata non valeant, nisi pistoris officium sponte susceperint qui pisto-rum sunt munificentiam consecuti. DAT. IIII NON. IUN. NAISSI DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS. (Valentiniano e Valente, anno 364). È anche, generalmente, vieta-ta la dismissione della funzione cui si è assegnati dalla nascita, sia pure assumendone un’altra. Cfr., tra le altre, CTh.14.3.8 (Valentiniano e Valente, anno 365).
86 Non possono sposare persone private o di teatro o che svolgano attività di auriga: CTh.14.3.21. IDEM AA. ET THEODOSIUS A. VITALI PRAEFECTO ANNONAE. Nulli pistori nec posteris eius in privatas personas vel thymelicas vel eas, quae aurigandi studio deti-nentur, liceat coniugii societate transire, etiamsi huic facto omnium pistorum accedat adsensus, etiamsi nostra elicita fuerint aliqua subreptione rescripta. Quod si quisquam in haec vetita ad-spirare temptaverit, sciat se verberibus adfectum deportatione puniendum facultatesque suas paneficio sociandas… Omnes igitur, qui filias pistorum in consortium sortiti sunt, vel ex thymelicis vel aurigis vel universis privatis pistorio corpori ilico deputentur. DAT. VIII ID. MART. RAVENNAE D. N. THEODOSIO A. I ET RUMORIDO V. C. CONSS. (anno 403).
87 CTh.14.4.8pr. IDEM AA. HILARIO PRAEFECTO URBI. Quicumque de suariorum corpore originariam functionem sub cuiuslibet desiderio auxilii vel honore declinasse noscun-tur vel ad diversa se officia contulisse aut adnotationibus vel rescriptis nostrae serenitatis elici-tis, ad munus pristinum revocentur, tam qui paterno quam qui materno genere inveniun-tur obnoxii… (anno 408).
88 CTh.14.4.7. IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. FLORENTINO PRAEFECTO URBI. Heredes suariorum, filiorum etiam emancipatorum bona omnia ac patrimonia requi-rantur, ut, sive personarum agatur ratio sive rerum, non minus habeatur obnoxius quem possessio tenet quam quem successio generis adstringit, dummodo suo ordini adtributos suarii non amittant et propriis facultatibus solitisque subsidiis aliena adque longinqua et ab hoc munere distracta non quaerant. DAT. XV KAL. MAR. MEDIOLANO CAESARIO ET ATTICO CONSS. (anno 397).
89 CTh.14.4.1. … itaque dinoscant facultates proprias suariorum esse obnoxias muneri ac de duobus alterum eligant; aut retineant bona quae suariae functioni destricta sunt ipsique suario teneantur obsequio aut idoneos quos volunt nominent, qui necessitati idem satisfaciant. Nullum enim vacare ab huius rei munere patimur… (anno 334).
90 CTh.14.7.1 [=BREV.14.1.1]. IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. GRACCHO CON-
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
31
Quanto ai curiali, alla fine del IV secolo gli imperatori devono tornare, per contrastarlo, sull’abbandono delle città da parte loro91, utilizzando, an-che, l’arma dell’esproprio dei beni92
Anche su questo versante, il fenomeno è, però, generale; riguarda non solo l’ordo ma quanti sono vincolati agli officia necessari al mantenimento della città, come mostrano le constitutiones che cercano di contrastare l’abbandono delle città, ordinando di ricondurre i fuggitivi ai propria offi-cia e l’appartenenza dei figli a loro nati da un’ingenua al collegium del pa-dre93, mentre se sia necessario aumentare il numero dei facenti parte di una
SULARI CAMPANIAE. De retrahendis collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non valeant attineri. De quorum agnatione haec forma servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero iustum erit, patri cedat ingenua successio. DAT. IX. KAL. IUN. MEDIOLANO, CAESARIO ET ATTICO COSS.
Interpretatio. Collegiati, si de civitatibus suis forte discesserint, ad civitatis suae officia cum rebus suis vel ad loca, unde discesserunt, revocentur: de quorum filiis haec servanda con-dicio est, ut, si de colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio; si vero de ingenua et collegiato, collegiati nascuntur.
Cfr. anche CTh.14.7.2 (Onorio e Teodosio, anno 412 o 409). 91 Con riferimento all’Egitto, CTh.12.18.1. IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS
AA. AD TATIANUM PRAEFECTUM AEGYPTI. Iudiciario omnes vigore constringes, ne vacuatis urbibus ad agros magis, quod frequenti lege prohibetur, larem curiales transferant fa-miliarem. DAT. VI ID. MAI. MARCIANOPOLI LUPICINO ET IOVINO CONSS. (anno 367).
92 CTh.12.18.2. IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTYCHIANO PRAEFEC-TO PRAETORIO. Post alia: curiales omnes iubemus interminatione moneri, ne civitates fu-giant aut deserant rus habitandi causa, fundum, quem civitati praetulerint, scientes fisco esse sociandum eoque rure esse carituros, cuius causa impios se vitando patriam demonstrarint. DAT. XVIII KAL. IAN. CONSTANTINOPOLI ARCADIO IIII ET HONORIO III AA. CONSS. (anno 396 [?]).
93 CTh.14.7.1 [=BREV.14.1.1]. IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. GRACCHO CON-SULARI CAMPANIAE. De retrahendis collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non valeant attineri. De quorum agnatione haec forma servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero iustum erit, patri cedat ingenua successio. DAT. IX. KAL. IUN. MEDIOLANO, CAESARIO ET ATTICO COSS.
Interpretatio. Collegiati, si de civitatibus suis forte discesserint, ad civitatis suae officia cum rebus suis vel ad loca, unde discesserunt, revocentur: de quorum filiis haec servanda con-dicio est, ut, si de colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio; si vero de ingenua et collegiato, collegiati nascuntur.
CTh.14.7.2 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. LIBERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Post alia: collegiatos et vitutiarios et nemesiacos signiferos cantabrarios et sin-gularum urbium corporatos simili forma praecipimus revocari. Quibus etiam supplicandi inhi-bendam facultatem esse censuimus, ne originem, quod fieri non potest, commutare ulla iussio videatur ac si forte per sacram auctoritatem cognoscitur aliqui liberatus, cessante beneficio ad originem revertatur. DAT. VI KAL. DECEMB. RAVENNAE HONORIO VIIII ET THEO-
GIOVANNA MANCINI
32
di tali corporazioni, l’imperatore può ordinare che vi siano annessi quanti esercitano mestieri simili94.
Analoga condizione di vincolo alla funzione della coltivazione della ter-ra vivono i coloni, originarii e incolae95, definiti in una legge di Giustiniano membra terrae delle quali satis inhumanum est che questa sia privata96.
Non possiamo esaminare, in questa sede, tutta la problematica relativa al rapporto di colonato nelle sue varie, possibili e ipotizzate, configurazioni e nelle implicazioni legate a fattori economici strutturali e fiscali sottese al rapporto di colonato.
Ci limiteremo ad accennare all’iniziale energico intervento di Costanti-no, teso ad assicurare, con un editto ad provinciales la permanenza dei co-loni nella terra d’origine97. Gli imperatori successivi continueranno a com-
DOSIO V AA. CONSS. (anno 412).
In particolare per le Gallie, qualche anno prima era stata dettata una disciplina singola-re, quanto ai figli, divisi tra il proprietario della madre e la città,: CTh.12.19.1 IMPP. AR-CADIUS ET HONORIUS AA. VINCENTIO PRAEFECTO PRAETORIO. Galliarum desti-tutae ministeriis civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt: plurimi siquidem col-legiati cultum urbium deserentes agrestem vitam secuti in secreta sese et devia contulerunt. Sed talia ingenia huiusmodi auctoritate destruimus, ut, ubicumque terrarum repperti fuerint, ad officia sua sine ullius nisu exceptionis revocentur. De eorum vero filiis, qui tamen intra hos proxime quadraginta annos docebuntur fuisse suscepti, haec forma servabitur, ut inter civita-tem et eos, quorum inquilinas vel colonas vel ancillas duxerint, dividantur, ita ut in ulteriorem gradum missa successio nullam calumniam perhorrescat. ET CETERA. DAT. III KAL. IUL. MEDIOLANO STILICHONE ET AURELIANO VV. CC. CONSS. (anno 400).
94 CTh.14.8.1. IMP. CONSTANTINUS A. AD EVAGRIUM PRAEFECTUM PRAE-TORIO. Ad omnes iudices litteras dare tuam convenit gravitatem, ut, in quibuscumque oppi-dis dendrofori fuerint, centonariorum adque fabrorum collegiis adnectantur, quoniam haec corpora frequentia hominum multiplicari expediet. DAT. XIIII KAL. OCTOB. NAISSO, AC-CEPTA VIII ID. NOVEMB. CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. (anno 315).
95 Un approfondito esame delle problematiche relative al colonato e attenta discussione della letteratura relativa, in Mirković M., The later roman colonate and freedom, cit. passim, ove interessante esame di fonti giuridiche, letterarie e papirologiche, nonché esaustiva bi-bliografia, cui si rimanda. Per un inquadramento generale, si vedano: Mazzarino S., Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana, Roma 1951, Santilli A., Appunti sull’origine del colonato, in Studi Senesi 87, serie III (1975), pp. 139-194, Giliberti G., Ser-vus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana, Napoli 1988, Castello C., Tre norme speciali romane in tema di filiazione, in Annuali Fac. Giur. Univ. Genova 2 (1963), pp. 292-369. Jones A.H.M., The roman colonate, in Id. The roman economy. Studies in ancient economic and administrative history, ed Brunt P. A., Ox-ford 1974, pp. 293-307; Marcone A., Il lavoro nelle campagne, in Storia di Roma III.1, Tori-no 1993, pp. 823-843; Carrié J.M., “Colonato del basso impero”: la resistenza di un mito, in Lo Cascio E. ed., Terre proprietari e contadini dell’impero romano, Roma 1997, pp. 75-150; Sirks A.J.B., The colonate in Justinian’s reign, in JRS 98 (2008), 120 ss.
96 C.11.48.23pr. IUST. Cum satis inhumanum est terram quae ab initio adscripticios ha-bebat suis quodammodo membris defraudari.
97 CTh.5.17.1pr. [=BREV.5.9.1pr.]. IMP. CONSTANTINUS A. AD PROVINCIALES. Apud quemcumque* colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suae re-
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
33
minare sanzioni a chi li accolga98, ribadiranno che devono sempre essere restituiti al dominus fundi99 (Arcadio e Onorio) e, pur se ingenui devono essere considerati servi terrae (Teodosio, Arcadio e Onorio)100.
Onorio e Teodosio – tra il 408 e il 423 – intervenendo sul tempo di prescrizione dell’azione di restituzione al luogo in cui fossero nati, fissato in trent’anni per i coloni e in venti per le colone, regolano an-che la posizione dei figli nati nella terra di proprietà di chi li ha ac-colti, riconducendoli al vincolo proprio dei genitori, distinguendo tra figli del colono e figli della colona, resi, questi ultimi, al prece-dente proprietario per un terzo se il padre sia colono altrui o intera-mente negli altri casi. Gli imperatori tendono comunque a favorire la permanenza del rapporto familiare ordinando la restituzione al do-minus dei coloni fuggitivi non degli stessi, ma di loro sostituti101. Con
stituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat. 1. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere. DAT. III. KAL. NOV. PACATIANO ET HILARIANO COSS.
Interpretatio. Si quis alienum colonum sciens in domo sua retinuerit, ipsum prius domino restituat et tributa eius, quam diu apud eum fuerit, cogatur exsolvere: ipse vero, qui noluit es-se, quod natus est, in servitium redigatur. Sul rapporto tra colonato e incolato, v. Gagliardi L., Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. 1. La classificazione degli incolae, Milano 2006, in partic. pp. 340 ss. e nt. 50 ove ampia bibliogra-fia, cui si rimanda.
98 CTh.5.17.2. [=BREV.5.9.2]. IMPPP. VALENT., THEODOS. ET ARCAD. AAA. CYNEGIO PF. P. Quisquis colonum iuris alieni aut sollicitatione susceperit aut occultatione celaverit, pro eo, qui privatus erit, sex auri uncias, pro eo, qui patrimonialis, libram auri co-gatur inferre. DAT. VIII. KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI, HONORIO N. P. ET EVODIO COSS.
Interpretatio. Si quis colonum alienum aut sollicitaverit aut occultaverit, si privati homi-nem sua sollicitatione susceperit, sex auri uncias domino reddat; si fiscalem sollicitatum tenuit, libram auri cogatur implere.
99 C.11.48.11. ARCAD./ HONOR. Originarios colonos nullis privilegiis, nulla dignitate, nulla census auctoritate excusari praecipimus, sed amputatis omnibus, quae aliquotiens per gratiam sunt elicita, domino vel fundo esse reddendos. ARCAD. ET HONOR. AA. AD POP.
100 C.11.52.1.1. THEOD./ ARCAD./ HONOR. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem ori-ginario iure teneantur, et licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem, sed posses-sor eorum iure utatur et patroni sollicitudine et domini potestate.
101 CTh.5.18.1. [=BREV.5.10.1pr.]. IMPP. HONOR. ET THEODOS. AA. PALLADIO PF. P. Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte pos-sidetur, calumnia penitus excludatur; quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari. 1. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, sive per fugam lapsus, seu sponte seu sollicitatione transductus, neque de eius condicione* du-bitatur, eum, contradictione summota, loco, cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restitui. 2. Quod si forte ipse, de cuius proprietate certatur, fatali sorte consumptus est, eius
GIOVANNA MANCINI
34
la Novella 31102 Valentiniano detta una regolamentazione articolata
posteritatem agrorum iuri cum omni peculio atque mercedibus, velut eo superstite, qui deces-sit, celeri iubemus exsecutione revocari. 3. In feminis sane observationem volumus esse diver-sam. Itaque mulierum, quae fuisse originariae docebuntur, si ante vicesimum annum de solo, cui debebantur, abscesserint, universa repetitio cesset; earum vero, quarum intra comprehen-sum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est, prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen condicione servata, ut vicaria cum agnatione partis tertiae non negetur, quae de colono suscepta est alieno, ita ut pro filiis quoque contrarii praebeantur. 4. Quod si non ad alienum praedium, sed cuiuscumque liberi hominis ac sui iuris secuta consortium in urbibus vel in quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum tempus reposci-tur, eius omnem originem secundum vetera constituta conveniet revocari. 5. Contestatas au-tem lites, si tamen quisquam docebitur solenniter fuisse conventus, salvas repetentibus esse decernimus. DAT. VI. KAL. IUL. RAVENNA, MONAXIO ET PLINTA COSS.
Interpretatio. Si quis colonum alienum in re sua vel in fuga lapsum vel sua voluntate mi-grantem triginta annos habuerit, ac si suum vindicet. Qui si intra triginta annos inventus fue-rit a domino, cum filiis secundum legem sibi debitis et omni peculio revocetur. Quod si forte mortuus fuerit, filii eius cum mercedibus suis vel patris mortui a domino revocentur. Colona etiam si viginti annis in alieno dominio et iure permanserit, a priore domino non requiratur; si tamen intra viginti annos inventa fuerit et de alieno colono filios susceperit, cum agnationis parte tertia revocetur: quia colonum duae partes agnationis sequuntur. Sane ne separatio co-niugii fiat, illum, cuius colonus est, vicariam mulierem et pro tertia agnatione mulieris domino compensare praecipimus. Si vero mulier iuris alieni ingenuum maritum duxerit, omnis mulie-ris agnatio ad eius dominium pertinebit. Quod hic minus est de colonae agnatione, in novellis legibus invenitur.
102 NV.31. DE COLONIS VAGIS ET DE ADVENIS. IMP. VALENTIN. A. FIRMINO PF. P. ET PATRICIO. Quum pure et fideliter observari debeant, quae caventur in legibus, latam dudum de colonis originariis fucum pati quorundam maligna mente cognovimus. Nam quum is, a quo discessit obnoxius, triginta annorum repellatur obiectu, eundo per hos atque alios designatum tempus assumit; ita contingit, ut, quum illi pereat, a quo fugit, nec huic, ad quem venit, possit acquiri, mansionum permutatione desinat esse, quod natus est, libertatem, quam nascendo non habuit, fugae sibi assiduitate defendens. Nulli umquam, nisi colono fugiti-vo, culpa sua praemium fuit: ea causa incipit melior effici, qua poenam meretur. 1. Quod ta-men sufficit huc usque licuisse. Nam quum prior dominus obice legis excluditur, illi eum iu-bemus acquiri, apud quem eosdem annos statuti temporis probatur implesse. Quod si propter conclusionem tricennalem et ad vim praescriptionis eludendam aequaliter habitet per diversos, is eum vindicet iure colonario serviturum, penes quem a die primae fugae triginta annorum posteriora tempora concluduntur, alias huic lucro cedat, cum quo maximam tricennii partem vagus et infidus habitator efficit. Quod etiam de mulieribus originariis aeque vagantibus praecipio custodiri. 2. Colona vero, quae petitori post viginti annorum curricula denegatur, si quem partum ante designatum tempus edidit, priori domino convenit non perire: aequum est, ut ad eum soboles redeat suscepta tunc temporis, quum adhuc mulier competebat, ut damnum amissae matris, quod processu contingit annorum, prolis saltem vindicatio consoletur. Quem casum iubemus vicariorum compensatione finiri, ne, quod impium est, filii a parentibus dividantur. 3. Item placet, ut pars, cuius maritum esse constiterit, pro uxore eiusdem meriti vicariam reddat, quatenus prava forsitan dominorum obstinatio a faciendo divortio conquie-scat, quia et in eius modi personis salva et inconvulsa debet coniunctionis affectio permanere. 4. Sane sicut colonas commutari posse, priora statuta iusserunt, ita etiam de viris licentia sit. Igitur commutationes factas lex nostra confirmat, ac si aliqua cessio sine personarum commuta-tione processit, vel deinceps facta fuerit, non valeat, ne ad alterum coloni, ad alterum possessio exhausta perveniat. 5. Advenae plerumque tenues abiectaeque fortunae quorundam se obse-
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
35
della prescrizione al fine di stabilire la pertinenza del colono al dominus della terra originaria o di una di quelle in cui si fosse stabilito e disciplina gli effetti di unioni matrimoniali – nel frattempo intervenute tra coloni ori-ginari di fondi diversi, o tra ingenui/ingenuae e colone/coloni – sia su coloni e ingenui, sia sulla prole. Ancora una volta è la funzione ad attrarre l’estraneo: la donna ingenua che si unisce a colono ne acquisisce lo status, l’uomo che si unisce alla colona, pur se libero, non può lasciare la terra di
quiis iungunt, ut, simulata laboris et obsequiorum patientia, accepto sumptu ac vestitu illu-viem et squalorem egestatis evadant. Ubi de angustiis cladis suae et humanitate et miseratione colligentes fuerint liberati, iam repleti, iam nihil de miseria cogitantes eligunt feminas ad pa-tremfamilias pertinentes, solertia, forma, utilitate meliores: quum satias ceperit, derelinquunt: non statu priore perpenso, non assuetudine coniunctionis, non dulcedine filiorum, nulla lege prohibente discedunt. Itaque si nulli quolibet modo obnoxius civitati ad praedium se cuiu-scumque rusticum urbanumque collegerit, et mulieri obnoxiae sociari voluerit, gestis municipa-libus profiteatur habitandi, ubi elegerit, voluntatem, ut hoc vinculo praecedente nec habitacu-lum, quod placuit, deserat, nec consortium mulieris abrumpat. Qua professione deprompta, salva ingenuitate, licentiam non habeat recedendi. 6 Pari lege mulieres ingenuas iubeo detine-ri, a quibus coniunctio appetita est et electa servorum vel colonorum, ut his abire non liceat. Filii earum, si denuntiatio non praecessit, in eorum iure et dominio, apud quos creati sunt vel creantur, colonario nomine perseverent: post denuntiationem vero editos secundum scitadiva-lia servos esse censemus, ut illos nexus, sicut dictum est, colonarius teneat semper obnoxios, hos condicio servitutis, Firmine, parens carissime atque amantissime. 7. Illustris et praecelsa magnificentia tua huius generalis constitutionis formam edictis propositis ad omnium faciet notitiam pervenire. DAT. PRID. KAL. FEBR. ROMAE. ACC. III. NON. FEBR. ROMAE. PP. IN FORO TRAIANI, ADELPHIO V. C. COS.
Interpretatio. Lex ista constituit, ut, si colonus proprium dominum fugerit, et triginta an-nis per diversorum domos aut agros fortasse latuerit, et non nisi impletis triginta annis a die fugae suae praedictum colonum dominus potuerit invenire, ab eo, apud quem inventus fuerit, tricennali annorum praescriptione dominus, qui fugam coloni sequitur, excludatur. Secunda iterum condicione currente, ut, si forte apud tres personas denis annis colonus ipse habitaverit, ille eum vindicet, apud quem posteriori tempore invenitur. Tertia condicio est, ut, si inter eos, apud quos per tricennium habitaverit, fuerit orta contentio, ipsi praedictus colonus addicatur, apud quem per illos triginta annos maiori annorum numero dignoscitur habitasse. De colonae vero fuga, par, apud quoscumque habitaverit, forma servetur, ea tamen condicione servata, ut, sicut de coloni iure proprius dominus trigintaannorum praescriptione excluditur, ita et impleto viginti annorum numero, de repetitione colonae domini petitio repellatur. Ita tamen, ut filii, qui intra viginti annos nati fuerint, quando adhuc colona domino competebat, a domino, qui colonam praeiudicio temporis perdidit, secundum constitutionem, quae sub titulo de episcopali iudicio processit, debeant revocari. Post vicesimum autem annum nati illius dominio acquirun-tur, cui colonam tempus addixerit. Iubetur etiam, ut de talibus personis commutatio non nege-tur, ita ut vicaria mancipia tam pro colona, quam pro portione filiorum dare coloni dominus mox procuret, quod etiam si convenerit, et pro colono is, cuius colona est, pari constitutione debebit implere. Advenae ingenui, qui se colonae iungi voluerint alienae, quia saepe fit, ut contubernia electa contemnant, gestis profiteantur, se de domo domini colonae, cui iunctus fuerit, nulla ratione discedere, et ingenuitate manente, nullam habeat licentiam evagandi, aut cui coniunctus fuerit, deserendi. Ingenua itemque mulier si contubernium coloni elegerit alie-ni, si ei denuntiatum non fuerit, coloni sint domino profuturi, quoscumque eius partus edide-rit. Post denuntiationem vero quoscumque ediderit, non colonos, sed servos noverit esse futu-ros.
GIOVANNA MANCINI
36
lei. Giustiniano interverrà, infine, elevando a trent’anni il tempo di prescri-zione anche per la donna103, e, nel caso di unione tra una donna libera e un adscrpticius alienus a dichiarare nulle le nozze104, vincolando comunque i figli alla coltivazione della terra, come adscrpticii o come coloni liberi105. 3. Conclusioni
Le norme che abbiamo visto sopra, si applicano, a ben considerare, a
gran parte della popolazione dell’impero, la quale si presenta, nell’età del dominato, frammentata e reciprocamente isolata in gruppi cui si appartiene per discendenza. E l’appartenenza all’uno o all’altro gruppo definisce la condizione non solo sociale, ma innazitutto giuridica dell’individuo.
Nel mutato ordine istituzionale, economico e fiscale del dominato, in cui alle corporazioni sono attribuite funzioni essenziali nel quadro della riorganizzazione socio-economica post-schiavistica, gli interventi della legi-slazione imperiale sembrano dettati dall’esigenza di assicurare in qualche modo continuità di esistenza e di attività a corpora in situazioni di impove-rimento, patrimoniale e demografico. Sono i corpora, non gli individui, i nuovi soggetti la cui esistenza l’ordinamento deve garantire.
L’attenzione del legislatore si sposta, così, a definire e salvaguardare i nuovi rapporti di inclusione/esclusione rilevanti per il nuovo ordine socia-le, in un mondo di individui, famiglie, gruppi sociali divenuti estranei, esterni l’uno all’altro, pur se formalmente unificati in una stessa civitas.
Nell’età repubblicana erano esistiti – per chi fosse parte del populus – diritti che fungevano in qualche misura da riferimento per la connotazione – fosse essa in termini di uguaglianza, inferiorità o pure di inesistenza – an-che della condizione degli altri individui, esterni al mondo dei maschi cives Romani.
Nel dominato, questo punto di riferimento non c’è: si è, tutti, sudditi, che è possibile revocare ad propriae artis et originis vincla106 Nessuno, tran-ne il dominus, è più potens sui.
Questa è la condizione generale degli individui: unificati dalla condi-zione di cittadini/sudditi, separati dall’appartenenza, ereditaria, a un ceto, a un gruppo funzionali alla conservazione della struttura di potere e di go-verno dell’impero.
103 C.11.48.23.3. 104 Nov. 22.17 (anno 536). 105 Nov. 162.2 (anno 539). Giustamente la Bianchini, Sulle unioni cit. p. 65, sottolinea
come la ratio sottesa agli interventi imperiali sia, volta a volta, quella di “assicurare la mag-giore consistenza di determinate categorie”.
106 CTh.10.20.14, Teodosio e Valentiniano (anno 424).
Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana ...
37
L’essere civis era stato, in primo luogo, essere libero, potens sui, appun-to. Nella repubblica è il civis – libero, maschio e ingenuus, se si vuole – a costituire il quadro di riferimento di diritti individuali Ora essere civis è es-sere subditus. L’appartenenza alla stessa comunità politica non comporta, di per sé l’integrazione, neppure al suo stesso interno.
Tornando al tema generale della ricerca, “Politiche di integrazione e vincoli giuridici: dal quadro generale all’applicazione locale”, è difficile re-sistere alla tentazione di invadere campi altrui, per sottolinaere come esista nel nostro ordinamento un vincolo generale, imprescindibile in ogni politi-ca di integrazione, che deve, a mio avviso, essere tenuto fermo.
Accennavo, in apertura, all’interdipendenza evidente nell’esperienza romana tra forme ed effetti dell’integrazione dello straniero alla società po-litica (romana) data e assetto non solo economico sociale, ma anche costi-tuzionale di quella.
La discussione si è focalizzata, negli ultimi mesi, sulla questione dell’ac-quisto della cittadinanza da parte dei migranti, per ius soli, dunque, e non più per ius sanguinis.
Ai fini dell’integrazione, però, l’inclusione in una medesima cittadinan-za può essere necessaria, ma – l’abbiamo visto – non sempre sufficiente. Essa, infatti, al di fuori del quadro di diritti di libertà riconosciuti a ogni uomo, può essere ininfluente, risolversi in nuove, inedite, forme di esclu-sione reciproca tra gruppi interni a una medesima società politica. Diritti che, inoltre, se non sanciti in una costituzione rigida rischiano di essere len-tamente e inconsapevolmente, cancellati.
Sottolineare, oggi, che ove venissero meno precettività e rigidità della nostra Costituzione, “integrazione” assumerebbe un significato diverso, è senz’altro banale, ma forse non inutile.