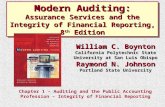Badii_ I topolini di Art. Note su Maus_Nuova Secondaria 2013
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Badii_ I topolini di Art. Note su Maus_Nuova Secondaria 2013
Nuova SecondariaPO
STE
ITA
LIA
NE
S.p.
A. S
ped.
in A
.P. -
D.L
. 353
/200
3 (c
onv.
in L
. 27/
02/0
4 n.
46)
art.
1, c
omm
a 1
- DC
B B
RES
CIA
Edi
tiric
e La
Scu
ola
2512
1 B
resc
ia -
Expé
ditio
n en
abo
nnem
ent p
osta
l tax
e pe
rçue
tass
a ris
coss
a - I
SSN
182
8-45
82
EDITRICE LA SCUOLA
Le emozioni vissute in rete.Il “caso” tristezza.
5gennaio 2013anno XXX
Imparare la filosofia dalle metafore
L’Inquiry Based
Science Education
La Shoah nelle arti visive. Tra fotografia,
pittura, cinema e graphics novels
NS2012-13cv05.indd 1 12/11/12 09.45
14
42EDITORIALE
Giovanni Gobber Ma il Ministero conosce la scuola? 5
NUOVA SECONDARIA RICERCAhttp://nuovasecondaria.lascuolaconvoi.it
Sandra Chistolini Il contraddittorio sinusoidale delle competenze nella professione docente
Elio Damiano L’eroe romantico. Le competenze come strumento euristico?
FATTI E OPINIONI
Il fattoGiovanni Cominelli Scuola e Stato. La malattia mortale del neo-centralismo 7
Pensieri del tempoGiuseppe Acone Ultime notizie dal pianeta scuola 8
Fabula docetGraziano Martignoni Quando muore l’imperatore 8
Asterischi di Kappa Orari di insegnamento Ue e Ocse 9
Il vangelo e la vitaPaola Bignardi Credo. Aiutami nella mia incredulità! 10
La lanterna di DiogeneFabio Minazzi A proposito della pedagogia del bastone e della carota 10
Il futuro alle spalleCarla Xodo Dalla parte dei giovani 11
Asterischi di Kappa Europa: le chiese diventano moschee 11
Risposta a domanda Contestazione di addebito per voti bassi? 12
Asterischi di Kappa I regali della burocrazia 21
PROBLEMI PEDAGOGICIE DIDATTICI
Barbara Bruschi Una rete di emozioni 14
Giuseppe Spadafora L’università e la formazione degli insegnanti 19
Claudio Melacarne La scuola come comunità di narrazione 22
Luciano Amatucci L’integrazione equilibrata degli immigrati 25
Maria Annita Baffa Lingua e comunità: una questione storica 29
Nuova Secondaria n. 5
108
64
99
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 1
STUDI
La Shoah nelle arti visive a cura di Massimo Giuliani 33
Liliana Picciotto Le fotografie della Shoah italiana 34
Mino Chamla Cinema e “rappresentazione” della Shoah 38
Daniele Liberanome La Shoah nella pittura contemporanea 42
Renata Badii I topolini di Art. Note su Maus di Art Spiegelman 44
PERCORSI DIDATTICI
Giuseppe Leonelli Per i cento anni di Elsa Morante 50
Fabio Minazzi Il lavoro come realizzazione sociale: Hegel 54
Stefano Cazzato Imparare la filosofia dalle metafore 57
Cinzia Bearzot Le donne della casa reale di Macedonia 60
Paolo A. Tuci Demagogia, corruzione e manipolazione
nell’Atene del V sec. a.C. 64
Carlo Lottieri LIBERALI E NO
Montesquieu e la virtù delle relazioni civili 67Rousseau e la coercizione sentimentale 70
Carmelo Di Stefano Alla scoperta dei Poliedri – I parte 74
Carla Simonetti Contributi di Bombelli alla nascita della Geometria analitica 80
Erasmo Recami Matematica e Fisica 84
Francesco Paparella Il vangelo secondo Higgs 86
Fausto Bersani Greggio, Fare chiarezza: elettrizzazione ed effetto Corrado Bernabè fotoelettrico 88
Ledo Stefanini Una ferrovia pneumatica 93
Maria Angela Fontechiari Inquiry Based Science Education: una didattica innovativa per le scienze 94
Gian Battista Vai Non fidarsi delle apparenze: una lezione dal terremoto emiliano 99
Gianluca Lapini Galileo Ferraris e i primordi dell’elettrotecnica italiana 104
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE a cura di Giovanni Gobber
Luigi Beneduci Risorse in internet per la storia della lingua 108
Francesca Costa Defamiliarising Input Presentation Strategies in CLIL.What do Students Think? 112
Giovanni Gobber Alla ricerca delle domande implicite nei dialoghi.Proposte per un esercizio di analisi 115
LIBRI
a cura di Luigi Tonoli e Lucia Degiovanni 119
@DIDATTICA CON LE SLIDEhttp://nuovasecondaria.lascuolaconvoi.it
Franca ZanettiIl testo argomentativo
Riccardo MerlanteLa letteratura e la luna
Anselmo Grotti Fausto MorianiRorty
Paolo A. TuciVoci critiche sulla democrazia: un confronto tra le fonti
Stefano ZappoliLa cultura europea nella seconda metà del XIX secolo
Lucia DegiovanniLe origini della lingua greca
Marta FerrariOscar Wilde. The development of individualism.
Alfredo MarzocchiFrazioni algebriche
Luca Lussardi Logica e algebrizzazione di Boole
Francesco AbbonaCristallografia fisica
Ledo StefaniniRelatività galileiana
Ersilia ConteAcqua: la classificazione delle acque
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 2
Progetto grafico: Fabio Paris Editions
su un’ idea originale di
(Laura Stefanutti, Tea Pinoni, Sonia Brambilla)
Coordinamento: Prof. Claudio Gobbi
Mensile di cultura, orientamenti educativi, problemididattico-istituzionali per le Scuole del secondo ciclodi istruzione e di formazioneFondatore e direttore emerito: Evandro AgazziAnno XXX - ISSN 1828-4582
Direzione, Redazione e Amministrazione: EDITRICE LASCUOLA, Via Gramsci, 26, 25121 Brescia - fax 030.2993.299 - Tel.centr. 030.2993.1 - Sito Internet: www.lascuola.it - Direttore re-sponsabile: Giuseppe Bertagna - Autorizzazione del Tribunale diBrescia n. 7 del 25-2-83 - P oste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.-D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Brescia- Editrice La Scuola - 25121 Brescia - Stampa Vincenzo Bona 1777Spa, Torino - Ufficio marketing: Editrice La Scuola, Via Gramsci 26,- 25121 Brescia - tel. 030 2993.290 - fax 030 2993.299 - e-mail:[email protected] – Ufficio Abbonamenti : tel. 030 2993.286(con operatore dal lunedì al venerdì negli orari 8,30-12,30 e 13,30-17,30; con segreteria telefonica in altri giorni e or ari )- fax 0302993.299 - e-mail: [email protected].
Abbonamento annuo 2012-2013: Italia: € 69,00 - Europa e Ba-cino mediterraneo: € 114,00 - Paesi extraeuropei: € 138,00 - Ilpresente fascicolo € 7,00. Conto corrente postale n.11353257(N.B. riportare nella causale il riferimento Cliente). L’editore si ri-serva di rendere disponibili i fascicoli arretrati della rivista in for-mato PDF. I diritti di tr aduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasimezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi. Foto-copie per uso personale del lettore possono essere effettuate neilimiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamentoalla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5 dellalegge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalitàdi carattere professionale, economico o commerciale o comun-que per uso diverso da quello personale possono esser e effet-tuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO,corso di P orta Romana n. 108, Milano 20122, [email protected] e sito web www.aidro.org.
Per eventuali omissioni delle f onti iconografiche, l’editore si di-chiara a disposizione degli aventi diritto.Sito della rivista http://nuovasecondaria.lascuolaconvoi.it
DIRETTORE
Giuseppe Bertagna - Università di Bergamo
COMITATO DIRETTIVO
Cinzia Susanna Bearzot - Università Cattolica, Milano
Edoardo Bressan - Università di Macerata
Alfredo Canavero - Università Statale, Milano
Giorgio Chiosso - Università di Torino
Luciano Corradini - Università Roma Tre
Lodovico Galleni - Università di Pisa
Pietro Gibellini - Università Ca’ Foscari, Venezia
Giovanni Gobber - Università Cattolica, Milano
Angelo Maffeis - Facoltà Teologicadell’Italia Settentrionale, Milano
Mario Marchi - Università Cattolica, Brescia
Luciano Pazzaglia - Università Cattolica, Milano
Giovanni Maria Prosperi - Università Statale, Milano
Pier Cesare Rivoltella - Università Cattolica, Milano
Stefano Zamagni - Università di Bologna
Redazione
RedazioneLuigi Tonoli, Lucia Degiovanni, Annalisa Ballini
Collaboratori redazionaliAndrea Potestio, Don Fabio Togni
Curatela Settore ScientificoFrancesca Baresi ([email protected])
ImpaginazioneFabio Paris Editions
Segreteria di RedazioneAnnalisa Ballini ([email protected])
Supporto tecnico area [email protected]
3
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 3
Gli articoli della Rivista sono sottoposti a referee doppio cieco (double blind). La documentazione rimane agli atti.Per consulenze più specifiche i coordinatori potranno avvalersi anche di professori non inseriti in questo elenco.
Salvatore Silvano NigroIULM
Maria Pia PattoniUniversità Cattolica, Brescia
Massimo PauriFisica teorica, Modelli matematici,
Università di ParmaJerzy Pelc
Semiotica, Università di VarsaviaSilvia Pianta
Geometria, Università Cattolica, BresciaFabio Pierangeli
Letteratura italiana, Università di Roma Tor VergataPierluigi Pizzamiglio
Storia della scienza, Università Cattolica, BresciaSimonetta Polenghi
Storia della pedagogia, Università Cattolica, MilanoLuisa Prandi
Storia greca, Università di VeronaErasmo Recami
Fisica, Università di BergamoEnrico Reggiani
Letteratura inglese, Università Cattolica, MilanoFilippo Rossi
Patologia generale, Università di VeronaGiuseppe Sermonti
Genetica, Università di PerugiaLedo Stefanini
Fisica, Università di MantovaFerdinando Tagliavini
Storia della musica, Università di FriburgoGuido Tartara
Teoria dei sistemi di comunicazione,Università di Milano
Filippo TempiaNeurofisiologia, Università di Torino
Marco Claudio TrainiFisica nucleare e subnucleare,
Università di TrentoPiero Ugliengo
Chimica, Università di TorinoLourdes Velazquez
Bioetica e Filosofia del Messico,Universidad Anáhuac, Northe Mexico
Marisa VernaLingua e letteratura francese,Università Cattolica, Milano
Claudia VillaLetteratura italiana, Università di Bergamo
Giovanni VillaniChimica, CNR, Pisa
Carla XodoPedagogia, Università di Padova
Pierantonio ZanghìFisica, Università di Genova
Vincenzo FanoLogica e filosofia della scienza,
Università di UrbinoRuggero Ferro
Logica matematica, Università di VeronaSaverio Forestiero
Biologia, Università Tor Vergata, RomaArrigo Frisiani
Calcolatori elettronici, Università di GenovaAlessandro Ghisalberti
Filosofia teoretica, Università Cattolica, MilanoValeria Giannantonio
Letteratura italiana, Università di Chieti - PescaraMassimo Giuliani
Pensiero ebraico, Università di TrentoAdriana Gnudi
Matematica generale, Università di BergamoGiuseppe Langella
Letteratura italiana contemporanea,Università Cattolica, Milano
Giulio LanzavecchiaBiologia, Università dell’Insubria
Erwin LaszloTeoria dei sistemi, Università di New York
Giuseppe LeonelliLetteratura italiana, Università Roma Tre
Carlo LottieriFilosofia del diritto, Università di Siena
Gian Enrico ManzoniLatino, Università Cattolica, Brescia
Emilio ManzottiLinguistica italiana, Università di Ginevra
Alfredo MarzocchiMatematica, Università Cattolica, Brescia
Vittorio MathieuFilosofia morale, Università di Torino
Fabio MinazziFilosofia teoretica, Università dell’Insubria
Alessandro MinelliZoologia, Università di Padova
Enrico MinelliEconomia politica, Università di Brescia
Luisa MontecuccoFilosofia, Università di Genova
Moreno MoraniGlottologia, Università di Genova
Gianfranco MorraSociologia della conoscenza, Università di Bologna
Maria Teresa MoscatoPedagogia, Università di Bologna
Alessandro MusestiMatematica, Università Cattolica, Brescia
Seyyed Hossein NasrFilosofia della scienza, Università di Philadelphia
Francesco AbbonaMineralogia, Università di Torino
Giuseppe AconePedagogia, Università di SalernoEmanuela Andreoni Fontecedro
Lingua e letteratura latina, Università di Roma Tre
Dario AntiseriFilosofia della scienza, Collegio S. Carlo, Modena
Gabriele ArchettiStoria Medioevale, Università Cattolica, Milano
Andrea BalboLatino, Università degli studi di Torino
Giorgio Barberi SquarottiLetteratura italiana, Università di Torino
Raffaella BertazzoliLetterature comparate, Università di Verona
Fernando BertoliniIstituzioni di Analisi Superiore, Università di Parma
Gianfranco BettetiniTeoria e tecniche delle comunicazioni,
Università Cattolica, MilanoMaria Bocci
Storia contemporanea, Università Cattolica, MilanoCristina Bosisio
Glottodidattica, Università Cattolica, MilanoMarco Buzzoni
Logica e filosofia della scienza, Università di Macerata
Luigi CaimiBiochimica e biologia molecolare, Università di Bre-
sciaLuisa Camaiora
Linguistica inglese, Università Cattolica, MilanoRenato Camodeca
Economia aziendale, Università di BresciaFranco Cardini
Storia medievale, ISU, Università di FirenzeMaria Bianca Cita Sironi
Geologia, Università di MilanoMichele Corsi
Pedagogia, Università di MacerataVincenzo Costa
Filosofia teoretica, Università di CampobassoGiovannella Cresci
Storia romana, Università di VeneziaLuigi Dadda
Elettrotecnica, Università di MilanoLuigi D’Alonzo
Pedagogia speciale, Università Cattolica, MilanoCecilia De Carli
Storia dell’arte contemporanea,Università Cattolica, Milano
Bernard D’EspagnatFisica, Università di Parigi
CONSIGLIO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEGLI ARTICOLI
Coordinatori del Consiglio:Luigi Caimi e Carla Xodo
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 4
Ma il Ministero conosce la scuola?Giovanni Gobber
EDITORIALE
5Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
Suscita apprensione l’uso burocratico del termine reclutamento, applicato agli insegnanti.È infatti parente della voce spagnola recluta, che a sua volta rinvia al francese recrue (darecroître ‘accrescere’): indicava, propriamente, un ‘arruolamento’ di nuovi soldati, per integrare
la truppa decimata dalle battaglie. Se il destino è di perire al fronte, c’è poco da stare allegri; ma incompenso, si porta a casa un po’ di denaro. Il docente non rischia la pelle ed è forse per questo cheviene retribuito poveramente.
Quanto lavora un insegnante? Chi ha proposto di aumentare le ore di insegnamento, senzacambiare la retribuzione, si basa sul tempo che egli o ella trascorre in aula. È un criterio come tanti.Anche un usciere der ministero sarebbe d’accordo. Il lavoro è interpretato come “ore passate sul postodi lavoro”. E siccome l’insegnante insegna (come direbbe Totò), deve insegnare di più, perché diciottoore alla settimana sono poche, se confrontate con le quaranta delle operaie d’antan. Del resto, lastampa quotidiana ed eziandio i rotocalchi settimanali ad usum tonsoris sono usi a lamentare iprivilegi del corpo docente: laddove italiane e italiani si vedrebbero costretti a ore di veglia negli uffici,nei negozi, financo nelle cantine, tutti in attesa che scocchi l’ora del rompete le righe, gli “operatoridella conoscenza” limiterebbero gli sforzi al minimo e, usciti dall’aula, si recherebbero freschi erilassati a zonzo, o a fare un altro mestiere ben retribuito.
Queste opinioni guardano alla quantità delle ore di lezione. Non tengono conto delle ore dedicate acorreggere compiti, fare programmi, discutere in riunioni etc. Soprattutto, non considerano l’intensitàdell’impegno e la concentrazione richiesta a un buon insegnante, il quale, come ogni professionista,deve affrontare situazioni sempre diverse e trovare soluzioni – non vi è monotonia nella scuola, che èluogo dell’imprevedibile. Insegnare non è “interagire” con macchine umane. Un’ora di lezione ben fattacosta più energie di una mattinata trascorsa “sul” posto di lavoro. I presunti privilegi della professionedocente esistono nelle opinioni e nelle dicerie degli untori della scuola. Basterebbe invece considerareche, nelle statistiche, la categoria degli insegnanti risulta fra le più colpite da stress psico-fisico.
Chi insegni e legga queste righe sorriderà amaramente: quante volte avrà udito parole aspre (nondiciamo “critiche”, perché la critica comporta capacità di giudicare), in bocca a personaggi cui serve unpomeriggio per sbrigare una pratichina, fare due calcoli, redigere mezza paginetta in una prosastentata. Tutti, poi, si ritengono capaci di insegnare, così come si considerano ottimi selezionatori dellaNazionale di calcio e ugualmente in gamba nel disegnare riforme elettorali. Fra cotanti tuttologi, gliesperti sono pochi. A ben vedere, non ci si improvvisa insegnanti: la professione richiede capacità epreparazione. Quest’ultima si può acquisire negli anni. Ma la capacità non viene da sola; è unapredisposizione della persona, che è disposta a coinvolgersi nell’impresa educativa. È, questa,un’avventura che logora e non sempre gratifica perché gli allievi fanno fatica a riconoscersi in debitoverso chi li ha formati – tanto più se le famiglie si sentono incaricate di proteggere i pargoli da presuntifannulloni capaci solo di dare voti negativi. Secondo un’opinione diffusa, la scuola è tenuta apreparare giovani esperti (i “tecnici” da inglese informatica impresa); deve però far loro apprendere
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 5
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX6
EDITORIALE
senza imporre una disciplina di studio e di comportamento – si ritiene che basti “andare su internet”(più wikipedia per tutti) e il gioco è fatto: allo stesso tempo, infatti, la scuola è considerata anzituttocome un luogo di socializzazione, una specie di oratorio (“laico”, beninteso).
Sarebbe ingeneroso pensare che i nostri governanti condividano simile coacervo di opinionicontraddittorie, di idées reçues messe in circolo anche dai mass media. Tuttavia, se si propone diaumentare le ore di lezione, vuol dire che ar ministero non si conosce la scuola. Questo nostrosospettaccio è alimentato pure dalle vicende recenti del TFA e dei bandi di concorso a cattedra.
Per accedere al tirocinio formativo attivo, si son dovuti superare tre esami scritti e uno in formaorale. Tutto questo si è svolto senza che sia stato indicato un programma, anche solo generico.Al candidato sono richieste conoscenze enciclopediche. D’altro canto, avviene pure che la verifica dellecompetenze in lingua straniera riveli lacune “drammatiche” (come usa dire oggi, per influsso inglese)e pure la matematica sembra mal messa. Un bell’esame è dunque necessario. Ma perché esigerel’enciclopedia? È facile ricorrervi, quando si ha il coltello dalla parte del manico. Gli stessi esaminatoriche chiedono la data di fondazione dell’Arcadia potrebbero cadere facilmente su una domandaintorno al sistema di versificazione di Metastasio – e non vi è dubbio che più di un giovane laureatosarebbe in grado di ridurre al silenzio più di un commissario.
È peraltro vero che molti si laureano con lacune simili a crateri lunari. Ne è prova il semplice fattoche a tentare le prove di accesso al TFA vi siano pure individui assolutamente impreparati – e sonoautentiche minacce per l’istituzione scolastica. È probabile che, anni prima, questi ultimi siano filtratitra le maglie larghette di qualche esaminatore all’università: qui bisogna ammettere che è mancata,non di rado, una valutazione coscienziosa. Anche per queste carenze e disattenzioni dell’accademia,l’avventura dei TFA sembra avviarsi con qualche difficoltà.
Sia poi consentito esprimere una riserva sul percorso previsto per la formazione: il tirocinio vero eproprio ha durata troppo breve. È invece notevole – nella durata del TFA – il carico dei corsi e deiseminari che si svolgeranno nelle Università: in proporzione, per queste attività è previsto il doppio deicrediti dati dal tirocinio nelle scuole. Al riguardo, è auspicabile che si eviti di riprodurre un aspettodavvero poco apprezzato dell’antica SSIS: la ripetizione di contenuti già previsti nei programmi deicorsi per i quali si è conseguita in precedenza la laurea. È inoltre lecito ritenere che non basti qualchesettimana di “osservazione” per decretare un’idoneità perenne. Non si attribuisce una patente senzaverifica periodica; del pari, non appare ingiustificata l’idea di vincolare il mantenimento in servizio alsuperamento di seri esami in itinere. Vanno inoltre previste verifiche del merito, tali che, per imigliori, sia garantito un riconoscimento ai fini professionale e retributivo. In molte realtà europee taliverifiche sono consuetudine. In Italia questo tarda a venire accettato perché il merito, nei fatti, non èriconosciuto (todos caballeros, ma con omologazione verso il basso).
Un argomento contro la verifica basata sul merito è: come si può stabilire la competenza di chi devegiudicare? È lecito ritenere che, per lo più, si tratti di un pretesto per sottrarsi a un giudizio. La scuolapubblica (statale o paritaria) ha l’interesse e il dovere di valutare i propri insegnanti. Tra l’altro, questoè un modo per certificare nella sostanza i titoli di studio rilasciati. Quanto più elevato è il prestigio delcorpo insegnante, tanto maggiore sarà il peso attribuito dalla società allo studio conseguito.
Contro la verifica del merito si pone, forse, un’altra ragione, cui è sensibile chi ci governa: i docentimigliori meritano un trattamento economico più elevato; ma non ci sono le risorse disponibili – e sitratta di un argomento povero: quando c’è la volontà politica, le risorse si trovano sempre. Se bisognarisparmiare, si può cominciare da tutto il resto, salvando la scuola e l’università.
Giovanni Gobber
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 6
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 7
FATTI E OPINIONI
Il fattodi Giovanni Cominelli
Scuola e Stato. La malattia mortale del neo-centralismoCome ogni inizio d’anno, anche quello del 2013 è stato accom-
pagnato, inevitabilmente, dalla retorica della speranza.
Tuttavia, per quanto riguarda le politiche di riforma delle isti-
tuzioni educative del Paese, ci troviamo pur sempre nella con-
dizione descritta nell’or acolo di Isaia, quando «una v oce
risuona da Seir in Edom» e si rivolge ad una scolta idumea: «Sen-
tinella! Quanto durerà ancora la notte? E la sentinella risponde:
Verrà il mattino, ma è ancora notte. Se volete domandare, tor-
nate un’altra volta». Alla vigilia di una campagna elettorale, tra
le più incerte del secondo dopoguerra, non ci attarderemo qui
a stilare l’ennesimo enciclopedico cahier delle domande senza
risposta relative a un sistema che pare aver scontentato tutti,
ma che vede pressoché tutti immobili nella soppor tazione.
Che cosa domandare? Forse è necessario partire dalle fonda-
menta dell’edificio, visto che “le ristrutturazioni” non hanno fer-
mato il declino. Giacché una cosa è certa: le piccole riforme non
servono che ad allungare l’agonia di un sist ema al collasso.
Muoversi dalle questioni di fondo non è una fuga utopistica
in avanti, come viceversa sostengono i sedicenti realisti o gli
scettici. Il punto di partenza è la constatazione che l’architettura
del modello, che lega da qualche secolo a questa parte Scuola,
Società, Stato, è deflagrata. Questi tre soggetti appaiono nei loro
rapporti reciproci come i tre lati sconnessi di un triangolo.
L’istituzione scolastica sembra vivere in un mondo a parte ri-
spetto alla società, che pure entra ogni mattina nei nostri edifici
scolastici sulle gambe dei r agazzi. Lo Stato, a sua v olta,
avvolge e imprigiona nella sua robusta rete amministrativa
l’universo dell’istruzione/educazione, contribuendo fortemente
all’isolamento dell’istituzione scolastica. Ciò che è saltata, tut-
tavia, è la base del triangolo, quella che collegava reciproca-
mente la Società e lo Stato. Dalla fine degli anni ’60, per quanto
riguarda l’Italia, lo Stato nazionale, politico e amministrativo
non è più la sintesi e il dominus della società civile. Nello schema
pessimistico di Hobbes e in quello più ottimistico di Hegel, gli
individui e la società sono il luogo del caos . Tocca allo Stato
– sia esso il risultato di un pacifico processo di contrattazione
tra le parti o l’esito di un’incarnazione violenta dell’Assoluto
nella Storia – pacificare, fare sintesi, impedire che la società im-
ploda nel conflitto dell’homo homini lupus.
I sistemi educativi furono pertanto fondati quali longa manus
dello Stato, come continuazione dello Stato con altri mezzi,
come luogo e canale di civilizzazione della società e dei suoi
conflitti.
L’hegelismo dei fratelli Spaventa nella seconda metà dell’Ot-
tocento e di Croce e Gentile dei primi del Novecento afferma
con grande coerenza: «Tale lo Stato, tale la Scuola». Questa cor-
relazione viene riproposta ancora oggi dal liberalismo centra-
lista, di fronte alla crisi del sistema. Quel che è certo è che i mu-
tamenti socio-culturali e antropologici hanno disconnesso quel
legame, che qualche nostalgico ha tentato illusoriamente in
questi ultimi anni di ripristinare nella scuola, all’insegna del
“Dio, Patria, Famiglia”, delle regole severe, della disciplina, delle
bocciature. E poiché si trattava di pura propaganda ideologica,
la realtà è andata in direzione del tutto opposta.
La ricostruzione del triangolo entro cui si svolge il processo
educativo è necessaria, se non si voglia approdare involonta-
riamente, ma tragicamente alla rottura del filo tra le generazioni.
Quale Stato? Questa è la domanda! Giacchè dietro l’afferma-
zione indubitabile che “tale è lo Stato, tale è la Scuola” si legge
in filigrana già un’idea di Stato. La pressione della crisi
finanziaria e del debito pubblico nonché la bancarotta e la cor-
ruzione dei centri di spesa sul territorio – Comuni, Province,
Regioni e, talora, scuole – stanno facendo rinascere l’illusione
di un neo-centralismo taumaturgico. Questa deriva è già in-
cominciata nel sistema di istruzione, in cui l’autonomia sco-
lastica, nata rachitica quale solo decentramento funzionale,
è stata gradualmente azzerata. Il ri-accentramento e l’impri-
gionamento sul letto di Procuste, per via di catene burocratiche
e amministrative, separa e al iena la scuola dalla società.
Perciò il tempo di apprendimento non è vissuto dai ragazzi
come tempo di vita. È un tempo alienato. Alienato per i ragazzi
e per i loro insegnanti. Così la scuola, che già deve sopportare
la delega educativa sempre più pesante delle famiglie e la pres-
sione del disagio sociale est erno, si tr ova a sua v olta a
generare disagio in proprio: nei ragazzi, sotto forma di noia,
depressione, aggressività, non-senso, e negli insegnanti, sotto
forma di demotivazione e di burn out crescenti.
Il tempo dello Stato educatore è finito. Questo era il messaggio
del nuovo Titolo V e dell’ipotesi federalista. Ma è evidente che
la politica e la società civile in Italia sono “ammalate di stato”.
Si tratta di una malattia mortale.
Giovanni Cominelli esperto di sistemi educativi
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 7
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX8
FATTI E OPINIONI
Fabula docet
Quando muore l’imperatore
Per questa Fabula vi racconto una storia che sembra giun-gere da lontano e subito si smarrisce in quella lontananzaproprio mentre si proietta come un’iridescente luce nelnostro futuro. Una favola da ultimo giorno. Il giorno dellamorte dell’imperatore Hirohito, il giorno in cui il Giapponeanche solo per un attimo si è fermato. È mai possibile fer-mare il mondo? La morte richiama il bisogno umanissimo,oggi così disatteso e banalizzato, di una liturgia. E la litur-gia, civile o religiosa, in qualsiasi modo la si prenda e la sipratichi, è infatti una grande e potente macchina simboli-ca capace per un momento di fermare il tempo, di con-templare l’attimo, di aprirlo all’infinito e all’eterno. Cosìnella lontananza che il mondo giapponese evoca, si spe-gne la figura ieratica di Hirohito, che un bellissimo film diSukurov, Il sole, ha raccontato proprio nei giorni dellasconfitta militare. Alla sconfitta ha fatto seguito la famosadichiarazione radiofonica in cui dichiarava di non esserepiù un dio. Hirohito, nel gennaio del 1946, pronunciò viaradio alla nazione il Tenno no ningen sengen (Dichiarazionedella natura umana dell’imperatore), con cui il sovrano di-
chiarava formalmente di non essere di natura divina, ne-gando di conseguenza la superiorità dei giapponesi neiconfronti delle altre nazioni del mondo. All’annuncio dellasua morte il 7 gennaio del 1989, molti, anche in Occidente,hanno avuto la percezione che stesse morendo non uneroe, non un gigante del secolo, ma un simbolo di qualco-sa che ci sfuggiva senza lasciarci indifferenti. In quell’ago-nia e poi nella sua morte, infatti, si sentiva vagamente lafine di un tempo, la cancellazione ultima di un enigma,dell’ultimo dimenticato segno di un tempo sacro. Un simbolo può vivere o morirema non sopravvivere, pena la suaobsolescenza e il suo oblio. Maperché questa fabula lontana einattuale? Che cosa lega la mortedell’imperatore con i temi cheagitano anche la nostra quoti-dianità, appena la guardiamosotto traccia? Forse una rispostaparziale la troviamo in una sor-prendente pagina di Elias Canet-ti Il diario da Hiroshima del dottorHachiya. In essa si racconta di un medicogiapponese di cultura occidenta-
Pensieri del tempodi Giuseppe Acone
Ultime notizie dal pianeta-scuola
Leggo sul Supplemento domenicale del Corriere della Sera (La Lettura del 7 Ottobre 2012),
quanto segue: «Il vero disastro è l’istruzione professionale da sempre considerata un ghetto,
diventato un tunnel senza speranza per gli studenti e un campo di battaglia per gli inse-
gnanti, che devono andare a lavorare con l’elmetto».
È l’estratto della dichiarazione di un bravissimo professore della scuola italiana, Gianfranco
Giovannone, autore del libro Perché non sarò mai un insegnante (Longanesi, Milano 2005),
dichiarazione fatta nel contesto di un’intervista assai equilibrata e con tratti di grande pene-
trazione pedagogica. Il professor Giovannone scrive con efficace e suggestiva lucidità.
Egli appartiene all’élite della docenza di questo povero Paese. Così accade che ci conforta
constatare che nella disastrata scuola italiana ci siano professori di tale levatura e compe-
tenza. Capaci di un loro umile eroismo in mezzo alle macerie. Ci crea dolore, invece, che tali
professori (i migliori) non possano nascondere un identikit del campo di battaglia in cui
operano, non possano fare da schermo ad una situazione insostenibile. Quanto emerge dal-
la dichiarazione del professor Giovannone al Corriere della Sera lascia comprendere che egli
continua ad operare in prima linea nonostante tutto.
Senza retorica, al prof. Giovannone e a tutti gli insegnati che operano sull’estrema frontiera
dell’istruzione professionale in Italia (in certi contesti ambientali si tratta di piccoli Bronx)
giunga, da questo piccolo pianerottolo della Rivista, il mio sincero sentimento di solidarietà.
Giuseppe Acone - Università di Salerno
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 8
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX9
FATTI E OPINIONI
le ricoverato dopo l’esplosione ad Hiroshima nell’ospeda-le che prima dirigeva e del suo disperato bisogno di trova-re un testimone per poter continuare a vivere da soprav-vissuto a quella immane catastrofe. Si racconta dell’illimi-tata gioia quando dentro quell’ospedale in rovine, tra itanti morti, venne ritrovato il ritratto dell’imperatore.
Ma l’imperatore esisteva sempre – scrive Canetti –, la continuitàdella vita dipendeva da quella di lui: anche durante la catastrofeche colpì la città il suo ritratto venne salvato. In mezzo alla folladegli agonizzanti e dei feriti gravi della città, poche ore dopol’esplosione della bomba atomica, il ritratto dell’imperatore vieneportato al fiume. I moribondi fanno posto: il ritratto dell’impe-ratore! il ritratto dell’imperatore! Bruciano ancora a migliaia dopoche il ritratto dell’imperatore è stato tratto in salvo e portato viada un battello.
Ma il dottor Hachiya non si dà pace dopo questo primoracconto:
egli va in cerca di ulteriori testimoni, in particolare di quelli chepresero parte all’impresa […] Si avverte – commenta Canetti –che di tutto quanto è successo, questo è per lui il fatto più riccodi speranza: suona come se fosse la sopravvivenza dell’impe-ratore.
Che cosa dunque cercava così perdutamente, là dove tut-to era morte e distruzione e il mondo sembrava non esse-re più, il dottor Hachiya? Non la sua vita o la sua individua-
le sopravvivenza, ma il ritratto dell’imperatore, che era lasopravvivenza stessa, il segno di una vita che poteva con-tinuare, l’ultima testimonianza di un mondo e di una uma-nità mortalmente ferita. Solo allora il medico giapponeseavrebbe potuto morire senza temere di essere con quellamorte del suo corpo biologico e storico anche annullatonel grande nulla della catastrofe, che cancella con la vitaanche il senso della sua esistenza.E se nella fine di Hirohito non abitasse lontanamente an-che per noi, l’ultima silenziosa agonia di un possibile testi-mone, tragica metafora, da cui poter dipanare un estremosenso alla vita? «Nous sommes au bord du désastre sansque nous puissions le situer dans l’avenir – scrive MauriceBlanchot – il est plutot toujours déjà passé et pourtantnous sommes au bord et sous sa menace». È su questo bordo, infatti, là dove “il ritratto dell’imperato-re” sembra smarrito e inesorabilmente dissolto dal tempo,che si alimenta necessariamente il nostro frenetico e an-goscioso commercio delle fotocopie per fermare la possi-bile e temuta nostra dissoluzione nell’oblio. «Una favola –diceva Goethe – che riporterà alla mente tutto e nulla». A noi scegliere. In questione, finalmente, non è poi la mor-te, ma la vita stessa.
Graziano Martignoni - Università di Friborgo (Svizzera)
Orari di insegnamento Ue e Ocse
I docenti italiani della scuola primaria svolgono 757 oredi insegnamento all’anno. La media oraria nei Paesidell’Unione è di 778 ore e quella dei Paesi dell’Ocse di779 ore, con una differenza rispettivamente di 21 e 22ore sotto la media (pari a -2,7%).I docenti italiani della scuola secondaria di primo gradosvolgono 619 ore di insegnamento all’anno. La mediaoraria nei Paesi dell’Unione è di 670 ore e quella deiPaesi dell’Ocse di 701 ore, con una differenza sotto lamedia rispettivamente di 51 (-7,6%) e 82 ore (-11,7%).I docenti italiani della scuola secondaria di secondogrado svolgono anch’essi 619 ore di insegnamentoall’anno. La media oraria nei Paesi dell’Unione è di 634 ore equella dei Paesi dell’Ocse di 656 ore, con una differenzasotto la media rispettivamente di 15 (-2,4%) e 37 ore (-5,6%).
Asterischi di Kappa
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 9
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX10
FATTI E OPINIONI
La lanterna di Diogenedi Fabio Minazzi
A proposito della pedagogia del bastone e della carota
Recentemente il Ministro Francesco Profumo ha evocato la peda-
gogia del “bastone” e della “carota”. Così ha affermato: «Dobbiamo
usare un po’ il bastone e un po’ di carota. Qualche volta un po’ di
più il bastone e un po’ di meno la carota. In altri momenti più carote,
ma mai troppe». A parte la larvata simpatia che sembra emergere
a favore della pedagogia del bastone (mai troppe carote!), come
uomini di scuola non possiamo non rimanere profondamente tur-
bati da questa affermazione. Possibile che chi occupa i vertici della
scuola e della formazione in Italia possa riferirsi alla “pedagogia del
bastone e della carota”? Vogliamo forse tornare all’esaltazione del
“santo manganello”? Vogliamo ricordare la brutta pagina di un gran-
de filosofo come Gentile che invoca la “pedagogia del bastone” per
raddrizzare la testa (e i pensieri) di un filosof o antifascista come
Martinetti? Oppure vogliamo dire che il popolo italiano andrebbe
trattato come un tempo si solevano trattare gli animali? Un tempo,
perché oggi non è più possibile picchiare un nostro fratello animale
senza incorrere – giustamente – nei rigori della legge che vieta di
procurare dolore ad un animale. Ma questo ministro ha mai pensato
che occupa la Minerva senza possedere uno straccio di mandato
popolare? Oppure si sente un “unto del signore” che, avendo in tasca
la verità, si può permettere di guidare un popolo recalcitrante di
docenti e studenti sulla strada del vero a colpi di zuccherini e di
bastonate? Purtroppo, l’affermazione del Ministro Profumo non
è un lapsus, ma è rivelatrice di una mentalità: quella di chi crede
veramente di avere il dovere di guidare, con mano ruvida, ma sicura,
dei bambini-docenti e dei bambini-studenti, recalcitranti, sulle vie
del vero, del bello e del buono.
Fabio Minazzi Università dell’Insubria
Credo. Aiutami nella mia incredulità!
Sembrerebbe esprimere una contraddi-
zione la preghiera di questo papà: cre-
de o non crede? In effetti la sua è una
delle preghiere più belle che il Vangelo
ci consegna, sospesa com’è tra fede e
incredulità; parola di una fede umile e
consapevole di altezze vertiginose im-
possibili all’uomo.
La preghiera del padre protagonista
dell’episodio nasce dal bisogno di avere
da Gesù un gesto che liberi il figlio epi-
lettico dalla terribile malattia che lo tie-
ne schiavo. “Se puoi qualche cosa…
abbi pietà di noi!”. A Gesù sembra non
piacere questa preghiera, e rimprovera
il padre: tutto è possibile a chi crede!
Ma questo uomo tenace non si
arrende, mostrando al tempo
stesso di riconoscere la sua poca
fede e la sua fiducia in Gesù: «Cre-
do, aiutami nella mia increduli-
tà». Ora che si è reso conto di
quanto fragile sia la sua fede, può
affidarsi all’impossibile di Dio e
ottenere il miracolo.
Ed è come se Gesù avesse voluto
dirgli: tu mi hai chiesto la guari-
gione del figlio, ma io voglio darti di
più, voglio che tu impari a fidarti di Dio,
a credere che Lui non solo può guarirti
il figlio, ma può liberarti per sempre
dalla paura e darti la forza di coloro che
si affidano. Quella di questo padre è
una preghiera che interpreta intensa-
mente l’esperienza spirituale di coloro
che, credenti in Dio, sono consapevoli
che la fede può misurarsi solo con il
metro dell’infinito. E con questo metro,
è sempre povera, fragile, piccola.
Fede e incredulità vivono dentro la co-
scienza del credente, in una tensione
continua che permette alla fede di non
trasformarsi in tranquillo possesso, ma
di restare apertura a Dio, nell’attesa del-
la sua compassione e nella disponibilità
al suo imprevedibile mistero: all’impos-
sibile, appunto!
Solo chi è convinto di avere una fede
certa e incrollabile è così sicuro di sé da
non avvertire più il bisogno di affidarsi
a Dio; e allora si colloca veramente nel
numero degli increduli.
Paola BignardiPubblicista, già presidente nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana
Il Vangeloe la vitadi Paola Bignardi
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 10
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 11
FATTI E OPINIONI
Asterischi di Kappa
Il futuro alle spalledi Carla Xodo
Dalla parte dei giovani
La storia o la fortuna delle parole riesce qualche volta a darti lo spaccato di
un momento della società rispetto al quale lunghe e dotte dissertazioni po-
trebbero sembrare periferiche. Il termine che aleggia sopra le nostre teste,
carico di quella suggestione che provoca il mistero – così suppongo sia per
gran parte dell’opinione pubblica – è choosy. Pur derivando da un verbo
molto comune, to choose che significa scegliere, ha una connotazione infor-
male, allude a una caratteristica giovanile. L’aggettivo veleggia col vento in
poppa perché è stato pronunciato da una figura istituzionale di grande po-
polarità e visibilità come il ministro Fornero. Tradotto magnificamente con
l’italiano “schizzinoso”, nelle intenzioni del ministro era/è inteso a qualificare,
o squalificare, l’irresponsabilità di molti giovani che “fanno i difficili” quando
viene loro offerta una chance di lavoro. Detto terra terra: i giovani, o almeno
parte di essi, si fanno male da soli, sono irresponsabili, dovrebbero farsi su le
maniche e accettare tutto quanto viene proposto, all’insegna dell’adagio
meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma c’è un ma.
Quel “ma” è rappresentato da un tratto intollerabile di parte della società.
Fu Mario Monti a stigmatizzarlo quando era commissario europeo. Son
passati quasi dieci anni da allora, ma nulla è mutato: resta aperta, anzi
apertissima, la questione giovanile, con la crisi e prima della crisi. Monti
parlava esplicitamente di “egoismo” degli adulti e da cos’altro dovrebbe
derivare la condizione di chi – la maggioranza – affronta il futuro senza fu-
turo, costretto per lo più a pagare per scelte di chi è venuto prima, preoc-
cupato solo del suo “particolare”, del suo oggi?
Il ministro Fornero la conosce di sicuro, ma vale la pena ricordare comun-
que la sofferenza di chi, dopo aver speso parte di giovinezza e risorse familia-
ri per conseguire una laurea, trova tutte le porte sbarrate. Prendiamo un cor-
so di laurea “difficile” come ingegneria: costoso, non fosse altro perché com-
porta un tempo mediamente lungo per il suo completamento, ma appetibile
perché dovrebbe garantire un accesso rapido al lavoro. Capita non di rado
che in colloqui per un posto di lavoro ci si senta chiedere di dar conto del-
l’esperienza maturata. Ma se trovi le porte chiuse e hai problemi economici
in famiglia, come avviene di frequente, ti devi adattare con la tua laurea a
svolgere lavoretti precari, come consegnare pizze a domicilio o fare il came-
riere in una birreria. In questo caso non saresti “choosy”, come dice la ministra
Fornero, ma che ne è del tuo “curricolo”? Rimarrai sempre al palo. Ma allora la
ministra dovrebbe completare così: «Non siate “choosy”, ma pensateci bene
prima di andare all’università, perché vi costa tempo e denaro e non vi dà
quasi nulla di ciò che vi promette». Ma questo sarebbe troppo per quello che
è ed è stata l’università. Forse per sistemare il motore sociale il cacciavite non
serve proprio più, non sarebbe più in grado di rimettere in sesto le cose.
Carla Xodo Università di Padova
Europa: le chiese diventanomoschee
L’oriente è pieno di chiese trasformate inmoschee, come la Omayyade di Damasco, laIbn Tulun del Cairo e la cattedrale di SantaSofia a Istanbul. Anni fa una profezia delloscrittore franco-romeno Emil Cioran gettòuna luce sinistra anche sull’Europa: «Ifrancesi non si sveglieranno fino a che NotreDame non sarà diventata una moschea». Si è tornati a citare Cioran ora che la chiesadi Saint-Eloi a Vierzon, fra la Loira e laBorgogna, diventerà un luogo di cultoislamico. La diocesi di Bourges, in mancanzadi fondi e fedeli, l’ha messa in vendita el’offerta più significativa, oltre a quella diaziende e commercianti, è arrivatadall’Association des Marocains. Il quotidiano Berry Républicain rivela chesono stati i fedeli, in accordo con la diocesi diBourges, ad appoggiare la scelta ditrasformarla in moschea. Recentemente sonousciti i dati sul cosiddetto “sorpasso islamicoin Francia”, dove si costruiscono più moschee,e più di frequente, di chiese cattoliche, e cisono più praticanti musulmani che cattolici.Il più noto leader islamico, Dalil Boubakeur,rettore della gran moschea di Parigi, haipotizzato che il numero delle moschee dovràraddoppiare, fino a quattromila, persoddisfare la domanda. Da anni gruppimusulmani stanno chiedendo ai cattolici ilpermesso di usare le chiese vuote, anche senzaacquisirle, per risolvere i problemi di trafficoprovocati da migliaia di musulmani chepregano in strada. Un fenomeno, quello dellaconversione delle chiese in moschee, comune atutto il centro e nord d’Europa. In Olanda250 edifici dove per oltre un secolo hannopregato cattolici, luterani e calvinisti hannocambiato di mano. In Germania quattrocentochiese cattoliche e cento protestanti sonostate chiuse. La Scandinavia vive lo stessofenomeno. In Inghilterra diecimila chiesesono state chiuse dal 1960 e per il 2020 siprevede la dismissione di altre quattromila. (da G. Meotti, «Il foglio», 18 ottobre 2012).
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 11
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX12
FATTI E OPINIONI
Risposta a domanda
Contestazione di addebito per votibassi?
Un lettore chiede se il Dirigente Scolastico, sulla base di lamen-
tele ricevute nei confronti di un insegnante, possa avviare pro-
cedimenti disciplinari, contestando al doc ente l’addebito,
senza averlo prima consultato. Abbiamo chiesto il parere a tre
esperti.
Spett. Nuova Secondaria,pongo la seguente domanda. Può il Dirigente Sc olasticoavviare procedimenti disciplinari sulla base di presunte lamen-tele verbali o scritte contro qualche docente, il quale si ritrovala lettera protocollo riservato tra capo e collo, con tanto di “con-testazioni di addebito ”… senza av erne nemmeno saputauna parola prima? Così, il suddetto “inquisito”, convocato a ri-spondere formalmente (cito il caso di un collega a me noto),si è giustificato puntualmente a voce e per iscritto, motivandoi “voti bassi” di quella certa verifica (l’oggetto del contenzioso)i quali gli erano stati imputati come una colpa: ha ricordatoil suo metodo di lavoro, funzionale alle “conoscenze” e alle “com-petenze” tanto reclamizzate nel POF e richiamate nei Piani diLavoro, la condivisione coi colleghi dei criteri di valutazione, laprogrammazione della prova, fatta per tempo e accompagnan-do la scolaresca con spiegazioni chiare e “sondaggi” (verificaformativa). Ha anche fatto presenti le difficoltà incontrate (pres-soché da tutti i colleghi) a lavorare in quella certa classe, mai suoi argomenti sono stati giudicati “non pertinenti”. […] Anzi,pure la beffa. Si aggiunge che non si son visti “segni di ravve-dimento” nelle sue parole.
Lettera firmata
Nel merito delle questioni proposte due sono gli aspetti
che richiedono un approfondimento, l’uno di contenuto, l’altro
di carattere procedurale o di metodo.
Quanto alla domanda se sia legittima o meno la contestazione
di addebito, «senza averne nemmeno saputa una parola pri-
ma» e «solo sulla base di pr esunte lamentele verbali o
scritte», la risposta è chiara. L’operato del dirigente scolastico
è formalmente corretto:
«Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cuiil dipendente lavora... quando ha notizia di comportamenti pu-nibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primoperiodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni con-testa per iscritt o l’addebito al dipendente medesimo e loconvoca per il contraddittorio a sua difesa» [D.lgvo 150/2009,art. 69, cma 2].
Tuttavia… si tratta davvero di una decisione giusta e inop-
pugnabile? Lo sarebbe a queste condizioni: il dirigente sco-
lastico a) ha ritenuto che l’attribuire «‘voti bassi’ in quella certa
verifica (l’oggetto del contenzioso)» fosse comportamento
punibile; b) ha ritenuto trattarsi di «infrazione di minore gra-
vità», per la quale è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori
al semplice «rimprovero verbale».
Ora, attribuire un ‘voto basso’ in una verifica è davvero un com-
portamento punibile? A quale dovere professionale sarebbe
venuto meno il docente? In questo caso, si potrebbe far rife-
rimento a mancanze lievi ai doveri inerenti alla funzione do-
cente o i doveri di ufficio (art. 492 D.Lgs.297/94), per le quali
è previsto il «rimprovero scritto», o a mancanze non gravi (art.
493 D.Lgs.297/94), per le quali è prevista la «censura». Ma a
che condizioni si può affermare che l’attribuire un voto basso
può essere considerato mancanza liev e o non gr ave? A
condizione che si provi e si documenti, oltre ogni possibile dub-
bio e alla luce del dispositivo di valutazione (criteri, procedure,
strumenti e metodi) deliberato a livello di Istituto alla luce degli
ordinamenti, che il docente manifesti «inefficienza ed incom-
petenza professionale»; ossia che non sappia verificare e va-
lutare.
Il punto è che, se non ricorrono queste condizioni, in modo
inequivocabile, il il comportamento del dirigente scolastico
risulterebbe lesivo della libertà di insegnamento del docente,
salvaguardata dalla norma costituzionale.
E ancora, posto che il dirigente sia in grado di provare e do-
cumentare l’incompetenza valutativa del docente, resta da ca-
pire perché abbia esperito la via del procedimento disciplinare
e non altre modalità di intervento, quali ad esempio l’esercizio
del ruolo di guida cultur ale, pedagogica e didattica dei
docenti che pure gli appartiene; oppure il semplice colloquio
chiarificatore o, al limite, il rimprovero verbale. Il fatto che abbia
deciso per una linea rigidamente censoria lascia pensare che,
nel caso in esame, si sia trovato di fronte a incompetenza va-
lutativa, oltre che documentata anche reiterata, per la quale
le misure già esperite si siano dimostrate inefficaci. Se così non
fosse (come il docente afferma), il comportamento del diri-
gente desterebbe molte perplessità, anche per quanto con-
cerne il metodo.
Ermanno PuricelliDirigente scolastico
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 12
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 13
FATTI E OPINIONI
La questione sollevata è generale e merita qualche riflessione:
è giusto che i dirigenti dispongano di margini di discrezionalità?
Sul piano giuridico, la risposta è nota a tutti quelli che si oc-
cupano di gestione del personale e di pubblica amministra-
zione: la discrezionalità di chi deve decidere è non solo neces-
saria, ma perfino utile – in via generale – a chi è oggetto di de-
cisione. Il libero convincimento è garanzia che il giudizio non
si trasformi in un automatismo disumano e che tutte le circo-
stanze possano essere pesate in modo equo e conforme a giu-
stizia e non solo a diritto. Son convinto che la domanda accorata
del docente vada più correttamente riferita non ai margini di
discrezionalità, ma all’utilizzo che nel caso concreto ne è stato
fatto. Utilizzo che – se le cose sono effettivamente andate come
riferito – appare effettivamente abnorme. Certo, occorrerebbe
chiedersi se non ci fossero altre circostanze che non emergono:
per esempio, se vi f ossero precedenti; se la sev erità del
giudizio si fosse accompagnata con argomentate motivazioni
o fosse stata espressa in modi apodittici e forse umilianti, come
purtroppo accade.
Ma qui si inserisce la seconda riflessione che l’episodio suscita
e che sembra più rilevante: comunque siano andate le cose, bi-
sogna saper tenere distinti i piani, professionale e disciplinare.
La questione della severità del docente, che fosse eccessiva o solo
giusta, era chiaramente di natura professionale. Questo tipo di
problemi va gestito con strumenti diversi, in primo luogo attra-
verso un colloquio. Qui non è in gioco la competenza relativa a
una specifica materia: sono in causa aspetti docimologici, peda-
gogici e relazionali sui quali tutti coloro che operano o hanno
operato in classe dovrebbero parlare un linguaggio comune, fatto
di esperienza ma anche di riflessione e di studio teorici.
Per dialogare, naturalmente, bisogna essere in due: e qui tor-
niamo alla difficoltà iniziale di attribuire torti e ragioni in una
vicenda della quale siamo tutti informati solo in via indiretta.
Se il dialogo sia mancato perché il dirigente abbia preferito im-
boccare impropriamente una scorciatoia disciplinare o perché
il docente si sia arroccato nell’intangibilità della propria auto-
nomia valutativa, non lo sappiamo e potr ebbero dirlo solo i
diretti interessati. Di certo quando sono in gioco i ragazzi, tutti
gli attori dovrebbero prima cercare di comprendere e di com-
prendersi, piuttosto che troncare le vie del dialogo.
Giorgio RembadoPresidente dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti
e alte professionalità della scuola)
La procedura seguita dal Dirigente è corretta sul piano
formale se sono state espletate tutte le fasi. Vanno considerate,
infatti, le novità introdotte in materia disciplinare e cautelare
per il personale della Scuola con il D.Lgs. n.150/2009 meglio
noto come Decreto Brunetta emanato in applicazione della
delega ex Legge n. 15/2009, che innova profondamente le
norme sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti pub-
blici.
Le nuove norme sul Codice disciplinare che la Legge citata con-
tiene modificano l’art. 55 del D. L.vo 165/2001, con l’introdu-
zione di altri sett e articoli fino al 55 octies, con nuove
procedure. Sostanzialmente cosa cambia per i docenti? Avver-
timento scritto, censura e sospensione senza retribuzione fino
a dieci giorni sono ora di competenza del dirigente scolastico,
con le modalità e i termini indicati dalle nuove norme.
L’avvio del procedimento disciplinare avviene quando il di-
rigente «ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo (dal rim-
provero verbale alla sospensione dal servizio, senza retribu-
zione, fino a dieci giorni)» e «senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito».
Per sanzioni superiori al rimprovero verbale è necessaria, quindi,
la contestazione dell’addebito, che deve contenere l’esposi-
zione degli aspetti essenziali del fatto contestato e deve essere
preceduta dall’accertamento del fatto mediante testimonianze,
raccolta di documentazione, eventuale audizione del dipen-
dente, senza però instaurazione di un contraddittorio. Succes-
sivamente alla contestazione d’addebito, il dirigente scolastico
deve convocare il docente «per il contraddittorio a sua difesa
[…] con un preavviso di almeno dieci giorni». Il dipendente
può avvalersi dell’eventuale assistenza di un avvocato o di un
sindacalista (non entrambi).
Fin qui le norme, va da sè che il caso, come descritto dal do-
cente, meriterebbe un ulteriore approfondimento. Comunque
il buon senso avrebbe voluto che il primo approccio al pro-
blema, che sembra riguardare esclusivamente le modalità di-
dattiche e valutative, il dirigente lo avesse prima delegato a
pacati e chiarificatori colloqui con il docente.
Paola TonnaPresidente dell’Apef
(Associazione per educatori e formatori)
NS5 01-13:Layout 1 15-11-2012 16:34 Pagina 13
Una rete di emozioni Barbara Bruschi
SIAMO PER FORTUNA CONSAPEVOLI DEI LIMITI DI UNA TV CHE SPETTACOLARIZZA LE EMOZIONI, MA FORSE
NON CI RENDIAMO ANCORA BENE CONTO DI COME QUESTO FENOMENO SIA PRESENTE ANCHE NELLA RETE, CON MECCANISMI PIÙ SOTTILI MA ALTRETTANTO CONDIZIONANTI. QUANTO PERDE IN PROFONDITÀ UN’EMOZIONE VISSUTA COSÌ? IL CASO, AD ESEMPIO, DELLA TRISTEZZA.
Forza ragazzi! questo gruppo si sostiene
da sé... non servono link con frasi fatte,
qui ognuno racconta la propria storia e
insieme si possono superare momenti
difficili... (da Facebook)
Spesso è possibile ricondurre le di-
verse epoche ai simboli che le
hanno caratterizzate. Volendo in-
dividuare gli aspetti che potr ebbero
connotare la nostra epoca, potremmo fa-
cilmente scegliere la mediazione e la con-
divisione.
Il contestoLe analisi sociologiche e demografiche,
da diversi anni, riportano il fatto che la
maggior parte delle persone possiede
numerose tecnologie per la mediazione
e ne fa un ampio impiego per interagire
con i pari, ma anche per esplorare le realtà
attorno a sé. La comunicazione diretta,
quella basata sulla sincronia e sulla con-
divisione di un medesimo luogo non
sembra più così frequente, al punto che,
in alcuni casi, ad essa si preferisce quella
mediata1. Non possiamo negar e che le
tecnologie ci hanno reso difficile accet-
tare le criticità connesse alla distanza: dif-
ficilmente, oggi, potremmo tollerare di
non sentire un nostr o caro per mesi,
solo perché si è trasferito dall’altra parte
del mondo o di non avere notizie di un
amico per intere giornate in quanto re-
sidente in una città distant e qualche
centinaio di chilometri dalla nostra. Sa-
remmo egualmente infastiditi dal non
poter comunicare, in tempo reale e più
volte al giorno, con chiunque ri entri
nella sfera dei nostri affetti. Abbiamo ne-
cessità di essere connessi e poco distanti
a prescindere dallo spazio e dal tempo
in cui viviamo. Il nostro contatto con l’al-
tro, oltre ad essere immediato, deve ri-
spondere ai criteri di rapidità e dinami-
cità tipici, in par ticolare, delle nuo ve
tecnologie e dei servizi messi a disposi-
zione da queste. Un cellulare spento o la
mancata risposta ad un sms sono in gra-
do di alterare il tono dell’umore della
gran parte della popolazione del mondo
occidentale.
Questo fenomeno trae origine in diversi
fattori tra cui spicca, soprattutto attual-
mente, la necessità di condividere. Infatti,
i nuovi prodotti mediali quali i social net-
work nascono e si diffondono sul prin-
cipio della condivisione. Da Facebook a
Twitter, passando attr averso qualche
decina di altre applicazioni, l’imperativo
categorico è: mettere in c omune. In
questi contesti siamo ciò che diamo
agli altri, ciò che lasciamo sul nostro pro-
filo affinché gli altri si costruiscano una
rappresentazione della nostra identità.
Passionari, tristi, solari o malinconici, i no-
stri “post” rappresentano gli ingredienti
per la configurazione e riconfigurazione
perenne del nostro io mediato. Nel mo-
mento stesso in cui pubblichiamo in rete
una fotografia o una frase noi siamo ciò
che quella fotografia o quella frase signi-
ficano, a prescindere da tutto il resto, dal-
la nostra storia precedente, dalla nostra
realtà, dal nostro essere un istante dopo.
Queste caratteristiche delle r elazioni
attuali interessano in particolare chi, a di-
verso titolo, si occupa di adolesc enti.
Come noto, i contesti mediati della co-
municazione sono, per la gran parte
degli adolescenti, un terreno molto fre-
quentato che ha assunto un valore so-
ciale decisamente importante. In parti-
colare, il nostro interesse di insegnanti
ed educatori è dato da una serie di ele-
menti che parrebbero ben sintetizzare
alcuni aspetti r elativi all’impiego dei
social network da parte dei più giovani.
Essi sono:
• l’estemporaneità delle emozioni;
• l’effimero emotivo;
• il virale emozionale;
• la spettacolarizzazione delle
emozioni;
• il Caos emotivo.
Di seguito illustreremo ciascuno di
questi fattori con una declinazione par-
ticolare rispetto alla tristezza. Tale scelta
è determinata dal fatto che questa emo-
zione, forse più di altr e, richiama un
tipo di intimità particolare che, general-
mente, tendiamo ad esibire con una cer-
1. Si pensi all’impiego degli sms e dei social network so-prattutto tra i più giovani.
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
14 Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 14
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
ta cautela anche quando essa viene
resa pubblica. Inoltre, la tristezza può es-
sere associata ad ev enti anche gr avi
che ci si aspetterebbe venissero affron-
tati con una delicatezza e un rispetto par-
ticolari, assai differenti dai toni e dagli
spazi che qualsiasi social network può as-
segnare loro. La realtà dei fatti ci dimostra
una certa presenza di questa emozione,
nell’ambito delle discussioni online, af-
frontata, spesso, con una leggerezza e
una semplicità che inducono alla rifles-
sione.
Quanto dura un’emozioneCominciamo affrontando il primo aspet-
to che riteniamo meriti una certa atten-
zione: l’estemporaneità delle emozioni. La
scrittura all’interno dei canali del web 2.0
è spesso improvvisata. Si scrive, appunto,
sull’onda delle emozioni o in risposta a
qualcosa che ha suscitato il nostro inte-
resse o ancor più un moto di empatia. Si
scrive per condividere ovvero per met-
tere i nostri “amici” a parte di quanto ci
sta accadendo. I messaggi che ne risul-
tano sono assai lontani dalla riflessione
che ha per lungo tempo caratterizzato
la comunicazione scritta.
La stesura di una lettera, spesso, richie-
deva tempo, quello necessario per sce-
gliere con cura le parole giuste, la forma
più appropriata al contenuto da trasmet-
tere e più adatta al nostro interlocutore.
I post non rispettano nessuna di queste
condizioni: si digitano le lettere sulla ta-
stiera e si preme invio; in pochi attimi si
genera e si consegna al pubblico qualun-
que nostro pensiero, qualsiasi conside-
razione, qualsiasi emozione. Non importa
se l’espressione risulterà esagerata, pe-
ricolosa, offensiva.
Ciò che interessa è esserci e dimostrare
di essere non solo pr esenti, ma anche
pensanti ed emotivamente attivi. Coloro
che frequentano abitualmente i social
network non si limitano a c ondividere
considerazioni su argomenti generali o
di interesse comune. Quel che caratte-
rizza questi contesti relazionali e comu-
nicativi è proprio il fatto di oltrepassare
qualsiasi confine tra pubblico e privato
e di puntare dritto alla sfera più intima
delle persone ovvero quella affettiva ed
emotiva. Prendiamo ad esempio uno dei
tanti post in cu i ci si può imbatt ere
esplorando le comunità di Facebook: «È
il blog personale, vorrei condividerlo con
voi del gruppo! Pur esponendomi diret-
tamente, infondo (sic) non c'è niente da
celare di se stessi, raccontarsi crea unio-
ne».
Appare immediatamente evidente non
solo l’annullamento pressoché radicale
di un confine tra pubblico e privato, ma
l’intento di creare comunità sulla base
dell’esternazione totale dei propri sen-
timenti, della propria emotività. In fun-
zione di questo non distinguo ciò che
può essere detto a tutti da ciò che
merita di essere trattato con maggior ri-
serbo e nemmeno scelgo piani differenti
di comunicazione. La relazione si trasfor-
ma in un fiume che, a seconda delle si-
tuazioni, potrà essere calmo e scorrere
tranquillo, ma che assai rapidamente po-
trà agitarsi ed esondare lasciando dietro
di sé detriti e segni talvolta indelebili del
proprio passaggio. Infatti, come tutto ciò
che non è scelto, preparato, calibrato e
selezionato, i messaggi lasciati all’interno
dei social network generano memorie in-
delebili capaci di fare ritorno nei momenti
più impensati. Parimenti, ciò che è estem-
poraneo appare in qualche modo privo
di radici: si prova un’emozione, si pubblica
un post e poi si v a avanti, magari cam-
biando completamente argomento, lin-
guaggio, registro comunicativo.
Gli esempi sono molt eplici, ma uno
tratto dall’attualità degli ultimi mesi ci
pare particolarmente rilevante. Nel mese
di aprile è deceduto in campo un giova-
ne calciatore: Morosini. È naturale che
questo lutto abbia avuto risonanza non
solo in ambit o calcistico. Questo caso
però, forse per la prima volta, ha avuto
dimensioni e caratteristiche differenti da
quanto si era potuto vedere in preceden-
za. In questa occasione il lutto è stato co-
struito, diffuso e fatto vivere all’interno
dei social network. Si è assistito a una sor-
ta di gara di velocità a chi twittava per
primo un c ommento alla tr agedia, a
chi, sul proprio profilo Facebook, riusciva
ad esprimere con le parole più toccanti
la propria tristezza in una sorta di rituale
per la celebrazione, non solo del c om-
pianto calciatore, ma della trist ezza in
quanto tale.
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
15
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 15
deo e brani dai quotidiani per incremen-
tare il pathos e rendere la notizia adegua-
ta, salvo cambiare completamente tono
e contenuto 30 secondi dopo, ovvero in
occasione del post successivo.
Si genera così ciò che abbiamo definito
l’effimero emotivo. Un’emotività veloce e
potente, ma che dura pochi istanti, che
non ammette il tempo del silenzio e della
riflessione, perché nei social network il si-
lenzio non è ammesso in quanto sinoni-
mo di assenza: nella grande rete della
condivisione, non è possibile essere as-
senti se si vuole continuare ad esistere.
Ciò che induce a riflettere non è tanto la
velocità di obsolescenza delle emozioni,
cui, probabilmente, ci aveva già in parte
abituati la televisione, quanto il rapporto
che questi vissuti dell’intimità hanno
con la vita fuori dai social network. In pra-
tica ci chiediamo se il Juk ebox delle
emozioni, che si applica nei social net-
work, non induca, soprattutto nei più gio-
vani, una sorta di bulimia emotiva che po-
tenzierebbe la tipica ricerca di emozioni
forti degli adolescenti e accrescerebbe
quel desiderio di distruzione dei legami
individuato da Pietropolli Charmet (2008).
La velocità e la potenza dei messaggi, ap-
pena menzionate, sono associate alla co-
municazione virale tipica dei social net-
work. Un messaggio può diffondersi ad
altissima velocità e coinvolgere una po-
polazione difficilmente raggiungibile
con altri mezzi e, in particolare, nello stes-
so arco temporale.
ContagioOvviamente, questo aspetto riguarda
anche la diffusione delle emozioni che dà
luogo ad un virale emozionale: una sorta
di turbinio di emozioni che rapidamente
passano nei profili di centinaia di persone
che a loro volta, senza troppo rifletterci e
spinti più dall’istinto che da una v era e
propria condivisione di sentimenti, con-
tribuiscono a mandare in circolo. Con po-
chi clic un’intera popolazione di amici o
presunti tali si troverà a condividere il me-
desimo stato d’animo o ad esprimersi in
merito con qualche considerazione altret-
tanto rapida ed estemporanea. Non si trat-
ta di un fenomeno di per sé critico, anzi,
in alcuni casi questa capacità del web può
essere anche utile. Ciò che tende a lasciare
perplesso, chi non si è ancora completa-
mente adeguato a questi trend, sono l’an-
sia, dimostrata dai più, di farsi coinvolgere
in vissuti emotivi che, sino a quel momen-
to, erano loro assolutamente estranei.
Estranei in quanto non appartenenti al
campo delle esperienze personali. A chi
è cresciuto in un contesto relazionale ba-
sato sul principio della presenza, della co-
noscenza diretta (Granieri, 2009, p. 117) e
sulla netta distinzione tr a pubblico e
privato può risultate difficile comprendere,
e accettare come sinceri, certi moti del-
l’animo che proprio in quanto tali sem-
brano entrare in collisione con un approc-
cio esibizionista e spettacolare.
2. «Nella società dei consumi della modernità liquida iltempo non è né ciclico né lineare, come normalmenteera nelle altre società della storia moderna e postmo-derna. Intendo mostrare che esso è invece puntillistico,ossia frammentato in una moltitudine di par ticelle se-parate, ciascuna ridotta a un punt o che sempre più siavvicina all’idealizzazione geometrica dell’assenza di di-mensione».
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
16 Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
Al centro del vortice di messaggi che par-
lavano della sua morte non c’era la tri-
stezza per il giovane strappato alla vita,
c’era la necessità di esserci nel momento
in cui si andava costruendo il dolore con-
diviso. A essere importante non era il ri-
cordo della persona, ma il dimostrare di
partecipare, attraverso il proprio post o
il proprio twit, a un lutto dalla potenza
incredibile. Incredibile quanto la velocità
con cui, con un altro post, si cambia ar-
gomento. Ciò perché la pagina di Face-
book o di qualsiasi altro social network,
non è fatta per ospitare la continuità, l’ap-
profondimento, ma per surfare tra emo-
zioni, sentimenti e messaggi in un
tempo che Bauman definisce puntillistico
(Bauman, 2009, p. 56)2.
In questo modo, riferendoci ad un altro
esempio, accanto alla fotografia che ri-
trae la propria nonna che, sotto choc, la-
scia il suo paese terremotato, troveranno
eguale cittadinanza la fotografia di un
gatto che dorme in una posizione biz-
zarra, il video con l’ultimo clip di Adèle
e la ricetta per cucinare bellissime torte
con i Marshmellows. Ciascuno di questi
post avrà i suoi commenti: gli amici
spenderanno parole tristi per la povera
nonna, eventualmente recuperando vi-
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 16
L’emozione fa spettacoloLa mia tristezza o la mia rabbia diventano
la strada più breve per avere il proprio
momento di c elebrità. Ritorniamo al-
l’esempio della nonna terremotata citato
poc'anzi. Postando la sua immagine e al-
cune parole di accompagnamento, riesco
ad attirare su di me l’attenzione del po-
polo dei miei amici che, in virtù del mi-
racolo della condivisione, si sentiranno
immediatamente nel dovere di parteci-
pare alla mia sofferenza e costruire attor-
no ad essa un momento celebrativo di di-
mensioni impensabili nelle realtà fisiche
al di fuori della r ete. In uno sc enario di
questo tipo viene naturale chiedersi se
l’ansia di condivisione non corrisponda
a una necessità insoddisfatta di gratifica-
zione. Come alcuni osser vatori hanno
avuto modo di sostenere, si ha netta la
sensazione che molti di coloro che ten-
dono a consegnare i propri vissuti più in-
timi o quantomeno il proprio bagaglio
emotivo ai post dei social network, in
qualche modo stiano c ercando di c o-
struirsi un profilo esistenziale (Walther J.
B. et al, 2008) differente da quello che la
realtà fisica dispone per loro quotidiana-
mente. In questo contesto non si può di-
menticare che nella rete siamo ciò che di-
ciamo ancor più che nella realtà. Attraver-
so i nostri post e i nostri twit costruiamo
giorno dopo giorno l’immagine che gli
altri hanno e avranno di noi. Un’immagine
che, a differenza della realtà fisica, può es-
sere studiata a ta volino, progettata e
implementata sulla base dei nostri desi-
deri espressi o latenti.
Dal quadro sin qui delineato emerge una
sorta di caos emotivo che caratterizzereb-
be i contesti comunicativi e relazionali del
web. Sembra molto difficile distinguere
l’intensità delle emozioni così come la
loro autenticità. L’impressione è di assi-
stere a una grande messa in scena in cui
ciascuno sgomita per avere la sua parte
e per dimostrare di contare qualcosa. Al
contempo si cede al dubbio circa la ca-
pacità che il popolo dei social network,
in particolare quello più giovane, dovrà
dimostrare, di gestire la propria affettività
nel modo più equilibrato possibile. Che
ne è di c olui che fuori dal w eb vive le
emozioni nella f orma e nell’int ensità
comune a tutti e che in quant o tali ri-
schiano di essere assolutamente ignora-
te? Cosa accade a Nar ciso (Pietropolli
Charmet, 2008) quando fuori dal suo pro-
filo scopre di non essere così particolare
e degno di celebrazione alcuna?
Che cosa può fare la scuola?A questo punto è naturale chiedersi se la
scuola debba avere un ruolo in quest o
contesto e, in caso aff ermativo, in che
cosa possa e debba consistere.
La risposta è, senza dubbio, affermativa:
non solo la scuola ha un ruolo, ma essa rap-
presenta una delle poche agenzie su cui
è possibile contare affinché le nuove ge-
nerazioni acquisiscano quelle competenze
indispensabili per gestire efficacemente
l’esistenza nelle realtà attuali. Il primo ri-
ferimento è alle competenze digitali (Cal-
vani, Fini, Ranieri, 2010) che nec essaria-
mente dovranno essere parte integrante
delle nuove forme di alfabetizzazione.
In particolare, risulterà importante insi-
stere sulla componente etica attraverso
la quale i soggetti potranno acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie
a definire ambienti relazionali adeguati,
fondati sul rispetto e la libertà3.
A nostro avviso, pur nella logica del
cambiamento, riteniamo difficile im-
maginare che un sistema sociale basato
sull’estemporaneità, sulla c onfusione
dei ruoli e delle situazioni possa realmen-
te procedere verso una direzione positiva
e costruttiva. Il rischio che si intr avede
all’orizzonte è quello di andare verso un
sistema sociale in cui i Narcisi combat-
tono per ottenere il loro momento o la
loro posizione di prestigio, incuranti di
quanto li circonda. Non dimentichiamo
che, sullo sfondo di questo contesto te-
lematico, è presente e prospera l’ideo-
logia del consumo che continua a pro-
3. «(…) una formazione alla competenza digitale vaconcepita soprattutto come sviluppo di una forma men-tis, di particolari attitudini cognitive e culturali in strettoaccordo con altre competenze di base che valorizzanocapacità critica, metacognizione e riflessività; la fr e-quentazione tecnologica di per sé non può allora essereconsiderata garanzia sufficiente di una r eale compe-tenza digitale; al di sopra di una certa soglia essa puòanche essere inutile o addirittura dispersiva o contro-producente» (Calvani, Fini, Ranieri, 2010, p. 46).
17Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 17
porre il suo modello basato sull’inutilità
e sulla fragilità. Inutilità della maggior
parte delle merci proposte e fragilità dei
comportamenti del c onsumatore che
solo nell’atto stesso del possedere sem-
brerebbe trovare, per un istante fugace,
il proprio equilibrio.
In questo scenario ben si acc oglie il
principio della comunità (i social network
come comunità, come spazio della con-
divisione), ma di una c omunità che in
quanto tale valorizza gli elementi che la
compongono per ciò che sono in grado
di dare, a prescindere dal loro valore este-
riore, e, soprattutto, per la capacità di
pensiero che sono in grado di dimostrare
(Silverstone, 2009, p. 62)4.
Quindi di una c omunità che tende a
prendere le distanze dalla superficialità
dell’emozione pubblicata, dove la tristez-
za non diventa l’icona da coltivare, ma
un’emozione che, come le altre, ha una
dimensione di profondità inalienabile. In
quanto tale, essa non è c oltivata o
ridotta a prodotto dell’estetica verbale,
ma affrontata con l’intimità e il riserbo
che si dedicano alle questioni importanti.
Alla scuola e ai docenti si chiede di tra-
smettere alle generazioni di net surfer il
senso di responsabilità che ciascun sog-
getto dovrebbe manifestare nei compor-
tamenti individuali e collettivi (Jenkins,
2010).
Responsabilità intesa come la consape-
volezza che ciascuna azione da noi com-
piuta ha un significat o e delle c onse-
guenze e che, in funzione di ciò, occorre
seguire modelli di comportamenti ade-
guati alle diverse circostanze e al valore
nonché al peso delle diverse situazioni.
Il motore dell’azione non deve essere il
presenzialismo, ma la riflessione, il pen-
siero che portano alla partecipazione au-
tentica ovvero quella che non si esaurisce
nell’atto stesso del partecipare, ma che
tende al cambiamento, al generare una
forma di intervento per modificare un cer-
to stato di cose. In questo modo si ritorna
al concetto di partecipazione attiva, e di
solidarietà civile ovvero di forme di con-
divisione in cui il senso è dat o dalla
misura in cui, attraverso la partecipazione
di tutti, si riesce a intervenire su una situa-
zione ritenuta inadeguata, dolorosa o in
qualche modo poco apprezzabile. Clicca-
re “mi piace” accanto al post della fotogra-
fia della nonna terremotata rappresenta
un atto di una leggerezza e di una facilità
estrema che ha però il pregio – del tutto
relativo – di farci sentire partecipi. Nel mo-
mento stesso in cui pr emo il tasto del
mouse sulla formula magica, sento di aver
preso parte a qualcosa di grande, di im-
portante, di a ver fatto il mio do vere.
Così, soddisfatto posso volgere lo sguardo
ad altro e rinnovare il mio impegno, ali-
mentando Narciso con l’illusione di con-
tare qualcosa.
Agli educatori è richiesto un intervento
atto a rinnovare il significato originale del-
l’impegno civile e della cittadinanza
intesa come l’insieme dei diritti e dei do-
veri. Pertanto, ben venga l’impegno nel
predisporre spazi per la libertà di espres-
sione e la parola democratica; al contem-
po è però necessario che in questi con-
testi vi sia posto anche per il dovere in-
teso come l’agire concreto, volto a pro-
durre cambiamento. Inoltre, occorre fa-
vorire il principio per cui nel moment o
in cui mi rendo conto di non poter agire,
lascio spazio alla riflessione, al pensiero
e all’ascolto. Ascolto non del rumore di
fondo, ma dei messaggi che contano ve-
ramente ovvero di quelli che, al di là di
ogni esibizionismo e di ogni superficialità,
nascono per lasciare un segno.
Barbara BruschiUniversità di Torino
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
BIBLIOGRAFIA
J. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, Il Mulino, Bologna 2009.G. Granieri, Umanità accresciuta. Come la tecnologia ci sta cambiando, Laterza, Roma-Bari 2009.A. Calvani, A. Fini, M. Ranieri, La competenza digitale nella scuola: modelli e strumenti per valutarla e svilupparla, Erickson, Trento2010.H. Jenkins, P. Marinelli, A. Purushotma, Culture partecipative e competenze digitali: media education per il 21° secolo, Guerini stu-dio, Milano 2010.Pietropolli Charmet G., Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi, Laterza, Roma-Bari 2008.R. Silverstone, Mediapolis: la responsabilità dei media nella civiltà globale, V&P, Milano 2009.M. Thelwall, D. Wilkinson & S. Uppal, Data mining emotion in social network communication: Gender differences in MySpace, «Jour-nal of the American Society for Information Science and Technology», 61(1), 190-199, 2010.J.B. Walther, B. Van Der Heide, S.Y. Kim, D. Westerman, S.T. Tong, The Role of Friends’ Appearance and Behavior on Evaluations ofIndividuals on Facebook: Are We Known by the Company We Keep? , «Human Communication Research», Vol. 34, No. 1, pp. 28-4, 2008.
4. «Pensare, parlare, ascoltare e agire sono le compo-nenti fondamentali del nostro stare al mondo, costitui-scono le premesse all’essere pubblico. Secondo Arendt,lo spazio dell’apparire ha senso solo quando gli esseriumani pensano, parlano, ascoltano e agiscono gli unicon gli altri, gli uni gli altri, gli uni per gli altri» (Silv er-stone R., 2009, p. 62).
18 Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 18
L’università e la formazione degli insegnantiGiuseppe Spadafora
L’IDEA DI UNA SCUOLA AUTONOMA, DEMOCRATICA E MERITOCRATICA, PUÒ ESSERE IL LUOGO
IN CUI I SOSTENITORI DEI SAPERI DISCIPLINARI E I CULTORI DELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
POSSONO TROVARE UN PUNTO D’INCONTRO E FARNE IL CENTRO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
DEGLI INSEGNANTI.
Il processo di globalizzazione del capi-
talismo finanziario è un evento talmen-
te egemone che, di fatto, ci potrebbe
indurre a pensare preliminarmente che
il problema della formazione universitaria
degli insegnanti, e della formazione in ge-
nere, sia del tutto insignificante o addi-
rittura pleonastico in un simile contesto.
Tanto più che la strategia di Lisbona del
2000, la quale ipotizzava che nel giro di
dieci anni, proprio grazie allo sviluppo del
capitale umano, l’Europa sarebbe diven-
tata l’economia della c onoscenza più
competitiva del pianeta, sembrerebbe ir-
reversibilmente fallita. Ritengo, invece, che
i princìpi culturali della formazione uni-
versitaria degli insegnanti, che attualmen-
te si svolge nelle strutture previste dalla
normativa - il corso di laurea quinquen-
nale a ciclo unico di Scienze della Forma-
zione Primaria per gli insegnanti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria
e il Tirocinio Formativo Attivo per gli in-
segnanti della scuola secondaria di primo
e secondo grado - debbano essere appro-
fonditi per migliorare la qualità del siste-
ma scolastico italiano del futuro.
Il tutto nasce, a mio avviso, dal dibattito
che da diversi anni si sta svolgendo nel
nostro paese, ma non solo, sulla serietà
della scuola, sulla possibilità che essa sia
autenticamente meritocratica e non
“bocciata” dalle indagini specifiche in
campo internazionale, ma anche dal
confronto tra Nord e Sud
del nostro paese (il proget-
to PISA, acronimo del Pro-
gramme for International
Student Assessment, rivolto
ai quindicenni è stato signi-
ficativo al riguar do e ha
generato i test dell’INVALSI,
Istituto Nazionale per il Si-
stema Educativo di Istruzio-
ne e della F ormazione, su
cui si vorrebbe costruire il
futuro sistema di v aluta-
zione scolastica e universi-
taria). Un punto di partenza
può essere l’intervento mol-
to tranchant, e discutibile, di
Francesco Alberoni (“Corrie-
re della Sera“, 2 novembre
2009) replicato in modo
più articolato e molto me-
glio documentato da diversi altri studiosi,
noti e meno noti, e da persone interessate
al problema. Il sociologo affermava che
la scuola deve essere una erogatrice di co-
noscenze chiare, cronologicamente de-
finite, e non di metodi (la colpa in questo
senso sarebbe dei pedagogisti che avreb-
bero copiato la pedagogia statunitense
senza radici storiche) e che l’arretratezza
della scuola italiana, rispetto a quella degli
altri paesi, sarebbe determinata proprio
da una mancanza di rigor e culturale,
con riferimento in particolare alla insuf-
ficiente acquisizione da parte degli stu-
denti delle conoscenze specifiche disci-
plinari. Si tratta, per quanto concerne il
dibattito culturale attuale nell’università,
della polemica tra “disciplinaristi” e “me-
todologi” o, meglio, tra cultori delle di-
scipline ed esperti delle scienze dell’edu-
cazione. Per cercare di fare chiarezza sulla
questione, anche per i non specialisti,
tenterò, nell’ambito di uno spazio limi-
tato, di riportare la questione nei confini
del dibattito culturale e non delle pole-
miche scarsamente documentate.
John Dewey (1859-1952).
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
19Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 19
Nell’ambito della specifica storia cultu-
rale italiana, poco affrontata nel dibattito
culturale internazionale, il rif erimento
centrale è Giovanni Gentile, filosofo an-
che sotto questo profilo “bestemmiato
e pianto”, non adeguatamente cono-
sciuto, ma molto citato. Nel 1901 il gio-
vane filosofo siciliano (aveva allora 26
anni) pubblica l’articolo Il concetto scien-
tifico della pedagogia. Egli sostiene che
la pedagogia, per essere scienza, si “risol-
ve” nella filosofia, che egli considera, da
buon idealista, la formazione dell’atto
mentale e della soggettività della perso-
na; proprio per questo, egli teorizza che
il mestiere dell’insegnante è quello del-
l’uomo colto che deve trasmettere le co-
noscenze, per cui “chi sa, sa anche inse-
gnare”. Nello stesso tempo il mestiere del
discente consiste nel riconoscimento del-
l’autorità (autorevolezza) del docente,
giacché la libertà dell’allievo sta nella rea-
lizzazione di un atto spirituale unico, una
“sintesi a priori ” intersoggettiva con
l’autorità culturale e il rigore etico del do-
cente. Su questi princìpi G entile co-
struisce l’idea di scuola meritocratica che
svilupperà nella sua riforma del 1923,
quando approfondirà e organizzerà il di-
segno del sistema scolastico, già avviato
dal precedente ministro Benedetto Cro-
ce. La scuola deve selezionare - e lo farà
con il famoso e difficile “esame di stato”-
poiché essa deve formare la classe diri-
gente e, quindi, deve scegliere, sulla
base delle innumer evoli conoscenze
trasmesse, gli studenti migliori. “Poche
scuole, ma buone”, dunque. Una scuola
che ha nel liceo classico e nella forma-
zione umanistica il suo asse por tante;
nell’istituto tecnico professionale la sua
“valvola di sfogo” per chi, spesso prove-
niente da famiglie meno abbienti, non
è in gr ado di c ompletare gli studi e
quindi deve essere avviato al la voro
tecnico-professionale; l’istituto magi-
strale per i maestri, “amorevoli” inse-
gnanti del popolo.
La scuola di Gentile, come è noto, non si
sarebbe mai pienamente realizzata. “Ri-
toccata” dal 1923 al 1929, “fascistizzata”
fino al drammatico epilogo della secon-
da guerra mondiale, costituì, però, un
esempio organico e c onsequenziale
alla sua filosofia c omplessiva, sicura-
mente l’unico originale progetto cultu-
rale nella st oria della scuola italiana,
nonché il riferimento costante per l’im-
maginario collettivo che invoca la serietà
e il merito nella scuola.
Nel secondo dopoguerra, dai princìpi co-
stituzionali del 1948 sull’istruzione e
formazione del cittadino (in particolare
gli artt. 3,33,34) fino agli anni ’90, dopo
la fine della guerra fredda, si è sviluppato
un continuo e contrastato tentativo di
costruire una scuola democratica aperta
a tutti, che potesse garantire il diritto allo
studio di ogni cittadino della Repubblica
italiana. Dall’istituzione della scuola me-
dia unica (L. 31.12.1962, n. 1859), alla con-
testazione studentesca del 1968 e alla
conseguente - “politicamente emotiva”
in seguito agli eventi della contestazione
- liberalizzazione degli accessi universi-
tari, fino alla normativa delegata degli
anni ’70 sulla scuola democratica come
“comunità scolastica” aperta anche ai
contributi gestionali delle famiglie e
delle istituzioni esterne, non si è riusciti
a realizzare, segnatamente per lo scontro
tra cultura politica cattolica e cultura lai-
co-marxista, un progetto di sistema com-
plessivo, tant’è che alla fine degli anni ’80
si parlò del “mito della grande riforma”.
Il dibattito sulla figura dell’insegnante,
specialmente dagli anni ’50 in poi, assu-
me un significato completamente diver-
so. L’insegnante non è considerato solo
un trasmettitore di conoscenze ma an-
che un conoscitore della didattica, dei
metodi e delle scienze dell’educazione,
che derivano dalla diffusione nel nostro
paese di un t esto di John D ewey, The
Sources of a Scienc e of Educ ation (Le
fonti di una scienza dell’educazione), del
2009. Sconosciuto negli Stati Uniti e in
gran parte della cultura europea, esso di-
venta il paradigma di riferimento per la
trasformazione della figur a dell’inse-
gnante, nella scuo la democratica, da
semplice trasmettitore di conoscenze a
professionista dell’insegnamento. Se-
condo tale prospettiva, lo studente della
scuola democratica non doveva essere
solo un “vaso da riempire”, una testa “ben
piena”, ma soprattutto una testa “ben fat-
ta”.
La scuola democratica avrebbe dovuto
valorizzare i talenti (non sempre l’ha fatto
o ci è riuscita), ma anche recuperare e in-
tegrare gli studenti deboli, che manife-
stano disagio negli apprendimenti, che
sono disabili, che non possono per mo-
tivi economico-sociali completare la
propria formazione scolastica. L’inse-
gnante della scuola democratica avreb-
be dovuto, dunque, riconoscere il merito
e favorire il recupero degli studenti in dif-
ficoltà e, proprio per quest o, essere
esperto delle conoscenze disciplinari e
al tempo stesso conoscitore dei metodi
e delle scienze dell’educazione. Al riguar-
do fu usata, specialmente da Aldo Visal-
berghi, la metaf ora dell’insegnante
come medico che applica in modo inter-
disciplinare le sue c onoscenze diffe-
renziate per operare la diagnosi e l’even-
tuale cura del malato.
Negli ultimi due decenni la scuola italia-
na, unitamente al sistema universitario,
nel contesto del disegno formativo eu-
ropeo, è stata “travolta” da numerose ri-
forme di sistema, da Berlinguer alla Mo-
ratti, da Fioroni alla Gelmini, riforme
complessive ispirate prevalentemente
dalle politiche dell’istruzione e della
formazione europee. In I talia la legge
sull’autonomia scolastica del 1997-1999
e la riforma del titolo V della Costituzione
del 2001 hanno tentato di disegnare una
struttura di scuola autonoma, non ancora
bene definita, incentrata sulla meritocra-
zia, considerata fondamentale in pr o-
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
20 Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 20
spettiva futura. È questo, a mio avviso, il
luogo in cui i “disciplinaristi” e i cultori del-
le scienze dell’educazione possono tro-
vare un punto d’incontro, che può essere
proposto all’interno della f ormazione
universitaria degli insegnanti per un ri-
lancio di un modello di scuola meritocra-
tica e democratica al tempo stesso.
È ormai acclarato da div erse ricerche
compiute negli ultimi anni che la prepa-
razione degli studenti nella scuola secon-
daria presenta “vuoti” notevoli, ma il pro-
blema cruciale per migliorare la situazione
rimane, a mio avviso, la formazione ini-
ziale e in servizio degli insegnanti.
È una formazione che deve essere ripen-
sata nell’università e nei sistemi istituzio-
nali preposti dalla normativa e che deve
partire dall’assunto che l’in segnante
conosca il suo ambito disciplinare (com-
petenza disciplinare), sappia insegnare
(competenza didattico-metodologica) e,
soprattutto, sappia valutare formando e
orientando il progetto di vita unico e ir-
ripetibile di ogni singolo studente nella
classe (competenza delle scienze del-
l’educazione). Queste tre competenze
determinano, inevitabilmente, un ripen-
samento dell’offerta formativa dell’uni-
versità all’interno dell’attuale quadr o
istituzionale per la formazione dell’inse-
gnante che, necessariamente, deve tener
conto dell’equilibrio dinamico tra le
competenze disciplinari e quelle delle
scienze dell’educazione.
La finalità complessiva è quella del recu-
pero del sistema-scuola in Italia, puntan-
do sulla rimotivazione della professiona-
lità docente (retributiva ovviamente,
ma soprattutto ideale, che trovi il suo hu-
mus nel significato della mission culturale
ed etica del docente, fondamentale per
lo sviluppo sociale), per la costruzione di
una scuola sì meritocratica, ma democra-
tica, che offra uguali opportunità a tutti.
Il “capitale umano” di cui l’Europa ha bi-
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
21Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
I regali della burocrazia
L'Italia morirà soffocata da burocrazie mortifere, inventatesolo per mantenere gli uffici che le scrivono. Un esempio.Partono i PON Asse II Obiettivo C, destinati a incrementarela qualità delle infrastrutture scolastiche siciliane. Si trattadi un gran numero di progetti e di risorse pubblicheeconomiche per centinaia di milioni di euro. I dirigentiscolastici sono chiamati a sottoscrivere un accordo (ex art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241) con il Comune e laProvincia, che attribuisce al Responsabile Unico delProcedimento l’onere della gestione, senza però conferirvistrumenti, poteri e procedure snelle. L’accordo consta di 10pagine di grande complessità e crea organismi che nonhanno nulla a che vedere con la gestione di una garad’appalto. È inventata una “cabina di regia” con funzioni disovrintendere le attività, una commissione di gara nominatadal consiglio d’istituto tra i propri funzionari apicali (ma
quali sarebbero?), un RUP designato dall’Istituzionescolastica (?) nell’ambito del proprio organico. In più ilpersonale dell’ufficio tecnico dell’ente locale dovrebbepredisporre i progetti esecutivi, la direzione dei lavori, ilcoordinamento della sicurezza e i collaudi. Ma quale ufficiotecnico di ente locale è in grado di assicurare questi obblighi?L’accordo tra Istituzione Scolastica ed Ente Locale chedovrebbe essere stipulato, inoltre, non tiene conto dei ruolinecessari nella gestione dell’appalto: il finanziatore, ilcommittente, il progettista e direttore dei lavori, ilcollaudatore e l’utilizzatore. Ovvio che alla fine si porrannodue alternative: o si violeranno le norme (e allora sarà giustogridare al malaffare ed invocare l'intervento taumaturgicodei soliti magistrati) oppure non si farà niente e ci silamenterà dei soldi Ue non spesi.
Asterischi di Kappa
sogno nasce anche dalla “difficile scom-
messa” per il rilancio di una nuova qualità
nella formazione degli insegnanti.
Non si può pensare che la crisi economica
ed etica, in tempo di globalizzazione fi-
nanziaria, si possa super are senza una
scuola di tutti e per tutti, fondata sui temi
della democrazia e della cittadinanza
attiva, meritocratica e democratica, che
formi ogni persona nella sua specificità
e particolarità e offra a ogni studente la
possibilità di esercitare pienamente il di-
ritto allo studio e di realizzare le poten-
zialità inespresse di cittadinanza demo-
cratica, ancora da maturare nella nostra
società italiana e meridionale, al di là della
facile retorica.
Giuseppe Spadafora Università della Calabria
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 21
Sempre più si risc ontra un’ampia
convergenza di studi che conside-
rano la conoscenza e l’apprendi-
mento come le risorse principali su cui
investire per innalzare la qualità del la-
voro dentro le or ganizzazioni, siano
queste orientate a produrre beni mate-
riali o immateriali. Qualsiasi organizzazio-
ne può essere letta come una knowledge
based company, come un contesto nel
quale viene generata conoscenza.
I contesti scolastici non sono estranei a
questa lettura, anche se in questi am-
bienti è c onsuetudine pensare che i
processi di generazione di conoscenza
e di appr endimento si r ealizzino so-
prattutto all’interno dei c onfini della
classe o scaturiscano solo dalle attività
svolte dagli studenti. Ciò che in vece
molti studi confermano è che nei con-
testi scolastici, così come in gran parte
delle organizzazioni, i processi di gene-
razione della conoscenza coinvolgono
direttamente il lavoro dei professionisti
che vi operano.
L’insegnante produce una conoscenza
su un particolare evento che andrà a se-
dimentarsi nella propria storia di forma-
zione, nei suoi repertori di azione. Quan-
do incontra un ev ento problematico,
quando tenta di risolvere una situazione
contraddittoria all’interno della propria
classe, si trova a dover gestire situazioni
complesse che lo spingono a mettersi in
discussione, a creare nuove soluzioni, a
riflettere sulla plausibilità delle teorie uti-
lizzate fino a quel momento. Per questo
motivo si annota che «all’interno del con-
testo scolastico l’insegnante è a un tem-
po professionista “formante” e professio-
nista “in formazione” e dunque un sog-
getto che vive una condizione di conti-
nuo apprendistato»1. Per esempio, quan-
do l’insegnante progetta un percorso o
un’unità didattica, solo parzialmente fa
ricorso a procedure apprese durante il
suo percorso di studio. Egli costruisce
strategie circostanziate in grado di co-
niugare tempi, spazi, organizzazione
dei contenuti disciplinari e interessi/po-
tenzialità degli studenti.
La scuola come comunità di narrazioneClaudio Melacarne
PERCHÉ RACCONTARSI? L’INSEGNANTE CHE COMUNICA LA PROPRIA ESPERIENZA PROFESSIONALE NE EVIDENZIA
VALORE E CRITICITÀ, COSTRUENDO UNA COMUNITÀ DI SAPERI IN CUI È LA PRATICA A RISCRIVERE, LEGITTIMARE E TRASFORMARE LE STORIE PROFESSIONALI.
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 22
Apprendere con le storiePiù che uno spazio burocratico, gover-
nato solo da norme e ruoli, la scuola sem-
bra assomigliare ad un c ontesto nel
quale sono l’informalità e la fluidità
delle decisioni a fare da volano dei pro-
cessi di inno vazione e c ostruzione di
nuova conoscenza.
Il costrutto di “comunità di pratica”2 ha
fornito una lente interessante con cui in-
terpretare la scuola come un’aggregazio-
ne informale di professionisti nella quale
un ruolo determinante è svolto dalla rete
di relazioni che si stabiliscono fra coloro
che condividono la stessa attività pratica.
Costruire una strategia per insegnare al-
l’interno di un contesto classe, condivi-
derla con dei colleghi, scambiarsi infor-
mazioni e opinioni su come gestire alcu-
ni eventi critici si configurano occasioni
vitali per la scuola per produrre e far cir-
colare la conoscenza professionale.
La produzione di sapere professionale
può essere descritta come un processo
di costruzione sociale di c onoscenza
che si genera attraverso la partecipazio-
ne a esperienze di scambio, negoziazio-
ne, realizzazione congiunta di pratiche
professionali. Le occasioni formali e in-
formali di confronto, le riunioni, lo scam-
bio di idee nei tempi morti, si configu-
rano tutte come esperienze dove il sa-
pere del singolo professionista può di-
ventare patrimonio collettivo. Il lavoro
dell’insegnante si svolge all’interno di
una comunità sociale e relazionale in cui
si generano saperi e conoscenze attra-
verso la costruzione di storie condivise
di apprendimento.
Le storie professionali sono il tramite at-
traverso il quale la conoscenza del sin-
golo può essere resa esplicita, può pas-
sare dal dominio individuale alla valida-
zione sociale tramite il confronto con i
colleghi. Le storie «consentono a elemen-
ti sparsi, comportamenti inspiegabili e
problemi ambigui di collocarsi dentro un
ordine che prende la forma di una storia.
1. B. Rossi, Intelligenze per educare. Sull’identità professio-nale dell’insegnante, Guerini e Associati, Milano 2005, p.225.2. E. Wenger, R. McDermott, W.M. Snyder, Coltivare comu-nità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione dellaconoscenza, Guerini e Associati, Milano 2007.3. K.E. Weick, Senso e significato nell’organizzazione, Cor-tina Raffaello, Milano 1997, p. 138.4. D.J. Clandinin, F.M. Connelly (eds), Teachers’ Professio-nal Knowledge Landscapes, Teachers College Press, NewYork 1995, p. 11.
L’ordine e la chiarezza raggiunte in una
piccola area vengono socializzate e pos-
sono essere estese ad ar ee adiacenti
meno ordinate. In ambito professionale
le storie sono una sorta di testo costruito
attraverso conversazioni collettive sem-
pre aperto a nuove interpretazioni»3.
All’interno della scuola le storie si fondo-
no dando vita a delle storie organizzative
più ampie, si trasformano, suggeriscono
finali diversi al proprio agire, generano
un curriculum narrativo. Per Clandinin e
Connelly «la capacità di riuscire a com-
prendere le ragioni del perché “siamo
quelli che siamo”, “facciamo quello che
facciamo” e “dove, in quali occasioni
scegliamo di fare una cosa piuttosto che
un’altra” è la miglior e strada per tr a-
sformare il curriculum»4 , cioè le modalità
con cui organizziamo l’esperienza didat-
tica.
L’insegnante che racconta a un collega
una propria esperienza pr ofessionale
ne evidenzia le criticità, trasforma
un’esperienza individuale in una narra-
zione che può essere di interesse a molti
di coloro che vivono un’esperienza ana-
loga. Da questo punto di vista una storia
si fonda su “conversazioni” che l’autore,
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
23Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 23
l’insegnante, intraprende con una si -
tuazione, con un pr oblema che ha di
fronte e che in qualche modo lo spiazza.
Successivamente, questa narrazione può
illuminare ad altri la strada da percorrere
per ridurre la complessità di un evento.
In altri termini, le conversazioni si trasfor-
mano in racconti condivisi, acquistano si-
gnificato e sedimentano gli appr endi-
menti individuali.
Disapprendere con le storieTuttavia non tutte le storie che circolano
dentro i contesti scolastici si configurano
come occasione di apprendimento. Que-
ste possono cogliere aspetti marginali ri-
spetto alle emergenze sociali, possono
non esplicitare quelle conoscenze che in-
vece sono necessarie alla scuola per ri-
spondere efficacemente alle turbolenze
esterne e interne. Si può in molti casi di-
sapprendere delle buone pratiche di la-
voro se le st orie che cir colano nella
nostra organizzazione non sono state in
qualche misura educate. Alcuni studi
sulle pratiche professionali hanno evi-
denziato che «se è vero che una comu-
nità include l’apprendimento come fatto
scontato nella storia della sua pratica, che
l’apprendimento appartiene al mondo
dell’esperienza e della pratica e segue la
negoziazione dei significati e si sviluppa
con le sue r egole, ovvero si determina
ovunque, con o senza la formazione, è al-
trettanto vero che appr endere nella
pratica non significa affermare che tutto
ciò che si muove dentro una comunità
di pratica è apprendimento. Le comunità
di pratiche hanno bisogno anche di di-
sapprendere, trasformarsi, evolvere»5.
Storie significativeLe comunità professionali di insegnanti
devono essere sostenute nella elabora-
zione di storie narrate in modo tale che
la pratica di insegnamento possa diven-
tare una pratica trasferibile e che all’in-
terno del racconto sia resa evidente la
poliedricità dell’esperienza: chi vi ha
preso parte, quali sono i vincoli all’interno
dei quali si è realizzata, quali i momenti
critici e le potenzialità, quali le risorse im-
piegate.
Se «ciascun attore organizzativo per la
personale esperienza di vita, per la sua
biografia professionale, per le proprie
pratiche sociali e culturali offre delle pos-
sibilità di conoscenza ad una comunità»6,
la formazione rivolta agli insegnanti e alle
altre professionalità della scuola può of-
frire setting, contesti e occasioni di ac-
compagnamento in grado di favorire la
costruzione di una comunità narrativa in
cui è la pratica a riscrivere, legittimare e
trasformare le storie professionali.
Pur potendo fare affidamento sui proces-
si naturali di generazione di conoscenza
professionale, la scuola necessita sempre
più di entrare in formazione, di trovare
spazi per entrare dentro la complessità
del lavoro di insegnamento e imparare
a descriverlo, incentivare lo scambio di
buone pratiche, dubitare delle prassi con-
solidate e agevolare la sperimentazione
di nuove pratiche di lavoro, allargare le
occasioni di confronto con altre comu-
nità professionali che condividono le me-
desime pratiche di lavoro.
Claudio MelacarneUniversità di Siena
5. L. Fabbri, Nuove narrative professionali. La svolta rifles-siva, in L. Fabbri, M. Striano, C. Melacarne, L’insegnante ri-flessivo. Coltivazione e tr asformazione delle pr aticheprofessionali, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 42.6. B. Rossi, Pedagogia delle organizzazioni. Il lavoro comeformazione, Guerini e Associati, Milano 2008, p. 254.
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 24
L’integrazione equilibrata degli immigrati Luciano Amatucci
IN MOLTI PAESI, NEL PRESENTE E NEL PASSATO, SONO STATI SPERIMENTATI MODELLI DIVERSI PER L’INSERIMENTO
DEI MIGRANTI NELLE SOCIETÀ NAZIONALI, CON RILEVANTE INCIDENZA SUI SISTEMI SCOLASTICI.
In questi ultimi anni nel nostro Paese
è venuto frequentemente alla ribalta
il problema dell’inserimento dei
migranti nella società nazionale , in
presenza di ripetut e manifestazioni
di intolleranza e dei conseguenti dibat-
titi, che hanno investito le politiche ge-
nerali sull’immigrazione e, in partico-
lare, le politiche sc olastiche nei con-
fronti dei figli dei lavoratori migranti. In
via preliminare si è proposto più volte
il tema dei possibili limiti agli accessi
dei migranti nel nostro Paese. Al riguar-
do è necessario procedere con cautela,
tenendo conto delle obiezioni di quanti
temono i rischi e i dann i di politiche
troppo permissive. Sembra dunque
opportuno accettare il c ondiziona-
mento degli ingressi all’effettiva dispo-
nibilità di posti di lavoro, di regola limi-
tati anche per gli aspir anti italiani, al
fine di evitare lo sviluppo di figure di
disperati, privi di mezzi di sussistenza,
alla ricerca di occasioni di lavoro anche
illegali pur di assicurare la propria so-
pravvivenza, che possono giungere a
percepire la società ospitante come ne-
mica e c ome possibile oggett o di
azioni di contrasto, anche violente. Si-
milmente, nel caso del naufragio di una
nave, si possono accogliere i naufraghi
nella scialuppa di salvataggio disponi-
bile soltanto nei limiti della sua capien-
za, per non andare a fondo tutti insie-
me. Una volta stabilita e acquisita que-
sta premessa, occorre definire le forme
e le modalità di accoglienza di coloro
che entrano nel P aese nel rispett o
degli equilibri. L’esempio di altri Paesi
dimostra l’esistenza di vari modelli, at-
tuali o operanti nel recente passato, per
l’inserimento dei migranti nelle società
nazionali, con incidenza anche sui siste-
mi scolastici1.
AssimilareIl modello di assimilazione (detto “fran-
cese”, per la fortuna avuta in Francia)
comporta la sostanziale omologazione
degli immigrati alla cultura del Paese di
accoglienza, con la perdita dei tratti del-
la loro identità originaria. Nelle scuole
viene facilitato l’apprendimento della
lingua nazionale e sono anche previste
“classi di accoglienza” per soli immigrati,
come opportuno strumento di transi-
zione didattica e anc ora, secondo un
lettura critica, come “sale di attesa”, de-
stinate a trattenere l’appartenente ad
una minoranza fino al suo pieno ade-
guamento, anche linguistico, alla socie-
tà ospitante.
SeparareDi contro, il modello di separazione, af-
fermatosi in Germania, comporta una
distinta collocazione degli appartenenti
a culture diverse nella vita s ociale,
nella scuola e, addirittura, nelle sedi abi-
tative. Questo modello cerca una giu-
stificazione nel convincimento che è
opportuno che le culture crescano su
se stesse, senza commistioni che ne
snaturino le caratteristiche. In Germania
è valsa anche la considerazione che il
lavoratore immigrato è un gastarbeiter
(un “lavoratore ospite”) destinato a
rientrare a t empo debito nel P aese
d’origine, così da richiedere, piuttosto
che l’integrazione sociale, l’inserimento
lavorativo2.
A ben vedere, sia il modello di assimi-
lazione che quello di separazione risul-
tano espressioni di nazionalismo, inclu-
sivo nel primo caso, ed esclusivo nel se-
condo3. Non soccorre nemmeno, per il
superamento di questo limite, il ricorso
al modello egalitario del melting pot
(cioè “crogiolo”, inteso come fusione di
più culture, di pari dignità, in una
entità nuova e distinta), sostanzial-
mente in crisi negli U.S.A., dove la pro-
clamazione teorica è risultata spesso
contraddetta dai c omportamenti di
fatto.
1. Cfr. L. Amatucci, Minoranze e immigrati nella società enella scuola, «Affari sociali internazionali», n. 2 (1996).2. Cfr. V. Zincone, Un freno all’accesso, un’accelerata allacittadinanza, in AA.VV., Immigrazioni e diritti di cittadi-nanza, Editalia, Roma 1991.3. Cfr. G. Favaro, I protagonisti dell’integrazione e la nor-mativa italiana, in D. Demetrio - G. Favaro, Immigrazionee pedagogia interculturale, La Nuova Italia, Firenze 1992;O. Fitzinger, L’accoglienza in Europa. Modelli e prospettive,in O. Fitzinger - M. Traversi (a cura di), Gli alunni stranierie il successo scolastico, Carocci, Roma 2006.
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
25Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 25
IntegrareTra gli estr emi dell’assimilazione e
della separazione, nella Comunità eu-
ropea si è proposta una formula bilan-
ciata, usualmente riportata alla nozione
di integrazione, che ha contemperato,
per la scolarizzazione dei figli dei lavo-
ratori stranieri comunitari, l’inserimento
nella lingua e nella cultur a del Paese
ospitante con la tutela della propria lin-
gua e cultura di origine, secondo un
modello coerente con la vicinanza cul-
turale tra i lavoratori dei diversi Paesi
europei in ‘mobilità’ all’interno della Co-
munità stessa4. Alla luce di questa for-
mula si può considerare la condizione
dei nostri emigrati negli Stati Uniti, che
hanno mantenuto i legami con le tra-
dizioni nazionali, coltivate addirittura
in associazioni a ba se regionale, e si
sono ad un tempo inseriti nella vita del
Paese di accoglienza, fino a conseguire
importanti cariche elettiv e nelle sue
amministrazioni locali. La formula della
integrazione è poi stata diffusamente
adottata come riferimento per le poli-
tiche di inserimento degli extracomu-
nitari, per i quali, in verità, risulta ridut-
tiva e inadeguata la mera integrazione,
se intesa, come talora avviene, quale si-
nonimo di assimilazione, cioè di fago-
citazione nella cultura del Paese ospi-
tante. A questo punto si è addirittura
invocato, per i rapporti tra autoctoni e
immigrati, un modello di integrazione-
interazione, in quant o la r eciproca
apertura, conseguente all’accoglienza
bilanciata, assicura la fecondità dello
scambio culturale, fermo restando il ne-
cessario rispetto da parte di tutti dei va-
lori postulati c ome universali5. Tali
sono i valori sottesi alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo proclama-
ta dall’Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite nel 1948 e precisati dall’O.N.U.
nel settembre 2000, con una Dichiara-
zione per il millennio, che è pervenuta
alla formulazione diretta dei valori as-
sunti a fondamento della sua azione: li-
bertà, uguaglianza, solidarietà, tolle-
ranza, rispetto per la natura, responsa-
bilità condivisa6.
In materia sono illuminanti le par ole
pronunciate da Benedetto XVI in un in-
tervento svolto nel 2008 in occasione
del sessantesimo anniversario della
Dichiarazione O.N.U:
«Da sempre la Chiesa ribadisce che i di-
ritti fondamentali, al di là della differen-
te formulazione e del diverso peso
che possono rivestire nell’ambito delle
varie culture, sono un dato universale,
perché insito nella stessa natura del-
l’uomo. La legge naturale, scritta da Dio
nella coscienza umana, è un denomi-
natore comune a tutti gli uomini e a
tutti i popoli; è una guida universale che
tutti possono conoscere e sulla quale
tutti possono intendersi»7.
Integrare e interagireNel nostro Paese già la legge 30 dicem-
bre 1986, n. 943, coniugava un’ampia
concessione di diritti ai lavoratori ex-
tracomunitari con la tutela della loro
identità culturale:
4. Direttiva C.E.E. n. 486 del 1977.5. Cfr. A. Papisca, Cittadinanza e cittadinanze, ad omnesincludendos: la via dei diritti umani , in M. Mascia (a curadi), Dialogo interculturale, diritti umani e cittadinanza plu-rale, Marsilio, Venezia 2007.6. Cfr. L. Amatucci - A. Augenti - F. Matarazzo, Lo spazioeuropeo dell’educazione, Anicia, Roma 2005.7. Discorso di Benedetto XVI tenuto nell’Aula Nervi delVaticano, riferito dalla stampa dell’11 dicembre 2008.
26 Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 26
«La Repubblica italiana … garantisce a
tutti i lavoratori extracomunitari le-
galmente residenti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento
e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani. La Repubblica italiana
garantisce inoltre i diritti relativi all’uso
dei servizi sociali e sanitari [...], al man-
tenimento dell’identità cultur ale, alla
scuola e alla disponibilità dell’abitazio-
ne, nell’ambito delle norme che ne di-
sciplinano l’esercizio».
La successiva evoluzione normativa
ha trovato, per gli aspetti sc olastici,
uno sbocco nell’art. 38 del Testo unico
25.7.1998, n. 286 delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla c ondizione dello
straniero:
«La comunità scolastica accoglie le dif-
ferenze linguistiche e culturali come va-
lore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra culture e
della tolleranza: a tal fine promuove e
favorisce iniziative volte all’accoglienza,
alla tutela della cultur a e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni».
L’impegno della nostr a Amministra-
zione scolastica ha finora privilegiato, a
favore degli ex tracomunitari, l’inse-
gnamento della lingua italiana, inteso
come mezzo per un pieno ingr esso
nella nostra società. Resta ferma l’esi-
genza di una adeguata organizzazione
scolastica e di un opportuno dosaggio
delle presenze straniere nelle classi, in
vista di questo apprendimento e della
tutela della lingua e cultura d’origine.
L’editoria ha già fornito alcuni contributi
per agevolare l’insegnamento della
lingua italiana agli stranieri8 e per pro-
muovere la conoscenza delle nostre isti-
tuzioni presso gli alunni stranieri9.
Ai nostri giorni sembra preferibile invo-
care una integrazione equilibrata degli
immigrati, intendendo per tale non
solo il c ontemperamento dell’inseri-
mento nella lingua e nella cultur a del
Paese ospitante con la tutela della lin-
gua e cultura d’origine, ma anche e so-
prattutto la facilitazione dell’acquisto del-
la cittadinanza del Paese di accoglienza
come compensazione della pr etesa,
che si rinnova nei confronti degli immi-
grati stessi, di riconoscere pienamente
le regole e i modi di vita degli ospitanti
e di concorrere con loro alla costruzione
di una società coesa, in vista di un co-
mune destino.
Si tratta, in sostanza, di dare giusta rile-
vanza al c. d. ius soli (diritto del territorio),
cioè al diritto di acquisto della cittadi-
nanza in base alla nascita in un deter-
minato territorio.
Al momento, invece, il c. d. ius sanguinis
(diritto del sangue) cioè il diritto di ac-
quisto della cittadinanza sulla base
della discendenza da cittadini assume
nel nostro ordinamento rilievo preva-
lente.
La cittadinanza pluralistaSussistono, invero, delle perplessità in
merito alla concessione automatica e in-
condizionata della cittadinanza ai figli
di stranieri in ba se al solo r equisito
8. Cfr. G. Favaro, Insegnare l’italiano ai bambini stranieri,La Nuova Italia, Firenze 2002; P. Affronte - A.L. Burci - E.Pischedda, Kit ‘Impariamo l’italiano!’ (per alunni stra-nieri), Erickson, Gardolo (TN) 2009.9. Cfr. G. Bettinelli - P. Russomando, Passaporto per l’Ita-lia. Educazione alla cittadinanza e alla C ostituzione perragazzi stranieri, Vannini, Gussago (BS) 2011.
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 27
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 27
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX28
della nascita in Italia. Il discorso si spo-
sta, allora, sulle condizioni da porre in
materia e si individua come essenziale
al riguardo, per lo straniero, la scolariz-
zazione avvenuta in Italia a un primo
livello, in grado di assicurare la cono-
scenza della nostra lingua e del nostro
ordinamento. In tal senso si è pronun-
ciato in più occasioni il nostro Presiden-
te della Repubblica10. È poi da conside-
rare che già la presenza nelle famiglie
di immigrati di giovani nati e scolariz-
zati in Italia, quali potenziali cittadini ita-
liani, potrebbe di per sé avere il benefico
effetto di intr odurre nelle famiglie
stesse una visione aperta dei rapporti
tra culture11. In attesa dell’acquisizione,
con la cittadinanza, del voto nelle ele-
zioni politiche, potrebbe valere, per gli
stranieri, l’attribuzione del diritto di
voto nelle elezioni amministr ative. In
questa materia sono depositati presso
le Camere o pr eannunciati appositi
progetti di legge.
10. Si veda, ad esempio, l’intervento di Giorgio Napoli-tano riportato dalla stampa quotidiana del 22 no vem-bre 2011.11. Cfr. A. Granata, Sono qui da una vita. Dialogo apertocon le seconde generazioni, Carocci, Roma 2011; D. Zo-letto, L’intercultura… fra le generazioni, «Mondialità», n. 6,giugno-luglio 2011.12. Cfr. L. Amatucci, Società multiculturale e cittadinanza
pluralista, in L’educazione interculturale, Erickson, Gar-dolo (TN) 2010, p. 1; L. Amatucci, Educare alla cittadi-nanza nella società multicultur ale. Gli sviluppidell’intercultura, Anicia, Roma 2011.13. Consiglio d’Europa, Consiglio di cooperazione cul-turale, Dichiarazione del 1993 relativa al progetto De-mocrazia, diritti umani, minoranze. Aspetti educ ativi eculturali.
14. Cfr. L. Corradini (a cura di), Cittadinanza e Costitu-zione. Disciplinarità e trasversalità alla prova della speri-mentazione nazionale. Una guida teorico-pratica perdocenti, Tecnodid, Napoli 2009.15. Cfr. Amatucci, Società multiculturale, cit.; Educare allacittadinanza, cit.
Risulta comunque utile, già nella situa-
zione attuale, il concetto di cittadinanza
pluralista, che esprime la conciliabilità
di più appartenenze in uno stesso indi-
viduo12. In questo senso si è chiaramen-
te pronunciato il C onsiglio d’Europa:
«La nozione di cittadinanza nelle società
democratiche diviene più complessa e,
pertanto, la realtà di una cittadinanza
pluralista deve essere riconosciuta. Ciò
significa che ciascun individuo può
desiderare di vedere i suoi problemi e
aspirazioni trattati in una par ticolare
sede politica, che in alcuni casi può es-
sere essenzialmente territoriale ed in al-
tri più chiaramente culturale, senza che
la partecipazione e l’esser membro di una
sede sia considerato subordinato o in al-
ternativa alle altre appartenenze»13.
Un’occasione per r endere concreta-
mente operante il disegno fin qui illu-
strato è offerto dall’applicazione della
legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha in-
trodotto nel nostro ordinamento sco-
lastico l’insegnamento di Cittadinanza
e Costituzione14, aprendo la strada al re-
cupero dell’educazione interculturale,
intesa come educazione al pluralismo,
anche con riferimento al concetto di cit-
tadinanza pluralista15.
In quest’ordine di idee, una circolare del
M.I.U.R. del 27.10.2010, n. 86, sul tema
Cittadinanza e Costituzione, ha indivi-
duato come fine dell’educazione alla cit-
tadinanza la formazione di mentalità
aperte ad una visione multi prospettica
e plurale della realtà.
Luciano Amatuccigià dirigente superiore Miur
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 28
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 29
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Lingua e comunità: una questione storicaMaria Annita Baffa
LE POLITICHE SCOLASTICHE ITALIANE CALATE DALL’ALTO HANNO SEMPRE AVUTO COME SCOPO IL RAGGIUNGIMENTO
DI UN MONOLINGUISMO CHE DOVEVA ELIMINARE I DIALETTI E LE LINGUE DI MINORANZA STORICA, COSÌ COME OGGI
SI CERCA DI INTEGRARE GLI ALUNNI STRANIERI RENDENDOLI SIMILI A NOI CON L’ITALIANO LINGUA VEICOLARE
E DUE LINGUE STRANIERE OBBLIGATORIE. LANGUAGE LOSS?
Lingua alta e linguesubalterneLa dicotomia lingua alta/lingua subalter-
na precede, in ordine di tempo, la nascita
degli studi linguistici e antropologici. Già
Marc Bloch, storico ucciso dai nazisti nel
1944, aveva intuito che le società posso-
no praticare un “bilinguismo gerarchi-
co”1. La forza assimilatrice della lingua
alta nei confronti di quella con meno po-
tere, alla quale «si vogliono riconoscere
solo gli aspetti più pittoreschi, in musei
polverosi»2, è così forte negli stati mo-
derni da essere in grado di distruggere
la memoria storica dei popoli. La tenden-
za assimilatrice è dovuta al fatto che la
lingua è l’aspetto immediatamente visi-
bile di ogni cultura, per cui il disconosci-
mento della lingua coincide con il ten-
tativo di cancellare la cultura di cui essa
è il primo veicolo. Un esempio noto è il
caso degli indiani d’America: sono stati
spesi milioni di dollari per dissotterrare
i “tesori”, ma nulla si è speso per salvarli
dall’estinzione.
In situazioni di dislivello di potere, la sto-
ria insegna, prevale sempre la lingua (e
cultura) alta. Menocchio, il mugnaio
friulano bruciato vivo dal Santo Uffizio3,
non preoccupava per la sua visione del
mondo, quanto per l’insieme di valori che
attestavano l’esistenza di una religiosità
insofferente ai dogmi. Bisognava elimina-
re l’esempio di un contadino che, pur par-
lando solo dialetto, opponeva resistenza
al condizionamento dimostrando di ave-
re una mente capace di ragionare.
Allo stesso modo, e sempre per impulso
del Santo Uffizio, a Guardia Piemontese
(Calabria), ottantasei valdesi furono scor-
ticati vivi e fenduti in due parti. «Le terre
spossessate agli er etici contribuivano
ad allargare i possedimenti dei baroni e
la cosa assumeva il suo pieno v alore
pedagogico: stai nell’etica imperante,
non deviare dalla norma e ti troverai ricco
e felice di stare intero con la tua brava pel-
le indosso»4.
Nel secolo a noi vicino, invece, le repres-
sioni linguistiche sono diventate un fatto
legale: in epoca fascista l’italianizzazione
di cognomi, l’esclusione delle minoranze
dai censimenti e, più tardi, i programmi
ministeriali che imponevano agli inse-
gnanti l’esclusivo uso della lingua nazio-
nale, giustificata dal fatto che bisognava
traghettare gli alunni dai dialetti all’ita-
liano5. A nulla servirono, allora, gli inse-
gnamenti dei sociolinguisti, secondo i
quali «le comunità in cui si parla una ed
una sola lingua sono piuttosto l’eccezio-
ne che la norma»6. Solo quando i dialetti
italiani erano già in abbandono i pr o-
grammi ministeriali li riconobbero come
patrimonio culturale dell’alunno. Erano
anni di diffusione di libri-denuncia e
del revival delle culture popolari che dagli
Stati Uniti si era diffuso in tutta Europa.
Il riconoscimento, però, è avvenuto nello
stesso periodo in cui in Italia «il dialetto
è regredito, mentre ha guadagnato spazi
una realtà intermedia: il mistilinguismo,
cioè l’uso alternato o incrociato di italiano
e dialetto»7.
L’obsolescenza delle linguesubalterne è un destino?Ancora oggi, che si tr atti di minoranze
storiche o di lingue di immigr ati, la
logica che accompagna l’emarginazione
è la st essa. Nell’ambito della scuola
l’emarginazione si “dilata” e include svan-
taggiati e stranieri negli stessi percorsi di-
dattici. Bernardi sosteneva che alla pratica
1. M. Bloch, Apologia della Storia, Einaudi, Torino 1988, p. 121.2. U. Bernardi, Le Mille Culture. Comunità locali e partecipa-zione politica, Coines Edizioni, Roma 1976, p. 7.3. Cfr. C. Ginzburg, Il Formaggio e i v ermi, Einaudi, Torino1976.4. Bernardi, cit., p. 89.
5. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza,Bari 1963.6. A. Mioni, La situazione sociolinguistica italiana: pro-blemi di classificazione e di educazione linguistica, inAA.VV., L’educazione linguistica, Atti della giornata di stu-dio GISCEL, Padova 17 settembr e 1975, Cleup, Padova
1975, p. 29.7. A. Sobrero, Lingue, varietà e dialetti nei documenti mi-nisteriali e nella realtà, in I. Tempesta - M. Maggio (a curadi), Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto e ita-liano L2, G.I.S.C.E.L, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 151-161: 153.
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 29
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX30
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
della fenditura si sono sostituite le «esem-
plificazioni pedagogiche, facenti capo
all’autoemarginazione, cioè al senso di col-
pa che nasc e da un c omportamento
non corrispondente ai modelli proposti
dalle agenzie di socializzazione . Per far
morire una comunità culturale basta es-
sere convinti che tutto ciò che le genera-
zioni hanno prodotto in quei luoghi è in-
degno di un vivere civile. Saranno gli stessi
portatori della cultura minoritaria a sba-
razzarsene, saranno loro a fendersi»8.
Anche Cardona9 sosteneva nel 1975 che
l’obsolescenza della lingua in posizione
di subalternità dipende da fatti accultu-
rativi che portano i parlanti a scegliere di
adeguarsi alla lingua considerata alta (o
fatta passare per tale) e a rifiutar e la
propria. «Così agli str anieri si insegna
l’italiano al fine di una più rapida integra-
zione e due lingue str aniere (diverse
dalle materne). Il percorso scolastico è se-
gnato a monte.
Sembra che la scuola cerchi di cancellare
ogni esperienza linguistica pr ecedente
adottando sistemi che producono esclu-
sione. Insegnare l’italiano agli stranieri, in
una sorta di corsa contro il tempo, giusti-
ficabile al fine di una rapida integrazione,
evidenzia anche il carattere autoreferen-
ziale del punto di vista che la governa: gli
“altri” devono diventare come noi, impa-
rare la nostra lingua, perché siamo convinti
che tutto tornerà come prima, convinti di
una “provvisorietà del momento”.
Un destino non inevitabileTra le tante minoranze storiche la cui lin-
gua era a rischio di obsolescenza ci sono
anche quelle che hanno cercato d’inter-
venire attraverso «la rivitalizzazione (quan-
do esistano ancora parlanti nativi) o il re-
vival (quando non vi siano più parlanti na-
tivi)»10. Con il “revival” si cerca di incenti-
vare l’uso della lingua creando una situa-
zione di diglossia. Quando, invece, ci
sono ancora parlanti nativi, sia pure in una
condizione di “semi speakers”, si cerca, at-
traverso la rivitalizzazione e una pianifi-
cazione di recupero dello status della lin-
gua minacciata, di ampliarne gli usi nei
vari domini sociali come in un normale
svolgersi dell’esistenza, cioè la lingua
che si int ende rivitalizzare andrebbe
usata contemporaneamente sia nei do-
mini bassi sia in quelli alti.
Alcune esperienze di questo genere sono
state realizzate in Sardegna, coinvolgendo
le famiglie; e ancora, un progetto condotto
a Galway (Irlanda) con l’intento di pro-
muovere l’uso del gaelico, non è stato pro-
posto alla popolazione in termini espliciti
ma come un’operazione economica, che
avrebbe provocato vantaggi concreti al-
l’intera cittadina11. Anche le c omunità
ladine e friulane oltre alla didattica della
lingua, hanno cercato di coinvolgere la po-
polazione. Nelle min oranze arbëreshë
del sud d’Italia, invece, ciò che ha sempre
rallentato il processo di educazione bilin-
gue è stata la divisione tra i sostenitori di
una Dachsprache, mancando nell’arbëresh
una koiné, e i sostenitori di un insegna-
mento di tutte le varietà.
Mi piace ricordare l’impegno di Pier Paolo
Pasolini per le comunità arbëreshë. Egli
partecipò anche a corsi di aggiornamento
organizzati in Puglia nel 1975. Erano gli
anni in cui anche gli studi linguistici ab-
bandonano l’ideologia unitaria, rivalutan-
do il patrimonio linguistico legato alla di-
versità considerata una ricchezza12.
Ma nemmeno la legge 482 del 1999 ha
spinto gli arbëreshë a trovare unitarietà
di intenti pedagogici.
In Italia le minoranze più favorite sono
quelle dell’Alto Adige, del Friuli, della
Valle d’Aosta – la cui tutela non deriva solo
dall’articolo 6 della Costituzione (che
abbraccia tutte le minoranze), ma anche
da provvedimenti precedenti e seguenti
la Costituzione.
Ma la fortuna non sempre segue le sorti
dei popoli, se questi persev erano nelle
scelte scolastiche sbagliate. Così è acca-
duto che in Valle d’Aosta l’insegnamento
bilingue si può considerare sulla via del
successo perché gli insegnanti realizzano
un curricolo unitario in cui si possono ri-
conoscere parti e funzioni specifiche ,
non una somma di più parti: un curricolo
di educazione linguistica, all’interno del
quale funzioni in parte simili e in parte di-
verse sono attribuite all’insegnamento e
all’uso dell’italiano e del fr ancese. Le
scuole sono uniche e il bilinguismo è stato
inteso non come possesso di competenza
nei due codici paragonabili a quelle di
due nativi (= equilinguismo) ma come ge-
stione di un r epertorio in cui le due
lingue sono possedute in modo differen-
ziato a seconda dei loro domini d’uso e
delle funzioni che esse assolvono nella
vita del parlante13. Tuttavia, dobbiamo
considerare parziale il successo valdosta-
no, dal momento che rimangono perples-
sità sulla scelta utilitarista di puntare sul
francese mentre nulla si è fatto per tute-
lare il patois, che è la L1 degli alunni val-
dostani.
In Alto Adige/Südtirol il sistema scolastico
è costituito da 3 scuole separate e il bilin-
guismo diffuso non è stato raggiunto14.
8. Bernardi, cit., p. 90.9. G.R. Cardona, Introduzione all’etnolinguistica, De Ago-stini, Novara 2006 (prima edizione 1976).10. Dal Negro - Guerini, cit., pp. 146-147.11. A. Marra, Plurilinguismo e lingue minoritarie. Una ri-flessione sul ruolo educativo, in A. Dettori (a cura di), Lin-gue e culture in contatto, Carocci, Roma 2005.
12. De Mauro, cit.13. M. Cavalli, Aspetti curricolari di un’educazione bi-/plu-rilingue:esperienze, riflessioni e prospettive in Valle d’Ao-sta, in T. Barbero/A. Fiore (a cur a di), Insegnare eapprendere in più lingue:una scommessa per l’Europa, Attidel Convegno, Torino, 13 dicembre 2001, IRRE Piemonte,2002.
14. L. Portesi, Crescere in più lingue in Alto Adige-Süd Tirol:esperienze di educazione plurilingue in provincia di Bol-zano, in T. Barbero/A. Fiore (a cura di), Insegnare e ap-prendere in più lingue:una scommessa per l’Europa, Attidel Convegno, Torino, 13 dicembre 2001, IRRE Piemonte,2002.
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 30
Secondo Baur15 le ragioni stori-
che e le loro conseguenze psicologiche
non hanno permesso alle due comunità
principali (italiana, tedesca) di incontrarsi
e la divisione, strumentalizzata anche a
livello politico, ha contribuito a rafforzare
il senso di appar tenenza ad una sola di
esse.
Un’indagine di Abel, Vettori e F orer16,
mette in luce come i fattori non linguistici
contribuiscono all’apprendimento o meno
dell’altra lingua. La ric erca, però, non
tiene conto dei bisogni linguistici indivi-
duali nel senso di scelte personali. Proba-
bilmente chi non si a vvicina all’altra
lingua non ne sente la necessità. Bisogne-
rebbe indagare di più sulle motiv azioni
personali e capir e come la diffusione
dell’inglese e l’idea che questa sia la
lingua franca d’Europa abbia sicuramente
contribuito a dividere ulteriormente le due
comunità in Alto Adige. Sarebbe interes-
sante conoscere quanti dei c osiddetti
monolingui italiani o tedeschi in realtà co-
noscono l’inglese come seconda lingua.
L’arrivo dei nuo vi migranti potrebbe
suggerire modelli dinamici, in continuo
adattamento alle esigenze personali. La
comunità deve offrire, il singolo deve poter
scegliere.
La scuola e la lingua delleminoranzeGli studi condotti sui “modelli” utilizzati
dalle scuole italiane (e non) nei confronti
delle “nuove minoranze”
costituite dagli alunni immi-
grati mostrano come, «nono-
stante le grandi differenze esistenti tra le
politiche migratorie dei diversi Paesi,
emergono
delle sorprendenti somiglianze nelle po-
litiche educative e scolastiche»17. Favaro
individua un modello che adotta classi
preparatorie o di accoglienza (provvisorie,
ma in realtà la permanenza in tali classi
dura poi anni), in attesa di inserimento nei
corsi comuni e per età anagrafica, model-
lo basato su misure di sostegno (lingui-
stico) durante le ore di altre discipline. E
le classi bilingui (cioè strutture parallele
e separate dal “sistema comune”). Anche
queste dovrebbero essere provvisorie
perché vi si insegna la lingua materna as-
sieme a quella del paese ospite, chiuden-
do ogni possibilità alla scelta individuale.
Svantaggi: durano tutta la scuola dell’ob-
bligo, mancano materiali didattici, non c’è
preparazione adeguata per gli insegnanti,
e inoltre, sotto la parola immigrati o mi-
granti, si cela una vasta gamma di diver-
sità linguistiche e culturali che rischiano
di essere appiattite e tenute separate dal-
la comunità ospitante.
Tutti gli interventi hanno al centro della
preoccupazione la lingua di arrivo (L2)
e/o le lingue che si insegnano nel sistema
scolastico ospite. Quella materna viene
ignorata. Anche F iltzinger ritiene che
«insegnare la lingua del paese d ’acco-
glienza e i comportamenti sociali del luo-
go per facilitare una futura integrazione
nella società di accoglimento è un con-
cetto di pedagogia per gli stranieri com-
15. S. Baur, Le Insidie della Vicinanza. Comunicazione e coo-perazione in situazioni di Maggioranza/minoranza, titolooriginale: Die Tücken der Nähe. Kommunikation und koo-peration in Merhheits/Minderheitssituationen. Kontextstu-die am Beispiel Südtirol, Edizioni Alfa & Beta, Meran 2000.16. A. Abel, C. Vettori, D. Forer, Learning the Neighbour’s
Language: the Many Challenges in A chieving a Real Multi-lingual Society. The Case of Second Language Acquisition inthe Minority-Majority Context of South Tyrol. In: EuropeanCentre for minority issues (ed.): European Yearbook of Mi-nority Issues, Vol. 9, 2011, p. 16.17. G. Favaro, I protagonisti dell’integrazione e la normativa
italiana, in D. Demetrio/G. Favaro, Immigrazione e Pedago-gia interculturale, La Nuova Italia, Firenze, 1992, pp. 68-72.18. O. Filtzinger, L’accoglienza in Europa: modelli e prospet-tive, in FILTZINGER, O. (a cura di) / TRAVERSI, M., La Scuoladell’accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico,Carocci-Faber, Roma, 2006, p. 110.
31Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 31
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX32
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Invece, nel 2009 il Parlamento europeo
ha riconosciuto come lingue madri sia
quelle autoctone che quelle straniere, per
le quali prevede una «offerta didattica
non obbligatoria e aperta a tutti». Questi
documenti hanno il merito di richiamarsi
non solo ai principi di eguaglianza ma an-
che ai risultati della glottodidattica sul-
l’utilità dello studio di L1. Sembra anzi che
la consapevolezza dei legislatori migliori
in funzione della percezione dell’urgenza
di intervenire, di fronte al regredire sia
delle lingue storiche che delle lingue de-
gli immigrati.
Tuttavia, ancora oggi, i punti poco chiari
rimangono. Non si pr ecisa quale do-
vrebbe essere quando si parla di L3 da
apprendere oltre alla mat erna (L1) e
alla L2 (del paese ospitante). C’è un solo
riferimento: la t erza lingua do vrebbe
essere franca. Tutte le scuole superiori in-
tendono come lingua franca l’inglese, ma
forse sarebbe più giusto affermare che
la lingua franca deve essere la lingua 2, cioè
quella del paese ospitante, la quale per-
mette a tutti, autoctoni e stranieri, di com-
prendersi. E lasciare libera scelta per la
terza.
Un secondo problema è costituito dal fat-
to che si tratta di documenti con valore
indicativo per cui i governi delegano a
enti locali (o perfino alle singole scuole)
l’intera responsabilità delle sc elte di-
dattiche. E le iniziativ e, oltre che di
diversa qualità, risultano anche frammen-
tarie. Per esempio in Calabria si è intro-
dotto l’arbëresh, nelle scuole delle mino-
ranze storiche, con progetti di sole venti
ore annue (!) e lasciati all’iniziativa di sin-
goli insegnanti. Nell’ambiente scolastico
si dice “meglio che niente”. Fishman af-
fermava che tali iniziative sono peggio
dell’aspirina data ai malati t erminali21.
Un altro caso è costituito dalle sperimen-
tazioni CLIL che assumono il principio
della corrispondenza tra una lingua e una
disciplina, in parallelo ad altre lingue e al-
tre discipline (al contrario di quel che si
fa nell’esperienza della Valle d’Aosta).
E poiché ciò avviene in lingue europee
che per gli studenti stranieri non sono
materne, il messaggio che viene tr a-
smesso è che le lingue europee sono più
importanti delle altre.
Mentre le sperimentazioni sc olastiche
condotte a B olzano, richiamandosi a
teorie linguistiche affermatesi dagli anni
‘70 (Cummins e van Ek) che descrivono
i modi e i gradi di apprendimento pluri-
lingue in scenari di immigrazione nella
prospettiva di coinvolgere tutti gli ambiti
d’uso delle lingue), vengono condotte
solo su tedesco e italiano, non tenendo
conto che lo scenario linguistico locale
è cambiato e che i tanti immigr ati ora
sono parte costitutiva della reale co-
munità linguistica locale e che la lingua
madre è ora protetta dall’UNESCO come
diritto degli individui non del territorio.
Si sperimenta come se il contesto fosse
un contesto ideale (che fu) di una comu-
nità di italiani, tedeschi e ladini, contro il
contesto reale (che è) di una c omunità
composta da italiani, tedeschi, ladini e tut-
ti gli altri con le stesse identiche nostre
esigenze. Nell’insegnamento occorre te-
nere sempre presenti i bisogni linguistici
individuali, per garantire il diritto alla dif-
ferenza. La scuola può solo tentare un dia-
logo su valori comuni a tutti.
E «se riesce a creare un movimento di
simpatia e tolleranza, ha svolto la sua fun-
zione più importante»22.
Maria Annita Baffa Università di Bolzano
pensatoria e assistenziale e parte dalla
premessa irreale di una provvisorietà del
momento, cioè che la società di acc o-
glienza diventi di nuovo un paese mono-
culturale e monoetnico»18.
E forse sono proprio queste false credenze
culturali che spingono alcuni ad atteggia-
menti razzistici che classificano le lingue
così come le persone. Una ricerca svolta
in Francia ha messo in luce come gli in-
segnanti francesi applichino il termine “bi-
linguismo” solo in casi di padronanza di
una prima lingua prestigiosa; nel caso de-
gli alunni immigrati, la loro competenza
nella lingua wolof, araba o por toghese
non viene presa in considerazione come
facente parte di un sistema di bilingui-
smo19. Anche De Angelis, Cortinovis e Dal
Negro20 mostrano come gli studenti
immigrati a Bolzano facciano propria la
tesi che “non è il numero di lingue cono-
sciute che conta ma quali lingue uno co-
nosce”. Il modello trentino permette la so-
stituzione di una delle lingue straniere cur-
ricolari con la lingua madre degli studenti.
Ma le scuole attivano solo corsi di spagno-
lo e/o di francese, in alternativa all’inglese
e/o al tedesco, perché lo spagnolo e il fran-
cese, che sono le lingue dei colonizzatori
dei paesi di provenienza di molti immi-
grati, risultano quelle “più rappresentate”
nelle scuole. E tutte le altre lingue?
Indicazioni internazionali e applicazioni localiL’UNESCO, nell’Education Position Paper
del 2003, introduce due nuovi obiettivi:
(a) una educazione di qualità per tutti e per
tutta la vita; (b) la promozione del mul-
tilinguismo a partire dalla lingua madre.
Nel 2007, ha sostenuto che per plurilin-
guismo si deve intendere l’insegnamento
della lingua materna, più quella nazionale
e una straniera, attraverso un approccio
composito e in uno spazio armonic o
aperto a tutte le lingue: il che lascerebbe
intendere tutte quelle pr esenti in un
dato spazio e in un dato tempo.
19. Favaro, cit.20. G. De Angelis, (a cura di), 2009, WP8a, In search of multi-competence: exploring language use and language valuesamong multilingual immigrant students in England, Italyand Austria, Research Report, nel sito www.linee.info Linee(Languages In a Network of European Excellence, Projectno. CIT4-2006-28388 Sixth Framework Programme, p. 41.21. Fishman, cit.22. A. Mioni, Bilinguismo intra e intercomunitario in AltoAdige/Süd Tirol, in F. Lanthaler, Mehr als eine Sprache,Alpha Beta Verlag, Merano 1990, p. 31.
NS5 14-32 problemi:Layout 1 15-11-2012 15:10 Pagina 32
33
This collection of essays on the
Holocaust focuses on its representation
through visual arts such as movies,
graphic novels, and paintings, media
by which the major tragedy of the modern Jewish people was received, perceived, and elaborated. An essay on the
photography during the Holocaust opens the collection: the photos of and in such an e vent are unique and precious
historical documents, that are able to confute those who negate the Holocaust itself and help the collective memory to
remember and better understand what happened, and how, and maybe why it has happened. The “art” produced during
and after the Holocaust was, and still is, mainly a symbolic representation and therefore it is in need o f a continuous
interpretation and critique; but precisely in such e xpressions of creativity the Holocaust conveys its most ar duous
interrogations on evil and the human condition.
La Shoah nelle arti visivea cura di Massimo Giuliani
Il dossier sulla Shoah di quest’anno si focalizza sulle arti visive – pittura, cinema e graphic novels
– e, in continuazione di quello dello scorso anno, esplora alcune particolari modalità con le quali
è stata recepita ed elaborata la più grande tragedia dell’ebraismo europeo moderno, simbolo della
disumanizzazione dell’uomo durante la s econda guerra mondiale. Apre però il dossier una
riflessione su quell’arte-medium, divenuta così quotidiana da farci dimenticare la sua dirompente
funzione, che è la fotografia. Arte loro malgrado, le fotografie della/nella Shoah (al pari di alcuni
cortometraggi sulle vittime e sui car nefici e su alcuni massac ri) sono oggi documenti storici di
eccezionale valore, che parlano più incisivamente di lunghi saggi e che possono, da sole, confutare
i negazionisti e aiutare la memoria collettiva, farcendoci ricordare ciò che è stato, come è stato e,
forse, perché è stato. I testimoni muoiono – lo scorso settembre se ne è andato anche Shlomo
Venezia, il solo sopravvissuto italiano ad essere stato parte di un Sonderkommando – ma le foto
restano e si s colpiscono nelle menti. In modo diverso operano pittura, arte cinematografica e
fumetto, uniti dall’essere “arte” e
dunque già interpretazione dell’evento,
ma in quanto r appresentazioni
simboliche esigono a loro volta di essere
‘lette critica- mente’ e ‘interpretate’:
anche in esse la Shoah riverbera come la
più grande interrogazione sul male
subìto e commess o dall’uomo cont ro
l’uomo, nel cuore del Novecento e nel
cuore dell’Europa (Massimo Giuliani).
Stu
diST
UD
I
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 33
Le fotografie della Shoah italianaLiliana Picciotto
Sulla Shoah esistono migliaia di immagini che potrem-
mo suddividere in a) immagini prodotte dai persecu-
tori, b) immagini prodotte dai perseguitati, c) immagini
prodotte dai testimoni, d) immagini prodotte dagli alleati
all’indomani della liberazione dei campi di concentramento
e di sterminio.
Per quanto riguarda l’Italia, a nostra conoscenza, disponiamo
soltanto di una serie di immagini del tipo a): un album fo-
tografico di un soldato di frontiera tedesco di stanza a Varese,
desideroso di spedire a casa sua istantanee sulle amenità che
aveva ritratto sul lago. L’album consta di parecchie decine di
scatti e comprende anche una serie a dir poco inquietante.
Si tratta di 11 fotografie che riguardano una intera sequenza
di un’azione di polizia antiebraica: concentramento in un giar-
dino di una villa di un gruppo di una ventina di persone (tre
fotografie), carico su camion da par te della polizia tedesca
del gruppo (sei fotografie), ritratti del gruppo di soldati im-
palati a seguire con lo sguardo il camion che se ne va (due
fotografie). L’autore di questi scatti è sconosciuto, così come
la provenienza del diario fotografico conservato oggi presso
il Museo del Risorgimento-Museo di storia contemporanea
di Milano. Il documento è così importante che richiederebbe
uno studio accurato per poterlo interpretare: come sono vestiti
i prigionieri, che divise portano i soldati o i poliziotti, che mese
dell’anno poteva essere, dove poteva essere questa villa, che
visi mostravano i prigionieri, come e in che epoca l’album
è arrivato al Museo del Risorgimento e molto altro. Ma da
dove emerge la Shoah in queste 11 foto? La si vede attraverso
l’atteggiamento dimesso e spaventato degli ebrei raccolti da-
vanti ai soldati tedeschi prima messi in fila poi fatti salire a
forza su un camion. Dall’atteggiamento dei due gruppi emerge
tutta la violenza dell’episodio: da una parte tranquille
persone vestite in abito borghese, dignitosissime, alcune con
barba, alcune con cappello e cappotto, riunite come un gregge
e dall’altra soldati con il mitra spianato. Le foto hanno una
forza intrinseca e, come molte immagini della Shoah,
parlano da sé. Non si vedono cadaveri non si vedono degra-
dazioni umane, ma noi guardando quelle foto siamo ancora
più spaventati: sapendo che cosa è successo a questa gente,
facilmente, ci possiamo mettere al loro posto e pensare che
avremmo potuto essere noi quegli anziani, quei bambini quelle
donne colte sulla frontiera italo-svizzera mentre credevano
di poter sfuggire al loro destino.
Per l’Italia non ci sono altre fotografie, Yad Vashem conserva
due scatti che ritraggono il quartiere ebraico di Roma e hanno
come didascalia “azione antiebraica”. Ma i personaggi che si
scorgono sul fondo della strada sono talmente piccoli da essere
impercettibili all’occhio, in pratica non si vede niente.
Chi l’ha visto?Non ci sono dunque molte immagini della Shoah italiana, ma
disponiamo per fortuna di parecchie immagini che rimandano
alla Shoah.
Mi riferisco all’importantissimo fondo documentario donato
dal Colonnello Massimo Adolfo Vitale al Centro di Documen-
tazione Ebraica Contemporanea nel 1957. Sono le fotografie
degli scomparsi da lui raccolte nell’ambito delle sue funzioni
di Presidente del Comitato Ricerche Deportati Ebrei (CRDE),
sorto in seno all’Unione delle Comunità Israelitiche, all’in-
domani della liberazione di Roma. Scopo del Comitato era
la raccolta di informazioni utili al ritrovamento dei deportati;
ottenere aiuti dalle autorità civili, militari, politiche e private;
fornire assistenza morale e mat eriale alle famig lie dei
deportati. Il CRDE fu il luogo in cui famigliari e conoscenti
potevano portare notizie, documenti, immagini dei loro cari
scomparsi, chiedendo aiuto per il loro rintraccio.
L’obiettivo di tale comitato consisteva nella ricerca appunto
degli scomparsi, in un ’atmosfera di t otale ingenuità e
ignoranza dei termini e della radicalità della Shoah. Roma era
appena stata liberata, ma il resto di Europa, per non parlare
dell’Ungheria, era ancora in preda alla follia omicida dei nazisti
e dei loro collaboratori, le frontiere ancora chiuse, il “terribile
segreto” non ancora svelato. Per gli ebrei di Roma lo shock
arrivò solo quando l’ambasciatore d’Italia a Varsavia, interes-
sandosi per sapere quanti e quali erano gli ebrei italiani liberati
ad Auschwitz, ricevette nella primavera del 1945 dalla Dele-
gazione per la Polonia della Croce Rossa italiana uno scarno
elenco di 45 persone. Dall’Italia, ma da Roma soprattutto, era-
no state strappate alle loro case migliaia di persone: dove erano
dunque finite? Non si poteva credere che tutte fossero morte.
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX34
STUDI
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 34
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 35
STUDI
La terribile verità si fece però a poco a poco strada. Lo stesso,
le speranze non morirono, i parenti giungevano al comitato
e portavano le fotografie dei loro cari in un disperato gioco
di “chi l’ha visto?”.
La stessa cosa successe in tutte le capitali europee liberate. Im-
magini simili tappezzarono il centro di raccolta e di informa-
zione a Parigi dell’hotel Lutaetia, quartier generale per le ri-
cerche degli scomparsi e per i soccorsi e i primi aiuti a chi rien-
trava dalla deportazione.
Il colonnello Vitale, oltre alla raccolta delle fotografie, operò
per stilare un elenco romano prima, nazionale poi, degli scom-
parsi per poterlo mandare a tutti i comitati di soccorso che
si moltiplicavano nell’Europa liberata e sconquassata.
A Roma le persone portavano le fotografie, che venivano prese
in consegna e graffate su cartoncini azzurri a linguetta, ognuna
con una lettera dell’alfabeto, in modo da poter essere riposte
in un cassetto da schedario e la loro ricerca fosse rapida; sulle
schede fu scritto a mano un cognome e un nome.
Dal primitivo scopo di ricercare gli scomparsi, persa ogni spe-
ranza di ritrovarli vivi, il CRDE si r iconvertì dopo qualche
anno, in un ente che raccoglieva i segni della Shoah: furono
interrogati i pochi reduci che cominciarono a rientrare nel
giugno del 1945 perché raccontassero che cosa avevano visto
durante la loro deportazione, furono raccolte lettere dalle pri-
gioni e dal campo di Fossoli, furono ricercate e ritrovate alcune
delle liste nominative di trasporto che accompagnavano i con-
vogli dei deportati, furono raccolti bigliettini gettati dal treno
dai deportati ritrovati da ferrovieri o poliziotti italiani e fatti
avere alle famiglie destinatarie. Sembrava a tutti che portare
al Comitato queste tracce servisse a rinfocolare il sottile filo
di speranza. Questa st raordinaria raccolta divenne una
raccolta documentaria importantissima e costituì il primo nu-
cleo dell’archivio del CDEC, diretto dal tra il 1955 e il 1958
da Roby Bassi, studente di medicina a Venezia e membro della
Federazione Giovanile Ebraica d’Italia.
Le foto raccolte allora furono qualche centinaio, custodite
amorevolmente dal CDEC ultimamente sono state affidate
a una ditta di restauro perché se ne prolungasse nel tempo
la conservazione. Il progetto, che comprese il salvataggio e la
duplicazione in digitale delle fotografie, è stato finanziato dalla
The Conference of Jewish Material Claims Against Germany con
sede a New York, dalla Soprintendenza ai Beni Archivistici della
Lombardia, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’in-
tervento fu altamente qualificato: le foto furono ripulite dalla
loro patina di sporco e dalle macchie di umidità, i punti me-
tallici, risalenti a ormai più di cinquant’anni, che producevano
ruggine furono rimossi e negli otto buchi provocati dalla cu-
citrice ai lati delle foto, fu passato un filo di poliestere che li
fissasse, senza danno e in maniera non invasiva, ai cartoncini
originali che si presentavano ancora sani. Il restauro fu lungo
e laborioso, ma il lavoro risultò ottimo. Ora il fondo docu-
mentario è salvo e conservato presso l’archivio fotografico del
CDEC.
L’evocazione dei destiniQuanto al contenuto delle fotografie in oggetto, occorre dire
che gli sguardi di coloro che hanno scattato le fotografie sono
molteplici ed emergono chiaramente dal modo stesso in cui
i soggetti sono stati ritratti. Queste immagini non rispondono
alla domanda che ci si pone sulle fotografie dello sterminio:
è possibile narrare o raffigurare l’inenarrabile violenza?
Nello sguardo delle persone ritratte non c’è nessuna idea, nes-
suna premonizione di ciò che accadrà loro, sono fotografie
di circostanza scattate in qualc he gita, talvolta al mar e,
spesso sono foto tessera. Sono ritratti di vite normali, salvo
alcune, quasi nessuna può essere definita una bella foto nel
senso estetico, sociale o artistico che si da a questa definizione.
In questa c ollezione, manca un element o fondamentale
della fotografia, il rapporto diretto ed esclusivo tra l’opera e
l’artista che con il suo scatto vuole dire qualcosa, che sta in-
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 35
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX36
STUDI
terpretando la realtà. Esiste, solitamente, una responsabilità
del soggetto creativo che qui manca totalmente.
L’unica domanda che è lecito porsi davanti a queste immagini
è: “a che cosa servono queste foto a noi qui e adesso?”. Servono
a ricordarci che queste persone mancano all’appello dei vivi,
che tutta una generazione è sparita, che di loro è stato fatto
scempio e che noi abbiamo il dovere della memoria. Non sono
le foto prese ad una a una che parlano, ma lo spazio che esse
occupano, il loro essere tutte insieme. La collezione in sé induce
emozione e senso di responsabilità. Chi guarda è portato na-
turalmente a cercare di capire a chi appartengono quei volti,
dove è nata una tal persona, che fine ha fatto, assieme a chi
è stata deportata, e molto altro.
È una specie di movente a posteriori generato dopo che lo
sguardo si è posato sulla fotografia. La coscienza civile è tra-
sferita dallo sguardo di chi scatta allo sguardo di chi fruisce
di queste immagini.
Esporle oggi per uno scopo diverso di quello per le quali sono
state raccolte costituisce una trasfigurazione del senso (la terza,
rispetto allo scatto originale) di queste immagini, risponde
al cosiddetto effetto di prossimità ricercato da tutti i musei
della Shoah in tutto il mondo: provocare l’emozione del vi-
sitatore tramite una evocazione individuale dei destini per-
sonali. Non sono ormai rari i monumenti della Shoah fatti
di fotografie: la torre dei volti all’United States Holocaust Me-
morial Museum di Washington (17 metri di altezza, gremiti
di fotografie famigliari), così
come la cupola delle fotogra-
fie a Yad Vashem, o il muro
delle fotografie al Memorial
de la Shoah di Parigi non ser-
vono a far conoscere le per-
sone ritratte ma servono a far
capire lo scandalo della loro
scomparsa. Come dice Cle-
ment Chéroux nel suo saggio
su Fotografia e Shoah pubbli-
cato nel 2006, ciò che colpi-
sce nelle fotografie scattate
prima che il massacr o ini-
ziasse «è il potere di evocare
un qualcosa che ancora non
è avvenuto nel momento in
cui l’immagine è stata scattata, ma che è irrimediabilmente
accaduto invece all’epoca di chi le osserva». E, dice Barthes
nel suo saggio La camera chiara: «Io leggo nell o stesso
tempo: “questo sarà” e “questo è stato”; osservo con orrore
un futuro anteriore di cui la morte è la posta in gioco». Con-
templando le fotografie del Fondo Vitale, riferendoci ancora
ad un concetto espresso da Barthes a commento delle foto fa-
migliari che precedettero la Shoah, si ha una sconvolgente
compressione della successione temporale, sensazione che vie-
ne moltiplicata dall’opposizione di ciò che si vede con ciò che
si sa di loro.
Non occorre scandagliare il nostro repertorio dell’immaginario
per capirle, dobbiamo guardarle così come sono, la loro forza
sta nell’ispirare serenità, nel non essere significative prese una
a una. Non c’è un solo autore, né un punto di vista univoco,
ma tanti punti di vista. I ritratti maschili sono in generale foto
tessera fatte fare da un fotografo professionale per ottenere
documenti, in un certo senso, sono foto costruite: le persone
sono molto in ordine, con camicia cravatta giacca, sedute, in
posa. Per questo, non si percepisce differenza sociale tra i sog-
getti ritratti, cosa che sarebbe stata normale visto che gli scatti
risalgono perlopiù agli Anni Trenta, epoca in cui le macchine
fotografiche erano un genere di lusso. Nessuno delle persone
ritratte poteva mai pensare che le loro immagini, rimaste nei
cassetti dei parenti sarebbero diventate, dopo la guerra, foto
segnaletiche per il loro rintraccio.
Una scena del filmSchindler’s Listdi Spielberg (1993).
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 36
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 37
STUDI
Le immagini femminiliCi si accorge che sono isolate spesso da fotografie di gruppo.
Talvolta la fotografia è ritagliata malamente, si riconosce la
mano dell’impiegato che ha creato la scheda di “chi l’ha visto”,
probabilmente la mano pietosa di qualche volontario del CRDE
o di Massimo Adolfo Vitale stesso che raccoglieva notizie e im-
magini per poi divulgarle per le ricerche.
Poi ci sono i bambini. Tra di essi Fiorella Anticoli di due anni,
diventata quasi un’icona dopo che il suo bel visino con capelli
avvolti da nastri bianchi è stata pubblicata su Il libro della me-
moria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945.
Intere famiglie furono distrutte durante la Shoah e talvolta
solo alcune immagini ora di uno ora dell’altro famigliare si
sono salvate. Prendiamo la foto delle sorelline Calò, Graziella
e Rina. La loro famiglia era in verità composta da un altro fra-
tellino, Marco nato l’1.1.1933, dalla mamma Silvia Di Veroli,
e dal papà Romolo Calò, tutti deportati e scomparsi. È evidente
che i parenti, come in questo caso, non sono stati in grado,
dopo la guerra, di trovare le immagini di tutti i famig liari
scomparsi e hanno portato alla sede del Comitato quello che
hanno potuto mettere insieme. Nel caso delle foto di bambini
dobbiamo tenere presente che essi non sono quasi mai de-
portati da soli ma con la loro famiglia.
Spillate sui cartellini ci sono anche foto di anziani: per esempio
Emma Luzzatto in Michaelstedter nata nel 1854, o Ida Trevi
in Ascoli del 1860. Come è possibile che qualcuno, consegnan-
do le foto al Comitato, potesse credere che fossero vive? Che
i nazisti avrebbero rispettato la vecchiaia? Eppure la Shoah
era ancora troppo vicina, i particolari e la radicalità del mas-
sacro erano ancora poco noti.
Ci troviamo di fronte a classiche foto qualsiasi che sono però
mute se non interpretate. Si è dovuto fare un lungo lavoro per
rintracciare le persone, talvolta una donna era segnalata con
il solo nome da sposata, talvolta vi è un solo deportato all’in-
terno di una fot o di g ruppo, talvolta la fot o ritrae un
neonato ma il nome corrisponde ad un giovane adulto. Il ri-
sultato, la pubblicazione del Fondo Vitale su web, costituisce
una risposta necessaria al crimine nazista che tendeva a ri-
muovere la materialità e perfino il ricordo di quegli individui
dalla nostra coscienza. Metterle a disposizione del pubblico
è stato un piccolo gesto di resurrezione.
Liliana Picciotto Cdec (Centro Documentazione Ebraica Contemporanea) - Milano
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE (in italiano quando tradotta)
S. Milton, Images of the Holocaust, in «Holocaust and Genocide Studies», 1,1 (1986), pp. 27-61 e 1,2 (1986), pp.193-216.L. Picciotto [Fargion], L’attività del Comitato ricerche deportati ebrei. Storia di un lavoro pionieristico (1944-1953), in Una storia ditutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza in Piemonte,Franco Angeli, Milano 1989, pp. 75-98.C. Chéroux (a cura di), Memoria dei campi. Fotografie dai campi di concentramento e di sterminio nazisti (1933-1999), Contrasto, Mi-lano 2001.R. Barthes, La camera chiara, Einaudi, Torino 2003.S. Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino 2004.R. Raskin, A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo, Aarthus University Press, Aarthus 2004.J.Struk, Photographing the Holocaust. Interpretation of the Evidence, I.B.Tauris, London-New York 2004.G. Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, R. Cortina, Milano 2005.C. Chéroux, Fotografia e Shoah, in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, vol.IV,UTET, Torino 2006.M. G. De Bonis, L’immagine della memoria. La Shoah tra cinema e fotografia, Onyx Edizioni, Roma 2007.An. Gilardi, Lo specchio della memoria. Fotografia spontanea dalla Shoah a You Tube, Bruno Mondadori, Milano 2008.F. Rousseau, Il bambino di Varsavia. Storia di una fotografia, Laterza, Bari Roma 2011.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 37
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX38
STUDI
Il cinema della Shoah ha, innanzitutto e come ogni cosa, una
storia. Ed è una storia ben scandita nel tempo1. Restringiamo
subito il campo di osservazione. Per cinema della Shoah si
intenderà qui quanto, in termini di documentario e finzione,
qualche volta intrecciati, viene prodotto dopo l’Evento, con l’in-
tento di offrirne in qualche modo una interpretazione e riela-
borazione.
Ci sono degli antefatti che meriterebbero da soli un’analisi estesa
e puntuale, ma che in questa sede possono essere soltanto som-
mariamente indicati: i film pre-, come quelli antisemiti della
Germania nazista; i film durante, come i più celebri Il grande
dittatore di Chaplin e Vogliamo vivere! di Lubitsch; le riprese
realizzate dagli stessi nazisti, con finalità diverse, tra “documen-
tazione” e propaganda; ed infine, e soprattutto, quanto viene
filmato dagli Alleati, in presa diretta, alla liberazione dei campi,
pellicole che comunque dovranno aspettare diverse decadi per
essere proposte al grande pubblico nella loro maggiore o minore
integralità. Il vero e proprio “cinema della Shoah”, nell’accezione
che si è detta più sopra, inizia forse con un curioso esempio
di docufiction, come si direbbe oggi, e cioè il film Ostatni etap
(L’ultima tappa, 1947), di Wanda Jakubowska, una vera ex-de-
portata polacca (ancorché non ebrea), poi regista affermata nel
suo paese, che lo realizza in parte ad Auschwitz, con la colla-
borazione di altri sopravvissuti.
C’è un evidente parallelo con la prima ondata, in quelli stessi
anni dell’immediato dopoguerra, di diari e testimonianze della
persecuzione e della prigionia, l’ondata, cioè, di Primo Levi e
di tanti altri che, per certi versi, allora, nessuno volle davvero ascol-
tare. Ed è un parallelo che si rafforza pensando al fatto che poi,
per parecchio tempo, fino forse ai primi anni settanta, il tema
della distruzione degli Ebrei durante la Sec onda Guerra
Mondiale sarà affrontato perlopiù, nel cinema di finzione eu-
ropeo e americano, con maggiore o minore coraggio, ma co-
munque sempre di lato, come ingrediente narrativo tra altri,
spesso come mero elemento di spettacolarizzazione, e comun-
que mai colto nella sua specificità.
Ci sono, naturalmente, eccezioni che confermano la regola, o
meglio passaggi che testimoniano la difficoltà e la complessità
di un percorso. Se è fondamentale, anche per la sua immediata
diffusione e per il successo mediatico nel tempo, un film di mon-
taggio come il br eve ed int enso Notte e nebbia di Alain
Resnais (1956)2, sono comunque significativi anche gli exploit
di film come Il diario di Anna Frank (George Stevens, 1959)
e L’uomo del banco dei pegni (Sidney Lumet, 1965). Se il primo
è ricollegabile, com’è ovvio, al successo planetario del libro da
cui era tratto (via un’altrettanto celebre piéce teatrale), il secondo
è significativo per il modo in cui la Shoah v iene tematizzata
più come memoria ineludibile del protagonista che come evento
di cui tentare una almeno parziale ricostruzione narrativa. Ma,
già allora: è poi possibile rappresentare o raccontare con im-
magini in movimento una realtà così, per definizione, irrap-
presentabile, e di cui per giunta non si è forse ancora colta la
reale portata storica e metastorica e la specificità ebraica, ben
oltre le generiche atrocità della guerra e la malvagità inumana
e senza limiti dei nazisti?
Nel frattempo altri film osano di più, come Kapò di Gillo Pon-
tecorvo (1960), e soprattutto alcune straordinarie opere rea-
lizzate nell’Europa Orientale, come La passeggera di Andrzej
Munk (Polonia, 1963)3 e Il negozio al corso di Jan Kadár e Elmar
Klos (Cecoslovacchia, 1965); ed è degno di nota il fatto che nel
1. Per una rassegna più estesa dell’argomento e più ricca di informazioni specifiche enotazioni critiche sui singoli film, anche se ferma a qualche anno fa, ci permettiamodi rinviare al nostro: Il cinema della Shoah e la memoria, in: Memoria della Shoah. Dopo«i testimoni», a cura di Saul M eghnagi, Donzelli, Roma 2007, pp. 143-154, anche on-line: http://www.ucei.it/giornodellamemoria/?cat=9&pag=11. Qualche piccola osser-vazione iniziale. Si sono richiamati, per chiarezza e brevità, i titoli italiani e non quellioriginali di pressoché tutti i film citati. Inoltre, non si è ritenuto necessario specificare,in ogni occasione, quando si trattasse di storie originali e quando in vece (in realtà,nella stragrande maggioranza dei casi) tratte da testi preesistenti, siano essi memoria-listica, ricostruzione storica o letteratura di finzione. 2. Ma Nuit et brouillard non è già più soltanto montaggio, con scene a colori, sui luoghi
Cinema e “rappresentazione” della ShoahMino Chamla
coinvolti, che si alternano a quelle di repertorio in bianco e nero. In altre parole: si co-mincia a decifrare il senso per l’oggi, si tenta di dare un’interpretazione, ben oltrequel che si vede. 3. È un film straordinario e leggendario, non completato per la morte dell’autore, eperciò montato da un collaboratore con un ricorso abbondante a singoli foto-grammi fissi. In realtà, i protagonisti non sono ebrei, ma una deportata politica po-lacca e la sua aguzzina. Questo non impedisce al regista (tra l’altro, “anche” di origineebraica) di ritrarre la realtà del campo (Auschwitz) come nessuno aveva mai fattoprima, mostrando ad esempio in modo molto esplicito e preciso, e sia pure sempredall’esterno, la procedura di messa a morte col gas nella sua fase più evoluta e per-fezionata.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 38
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 39
cinema, all’Est, il discorso sulla persecuzione e lo stermino
del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale è
molto più esplicito che nelle parallele celebrazioni ufficiali
degli stessi anni negli stessi paesi, quando gli Ebrei in quanto
tali spariscono e divengono soltanto vittime, come tutte le altre,
della “barbarie nazifascista”.
Raccontare per testimoniareL’atmosfera cambia, anche per il cinema, nella seconda metà
degli anni settanta4. Anche per il cinema: poiché in realtà è
tutta la discussione pubblica sulla Shoah c he cambia, in
quest’epoca, e ancor più cambierà nei decenni successivi. Si
entra, intanto, nell’era del testimone: i sopravvissuti parlano
e raccontano, finalmente, perché sentono che c’è reale in-
teresse per quello c he hanno da r accontare5. Si coglie
sempre di più la specifica portata ebraica della vicenda, quale
apice di un fenomeno, l’antisemitismo, che ha a che fare con
gli strati più profondi e anzi le viscere della coscienza europea
e occidentale (ma non solo) in genere. La gestione della Me-
moria diventa preoccupazione condivisa. Mentre gli storici
approfondiscono come non mai le loro ricerche; i filosofi cer-
cano di “pensare Auschwitz”; gli artisti di tutti i tipi tentano
di trovare le forme adeguate e le giuste strategie per narrare
e rappresentare…
Il cinema non è da meno di tutto il resto. Anzi: proprio l’in-
trinseca popolarità del mezzo – il suo impatto, in apparenza,
immediato sugli spettatori, anche quando è “cinema (più) dif-
ficile” – lo mette spesso al centro delle dinamiche più pubbli-
camente rilevanti. Inizia così l’epoca dei film-evento. Curio-
samente, ad aprire la pista non è un film per il cinema ma uno
sceneggiato televisivo molto hollywoodiano, nelle intenzioni
e nell’impianto, e cioè Holocaust (Marvin Chomsky, 1978). La
tradizionalissima narrazione non de ve ingannare. Per la
prima volta, attraverso le vicende esemplari della famiglia ebrai-
co-tedesca che ne è protagonista, ad essere tematizzato è ap-
punto l’Olocausto del titolo, in quanto tale; non a caso la messa
in onda in Ger mania sconvolgerà gli spettatori tedeschi.
Mentre Shoah di Claude Lanzmann, qualche anno d opo
(1985), è l’oper a fondativa per eccellenza di un matur o
“cinema della Shoah”. Anche qui il titolo (fondamentale, tra l’al-
tro, per la diffusione su scala globale del termine ebraico a de-
finire l’Evento) è già significativo di per sé, nella sua vaghezza
(gli eventi) e insieme nella sua puntualità (l’Evento nel suo essere
unitario e particolare). Attraverso le sue nove ore e mezzo di
interviste ai sopravvissuti (ma anche ad aguzzini e “spettatori”),
rigorosamente senza filmati di repertorio, Lanzmann ricrea la
Shoah con la testimonianza, ed anzi dà a quest’ultima un nuovo
e definitivo significato, senza alcun intento meramente docu-
mentario o di “rappresentazione”, ma piuttosto compiendo
un’azione che è, insieme, nominazione delle vittime, narrazione
straziante senza consolazione finale, e vero e proprio “pensiero
della Memoria”. Shoah non è, beninteso, un film popolare, ma
costituisce comunque un archetipo ineludibile, un punto di ri-
ferimento per tutto il cinema che verrà dopo e che vorrà parlare
di questo6. E poi c’è Schindler’s List, che è davvero il film-evento
e spartiacque – seguito, in questo, e al suo stesso livello, soltanto
da La vita è bella di Benigni, forse da Train de vie di Mihaileanu,
4. Ma va almeno ricordato Mr. Klein (Losey, 1976), per il suo valore metaforico ed anti-cipatore, nel narrare dell’identificazione progressiva di un gentile francese con il suodoppio ebreo, fino a condividerne la deportazione.5. In realtà, un antefatto importante di tutto questo era già stato il Processo Eichmanndel 1961, appunto per il nuovo ruolo ch’era stato attribuito ai sopravvissuti-testimoniin quell’occasione.
6. E non si parla soltanto del “cinema dei testimoni”, che si è tutto collocato, dichiara-tamente, nella scia di Shoah – si veda, al riguardo, soltanto a modo di esempio, il “con-solatorio” (ma non per questo disprezzabile) The Last Days di James Moll (1998); e lamemoria testimoniata, certo molto consapevole della lezione di Lanzmann, negli ita-liani Memoria (Gabbai, 1997) e Volevo solo vivere (Calopresti, 2006).
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 39
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX40
STUDI
e sicuramente da Il pianista di Polanski. Il fatto è che Spielberg
porta a maturazione, nel suo film, un discorso sulla rappresen-
tazione cinematografica della Shoah che è quasi paradossale:
non si può rappresentare la Shoah in quanto tale, ma si può
soltanto narrarne uno scorcio, e questa narrazione è, prima di
tutto, interpretazione e “pensiero”, nel senso di interrogazione
sull’Evento.
Può apparire strano parlare in questo modo di un film di così
evidente e magistrale spettacolarità, e così, in apparenza, per-
fettamente hollywoodiano. Ma la vicenda stessa scelta del regista
(per un film che è, tra l’altro, dichiaratamente e programma-
ticamente, dall’inizio alla fine , ebraico-identitario), quella
appunto del “salvatore di ebrei” Oskar Schindler, che non riesce
a salvarne che un numero comunque limitato (soprattutto ri-
spetto a quello dei sommersi) è forse metaforica di altro, e cioè
appunto l’impotenza finale della rappresentazione, la piena con-
sapevolezza dell’impossibilità, estetica ed etica al contempo, di
una immagine che sia davvero riproduzione anche solo sostan-
ziale della cosa.
La rappresentazione impossibileOvviamente, ogni film-evento, tra quelli nominati, merite-
rebbe, al di là di una puntuale ricognizione critica, una di-
scussione approfondita che ne mettesse in evidenza appunto
le contraddizioni sempre latenti tra spettacolo e messaggio
più profondo, o tra consapevolezza ebraica e significato uni-
versalmente umano, o tra realismo più esasperato e metafo-
rizzazione più o meno spinta, etc. Ma quella traccia della rap-
presentazione impossibile pare, a chi scrive, la più interessante,
anche per andare oltre i film-evento7, ad indagare e individuare
percorsi in quella che è ormai una produzione vasta e disse-
minata, fino a ritrovare echi della Shoah anche in film dove
davvero non ci aspetteremmo di trovarli.
Certo è ac caduto quanto era largamente prevedibile: la
Shoah è diventata sempre più, negli ultimi anni, pretesto e ar-
tificio, un modo per nobilitare a poco prezzo la narrazione
cinematografica e renderla in qualche modo più alta e
solenne, oltreché comunque appetibile al grande pubblico8.
Mentre intanto sempre più forte si fa quell’impressione, quel
fastidioso ronzio nella pancia e nella testa (che sempre, in re-
altà, sullo sfondo, magari insieme ad altre suggestioni di segno
contrario, ha accompagnato molti di noi, e sicuramente l’au-
tore di questa nota): davvero lo sterminio non è soltanto ir-
rappresentabile, ma è pure osceno tentare di narrare qualcosa
al riguardo, non appena si faccia la più piccola deviazione dal
rigore assoluto di Lanzmann nel suo capolavoro archetipico
e quindi, proprio per questo, letteralmente e attualmente ini-
mitabile e ineguagliabile.
In particolare, è la Shoah nel suo farsi compiuto a risultare,
di fatto e di diritto, non rappresentabile e neppure “lavorabile”,
attraverso l’immagine filmica, come se davvero il punto di
vista di chi non si è salvato fosse inattingibile (e non solo, be-
ninteso, con il linguaggio del cinema). Non è un caso che la
camera a gas resti un tabù non aggirabile, anche e soprattutto
quando sembra che ci si voglia spingere vicinissimo a raccon-
tarla in modo compiuto9. Ma anche l’Aktion nazista, la morte
perpetrata “sul luogo”, in modo più o meno sistematico10, ri-
mane inaffrontabile, in tutta la sua crudezza, per il cinema
– mentre è semmai il memoir letterario, ed anche quella tipica
manifestazione della “memoria delle generazioni successive”
che è appunto il memoir romanzato o comunque ricostruito
(vedi Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer,
compreso il film che ne è stato tratto e che pare rispettarne
tutte le int enzioni – Sc hreiber, 2005 –, ma anc he un
capolavoro assoluto quale Gli scomparsi di Daniel Mendel-
sohn), a tentare di recuperare in ogni modo anche, e soprat-
tutto, quelle vicende estreme e ancor più rimosse di altre (pro-
prio perché è più difficile ricordare una morte ch’è, se è pos-
sibile, ancora più nasc osta, nelle pieg he della st oria, di
quella, o di quelle, nei Lager).
7. Anzi, si può dire che già l’epoca in cui un film-evento poteva incidere con prepo-tenza nel dibattito pubblico relativo alla “memoria della Shoah” sia passata per sem-pre, alle nostre spalle. Ancora una volta, è evidente il collegamento con il moodgenerale relativo alla gestione pubblica della Memoria e con le sue trasformazioninel tempo (oltre al fatto che non tutti i registi, comunque, sono Spielberg o Polan-ski). 8. Mentre comunque la fiction televisiva, e soprattutto quella italiana, porta spesso al-l’estremo, fino alla caduta nel ridicolo, le mancanze e i pericoli insiti nel “cinema dellaShoah”.9. Molto forte in tal senso è, per esempio, Amen, di Costa-Gavras (2002).10. Non soltanto, dunque, le fucilazioni di massa in Russia, Ucraina o Lituania, maanche quello che tante testimonianze ci raccontano, la caccia all’ebreo nel cuore dellecittà est-europee, con il sangue che letteralmente scorre e cola giù dai marciapiedi;quel che spesso e v olentieri accompagnava la vera e propria deportazione verso icampi.
11. Vento di primavera è, in realtà e soprattutto, il primo racconto cinematograficocompiuto della “retata del Velodromo d’Inverno” (16 e 17 luglio 1942), pagina neris-sima del collaborazionismo francese. In tal senso, può essere interessante incrociarlocol già citato Mr. Klein ed il recente, proiettato sull’oggi, La chiave di Sara (Paquet-Brenner, 2010).12. Ai confini di questa tematica, e di quella dei complessi rapporti tra giovanissimied adulti coinvolti con e per loro, si devono ricordare almeno due film più “vecchi”quali Arrivederci ragazzi (Malle, 1997) e soprattutto Dottor Korczak (Wajda, 1990), cheè anche, tra l’altro, un affresco forte sul Ghetto di Varsavia nella sua fase finale. 13. Mentre un film interessante, e pour cause recente, sulla resistenza armata ebraicatra Polonia e Bielorussia è Defiance – I giorni del coraggio (Zwick, 2008). 14. Alla Zona grigia si può ricollegare un film antesignano del 1989, Oltre la vittoria,di Robert M. Young, girato in parte ad Auschwitz, e che nel raccontare la vicenda di so-pravvivenza del pugile ebreo greco Salamo Arouch già si distingueva per realismo ebrutalità della rappresentazione.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 40
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 41
STUDI
Non a caso, la strategia narrativa cui si ricorre di più, nel ci-
nema recente (ma anche, in qualche caso, in quello pre-Schin-
dler’s List) è quella dell’evidenziazione del punto di vista, un
chiaro escamotage per raccontare il non altrimenti raccontabile.
Si veda, in tal senso, tutto il filone dello sguardo infantile e/o
adolescenziale, dei bambini e ad olescenti, appunto, che
vedono, vivono, raccontano e soprattutto interpretano, più
o meno guidati dag li adulti, la Shoah: il r emotissimo
Andremo in città (N. Risi,1966), Jonah che visse nella balena
(Faenza, 1993), lo stesso La vita è bella, L’isola di Via degli Uc-
celli (Kragh-Jacobsen, 1997), L'ultimo treno (Bogayevicz, 2001),
Senza destino (Koltai, 2005), Il bambino col pigiama a righe
(Herman, 2008), per certi aspetti Vento di primavera (Bosch,
2010)11 e sono, non a caso, quasi tutte vicende vere e di sal-
vezza, con la significativa eccezione del recente, a ragione molto
controverso film di Mark Herman, che spinge la sua narra-
zione metaforica fino al punto di far entrare nella camera a
gas, con l’amichetto ebreo, il figlio del comandante nazista
del campo, nel nome appunto di un comune e innocente
sguardo infantile sulla realtà12.
Anche un film poco noto e poco visto come La zona grigia
(Blake Nelson, 2001) sc eglie la st rada della prospettiva,
quello davvero radicale dei Sonderkommando di Auschwitz
nell’occasione della loro rivolta del 7 ottobre 194413, per rap-
presentare appunto, il più possibile, l’estremo. Ma neppure
così l’estremo può essere attinto fino in fondo, e sia pure in
un film che certo non difetta di crudo realismo (è in gran parte
ambientato negli e intorno agli edifici dei crematori) e che
si candida in modo dichiarato al ruolo dell’Anti-Schindler
e Anti-Spielberg14.
Soprattutto, la questione del punto di vista si fa trasparente
dove si ricorre alla creazione di realtà alternative (Train de
vie, 1998; Jakob il bugiardo, Kassovitz, 1999). Fino alla devia-
zione più radicale, la reinvenzione della storia e il totale ca-
povolgimento di prospettiva negli Inglorious Bastards di Ta-
rantino (2009). In effetti, al di là di tutte le riserve etiche e
storiche che si possono sollevare al riguardo di quel film, va
comunque notato che si tratta appunto di un rovesciamento
della realtà che proprio in ragione della sua inverosimiglianza
ci rimanda al nod o cruciale della questione, e cioè la
dichiarata e alla fine saggia impotenza del mezzo cinemato-
grafico nel parlare dell’evento Shoah.
Un detour è necessario, talvolta, o forse sempre, per poter (non)
rappresentare la Shoah.
Mino Chamla - Liceo Ebraico - Milano
BIBLIOGRAFIA
The Holocaust Film Sourcebook. Edited by Caroline Joan (Kay) Picart. Volume I. Fiction; Volume II: Documentary and Propaganda, Prae-ger, Westport (Connecticut), London 2004.R. Ghiaroni, Catalogo della documentazione filmica e sitografica, in Memoria della Shoah. Dopo «i testimoni», a cura di Saul Meghnagi,Donzelli, Roma 2007, pp. 171-271 (forse il più completo repertorio disponibile al momento in lingua italiana).R.C. e C.J. Reimer, Historical Dictionary of Holocaust Cinema, The Scarecrow Press, Lanham - Toronto - Plymouth (UK) 2012.A. Insdorf, Indelible Shadows. Film and the Holocaust, Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne 2003 (terzaedizione).L. Baron, Projecting the Holocaust into the Present. The Changing Focus of Contemporary Holocaust Cinema, Rowman & Littlefield Pu-blishers, London, Boulder, New York, Toronto, Oxford 2005.Il racconto della catastrofe. Il cinema di fronte ad Auschwitz. A cura di Francesco Monicelli e Claudio Saletti, Cierre, Verona 1998.Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema, Fondazione Serughetti Centro Studi e Documentazione La Porta, Ber-gamo 1999.G. Fink, «In a fleeting montage…»: il cinema americano e la Shoah, Cap. 10 di: ID., Non solo Woody Allen. La tradizione ebraica nel ci-nema americano, Marsilio, Venezia 2001, pp. 183-205.C. Gaetani, Il cinema e la Shoah, Le Mani, Genova 2006.Teaching the Representation of the Holocaust. Edited by Marianne Hirsch and Irene Kacandes, The Modern Language association ofAmerica, New York 2004.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 41
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX42
STUDI
Se è vero, come è vero, che la traccia lasciata dalla Shoah
sulla cultura europea e occidentale è indelebile, il tema
“arte e Shoah” rischia di essere affrontato in modo ridut-
tivo. Non è sufficient e soffermarsi sugli artisti che hanno
vissuto direttamente quella grande tragedia1; bisogna gettare uno
sguardo su altri, più contemporanei, che l’hanno trattata o che
ne sono stati influenzati.
L’argomento è tanto ampio da andare ben al di là dei limiti di
questo articolo, per cui ci soffermeremo solo su alcuni artisti,
evidenzieremo solo alcune modalità con cui la Shoah ha influen-
zato lo sviluppo delle arti visive del dopoguerra.
In effetti ha imposto un balzo in avanti nella creatività, e non
poteva essere altrimenti: per affrontare il tema della Shoah, in
cui la realtà aveva superato ogni immaginazione, era necessario
stravolgere il mondo iconografico esistente, inventarne uno to-
talmente nuovo, oppure eliminare ogni riferimento concreto2.
Marc ChagallUn primo tentativo in questo senso lo si deve a Marc Chagall
(1887-1985), e in relazione a eventi precedenti alla Shoah, ossia
all’ondata di antisemitismo culminata nella Notte dei Cristalli
del 1938. Quel che allora colpì l’artista, non furono solo gli eccidi
e le distruzioni, ma il fatto che nessun paese si schierasse in modo
convinto a difesa degli ebrei tedeschi. Chagall dipinse allora la
sua Crocefissione Bianca, in cui campeggia la figura di Gesù sulla
croce, con il bacino avvolto in un tallit – uno scialle di
preghiera ebraico –, e sullo sfondo è rappresentata la distruzione
di un ambiente tipicamente ebraico. Chagall, come Picasso, aveva
ripreso una tipica rappresentazione cristiana e l’aveva spogliata
di ogni valenza religiosa, per farne un’icona di dolore universale;
il suo passo ulteriore, rivoluzionario, fu di utilizzare l’immagine
di Gesù per rappresentare le sofferenze del popolo ebraico, che
tradizionalmente veniva incolpato della sua morte. L’obiettivo
era certo di scioccare il pubblico e creare un dibattito attorno
alla condizione degli ebrei nel Terzo Reich, ma la scelta di Chagall
derivava dalla sostanziale impossibilità di trasmettere in modo
diverso, con strumenti abituali, il senso di quel che accadeva.
Chagall tornò a utilizzare questa simbologia nel bel mezzo della
Shoah, nella sua Crocefissione Gialla, simile alla precedente ma
ancor più v iolenta, e poi anc ora in di verse altre opere3,
avvicinata ad altri simboli di matrice chiaramente ebraica (capra,
violinista ...). Iniziò cioè a utilizzarla secondo il suo abituale sche-
ma di lavoro, basato sull’accostamento di simboli divenuti dei
Marc Chagall, Crocefissione Bianca(1938). Chicago, Art Institute.
1. Questi artisti sono ben analizzati in S.Feinstein: Dall’ossequio alla trasgressione: l’artee l’Olocausto in M. Cataruzza et alii (ed.), Storia della Shoah (Torino, 2006), pp. 186-237,che riporta anche un’ampia bibliografia in merito; interessante e vasta è poi la colle-zione del museo Yad Vashem di Gerusalemme. Fra gli artisti che hanno vissuto la Shoà,spicca la figura di Felix Nussbaum, espressionista tedesco, che continuò a dipingerefino alla sua deportazione ad Auschwitz e che ci ha lasciato opere fondamentali (comeAutoritratto con Carta d’Identità o Danza della Mor te) per c omprendere lo stat od’animo di chi fuggiva senza reale speranza di sopravvivenza. 2. Anche nel dopoguerra e fino a t empi recentissimi c’è chi ha prodotto arte docu-mentativa sulla Shoah, riproducendo quanto avvenuto o quanto è rimasto, come adesempio Deborah Howard con i suoi disegni di sopravvissuti; ma è un percorso chesi sovrappone con i numerosi film, le fotografie, i testi a disposizione e quindi è pocoseguito.3. Si guardi Sacrificio di Isacco nella sua serie sul Messaggio Biblico (anni ‘50-‘60), in cuiun Gesù che porta la croce fa parte di un gruppo di uomini a lutto; o Esodo del 1952-66, in cui Mosè conduce verso Israele anche le vittime dell’Olocausto fra cui campeg-gia la figura di un Gesù in croce; oppure nelle vetrate della Cattedrale Fraumuster diZurigo.
La Shoah nella pittura contemporaneaDaniele Liberanome
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 42
43
STUDI
termini di un suo proprio vo-
cabolario, per cui le sue opere
possono essere lette come
una sorta di rebus, compren-
sibile attribuendo il corretto
significato a quei simboli.
L’astrattismoLa Shoah ha c osì radical-
mente influenzato tutto il
lavoro di Chagall, ma attra-
verso la laicizzazione della fi-
gura di Gesù, anche il percorso di un gran numero di artisti suc-
cessivi4, svolgendo un ruolo fondamentale nello sv iluppo di
un’arte figurativa non documentativa legata alla Shoah.
Altri artisti, come gran parte degli esponenti del fondamentale
movimento americano degli “Espressionisti astratti”5, trovarono
impossibile rappresentare la realtà dopo l’Olocausto; si
sentirono obbligati a spostarsi verso l’astrattismo, trascinando
con sé buona parte dell’arte occidentale. Uno dei più noti fra
loro, Mark Rothko (1903-1970), in gioventù dipingeva scene
di vita urbana.
Nel 1941, però, non appena si diffuser o le notizie sulla
Soluzione Finale, cambiò improvvisamente soggetto passando
a trattare miti greci e romani, – distanti da una realtà che mal
sopportava –, oppure scene religiose cristiane, seguendo il mo-
dello di Chagall. Qualche anno dopo, sentì di dover completare
questo processo di distacco dalla figurazione dipingendo i suoi
celebri quadri “color-field”, losanghe di colore diverso che pos-
sono ricordare le fosse comuni allineate che si vedevano nelle
fotografie provenienti dall’Europa nazista6.
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
4. Barnett Newman, ad esempio, nella The Stations of the Cross, tracciò una linea ver-ticale su un fondo monocromo bianco aggiungendo le ultime par ole di Gesù sullacroce riportate dai Vangeli, Lama sabachtani. Si guardi anche Redeemer of Auschwitzdi Mathias Goeritz, e anche le opere di Mané Katz (del 1945), di Marcel Janko, di YankelAdler, fra gli altri.5. Lo stesso percorso di distacco progressivo dalla figurazione per effetto delle im-magini di mutilazione e di tr agedia della Shoah, è stato esplicitamente seguito daaltri espressionisti astratti come Barnett Newman, che nel 1945 distrusse tutti i suoiprecedenti lavori figurativi.
6. In alcuni suoi lavori, i riferimenti all’Olocausto paiono fondersi con il senso di scon-forto che precede il suicidio. Le opere della serie Black on Maroon del 1958, concepitaper il Seagram Building di New York (una tela si trova alla Tate Gallery di Londra), pa-iono vere “porte dell’inferno” con le losanghe in verticale che paiono colonne di fumoo di fuoco. Quei lavori colpirono i collezionisti John and Dominique de Menu, che necommissionarono di simili per la loro cappella privata di Houston (Texas) – conside-rata da Rothko come il suo capolavoro.
Le installazioniA partire dagli anni ’60-’70, quando si era placato il dolore acuto
per quanto era accaduto ed era possibile riflettervi meglio, alcuni
artisti hanno ripreso a raffigurare il tema della Shoah utilizzando
un’iconografia del tutto nuova, senza seguire l’impostazione di
Chagall.
Alcuni di loro, hanno riutilizzato oggetti o immagini oramai
irrimediabilmente riconducibili alla Shoah grazie alla diffusione
di film e documenti in genere, trasferendoli in un contesto di-
verso e creando opere dal forte potere evocativo.
Dani Karavan (1930), ha creato una serie di installazioni tra-
sferendo in piazze e musei alcuni metri di binario di treno evi-
dentemente non nuovo, completo di traversine e di massicciato.
I binari terminano contro un muro su cui ha scritto il numero
dell’ultimo detenuto uscito da Auschwitz. Ha poi introdotto al-
cune varianti alla sua opera, eliminando quel numero, sisteman-
do il binario anche sul muro perpendicolare a terra o aggiun-
gendo televisori che trasmettono video di un uomo che cam-
mina. La sostanza, però, non cambia. I binari, così sistemati, evo-
Marc Chagall, Solitudine(1933). Museodi Tel Aviv.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 43
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX44
cano potentemente la Shoah, Auschwitz, l’assenza di ogni spe-
ranza di ritorno dalle deportazioni, la disperazione di coloro
che viaggiavano sui treni della morte, con un notevole impatto
emotivo.
Jenny Stolzenberg (1947) ha invece creato copie in ceramica di
alcune scarpe di deportati, prese dalle cataste che sono state tro-
vate nei lager liberati, oppure prestate da sopravvissuti. L’ap-
proccio della Stolzenberg è diverso rispetto a Karavan, perché
la scarpa si ricollega alla storia personale di una vittima, tende
a trasmettere più la dimensione personale della t ragedia,
meno quella collettiva. Christian Boltanski (1944), ha utilizzato
invece montagne di vestiti: nell’installazione “No man’s land”
che ha presentato all’Armory Show del 2010, il pubblico si trova
di fronte ad un muro massiccio sessantasei metri di lunghezza
costruito da scatole impilate di biscotti ossidati, attorno al quale
si sviluppa un paesaggio di indumenti smessi. Gli stessi indu-
menti che si trovano in “Reserve” del 1989, per riempire le stanze
e i corridoi del Museum Gegenwartskunst di Basilea7.
Il ritorno al figurativoLa potenza evocativa delle icone della Sho-
ah è stata utilizzata anche in lavori che ri-
flettono sui nodi sociali della società del
dopoguerra, e che dimostrano l’impatto
duraturo della Shoah sull’arte del dopo-
guerra.
Philip Guston (1913-1980), nato in Ca-
nada da una famig lia di ebr ei fuggiti
dall’Ucraina, esponente dei spicco del-
l’Espressionismo Astratto americano, è
noto anche per le sue opere della maturità,
in cui tornò a creare opere figurative. La
sua fonte di ispirazione è il surrealismo;
nelle sue tele rappresenta quindi i pensieri,
l’inconscio, e non di r ado ritroviamo
simboli della Shoah che si riferiscono a
sensazioni vissute nella realtà quotidiana.
Si consideri, ad esempio, Dipingendo, fu-
mando, mangiando del 1973, un olio su
tela esposto allo Stedelijk Museum di Am-
sterdam; in in primo piano è dipinta una
figura con una sigaretta in bocca – vero-
similmente l’artista stesso – e in secondo piano gli oggetti che
rappresentano il suo pensiero, fra cui una montagna di scarpe,
che, al di là della Shoah, indica le angosce e le paure più profonde.
Michal Rovner (1957), mostra immagini riferibili alla Shoah,
ma rimuove i contrassegni che ancorano quelle immagini a un
momento storico preciso e ben individuato, in modo che al-
ludano non solo e non tanto alle sofferenze di un popolo par-
ticolare in un determinato momento storico, ma al tema del-
l’oppressione in genere.
In particolare, nel video all’ingresso della sua mostra “Against
Order? Against disorder?” alla Biennale di Venezia del 2003, poi
riproposto nel Museo di Tel Aviv nel 2011, sembra riprendere
da lontano un gruppo di persone che camminano in circolo,
obbligati a seguire un percorso ben definito; apparentemente
7. Stesso genere di lavoro è 6 millon + di Antonia Stowe, che ha raccolto da paesi di-versi, oltre 6 milioni di bottoni diversi e li ha stesi sui pavimenti di grandi spazi oppureall’interno di teche cilindriche in plexiglass. L’installazione, è stata presentata in variegallerie e luoghi pubblici inglesi.
Marc Chagall, Il rabbino di Vitebsk (1914-1922). Ca’ Pesaro, GalleriaInternazionale d’ArteModerna.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 44
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 45
STUDI
si trovano quindi in un luogo di prigionia. Lo sfondo è di un
bianco accecante, che sembra neve, e gli uomini indossano lunghi
pastrani, come i chassidim dell’Europa orientale, tutti elementi
che fanno ricordare le marce della morte. Talvolta qualche figura
si allontana dal percorso e allora scompare, si spegne, come mor-
ta. Il percorso si chiude in alte colonne d’ombra, – forse il fumo
dei forni crematori, forse alcuni cipressi.
Il lavoro Foglie Morte di di Menashé Kadishman (1932) per certi
versi appare fortemente legato a quello della Rovner, per altri
se ne distanzia decisamente. È stato concepito per il Museo ebrai-
co di Berlino (dove è esposto permanentemente), ma poi ripro-
posto in altre mostre, come “Omanut: Israele Arte e Vita” tenutasi
al Palazzo Reale di Milano nel 2006. In una stanza o in uno spazio
abbastanza ampio, a forma irregolare, Kadishman sistema più
strati di oggetti piatti ovoidali di metallo. Si direbbero foglie, pen-
sando al titolo, ma a guardare bene sono facce, tutte diverse, tutte
terrorizzate, tutte cadute e morte. Ricordano il gran numero di
persone, ciascuna con la sua storia, tutte degne di vita e indegne
della fine fatta. In questo senso, il riferimento alla foglia è frutto
di una v isione positiva, sionista: l’albero che ha gener ato
quelle persone continua a essere vivo. Una lettura poetica con
mille sfaccettature della Shoah, in cui da un lato si riprende il
tema dell’universalismo dell’Olocausto che troviamo in Rovner,
dall’altro i riferimenti agli aspetti tragici sono assai più evidenti.
Di più difficile lettura, ma certo non meno significative, sono
le opere che trattano il tema dell’Olocausto senza usare icone
a tutti note, o segni particolari, ma inserendosi come parte in-
tegrante del lavoro degli artisti, come uno dei vari temi trattati
all’interno del loro percorso.
Anselm Kiefer (1945), conoscitore della spiritualità ebraica, con-
duce da tempo un’analisi sul ruolo del suo popolo – tedesco –
nella Shoah. Ne è testimonianza la serie di pitture Todesfuge (o
Fuga della Morte), iniziata nel 1981 e ispirata dall’omonima e
celebre poesia di Paul Celan, che rilegge i rapporti fra la vecchia
Germania, – simboleggiata dalla Margharete del Faust di
Goethe – e il popolo ebraico – rappresentato dalla Shulamith
del Cantico dei Cantici8. Nella Shoah, scrive Celan, le due figure
seguono un percorso opposto, inconciliabile, testimoniato dalla
contrapposizione fra i capelli d’oro di Margarethe e i capelli di
cenere di Shulamith. Kiefer riprese questa metafora in tele come
Margarethe della collezione Saatchi, in cui i capelli biondi, rea-
lizzati in paglia, terminano con delle fiammelle, quasi accen-
dessero il fuoco dei forni crematori; oppure in Dein goldenes haar
Margarethe della collezione Sanders, in cui quei capelli sono si-
stemati ad arco attraverso cui passano delle linee, che fanno pen-
sare a dei binar i, e su llo sfondo è dipint o un l uminoso
paesaggio rurale, come lo si vedrebbe da un treno in movimento.
Al contrario, una delle tele dal titolo Shulamith, anch’essa parte
della collezione Saatchi, è una pittura d’interno dalle tonalità
scure, o meglio, la riproduzione fedele di un progetto pensato
dall’architetto nazista Wilhelm Kreis come cappella mortuaria
dei soldati tedeschi. In altre Shulamith, il volto della donna è to-
talmente coperto, quasi annullato, dai capelli-cenere, mentre
sullo sfondo sono dipinti dei grattaceli scuri, simbolo della mo-
dernità, che terminano a forma di camino.
Kiefer inserisce quindi la Shoah all’interno di un percorso che
ha radici nel lontano passato, ricco di spunti di riflessioni, di
messaggi, che però richiedono un’attenta lettura per essere com-
preso appieno. D’altro canto, il mancato utilizzo delle icone per-
mette di sviluppare una riflessione originale sulla Shoah che non
si poggia sull’impatto emotivo, sempre più limitato e difficile,
dato dalla visione di documentari, film e fotografie.
Daniele Liberanome Milano
8. Kiefer è autore anche di una serie di oper e sulla Shoah con un utilizzo le tipicheicone, come “Iron Path” (1986) o Lot’s Wife (1989), con i binari in primo piano.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 45
I topolini di ArtNote su Maus di Art Spiegelman
Renata Badii
In questo contributo vorrei provare ad affrontare il com-
plesso tema della rappresentazione della Shoah nel vasto
mondo dei fumetti e delle arti grafiche muovendo da uno
specifico esempio, Maus di Art Spiegelman: un romanzo gra-
fico che ha avuto un’eccezionale ricezione internazionale e
ha fatto parlare di sé non soltanto la stampa specializzata in
comics, ma anche e soprattutto la letteratura della Shoah.
Divenuto un vero e proprio caso di studio1, Maus è spesso in-
dicato come un importante compendio didattico per la Ho-
locaust Education: la promozione dello studio della Shoah nelle
scuole come strumento di educazione civica alla tolleranza
e di prevenzione del razzismo. Le ragioni addotte sono almeno
due. In primo luogo, la semplicità della forma narrativa del
fumetto per degli adolescenti, il cui rapporto con la realtà oggi
è mediato – ancor più che per gli adulti – da una cultura es-
senzialmente visuale. In secondo luogo, la capacità di questo
fumetto di problematizzare la questione stessa della rappre-
sentabilità della Shoah, facendo emergere i problemi di natura
etica ed estetica relativi alla possibilità di rappresentare – nar-
rativamente e graficamente – un orrore “indicibile” e “inim-
maginabile” come la Shoah. Insomma, una lettura semplice,
ma non semplificatoria.
Nato a Stoccolma nel 1948 da Vladek e Anja Spiegelman, ebrei
polacchi sopravvissuti a Auschwitz, Art è cresciuto a New York.
Attivo nel mondo del fumetto underground fin dagli anni Ses-
santa, negli anni Ottanta dirige insieme alla moglie Françoise
Mouly due importanti antologie di fumetti, Arcade e Raw,
dove la storia di Maus comincerà ad essere pubblicata a pun-
tate. Maus uscirà poi in due volumi, pubblicati da Pantheon
Books rispettivamente nel 1986 e nel 1991.
Nel 1992 Spiegelman è stato insignito del prestigioso Premio
Pulitzer per il suo fumetto. A venticinque anni dalla pubbli-
cazione di Maus, l’autore è tornato a parlare del suo libro in
MetaMaus (la cui traduzione italiana è in uscita per Einaudi):
un cofanetto formato da un libro e da un dvd che raccoglie
le interviste a suo padre, i materiali preparatori, e dove Spie-
gelman cerca soprattutto di rispondere alle tre domande che
si è sentito rivolgere più spesso in questi anni rispetto al suo
lavoro: perché un fumetto? perché i topi? perché l’Olocausto?
Queste tre domande costituiscono anche il filo conduttore delle
note che seguono.
In realtà, la storia narrata in Maus è innanzitutto la storia della
relazione tra un padr e e un fig lio. La nar razione inizia
infatti nel 1978 a Rego Park (Queens, New York), quando Art
chiede a Vladek di pot erlo intervistare perché da anni
vorrebbe scrivere un fumetto su di lui e la sua “storia”. L’idea
originaria di Spiegelman non è quella di parlare dell’“Olocau-
sto”; Maus nasce piuttosto dal desiderio di un figlio di cono-
scere suo padre e il passat o che si cela dietro quel numero
175113, tatuato “da sempre” sull’avambraccio dell’uomo.
Il rapporto tra Art e Vladek, come emerge nel corso del rac-
conto, non è mai stato facile. Emblematiche le prime vignette
di Maus: siamo a Rego Park nel 1958, e un Art Spiegelman
bambino torna a casa piangendo, perché i suoi amici non lo
hanno aspettato mentre pattinavano nel parco. Al racconto
del figlio, Vladek risponde seccamente nel suo maldestro in-
glese: «Amici? Tuoi amici? Se chiudi loro insieme in stanza
senza cibo per una settimana, allora tu vedi cosa è amici!»2.
Non è facile essere il figlio di due persone scampate allo ster-
minio nazifascista. L’orrore vissuto non si può dimenticare,
il trauma subito rimane per sempre.
Rispetto alle testimonianze prodotte dalla generazione dei so-
pravvissuti, la storia narrata da Spiegelman cerca però di far
emergere anche il punto di vista della seconda generazione,
quella dei figli dei sopravvissuti, raccontando anche i loro trau-
mi. Maus non narra soltanto la storia di Vladek, ma anche il
tentativo di suo figlio Art di appropriarsi di una memoria fa-
miliare a lungo taciuta dai genitori, e che pure ha inciso dra-
sticamente sulla sua vita. A cominciare dal fatto che Art non
ha mai conosciuto Richieu, il primogenito degli Spiegelman,
1. Per una visione d’insieme degli studi su Maus, prevalentemente di lingua inglese,cfr. Park 2011.2. Nelle citazioni farò riferimento alla traduzione italiana, cfr. Spiegelman 2000.
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX46
STUDI
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 46
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 47
STUDI
morto nel ghetto di Zawiercie
a sei anni: un «fratello fanta-
sma» (così lo chiama Art in
una vignetta che lo r itrae
mentre conversa con la mo-
glie) di cui i genitori non par-
lavano mai quand o lui era
bambino, ma la cui foto appe-
sa nella loro camera da letto
«era come un r improvero»
per il piccolo Art – la rappre-
sentazione di un «bambino
ideale» con cui non poteva
competere (171). «Non mi
sono mai sentito in colpa per
Richieu, ma avevo gli incubi
sulle SS… » (172).
Art proverà invece un enorme
senso di c olpa per la mor te
della madre, suicidatasi nel
1968, quando l’autore ha ap-
pena vent’anni. Nel primo li-
bro di Maus, Spiegelman ri-
produce le tavole del fumetto
che aveva disegnato dopo la
morte di Anja: in Prigioniero
del Pianeta Inferno (questo il
titolo del fumetto, il cui stile
psichedelico contrasta netta-
mente con la sobrietà grafica
di Maus), il giovane Spiegel-
man aveva raffigurato se stesso
con indosso l’uniforme a stri-
sce, caratteristica degli inter-
nati dei lager ; le v ignette lo
mostrano mentre, del tutto in-
capace di condividere il pro-
prio dolore con quello del padre, viene sopraffatto dai sensi
di colpa, che si materializzano in una vera e propria prigione.
Le immagini che rappresentano i suoi pensieri mostrano il
corpo senza vita della madre accanto a una montagna di ca-
daveri sovrastati da una svastica, mentre Art si chiede inces-
santemente di chi sia la colpa: della depressione, di Hitler, o
di un figlio incapace di amare sua madre?
A distanza di anni da quelle v ignette, Maus è il tentativo di
costruire un ponte tra le esperienze di due diverse generazioni
e di mettere in comunicazione i rispettivi traumi. Il libro è così,
al tempo stesso, il racconto di un sopravvissuto alla Shoah,
come recita il suo sottotitolo, ma anche un esempio di “post-
memoria” tra generazioni (Hirsch 2008), che permette di evi-
denziare agli studenti molte questioni: la trasmissione della
memoria, l’onerosità del ricordo, la pluralità delle memorie
relative a un qualsiasi evento traumatico, come dimostra il caso
emblematico della Shoah.
La narrazione di Maus intreccia dunque costantemente due
diversi piani temporali: da un lato il presente, in cui Art con-
versa con Vladek e lavora a quel fumetto che i lettori stanno
leggendo, dall’altro lato il passato che prende forma dal rac-
conto di suo padre, trasportandoci in un altro luogo e un altro
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 47
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX48
tempo. Sosnowiec, Polonia, metà degli anni Trenta: l’incontro
di Vladek e Anja Zylberberg, il matrimonio, la nascita di Ri-
chieu, una fiorente attività commerciale. Poi, nel settembre
1939, l’evento che cambia la vita degli Spiegelman e di tutti
gli ebrei d’Europa: l’invasione tedesca della Polonia e l’inizio
della Seconda guerra mondiale. Nel corso dei loro incontri,
Vladek racconta al fig lio l’esperienza della guer ra come
militare dell’esercito polacco, la prigionia, e poi l’orrore di fron-
te alla nuova condizione degli ebrei: la legislazione razziale,
la confisca delle aziende di famiglia, l’umiliazione del ghetto,
l’uccisione dei propri familiari e amici, e infine il disperato
tentativo di nascondersi insieme ad Anja fingendosi polacchi,
per evitare la deportazione nei lager.
Scoperti dalla Gestapo , i c oniugi
Spiegelman saranno deportati ad
Auschwitz nel marzo del 1944. En-
trambi si salveranno dal lager e dalle
“marce della mor te”, e nell’estat e
del 1945 riusciranno finalmente a ri-
congiungersi a Sosno wiec – una
città che non ha più nulla da offrire
agli ebrei, tanto da spingere gli Spie-
gelman a trasferirsi in Svezia e poi
negli Stati Uniti.
Oltre alle immagini, Spiegelman si
affida a una scelta semplice, tipica del
fumetto, per rappresentare la cesura
– irriducibile – t ra il pr ima e il
dopo nella vita di suo padre: la lin-
gua. Il Vladek del presente si esprime
in un ing lese elementare, spesso
sgrammaticato, che ricalca le strut-
ture sintattiche del polacco. Il lin-
guaggio dei ricordi di Vladek, invece,
è spigliato, scaltro, deciso: il Vladek
del passato è un ottimo or atore,
dotato di una grande prontezza lin-
guistica, e la sua buona conoscenza
del tedesco e dell’inglese gli salverà
la vita in molte occasioni.
Vignetta dopo vignetta, i lettori non
apprendono soltanto il racconto co-
rale che prende forma dai ricordi di
Vladek, ma anche i dilemmi – estetici
ed etici – che assillano Art nel corso
della creazione di Maus.
Il macro-problema è quello di tro-
vare un modo efficace per rappresen-
tare graficamente la “questione ebraica”. La soluzione indivi-
duata da Spiegelman è nota: disegnare i protagonisti umani
come figure antropomorfe dalle sembianze animali, scegliendo
uno specifico animale per ciascuna “nazionalità”. Una scelta
che è stata anche criticata, perché sembra paradossalmente
confermare l’ideologia razziale e razzista del nazionalsocia-
lismo. Tuttavia, la tipizzazione di Maus permette immedia-
tamente di spiegare agli studenti che, per capire come si sia
giunti ad Auschwitz, è necessario comprendere in primo luogo
l’immagine del mond o tipica del nazionalsocialismo , il
modo in cui la propaganda del Terzo Reich rappresentava gli
ebrei, e come questa immagine finì per essere considerata la
STUDI
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 48
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 49
STUDI
realtà sia dai non ebrei che dagli stessi ebrei, i quali, con l’acuir-
si della persecuzione, dovettero necessariamente accettare ciò
che il nazismo imponeva loro, e cioè che l’essere ebrei fosse
solo una questione di sangue. Necessariamente, allora, gli ebrei
dovranno essere raffigurati come dei topi, perché è così che
li rappresentava il regime: ratti, parassiti che attentano alla
salute razziale della Volksgemeinschaft tedesca e de vono
essere “liquidati” come la peggiore delle pestilenze.
Coerentemente, i tedeschi non potranno che essere rappre-
sentati come gatti, gli eterni nemici dei topi, instancabili nel
dar loro la caccia. Le altre “nazionalità” sono parimenti rap-
presentate da animali: i polacchi sono maiali (così li appel-
lavano i nazisti), gli americani cani, i francesi rane, i rom far-
falle. Le fattezze animali dei protagonisti di Maus permettono
di attutire la violenza o l’oscenità delle immagini che
raccontano i ricordi di Vladek. Ma soprattutto, questa tipiz-
zazione permette di discutere con gli studenti la seguente do-
manda: che cosa vuol dire, in realtà, “essere ebreo”? Anche ri-
fiutando la visione razziale imposta dal nazionalsocialismo, è
comunque possibile pensare l’ebraismo solo in termini di na-
zionalità o di etnia? E più in generale: possiamo davvero ridurre
l’identità di una qualsiasi persona ad una, e una sola, caratte-
ristica – qualunque essa sia?
Nel corso della narrazione, infatti, Spiegelman è il primo a
mostrare i limiti della sua tipizzaz ione, mandandola in
crisi. Ad esempio, alcune vignette visualizzano i dubbi di Art
rispetto a come rappresentare sua moglie, una donna di na-
zionalità francese convertitasi al giudaismo: dunque, Françoise
è una rana o un topo? In molte occasioni, i protagonisti ebrei
riescono a farsi passare per polacchi, indossando delle ma-
schere da maiali: ma cosa simboleggia esattamente quella ma-
schera? In un’altra pagina, Vladek ricorda il caso di un inter-
nato ad Auschwitz che supplicava continuamente le guardie
di liberarlo, affermando di essere un tedesco. Nella vignetta
successiva, Art chiede al padre se quell’uomo fosse “realmente”
tedesco, e alle spalle dei due topolini l’immagine del detenuto,
che nella vignetta precedente era ovviamente rappresentato
come un topo, si trasforma in quella di un gatto con indosso
l’uniforme a strisce: «Chi sa… », risponde Vladek, «Ma per
tedeschi quello era ebreo» (206). Con una semplice sequenza,
Spiegelman rivela la violenza e la paradossalità dei meccanismi
di identificazione tipici di qualsiasi razzismo (non soltanto
dell’antisemitismo nazifascista), mostrandoci che la comples-
sità di una v ita umana non può esser e ridotta ad una
“etichetta” – ebreo, tedesco, omosessuale, musulmano, clan-
destino...
L’altro problema che affiora dalle pagine di Maus riguarda il
crescente senso di inadeguatezza avvertito da Art rispetto al
suo progetto. Il racconto di suo padre «sanguina storia»: la
narrazione della vicenda personale di Vladek diviene lenta-
mente la narrazione dello sterminio degli ebrei d’Europa. Ma
è possibile – si chiede Art – rappresentare l’inferno senza averlo
vissuto? Chi è lui per parlare della Shoah? Come può «dare
un senso ad Auschwitz» se non riesce nemmeno a instaurare
un rapporto decente con suo padre (170-2)? La sensazione che
prova fin da bambino – sentirsi in colpa rispetto ai genitori
per non essere in grado di comprendere la loro esperienza e
per aver avuto una vita più facile – si trasformerà in
depressione dopo la morte di Vladek (1982) e l’inatteso suc-
cesso del primo volume di Maus, quando le lusinghe dello
“Shoah business” sono in agguato (197 ss.).
Nel 1991 Spiegelman ultimerà il suo fumetto: non perché sia
riuscito ad individuare una risposta al senso di inadeguatezza
suscitato dal tentativo di rappresentare la storia di Vladek e
di tutte le alt re vittime del nazifascismo , ma per ché la
volontà di conoscere e trasmettere la memoria di suo padre
si è comunque imposta, nonostante i tanti dilemmi. Nei tredici
anni occorsi per creare Maus, Art ha continuato a confidare
nella potenza della semplicità per parlare dell’orrore indicibile
di Auschwitz. E il racconto dei suoi topolini ci aiuta non sol-
tanto a comprendere quanto accaduto, ma anche a riflettere,
senza alcuna retorica, sul significato che lo studio della Shoah
e la t rasmissione delle memo rie delle v ittime dell’odio
razziale possono rappresentare oggi per noi.
Renata Badii
Gonzaga University in Florence
BIBLIOGRAFIA
M. Hirsh, The Generation of Postmemory, «Poetics Today», 29, 1 (2008), pp. 103-28.H.S. Park, Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale. A Bibliographic Essay, «Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies», 29,2 (2011), pp. 146-64.A. Spiegelman, (2000) Maus. Racconto di un sopravvissuto, Einaudi, Torino 2000 (tr. it. di Maus I, Maus II, Pantheon Books, New York, 1986,1991). - Id., MetaMaus. A Look Inside a Modern Classic, Maus, edited by Hillary Chute, Viking Press, New York 2011.
NS5 33-49 studi:Layout 1 15-11-2012 15:21 Pagina 49
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX50
PERCORSI DIDATTICI
Per i cento anni di Elsa MoranteGiuseppe Leonelli
L’ARTICOLO INTRODUCE ALL’OPERA DI ELSA MORANTE SEGUENDONE
LE INTERNE RELAZIONI TEMATICHE E STILISTICHE. NE DELINEA I TRATTI SALIENTI DELLA SCRITTURA TRA «ROMANZO,MEMORIALE, BALLETTO, TRAGEDIA, COMMEDIA».
Elsa Morante nacque a Roma, il 18
agosto 1912, da madre ebrea, mo-
denese d’origine e padre siciliano.
Sono passati, da allora, cento anni e per
quella che fu definita da György Lukács
uno dei massimi scrittori a sua conoscen-
za, l'anno appena terminato avrebbe do-
vuto essere occasione di celebrazioni e
convegni, per la verità, meno fervide le
une e meno numerosi gli altri di quanto
ci si sarebbe aspettato.
Menzogna e sortilegioIl romanzo che la rivelò, Menzogna e sor-
tilegio, fu pubblicat o nel 1948, dopo
quattro anni di gestazione e un numero
cospicuo di racconti pubblicati fin da
giovanissima, parte dei quali confluiti nel
1941 nella raccolta Il gioco segreto. Men-
zogna e sortilegio uscì in anni in cui si po-
nevano i termini di quella che sarebbe
stata definita in seguito da Salinari1 «la
questione del realismo» e si combatteva,
con Muscetta2, il «controrealismo». Il ro-
manzo, a parte qualche lettura d’eccezio-
ne, suscitò più perplessità che interesse.
Non assomigliava a nessun altro del se-
colo in corso e meno che mai a quelli che
maturavano nella stagione immediata-
mente post-bellica, afflitti da problemi
di temi, di struttura e di linguaggio.
In questo contesto, Menzogna e sortilegio
si presentava in splendida, ancorché
contrastata, solitudine. Le vicende rac-
contate costituiscono un grosso romanzo
familiare, in buona parte d’ispirazione
autobiografica, che si svolge attraverso
tre generazioni. Al momento in cui en-
triamo nella narrazione, tutto è compiu-
to ed Elisa, la voce narrante, si presenta.
È l’unica superstite della sua famiglia, ora
che anche la madre adottiva, un’antica
fidanzata di suo padre, dalla «vita sver-
gognata», ma generosa nel prendersi cura
di lei, è morta e lei è rimasta completa-
mente sola in una casa da cui non esce
mai e in cui non riceve nessuno. Da al-
lora, il suo rapporto con la realtà si è pro-
gressivamente allentato, fino a trasfor-
marsi in una perenne coabitazione con
quella che definisce la menzogna, ovvero
un surplus d’immaginario che invade la
sua mente e dissolve la realtà in fantasmi,
ectoplasmi che attraversano ogni ora del-
la sua vita quotidiana, mentre le favole
si trasformano in una sorta di Rivela-
zione.
Dal momento della morte della sua be-
nefattrice, però, le favole e i sogni hanno
subito un’ulteriore metamorfosi, trasfor-
mandosi in memoria, la nuova compagna
che ha assorbito e strutturato l’antica
menzogna. La menz ogna-memoria si
tramuta, senza cessare di essere tale, in
sortilegio, un atto di magia: risorgono le
persone, che, evocate, si radunano intor-
no ad Elisa e pretendono di rivivere, di
rimpastarsi dalle loro ceneri e assumere
una nuova forma; chiedono, ormai dis-
solte le loro vite, di diventare personaggi,
ectoplasmi di parole, parvenze ubique in
cui ognuno potrà incarnare se stesso, ri-
confermare la propria dolorosa identità
terrena, ma aprirsi anche alla nuova vita
che i lett ori insuffleranno in lor o. In
mezzo a quei morti, quattro, soprattutto,
«giganteggiano fra gli altri, come statue
fra minuscoli passeggeri»3. La prima è
Anna, la madre vera; la seconda è Rosa-
ria, la madre adottiva; il terzo è il padre,
Francesco, detto Il butterato. Il quarto è
Edoardo, ovvero Il Cugino, vero colpe-
vole, inventore «di tutta la nostra vicen-
da, e subdolo tessitore d’ogni nostro in-
trigo»4.
1. C. Salinari, La questione del realismo, in Id., Preludio efine del realismo in Italia, Morano, Napoli 1967.2. C. Muscetta, Realismo, neorealismo, controrealismo,Garzanti, Milano 1976. 3. E. Morante, Menzogna e sortilegio, in Id., Opere, I, Mon-dadori, Milano 1988, p. 32.4. Ibi, p.33.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 50
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 51
PERCORSI DIDATTICI
Elisa è colei che racconta la storia e ne
costituisce il punto di vista, prima di es-
servi assorbita anche come personaggio
ed entrarvi, infine, a circa due terzi dello
sviluppo dell’opera, in for ma di se
stessa bambina. Uno dei problemi che
i critici si sono posti è quale sia il rap-
porto fra Elisa ed Elsa, fra la narratrice
e l’autrice. La Morante sceglie un per-
sonaggio-narratore, che entra nel ro-
manzo in una prima persona che in re-
altà corrisponde a una terza. Ne risulta
un’onniscienza dissimulata e resa critica
dal fatto che si fa portatrice del punto
di vista dei morti, se è vero che sono essi
stessi a dettare le vicende che vengono
raccontate. Ma essere una narratrice me-
dium non vuol dir e scomparire in
quanto individualità. Non è un caso che
il nome della ragazza, Elisa, riproduca
quasi letteralmente quello di Elsa. Se il
linguaggio di Elisa non fosse quello di
Elsa, anche il rapporto di Elsa con la nar-
razione sarebbe profondamente diverso.
La sovrapposizione, in realtà, è quasi to-
tale, ma se non ci fosse Elisa, Elsa sareb-
be un deus ex machina invisibile. Pro-
iettando un’immagine di sé in forma di
personaggio, Elsa attiva una funzione
che le consente di vedersi al centro del
racconto.
Ne risulta che tutto il multiforme, va-
stissimo mondo poetico morantiano
prende senso e unità in una sorta di io
narrante, che soprassiede all’articolazio-
ne e alla caratterizzazione della materia
narrata, ma costituisce anche uno spec-
chio, un punto di fuga c he riconduce
l’autrice a se stessa. Attraverso Elisa, la
Morante partecipa alla narrazione e ne
garantisce direttamente il senso, os-
servando da una posizione lievemente
arretrata. Entrare nel personaggio di Eli-
sa e attraverso di lei in tutti gli altri si-
gnifica donare se stessa all’altro, come
fanno gli attori sul palc oscenico. In
questo senso Menzogna e sortilegio è ro-
manzo supremamente teatrale, come è
stato più volte rilevato, per lo più senza
spiegarne se non genericamente il senso,
che è assai più specifico di quanto non
si possa pensare.
Questo modo narrativo in cui dominano
i giochi di specchio di una continua mise
en abîme dell’autrice, sorta di fantasma
tra i fantasmi che s’aggira per un vissuto
sigillato dalla morte e ora riproposto a
un altro tipo di vita, si esprime soprat-
tutto nell’uso intenso e rigoglioso del-
l’aggettivazione, gli «splendidi aggettivi»,
per dirla con Mengaldo, «che spesso si
ammassano sulla pagina… molto meno
per horror vacui decorativo che per ric-
chezza, tensione di pathos»5. L’aggettivo
è, in Menzogna e sortilegio, assai più che
un’espansione linguistica funzionale
per la descrizione della realtà. È cuore e
anima della realtà, un punto di vista sul
mondo che continuamente lo nutre e
rinnova a se stesso: in questo senso, come
in Manzoni, l’aggettivo è una cosa seris-
sima, che va soppesata e calibrata; ma,
mentre in Manzoni la conseguenza è un
uso moderato, nella Morante l’aggettivo
è profuso con abbondanza, anche se mai
sperperato. Esso si presenta come uno
strumento attraverso cui prendere co-
scienza delle infinite articolazioni della
realtà, ha una valenza caleidoscopica il
cui effetto si trasmette al lettore, susci-
tando in lui la percezione che chi raccon-
ta esprime prima di tutto il senso di una
felicità narrativa che ha pochi eguali (la
Recherche di Proust, Cent’anni di solitu-
dine di Garcia Marquez?) nel romanzo
contemporaneo. È qui, forse, una delle
accezioni principali, se non la principale,
del secondo membro del dittico che dà
titolo al romanzo, la parola, e conseguen-
temente la nozione, di sortilegio. Il mon-
do esiste allorché viene nominato e
certo questo procedimento interessa e
implica in tutta l’opera della Morante,
e soprattutto nel primo dei suoi romanzi,
una facoltà creativa magica, la capacità
di vedere con occhi incontaminati tutto
quello che gli altri non vedono. Elisa-Elsa
guarda con occhi di bambina, appartiene
già agli F.P., i Felici Pochi che incontria-
mo vent’anni dopo nel Mondo salvato
dai ragazzini: quelli che sono pochi, ma
si possono inc ontrare dappertutto, e
sono sempre poveri, anche se nascono
ricchi, e «pure quando siano volgarmen-
te intesi brutti/in REALTÀ sono belli»,
perché «la REALTÀ /è di rado visibile
alla gente»6. A tal punto poco visibile, che
per vederla ci vuole un sortilegio. Ecco
cos’è, dunque, la realtà: Menzogna e sor-
tilegio, menzogna per molti, sortilegio
per pochi. Menzogna è l’irreale che la
maggior parte degli uomini crede essere
il reale, sortilegio l’irrealtà che solo
pochi riconoscono come realtà. Ma c’è
forse un livello, che riguarda strettamen-
te l’arte, in cui la menzogna, lungi dal-
l’essere «incanto e vizio, follia e illusio-
ne… mezzo per raggiungere un falso pa-
radiso, droga che proietta l’anima in una
stupefazione fantastica»7, come i più in-
terpretano, è una condizione del sorti-
legio.
L’isola di ArturoPassano gli anni, la Morante pubblica nel
1957 L’isola di Arturo, cominciato nel
1952. A differenza del primo, il secondo
romanzo, cui viene conferito il premio
Strega, riscuote grande successo presso
i lettori. Protagonista è Arturo, un ragaz-
zo di quattordici anni, che vive dalla na-
scita nell’isola di Procida. Il suo nome
è esemplato su quello della stella più lu-
minosa della costellazione di Boote,
ma rinvia segretamente almeno a due al-
tri referenti. Uno, lo ha fatto notare il De-
5. P.V. Mengaldo, Spunti per un’analisi linguistica dei ro-manzi di Elsa Morante, in Id., La tradizione del novecento.Quarta serie, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 151-152.6. E. Morante, La canzone degli F.P. e degli I.M., parte I, In-troduzione esplicativa, vv. 15-17, in Ead. , Il mondo sal-vato dai ragazzini, Einaudi, Torino 2012, p. 131.7. Cfr., fra gli altri, C. Sgorlon, Invito alla lettura di Elsa Mo-rante, Mursia, Milano 2005, pp. 46-47.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 51
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX52
PERCORSI DIDATTICI
benedetti in un suo g rande saggio8, è
Artù, il r e del ciclo br etone; l’altro,
Arthur Rimbaud, il ragazzo «dalle suole
di vento», come lo definì Verlaine, per la
Morante «ragazzetto…senza corte né fa-
miglia»9, il più caro, il più amato degli
F. P., i Felici Pochi, nella Canzone a loro
dedicata. Ed effettivamente troviamo Ar-
turo, all’inizio del romanzo, vivere nella
sua isola praticamente solo dalla nascita,
che ha provocato la morte della madre,
da lui sempre rimpianta e di cui gli resta
solo una sbiadita fot ografia. Unico
affetto è un padr e mezzo tedesco e
mezzo italiano, di nome Wilhelm, per lo
più assente, sempre impegnato in miste-
riosi viaggi, assurto, nella fantasia del fi-
glio, quasi a figura divina. Arturo narra
anch’egli, come Elisa, in prima persona:
il primo capitolo del romanzo, Re e
stella del cielo, è una veloce ricapitolazio-
ne degli anni trascorsi sull’isola. Arturo
si presenta al lettore come un piccolo Ro-
binson, immerso in un’esistenza in cui
non sembra scorrere il tempo e «un idil-
lio solitario e supremo lo affratella alle
meraviglie del mondo»10. Tutto questo
dura fino a che non arriva, all’inizio del
secondo capitolo, un pomeriggio d’in-
verno, annebbiato, contro le consuetu-
dini climatiche dell’isola, da un piovasco
freddo, immagine simbolica d’un turbi-
ne esistenziale incipiente. Vediamo il ra-
gazzo nel porto di Procida, «combattuto
fra l’impazienza e la ripugnanza»11: sta
aspettando l’arrivo del piroscafo delle tre,
che gli porterà una nuova madre, la don-
na con la quale suo padre si è appena ri-
sposato.
Si può dir e che, con questa pr ecisa
scansione del giorno e dell’ora dell’arrivo,
il tempo entri per la prima volta nella vita
d’Arturo: è come se il ragazzo uscisse im-
provvisamente dalla dimensione solitaria
e immobile del mito; la sua vita, fra poco,
diventerà simile a quella di tutti. Il fan-
ciullo divino sta per affac ciarsi alla
realtà, al funebre apparir del vero della
Silvia leopardiana, cui la maggior parte
dei personaggi di Menzogna e sortilegio,
a partire da Elisa, la narratrice, si sottrag-
gono, prima o poi, chi con la morte, chi
con la pazzia, chi con la menzogna o con
sogni e favole. Il primo scrollo tellurico
che la realtà arreca al reame immaginario
del piccolo re è la scoperta dell’amore,
che pian piano s’insinua nella sua vita,
prima insospettato, poi esorcizzato con
una sorta di sc ontrosa alterigia, per
colei che dovrebbe essere solo sua madre.
Quasi contemporaneamente, la figura
paterna si sgretola, da idolo si trasforma
in parodia del se stesso di prima: Arturo
scopre che i suoi viaggi epici in realtà non
superano il territorio della circumvesu-
viana e sono motivati da sordidi, mise-
rabili affari. Il r agazzo conosce anche
l’umiliazione di vedersi preferito, negli
affetti paterni, dall’amore per un piccolo
malvivente detenuto nel penitenziario di
Procida. La situazione si fa insostenibile:
Arturo decide di partire per sempre, pro-
prio nel momento in cui sc oppia una
guerra che si rivelerà terribile e in cui an-
che lui, con tutta probabilità, sarà invi-
schiato. Nel momento in cui la nave si
stacca dal molo, è come se un cordone
ombelicale psichico venisse definitiva-
mente lacerato.
Ma è una nascita o è una morte? A mano
a mano che la nave si allontana da Pro-
cida, l’isola si trasforma in un paradiso
«altissimo e confuso», per dirla con i ver-
si di Penna in epigrafe, che, possiamo
completare con quel che segue e risulta
omesso nella citazione, «ci porta a bere
la cicuta», ossia a morire.
Il viaggio dell’eroe verso il vasto mondo
non porterà a nessuna iniziazione e
non prelude, come accade nei miti, al ri-
torno, ormai completato il ciclo della
crescita che trasforma il ragazzo in
uomo.
L’abbandono dell’isola, l’immagine ar-
chetipica dell’utero, è un esilio definitivo
da se stesso. Appaiono, a chiusura di li-
bro, nella pienezza del loro significato,
i versi della bellissima poesia Dedica pre-
messa al romanzo, soprattutto i primi
due e l’ultimo: «Quello, che tu credevi
un piccolo punto sulla terra/, fu tutto»
e «fuori del limbo non c’è eliso». Una
volta entrato in mezzo agli altri uomini
il ragazzo scomparirà, non sapr emo
più niente di lui. Lo ritroveremo, in li-
mine ad un altro libro, reincarnato nel
ragazzo morto protagonista di Addio, la
stupenda poesia che apre Il Mondo sal-
vato dai ragazzini, uscito in prima edi-
zione nel 1968. Ecco le sue par ole,
rivolte alla donna che lo cerca dapper-
tutto, proprio come Nunziatina cercava
Arturo, senza trovarlo, nell’ultimo capi-
tolo, intitolato Addio, del romanzo: «Tu
lo sapevi che le fanciullezz e sulla
terra/sono un passaggio di barbari divi-
ni/col marchio carcerario della fine già
segnata./Lo sapevi. Eppure volevi farmi
vivere/quando io non volevo più vivere».
8. G. Debenedetti, L’Isola della Morante, in Id., Intermezzo,Mondadori, Milano 1962, p. 107: «Il suo è un nome dibattesimo come quello di tutti i cristiani, ma contienedue allusioni: una mitico astrologica, in quanto è il nomedi una stella; e una epic o-leggendaria, in quanto è ilnome del re del ciclo bretone».9. E. Morante, La canzone, cit., vv. 37-38, p. 124. 10. C. Garboli, L’isola di Arturo, in Id., Il gioco segreto. Noveimmagini di Elsa Morante, Adelphi, Milano 1995, p. 71.11. Cfr. Opere, I, cit, p. 1026.
Carlo Levi, ritratto diElsa Morante.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 52
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 53
Il «marchio carcerario della fine già se-
gnata»: lo t roviamo dunque, questo
marchio, che prima di Arturo affligge
Elisa e si stampa sul tessuto di Menzogna
e sortilegio, anche nel Mondo salvato dai
ragazzini, che in questo senso ha ben
poco a che fare con la festa del puer del
Sessantotto, cui il libro, che non si sa pre-
cisamente che cosa sia, stando alla sua
autrice12, è stato incautamente connesso.
Nella sua natura composita, e affastellata
di temi che attraversano e n utrono
tutta l’opera della Morante, Il Mondo sal-
vato dai ragazzini partecipa di quello che
è il vero, grande tema della scrittrice: la
sacralità della v ita che persiste anche
quando sembrerebbe rifiutare se stessa,
raccontata con una meravigliosa capa-
cità di rappresentazione.
Chi ha parlato, e non sono pochi, per la
sua opera narrativa, di romanzo-saggio
è completamente fuori strada. Nessuno
come lei sa vedere e quindi raccontare13,
tradotti in eventi e personaggi, il bene,
il male, il dolore, la felicità, il loro incro-
ciarsi, impastarsi, respingersi, ma anche
darsi la mano e addir ittura inseguirsi,
raggiungersi e scambiarsi di posto.
La sua lingua magica stimola e rigenera
continuamente la realtà da se st essa,
confinando in una zona oscura, impro-
nunciabile, solo una cosa: il potere. Lo
sentiamo, ma non lo v ediamo mai: il
potere, nella sua pura essenza, è irrap-
presentabile, perché, per la M orante,
esso in sé non esiste, sta sempre al posto
di qualcos’altro, sicché noi possiamo
solo vedere i suoi effetti sul mondo.
La StoriaNel 1974 esce il terzo grande romanzo,
La Storia: accolto, cosa che oggi pare in-
credibile, da una vera e propria levata di
scudi da gran parte della cultura lette-
raria italiana. Non piace quasi a nessuno,
neppure al più caro degli amici della
Morante, Pier Paolo Pasolini, quasi ca-
tafratto nell’incomprensione. Moravia,
l’ex marito del-
la scrittrice,
tace, non si sa
se perplesso o
indispettito o
semplicemente
se ritenga op-
portuno aste-
nersi dal giudi-
zio. Calvino,
chissà perché,
a m m o n i s c e
sentenziosa-
mente che è le-
cito, in un’ope-
ra d’arte, far ri-
dere, non far
piangere.
Un’intellettuale
del «Manife-
sto», Rossana
Rossanda, so-
spetta la scr it-
trice di v oler
vendere disperazione, obbiettando che,
in questo caso, sarebbe meglio vendere
patate. In realtà la Storia non ha nulla a
che fare con la disperazione e neppure
Aracoeli, l’ultimo, dolentissimo, ma non
disperato romanzo, con il quale si con-
clude l’opera e quasi la vita della Moran-
te.
Quel che si esprime nella Morante non
è la disperazione, ma il dolore (sono le
lacrimae rerum virgiliane, ma anche il
dolore «eterno», che «ha una voce e non
varia» di Saba). Esso assume, come in
tutti i grandi scrittori, un’aura di cosmi-
cità che lo trasforma in un complesso ac-
cordo musicale, le cui componenti ar-
moniche possono suscitare vibrazioni di
fortissima, vitale intensità.
Nella Storia, per fare un unico esempio,
proprio ad apertura di romanzo, ci tro-
viamo di fronte a una violenza sessuale
che assurge in seguito al senso di una mi-
steriosa incarnazione, perché il frutto del
ventre di Ida, profanato dal soldato te-
desco dagli occhi azzurro-cupo, sarà
Useppe, che erediterà quegli occhi ed
esprimerà attraverso di essi la sua natura
inerme, e a suo modo salvifica, di agnus
dei nel cuore stesso del macello che af-
fligge il mondo.
Giuseppe Leonelli
Università Roma Tre
12. Si legge nella quarta di copertina del volume, ano-nima ma composta, come di consueto, dall’autrice: «Unromanzo. Un memoriale. Un balletto, Una tragedia. Unacommedia. Un madrigale. Un documentario a colori. Unfumetto. Una chiave magica». Potrebbe stare benissimoper una definizione della vita.13. Garboli accenna, a proposito della Storia, al «suonoromanzesco della Morante… prodotto da un passo si-curo, spedito, potente, indaffarato, senza nervosismo,senza fretta, il passo di chi è occupato a narrare» e nonha testa per pensare ad altro» (C. Garboli, La storia, in Id.,Il gioco segreto, cit., p. 155).
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 53
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX54
PERCORSI DIDATTICI
Il carattere spirituale dellavoro e la dialetticadell’autocoscienzaHegel ha saputo indagare, con indubbia
perspicacia critica, i differ enti aspetti
qualificanti del lavoro umano. Per com-
prendere la sua disamina, che ci consente
di enucleare il sottile gioco dei molteplici
riflessi che si pongono in essere entro la
prassi sociale del lavoro, sarà opportuno
tener presente anche la profonda analisi
del lavoro che si può evincere dal primo
capolavoro hegeliano, la Fenomenologia
dello spirito (1807). Se si tengono presenti
le complesse pagine hegeliane consacrate
ad una analisi dell’autocoscienza si può
meglio penetrare, fenomenologicamente
e concettualmente, la pr ecisa natura
della prassi sociale del lavoro.
Per Hegel della Fenomenologia l’autoco-
scienza costituisce un momento dialet-
tico assai complesso, quello mediante il
quale si può comprendere il preciso pas-
saggio dalla Begierde (dall’appetire, de-
siderare sensibilmente) allo scontro tra
le differenti autocoscienze. Configu-
randosi come autocoscienza la coscienza
si volge, da un lato, proprio attraverso il
suo appetire, ad un determinato oggetto
che, tuttavia, risulta essere un mero fe-
nomeno, giacché la sua essenza coincide
col suo stesso dileguare; dall’altro lato,
si volge verso se stessa perché il proprio
oggetto è appunto se stessa che, inizial-
mente, si configura solo in antagonismo
con l’oggetto appetito. In tal mod o
l’autocoscienza costituisce un appetito
che cerca se stesso senza saperlo, è il pro-
prio appetire stesso che si rende conto
di questa sua asc esa all’autocoscienza
solo nella misura in cui individuerà altre
autocoscienze. Ma occorre anche avver-
tire come per H egel l’autocoscienza
esista sempre come potenza eminente-
mente negativa: accanto alla realtà po-
sitiva dell’autocoscienza, che si c on-
trappone a quanto la oltrepassa, esiste
anche ciò che si nega e vuole pr oprio
mantenersi in tale negazione. Il c he
coincide con la concretezza della v ita
umana entro la quale il singolo uomo
«non è mai ciò che egli è», proprio per-
ché oltrepassa sempre se stesso, è sempre
al di là di sé, si proietta costantemente
nel futuro e si sottrae quindi ad un per-
manere che non sia un per manere del
suo stesso appetito cosciente di essere un
appetito. Per questa ragione, come ha ri-
levato Jean Hyppolite, «la Begierde uma-
na si trova solo quando ne vede un’altra,
o meglio quando si dirige su un’altra e
diviene appetito di essere riconosciuta
e dunque di riconoscere se stessa»1. La
vocazione umana si attua proprio in
questa socialità instaurantesi tra le dif-
ferenti autocoscienze, dove l’essere cui
aspira ogni autocoscienza non è mai l’es-
sere della natura, bensì quello della Be-
gierde, dell’appetito, l’inquietudine del
Sé che non può mai configurarsi come
una cosa, un essere o un esserci, proprio
perché l’autocoscienza si qualifica, sem-
mai, come negazione del suo stesso es-
serci, come una realtà sempre diveniente
che, proprio per questo, si sottrae, peren-
nemente, all’essere, anche se poi questo
suo continuo sottrarsi all’essere deve poi
manifestarsi proprio nell’essere. Il che
rinvia precisamente alla dialettica dell’Al-
tro e del Sé. Di fronte alla positività della
vita il Sé costituisce, pertanto, l’unità ri-
flessa trasformatasi in mera negatività:
il Sé emerge solo nel c ontrasto con
l’Altro. Per Hegel il concetto dello spirito
si costruisce attraverso questa duplica-
zione dell’autocoscienza, proprio perché
la duplicità e l’alterità, la lotta del Sé con
l’Altro, rappresentano l’esserci della
vita stessa. Anzi, nel rapporto conflittuale
tra il Sé e l’Altro ci si trova di fronte a un
susseguirsi continuo e mobile di doppi
sensi: l’Altro appare come il Sé, mentre
il Sé, a sua v olta, appare come l’Altro.
Il lavoro come realizzazione sociale:HegelFabio Minazzi
HEGEL È IL PENSATORE CHE È RIUSCITO AD ANALIZZARE, IN PROFONDITÀ, GLI ASPETTI QUALIFICANTI DEL LAVORO UMANO. L’INTERVENTO ESAMINA LE COMPLESSE PAGINE DELLA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO
PER METTERE IN EVIDENZA GLI ASPETTI SOCIALI E RELAZIONALI INTERNI ALLA PRASSI LAVORATIVA
1. Jean Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenolo-gia dello spirito» di Hegel, Presentazione di Mario Dal Pra,trad. it. di Gian Antonio De Toni, La Nuova Italia Editrice,Firenze 1972, p. 203.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 54
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 55
PERCORSI DIDATTICI
Di fronte all’Altro il Sé perde se stesso,
per poi perdere anche l’Altro perché in
lui sorge il Sé. In altre parole la negazione
dell’Altro, connessa con la Begierde, con
l’appetito, costituisce anche un’auto-
negazione, proprio perché sono in gioco,
in lotta, due autocoscienze con un terzo
elemento: quello dell’alt erità, poiché
l’essere per l’altro non è ancora l’essere
per sé. L’essere della vita quale alterità co-
stituisce un terzo elemento che spiega al-
lora la dialettica specifica che si instaura
tra il Sé e l’Altro, il che consente anche,
infine, di meg lio intendere proprio la
precisa natura del lavoro. Se infatti si so-
stiene che nella lotta dialettica tra le au-
tocoscienze l’Altro si manifesta come il
Sé e il Sé, a sua volta, si manifesta come
l’Altro, allora, proprio per il porsi dell’Io
della Fenomenologia hegeliana, la media-
zione tra questi due momenti risulta es-
sere sempre essenziale e c ostitutiva.
Scrive infatti Hegel: «nell’autocoscienza
immediata l’Io semplice è l’oggetto as-
soluto, che peraltro per noi o in sé è l’as-
soluta mediazione, e ha per momento es-
senziale l’indipendenza sussistente»2.
Nella positività concreta e mobile dell’es-
sere vitale l’autocoscienza si innalza
così al di sopra della vita stessa: se la vita
rappresenta una schiavitù, l’uomo si li-
bera proprio da questa dimensione che,
tuttavia, costituisce sempre la condizione
positiva del suo stesso emergere.
Esattamente entro questa singolare ten-
sione dialettica si delinea il rapporto tra
signoria e servitù nel quale Hegel richia-
ma proprio, in mod o eminentemente
strategico, il ruolo specifico del lavoro
quale anima più vera e profonda di tale
reciproca tensione, eminentemente dia-
lettica. Se di primo acchito il signore si
configura immediatamente, agli occhi
del servo, come quella liberazione e si-
gnoria che egli non ha saputo attuare,
quindi come umiliazione e r iconosci-
mento della propria dipendenza dal si-
gnore, tuttavia nella sua v ita servile
sono comunque presenti anche due
altri momenti che lo aiutano a prendere
progressivamente coscienza di sé quale
autocoscienza. In primo luogo, il mo-
mento della paura, dell’angoscia totaliz-
zante di fronte alla morte, esperienza me-
diante la quale il servo è per la prima vol-
ta fuoriuscito dalla sua vita, priva di spi-
ritualità, sperimentando l’assoluta nega-
tività dell’autocoscienza. Avendo avuto
paura della morte il servo ha provato
l’esperienza spirituale dell’autocoscienza
che è in grado di fluidificare ogni ele-
mento della vita, facendo percepire l’as-
soluta negatività, il che gli ha consentito
di percepire una totalità che nella vita or-
ganica ordinaria è al di là di ogni espe-
rienza possibile. In secondo luogo, me-
diante il servire il servo vive e fa sua una
disciplina lavorativa che progressiva-
mente lo distacca dall’esserci naturale.
Proprio su questo terreno interviene poi
il lavoro a trasformare la servitù del servo
in autentica padronanza. Il servo infatti,
nella sua stessa continua dipendenza la-
vorativa ha costante esperienza dell’in-
dipendenza dell’essere che deve trasfor-
mare onde poterlo rendere adeguato al-
l’appetito del signore. Il signore, grazie
al lavoro del servo, riesce infatti a godere
del mondo, soddisfacendo i propri ap-
petiti attraverso la negazione completa
delle cose predisposte dal la voro del
servo. Ma proprio lavorando il servo for-
ma e c oltiva se st esso nel moment o
stesso in cui dà for ma alle c ose del
mondo attraverso la pr opria autoco-
scienza e per questa ragione può poi ri-
trovare se stesso nelle sue stesse opere.
Lavorando, in mod o apparentemente
inessenziale, il servo attribuisce la carat-
teristica del permanere e sussistere del-
l’essere-in-sé al suo stesso essere-per-sé.
Proprio attraverso il proprio lavoro ser-
vile il servo giunge così a comprendere
e contemplare la propria indipendenza
dal padrone. Proprio grazie al lavoro l’au-
tocoscienza del servo si innalza alla per-
cezione di se stessa come presente nel-
l’essere: quella cosalità che inizialmente
si contrapponeva negativamente al ser-
vo, proprio attraverso la mediazione del
lavoro si configura ora come il puro es-
sere-per-sé della coscienza del servo. In
tal modo l’essere-per-sé della coscienza
e l’essere-in-sé della vita non sono più
separati, proprio perché il lavoro ha at-
tuato una mediazione critica fondamen-
tale mediante la quale l’autocoscienza si
innalza alla propria percezione nell’es-
sere. Questo risultato costituisce, dun-
que, il frutto specifico del lavoro. Occor-
re quindi ripercorrere analiticamente la
disamina hegeliana del pr ocesso del
lavoro. Come si è visto l’appetito del si-
gnore si riserva un rapporto di pura ne-
gazione dell’oggetto in grado di soddi-
sfarlo. Tuttavia, rileva Hegel, tale appa-
gamento del sig nore costituisce, in
realtà, un «dileguare, perché gli manca
il lato oggettivo o il sussistere» dell’oggetto
stesso quale fr utto della mediazione
innescata dal lavoro servile.
Hegel: il lavoro qualedileguare trattenutoBen diverso è invece il rapporto del servo
con l’oggetto in grado di soddisfare l’ap-
petito del sig nore, proprio perché in
questo caso il rapporto con la cosa è me-
diato dal lavoro servile:
il lavoro, invece, è appetito tenuto a freno,è un dileguare trattenuto; ovvero: il lavoroforma. Il rapporto negativo verso l’oggettodiventa forma dell’oggetto stesso, diventaqualcosa che permane; e ciò perché proprioa chi lavora l’oggetto ha indipendenza. Talemedio negativo o l’operare formativo co-stituiscono in pari tempo la singolarità oil puro essere-per-sé della coscienza che ora,nel lavoro, esce fuori di sé nell’elemento delpermanere; così, quindi, la coscienza che
2. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. di En-rico De Negri, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1963, 2voll., vol. I, p. 158, mentre le citazioni che seguono neltesto sono tratte da pp. 162-3 e p. 163.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 55
lavora giunge all’intuizione dell’essere in-dipendente come di se stessa.
Attraverso il lavoro l’oggetto del mondo
assume una propria forma particolare,
diventa in grado di soddisfare un deter-
minato appetito. Mentre per il signore
l’appetito è un puro dileguare negativo,
il lavoro del servo costituisce un «dile-
guare trattenuto», ed è trattenuto proprio
perché attraverso il suo lavoro il servo
forma l’oggetto, trasformandolo in qual-
cosa che permane. Ma tale «operare for-
mativo» costituisce «il puro essere-per-
sé della coscienza» che proprio grazie al
lavoro fuoriesce da sé installandosi nel
mondo sotto la forma del permanere. Ri-
sultato: solo attraverso il lavoro la co-
scienza giunge infine «all’intuizione
dell’essere indipendente come di se stes-
sa». In tal modo il servo si emancipa dalla
dipendenza dal signore e lo stesso rap-
porto servo/padrone giunge al suo ribal-
tamento dialettico, perché non è certa-
mente più il servo a dipendere dal padro-
ne, bensì il padrone a dipendere dal la-
voro del servo. Il servo, proprio lavoran-
do, mantiene il padrone, mentre il pa-
drone, costringendo il servo al lavoro ser-
vile, ne dipende totalmente.
D’altra parte per Hegel il lavoro servile
non ha comunque solo questo significato
positivo, ponendo «la coscienza servile
come puro essere-per-sé» che diventa «a
sé l’essente», ma possiede anche, al con-
tempo, un suo altrettanto preciso signi-
ficato negativo nei confronti dell’assoluta
negatività dell’autocoscienza, ovvero
quel sentimento dell’«assoluto fluidifi-
carsi» delle cose percepito dal servo at-
traverso la paura, angosciosa, che ha pro-
vata di fronte alla morte.
Infatti, nel formare la cosa, la negativitàpropria di quella coscienza, il suo essere-per-sé, le diventa un oggetto, sol perché essa to-glie l’essente forma opposta. Ma tale nega-tivo oggettivo è appunto l’essenza estranea,dinanzi alla quale la cos cienza servile ha
tremato. Ora peraltro essa distrugge questonegativo, che le è est raneo; pone sé, comeun tale negativo, nell’elemento del perma-nere e diviene così per se stessa un qualcosache è per sé. Alla coscienza servile l’esser-per-sé che sta nel signore è un esser-per-sédiverso, ossia è solo per lei; nella paura l’es-ser-per-sé è in lei stessa; nel formare l’es-ser-per-sé diviene il suo proprio per lei, edessa giunge alla consapevolezza di essere essastessa in sé e per sé.
In altri termini potremmo allora dire che
proprio attraverso il lavoro emerge
infine il pensier o. Se infatti si sca va
proprio in questo significato negativo del
lavoro servile si evince che il servo riesce
a trasformare la cosa naturale in un de-
terminato oggetto adatto all’appetito
del signore, proprio perché rimuove
dalla cosa quella «forma opposta», il «ne-
gativo oggettivo», «l’essenza estranea» di-
nanzi alla quale aveva precedentemente
tremato per la paura della morte. Ma po-
nendo sé come tale negativo nell’ambito
del permanere oggettivo, la coscienza
«diviene così per se stessa un qualcosa che
è per sé». In tal modo formando, attra-
verso il lavoro, l’oggetto dell’appetito, la
coscienza servile giunge infine «alla
consapevolezza di essere essa stessa in sé
e per sé», giunge cioè alle soglie del pen-
siero. Infatti l’essere-per-sé presente nel
signore costituisce un essere-per-sé di-
verso, che risulta essere tale solo per lei
che rappresenta il servo di quel padrone;
di contro nell’esperienza della paur a
angosciosa la coscienza percepisce un es-
sere-per-sé che è presente unicamente,
per quanto radicalmente, in lei stessa. In-
vece solo lavorando «l’essere-per-sé di-
viene il suo proprio per lei». Esterioriz-
zandosi la coscienza servile non si costi-
tuisce come un «Altro da lei», proprio
perché in questo caso la «forma» costi-
tuisce «il suo puro esser-per-sé che quivi
alla coscienza servile si fa verità». Proprio
nel lavoro, che sembrava impoverirla ed
estraniarla da sé, la coscienza servile ri-
trova infine se stessa. E ritrova se stessa,
scoprendosi e conoscendosi quale auten-
tico pensiero. Il pensiero, quindi, nasce
essenzialmente dal lavoro perché solo la-
vorando si prende piena consapevolezza
di se stessi, proprio perché il lavoro ci
pone a contatto continuo con una realtà
esterna che resiste e si oppone alla
nostra azione e che proprio nel suo re-
sistere e nel suo opporsi pone continua-
mente dei problemi che possiamo cer-
care di superare solo ricorrendo alla no-
stra intelligenza e alla nostra determina-
zione, insomma al cervello e alla volontà.
Aggiunge ancora Hegel: «senza la disci-
plina del ser vizio e dell’obbedienza la
paura resta al lato formale e non si river-
sa sulla consaputa effettualità dell’esisten-
za». La paura, proprio nella misura in cui
ha rivelato «l’essenza semplice dell’au-
tocoscienza», il suo assoluto fluidificarsi,
che scopre un «puro e universale movi-
mento», ci rivela la potenza dell’autoco-
scienza: ma questa potenza può realiz-
zarsi solo ed unicament e attraverso il
«dileguare trattenuto» rappresentato
dal lavoro, perlomeno nella misura in cui
il lavoro è effettivamente in grado di for-
mare, proprio perché «senza il formare
la paura resta interiore e muta, e la co-
scienza non diviene coscienza per lei stes-
sa». La libertà del pensiero, proprio per
non essere irretita entro i limiti della
schiavitù, deve insomma vivere un’espe-
rienza radicale che le fornisca «la con-
sapevolezza di sé come essenza». Proprio
questa radicalità – ben espressa nella pa-
gina hegeliana dall’esperienza dell’ango-
scia di fronte alla morte che vanifica ra-
dicalmente ogni determinazione consue-
tudinaria della vita ordinaria –indica la
capacità del pensiero di elevarsi, infine,
all’universale e, per H egel, allo st esso
concetto assoluto.
Fabio Minazzi Università dell’Insubria
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX56
PERCORSI DIDATTICI
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 56
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 57
PERCORSI DIDATTICI
Jerome Bruner sosteneva che tutto
può essere insegnato a tutti, ma in
forme adeguate all’età, al livello di
sviluppo, alle capacità e agli interessi degli
alunni1. Una delle pr incipali difficoltà
nell’insegnamento della filosofia è il po-
tente livello di astrazione del suo apparato
concettuale che rischia di essere banaliz-
zato per un eccesso di semplificazione e
di schematismo, soprattutto quando in
questione ci sono orientamenti filosofici
altamente riflessivi e sistematici dove il
concetto sembra avere una vita propria,
quasi indifferente alla realtà che rappre-
senta. Ad esempio, la filosofia hegeliana
può essere una vera e propria insidia per
quei docenti costretti a parlare di dialet-
tica, spirito, verità, coscienza, razionalità, ad
alunni imprigionati, come gli schiavi
nella caverna platonica, nelle maglie di un
pensiero concreto e sensibile. Che fare?
Ci sono molti metodi per avvicinarsi allo
studio della filosofia (e di quella hegeliana
in particolare) tra cui non è da sottova-
lutare quello retorico che si serve delle
metafore per arrivare ai concetti 2.
Nella prefazione alla Fenomenologia dello
spirito, incuneate all’interno di un’argo-
mentazione che già dalle prime righe si
preannuncia stringente, troviamo dieci
metafore3. Può sembrare strano che He-
gel, il filosofo del concetto, usi un espe-
diente retorico. Ed ancora più strano che
usi la metafora non solo per il suo valore
persuasivo ma come formazione precon-
cettuale o paraconcettuale. Come cerche-
rò di mostrare, infatti, le metafore hege-
liane non sono solo strumenti del dire ma
anche strumenti del pensare. Consideria-
mole in ordine di presentazione.
Le metafore hegeliane1. Il boccio dispare nella fioritura, e si po-
trebbe dire che quello vien confutato
da questa; similmente, all’apparire del
frutto, il fior e vien dichiarato una
falsa esistenza della pianta, e il frutto
subentra al posto del fiore come sua ve-
rità.
2. Lo spirito si mostra così povero, che
sembra impetrare, per un po’ di ristoro,
il magro sentimento del divino, simile
al viandante che nel deserto brama una
sola goccia d’acqua.
3. Ma quel modo che nella creatura, dopo
lungo placido nutrimento, il primo re-
spiro interrompe quel lento processo
di solo accrescimento quantitativo, e
il bambino è nato; così lo spirito che si
forma, matura lento e placido verso la
sua nuova figura e dissolve brano a
brano l’edificio del suo mondo prece-
dente.
4. Quanto poco un edificio è compiuto
quando le sue fondamenta sono state
gettate, tanto poco il concetto dell’in-
tiero, che è stato raggiunto, è l’intiero
stesso.
5. Quando noi desideriamo vedere una
quercia nella robustezza del suo tronco,
nell’intreccio dei suoi rami e nel rigo-
glio delle sue fronde, non siamo sod-
disfatti se al suo posto ci venga mostra-
ta una ghianda; similmente la scienza,
corona del mondo dello spirito, non è
compiuta al suo inizio.
6, 7. Ma questa è verità, non come se l’ine-
guaglianza fosse stata eliminata, a
quel modo c he dal metallo pur o è
espulsa la scoria; e neppure è essa ve-
rità, come dalla botte or ora costruita
si è rimosso l’arnese; anzi l’ineguaglian-
za stessa è ancora immediatamente
presente nel vero come tale, è presente
come il negativo.
8. Così, mentre ciascuno, pur possedendo
occhi e dita, se gli si mettano a dispo-
sizione cuoio e arnesi è poi incapace di
fare delle scar pe, – par e invece che,
quanto alla filosofia, domini ora il pre-
giudizio che ciascuno sappia immedia-
tamente filosofare e giudicare di filo-
sofia, possedendo egli nella sua ragione
naturale la misur a a ciò adatta: –
come se ciascuno non possedesse, simil-
mente, nel suo piede la misur a di
una scarpa.
9. Quanto alla filosofia genuina, noi ve-
diamo come l’immediata rivelazione
Imparare la filosofia dalle metaforeStefano Cazzato
PER NON COMUNICARE IL PENSIERO FILOSOFICO COME FOSSE UNA SEQUENZA DI CONCETTI DISTANTI
DALLA REALTÀ, NON È DA SOTTOVALUTARE L’EFFICACIA DELLA METAFORA, UN APPROCCIO AGLI ARGOMENTI
COINVOLGENTE E RIGOROSO NELLO STESSO TEMPO.
1. J. Bruner, Verso una teoria dell’istruzione , Armando,Roma 1967.2. Per uno studio generale sulla metafora si veda B.M.Garavelli, Le figure retoriche. Effetti speciali della lingua,Bompiani, Milano 1993.3. G.W.F.Hegel, Fenomenologia dello spirito, La Nuova Ita-lia, Firenze 1996.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 57
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX58
PERCORSI DIDATTICI
del divino e il buon senso, che non si
è mai curato di coltivarsi né con la fi-
losofia né con altra forma del sapere,
si considerino senz’altro quale perfetto
equivalente e ottimo surrogato della
lunga via della cultura, di quel ricco e
profondo movimento per cui lo spirito
giunge al sapere, quasi come si decanta
la cicoria quale surrogato del caffè.
10. Questa via ordinaria si fa in maniche
di camicia; il sentimento eccelso del-
l’Eterno, del Sacro, dell’Infinito, percor-
re invece in paramenti sacerdotali un
cammino che è piuttosto esso stesso
l’immediato essere nel centro.
Analisi Consideriamo le metafore 1, 3, 4 che fan-
no essenzialmente riferimento ai concetti
hegeliani della maturazione, del supera-
mento e della totalità. La parte (il boccio,
la creatura, le fondamenta) è destinata ad
essere superata in v ista di quel tutt o
(l’intero) che rappresenta la sua piena rea-
lizzazione, la sua verità (il frutto, il bam-
bino, l’edificio). È q uesto il pr ocesso
lento e graduale, ma necessario e ineso-
rabile, di formazione dello spirito che –
come le metafore ci illustrano – non con-
siste solo nell’accrescimento quantitativo
del pre-esistente ma anche nella sua dif-
ferenziazione qualitativa. Anzi, di tale por-
tata e intensità è questo accrescimento che
il risultato del processo sembra dissolvere,
negare, falsificare i suoi inizi. Eppure que-
gli inizi, quel mondo precedente, quelle
origini, sono nobili e importanti.
Consideriamo, a tal proposito, le metafore
6 e 7 che fanno riferimento al concetto di
conservazione del negativo, forse il con-
cetto hegeliano più importante. Il proces-
so della verità, mediante il quale lo spirito
diviene ciò che deve divenire, non è solo
superamento e diversificazione, ma anche
memoria e conservazione dialettica del
superato e del differente. Diversamente
da un metallo puro, dal quale sono state
eliminate le scorie, l’ineguaglianza è im-
mediatamente presente come negativo
nella verità e ne è parte integrante e ar-
ricchente. I passaggi intermedi e le diffe-
renze interne fanno la verità totale dello
spirito come il boccio e il fiore fanno la
verità compiuta del frutto. La verità di una
botte è anche il processo sintetico della sua
costruzione, compresi i materiali e gli ar-
nesi necessari per costruirla. È singolare
che Hegel sostenga che la verità non è
l’astratto ma il concreto dove concreto è
ciò che con-cresce (cresce insieme), si svi-
luppa e si completa nel tempo anche per
mezzo delle differenze, delle contraddi-
zioni e delle variazioni. Che cos’è allora
il concreto, se non la storia stessa?
Se la verità è lo sviluppo dello spirito sino
al momento della sua autocomprensione,
il compito della filosofia è di essere la co-
scienza riflessiva, la comprensione razio-
nale, di questo sviluppo, dai suoi inizi al
suo compimento. È questo il punto in cui
in Hegel storia e filosofia si saldano con
la conseguenza che la filosofia non può
non essere una filosofia della storia. Del
resto, uno dei modi di int endere la
celebre identità hegeliana di razionale e
reale è la fedeltà con cui la filosofia segue
(o dovrebbe seguire) passo dopo passo il
cammino dello spirito, cioè la storia,
tormentata e faticosa, del suo intero iti-
nerare. Questo compito della filosofia è
chiarito dalle metafore 2, 5 e 9. Più pre-
cisamente: la metafora 2 chiarisce un er-
rore abituale del filosofo che, mosso
dalla sete della verità, rischia di acconten-
tarsi di una parte della verità come il vian-
dante nel deserto trova un po’ di ristoro
in una goccia d’acqua; la metafora 5 dice
che chi desidera il tutto non può essere
appagato da una soddisfazione parziale
perché sarebbe deluso come quell’uomo
che, desiderando vedere una quercia ro-
busta, intricata e rigogliosa, debba accon-
tentarsi di vedere una ghianda. La meta-
fora 9 va oltre il rapporto tra il tutto e la
parte e introduce quello tra l’apparenza
e la realtà. Spesso, lamenta Hegel, l’errore
dei filosofi non è quello di scambiare la
parte con il tutto ma quello, più clamo-
roso e pericoloso, di scambiare la verità
con il suo sur rogato (il buon senso)
come qualcuno sconsideratamente scam-
bia la cicoria, di cui decanta le lodi, per
caffè. Le metafore 2 e 5 fanno riferimento
a un errore di prospettiva proprio di quei
filosofi che, incapaci di uno sguar do
globale e sistematico, si incagliano nel par-
ticolare, lo assolutizzano e, assolutiz-
zandolo, lo astraggono dalla storia della
quale è parte. E invece di considerare il
cammino dello spirito nella sua totalità
si fermano a una delle sue stazioni, fosse
pure per impetrare un po’ di ristoro. La
metafora 9 fa riferimento, invece, a un er-
rore di profondità, tipico di quei filosofi
che, incapaci di uno sguardo radicale e fe-
nomenologico, si fermano alla superficie
disordinata e caotica degli eventi storici
invece di penetrarne l’essenza intimamen-
te razionale.
Chi siano questi filosofi r isulta, infine,
chiaro dalle metafore 8 e 10 nelle quali
Hegel polemizza contro il dilettantismo
filosofico, contro i profani che fanno fi-
losofia “in maniche di camicia” mentre lo
spirito procede in “paramenti sacerdotali”,
contro il pr egiudizio che basti a vere
occhi e dita e cuoio e arnesi per fare delle
scarpe: cioè la ragione e un po’ di stru-
menti filosofici per v enire a capo della
questione della verità. Una questione
così eccelsa che non può essere lasciata in
mani comuni e ordinarie. La filosofia –
conclude Hegel sulla scia dei grandi clas-
sici – è una missione sacra e non un me-
stiere.
Fonti di esperienza econoscenzaDalle dieci metafore si potrebbero svilup-
pare molti concetti ma quelli considerati
costituiscono già una valida introduzione
al pensiero di Hegel la cui mossa retorica
originale non è tanto quella di utilizzare
le metafore ma di collocarle nella prefa-
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 58
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 59
zione come un avvio, un assaggio del suo
complesso sistema filosofico.
L’esperienza didattica qui pr oposta è
solo l’esemplificazione di un metodo di
lavoro, di un approccio al pensiero che
vuole essere coinvolgente e rigoroso nello
stesso tempo. Insisto sul rigore di un’ana-
lisi metaforica visto che molti non riten-
gono la metafora (e neppure gli esempi,
le similitudini, le allegorie) come una chia-
ve di accesso credibile allo studio della fi-
losofia e preferiscono considerarla come
una figura retorica, negandone il valore
concettuale e conoscitivo4. Ma la lettera-
tura filosofica di ogni epoca è ricchissima
di metafore. Platone paragona la cono-
scenza sensibile al buio in cui si trovano
gli uomini nella caverna. Seneca paragona
il presente al mo vimento senza sosta
delle stelle. Cartesio considera l’opinione
come una vecchia casa da abbandonare
non prima, però, di aver posto le fonda-
menta della nuova. Per Bacone un indi-
viduo di intelligenza mediocre (lo zoppo),
posto sulla retta via, arriva alla verità più
rapidamente di un uomo di fine intelli-
genza (un esperto corridore), posto sulla
strada sbagliata. Per Kant il mondo è un
abisso sbadigliante. Condillac ricorre a
una statua di marmo per mostrare che la
conoscenza nasce dal sentire e, per restare
sul terreno gnoseologico, Locke si inventa
la celebre metafora della tabula rasa per
confutare l’innatismo. Montesquieu,
piuttosto arditamente per il suo tempo,
conia l’immagine di una natura a lungo
vergine, che rinuncia di fronte alla scienza
al suo pudor e e per de, in un unic o
istante, la propria innocenza. Nietzsche
ricorda che il mondo non è una mela
d’oro tenera e vellutata ma un mostro di
forze. Di grande efficacia contro l’idea di
conoscenze eterne è l’esempio, fatto da
Simmel, di tante ex verità che scendono
dalla scala di servizio mentre altrettante
verità salgono dalla scala principale. Lu-
kács afferma che la teoria nietzscheana
della razza si distingue da quella di Ro-
senberg come un diavolo
giallo si distingue da un
diavolo azzurro. Wittgen-
stein parla di certe propo-
sizioni come di rotaie di
un treno. L’Angelus novus
di Benjamin è una stu-
penda metafora della mo-
dernità5. Rosenzweig pa-
ragona l’identità di pen-
siero ed essere, caratteri-
stica dell’intera filosofia
occidentale dagli ionici a
Hegel, a una par ete dipinta ad affr esco
mentre la parete su cui sono appesi dei
quadri rimuovibili rappresenterebbe la
fine di quell’identità.
Hans Blumenberg ha scritto un intero li-
bro sulla metafora del naufragio, mo-
strando come essa innervi tutta la filosofia
occidentale da Lucrezio a Jaspers6. Ed è
stato proprio Blumenberg a fondare la
metaforologia, la scienza delle metafore
filosofiche in quanto strumenti del pen-
siero. Egli sostiene che «la metafora crea
esperienza senza derivare dall’esperienza»
poiché mostra con l’immediatezza del di-
scorso analogico quanto il discorso logico
è costretto a dimostrare attraverso una se-
rie di passaggi intermedi7. Quei passaggi
che sono sicuramente indispensabili per
la formazione di un pensiero astratto e lo-
gicamente evoluto ma – riconosciamolo
– sono anche impervi, faticosi e noiosi per
molti studenti. Al contrario, secondo
Blumenberg, la metafora rende presente,
fa vedere, mette sotto gli occhi gli “oggetti”
della filosofia e crea delle stimolanti oc-
casioni di conoscenza. Sta all’abilità del
docente fare il salto dall’analogia alla lo-
gica perché la metafora non sostituisce il
concetto, ma prepara alla conoscenza del
concetto. Ne costituisce l’anticipazione,
la prefazione e la t raduzione. E non
sempre è vero, come le dieci metafore he-
geliane dimostrano, che tradurre è tradire.
Inoltre non è da sottovalutare, come re-
centi studi ormai hanno chiarito, che l’in-
terlocutore è più disposto all’attenzione
se ad essere coinvolto nel processo cogni-
tivo non è solo il suo pensiero ma anche
la sua sensibilità, le sue emozioni, la sua
esperienza8. Per Vico, un hegeliano ante
litteram, era fondamentale c olpire la
fantasia per arrivare alla ragione. Era fon-
damentale cioè movere e delectare se si vo-
leva docere. Ed è innegabile che le meta-
fore svolgano perfettamente questa fun-
zione, anche perché sono più facili da ca-
pire e da memorizzare dei concetti in sen-
so stretto.
Stefano CazzatoLiceo linguistico «Carducci», Roma
4. Sul valore conoscitivo di esempi e paragoni si veda S.Cazzato, Ragionare per esempi, «Nuova secondaria», 8, 15Aprile 2003, pp. 63-65.5.W. Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino 1982.6.H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, il Mulino, Bo-logna 1985.7.H. Blumenberg, Paradigmi di una metaforologia, il Mu-lino, Bologna 1969.8.D. Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1997.
Paul Klee, Angelus Novus.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 59
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX60
PERCORSI DIDATTICI
La questione della posizione della
donna in G recia è spesso s tata
trattata da un punto di vista ate-
nocentrico, data la sproporzione tra le
nostre conoscenze sul contesto ateniese
e quelle su altre zone del mondo greco;
solo con l’epoca ellenistica si è a vuto
qualche ampliamento di prospettiva, co-
munque settoriale (l’Egitto tolemaico,
con il suo pat rimonio papiraceo, e
l’Asia seleucidica, con le attestazioni epi-
grafiche, hanno permesso di considerare
in parte anche situazioni sociali e giu-
ridiche diverse). Ma negli anni più re-
centi lo sviluppo degli studi sulla Ma-
cedonia, dovuto anche all’aumento
della documentazione disponibile, ci ha
offerto un quadro più soddisfacente del-
la società macedone, il che ci consente
di porre il problema delle donne mace-
doni, seppure soprattutto riguardo alle
donne della casa reale.
La Macedonia era uno stato federale ar-
ticolato in diversi cantoni, guidati da
capi guerrieri; era stato unificato dai
Macedoni, di probabile ascendenza do-
rica, nel VII secolo. La dinastia degli Ar-
geadi esercitava sui Macedoni una mo-
narchia di tipo arcaico, dallo stile di vita
“omerico”. Il re Alessandro I, detto “Fi-
lelleno”, riuscì a farsi riconoscere come
greco attraverso l’ammissione ai Giochi
Olimpici e realizzò una sensibile espan-
sione della M acedonia verso oriente,
fino al fiume Strimone, e verso il sud,
fino al monte Olimpo. Spesso in diffi-
coltà per la pressione dei barbari inse-
diati lungo i confini (Illiri e Traci) e per
le frequenti crisi dinastiche (il re era un
primus inter pares, la cui ascesa al trono
doveva essere ratificata dall’assemblea
del popolo in ar mi), la M acedonia
restò a lungo ai margini della storia gre-
ca, cercando, attraverso legami di alle-
anza con le diverse potenze greche, di
mantenere la propria unità e indipen-
denza. Solo con Filippo II e il figlio Ales-
sandro III il Grande la Macedonia di-
venne una grande potenza, dalla quale,
con la fine dell’impero di Alessandro,
nacquero le grandi monarchie ellenisti-
che.
In età classica, la collocazione periferica
della Macedonia sul piano geografico e
culturale e la estrema scarsità di docu-
mentazione epigrafica, dovuta con ogni
probabilità al diffuso analfabetismo ,
hanno reso impossibile farsi un ’idea
chiara della condizione femminile, sia
per le donne dell’élite, sia, a maggior ra-
gione, per quelle comuni. In generale,
si può dire che la donna macedone as-
somigliava a quella omerica o a quella
delle antiche aristocrazie, più che alla
donna greca contemporanea. Fino alla
fine del IV secolo i corredi delle tombe
mostrano che le donne sono associate
alla casa e ai compiti familiari, soprat-
tutto religiosi: la donna trova dunque
il suo spazio di espressione nella fami-
glia e il suo compito è prima di tutto
quello di generare figli. Sulla situazione
giuridica, che ad Atene ci è nota soprat-
tutto dall’oratoria, non siamo informati
a sufficienza: sembra che le donne, so-
prattutto se vedove, potessero svolgere
transazioni legate alla proprietà terriera,
come accadeva in altre società doriche.
Ma fino all’epoca di Filippo II il livello
di vita restò complessivamente piutto-
sto basso e ciò influì in modo non po-
sitivo sulla condizione femminile, che
restò relativamente modesta sul piano
giuridico e culturale.
In età classica e poi nel corso dell’elle-
nismo, sono le donne della famiglia rea-
le macedone, quella deg li Argeadi, a
darci qualche informazione, settoriale
ma interessante, sulla condizione fem-
minile. Due sono gli aspetti che meri-
tano di essere considerati: la pratica del-
la poligamia e il r uolo delle donne
come strumento di alleanza politica.
MogliLa pratica della poligamia ebbe conse-
guenze notevoli su una casa reale nel-
l’ambito della quale, a quanto sembra,
ogni maschio della famig lia poteva
Le donne della casa reale di MacedoniaCinzia Bearzot
NON SOLO ATENE CI FA CONOSCERE LA CONDIZIONE DELLA DONNA IN GRECIA: LA MACEDONIA, ANCHE SE PERIFERICA DA UN PUNTO DI VISTA CULTURALE, OFFRE PROFILI FEMMINILI FORTI, COME QUELLI DELLE DONNE DI POTERE.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 60
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
ambire alla successione. Il sovrano con-
cludeva matrimoni con donne diverse,
a scopi spesso diplomatici: Filippo II
ebbe sette mogli/concubine diverse, di
origine greca (la tessala Filinna), mace-
done (l’ultima mog lie, Cleopatra) o
straniera (l’illirica Audata, la getica
Meda, l’epirota Olimpiade, la madre di
Alessandro). I figli di queste unioni ave-
vano una posizione incerta rispetto
alla successione, che non era garantita
da criteri ben definiti come, per esempio,
la primogenitura. Erano, in realtà, i figli
della moglie più “autorevole” ad essere
nella posizione migliore per la successio-
ne: è il caso di Alessandro, che non era
il primogenito di Filippo ma era il figlio
della “first lady”, Olimpiade, la sola mo-
glie cui Filippo aveva dato anche un ruo-
lo pubblico. La posizione di “first lady”,
però, non poteva dirsi acquisita una volta
per tutte; la regina poteva cadere in di-
sgrazia a favore di nuove spose, come ac-
cadde appunto ad Olimpiade quando Fi-
lippo volle convolare a n uove nozze
con la giovane macedone Cleopatra.
Questa situazione creava grande incer-
tezza a corte e costringeva le donne della
casa reale a lottare per garantire a se stes-
se un ruolo preponderante e ai fig li la
successione: gli scontri, che vedevano la
corte dividersi in fazioni, si giocavano su
temi diversi, come il ruolo di prima mo-
glie, l’origine etnica, la capacità di eser-
citare la maggiore influenza sul re. La
moglie caduta in disgrazia non esitava,
talora, a promuovere congiure contro il
marito, se vedeva a rischio la propria po-
sizione e la successione dei figli: l’epirota
Olimpiade, messa da parte per la mace-
done Cleopatra, umiliata dalla prospet-
tiva di perdere il proprio ruolo di regina
madre e di v edere il fig lio Alessandro
scalzato dalla posizione di erede, avrebbe
organizzato l’assassinio di Filippo. Vera
o falsa che sia, la storia – una delle tante
del genere – è significativa del clima che
si respirava alla corte argeade.
BasilisseL’uso della donna per la creazione di al-
leanze matrimoniali era tradizionale nel-
le aristocrazie greche. La monarchia ma-
cedone, con la sua ispirazione “omerica”,
continuò a praticare questo uso, per mo-
tivi politici e diplomatici. I matrimoni
delle donne della famiglia del re erano
un prezioso strumento per intessere re-
lazioni diplomatiche, porre fine a guerre,
sancire alleanze; ma la loro posizione a
corte poteva cambiare, qualora quelle re-
lazioni si rompessero o diventassero di
secondaria importanza. In questo caso
l’origine straniera della regina la metteva
in difficoltà e si riverberava sui figli, con-
siderati bastardi sul piano et nico e
quindi deboli in t ema di successione.
Nonostante ciò i matrimoni dinastici di-
vennero una delle cifre dell’ellenismo,
non solo in Macedonia ma anche nelle
altre monarchie.
Studi recenti
hanno eviden-
ziato che le don-
ne ebbero un ruolo
molto importante
nell’immagine della
monarchia macedone
e, in generale, elleni-
stica, a causa del suo
carattere familiare e
dinastico. Esse ot-
tennero, attraverso il
matrimonio e la ma-
ternità, un ruolo pub-
blico spesso ampia-
mente enfatizzato.
Come la donna citta-
dina greca aveva la
funzione di gene-
rare cittadini liberi, così le donne di casa
reale avevano il compito di assicurare la
successione. Esse furono quindi centrali
nell’ideologia dinastica: il loro ruolo è
celebrato nei monumenti a carattere fa-
miliare, come il Philippeion dedicato da
Filippo II ad Olimpia, che comprendeva
statue della madre e della moglie di Fi-
lippo.
Per queste donne l’oikos, la casa, era la
corte reale, in cui svolgevano compiti di
gestione e amministrazione, ma anche
funzioni religiose; avevano a disposizio-
ne molto denaro, come rivelano le loro
attività evergetiche, le offerte votive, le
dediche celebrative. Molte esercitarono,
o tentarono di eser citare, un r eale
potere; e alcune di loro, come Olimpia-
de, Cinnane, figlia di Filippo e moglie
di Aminta IV, ed Euridice, moglie di Fi-
lippo Arrideo, non disdeg narono di
Stele funeraria(ca. 420 a.C).
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 61
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX
PERCORSI DIDATTICI
mettersi alla testa di eserciti. L’importan-
za assunta da alcune figure femminili è
sottolineata dalle ricostruzioni propa-
gandistiche che le r iguardano, dalla
leggenda nera di Euridice e di Olimpiade
alla santificazione di Fila, figlia di An-
tipatro e sor ella di Cassandr o, poi
moglie di Demetrio Poliorcete.
Proprio a partire da Fila è attestato l’uso
del termine ufficiale di basilissa, “regina”:
un titolo che interessa tutte le donne del-
la famiglia, comprese le figlie nubili. Si
tratta, evidentemente, di uno strumento
per valorizzare il r uolo delle donne
della casa reale sul piano individuale e
nell’ambito della dinastia; mentre il
culto dinastico, praticato in Egitto e in
Siria, non è att estato in Macedonia,
dove i sovrani sono considerati uomini
come gli altri. È presente invece anche
in Macedonia l’uso di dare nomi delle
donne della famiglia reale alle fondazio-
ni coloniali: Tessalonica prese il nome
dalla moglie di Cassandro, figlia di Fi-
lippo II, che ebbe un ruolo fondamen-
tale nella legittimazione delle pretese del
marito sul trono macedone.
È difficile valutare il ruolo delle donne di
casa reale nell’evoluzione della condizio-
ne giuridica e culturale delle donne ma-
cedoni, ma la loro immagine pubblica
potrebbe aver influenzato i miglioramenti
che sembrano potersi desumere dalle
fonti, soprattutto epigrafiche. Migliora-
menti che interessarono la condi-
zione delle stesse regine e
principesse, la cui impor-
tanza cresce di pari passo
con l’abbandono progressi-
vo della poligamia.
Un caso significativoÈ quello di Euridice, principessa
di sangue illirico andata sposa nel
392 ca. ad Aminta III di Mace-
donia e madre dei suoi figli
Alessandro (II), Perdicca
(III) e Filippo (II). La
tradizione la pr e-
senta in mod o
duplice. Secondo
alcuni, sarebbe
stata respon-
sabile della
c o n g i u r a
contro il
m a r i t o
Aminta, in
favore del
genero ed amante Tolemeo di Aloro; per-
donata da Aminta, avrebbe organizzato
l’assassinio dei figli Alessandro e Perdicca
e avrebbe poi sposato Tolemeo, divenuto
reggente (Giustino VII, 4-6; scolio ad
Eschine II, 29). Secondo altri, la sovrana
era moglie e madre devota, preoccupata
di tutelare i figli nel suo difficile ruolo
di regina-vedova e perciò assai attiva sul
piano politico (Eschine II, 26-29).
È probabile che abbia ragione Eschine.
L’oratore, nel discorso Sull’ambasceria
del 343, dichiara di aver rievocato in pre-
cedenza, di fronte a Filippo, un episodio
che avrebbe visto la regina madre rivol-
gersi allo stratego ateniese Ificrate, per
essere aiutata, dopo la morte di Alessan-
dro II (368), a garantire ai figli superstiti
la salvezza e la suc cessione. Anche se
l’episodio è fittizio , quanto Eschine
dice attesta che nel 343 i rapporti fra Fi-
lippo e la madre erano ritenuti ottimi
dall’opinione pubblica greca. Che, del
resto, la reputazione di Euridice sia ri-
masta intatta nel tempo anche nel con-
testo macedone lo conferma il fatto che
Filippo dedicò nel 338 una statua della
madre nel Philippeion di Olimpia, insie-
me alla propria e a quelle del padre
Aminta, della moglie Olimpiade e del fi-
glio Alessandro (Pausania V, 20, 9-10).
La tradizione ostile sembr a dunque
inattendibile, ma testimonia come una
regina potesse essere coinvolta in torbide
vicende dinastiche, fino ad essere rite-
nuta responsabile delle peggiori nefan-
dezze verso il marito e i figli. Euridice
era certo sfavorita dal fatto di essere di
origine straniera: Plutarco (De liberis
educandis, 14 b) la definisce “illirica e tre
volte barbara (tribarbaros)”. È probabile
che questa origine barbarica abbia fa-
vorito la nascita della leggenda nera ap-
prodata a Giustino, nata nell’ambito del-
la corte per screditare la regina come
barbara e fedifraga e quindi, indiretta-
mente, la sua prole, a vantaggio di altri
aspiranti al trono: in particolare Arche-Statua di Musa.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 62
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 63
PERCORSI DIDATTICI
lao, Arrideo e Menelao, figli di Gigea,
prima moglie di Aminta III, che era ma-
cedone e che apparteneva alla casa ar-
geade (portava il nome della sorella di
Alessandro I Filelleno).
Nello stesso passo in cui la definisce tri-
barbaros, Plutarco aggiunge un ele-
mento interessante per il t ema della
condizione femminile in Macedonia,
anche a livelli sociali elevati. Egli dice
che Euridice si mise a studiar e in età
avanzata, per seguire i figli nello studio,
e dedicò un epigramma alle Muse così
concepito: “Euridice figlia di Sirra, cit-
tadina, consacrò questa offer ta alle
Muse, colto nell’anima il desiderio di sa-
pere. Già madr e di fig li fiorenti, si
sforzò d’imparare le lettere, che serbano
delle parole il ricordo”. Euridice sembra
autorappresentarsi come madre orgo-
gliosa della prole e persona sensibile
all’esigenza di una crescita culturale. La
testimonianza, oltre a gettar luce sulla
personalità di E uridice, mostra che
una regina macedone poteva essere
del tutto analfabeta.
Euridice è dunque una personalità che
esemplifica bene ruolo, funzioni, diffi-
coltà delle donne della casa reale ma-
cedone. Sposata per motivi diplomatici,
ella era divenuta la “first lady” di Ma-
cedonia, preferita da Aminta alla prima
moglie macedone Gigea, e madre del-
l’erede al t rono, nonostante Aminta
avesse avuto da Gigea altri figli. Rimasta
vedova e coinvolta nella crisi dinastica
che seguì alla morte di Aminta, seppe
reagire politicamente e culturalmente,
contrastando con successo la “leggenda
nera” costruita intorno alla sua persona.
Proprio nell’ambito della politica auto-
promozionale svolta da Euridice nel dif-
ficile arco d’anni compreso tra la morte
di Aminta e la stabilizzazione della suc-
cessione di Filippo vanno inserite, con
ogni probabilità, le testimonianze epi-
grafiche che la riguardano. Oltre all’iscri-
zione conservata per tradizione letteraria
da Plutarco, si tratta di tre documenti
epigrafici, tre basi di statua ritrovate a
Vergina: due dediche a Eukleia e una
base di statua con la dicitura “Euridice
figlia di Sirra”. In queste iscrizioni Eu-
ridice si presenta in piena autonomia ri-
spetto agli Argeadi, marito e figli, sot-
tolineando quasi con orgoglio, come “fi-
glia di Sirra”, anche la propria origine
straniera, e definendosi “cittadina”. Tut-
tavia, le dediche ad Eukleia mostrano il
suo inserimento nel culto familiare di
Artemide Eukleia, e sempre al contesto
familiare riporta la sua orgogliosa au-
todefinizione di “madre di figli fiorenti”.
Non sembra quindi infondato cogliere
qui l’espressione di una consapevole e
sistematica reazione alle accuse di bar-
barie, di adulterio, di cospirazione dina-
stica, di omicidio dei due figli maggiori
rivoltele nel corso di una campagna di
denigrazione scatenata a fini evidente-
mente dinastici.
La cronologia delle iscrizioni dedicate
da Euridice è stata molto discussa, ma
una adeguata c ollocazione sembra la
fine degli anni ’50, all’altezza della ten-
tata usurpazione di Archelao e dell’at-
tacco alla figura di Euridice promosso
dai figli di Gigea. Esse fanno probabil-
mente parte di una campagna autopro-
mozionale che intendeva reagire alle ca-
lunnie e accreditare, presso l’opinione
pubblica macedone, l’immagine di Eu-
ridice come donna indipendente e vo-
litiva, capace di forti iniziative politiche
autonome, ma devota alla famiglia e ma-
dre amorevole, impegnata a tutelare i di-
ritti dei figli. E anche, si può aggiungere,
consapevole dell’importanza, per la
propria immagine pubblica, dell’alfabe-
tizzazione e della promozione culturale,
espressamente celebrate in una dedica
alle Muse: un aspett o che potrebbe
aver influenzato l’opinione pubblica
in tema di condizione femminile.
Cinzia Bearzot Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano
BIBLIOGRAFIA
In generale, per un aggiornamento sulle monarchie ellenistiche si rimanda a F. Landucci, L’ellenismo, Bologna 2010; per gli aspetti familiarie dinastici, cfr. in particolare 43-48. Sulle donne nella monarchia macedone E.D. Carney, Women and Monarchy in Macedonia, Norman,Okla. 2000; sempre della C arney, si v eda il più r ecente articolo Macedonian Women, in J. Roisman, I. Worthington (eds.), ACompanion to Ancient Macedonia, Chichester; Malden, MA 2010, 409-427, che tiene conto, per quanto possibile, anche delle donneestranee alla casa reale. Inoltre, I. Savalli-Lestrade, Il ruolo pubblico delle regine ellenistiche, in S. Alessandrì (ed.), Historie. Studi Nenci,Lecce 1994, 415-432.Ulteriore bibliografia, insieme ad una analisi del caso di Euridice, si troverà in C. Bearzot, Donne di potere nel mondo antico: Euridice,moglie di Aminta III di Macedonia, "NS Ricerca" n. 3, novembre 2012 (pubblicato sul sito).
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 63
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX64
PERCORSI DIDATTICI
Il tema del funzionamento della de-
mocrazia e delle sue istituzioni è di
stringente attualità, soprattutto per
i casi di degenerazione a cui esso può
esporsi. Si proporrà dunque un breve
percorso didattico che, partendo da
un testo, permetterà di riflettere sulle
modalità attraverso le quali la volontà
popolare poteva essere manipolata
nell’Atene del V secolo a.C. Potranno
servirsi di tale percorso non solo i do-
centi di Greco del triennio superiore del
Liceo classico, ma anche quelli di Storia
del biennio di qualsiasi ordine di scuola
secondaria superiore. Le discipline coin-
volte sono molt eplici: la st oria, per
l’approfondimento nella conoscenza
della realtà ateniese; l’educazione civica,
per la riflessione di carattere politico-
istituzionale e per i problemi relativi alla
manipolazione della volontà popolare;
la letteratura greca, per la conoscenza del
teatro di Aristofane, dal cui testo si par-
tirà per affrontare la tematica in esame.
In primo luogo, è necessario definire
cosa si intenda per manipolazione della
volontà popolare: essa consiste nel ten-
tativo di or ientamento dell’opinione
pubblica tramite il ricorso non solo a
strumenti di persuasione che rasentano
o valicano i limiti della correttezza, ma
anche all’intimidazione, alla corruzione
e a una sottile violazione delle istituzioni,
che peraltro apparentemente continua-
no a funzionare regolarmente.
Con tutta evidenza, si tratta di un tema
cruciale per lo studio del funzionamento
(e del malfunzionamento) di ogni de-
mocrazia, compresa quella ateniese.
In quanto tale, dunque, esso mer ita
particolare attenzione attraverso l’inda-
gine svolta direttamente su episodi spe-
cifici e su passi tratti dalla produzione
teatrale, segnatamente di genere comico,
che costituiscano in qualche modo uno
specchio della realtà quotidiana.
Ci si occuperà qui della parodia di una
seduta del Consiglio dei Cinquecento (la
boulé) inscenata in un passo di una com-
media di Aristofane presentata nel 424,
i Cavalieri. Tale testimonianza, pur non
riferendosi a un episodio storicamente
avvenuto, riveste grande importanza,
perché, per quanto deformata dagli in-
tenti parodistici, fornisce un’idea di
come potesse svolgersi una riunione del-
la boulé e di quali tentativi potessero es-
sere messi in atto per accattivarsi il
favore popolare.
La pagina di Aristofane, inoltre, è incen-
trata sulla figura di Paflagone, sotto la cui
maschera si può facilmente riconoscere
Cleone, il famoso demagogo, bersaglio
del resto privilegiato nella produzione del
commediografo. Nei Cavalieri, Demo
(il popolo di Atene) appare del tutto as-
servito a Paflagone-Cleone; i due schiavi
di Demo (i noti st rateghi Demostene e
Nicia) decidono allora di contrapporre a
costui, secondo le parole di un oracolo,
il Salsicciaio Agoracrito, un altro dema-
gogo ribaldo e disonesto, che avrà l’ap-
poggio del coro dei cavalieri. L’amara con-
clusione della commedia vede l’allonta-
namento dall’agorà di Paflagone-Cleone
e la vittoria del Salsicciaio, il quale ha la
meglio sull’avversario paradossalmente
solo perché è un mascalzone ancor più
spregiudicato di lui.
La parodia di Aristofane di unaseduta del Consiglio di AteneDopo un violento scontro con il Salsic-
ciaio, Paflagone decide di recarsi nella
boulé nella quale si tiene una riunione
che viene dettagliatamente raccontata in
un ampio monologo dal Salsicciaio.
Si darà conto di seguito delle tecniche
impiegate dai due demagoghi per accat-
tivarsi il favore popolare.
Demagogia, corruzione e manipolazione nell’Atene del V secolo a.C.Paolo A. Tuci
LA MANIPOLAZIONE DELLA VOLONTÀ POPOLARE NON È UN MECCANISMO INVENTATO DALLE DEMOCRAZIE MODERNE;ANCHE L’ATENE CLASSICA, CHE FA DEL SUO GOVERNO DEMOCRATICO UN VANTO, LA CONOSCE E LA USA. SU "NS RICERCA" N. 3, NOVEMBRE 2012 (PUBBLICATO SUL SITO), UN SAGGIO SCIENTIFICO INDAGA IL FENOMENO
ATTRAVERSO LA PRODUZIONE TEATRALE, SOPRATTUTTO COMICA, CHE COSTITUISCE IN QUALCHE MODO UNO SPECCHIO
DELLA VITA REALE. QUI UNA SINTESI DEL SAGGIO AD USO DIDATTICO.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 64
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 65
PERCORSI DIDATTICI
1) Intimidazione: Paflagone afferma
che i cavalieri hanno ordito una congiura
ai danni della cittadinanza.[v. 624] Sì, vale la pena di ascoltare i fatti.Subito di qui mi lanciai al suo inseguimen-to; e là dentro rimbombavano le sue parolequasi fossero tuoni; e scagliava mostruosemenzogne contro i cavalieri: parole grandicome montagne; ed affermava in manieradel tutto persuasiva che sono dei congiurati.E tutta la boulé, ascoltandolo, fu piena dellesue menzogne – quasi fossero malerba –,impallidì, fece lo sguardo truce, aggrottò lafronte. E quando mi accorsi che la boulédava credito alle sue parole e si lasciava in-gannare dai suoi raggiri: «Suvvia, Scitalie Fenaci, – dissi – Berescheti, Cobali e Mo-toni, ed Agorà, nella quale ragazzino fuieducato, datemi ora audacia, lingua prontae voce impudente». […]
2) Ricorso a comunicazioni gradite al-
l’uditorio: il Salsicciaio tenta di distrarre
i Consiglieri dal timore della congiura
annunciando la vendita a costi contenuti
di un cibo assai popolare come le alici.[v. 641] Ruppi la porta della cancellata emi misi ad urlare a squarciagola: «Membridella boulé, porto buone notizie; voglio an-nunziarle a voi per pr imi: da quando èscoppiata la guerra non ho mai visto aliciad un prezzo più conveniente». E subito iloro volti si rasserenarono: volevano darmiuna corona per la buona notizia. Ed io liconsigliai, in gran segreto, di confiscare i vasiai fabbricanti: così avrebbero potuto com-prare, per un obolo, una grande quantitàdi alici. Quelli scoppiarono in un applauso:mi guardavano a bocca aperta.
3) Ricorso a pr oposte demagogiche:
Paflagone sfrutta la sensibilità religiosa
dei buleuti, invitandoli a compiere un sa-
crificio (che tra l’altro, si ricordi, implica
la distribuzione gratuita delle carni of-
ferte) per ringraziare gli dei del basso co-
sto delle alici.[v. 651] Lui, il Paflagone, si fa furbo; sa qua-li discorsi piacciono moltissimo ai buleuti,e fa questa proposta: “Signori, alla luce deifelici avvenimenti ora annunziati, ritengoche si debbano immolare cento buoi alla deaper questa buona notizia”. La boulé tornòa dargli il suo assenso.
4) Nuovo ricorso a proposte dema-
gogiche: il Salsicciaio rilancia
sul numero degli animali
da sacrificare (aumentan-
do dunque la mole della
carne a disposizione
per la distribuzione
gratuita).[v. 658] E io ,quando miaccorsi di es-sere battuto,sopraffattod a l l a …merda divacca, ri-lanciai ad u e c e n t obuoi, e li consi-gliai di promet-tere in voto allaCacciatrice, per ilgiorno dopo, millecapre, se le sar dinefossero costate ce ntoun obolo. La boulé sivolse di nuovo dalla miaparte. A sentire questeproposte, lui perse le staffe,cominciò a dar di matto: al-lora, i pritani e gli arcieri lotrascinarono via; e i buleuti, inpiedi, facevano chiasso per le alici.
5) Tentativo di ampliare la base del
proprio consenso: Paflagone si guadagna
il favore di c oloro che al demagogo
erano tradizionalmente ostili, cioè i
fautori della pace con Sparta.[v. 667] Lui li pregava di aspettare un mo-mento: «così sapr ete – dice va – qualinotizie porta l’araldo da Sparta: è venutoper la tregua”. E loro tutti insieme ad unavoce: “la tregua, ora? Si capisce, carino: han-no saputo che abbiamo le alici a buon mer-cato. Non abbiamo bisogno della tregua:continui la guerra!». E urlavano ai pritanidi sciogliere la seduta; e, da ogni parte, sal-tavano la cancellata.
6) Ricorso alla corruzione: il Salsicciaio
conquista definitivamente il favore dei
buleuti donando ai suoi concittadini ci-
polle e coriandolo.
[v. 676] Ed io me la svignai e comprai tuttoil coriandolo e le cipolle che c’erano al mer-cato; e poi li ho distribuiti gratis a loro, chene erano sprovvisti: perché condissero le ali-ci. Così sono entrato nelle lor o grazie.Tutti si lasciavano andare a lodi straordi-narie nei miei confronti, a grida di appro-vazione: e così, con un obolo di coriandolo,mi sono conquistato tutta la boulé. Ed ora,eccomi qua [v. 682].
La presentazione dei Consiglieri e dei demagoghiI cinquecento Consiglieri appaiono
come personaggi facilmente manipola-
bili, proni ad accordare il proprio favore
a colui che presentasse le offerte più van-
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 65
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX66
PERCORSI DIDATTICI
taggiose e demagogiche. Aristofane do-
veva averne una considerazione piuttosto
bassa; del resto, lo stesso Paflagone in
precedenza aveva esclamato esplicita-
mente che il Popolo (Demo) se ne sta se-
duto nella sala del Consiglio (bouleute-
rion) «con la sua fac cia da ebete» (Eq.
395-396). Pur non dimenticando il con-
testo parodistico in cui il brano è inserito,
è innegabile che il commediografo for-
nisca una presentazione assai desolante
dell’avvedutezza e della dirittura morale
dei Cinquecento. Essi sono considerati
come personaggi: a) di scarsa affidabilità
per la gestione della cosa pubblica, in
quanto interessati più a pr ocacciarsi
facilmente il cibo (le alici, la carne dei sa-
crifici, cipolle e coriandolo come condi-
mento), che ad amministrare con cor-
rettezza gli affari cittadini; b) di infima
levatura morale, pronti a farsi comprare
persino da un «obolo di coriandolo»; c)
di scarsa perspicacia ed int elligenza,
perché non in g rado di accorgersi che
non uno solo, bensì tutti e sei gli inter-
venti dei demagoghi erano volti a raggi-
rarli con ogni forma d’inganno mirante
a guadagnare il loro favore. Se è naturale
che i buleuti, cittadini comuni scelti at-
traverso il sorteggio, fossero particolar-
mente interessati al proprio sostentamen-
to quotidiano, ben più allarmante appare
che essi non siano capaci di rendersi con-
to dei tentativi di manipolazione di cui
erano oggetto: questo giudizio, per quan-
to da attenuarsi perché deliberatamente
deformato dagli intenti comici dell’au-
tore, deve essere opportunamente con-
siderato quando si studino episodi storici
della manipolazione nella boulé del V sec.
Naturalmente, per ottenere un tale effet-
to sugli sprovveduti buleuti doveva ri-
vestire eccezionale importanza non solo
ciò che veniva detto dai demagoghi nei
dibattiti, ma anc he come ciò v eniva
detto. Le fonti in nostro possesso, da Tu-
cidide (III, 36, 6) alla Costituzione degli
Ateniesi di Aristotele (XXVIII, 3), a Plu-
tarco (Nicia VIII, 6) descrivono il Cleone
storico molto vicino al Paflagone aristo-
faneo, anche nello «stile oratorio». Tale
conferma che esse forniscono alla pre-
sentazione aristofanea dello stile oratorio
di Cleone induce a domandarsi se e in
quale misura possa esser e ravvisata
un’analoga corrispondenza tra la parodia
e la realtà storica anche nelle modalità
adottate da Paflagone e da Cleone per
circuire il proprio uditorio. È nota alme-
no una misur a attuata da Cleone c he
può ben adattarsi al quadro del Paflago-
ne autore di proposte demagogiche di-
pinto dal commediografo: Cleone avreb-
be elevato da due a tre oboli l’indennità
giornaliera per i giudici del tribunale, ri-
scuotendo così il favore dei cittadini ate-
niesi, i quali erano, nella loro totalità, i
diretti beneficiari di tale innovazione. Tra
l’altro Cleone fu anche aperto alla cor-
ruzione se, come ricorda Teopompo
(FGrHist 115 F 94b), «prese cinque ta-
lenti dagli isolani per persuadere gli Ate-
niesi ad alleggerire il tributo» che essi pa-
gavano annualmente. Del resto, il dema-
gogo, che fu st ratego nel 424/3, ebbe
molto probabilmente a che fare con la
boulé, della quale peraltro fu forse anche
membro. Non si può dunque escludere
la possibilità, anzi, considerato l’abituale
modus operandi del demagogo, si può
giungere a ipotizzare come probabile che
Cleone abbia usato la sua impudenza, ef-
ficacemente parodiata da Aristofane,
per circuire i buleuti.
Oltre la parodiaLa parodia aristofanea di questa riunione
buleutica fornisce indicazioni importanti
su come poteva esser messo in atto un
tentativo di manipolazione e sugli effetti
che esso doveva provocare. Ma, si badi,
tali notizie non sono solo vuote suggestio-
ni provenienti da qualche isolata rappre-
sentazione parodistica, bensì probabili de-
duzioni che derivano dal confronto tra ciò
che della realtà storica ci è noto (il tipo
di oratoria di Cleone, il suo provvedimen-
to con cui fu innalzato il compenso per
gli eliasti, l’episodio di corruzione in re-
lazione alla tassa degli alleati) e le allusioni
che provengono dalla commedia, con-
fronto che depone tutto a favore dell’af-
fidabilità di questa: del resto, la parodia
di Aristofane colpisce i mezzi della ma-
nipolazione, enfatizzandoli iper bolica-
mente tanto da suscitare il riso, ma non
nega, anzi conferma il ricorso a tali me-
todi nella prassi quotidiana. Da un lato,
Cleone, che «sa quali discorsi piacciono
moltissimo ai buleuti», e forse anche gli
altri demagoghi che usciranno dalla sua
“scuola”, è in grado di adulare i suoi ascol-
tatori con lusinghe e proposte demago-
giche, per circuirli ed ottenerne il favore;
dall’altro, i buleuti non sembrano capaci
di accorgersi di tali forme di raggiro e di
piaggeria, rimanendo così involontaria-
mente manipolati ed ingannati.
Paolo A. TuciUniversità Europea di Roma
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Il presente testo costituisce una sintesicon taglio divulgativo del mio studio in-titolato Tecniche di manipolazione dellavolontà popolare in una seduta buleuticaparodiata da Aristofane (Eq. 624-682),pubblicato sul n. 3 di NS Ricerca, al qualesi rimanda per ogni approfondimentobibliografico.Mi limito a segnalare il più recente inter-vento a me noto sulla figura di Cleonenella commedia: M.G. Fileni, Commediae oratoria politica: Cleone nel teatro di Ari-stofane, in F. Perusino - M. Colantonio, Lacommedia greca e la storia. Atti del semi-nario di studio. Università di Urbino, 18-20maggio 2010, Pisa 2012, pp. 79-128.La traduzione impiegata nel testo è diG. Mastromarco, in Aristofane, Comme-die, I, Torino 1983, pp. 263-267.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 66
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 67
PERCORSI DIDATTICILIBERALI E NO
Spirito delle leggi, in cui è compendiata
una visione attenta alla c oncretezza
delle diverse vicende, all’insegna di un
razionalismo nutrito di osser vazioni
empiriche e verifiche sul campo. Come
ha rilevato Judith N. Shklar, «se è assur-
do sostenere che Montesquieu fu sul se-
rio uno scienziato naturale, è vero che
egli apprese dai biologi, e specialmente
dai testi di medicina, ciò che gli era ne-
cessario conoscere per sviluppare una
scienza dell’uomo come essere sociale»1.
Morirà a P arigi nel 1755, lasciando
una vasta opera che includeva anche un
Traité des devoirs (del 1725, purtroppo
andato perduto) e i Pensieri, redatti nel
corso degli anni e in cui sono riconosci-
bili alcuni dei tratti migliori dell’intel-
ligenza di questo studioso.
Tra pluralismo e relativismoLe Lettere persiane sono un testo di dif-
ficile classificazione. Redatto nella forma
di una conversazione epistolare tra due
viaggiatori iraniani, Uzbek e Rica, il
volume rappresenta una sapida critica
dei costumi francesi, specialmente no-
biliari. La scoperta di mondi estranei al
paradigma europeo, che aveva caratte-
rizzato l’esperienza di quanti avevano at-
traversato l’Atlantico per colonizzare le
Americhe, viene qui riproposta attraver-
so le ironie e i sarcasmi di un paio di stra-
nieri che descrivono la Francia settecen-
tesca mettendo in evidenza le innume-
revoli contraddizioni che caratterizzano
quell’universo sociale.
Lo spirito dei Lumi emerge a più riprese:
nelle critiche all’assolutismo, ai dogmi
della Chiesa cattolica, alle tradizioni.
Quella che viene proposta è una razio-
nalità duttile, venata di sc etticismo,
consapevole della necessità delle conven-
zioni e al t empo stesso indisposta a
considerarle come assoluti2.
LIBERALI E NOCarlo Lottieri
Montesquieu e la virtùdelle relazioni civili
NOTO SOPRATTUTTO PER LA TEORIA DELLA DIVISIONE DEI POTERI,MONTESQUIEU È AUTORE CHE SI CARATTERIZZA PER UNA VISIONE
ASSAI RAFFINATA DEL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E ISTITUZIONI, TRA CULTURA E COSTUMI, SUPERANDO IL RAZIONALISMO
GIURIDICO E APRENDO A UNA VISIONE PLURALISTA, LIBERALE
E TOLLERANTE DELLE RELAZIONI TRA GLI UOMINI.
Charles Sécondat, barone di Mon-
tesquieu, è stato uno degli inter-
preti più raffinati di quell’Illumi-
nismo francese (e filo-britannico) che
all’inizio del XVIII secolo cercò di rifor-
mulare in senso liberale le istituzioni po-
litiche dell’assolutismo e tentò di realiz-
zare, con gli strumenti della ragione, un
ripensamento generale della cultura del
tempo.
Nato nel 1689 a La Brède, poco distante
da Bordeaux, e indir izzato verso lo
studio del diritto, diventa magistrato nel-
la sua città e figura eminente di una no-
biltà della toga molto solida economica-
mente, in quanto attiva nella coltivazione
della vite e nel commercio del vino. Nel
1721 manda alle stampe in forma ano-
nima le Lettere persiane, che gli conferi-
scono presto una notevole fama inter-
nazionale (tutti riconobbero in lui l’au-
tore di quelle pagine) e che rappresen-
tano una straordinaria testimonianza dei
fermenti dell’epoca.
Il suo lavoro maggiore, ad ogni modo,
vedrà la luce solo nel 1748: si tratta dello
1. J.N. Shklar, Montesquieu (1987), il Mulino, Bologna1990.2. Rappresentativo di un atteggiamento equilibrato difronte alla religione è questo pensiero, che testimoniauna sensibilità non riconducibile all’ateismo libertino:«Cosa vuol dire essere moderati nei propi principi! InFrancia passo per avere poca religiosità, in Inghilterraper averne troppa» (Montesquieu, Pensées diverses, inOeuvres complètes, Firmin Didot, Paris 1854, p. 625).
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 67
L’idea di fondo è che bisogna saper va-
lorizzare quella creatività capace di far
interagire in termini positivi il rigore del
pensiero e la complessità del reale.
Nelle Lettere è cruciale l’affermazione di
una prospettiva relativista. In fondo, i
francesi appaiono strani agli occhi dei
persiani esattamente come i secondi lo
sono agli occhi dei pr imi. L’idea che
quello europeo sia il canone della civiltà
(politica, religiosa, civile ecc.) esce mal-
concio dalle analisi di questo scritto, se-
gnato da un’ironia corrosiva, sebbene ci
sia molto di occidentale (si pensi allo
stoicismo e poi soprattutto al cristiane-
simo) in questa for te affermazione di
una prospettiva universalista. In qualche
modo, la messa in discussione dell’eu-
rocentrismo è la pr emessa per quel-
l’aprirsi all’altro che può portare, lungo
percorsi inaspettati, a riscoprire alcuni
dei tratti più originari della stessa espe-
rienza europea.
L’universalismo si sposa con una forte
idea della naturale socialità degli uomi-
ni: contro ogni filosofia politica piegata
a proteggere le ragioni del potere statale.
Sono così di straordinario interesse le
pagine dedicate alla reinvenzione del
mito dei Trogloditi. Nelle lettere XI-XIV
Montesquieu rovescia il paradigma
hobbesiano nel momento in cui raccon-
ta la vicenda di questo popolo, che se-
condo Erodoto abitava l’Etiopia. A
lungo dominato da insocie volezza e
spirito aggressivo, per la sua incapacità
di riconoscere regole e limiti alla propria
azione, quel popolo africano si era pro-
gressivamente esaurito. La sua rinascita,
quando ormai non sopravvivevano che
pochi esemplari di tale etnia, si dovrà
all’azione di due uomini giusti, i quali
pongono le premesse per una vita civile
basata sulla saggezza, sul rispetto dell’al-
tro, su una certa forma di generosità. La
conclusione del racconto è particolar-
mente interessante, dato che venne il
giorno in cui «i Trogloditi credettero op-
portuno scegliersi un re; stabilirono che
si conferisse la corona a colui che era il
più giusto, e tutti posero gli occhi su un
vecchio venerabile per età e per antica
virtù». Questi però reagì mostrando sof-
ferenza, convinto che una società civile
non potesse essere dominata da un so-
vrano, e che le virtù e le buone relazioni
sociali possano molto di più del potere
e dell’autorità politica.
Nella condizione in cui vi trovate, senza un
capo, dovete essere virtuosi vostro malgra-
do; altrimenti non potreste sopravvivere
e cadreste nella sciagura dei vostri primi
padri. Ma questo giogo vi pare troppo
duro: preferite essere soggetti a un principe
e obbedire alle sue leggi, meno rigide dei
vostri costumi3.
La tesi cruciale è che la giustizia è assai
più il frutto delle virtù liberamente
adottate che delle legg i imposte dal
potere. L’insocievolezza del punto di
partenza hobbesiano non può essere su-
perata da un potere dispotico, ma solo
dallo svilupparsi di buoni c ostumi;
egualmente bisogna attendersi che an-
che questo tipo di società difficilmente
potrà durare a lungo, dato che gli uo-
mini sono spesso desiderosi di avere un
padrone e perdere la libertà.
A ben guardare, in Montesquieu appare
evidente una netta contraddizione tra
questo forte senso della realtà sociale –
che lo por ta a valor izzare il dir itto
quale prodotto spontaneo delle intera-
zioni umane – e, all’opposto, un certo
razionalismo che a più riprese si mani-
festa in taluni scritti.
Basti pensare a quella celebre formula
che vorrebbe il giudice quale bouche
de la loi (bocca della legge),4 nell’illu-
sione di superare ogni arbitrio e sog-
gettività grazie a un pr ocesso di de-
personalizzazione del magistrato che
lo porti ad essere un semplice esecu-
tore di quanto il sistema normativo
racchiude in sé.
Limitare il potere, costituzionalizzare la monarchiaQuando nel dibattito giuridico e politico
contemporaneo ci si riferisce allo studio-
so francese il più delle volte lo si ricorda
per la teoria della divisione dei poteri: per
quella sistematizzazione concettuale
che distingue tra esecutivo (il governo),
legislativo (le camere incaricate di redi-
gere le leggi) e giudiziario (il sistema dei
tribunali che sono incaricati di ammi-
nistrare la giustizia).
Questa sua tesi – che nello Spirito delle
leggi è illustrata in uno spazio molto li-
mitato – non è del tutto originale. In fon-
do, il francese recupera la tripartizione
che già era stato formulata da Locke, so-
stituendo al potere federativo (concer-
nente le relazioni internazionali) il
potere giudiziario. In Montesquieu l’idea
centrale è che debba esservi un sistema
di “pesi e contrappesi” o, in altre parole,
un meccanismo di controllo grazie al
quale ciascuno dei tre rami del sistema
istituzionale sia chiamato a esercitare una
limitazione degli altri due.
Si tratta, insomma, d’immaginare una
tecnologia volta a impedire l’assolutismo
e ad evitare il trionfo indiscusso e poten-
zialmente distruttivo per la vita sociale
di una volontà arbitraria. Quando a metà
del ventesimo secolo Hayek attaccherà
ciò che in Dicey viene definito il «potere
senza legge», è chiaro come lo studioso
austriaco si rifaccia soprattutto a Mon-
tesquieu: e non a caso egli sottolinea che
lo «scopo del movimento contro il po-
tere arbitrario era, fin dall’inizio, stabilire
il governo della legge»5.
Divisione dei poteri e principio di lega-
lità, fin dall’inizio, sono quindi stretta-
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX68
PERCORSI DIDATTICI
3. Montesquieu, Lettere persiane, XIV. Il passo mostra unaqualche assonanza con quello della Bibbia in cui Dio re-siste, mostrando sofferenza, di fronte alla richiesta degliIsraeliti di avere un re (1 Samuele, 8).4. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, libro XI, cap.5.5. F.A. von Hayek, La società libera (1960), Seam, Formello1996, p. 258.
LIBERALI E NO
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 68
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 69
mente connessi, e certamente nello Spi-
rito delle le ggi abbiamo in embr ione
quell’elaborazione concettuale che poi si
definirà nella teoria dello Stato di diritto
e, ancor meglio, nella teoria dello Stato
costituzionale di diritto6.
Ovviamente è impor tante evidenziare
come vi sia molto di irreale e perfino di
“ideologico” (in senso mar xiano) non
soltanto nell’idea della separ azione dei
poteri, ma ancor più nell’idea di un po-
tere che si autolimita. In merito al primo
punto Locke era stato molto chiaro
quando aveva affermato che una vera se-
parazione tra esecutivo e federativo era
nei fatti impossibile7. La stessa storia in-
glese – ma non diversa è la situazione in
altri contesti – non ha mai visto un ese-
cutivo autenticamente distinto dal legi-
slativo8 (per non parlare delle continue
interferenze tra esecutivo e legislativo, da
un lato, e giudiziario, dall’altro).
In termini più r igorosi va poi pr ecisato
come la scelta di restare all’interno del qua-
dro della sovranità statuale renda impos-
sibile quel plur alismo che il gener oso
progetto dello studioso di Bordeaux avreb-
be voluto salvaguardare. La sovranità è
strutturalmente unitaria – monolitica,
accentrata, verticistica – e non può certo
bastare una tripartizionale funzionale tra
gli organi in cui si articola lo Stato stesso
a creare un autentico ordine di libertà.
Di questo fu forse in parte consapevole lo
stesso Montesquieu, se si considera che
alla fine egli investì non molto sulla di-
visione dei poteri, mentre fu sempre un
deciso difensore delle autonomie locali:
a partire dalle libertà e dai privilegi della
sua Bordeaux, centro tradizionalmente le-
gato ai commerci e, grazie anche alle rotte
marine, alle città inglesi.
Sviluppare i commerci per favorire la paceNella principale opera dello studioso
francese, la riflessione sulla società e sul
rapporto che essa int rattiene con le
istituzioni si orienta in molte direzioni,
esaminando l’influenza del clima, della
religione, dei costumi e via dicendo. Al
centro dell’analisi vi è quell’esprit général
che può essere afferrato grazie a una let-
tura di quei rapporti effettivi, culturali
e socialmente situati grazie a cui una so-
cietà prende realmente forma. Contro
l’astratto razionalismo di tanti suoi
contemporanei, e seguendo un percorso
assai diverso rispetto a quello di Giam-
battista Vico, Montesquieu rigetta la mo-
dellistica del diritto ideale e, assunto l’uo-
mo quale è, cerca di cogliere la società
nel suo farsi effettivo.
È questa c oncretezza che lo por ta a
sviluppare importanti considerazioni sul
rapporto tra pace e commercio che sa-
ranno destinate a influenzare in profon-
dità la storia delle idee. Per Montesquieu
«l’effetto naturale del commercio è por-
tare la pace. Due nazioni che negoziano
tra di loro diventano reciprocamente di-
pendenti, se l’una ha un int eresse nel
comprare e l’altra nel vendere. E tutte le
unioni sono basate sui bisogni recipro-
ci»9. Mentre l’assolutismo spinge verso
politiche mercantiliste e di fatto autar-
chiche, egli auspica una crescente inte-
grazione economica tra le diverse realtà
e crede che tale processo possa allonta-
nare ogni ipotesi di conflitto.
La pace delle nazioni, ad ogni modo, è
solo una conseguenza di quello spirito
cooperativo che cresce con l’estendersi
delle relazioni di mercato. Nella stessa
parabola dei Trogloditi uno dei pr imi
passaggi che porta al disastro sociale sarà
la scelta di produrre unicamente per il
proprio consumo10. La chiusura econo-
mica è una componente cruciale dell’in-
socievolezza e dello spirito militaresco.
Neppure si deve scordare che l’intera ri-
flessione dello studioso francese poggiava
sulla tesi che «dove vi è il commercio, là
i costumi si addolciscono»11, rilevando
che l’intreccio di rapporti e interessi che
si trova al cuor e dell’universo degli
scambi favorisce lo sviluppo di interazio-
ni e accresce la cooperazione.
Uomo che aveva molto viaggiato, deci-
samente anglofilo (era anche vissuto in
Inghilterra), pronto a dialogare e aperto
al confronto con chiunque, Montesquieu
è l’interprete di un Illuminismo non an-
cora totalmente prigioniero del proprio
razionalismo ed è l’espr essione di una
Francia periferica, lontana dalle logiche
di corte e dai fasti parigini.
6. Su tali temi si veda: P. Costa - D. Zolo (a cura di), Lo statodi diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano 2006.7. «Sebbene, come ho detto, il potere esecutivo e il po-tere federativo di ogni comunità siano realmente di-stinti in se st essi, tuttavia essi possono difficilment eessere separati, e collocati, nello stesso tempo, nellemani di persone distinte. Infatti entrambi, nel loro eser-cizio, richiedono la forza della società, ed è quasi prati-
camente impossibile collocare la forza della comunitàpolitica in mani distinte e non subordinate l’una all’altra,o collocare il potere esecutivo e quello f ederativo inpersone che possono agir e separatamente, sicchè laforza del pubblico sarebbe collocata sotto comandi di-versi; il che potrebbe condurre un giorno o l’altro a cau-sare disordine e rovina» (J. Locke, Secondo trattato delgoverno civile, § 148).
8. Basti pensare, oggi, alla pratica dei decreti legge.9. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, libro XX, cap.2.10. «Lavorerò il mio campo solo per chè mi rifornisca ilgrano necessario a nutrirmi; una quantità maggiore misarebbe inutile; non mi affaticherò certo invano» (Letterepersiane, XI). Un passo che dimostr a la volontà di rinun-ciare, al tempo stesso, alla generosità e allo scambio.11. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, libro XX, cap.1.
Montesquieu, Lettres persanes -frontespizio della prima edizione (1721).
LIBERALI E NO
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 69
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX70
PERCORSI DIDATTICI
Rousseau e la coercizionesentimentale
NEL CONTRATTO SOCIALE JEAN-JACQUES ROUSSEAU RIGETTA LA CIVILTÀ, LA TEORIA LIBERALE QUALE LIMITAZIONE DEL POTERE, L’ECONOMIA DI MERCATO.ALL’INDIVIDUALISMO EGLI CONTRAPPONE UNA RELIGIONE CIVILE
CHE SAPPIA ESSERE IL COLLANTE DI UNA COMUNITÀ DEMOCRATICA
CHE ASSORBE IN SÉ OGNI COSA E COSTRUISCE L’UOMO NUOVO.
Difficilmente si potrebbe soprav-
valutare il ruolo storico di Jean-
Jacques Rousseau, che non sol-
tanto ha influenzato in profondità larga
parte del pensiero politico successivo – da
Kant a Marx – ma che pure ha imposto
un nuovo modo di concepire la società e
le istituzioni.
Romanziere e musicista oltre che filosofo
e pedagogista, Rousseau nasce il 28 giugno
1712 a Ginevra, dove ha un’infanzia piut-
tosto triste. La madre decede pochi giorni
dopo averlo messo al mondo e lo stesso pa-
dre, che muore quando Jean-Jacques ha
solo dieci anni, manifesterà nei suoi riguar-
di un’attenzione molto limitata. Dopo es-
sere stato valletto, segretario e insegnante
di musica12, nel 1755 dà inizio a una car-
riera intellettuale di straordinario successo,
vincendo il concorso indetto dall’accade-
mia di Digione con il Discorso sulle scienze
e sulle arti. Da quel momento entra in con-
tatto con i migliori ingegni del tempo: da
d’Alembert a David Hume.
A quello scritto fanno seguito il Discorso
sull’origine e sui fondamenti della disegua-
glianza tra gli uomini (1754), il Contratto
sociale e Emilio (entrambi del 1762), le
Confessioni, che inizia a scrivere nel 1764
e che usciranno (postume, in due tomi)
solo nel 1782 e nel 1789. Nel 1761 pub-
blica anche un romanzo, La nuova Eloisa,
che conosce un notevole successo.
Come ha scritto Romain Rolland, nella
Francia della seconda metà del diciotte-
simo secolo Rousseau «è l’annunciatore
della Repubblica. A lui si appella la Rivo-
luzione francese. La sua apot eosi ebbe
luogo durante l’apogeo della Convenzio-
ne. E fu Robespierre a decretare il trasfe-
rimento delle sue ceneri al Pantheon»13.
Dopo una serie di difficoltà – causate dal
radicalismo delle sue tesi – che lo portano
a lasciare la Francia e a prendere rifugio
pure in Svizzera, nel 1778 si r itira nella
campagna parigina, a Er menonville,
dove muore il 2 luglio.
Stato di natura e società civile Nel Discorso del 1750 che per la pr ima
volta lo impone all’attenzione generale,
Rousseau annuncia alcune tesi importan-
ti, che in qualche modo era già presenti
in qualche scritto precedente: a partire
dall’opposizione tra la felicità innocente
dello stato di natura e la civiltà moderna,
dominata da egoismo, insincerità, ano-
mia. La ci vilizzazione non ha quindi
aiutato l’uomo, dato che il cosiddetto pro-
gresso è – nella sua essenza – un fattore
di estraniazione dell’uomo dalla sua
vera natura.
Questi argomenti saranno ripresi e svilup-
pati nel secondo Discorso, del 1754, in cui
s’afferma che la causa cruciale del decadi-
mento è da riconoscere nella nascita della
proprietà privata. L’integrazione economica
che discende dalla divisione del lavoro fa
venir meno la natur ale socialità deg li
ordini comunitari primitivi. Per Rousseau
nella condizione originaria che precede la
proprietà, lo scambio e la divisione del la-
voro, la dispar ità delle condizioni «è
appena sensibile e la sua influenza è quasi
nulla»14. Solo in società gli uomini iniziano
a differire in profondità.
Il peccato originario “laico” che caratte-
rizza la cultura collettivista moderna
inaugurata dal Ginevrino consiste dun-
que nel dare vita a relazioni di mercato.
Ai suoi occhi, la proprietà è una creazione
artificiosa e illegittima, che muta l’animo
stesso dell’uomo. Mentre Montesquieu ri-
teneva che la società degli scambi favo-
risse una disponibilità a interagire con il
prossimo, a giudizio di Rousseau con l’av-
vento degli scambi gli uomini divennero
«avari, ambiziosi e cattivi»15. Lo stesso di-
ritto nasce solo a protezione dei possiden-
ti, allo scopo di congelare un ordine di di-
LIBERALI E NO
12. Maurras utilizzerà anche il fatto che Rousseau siastato costretto a fare molti mestieri per attaccarlo c onferocia: «Capace di tutti i mestieri, compresi i più disgu-stosi, di volta in volta lacchè e favorito, maestro di mu-
sica, parassita, mantenuto, si è istruito praticamente dasolo» (Ch. Maurras, Romantisme et révolution, NouvelleLibrairire nationale, Paris 1922).13. R. Rolland, Rousseau, Mondadori, Milano 1950, p. 7.
14. J.J. Rousseau, Discorso sull’origine e sui fondamentidella diseguaglianza tra gli uomini, parte I.15. Ibi, parte II.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 70
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 71
PERCORSI DIDATTICI
seguaglianza e negare la libertà naturale.
Alcune delle tesi fondamentali del socia-
lismo ottocentesco, a partire dalla con-
danna dell’occupazione originaria della
terra, sono già chiaramente formulate in
questo scritto:
Il primo che, avendo recintato un terreno,
ebbe l’idea di dire “questo è mio”, e trovò
persone abbastanza semplici per crederlo,
fu il v ero fondatore della società ci vile.
Quanti delitti, guerre, assassinii, quante
miserie e quanti orrori non avrebbe rispar-
miato al genere umano chi, strappando i
pioli e colmando il fossato, avesse gridato ai
suoi simili: “Guardatevi dall’ascoltare tale
impostore: siete perduti se dimenticate che
i frutti sono di tutti e che la terra non è di
nessuno.
Nella sua difesa delle comunità organiche
del passato e nel suo rigetto dell’individuo
indipendente, Rousseau inaugura logiche
collettiviste destinate – dopo di lui – a fare
molto strada.
Egli vede nello sviluppo della civiltà e dei
commerci una minaccia per le comunità
semplici e oneste. Nelle due lettere sulla
Svizzera che scrive nel 1763 quando è a
Neuchâtel – dove si è rifugiato per sfug-
gire alle persecuzioni suc cessive alla
pubblicazione dell’Émile – la tesi cruciale
è che le popolazione dei cantoni stanno
perdendo virtù e innocenza perché «han-
no cominciato a comunicare con le altre
nazioni, hanno pr eso il gust o a quel
modo di vivere e hanno voluto imitarlo;
si sono persuasi c he il denaro era una
buona cosa e hanno voluto averne»16.
È l’imporsi del mercato e delle libertà che
esso veicola a minare la felicità di quei
montanari. Come sottolinea Frédéric S. Ei-
geldinger, gli svizzeri «che Rousseau ha co-
nosciuto durante la sua g iovinezza non
sono più oggi questo popolo felice che vive
in autarchia: l’introduzione delle industrie
da parte dei rifugiati ugonotti ha creato la
divisione del lavoro»17.
Ad ogni modo, egli non avversa soltanto
la proprietà e il mercato, ma anche l’as-
solutismo monarchico difeso dai teorici
dell’origine divina del potere e, soprat-
tutto, da un autore come Hobbes. La sua
impresa dovrà quindi consistere nel di-
fendere in termini del tutto nuovi la so-
vranità, portandosi in terreni mai prima
esplorati.
La volontà generale e la “nuova democrazia”Per molti aspetti, Rousseau può essere con-
siderato all’origine del socialismo come
della democrazia e in quest o senso il
testo fondamentale è il Contratto sociale.
In quest’opera il Ginevrino non si pro-
pone affatto di riportare l’uomo ai tempi
del “buon selvaggio”, ma recupera un’idea
molto classica della politica – quella che
Constant battezzerà la libertà degli antichi
– per dare vita a istituzioni democratiche
destinate a porre al centro il cittadino18.
In questo senso, l’uomo della democrazia
prefigurata da Rousseau è davvero l’an-
titesi del borghese moderno, che si realizza
essenzialmente nelle pr oprie relazioni
familiari, sociali e lavorative.
L’obiettivo della nuova comunità politica
progettata dal Contratto sociale consiste
dunque nel restaurare un’umanità per-
duta a causa della civiltà e del progresso,
aiutando gli uomini a recuperare quella
condizione originaria che smarrirono
quando la proprietà privata venne a se-
parare i destini dei singoli e quand o la
logica dell’interesse privato si fece strada
all’interno delle r elazioni umane. At-
traverso il contratto sociale e l’ordine de-
mocratico che ne deriva, l’uomo ricon-
quista valori che aveva perduto:
ciò che l’uomo perde con il contratto sociale
è la sua libertà naturale e un diritto illimitato
a ciò che lo tenta e che egli può raggiungere;
ciò che guadagna è la libertà civile e la pro-
prietà di tutto ciò che possiede19.
La nozione cruciale, che permette a
Rousseau di garantire ordine e libertà (so-
vranità e autogoverno), è quella della vo-
lontà generale. In una società democratica
il destino non è stabilito da un re o da un
gruppo di governanti, e neppure da quel-
l’assommarsi delle singole volontà private
ed egoistiche che possono esprimersi nel
gioco elettorale dei sistemi rappresentativi.
Nella dinamica della democrazia emerge
infatti una volontà che trascende gli indi-
vidui e c he, per R ousseau, «è sempr e
retta» e di conseguenza infallibile.
Obbedire alla so vranità democratica
non comporta alcuna perdita di autono-
mia e per questo non ha senso pensare a
una limitazione del potere20.
Anche nella circostanza in cui si trovi a
“subire” una decisione che non si vorreb-
be, il contrasto è tra una volontà singola
fittizia (distorta) e quell’autentica volontà
che si esprime, appunto, nella volonté gé-
nérale21.
Se le cose stanno così, non c’è alcuna ra-
gione di delimitare l’area della sovranità
o della legislazione, dato che «la libertà
è obbedienza alla legge c he ci siamo
prescritta»22.
In un regime politico basato sul popolo
«ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a nes-
suno» e quindi l’area d’intervento del po-
tere può crescere a dismisura senza che
LIBERALI E NO
16. J.J. Rousseau, Lettres sur la Suisse (1763), a cura di F.S.Eigldinger, Slatkine, Paris 1997, p. 31.17. F.S. Eigldinger “Introduction” a J.J. Rousseau, Lettressur la Suisse, cit., p. 11.18. Nelle Confessioni egli afferma di avere imparato aleggere grazie alle Vite degli uomini illustri di Plutarco,che l’avrebbero iniziato alla grandezza della religione
civile degli Antichi.19. J.J. Rousseau, Contratto sociale, I, § 8.20. D’altra parte mentre Montesquieu è anglofilo, Rous-seau avversa l’ordine costituzionale britannico: «Il po-polo inglese pensa di essere libero, si sbaglia fortemente,lo è solo durante l’elezione dei membri del Parlamento:non appena sono eletti, esso è schiavo, non è niente. Nei
bei momenti di libertà, l’uso che ne fa gli fa meritare diperderla!» (Ibi, III, § 15).21. La sua tesi è che quando «l’opinione c ontraria allamia prevale, ciò non prova altro se non che mi ero sba-gliato, e che quello che reputavo essere la volontà ge-nerale non lo era» (Ibi, IV, § 2).22. Ibi, I, § 8.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 71
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX72
PERCORSI DIDATTICI
alcuno possa sentirsi meno liber o23.
Non è un caso, in questo senso, che i gia-
cobini abbiamo trovato proprio in Rous-
seau la propria principale fonte d’ispira-
zione.
A giudizio di Galvano Della Volpe, lo stes-
so debito del marxismo-leninismo nei ri-
guardi del Ginevrino è rilevante, dato che
gli argomenti di Rousseau in favore del-
l’uguaglianza «sono da annoverare tra le
essenziali premesse storiche e ideali del
concetto-modello dell’abolizione delle
classi in una società di liberi»24.
Non solo. Per la sua enfasi sulla comunità
egli ha in larga misura posto le basi del
Romanticismo politico e dei suoi esiti na-
zionalisti. Affermando il primato dell’or-
ganismo sociale nei riguardi dei singoli
individui, egli è poi un autore di riferi-
mento della tradizione comunitarista e
di quella repubblicana, per non parlare
del debito che una certa parte del pensie-
ro ecologista ha verso uno studioso che,
scandalizzando enciclopedisti e illumini-
sti, ha anteposto l’idillio del buon selvag-
gio all’artificiosa e gretta esistenza dell’uo-
mo moderno che si vuole civile.
Gli educatori della cittadinanzaCome è facile avvertire, la volontà generale
è una nozione che può essere afferrata solo
all’interno di un quadr o metafisico e,
verrebbe da dire, grazie alla guida della
fede. La stessa nozione di religione civile,
va detto, fu formulata proprio da Rous-
seau, il quale era persuaso che fosse neces-
sario mettersi sulle tracce dei Greci e dei
Romani, ridando una connotazione sacra-
le alle istituzioni politiche.
In Rousseau, l’importanza della pedagogia
ai fini della costruzione della filosofia po-
litica non può allora essere sottostimata.
Se la democrazia ha il compito di salvare
l’umanità dall’egoismo e dalla civiltà mo-
derna, quello che si prospetta è un compito
di ridefinizione della società che sia capace
di sottrarla alla pr opria imperfezione.
Per il Ginevrino, la nuova sovranità deve
proporsi di dar vita a un uomo nuovo, sen-
za porre limiti al proprio agire.
Colui che osa intraprendere l’istituzione di
un popolo deve sentirsi in grado di cambiare,
per così dire, la natura umana, di trasformare
ogni individuo che, per se stesso, è un tutto
perfetto e solitario, in una parte di un tutto
più grande, da cui questo individuo riceva
in qualche modo la sua vita e il suo essere25.
È sulla base di queste tesi che i rivoluzio-
nari francesi costruiranno la Repubblica
del Terrore e del la Dea Rag ione, ma
quella lezione seguiterà a essere molto in-
fluente anche in seguito. Nella Francia del-
la Terza Repubblica, le riforme del sistema
educativo introdotte da Jules Ferry sono
molto debitrici della lezione del Contratto
sociale e dell’Emilio, e non è certo sorpren-
dete che una tale impostazione abbia ge-
nerato un duro contrasto tra lo Stato fran-
cese e la Chiesa cattolica.
Come ha scritto Mona Ozouf, la scuola
di Stato costruita attorno al civismo dei
valori laici «insegna la Repubblica come
una forma che non si può mettere in di-
scussione, e quasi naturale, del politico.
(…) Il suo obiettivo e la sua vera funzione
sono quelli d’impregnare di valori repub-
blicani la coscienza del bambino»26.
In tutto ciò è proprio evidente l’eco delle
tesi di R ousseau, che arrivò a scr ivere:
«Aprendo gli occhi, un bambino deve ve-
dere la patria e fino alla morte non deve ve-
dere altro che lei. Ogni vero repubblicano
succhiò con il latte della madre l’amore del-
la patria, cioè delle leggi e della libertà. Il
suo essere è tutto in questo amore»27.
In un recente volume Kenneth Minogue
ha giustamente attribuito a Rousseau la
paternità del sentimentalismo, ricordando
– non senza una qualche ironia – come nel
ginevrino fosse for te la propensione «a
scoppiare in lacrime di fronte ai mali del
mondo»28. Ma vivere in termini emozio-
nali di fronte a categorie astratte conduce
a sacrificare la realtà concreta e questo, nei
fatti, apre agli esiti più nefasti.
In tal senso se Jean-Jacques Chevallier ha
parlato di assolutismo in rapporto alla vo-
lontà generale e ha evidenziato il forte le-
game con i fondat ori della so vranità,
Jacob L. Talom a sua volta ha evidenziato
come quel pensiero si diriga verso prospet-
tive tanto antiliberali da giustificare gli esiti
più inquietanti29. Non si può certo impu-
tare a un intellettuale morto dieci anni pri-
ma della Rivoluzione francese la ferocia del-
la ghigliottina o (addirittura) l’orrore dei
campi di sterminio del ventesimo secolo,
ma è pur vero che la progressiva erosione
dei principi liberali e il lungo processo di
discredito che essi conosceranno presso gli
intellettuali europei non sarebbe neppure
pensabile senza il fondamentale contributo
dell’autore del Contrat social.
Carlo Lottieri
Università di Siena
LIBERALI E NO
23. Ibi, I, § 6. D’altra parte, l’atto di associazione politica«produce un corpo morale e collettivo composto datanti membri quant e sono le v oci dell’assemblea, ilquale riceve da tale atto la sua unità, il suo io comune,la sua vita e la sua volontà» (Ibidem).24. G. della Volpe, Rousseau e Marx (1957), con la prefa-zione di Nicolao Merker, Riuniti, Roma 1997, p. 122.25. J.J. Rousseau, Contratto sociale, II, § 7.26. M. Ozouf, L’Ecole, l’Eglise et la République, Cana, Paris,p. 12. Un’eco delle tesi di Rousseau è evidente in Dur-kheim, secondo cui se lo Stato non operasse una strettavigilanza sull’azione pedagogica «la grande anima della
patria si dividerebbe e si comporterebbe in una molti-tudine incoerente di piccole anime frammentarie inconflitto tra loro» (É. Durkheim, Éducation et sociologie,Puf, Paris 1989, p. 59).27. J.J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement dePologne (1770-71) in Œuvres complètes, tomo terzo, Gal-limard, Paris 1964, p. 966. Una traccia di questa enfasisui sentimenti si ritrova anche nelle teorie di Rousseauin materia musicale, che in opposizione a Jean-PhilippeRameau esalta il carattere “naturale” della melodia ac-compagnata e anticipa lo stile neoclassic o, abbando-nando la complessità dello stile bar occo. Sul tema si
veda ad esempio: Y. Nairo, “L’unité de mélodie de Jean-Jacques Russeau”, The Bullettin of Kansai University So-ciety for the Study of French Language and Literature, 38(2012), pp. 117-141.28. K. Minogue, The Servile Mind. How Democracy Erodesthe Moral Life, Eincounter Books, New York 2010, p. 96.29. J.L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria(1952), il Mulino, Bologna 1967. Per una pr ospettivaassai avversa alle tesi di Talmon, si veda: L. Dulmont, Es-sais sur l’individualisme. Une perspective anthropologiquesur l’idéologie moderne, Seuil, Paris 1983.
NS5 50-73 percorsi:Layout 1 15-11-2012 15:38 Pagina 72
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX74
PERCORSI DIDATTICI
Alla scoperta dei Poliedri (I parte)Carmelo Di Stefano
LA GEOMETRIA DELLO SPAZIO VIENE AFFRONTATA RARAMENTE NEI CURRICOLA DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE. IN QUESTO LAVORO, USANDO IL SOFTWARE CABRI 3D®, PROPORREMO VARIE
ATTIVITÀ DIDATTICHE DI RICERCA CHE CI PERMETTANO DI SCOPRIRE I POLIEDRI. IN QUESTA PRIMA PARTE PARLEREMO DEI POLIEDRI IN GENERALE E DELLA COSIDDETTA FORMULA DI EULERO.
Iquesiti relativi ad argomenti di geo-
metria dello spazio si rivelano i meno
risolti e addirittura i meno tentati nei
test di ammissione alle U niversità, nei
quesiti di gare matematiche e in generale
in attività di diverso accertamento (In-
valsi, OCSE-PISA, …). Ciò è dovuto cer-
tamente alla loro intrinseca difficoltà,
poiché se è vero che viviamo in uno spa-
zio almeno tridimensionale è altrettanto
vero che la nostra immaginazione spa-
ziale è soprattutto bidimensionale. Non
è un caso che si è dovuto aspettare fino
al Rinascimento perché la prospettiva
potesse fornire un modo di rappresen-
tare lo spazio 3D su un supporto 2D. An-
cora oggi, in una società a t ecnologia
«fortemente invasiva» i tradizionali sup-
porti 2D di scrittura (quaderni, lavagne,
…) sono stati sostituiti con supporti più
evoluti ma ancora 2D (monitor, lavagne
multimediali, …).
Non vogliamo entrare in questioni psi-
cologiche o sociologiche che esulano dal-
le nostre competenze, ci limitiamo a os-
servare che la geometria tridimensionale
è difficile. Aggiungiamo che non voglia-
mo parteggiare per alcuna delle due pos-
sibili opzioni: la geometria tridimensio-
nale è difficile perché non è adeguata-
mente trattata nei diversi curricoli sco-
lastici o non è trattata perché è difficile?
Premettiamo che l’interesse primario
dell’articolo non è quello di una tratta-
zione rigorosa, tipica dei libri di testo, che
possa essere seguita da uno sparuto nu-
mero di studenti di alcuni li velli di
studio (licei Scientifici per intenderci),
quanto piuttosto quello di proporre al-
cuni suggerimenti che possano coinvol-
gere la maggioranza degli studenti di una
classe di un qualsiasi indirizzo, che tratti
o meno la cosiddetta «matematica forte».
Sarà perciò privilegiato un approccio in-
tuitivo e di scoperta e le costruzioni pro-
poste non saranno eccessivamente labo-
riose. Ciò significa che le «definizioni»
proposte avranno l’obiettivo di far com-
prendere di cosa stiamo parlando, non
certo quello di presentare gli oggetti con
il massimo rigore matematico. Il che vuol
dire che esse possono essere sicuramente
occasione di contestazione da parte del
lettore che predilige il rigore matematico.
Le attività presentate in questo lavoro,
nello stesso spirito di un precedente la-
voro sui tetraedri1, sono da effettuarsi
con l’ausilio di un ben noto software di
geometria dinamica: Cabri 3D®.
Tutte le costruzioni proposte negli arti-
coli possono scar icarsi come files Ca-
bri3d dal sito http://matdidattica.alter-
vista.org/Cabri3D.htm
Definizione di poliedroLa prima questione che deve risolversi è
cosa si intenda per poliedro. Procederemo
per analogia, partendo quindi dal corri-
spondente argomento di poligono affron-
tato nella più nota geometria bidimen-
sionale. Il poli gono rappresenta una
parte di piano delimitata da seg menti a
due a due consecutivi ma non adiacenti.
Il numero minimo di segmenti è tre e il
poligono così determinato viene detto
triangolo. Il poliedro sarà quindi una parte
di spazio delimitata da poligoni a due a
due con un lat o in c omune ma non
complanari. Tre poligoni non sono suf-
ficienti a racchiudere una parte di spazio,
ma ne necessitano quattro, tutti triangoli,
ottenendo così il poliedro formato dal nu-
mero minimo di poligoni, cioè il tetraedro,
di cui forniamo un esempio (ovviamente
costruito con Cabri 3D) in Figura 1.
1. Di Stefano C., Dal triangolo al tetraedro, «Nuova Se-condaria» numeri di Aprile, Maggio, Giugno 2010 e Gen-naio 2011. Figura 1
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 74
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 75
In ogni caso nei poliedri possiamo di-
stinguere i poligoni che li hanno deter-
minati, che chiamiamo facce, poi i lati
delle facce, che chiamiamo spigoli, e in-
fine i vertici delle facce, che chiamiamo
appunto vertici. Come per i poligoni an-
che per i poliedri possiamo distinguere
quelli convessi dai concavi. Un poliedro
è convesso se il piano che contiene una
faccia lascia tutte le altre facce nello stesso
semispazio. Per esempio il poliedro di Fi-
gura 2 non è convesso, perché il piano
che contiene il triangolo ABC «attraver-
sa» il poliedro.
Cominciamo ad osservare alcuni fatti,
validi per ogni poliedro convesso.
1. Ogni vertice è incontro di non meno
di tre facce e di non meno di tre spi-
goli.
2. In ogni vertice si possono incontrare
poligoni tali che la somma degli angoli
interni che hanno quel tale vertice in
comune sia inferiore a 360°.
Il tetraedro ci suggerisce un modo per
ottenere facilmente poliedri convessi
che, in linea teorica, hanno un numero
di facce a piacere. Basta tracciare un po-
ligono convesso di n lati sul piano ed
unire i suoi n vertici con un punto a pia-
cere esterno al detto piano. La figura ot-
tenuta si chiama piramide.
In effetti v i è anc he un alt ro modo
ugualmente semplice, sempre a partire
da un poligono convesso tracciato su un
piano, basta condurre da uno dei vertici
una retta a piacere che incontra un
piano parallelo al dato. Quindi tracciamo
le parallele a tali rette per gli altri vertici,
determinando così sull’altro piano un
poligono congruente al dato. Il poliedro
convesso che ha per vertici quelli di que-
sti due poligoni si chiama prisma.
Nei successivi paragrafi chiariremo altre
questioni.
La formula di EuleroConsiderando una generica piramide co-
struita su un poligono di n vertici, osser-
viamo che essa ha n+1 vertici (quelli del-
la base e quello est erno che a questi si
unisce), n+1 facce (la base e gli n trian-
goli ottenuti unendo il ver-
tice esterno con i v ertici
della base) e 2n spigoli (gli
n della base e g li n che
uniscono i detti vertici con
il vertice esterno). Osser-
viamo che
(n + 1) + (n + 1) – 2n = 2
Allo stesso modo osser -
viamo che per un generico
prisma costruito su due
poligoni di n vertici ciascuno, ha 2n ver-
tici (quelli delle basi), n + 2 facce (le due
basi e gli n parallelogrammi ottenuti
unendo i vertici corrispondenti dei po-
ligoni di base congruenti) e 3n spigoli (n
per ogni base e n che uniscono i vertici
corrispondenti). Stavolta avremo:
2n + (n + 2) – 3n = 2
La verifica effettuata su altri poliedri ci
suggerisce di ipotizzare, per ogni polie-
dro convesso, la validità della seguente
relazione:
V + F – S = 2.
Essa è nota come formula di Eulero, ed
è effettivamente vera per tutti i poliedri
convessi. La sua dimostrazione più nota
è dovuta a Cauchy, ma mette in gioco ar-
gomenti non svolti nei tradizionali corsi
di matematica delle secondarie superiori,
quindi preferiamo non presentarla.
Figura 2 Figura 3
Figura 4
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 75
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX76
PERCORSI DIDATTICI
Vogliamo vedere invece se essa valga an-
che per poliedri non convessi. Prima ri-
solviamo la questione della costruzione
di tali poliedri.
Pensiamo che l’unione non disgiunta di
due poliedri convessi conduca in gene-
rale a un poliedro non convesso. Con il
precedente termine intendiamo il fatto
che i due poliedri convessi abbiano al-
meno un punto in comune.
Per comodità di linguaggio nel seguito
chiameremo caratteristica di Eulero di un
poliedro la quantità V + F – S, i poliedri
euleriani hanno caratteristica di Eulero
uguale a 2; ogni altro poliedro ha ovvia-
mente caratteristica intera.
Poiché vogliamo stabilire se queste
nuove figure verificano la formula di Eu-
lero, ci int eressa risolvere la seguent e
questione: possiamo unire due poliedri
in modo che la caratteristica del poliedro
unione sia somma delle due caratteristi-
che dei poliedri unione? La risposta è po-
sitiva nel caso proposto dalla Figura 5,
in cui due tetraedri hanno in comune un
punto che è vertice di uno solo dei due.
La caratteristica di E ulero di quest o
poliedro è perciò
2 × 4 + 2 × 4 – 2 × 6 = 4.
Quindi abbiamo già un esempio di po-
liedro non convesso e non euleriano.
Vediamo altri esempi usando quel par-
ticolare prisma le cui facce sono tutti ret-
tangoli e che chiamiamo parallelepipedo
rettangolo. Adesso uniamo due paralle-
lepipedi in modo che non vi siano so-
vrapposizioni né di spigoli, né di vertici,
ma con una faccia di uno che è sovrap-
posta a par te di una fac cia dell’altro,
come mostrato in Figura 6.
Quanto vale la caratteristica di Eulero in
questo caso? I vertici e gli spigoli vengo-
no semplicemente a sommarsi, mentre
si viene a perdere una delle facce, quella
che «produce» la faccia non convessa del
poliedro unione. Ciò significa che la
quantità V + F – S verrà ad aumentare
di un’unità. Infatti nel nostro caso avre-
mo
(8 + 8) + (6 + 5) – (12 + 12) = 3
Pertanto abbiamo trovato un esempio di
poliedro non convesso per cui si ha
V + F – S = 3.
Se ripetiamo la precedente costruzione
con più parallelepipedi rettangoli, riu-
sciamo a ottenere qualsiasi numero in-
tero maggiore di 2. Per esempio il polie-
dro di Figura 7 ha caratteristica
4 (3 × 8 + 6 + 2 × 5 – 3 × 12).
Figura 5 Figura 6
Figura 7 Figura 8
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 76
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 77
PERCORSI DIDATTICI
Un altro modo di c ostruire poliedri
non convessi consiste nel far coincidere
solo un vertice, come mostrato nella Fi-
gura 8.
Nasce una prima interessante questione.
AC deve considerarsi un unico spigolo
o l’unione dei due spigoli AB e BC? Que-
sto è importante per calcolare la carat-
teristica di Eulero del poliedro.
Abbiamo detto che uno spigolo è un lato
di una faccia, dato che AB e BC appar-
tengono a facce diverse, possiamo con-
siderarli distinti, quindi in questo caso
nell’unione veniamo a perdere un ver-
tice, dato che B è comune a entrambi i
poliedri unione.
Quindi diminuiamo di 1 unità solamen-
te il numero dei vertici, e perciò avremo
ancora un poliedro di caratteristica 3
Figura 10A Figura 10B
Figura 11A Figura 11B Figura 11C
(2 × 8 – 1 + 2 × 6 – 2 × 12).
Possiamo invece fare coincidere un solo
spigolo, come mostrato in Figura 9.
Anche in questo caso AB e BC, così come
DE ed EF sono da considerarsi spigoli di-
stinti. Quindi in totale abbiamo perso 2
vertici (quelli che coincidono in B ed E)
e uno spigolo (BE). Ancora una volta la
caratteristica è perciò
3: (2 × 8 – 2 + 2 × 6 – (2 × 12 – 1)).
Consideriamo adesso il caso in cui uno
spigolo è sovrapposto ad un altro, senza
però che vi sia coincidenza fra gli spigoli,
con due possibilità come mostrato nelle
due Figure 10A e 10B. Con un vertice in
comune o senza vertici in comune.
Ancora una volta abbiamo qualche pro-
blema con gli spigoli. Stavolta BC è o no
uno spigolo? In entrambi i casi possiamo
considerarlo lato di una fac cia? No, è
parte della faccia superiore nella Figura
10A, quindi nel primo poliedro dobbia-
mo considerare lo spigolo AB, ma anche
lo spigolo AC come lato della faccia del
poliedro a destra; nel poliedro di Figura
10B invece avremo lo spigolo AB e lo
spigolo CD. In ogni caso nell’unione
non abbiamo «perdita» di spigoli, ma
solo di un vertice nel primo poliedro e
addirittura di niente nel secondo. Per-
tanto il primo poliedro ha caratteristica
3 e il secondo è invece euleriano. Possia-
mo poi considerare le varianti dei casi
precedenti con una faccia sovrapposta,
come mostrato nelle figure 11. Abbiamo
evidenziato alcune fac ce che devono
considerarsi nel computo. Pertanto in
Figura 11A, AB e BD non sono da con-
Figura 9
Figura 12A Figura 12B Figura 12C
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 77
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX78
PERCORSI DIDATTICI
siderarsi spigoli, perché non sono lati di
alcuna faccia, mentre GA, AC, CD e DF
sono spigoli. Lo stesso accade per il po-
liedro di Figura 11B, con AC e BD che
non sono spigoli e per il poliedro di Fi-
gura 11C, in cui AB non è spigolo.
Riproduciamo le figure precedenti can-
cellando appunto questi «non spigoli».
In conclusione in Figura 12A, perdiamo
il vertice B, 3 delle 6 facce del parallele-
pipedo più piccolo e 2 spigoli (AB e BD),
quindi nel complesso la somma delle due
caratteristiche dei poliedri: 2 + 2, diventa
4 – (1 + 3 – 2) = 2.
In Figura 12B, perdiamo i vertici A e B,
4 facce e 4 spigoli (AC, BD e AB due volte
perché in comune) perciò
V + F – S = 4 – (2 + 4 – 4) = 2. Infine in
Figura 12C, non perdiamo vertici, né spi-
goli, perché la perdita di AB è compensata
dal fatto che lo spigolo CD è sostituito da-
gli spigoli AC e BD. Perdiamo solo 2 facce,
quindi V + F – S = 4 – 2 = 2.
Quindi in ogni caso i poliedri così otte-
nuti sono euleriani.
Sovrapponiamo adesso un t etraedro
in modo che si possa avere in comune
un vertice senza avere per forza uno spi-
golo o una parte in comune.
In figura 13A, perdiamo una fac cia,
ma aumenta uno spigolo, CD si «sdop-
pia» in AC e AD, quindi
V + F – S = 4 – 1 = 3.
In Figura 13B, perdiamo 1 vertice e 1 fac-
Figura 13A Figura 13B
Figura 14A Figura 14B
Figura 13C
cia: V + F – S = 4 – (1 + 1) = 2.
Infine in Figura 13C, perdiamo 2 vertici,
1 faccia e 1 spigolo . ACBED non è
un’unica faccia, perché ACD e CDBE ap-
partengono a piani diversi. Perciò
V + F – S = 4 – (2 + 1 – 1) = 2.
Quindi a parte il primo caso che tutto
sommato coincide con quello già visto
per i parallelepipedi, gli altri poliedri
sono euleriani.
Perciò possiamo dire che aumenteremo
la caratteristica di un poliedro euleriano
solo sovrapponendone due in modo che
non abbiano vertici, spigoli o facce in co-
mune.
Come possiamo in vece diminuire la
caratteristica euleriana? Intuitivamente
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 78
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 79
PERCORSI DIDATTICI
pensiamo di effettuare un procedimento
inverso alla so vrapposizione, ossia la
creazione di una cavità. Vediamo se que-
sta sensazione corrisponde a realtà.
Nel primo caso il buco elimina solo una
faccia, nel secondo invece, «trapassando»
il poliedro, ne elimina 2. Non vi sono
perdite né di spigoli, né di v ertici,
quindi avremo rispettivamente una ca-
ratteristica di 4 – 1 = 3 e di 4 – 2 = 2.
Quindi la sensazione non era corretta.
In effetti per diminuire la caratteristica
di Eulero dobbiamo fare sì che V + F –
S complessivamente diminuisca più di
2 unità. L’idea è dovuta a Simon Lhuilier
(1750-1840)2, ed è il poliedro di Figura
15 che lo st esso Lakatos nell’opera
citata chiama portafotografie.
Infatti questo poliedro ha 16 vertici, 16
facce e 32 spigoli, quindi
V + F – S = 32 – 32 = 0.
Per la costruzione con Cabri 3D basta
creare un cubo e poi un cubo a esso in-
terno, nascondere quest'ultimo e c o-
struire perciò i tronchi di piramide, cia-
scuno dei quali rappresenta un «bordo»
del portafotografie, unendo i vertici dei
due cubi.
«Attaccando» due portafotografie co-
struiamo un poliedro a caratteristica ne-
gativa, – 2, come mostrato in Figura 16.
Non è difficile capire che l’aggiunta di
ulteriori «buchi» diminuisce di due
unità per buco la caratteristica euleriana.
Non approfondiamo ulteriormente la
questione, lasciando alla fantasia del do-
cente e dei suoi studenti la costruzione
di poliedri di caratteristica qualsiasi.
Nella prossima parte considereremo
particolari poliedri convessi, i cosiddetti
poliedri platonici o regolari.
Carmelo Di StefanoLiceo Scientifico «E. Vittorini», Gela (CL)
Figura 15 Figura 16
BIBLIOGRAFIA
L. Brusotti, Poligoni e poliedri, in «Enciclopedia delle matematiche elementari e complementi», a cura di L. Berzolari, G. Vivanti, D. Gigli,Volume II, parte I, Hoepli, Milano 1979T. Heat, A history of Greek Mathematics, Vol. II, Form Aristarchus to Diophantus, Dover, New York 1981.
2. Lakatos I., Proofs and refutations, Cambridge Univer-sity Press, 1976, p.19.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 79
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX80
PERCORSI DIDATTICI
Contributi di Bombelli alla nascita della Geometria analitica Carla Simonetti
IL MERITO E LE ORIGINI DELLA GEOMETRIA ANALITICA TROPPO SPESSO VENGONO FATTI
COINCIDERE IN MODO SUPERFICIALE E SBRIGATIVO CON IL MERO CONTRIBUTO DI CARTESIO. QUESTO SCRITTO CI PORTA E TROVARE LE TRACCE DELL’ITALIANO BOMBELLI
NELLA COSTRUZIONE DI QUESTA PARTE IMPORTANTE DELLA MATEMATICA.
Le poche notizie che si hanno sulla
vita di Rafael Bombelli (1526?-
1574?) sono dedotte dalle afferma-
zioni che lui stesso fa nel suo libro Alge-
bra in cui si definisce «cittadino bologne-
se» ed in effetti si è potuto accertare che
la famiglia Bombelli apparteneva alla no-
biltà del contado bolognese. Egli ci co-
munica inoltre di essersi occupato della
bonifica della Val di Chiana e di avere
composto la sua opera in un periodo di
sosta di questi lavori mentre era ospite
alla Rufina nella villa del vescovo di Melfi
che tale bonifica aveva ordinato.
Nel 1572 Bombelli pubblica i primi tre
libri della sua opera che trattano esclu-
sivamente di algebra. Nella prefazione
esprime il suo intento di rivalutare l’al-
gebra, fino ad allora non trattata come
vera scienza e le cui argomentazioni era-
no considerate valide solo se dimostrate
per via geometrica. Afferma: «ne meno
parmi necessario sia che si sforzi di far co-
noscere che la parte maggiore dell’Aritme-
tica (hoggi dal vulgo Algebra detta) tenghi
ella sola tra queste [le discipline matema-
tiche] il primato, perché di lei tutte l’altre
bisogna che si prevagliano, né già potriano
così l’Aritmetico come il Geometra senza
quella sciogliere i Problemi suoi e provare
le sue dimostrazioni1» e aggiunge: «mi son
posto nell’animo di voler e a per fetto
ordine ridurla, e dirne quanto dagli altri
è stato taciuto in questa mia presente ope-
ra, la quale, sì perché questa bella scientia
sii conosciuta, come per giovar a tutti, mi
son dato a comporre2». Con questa nuova
impostazione degli studi Bombelli apre
la porta a quel ramo della matematica
che sarà chiamato Geometria Analitica.
I numeri immaginariBombelli espone regole specifiche per ef-
fettuare operazioni con numeri negativi
e dà significato anche alle radici quadrate
di questi introducendo così i numeri che
noi chiamiamo immaginari. Chiama
più di meno l’unità immaginaria che noi
indichiamo con i, e meno di meno il suo
opposto -i e dà esplicitamente, anche per
questi nuovi enti, le regole per lo svol-
gimento delle operazioni:
«Più di meno via più di meno, fa meno
[ i . i = -1]
Più di meno via men di meno, fa più
[ i . (-i) = 1]
meno di meno via più di meno, fa più
[ -i . i = 1]
Meno di meno via men di meno, fa meno»3.
[ -i . (-i) = -1]
Lo storico della Matematica Bortolotti
scrive: «Qui, per la prima volta, si consi-
derano come enti aritmetici numeri im-
maginari, si rappresentano questi con sim-
bolismo opportuno al lor calcolo, e le leggi
di questo calcolo vengono effettivamente
poste, ...».4
Bombelli si muove in questo insieme nu-
merico ampliato con disinvoltura e ar-
riva a trattare i numeri che noi chiamia-
mo complessi.
Nel risolvere l’equazione di sec ondo
grado x2 + 20 = 8x trova la radice qua-
drata di 16-20 = - 4 e scrive: «4 + di - 2
over 4 - di – 2, e ciascuna di queste quan-
tità da sé sarà la valuta del Tanto»5.
Di fronte a somme tra numeri reali e ra-
dici quadrate di numeri negativi Bom-
belli si trova principalmente nel corso
della risoluzione di equazioni di t erzo
grado applicando la relativa formula sco-
perta da Scipione Del Ferro e utilizzata
da Cardano e Tartaglia. In tale formula
è presente la somma tra un numero reale
e un r adicale quadratico, ma pr oprio
quando l’equazione ha tre radici reali, il
1. R. Bombelli, L’algebra, Opera di Rafael Bombelli da Bo-logna, prima edizione integrale, Prefazione di E. Borto-lotti e U. Forti, Feltrinelli, Milano 1966, p. 7.2. Ibi, p. 8.3. Ibi, p. 133.4. Ibi, p. XXIX.5. Ibi, p. 201.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 80
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 81
radicale ha r adicando negativo; ciò
aveva messo in difficoltà i matematici
che avevano chiamato questo «caso ir-
riducibile».
Bombelli supera brillantemente lo sco-
glio e per compiere operazioni tra nu-
meri di questo tipo utilizza le regole pre-
cedentemente da l ui esplicitamente
esposte a proposito di «numeri composti,
come se fossero binomi» intendendo per
binomio «una quantità composta di dui
nomi aggionti insieme dissimili» e porta
ad esempio: «si dirà 6 + R.q.5 [6 + √5],
e questo si chiama Binomio, per essere un
composto di due quantità dissimili, essen-
do il numero R.q.5 di diversa natur a»6.
Le regole per operare con numeri di que-
sto tipo vengono chiarite con esempi e
possono essere applicate anche quando
il radicando è negativo.
Dare significato alle radici quadrate di
numeri negativi era una intuizione che
possiamo considerare estremamente
ardita se pensiamo che in quel momento
storico i numeri negativi in Europa ve-
nivano scartati sia c ome coefficienti
che come risultati delle equazioni ed era-
no chiamati numeri assurdi.
I libri geometriciIl manoscritto dei libri quarto e quinto,
libri geometrici che avrebbero dovuto
accompagnare i tre algebrici, sarà ritro-
vato nel 1923 presso l’Archiginnasio di
Bologna dallo storico della matematica
Bortolotti che pubblicherà l’opera com-
pleta; questi afferma che essi segnano «il
distacco tra l’algebra geometrica degli an-
tichi e la moderna Geometria Analitica»7.
In questi due libr i Bombelli espone
una geometria che si evolve adottando
tecniche algebriche e che chiama «alge-
bra linearia» in quanto si esprime attra-
verso segmenti. Egli procede nella riso-
luzione di problemi geometrici facendo
riferimento alla precedente trattazione
algebrica e «traducendo» nel linguaggio
geometrico i singoli passaggi seguiti in
ambiente algebrico.
I due rami della matematica assumono
pari dignità, operano secondo un reci-
proco sostegno, e c ostituiscono una
sorta di società di mutuo soccorso; at-
teggiamento questo che sarà alla base
della geometria analitica. Nella prefazio-
ne all’opera del Bombelli ristampata nel
1966, Forti scive: «...la validità della co-
struzione geometrica risulta dallo svolgi-
mento algebrico (e perciò logico) di cui essa
è la visibile interpretazione»8.
A chiusura del terzo libro Bombelli af-
ferma che Aritmetica e Geometria sono
l’una «la prova dell’altra» e l’altra «la di-
mostrazione dell’una» e che questo sarà
chiaro quando «l’una e l’altra mia opera
avranno veduta, ma perché non è ancora
ridutta a quella perfezione che la eccellen-
tia di questa disciplina ricerca, mi son ri-
soluto di volerla prima meglio considerare,
avanti che la mandi nel cospetto degli huo-
mini»9.
Bombelli muore poco dopo la pubbli-
cazione del suo libro, nulla sappiamo re-
lativamente a come avrebbe voluto ope-
rare sulla parte geometrica, ma già così
come ci è g iunta essa segna «quasi un
punto di passaggio, e talvolta una vera an-
ticipazione, della geometria analitica di
Cartesio».(Forti)10
Per realizzare una sorta di connubio tra
algebra e geometria, è necessario dispor-
re di una modalità di traduzione dei ri-
spettivi linguaggi. Bombelli pone le
basi per questo «dizionario».
Operazioni tra numeri -Operazioni tra segmentiNel capitolo primo del libro quarto
Bombelli, esprimendo attraverso proce-
dimenti geometrici le operazioni alge-
briche, introduce alcuni concetti che sa-
ranno basilari per la geometria analitica.
Egli espone come procedere per: Som-
mare di linee – Sotrare di linee – Molti-
plicare di linee – Partire di linee.
Introduzione del segno per i segmenti
Libro quarto – Capitolo primo
«Sotrare di linee. Il sotrare di linee non
è altro, che tagliare della maggiore una
parte pari alla minore, quando la minore
si ha da cavare della maggiore, et quello
che resta fuora del taglio sarà il restante;
ma se si harà a cavare la maggiore della
minore si farà il medesimo et quello che
resta sarà meno»11.
In questo modo Bombelli int roduce i
segmenti negativi. Dare il segno anche
ai segmenti è un passo che non sarà
compiuto neanche da Cartesio ma che
giustamente è proposto da chi in campo
algebrico aveva ampliato l’insieme nu-
merico dando significato alle radici
quadrate dei numeri negativi.
Introduzione del se gmento unitario
(Bombelli utilizza lettere minuscole per
indicare sia i punti che i segmenti)
Libro quarto – Capitolo primo
«Partire di linee. Il partire di linee non
si può fare se non è dato una comune mi-
sura; come sarebbe se si avesse a partire la
linea .a.e. per la .a.c., et non dicendo altro
non si possono partire, ma se si darà la .f.
per comune misura, ...»12.
6. Ibi, p. 65.7. Ibi, p. XXV.8. Ibi, p. XXII.9. Ibi, p. 476.10. Ibi, p. XXII.11. Ibi, p. 486.12. Ibi, p. 487.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 81
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX82
PERCORSI DIDATTICI
Bombelli stabilisce un segmento, che in-
dica con f, come unità di misura; traccia
i segmenti ae (dividendo) ed ac (diviso-
re) con il punto a in comune, prolunga
ac di un tratto cb uguale ad f. La parallela
a ce condotta per b incontra il prolun-
gamento di ae in g.
Per il teorema di Talete il rapporto tra ae
ed ac è il segmento eg.
Il segmento unità è usato dal Bombelli
anche nella parte algebrica della sua ope-
ra nel corso delle giustificazioni geome-
triche per le risoluzioni delle equazioni
di terzo grado.
Radice quadrata
Libro quarto – Capitolo primo
«A trovare il creatore in linee [creatore
radice quadrata]... il quale creatore
non patisce le difficoltà che pate nel nu-
mero; perché sempre si troverà il creatore
di ogni preposta linea, essendo nota la co-
mune misura,come per esempio sia la li-
nea .b.d. la quale sia 7 cioè sette volte la
linea .g. et che si detta linea se ne voglia
il creatore»13.
Sceglie un segmento come unità di mi-
sura e procede geometricamente appli-
cando i t eoremi che noi c hiamiamo
primo e secondo di Euclide.
Questo procedimento era già stato espo-
sto nel libro primo dove il segmento uni-
tario è stato introdotto: «Sia la linea .a.
una misura data per la unità, come sareb-
be palmo, piedi, braccia, o simili,...»14.
Potenze
Libro quarto – Capitolo primo
In questa proposizione Bombelli, prece-
dendo Cartesio, rappresenta con seg-
menti anche le potenze. Si tratta di un
passaggio fondamentale per tradurre in
forma geometrica le espressioni aritme-
tiche superando la loro rigida interpre-
tazione geometrica che portava, tra l’al-
tro, i matematici solo a trattare potenze
con esponenti inferiore a quattro e ad
esprimere solo somme t ra termini di
ugual grado.
Già nel libro secondo dei tre pubblicati
per la giustificazione del procedimento
di risoluzione di equazioni di terzo gra-
do, Bombelli aveva rappresentato il bi-
nomio x ( x2 + p ) con un rettangolo con
i lati aventi come lunghezza uno x e l’al-
tro la somma di due seg menti di lun-
ghezza rispettivamente x2 e p.
L’Algebra di Bombelli godrà di grande no-
torietà in tutta Europa, Leibniz affermerà
di avere basato proprio su questa opera
la sua preparazione matematica ed è pro-
babile che anche Cartesio la conoscesse.
Scrive Bortolotti: «non è quindi lecito che
a quest’ultimo [Cartesio] sia attribuito quel
passo che al dir degli storici costituisce così
essenziale progresso nella rappresentazione
analitica delle grandezze geometriche»15.
Dimostrazione della lunghezza delle di-
gnità essendo nota la cosa
Viene proposta la costruzione geometrica
delle successive potenze (dignità) di un
numero espresso attraverso un segmento:
«Essendo noto la valuta della Cosa rispet-
tiva a una misura data si può trovare in
lunghezza tutte l’altre dignità»16.
Bombelli indica il seguent e procedi-
mento.
Sia A il segmento unitario e α il segmento
di cui si vogliono determinare le potenze.
Si tracciano due r ette perpendicolari
mk ed no che si incontrano in un punto
a.
Si procede attraverso successive applica-
zioni del secondo teorema di Euclide.
In riferimento alla figura sia ab=A e ac
=α, si traccia il semicerchio che passa per
b e per c ed ha il c entro su mk, si
individua così il punto d su mk. Il seg-
mento ad è «la valuta del censo» (quadra-
to).
Si traccia il semicerchio passante per c e
d e avente il centro su no, si individua il
punto e su no, ae è il «cubo». Si procede
analogamente, si traccia il semicerchio
fed, af è il «Censo Censo» (quarta poten-
za), e così via.
ad Censo (α2)
af Censo Censo (α4)
ae Cubo (α3)
ag Censo Cubo (α5)
I Bourbaki scrivono: «Una volta scelta
l’unità di lunghezza, esiste una corrispon-
denza biunivoca fra le lunghezze ed i rap-
porti di grandezze, egli [Bombelli] defi-
nisce, sulle lunghezze, le diverse operazioni
algebriche (supponendo, si intende, fissata
l’unità) e, rappresentando i numeri con
13. Ibi, p. 488.14. Ibi, p. 41.15. E. Bortolotti, Lezioni di geometria analitica, Vol.I, Ed.Zanichelli 1923, p. XXXVII.16. R. Bombelli, L’algebra, cit., p.491.17. N. Bourbaki, Elementi di storia della matematica, Fel-trinelli, Milano 1963, p.153.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 82
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 83
PERCORSI DIDATTICI
le lunghezze, ottiene la definizione geome-
trica del corpo dei numeri reali (punto di
vista di cui spesso si attribuisce il merito
a Descartes) e dà così alla sua ‘Algebra’
una solida base geometrica»17.
Nelle Indicazioni nazionali per gli obiettivi
specifici di apprendimento per le Supe-
riori della n uova riforma, alla v oce
Aritmetica e algebra, tra le «competenze
attese a conclusione dell’obbligo di istru-
zione» troviamo: «utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo aritmetico e alge-
brico rappresentandole anche sotto forma
grafica».
Da Bombelli, come abbiamo visto, può
venire qualche interessante suggerimento
in tal senso.
Prima e dopo BombelliDobbiamo ricordare che la parte pub-
blicata dal Bombelli della sua o pera
era solo quella algebr ica nella quale,
come già osservato, sono però presenti
alcune di quelle intuizioni che saranno
alla base della geometria analitica e che
successivamente nei due libri geometrici
avrebbero trovato la loro specifica col-
locazione ed esposizione.
Manca, da parte del matematico bolo-
gnese, l’introduzione degli assi di riferi-
mento, che caratterizzeranno la geome-
tria di Cartesio (1596, 1650); questi, in
linea con il greco Apollonio (262?, 190?,
BIBLIOGRAFIA
G. Loria, Storia delle Matematiche, Hoepli, Milano 1950.S. Maracchia, Storia dell’algebra, Liguori Editore, Napoli 2005.
a.C.), riferirà ciascuna curva analizzata
ad una semiretta (ascisse), opportuna-
mente individuata per og ni specifico
caso, ai cui punti sono «ordinatamente
applicati» segmenti paralleli tra loro
(ordinate). Ciò permetterà a Cartesio di
esprimere attraverso equazioni algebri-
che le proprietà delle varie curve.
Ma il filosofo e matematico francese, al
contrario di Bombelli, non apre all’idea
di dare un segno anche ai segmenti e
tratta solo c oordinate positive. Sarà
Eulero, nel 1748 nella sua opera Intro-
ductio in Analiysin Infinitorum, ad assu-
mere come assi coordinati due rette in-
cidenti non dipendenti dal particolare
problema trattato e a cui si riferiscono
tutti i punti del piano alle coordinate dei
quali viene così assegnato il segno.
Carla Simonetti Mathesis Firenze
R.Bombelli, Algebra, Bologna 1579.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 83
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX84
PERCORSI DIDATTICI
La fisica – come e più di ogni altra
scienza – ha bisogno, lo di sa,
della matematica per esprimere
in forma precisa e compatta le conclusio-
ni teoriche cui via via perviene. È fin trop-
po noto che già Leonardo da Vinci avver-
tiva che «nissuna umana investigazione si
pò dimandare vera scienzia s’essa non pas-
sa per le matematiche dimostrazioni».
Necessità della matematicaAnche solo per esprimere ed applicare le
leggi elementari della Meccanica, la fisica
ebbe bisogno del calcolo infinitesimale,
la cui costruzione cominciò con la Scuola
di Galileo («calcolo delle flussioni») e
continuò con Newton e Leibniz. Da
allora le equazioni differ enziali (ma
anche quelle alle differenze finite) non
hanno più lasciato la fisica. Lo stesso si
può dire per il calcolo vettoriale e tenso-
riale, tanto in fisica classica che in Rela-
tività Speciale e in T eoria dei campi
quantizzati. Ed è noto che l’algebra ten-
soriale, insieme con le geometrie non eu-
clidee, ha poi trovato un ambiente ideale
nella Relatività Generale. Non dimenti-
chiamo inoltre che il calcolo variazionale
(con il formalismo lagrangiano e hamil-
toniano) ha in un certo senso permesso
il passaggio dalla meccanica classica alla
Meccanica Quantistica; mentre la Teoria
dei Gruppi ha svolto e svolge un ruolo da
regina, per esempio, in fisica delle par-
ticelle fondamentali (nel 1929 Ettore Ma-
jorana scriveva all’amico Giovannino
Gentile: «...studio la teoria dei gruppi con
la ferma intenzione di impararla, simile
in questo a quell’eroe di Dostoievski che
un bel giorno cominciò a mettere da par-
te qualche spicciolo, con la persuasione
di diventare presto ricco quanto Ro-
thschild»). Naturalmente anche altre
algebre, come quelle di Clifford, hanno
svolto e svolgono una funzione fonda-
mentale.
Nella fisica di oggi trovano applicazione
quasi tutti i rami delle matematiche, dallo
studio degli Spazi fibrati alla Topologia:
e la fisica non può farne a meno. Senza
dimenticare che una par te notevole
delle attuali ricerche in fisica e nei rami
della scienza ad essa collegati non potreb-
bero procedere senza le tecniche di com-
putazione numerica e algebrica. I calco-
latori elettronici sono essenziali per ese-
guire complicati calcoli algebrici (ad
esempio in Fisica delle particelle elemen-
tari e in Relatività Generale), ed ancor più
per analizzare masse enormi di compli-
cati dati sper imentali o per r isolvere
equazioni e sistemi di equazioni non trat-
tabili con l’Analisi; su questo versante
sono essenziali l’Analisi Numerica, l’Ot-
timizzazione, e in generale tutte le tec-
niche informatiche.
A questo punto sarebbe interessante
considerare alcuni casi in cui la matema-
tica stessa, attraverso le sue soluzioni, ha
suggerito e suggerisce l’esistenza di nuovi
campi di indagine naturale. È infatti de-
gno di nota, anche dal punto di vista fi-
losofico, che le varie soluzioni fornite dal-
la matematica (spesso sovrabbondanti ri-
spetto a quelle previste dal fisico) corri-
spondono quasi sempre a realtà esistenti
in natura! Qui ricorderemo solo che al-
cuni «doppi segni» (più e meno) presenti
nelle soluzioni fornite dalla matematica
in vari problemi, e apparentemente ba-
nali, hanno in realtà: (a) suggerito, in
Meccanica Quantistica, l’esistenza di
fermioni e bosoni; (b) mostrato come la
Relatività Speciale già dal 1905 prevedeva
l’esistenza dell’antimateria, oltre che
della materia; (c) suggerito che la stessa
Relatività Speciale possa essere estesa ad
includere onde ed oggetti più v eloci
della luce... Dopo questo breve elenco,
preferiamo passare a considerazioni più
generali su fisica e matematica.
1.Work partially supported by INFN and CAPES: the au-thor is presently visiting as PVE the DMO/FEEC/UNI-CAMP and acknowledges H.E.Hernandez-Figueroa andC.Castro’s hospitality. He also thanks G.Battistoni, E.Gian-netto, G.Maccarini, G.Marmo, S.Paleari, P.Pizzochero,P.Riva for stimulating discussions and kind interest; andis grateful to G.Bertagna, M.G.Pesci and F.Baresi for invi-ting this paper.2. [email protected] ; www.unibg.it/recami
Matematica e FisicaErasmo Recami 2
LA MATEMATICA, PRODOTTO INTERNO DEL CERVELLO UMANO, CI PERMETTE DI DESCRIVERE E MEGLIO COMPRENDERE LA NATURA FISICA ESTERNA A NOI. DALLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ ALLE STRAORDINARIE COINCIDENZE NUMERICHE
GIÀ NOTATE DA WEYL, EDDIGTON E DIRAC.
1
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 84
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 85
PERCORSI DIDATTICI
Se ripensiamo alla struttura dell’universo
materiale, e alla vertiginosità delle sue
dimensioni, sia nella dir ezione del
macro sia nella direzione del micro, dob-
biamo riconoscere che la realtà ha su-
perato come sempre la fantasia; il rap-
porto tra il raggio del cosmo e il raggio
di un protone (uno dei numeri fonda-
mentali più grandi che si incontrino in
natura) risulta per esempio di circa
1040: un uno seguito da quaranta zeri.
E tale uni verso fisico, a par tire dal
mondo subatomico e su, attraverso la
complessità degli organismi v iventi,
fino agli ammassi di galassie dispiega
non solo un’incredibile varietà di forme,
ma anche un mirabile ordine. Einstein
ha lasciato scritto: «II fatto che la totalità
delle nostre esperienze sensoriali sia tale
che mediante il pensiero essa può venire
ordinata, ci lascia pieni di stupore...
L’eterno mistero del mond o è la sua
comprensibilità».
Quasi non ci si meraviglia più della stra-
ordinaria eleganza delle leggi fisiche che
soprintendono alla materia, man mano
che esse vengono scoperte e precisate,
soltanto perché ci si è abituati a trovare
la natura sempre regolata da principi
matematici reconditi, sì, ma semplici.
Già se ne erano avveduti Keplero, Galileo
e Bruno, i quali condividevano con gli
antichi pitagorici la convinzione che il
cosmo fosse ordinato secondo le più alte
e perfette leggi razionali matematiche. La
stessa matematica va costruendo con le
sue architetture logiche un g randioso
universo razionale che si sviluppa paral-
lelamente a quello che viene rivelandosi
all’indagine naturale. E ciò non è dovuto
solo al fatto che le teorie matematiche,
come ha chiarito Göedel, si evolvono in
modo simile a quello delle teorie fisiche...
Di fronte al mondo naturale, che sembra
presentare una inesauribile serie di sca-
tole cinesi sia all’ingiù, verso il microsco-
pico, sia all’insù, verso il macrocosmo, ci
si chiede se tali serie incontrino dei
limiti; analogamente, la matematica ha
sempre lottato col problema dell’infini-
tamente piccolo e dell’infinitament e
grande: da Zenone di Elea a C avalieri,
Torricelli, Galileo, Newton e Leibniz, da
Archimede a Peano, Cantor, Russell e Co-
lien. Si può anzi dire che la matematica
è per gran parte scienza dell’infinito, suo
fine precipuo essendo la comprensione
simbolica dell’infinito con strumenti
umani, vale a dire finiti.
D’altronde la scoperta del cosiddetto «in-
finito potenziale», che come diceva Lucio
Lombardo Radice è una delle meraviglio-
se conquiste intellettuali che facciamo
spontaneamente nell’infanzia, la fac-
ciamo sia a livello propriamente mate-
matico, pensando di aggiungere sempre
«uno» nel contare, sia meditando sulla
realtà: per esempio , la diffic oltà di
pensare una fine dello spazio, una bar-
riera dopo la quale non ci sia nuovo spa-
zio, è una delle vie naturali che condu-
cono alla conquista della specifica cate-
goria mentale di infinito potenziale.
Caratteristiche esclusive dell’arte mate-
matica sono il suo rigore razionale e la
sua certezza logica. Già Platone diceva
esistere nella matematica qualcosa di ne-
cessario e, se non er ro, di nec essità
divina.
Gli fa eco, più esplicitamente, Russell: la
contemplazione di ciò che non è umano,
la scoperta che la nostra mente è capace
di analizzare ciò che è fuori di noi, la per-
cezione che la bellezza appartiene tanto
al mondo esteriore quanto a quello in-
teriore, sono mezzi potenti per superare
il senso di debolezza ed esilio in mezzo
alla quasi onnipotenza delle forze ester-
ne. «Ma», aggiunge Russell, «la matema-
tica ci porta nella regione della necessità
assoluta, alla quale deve conformarsi non
solo il mondo reale, ma ogni mondo pos-
sibile […].
Per la maggior parte degli uomini la vita
effettiva è una l unga mediocrità, un
perpetuo compromesso tra l’ideale e il
possibile; ma il mondo della pura ragione
non conosce compromessi, né limitazioni
pratiche, né barriere all’attività creativa
Foto di gruppo dei fisici più famosie importanti di inizioNovecento alla Conferenza di Solvaysulla Meccanica Quantistica (1911).
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 85
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX86
PERCORSI DIDATTICI
che realizza nei suoi splendidi edifici l’ap-
passionata aspirazione al perfetto dalla
quale sorgono tutte le grandi opere».
Interrogativi apertiCiò vuole dire che tutto della natura ci
è cristallinamente chiaro, dalle particelle
subnucleari ai modelli c osmologici?
Non è certo così. Come amava asserire
il grande fisico-matematico Hermann
Weyl, tutta la scienza, e in primo luogo
la fisica e la matematica, ci fanno apparire
il creato sempre più come un mondo
aperto: «La scienza non può fare altro che
mostrarci un or izzonte aperto...». O,
per citare ora la frase di uno scr ittore,
Franz Werfel, «Il mondo non è solo
questo mondo». La stessa vitalità di un
settore della fisica si misur a più dai
problemi nuovi che sa porre, che non dai
problemi vecchi che risolve. E l’argomen-
to del micro e del macro, su cui abbiamo
fissato la nostra attenzione, spalanca le
porte a molti interrogativi. L’uomo ha
pensato dapprima che l’«universo» fosse
la sua vallata, poi l’intera Terra, poi il Si-
stema Solare, poi la Via Lattea. È or a
un’analoga ingenuità credere che il
nostro cosmo esaurisca l’universo del-
l’esistente? E se così è, esistono per caso
delle simmetrie per cui i car atteri del
creato si possono leggere in ogni suo
frammento? La c ostante presenza di
questi interrogativi al nost ro animo
spiega perché abbia avuto a suo tempo
tanto successo tra il pubblico l’appros-
simativo modello che assimilava ogni
atomo al sistema solare.
Il vangelo secondo Higgs
Ora che gli entusiasmi e il clamore per il bosone di Higgs si
sono calmati è forse possibile fare una riflessione più distesa sul
significato di questa scoperta e, in particolare, sulla sua valenza
«teologica»-filosofica, sintetizzata dalla definizione con cui i me-
dia hanno presentato il bosone st esso, ovvero la «particella di
Dio».
Insomma: c’è un qualche rapporto tra il bosone di Higgs e il di-
vino? È una scoperta che avvicina l’uomo alla contemplazione
di Dio?
Basterebbe sapere da dove nasce il nome «particella di Dio» per
ridimensionare gli entusiasmi dei credenti riguardo la scoperta,
presentata al Cern di Ginevra intorno al bosone di Higgs. L’appel-
lativo, come ormai è noto, deriva da una efficace scelta editoriale:
quando Leon Lederman presentò alla casa editrice, la Dell Publi-
shing, il manoscritto in cui raccontava la sua ricerca fisica e le dif-
ficoltà di trovare sperimentalmente la par ticella teorizzata da
Higgs, voleva chiamare quel bosone the Goddamn Particle, ov-
vero la «particella maledetta» (proprio perché non era possibile
dimostrarne l’esistenza). L’editore propose il più suggestivo
«particella di Dio», e quel nome rimase, diventando la definizione
più nota al grande pubblico del bosone in questione. Il tutto
sembra nascere da un (voluto) equivoco linguistico. In realtà se
prendiamo l’icastica dicitura «particella di Dio» come metafora
per indicare l’importanza che il bosone di Higgs ha per la teoria
fisica sulla materia e l’universo, la scelta della Dell Publishing si
rivela, per uno di quei casi di s erendipità di cui la st oria della
scienza è ricca, abbastanza corretta.
La verifica sperimentale dell’esistenza della particella che Higgs
teorizzò, infatti, permette di confermare un aspetto centrale del
Modello Standard, la teoria fisica unificata sulle particelle ele-
mentari le cui basi furono gettate circa 50 anni fa. Il bosone di
Higgs spiega l’esistenza della materia e quindi il comportamento
della realtà nell’universo osservabile. Ma proprio questa sua im-
portanza e questa sua natur a quasi «divina» (spiega nascita e
leggi del mondo fisic o) ribadiscono, paradossalmente, quanto
poco la teoria di Higgs avesse e abbia tuttora a che fare con l’am-
bito del sacro.
Per spiegare questo paradosso bisogna ricordare quanto diceva
Aristotele. Nella sua indagine sulle cause del movimento e della
sostanza il filosofo di Stagira distingueva tra causa materiale, fi-
nale, formale ed effic iente. La causa efficient e può essere de-
scritta come la forza che produce un cambiamento nella realtà,
quella materiale la realtà sulla quale tale forza agisce, quella
formale la forma che l’azione efficiente produce sulla materia e
Queste domande hanno via via acquista-
to una veste scientifica, specialmente da
quando Weyl, Eddington, Dirac e altri
hanno cominciato a rilevare importanti
coincidenze numeriche, note come «re-
lazioni tra i grandi numeri», che sembra-
no proprio correlare i microcosmi sub-
nucleari (cioè le particelle dette adroni)
all’intero nostro cosmo. Ricordiamo che,
mentre il cosmo è governato dall’intera-
zione gravitazionale, i protoni, i neutroni
e le alt re particelle costituite da quark
sono invece governati dalla cosiddetta
«interazione forte». L’interazione gravi-
tazionale è sbalorditivamente più debole
di quella forte; quest’ultima è circa 1040
volte più «intensa» della prima. La coin-
cidenza numero uno è c he tale valore,
dieci elevato alla quarantesima potenza,
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 86
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 87
PERCORSI DIDATTICI
quella finale lo scopo al quale l’intero processo tende; nell’esem-
pio classico uno scultore è la causa efficiente che si esercita sul
marmo come
sua materia comunicando a quest’ultimo una forma con lo
scopo di creare un oggetto bello o di conseguire fama per
mezzo dell’opera d’arte (ma nell’ambito dei processi naturali
forma e fine spesso coincidono).
Le scienze «dure», come la fisica, si occupano unicamente delle
questioni relative alla causa materiale ed efficiente e non dicono
nulla, in quant o scienze, sull’aspetto finale e f ormale dell’esi-
stente; la moderna fisica, con Galilei e Newton, nasce proprio
come rifiuto di quelle ricerca sullo scopo e la natura intrinseca
del reale che caratterizzava la precedente analisi della filosofia
della natura. Le questioni formali-finalistiche rappresentano il
campo di indagine della filosofia e della religione; metodologi-
camente il compito dell’indagine sul sacro e la forza della rive-
lazione divina (per coloro che vi credono) sta nel fornire risposte
(spesso aporetiche e spiazianti) sulle questioni dello scopo e
della natura intrinseca delle cose, prima fra tutte l’uomo. Un’ana-
loga distinzione tra campi di indagine e metodologie di ricerca
è proposta da Kant, il quale distinguendo int elletto e ragione,
pone la differenza tra l’indagine scientifica sul mondo (legata
all’ambito empirico e retta dalle categorie dell’intelletto) e la ri-
cerca di dottrine universali che possano fornire all’uomo una sin-
tesi ultima, una visione c omplessiva, appunto le idee della r a-
gione (anima, mondo e Dio). La v oce più lucida nel ’900 c he
ribadisce tale distinzione di campi di studio e questioni su cui in-
dagare è quella di Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein osservava
dolorosamente che il mondo dei fatti, collegati tra loro in modo
casuale e capace di decidere della verità delle proposizioni lin-
guistiche, non ospita né valori né verità ultime; purtroppo pro-
prio di queste cose, le più importanti, l’uomo è quindi costretto
a tacere, in quanto sottratte alla costruzione di un sapere logico-
empirico, verificabile.
Ecco che il paradosso sul bosone di Higgs è spiegato. Se la sco-
perta del Cern rappresenta una conquista teorica veramente così
importante, in quanto verità scientifica, essa, proprio nella sua
epocalità, non ha e non può a vere a che far e nulla con Dio, in
quanto ci parla solo di causa efficiente e di materia, di intuizioni
empiriche e categorie dell’intelletto, di stati di fatti e proposizioni
del linguaggio. Dio se ne sta altrove, nascosto oltre i fatti o tra di
essi, ma mai cosa tra le altre cose del mondo.
Francesco PaparellaIULM Milano
è uguale - come ricorderemo - al rappor-
to tra raggio del cosmo e raggio degli
adroni (di un pr otone, ad esempio).
Coincidenza numero due: la durata ca-
ratteristica della vita del nostro macro-
cosmo gravitazionale è multipla di quella
degli adroni secondo il medesimo rap-
porto! Coincidenza numero tre: la massa
del cosmo è circa 1080 volte (cioè 1040,
al quadrato) quella di un protone. E così
via. Tutto ciò non è spiegato dalla Rela-
tività Generale: esula dalle teorie esisten-
ti.
Queste coincidenze numeriche suggeri-
scono invece che cosmo e adroni siano
oggetti finiti e simili. Tutte queste «rela-
zioni fra grandi numeri» si possono
spiegare se si assu me che gli adroni
siano grosso modo ottenibili contraendo
un intero cosmo come il nostro proprio
di un fattore 1040. Protoni e neutroni sa-
rebbero, per intenderci, dei micro-uni-
versi...
E dunque, anche il nostro universo è una
particella di qualche super-universo?
Qui siamo ai confini della scienza attuale,
che non può rispondere; anche se già si
comincia a parlare delle proprietà del co-
smo come di un tutto unico.
È necessario, a questo punto, fermarsi.
Siamo tentati però di concludere ricor-
dando ancora le par ole di H ermann
Weyl: «Molta gente pensa che la scienza
oggi sia lontana da Dio . A me pare, al
contrario, che per una persona colta sia
molto più difficile avvicinarsi a Dio a par-
tire dalla storia e dal lato spirituale del
mondo; qui, infatti, sperimentiamo la
presenza della sofferenza e del male, ed
è difficile armonizzarla con un Dio mi-
sericordioso e onnipotente... Ma nella no-
stra conoscenza dei fenomeni fisici, i pro-
gressi sono stati tali che ne possiamo ot-
tenere la visione di una perfetta armonia.
Qui non esistono né sofferenza né male,
ma solo per fezione. Nulla impedisce
che noi, in quanto uomini di scienza,
prendiamo parte all’adorazione cosmica
che trovò espressioni così potenti nel più
illustre fra i poemi in lingua t edesca, il
canto degli arcangeli all’inizio del Faust
di Goethe.»
Erasmo RecamiINFN - Sezione di Milano,
Università degli Studi di Bergamo
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 87
Parte I: l’effetto fotoelettricoCome è noto materiali quali l’ambra, il
vetro, la plastica, la ceralacca, l’ebanite,
ecc., se st rofinati con un panno di
lana, acquistano la proprietà di attrarre
corpi leggeri come piccoli pezzetti di
carta. Si dice che nello st rofinio una
bacchetta composta da uno dei mate-
riali sopra elencati è stata elettrizzata o
caricata di elettricità.
Le evidenze sperimentali mostrano
l’esistenza di due distinti stati di carica
elettrica. Seguendo la t radizione, la
stragande maggioranza dei manuali
utilizzati nelle scuole li chiamano elet-
tricità positiva ed elettricità negativa:
più specificatamente vengono definiti
carichi di elettricità positiva i corpi che
si comportano come il vetro e carichi
di elettricità negativa quelli che si
comportano come la plastica. Tuttavia
è doveroso specificare che i termini po-
sitivo e negativo in realtà sono assolu-
tamente convenzionali. Se ai fini dello
studio delle interazioni elettriche non
fa alcuna differenza definire i due stati
di carica con due termini distinti, quali
essi siano, la differenza non è assoluta-
mente irrilevante nel momento in cui
diventa determinante conoscere esatta-
mente il segno delle cariche elettriche
coinvolte in un esperimento.
Supponiamo, ad esempio, di voler stu-
Fare chiarezza: elettrizzazione ed effetto fotoelettricoFausto Bersani Greggio, Corrado Bernabè
LA DISCRASIA PRESENTE IN MOLTI TESTI TRA TEORIA E LABORATORIO È ASSAI MARCATA, CONTRAVVENENDO
GRAVEMENTE ALLO SPIRITO DELLA FISICA CHE, PER DEFINIZIONE, È UNA SCIENZA SPERIMENTALE. IN QUESTO ARTICOLO SI CERCA DI FARE CHIAREZZA SUL TEMA DELL’ELETTRIZZAZIONE UTILIZZANDO, OLTRE AGLI STRUMENTI CLASSICI, UNA VERSIONE QUALITATIVA DELL’EFFETTO FOTOELETTRICO ARRIVANDO
POI A MISURARE LA CARICA DELL’ELETTRONE CON UN METODO VELOCE, SUFFICIENTEMENTE PRECISO
E FACILMENTE REALIZZABILE, SENZA DOVER INCORRERE NEI GRAVOSI COSTI, SPESSO SOVRASTIMATI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LABORATORI.
diare, da un punto di vista qualitativo,
l’effetto fotoelettrico, ossia l’emissione
di fotoelettroni da una lamina metallica
investita da luce UV. Ciò è possibile far-
lo utilizzando materiali poveri, facil-
mente reperibili. Innanzi tutto è neces-
sario procurarsi una lampada a vapori
di mercurio.
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX88
PERCORSI DIDATTICI
Figura 1
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 88
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 89
PERCORSI DIDATTICI
In essa sono presenti due bulbi: quello
interno in quarzo, di alcuni millimetri
di diametro, contiene vapori di mercu-
rio ad alta pressione i quali, scaldandosi
al passaggio della corrente, emettono
radiazioni, prevalentemente UV (λ ≈253,7 nm), riconvertite in radiazioni vi-
sibili dai fosfori depositati sulla parete
interna del bulbo esterno.
Tali fosfori, pertanto, fungono da veri
e propri trasduttori di frequenza. Inol-
tre il v etro esterno svolge anche le
funzioni di protezione del bulbo inter-
no e di cust odia dei c ontatti degli
elettrodi principali e di quelli di innesco
(v. fig.1).
Ricordiamo che l’effetto fotoelettrico
è un effetto a soglia per quanto riguar-
da la frequenza: per ciascun materiale
esiste una frequenza di soglia fo che, nel
caso dello zinco, si colloca nella banda
ultravioletta (1,02·1015 Hz).
Per frequenze inferiori ad fo l’effetto
scompare, qualunque sia l’intensità
di illuminazione.
È evidente quindi che per liberare fo-
toelettroni dallo zinco bisogna disporre
di radiazione UV. Poiché il normale ve-
tro è impermeabile a tali frequenze, è
necessario rompere con cautela l’invo-
lucro esterno della lampada lasciando
in evidenza solo il bulbo interno in ve-
tro al quarzo, il quale invece risulta per-
meabile alla luce UV (v. fig.2)1.
A questo punto elettrizziamo una bac-
chetta di vetro strofinandola con un
panno di lana e, successivamente, tra-
sferiamo, per c ontatto, la car ica su
una lamina di zinco posta sulla parte
superiore di un elettrometro (v. fig.3).
Si raccomanda di ripulire, in via pre-
liminare, la piastrina di zinco con un
detergente e di passarla legger mente
con carta vetrata fine per eliminare
eventuali tracce di grasso ed impurità
che potrebbero ostacolare l’interazione
diretta tra i fotoni UV e g li elettroni
dello zinco.
L’ago mobile devierà dalla sua posizione
verticale con un angolo proporzionale
alla carica trasferita tramite la bacchetta.
La successiva accensione della lampada
ad UV det ermina un r apida discesa
dell’indice evidenziando una progres-
siva neutralizzazione dell’elettrometro
(v. figg. 4A e 4B).
Poichè la scarica dell’elettrometro è in-
terpretabile sulla base dell’effetto fotoe-
lettrico, ossia in termini di emissione
di fotoelettroni, tale esperienza dimo-
stra che la carica ceduta inizialmente
dal vetro alla superficie di zinco doveva
necessariamente essere negativa.
Quando, al contrario, l’elettrometro è
carico positamente si produce una
scarica del tutto trascurabile. In realtà,
anche in quest o caso, la r adiazione
UV libera elettroni dalla lastra, ma que-
sti vengono nuovamente attirati dalla
carica positiva della stessa. Per verificar-
lo provvediamo a caricare per strofinio
una bacchetta di plexiglass con un
panno di lana, trasferendo poi, sempre
per contatto, la carica sulla lamina di
zinco. In tal caso osserveremo che la
luce UV non produce alcun effetto dal
momento che l’ago metallico rimane
nella sua posizione originale (v. figg. 5A
e 5B). Pertanto ciò dimostra che la ca-
rica posseduta dalla bacchetta di plexi-
glass era positiva.
Al fine di verificare in modo inequivo-
cabile che gli eventi descritti sono im-
putabili unicamente all’effetto fotoelet-
trico, e non ad altre cause, ci rimettiamo
nelle stesse condizioni della fig.3, inter-
ponendo questa volta, tra la lampada
UV e la lastra di zinco carica negativa-
mente, un filtro di vetro comune che,
come ho già premesso, risulta imper-
meabile alle radiazioni UV.
In tal caso la scarica cessa immediata-
mente e l’indice dell’elettrometro rima-
ne immobile anche se intensifichiamo
l’illuminazione avvicinando la lampada,
per quanto possibile, alla superficie di
zinco (v. fig.6).
Figura 2 Figura 3
1. A titolo cautelativo, per evitare esposizioni a radia-zioni UV, è opportuno tenere gli studenti a debita di-stanza dall’apparato durante la prova dell’effettofotoelettrico, magari con l’inserimento di una capsulaprotettiva di forma cilindrica posta att orno alla lam-pada utilizzata. Tale capsula può essere realizzata conmateriale opaco e su di essa dovrà essere praticato unforo in corrispondenza della posizione della lamina dizinco in modo tale che la radiazione UV colpisca in ma-niera direzionale solo la piastra metallica.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 89
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX90
PERCORSI DIDATTICI
Parte II: la misura dellacarica dell’elettroneDopo aver chiarito il segno della carica
del vetro e del plexiglass una v olta
elettrizzati per strofinio con un panno
di lana, ed alcuni aspetti qualitativi le-
gati all’effetto fotoelettrico, un naturale
completamento di questa sezione didat-
tica può essere costituito dalla misura-
zione della carica dell’elettrone attra-
verso un procedimento elettrolitico.
L’attrezzatura specificatamente richiesta
per effettuare la nota eperienza di Mil-
likan, in genere, presenta costi proibitivi
per i bilanci di un istituto. L’elettrolisi,
argomento di confine tra fisica e chimi-
ca, per c ontro offre il vantagg io di
utilizzare in modo versatile strumenta-
zione che, di norma, in un laboratorio
di media levatura è già preesistente e
che può esser e impiegata anc he in
molti altri esperimenti.
Il circuito elettrico di cui ci siamo
serviti è piuttosto semplice (v. fig. 7A):
viene sfruttata l’elletrolisi del solfato di
rame (soluzione al 5%) in una cella con
elettrodi di rame. Anche in quest o
caso è opportuno inizialmente sgrassare
in modo accurato gli elettrodi per ri-
durre eventuali isolamenti elettrici.
Gli ioni SO4- - che giungono sull’anodo
fanno andare in soluzione ioni di rame
postivi (Cu++), mentre gli ioni di
rame positivi provenienti dalla soluzio-
ne si depositano sul catodo. Ogni ione
trasporta in ogni caso due cariche ele-
mentari (positive o negative).
Il problema fondamentale consiste nel
misurare la variazione di massa deg li
elettrodi. Misurare l’aumento di massa
del catodo, o la rispettiva diminuzione
dell’anodo, sono due operazioni teori-
camente equivalenti. Tuttavia dal punto
di vista pratico la misura fatta sul catodo
risulta alquanto più difficile poic hè
l’elettrodo si ricopre di un deposito
polveroso che, alla minima vibrazione,
tende a depositarsi sul fondo della cella.
Al contrario l’anodo rimane compatto
e facilmente manipolabile. La sua dimi-
nuzione di massa può esser e misurata
con una bilancia avente la sensibilità del
millesimo di grammo (v. fig.8).
È necessario inoltre disporre di un ge-
neratore di t ensione variabile (o in
caso contrario di un reostato) per re-
golare l’intensità di corrente, monito-
rata tramite un amperometro, la quale
potrebbe non mantenersi costante du-
rante l’intero esperimento2.
Inoltre abbiamo inserito una resistenza
di protezione pari a 22 Ω.
Se indichiamo con t la durata della pro-
va, con δMCu la diminuzione di massa
dell’anodo3, essendo I l’intesità di cor-
rente misurata dall’amperometro4,
avremo che la carica totale fluita nel cir-
cuito è
Q = I · t
Figura 4A
Figura 4B
2. In fig. 7B compare anche un voltmetro per il controllodella tensione ai capi del generatore. In realtà l’utilizzodi tale strumento non è necessario ai fini dell’esperi-mento.3. La massa di un at omo di rame corrisponde a MCu =63,546 u.m.a.·1,66*10-27 kg/u.m.a. = 1,05·10-25 kg. Si os-servi che possiamo ragionevolmente ammettere che laperdita di due elettroni da parte di un atomo di rameappartenente all’anodo lascia invariata la massa totaledell’atomo stesso. Infatti tale perdita corrisponde ad unamassa di circa 1,82·10-30 kg, ossia lo 0,0017% di MCu.4. L’incertezza sulla misur a dell’intensità di c orrente,sulla base delle indicazioni fornite dal manuale dell’am-perometro utilizzato, era pari al 2% della lettura + 10 di-gits.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 90
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 91
PERCORSI DIDATTICI
Il numero degli ioni di rame provenienti
dall’anodo, e passati in soluzione, sarà
mentre il numero di elettroni trasferiti
è dato da
Pertanto la carica elettrica di un elettro-
ne corrisponderà al rapporto
L’errore relativo associato a tale misura,
sulla base dei dati a nostra disposizione,
utilizzando le regole di propagazione
degli errori, sarà dato da
Evidentemente per diminuire l’incertez-
za si può aumentare la durata del pas-
saggio della corrente e/o aumentare l’in-
tensità di c orrente incrementando la
f.e.m. erogata del generatore.
Inoltre si potrebbe sviluppare un’inte-
ressante analisi statistica dei r isultati
coinvolgendo più classi, magari conser-
vando le misur e ottenute, eventual-
mente in anni successivi.
Un esempio da noi condotto in labora-
torio ha fornito i seguenti risultati:
MCu (iniziale) = (3,617 ± 0,001)g
MCu (finale) = (3,557 ± 0,001)g
δMCu = (0,060 ± 0,002)g
I = (0,190 ± 0,014)A
t = (900 ± 1)sec
da cui segue che
con
Pertanto otteniamo:
un valore assolutamente accettabile
non solo dal punto di vista dell’ordine
di grandezza, ma coerente anche con il
valore teoricamente atteso di 1,6·10-19
C, da cui si discosta di un 6%.
Visti i risultati ottenuti e la relativa sem-
plicità dell’apparato sperimentale uti-
lizzato possiamo tranquillamente affer-
mare che tale approccio laboratoriale ri-
sulta competitivo con strumentazioni
aventi lo stesso obiettivo, ma assai più
onerose.
ConclusioniLa nostra proposta didattica consiste
nell’accostamento di due argomenti, tra
loro trasversali, che possono esser e
trattati sperimentalmente in parallelo,
in modo semplice e chiaro nella stessa
unità didattica, mettendo in evidenza la
Figura 5A
Figura 5B
Figura 6
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 91
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX92
PERCORSI DIDATTICI
possibilità di attuare operazioni di sin-
tesi concettuale ed ottenere eccellenti ri-
sultati strumentali rispettando anche la
logica del risparmio. Ciò oggi si rende
possibile grazie anche alla facile repe-
ribilità sul mercato di componenti che
qualche anno fa risultavano non par-
ticolarmente diffusi e c omunque più
costosi di quelli attuali, come ad esem-
pio una semplice lampada a vapori di
mercurio per generare raggi UV acqui-
stabile in un qualunque nego zio di
materiale elettrico.
Questi semplici esperimenti sono in ge-
nere facilmente eseguibili in un labo-
ratorio di Fisica a livello liceale e rite-
niamo forniscano spunti di discussione
estremamente utili non solo per gli stu-
denti. Infatti tali argomenti, unitamente
ad altri legati alla Fisica Moderna, sono
stati oggetto anche di un corso di aggior-
namento che abbiamo tenuto presso il
Liceo Scientifico A. Volta (Riccione) il
quale ha generato un confronto profes-
sionale virtuoso fra i doc enti da cui
sono nate interessanti proposte di lavo-
ro.
Da alcuni anni stiamo sempr e più
orientando, anche attraverso corsi di
potenziamento e valorizzazione delle
eccellenze presenti nelle nostre classi, i
programmi curriculari verso temi legati
alla fisica del ‘900.
La crescita culturale legata a questo tipo
di percorso, tuttavia, non sempre trova
adeguato riscontro nel mondo della
scuola, un mondo nel quale la frattura
tra l’attualità scientifica ed il mond o
della didattica, accompagnata spesso da
una perdita della visione d’insieme
dell’Universo fisico, rappresentano uno
scenario tutt’altro che occasionale.
Fausto Bersani Greggio, A.T. Corrado Bernabè
Liceo Scientifico «A. Volta» (Riccione)
BIBLIOGRAFIAPSSC, Fisica, Zanichelli, Bologna 1963.E.H. Wichmann, La fisica di Berk eley. 4: fisica quantistica,Zanichelli, Bologna 1973.R. Sexl - I. Raab - E. Streeruwitz, Elementi di fisica, Zanichelli, Bo-logna 1986.J.B. Marion, La fisica e l’univ erso fisico, Zanichelli, Bologna1975.R. Sexl - I. Raab - E. Streeruwitz, Elementi di fisica, Zanichelli, Bo-logna 1986.
Figura 8
Figura 7A
Figura 7B
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 92
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 93
PERCORSI DIDATTICI
Furono i fratelli Jacob e Joseph Sa-
muda, inglesi, a registrare il pri-
mo brevetto di una ferroviaatmo-
sferica nel 1838. Nel 1841 Joseph Samu-
da espose le sue idee circa la possibilità
di realizzareuna ferrovia a propulsione
pneumatica in un libretto che suscitò
grande interesse: A Treatise on the
Adaptation of Atmospheric Pressure to
the Purposes of Locomotion on Railways,
ma fu solo nel1844 che venne inaugu-
rata la pr ima tratta della Dublin and
Kingstown Railway, che rimase inservi-
zio per dieci anni.
Il treno correva su due normali rotaie al
centro delle quali era steso un tubo d’ac-
ciaio entro il quale correva un pistone
azionato da una differenza di pressione.
Il pistone era collegato al treno attraverso
una lama che scorreva in una fessura ta-
gliata longitudinalmente nel tubo.
Naturalmente, a mantenere la differenza
di pressione provvedevano pompe aspi-
ranti dislocate lungo il tragitto ad alcuni
chilometri di distanza.
Con un tubo di 15 pollici (38 cm) di dia-
metro si raggiunsero velocità intorno a
100 km/h.
Ma è più divertente se facciamo alcuni
calcoli. Ipotizzata una sezione di 0,2 m2,
ed una velocità di 20 m/s, chiediamoci
in quanto tempo la vogliamo raggiun-
gere. Se prevediamo un minuto, l’acce-
lerazione sarà
Una massa plausibile per un treno è 10
tonnellate (104 kg) e quindi la forza agen-
te sul pistone dev’essere
Se, come abbiamo ipotizzato, la sezione
del tubo è 0,2 m2, la differenza di pres-
sione sulle due facce del pistone dovrà
essere
Questa differenza di pressione va man-
tenuta nel tubo nonostant e il pistone
avanzi alla velocità di 20 m/s. Per la legge
dei gas sarà
dove x è la distanza dal termine del tubo
e la pressione p si deve mantenere di 1/6
inferiore all’atmosferica. Ma, se il pistone
scorre con velocità V, la legge prende la
forma
e quindi
che fornisce il numero delle moli d’aria
che devono venire espulse dal tubo nel-
l’unità di tempo, Inserendo in questa i
valori ipotizzati si ottiene
Al termine della t ratta bisogna predi-
sporre pompe in g rado di estrarre dal
tubo almeno 3 m3/s.
Ledo Stefanini Università di Mantova-Pavia
Una ferrovia pneumaticaLedo Stefanini
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 93
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX94
PERCORSI DIDATTICI
Secondo il Rappor to Rocard
(Fig.1), la ragione dello scarso in-
teresse dei g iovani per g li studi
scientifici è essenzialmente connessa al
modo in cui le scienze vengono insegna-
te a scuola.
In particolare, vengono evidenziati come
aspetti problematici l’approccio didattico
tradizionalmente trasmissivo, finalizzato
alla semplice memorizzazione dei con-
tenuti, e l’impostazione prevalentemente
teorica e astratta di stampo deduttivo.
In relazione a quest’ultimi aspetti, anche
nei casi più favorevoli in cui le atti vità
sperimentali sono incluse nella prassi di-
dattica ordinaria, spesso assol vono a
una funzione «dimostrativa» dei concetti
precedentemente trasmessi dall’inse-
gnante o trattati dal manuale. In questi
casi, il compito richiesto agli studenti
consiste spesso nella mera esecuzione di
procedure predefinite, di cui è facile pre-
vedere i risultati. Sul piano formativo
non si tratta quindi di esperienze di ri-
cerca autentica, ma piuttosto di attività
finalizzate a richiamare e consolidare no-
zioni teoriche o, al più, utili allo sviluppo
di semplici abilità procedurali. Inoltre,
secondo una prospettiva più generale,
connessa a fattori di natura epistemolo-
gica, tali esperienze possono fornire
agli studenti una v isione della scienza
non del tutto adeguata e coerente all’idea
contemporanea.
Inquiry Based Science Education: una didattica innovativa per le scienzeMaria Angela Fontechiari
IN QUESTI ULTIMI ANNI SI È REGISTRATO UN CRESCENTE INTERESSE VERSO
L’INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE), INDICATA DAI DOCUMENTI UFFICIALI EUROPEI
COME UN APPROCCIO DIDATTICO EFFICACE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA CRISI
DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA, CHE POTREBBERO SERIAMENTE COMPROMETTERE IL FUTURO DELL’EUROPA. ECCONE UNA PRESENTAZIONE.
La rilevanzaL’impegno europeo per la diffusione
dell’IBSE nei paesi dell’unione si basa
sulla costatazione dei suoi effetti positivi
sull’interesse e sui risultati di apprendi-
mento, emersi nella r ealizzazione di
progetti basati sulla sua implementazio-
ne.
L’efficacia dell’IBSE è ampiamente con-
fermata anche dalla letteratura interna-
zionale, essenzialmente riferita a ricerche
svolte in contesti in cui l’applicazione di
tale approccio è da tempo consolidata e
prevista dalle linee guida istituzionali. In
particolare, è stato dimostrato l’impatto
positivo dell’IBSE sulla c omprensione
profonda dei concetti scientifici, sullo
sviluppo di c ompetenze specifiche e
trasversali, incluse quelle di livello ele-
vato, nel promuovere l’interesse e la mo-
tivazione e nel migliorare i risultati di ap-
prendimento. Tali effetti risultano per-
sistenti nel t empo e s i riferiscono a
tutti gli studenti, compresi quelli con sto-
rie di insuccesso scolastico o con diffi-
coltà di apprendimento, garantendo al
tempo stesso il raggiungimento di livelli
di eccellenza. Alcuni studi hanno inoltre
dimostrato la maggiore efficacia dell’IB-Figura 1
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 94
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 95
PERCORSI DIDATTICI
SE a confronto con metodologie tradi-
zionali, anche nello sviluppo della lite-
racy scientifica. Nonostante questi dati
positivi e i numerosi sforzi per favorirne
l’implementazione, la diffusione dell’IB-
SE in Europa è ancora piuttosto limitata
e fino ad ora ha coinvolto prevalente-
mente la scuola primaria. Tale situazione
riguarda anche il caso specifico dell’Ita-
lia, dove a parte l’eccezione di alcune re-
altà locali coinvolte in progetti europei,
si registra ancora una scarsa conoscenza
di questo approccio innovativo.
Considerando i modesti risultati conse-
guiti dagli studenti italiani nelle prove
internazionali PISA, sia sul piano delle
competenze, sia su quello dell’interesse,
l’IBSE potrebbe essere un efficace stru-
mento da introdurre nella scuola secon-
daria di secondo grado per invertire tale
tendenza.
Istruzioni per l’usoL’‘IBSE è un approccio didattico indut-
tivo, di matrice costruttivista, orientato
al processo piuttosto che al prodotto. Si
caratterizza come strategia di apprendi-
mento attivo e cooperativo, centrata sul-
lo studente, con l’insegnante che svolge
il ruolo di facilitatore. Sono questi gli
aspetti fondamentali che consentono di
formulare una definizione generale del-
l’IBSE, utile a qualificare tale approccio
dal punto di vista pedagogico-didattico.
L’analisi della denominazione Inquiry
Based Science Education (Educazione
Scientifica Basata sull’Indagine) mette
in luce una significativa dicotomia, che
richiama in modo esplicito i settori della
ricerca e dell’educazione nello specifico
ambito scientifico.
In effetti il termine suggerisce la connes-
sione tra l’attività di indagine alla base
del processo che genera nuove cono-
scenze scientifiche e l’attività di appren-
dimento e di insegnamento delle scienze.
A tal r iguardo, la letteratura di riferi-
mento sottolinea come l’IBSE non sia
propriamente una singola e specifica me-
todologia didattica, ma rappresenti piut-
tosto un approccio multiforme e varie-
gato, che riunisce in sè alcuni elementi
chiave riconducibili alla dicotomia evo-
cata dalla sua denominazione.
Tali elementi costituiscono gli aspetti sa-
lienti di un processo di apprendimento
che simula l’indagine scientifica, fondato
sull’idea che gli studenti possano acqui-
sire conoscenze e competenze scientifi-
che utilizzando le modalità e i percorsi
che guidano gli scienziati nella compren-
sione del mondo naturale.
Nonostante la pluralità dei modi di con-
durre la ricerca scientifica sul piano in-
dividuale e la diversità di approcci che
caratterizzano la r icerca nei di versi
ambiti disciplinari, si possono indivi-
duare alcuni aspetti che solitamente ca-
ratterizzano il processo di ricerca scien-
tifica, assunti dall’IBSE come caratteri-
stiche chiave che qualificano in modo
specifico tale approccio (Fig.2), deline-
andone la seguente definizione opera-
tiva.
La domanda iniziale p er il coinvolgi-
mento degli studenti (engage)
L’IBSE è un processo che coinvolge gli
studenti in una sfida formulata sotto for-
ma di domanda, riferita a fatti e fenome-
ni della realtà naturale.
Tale domanda inziale deve essere scien-
tificamente orientata, cioè prevedere
risposte che derivano da indagini scien-
tifiche dirette o indirette, basate sulla rac-
colta di dati sperimentali; inoltre, non
deve prevedere una risposta univoca, ma
una pluralità di risposte alternative,
ugualmente legittime in quanto riferite
a paradigmi diversi. La «sfida» iniziale
deve essere significativa, riguardare cioè
questioni rilevanti e connesse a contesti
di vita reale e, al tempo stesso, prevedere
risposte «accessibili» agli studenti e ade-
guate al loro livello di sviluppo. Essa si
considera efficace nella misura in cui su-
scita negli studenti il bisogno di cono-
scere, attiva naturalmente il processo di
investigazione ed è in grado di generare
altre domande che alimentano e guidano
la ricerca di spiegazioni.
Figura 2
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 95
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX96
PERCORSI DIDATTICI
La raccolta di prove (evidence)
La raccolta di e videnze sperimentali
rappresenta il mezzo fondamentale uti-
lizzato dagli studenti, per costruire spie-
gazioni che siano accettabili e significative
dal punto di vista scientifico. I dati spe-
rimentali possono derivare da esperienze
svolte direttamente in laboratorio o sul
campo, da fonti indirette e anche dall’ap-
plicazione di modelli. In tal senso l’IBSE
non comporta necessariamente lo svol-
gimento di attività sperimentali, qualora
questo non fosse possibile per ragioni di-
verse, mentre richiede come condizione
essenziale e irrinunciabile il r icorso a
«prove» per supportare le risposte e le
spiegazioni proposte, coerentemente al
carattere sperimentale della scienza.
La formulazione di spie gazioni (ex-
planation)
Gli studenti for mulano risposte alle
domande di ricerca a partire dalle evi-
denze sperimentali raccolte. La costru-
zione di spiegazioni coinvolge vari pro-
cessi cognitivi, alcuni dei quali pr opri
dell’indagine scientifica (classificar e,
analizzare, inferire, fare previsioni, ecc.),
altri più generali e trasversali (ragionare
in modo logico e pensare criticamente).
Tale attività, pur focalizzandosi sulla co-
struzione di spiegazioni logiche e coeren-
ti rispetto alle prove selezionate, coinvol-
ge anche la creatività e l’immaginazione
degli studenti, tiene conto del rispettivo
background individuale di esperienze e
conoscenze pregresse e include sia osser-
vazioni, sia inferenze, riproducendo in
tal modo la c omplessità del pr ocesso
scientifico.
La valutazione delle spiegazioni (eva-
luation)
Gli studenti val utano le spiegazioni
proposte mettendole in relazione con le
conoscenze scientifiche riguardanti le
questioni affrontate. Il processo prevede
il confronto delle idee messe in campo
dagli studenti, come risultato delle inda-
gini svolte, quelle proposte dall’insegnan-
te e quelle riportate nelle diverse fonti
consultate. Un’attenzione particolare
viene rivolta alle spiegazioni alternative,
che possono derivare dall’applicazione
di analoghe procedure o essere il risultato
di indagini intenzionalmente diversifi-
cate, riferite cioè a modi diversi di affron-
tare lo stesso problema e che proprio per
questo meritano di essere approfondite.
Gli strumenti fondamentali di questa
fase di revisione sono il dialogo e la di-
scussione, costantemente alimentati
dalle domande, il cui ruolo strategico è
finalizzato non solo ad avviare e dirigere
il processo di ricerca, ma anche a guidare
il controllo e la verifica dei risultati ot-
tenuti.
La comunicazione delle spie gazioni
(communication)
Gli studenti presentano gli esiti del loro
processo di ricerca comunicando e giu-
stificando i risultati ottenuti. Questa fase
di condivisione richiama il car attere
intersoggetivo della scienza, che prevede
la comunicazione dei risultati per garan-
tirne la replicazione, il relativo controllo
e l’eventuale utilizzo in nuove domande
di ricerca. La comunicazione degli stu-
denti deve essere chiara, rigorosa e com-
pleta; essa inoltre deve includere una ar-
gomentazione convincente del processo
svolto, mostrando in modo chiaro ed
esplicito la connessione tra le evidenze
sperimentali, le conoscenze scientifiche
esistenti e le spiegazioni proposte.
Oltre la definizione operativaE’ importante sottolineare come gli ele-
menti del processo descritto non siano
da interpretare come una rigida sequenza
di passaggi obbligati, ma piuttosto come
caratteristiche specifiche dell’IBSE che,
a seconda delle particolari condizioni di
contesto, è possibile implementare in va-
rio modo. Considerati globalmente,
questi elementi c hiave conducono gli
studenti a comprendere alcuni aspetti ri-
levanti della scienza, perseguendo il
duplice obiettivo della sperimentazione
e della conoscenza dei processi propri
dell’indagine scientifica.
Al di là della definizione o perativa,
l’aspetto che maggiormente qualifica la
pedagogia dell’IBSE, svelandone la sua
vera essenza, è la riflessione che caratte-
rizza l’intero processo di apprendimento.
Mentre gli studenti conducono le loro
indagini sono continuamente guidati a
riflettere sul processo in corso. Questa al-
ternanza tra il «fare» e il «r iflettere su
quello che si sta facendo», sul «come» e
sul «perchè», permette il raggiungimento
di obiettivi di vario livello: la compren-
sione dei concetti scientifici, lo sviluppo
di competenze e l’acquisizione di signi-
ficati, sviluppando al tempo stesso mo-
tivazione e interesse. In tale prospettiva,
l’IBSE si c onfigura sia c ome attività
pratica-laboratoriale, sia come processo
mentale, qualificandosi anche come at-
tività metacognitiva di livello superiore,
utile ed efficace per comunicare agli stu-
denti la natura della scienza.
In confronto ad altri approcci didattici,
gli elementi che scaturiscono dalla rifles-
sione sul processo rappresentano il va-
lore aggiunto dell’IBSE. In tal senso, ven-
gono ad esempio super ate le atti vità
hands-on o la metodologia dell’imparare
facendo, che pur presentando un indi-
scutibile valore pegadagogico-formativo,
si caratterizzano essenzialmente come at-
tività pratiche. Questa specifica conno-
tazione, se da un lato non esclude la ri-
flessione sulle esperienze, dall’altro non
ne prevede esplicitamente lo sv olgi-
mento, limitando così la possibilità di co-
municare agli studenti la natura della
scienza. In effetti, la ricerca in campo
educativo ha dimostrato che il semplice
coinvolgimento in attività sperimentali
che simulino il processo di ricerca scien-
tifica non è sufficient e a sviluppare in
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 96
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 97
PERCORSI DIDATTICI
modo implicito l’idea di scienza. Il
raggiungimento di tale ambizioso obiet-
tivo richiede invece l’impegno in un’at-
tività mentale, da svolgere contempo-
raneamente a quella pratica, che prevede
come momento cruciale la riflessione
esplicita sul processo in corso. Dal mo-
mento che la comprensione della natura
della scienza viene indicata in letteratura
come una condizione particolarmente
favorevole allo sviluppo della literacy
scientifica, il valore formativo dell’IBSE
risulta particolarmente rilevante anche
in riferimento a tale possibile risultato.
I livelli dell’IBSENon tutte le «atti vità inquiry» sono
equivalenti: diversi autori descrivono un
continuum di differenti livelli, che oltre
a rappresentare un utile r iferimento
per riconoscere un’autentica «attività in-
quiry», permette anche di determinare
il «grado di inquiry» di una data espe-
rienza di apprendimento. A tal riguardo,
i tipi di tassonomia riportati in lettera-
tura propongono un numero variabile
di livelli di inquiry, ma sostanzialmente
convergono nel criterio di classificazione.
Esso si riferisce al diverso grado di re-
sponsabilità e di autonomia attribuito
agli studenti nel progettare e condurre
le loro indagini, connesso al livello di
«strutturazione» delle attività, predispo-
sto dall’insegnante (Fig.3). Sul piano
operativo risulta discriminante la quan-
tità di informazioni fornite agli studenti,
che si traduce in una variazione signi-
ficativa del grado di complessità delle at-
tività proposte (Fig. 4).
Il modello di classificazione più diffuso
descrive quattro diversi livelli, compresi
tra due estremi: l’ «inquiry confermativo»
e l’ «inquiry aperto».
Figura 3. I quattro diversi livelli di inquiry in relazione al grado di responsabilità degli studenti e/o al livello di guida fornitadall'insegnante (NRC, 2000).
Figura 4. I quattro diversi livelli di inquiry e le informazioni fornite agli studenti(Bell, Smentana & Binns, 2005; Bianchi & Bell, 2008).
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 97
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX98
PERCORSI DIDATTICI
Quest’ultimo rappresenta il li vello di
maggiore complessità in termini di ri-
chieste cognitive e gestione del processo.
Nell’ «inquiry aperto» l’insegnante deve
controllare un percorso imprevisto e im-
prevedibile, essendo completamente
aperto all’iniziativa degli studenti, i
quali scelgono la domanda di ricerca e
progettano e conducono le loro indagini
in ogni fase.
Nonostante l’elevato grado di autonomia
e di responsabilità affidato agli studenti,
rimane comunque cruciale il ruolo del-
l’insegnante, al quale si richiede di for-
nire un adeguato supporto per facilitare
il processo diretto dagli studenti. Per con-
tro, nell’inquiry di livello più basso la re-
sponsabilità del processo è completa-
mente affidata al docente, il quale dirige
ogni fase dell’attività, fornendo tutte le
informazioni necessarie in tal senso.
Nei livelli intermedi di «inquiry struttu-
rato» e «inquiry guidato» le attività pre-
sentano un grado di strutturazione pro-
gressivamente decrescente, nel senso
che nel primo caso è l’insegnante che for-
nisce sia la domanda di ricerca, sia la pro-
cedura per la sol uzione, lasciando agli
studenti il compito di formulare spiega-
zioni sulla base delle indicazioni fornite,
mentre nell’inquiry guidato sono g li
studenti a scegliere il procedimento per
formulare le risposte alla domanda di ri-
cerca, in questo caso posta dall’insegnan-
te.
Rispetto al possibile repertorio di attività
inquiry si dovrebbe dare agli studenti
l’opportunità di partecipare ad esperien-
ze riferite a ciascuno dei diversi livelli. In
effetti, il piano ideale per un’efficace im-
plementazione dell’IBSE pr evede un
percorso di graduale passaggio tra attività
con un crescente livello di complessità,
tenendo conto che lo sviluppo di abilità
inquiry richiede tempo sia per gli studen-
ti, sia per gli insegnanti. Ovviamente la
pianificazione di tale percorso è affidata
all’insegnante che deve valutarne i modi
e i tempi più opportuni, in base alle spe-
cifiche condizioni di contesto.
Talvolta l’approccio basato sull’inquiry
è classificato anche come «full o partial»
a seconda della presenza completa o par-
ziale dei cinque elementi chiave indicati
nella definizione operativa (engage, evi-
dence, explanation, evaluation, commu-
nication).
Tendenzialmente tutte le possibili varia-
zioni e gli eventuali adattamenti sono ac-
cettabili, purchè l’esperienza di appren-
dimento sia centrata su una domanda di
ricerca che prevede risposte basate su
evidenze sperimentali (non importa se
acquisite in modo diretto o indiretto),
e che le attività siano sempre accompa-
gnate da una significativa riflessione sul
processo svolto.
Maria Angela Fontechiari,Docente di Scienze Naturali, Parma
Scuola Internazionale di Dottorato, Universi-tà di Camerino
BIBLIOGRAFIA
R.L. Bell, L. Smentana, I. Binns, Simplifying Inquiry Instruction, in «The Science Teacher», 72 (7), 2005, pp. 30-34.P. Brickman, C. Gormally, N. Armstrong, B. Hallar, Effects of Inquiry-based Learning on Students' Science Literacy Skills and Confi-dence, in «International Journal for Scholarship of Teaching and Learning», 3 (2), 2009, pp. 1-22.W. Harlen, J. Allende, Report of the Working Group on Teacher Professional Development in Pre-Secondary IBSE. Fundacion para Estu-dios Biomedicos Avanzados, Facultad de Medicina, University of Chile, 2006.L.B. Flick, N.G. Lederman, Scientific Inquiry And Nature of Science, Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006.H.L. Gibson, C. Chase, Longitudinal Impact of an Inquiry-Based Science Program on Middle School Students' Attitude Toward Science,in «Wiley Periodicals», Inc. Sci Ed 89, 2002, pp.693-705.National Research Council, Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning, DC: NationalAcademic Press, Washington 2000.National Research Council, National Science Education Standards, DC: National Academic Press, Washington 1996.M. Rocard, et al. Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. EC Directorate for Research (Science, Eco-nomy and Society), Brussels 2007.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 98
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 99
PERCORSI DIDATTICI
Si è voluto far credere che la Pianura
Padana, per la sua apparente piat-
tezza, non fosse zona sismica. In
realtà, sepolta sotto la metà S delle allu-
vioni del Po c’è metà della catena appen-
ninica ancora in crescita. Geologi, geo-
fisici e storici fin dagli anni 1970 hanno
rinfrescato la memoria dei terremoti sto-
rici e cartografato le ragioni geologiche
di questa sismicità della pianura.
Peccato che i progettisti di opere civili,
segnatamente capannoni, le abbiano
ignorate. Ora bisogna investire in rico-
struzione, mitigazione pr eventiva, e
soprattutto educazione a una n uova
mentalità.
«Ma quella per noi non era una zona si-
smica!» è stato il ritornello uscito più vol-
te dalla bocca di personaggi chiave,
qualificati spesso dal titolo di ingegnere,
nei giorni caldi del terremoto e in quelli
della valutazione fredda e dur a dei
morti, dei danni e del disastro. «Ma quel-
la era zona dichiarata sismica solo dal
2003!». Questo ripeteva ancora a due
mesi dal sisma il responsabile regionale
di Confindustria, ingegnere.
Che l’Italia sia sempre stata dominata da
avvocati, valenti o azzeccagarbugli, sta-
tisti o capitani d’industria, lo sapevamo.
Ma che una classe potente e un ordine
professionale pigliatutto, come quello de-
gli Ingegneri, abbia buttato alle ortiche
la talare di una rigorosa scienza speri-
mentale e saggi principi costruttivi, pur
di galleggiare nella perpetua competizio- Fig. 1 – Mappa della pericolosità sismica d’Italia (da INGV 2004).
Non fidarsi delle apparenze: una lezione dal terremoto emilianoGian Battista Vai
IL TERREMOTO EMILIANO TRA GLI STUDI DEGLI ESPERTI E LA VOCE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 99
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX100
PERCORSI DIDATTICI
ne coi legulei, il terremoto ha messo sot-
to gli occhi di tutti. Quei capannoni mo-
derni a semplice gravità, abbattuti come
fuscelli, in un paese come l’Italia che ha
la registrazione storica più completa al
mondo dei sismi deg li ultimi 2000
anni, sono uno scandalo. Come fu uno
scandalo che il n uovo governo pie-
montese dell’Italia unita 150 anni fa
abrogasse le legislazioni borbonica e pa-
palina già avanzate per quei tempi e ap-
plicate nella parte più sismica della pe-
nisola. Il Piemonte non ne disponeva,
per essere fortunatamente quasi immu-
ne da sismi, e l’Italia per legge veniva pri-
vata della memoria (Guidoboni & Va-
lensise 2011). Purtroppo, anche gli ita-
liani, villici o notabili non importa, per
natura e cultura non hanno coltivato
granché la memoria di quel passato do-
loroso, sublimandola di preferenza nella
poesia e nel folclore religioso.
Vediamo allora perché le giustificazioni
di cui sopra sono infondate e, per certi
aspetti, impudenti, come alcuni inge-
gneri hanno riconosciuto. Alle loro re-
sponsabilità, però, vanno r ichiamate
molte altre categorie, tecniche, politiche,
scolastiche, religiose, e noi tutti cittadini,
che soli in definitiva possiamo diventare
la matrice di una nuova mentalità: im-
parare a convivere con i terremoti, pre-
venendone gli effetti.
La classificazione sismica delterritorioNel 1570 il disast roso terremoto di
Ferrara induceva un eminente studioso,
Pirro Ligorio, a formulare le prime in-
dicazioni al mondo su come progettare
le città e le abitazioni per cautelarsi dal
ripetersi dei terremoti. Era nata la pre-
venzione sismica basata sull’osservazio-
ne che veniva storicizzata classificando
come sismica quella città. Stato della
Chiesa e Regno delle Due Sicilie fecero
tesoro di quell’esperienza, elaborarono
una normativa antisismica e dedicarono
risorse alla ricostruzione dopo i terremo-
ti che colpivano i loro territori. La legi-
slazione piemontese, trasferita all’Italia
con l’unità, non prevedeva norme anti-
sismiche. Da allora in Italia verranno
considerati sismici solo i comuni colpiti
da un evento disastroso a partire dai pri-
mi del Novecento (effetto del terremoto
di Messina/Reggio Calabria 1908). Per
farsi un’idea, in Emilia-Romagna prima
del 1981 i comuni classificati sismici era-
no 12, per salire a 89 dopo il 1981 (e es-
serlo tutti oggi).
Il punto di svolta fu il duplice terremoto
del Friuli del 1976 (M 6.6 e 6.1; intensità
max MCS X). Mille morti e ingenti dan-
ni in una regione allora depressa ma pie-
na di memorie della Grande Guerra fe-
rirono il Paese che era in pieno sviluppo.
L’Italia aveva riformato l’università, fi-
nanziato gli enti di ricerca, si era dotata
finalmente di una carta geologica di base
dell’intero Paese a un sec olo dalla sua
unità politica. Era nata una nuova classe
tecnica, i geologi (e i geofisici), compe-
titiva a livello internazionale e pronta a
integrare le competenze lacunose degli
ingegneri. Lo studio dei t erremoti del
Friuli e dell’Irpinia (1980, tremila morti,
M 6.7; intensità max X) comportarono
la costruzione di una rete di sorveglianza
dei terremoti in tempo reale estesa al
Paese e al Mediterraneo. Il patrimonio
di indagini geofisiche commerciali (in-
dustria petrolifera) e dedicate venne usa-
to per tracciare in pr ofondità nella
crosta le faglie generatrici dei terremoti
che i geologi individuano in superficie.
Gli enormi patrimoni degli archivi sto-
rici-artistici del Paese vennero sfruttati
per ricostruire pericolosità e ricorrenza
dei sismi italiani, fornendo agli studiosi
del mondo il più ricco e preciso catalogo
sismico di una regione chiave negli ul-
timi 2000 anni.
Il risultato pratico di quest o sforzo
scientifico-tecnologico, in cui sono stati
impegnati per un decennio alcune mi-
gliaia di giovani geologi, geofisici, e in-
gegneri, è stata la formulazione di carte
sintetiche di pericolosità sismica dell’in-
tero Paese. Su questa base, a partire dagli
Fig. 2 – Struttura geologica del nord Italia togliendo dalla Pianura Padana le allu-vioni quaternarie e i depositi marini del Pliocene e Pleistocene. Ne risalta la catenaappenninica sepolta a S del Po e la prominenza delle dorsali di Ferrara e Miran-dola (subito sotto il tondo nero di ancoraggio del plastico) (da Vai 2009, p. 111).
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 100
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 101
PERCORSI DIDATTICI
anni 1980, a var ie riprese, sono stat e
avanzate alle autorità competenti propo-
ste di classificazione sismica, per cui oggi
quasi l’intero Paese è classificato sismico
(con aree a diversa pericolosità), ad ec-
cezione della Sardegna, parti della Puglia,
e poche altre zone (Fig. 1) (INGV 2004).
Veniva dato avvio anche a studi di
micro zonazione sismica in cui valutare
localmente gli effetti del sito (tipo di ter-
reno e substrato, morfologia, ecc.) in ter-
mini di aggravanti o attenuanti della pe-
ricolosità regionale stimata.
Ma far prendere coscienza ad una popo-
lazione che deve adattarsi a pr ivazioni
perché ha dimenticato di essere in po-
tenziale pericolo non è opera agevole. E
tanto meno lo è farlo digerire a politici,
imprenditori, e dirigenti. La mia piccola
esperienza in quegli anni è stata penosa.
Blandizie, minacce, suppliche, diffidenza,
di tutto pur di ritardare un decreto o mi-
nimizzare parametri e valutazioni rela-
tive al rischio sismico di uno o più co-
muni. La r esistenza a pr endere atto
della «oggettività» scientifica ha avuto
certo effetti al ribasso sugli iter finali dei
vari stadi della classificazione. Questo at-
teggiamento chiarisce anche la ragione
dei tragici crolli di edifici recenti in co-
muni già classificati sismici da molto
tempo come l’Aquila. Su questo piano
l’Italia e gli italiani hanno evidentemente
un ritardo culturale e educativo dannoso
e tragico che solo la scuola, fin dalla pri-
ma infanzia, può colmare.
Classificazione e pericolositàLa pericolosità sismica di un sito dipende
dalle caratteristiche geologiche della re-
gione in cui si trova (soprattutto numero
e dimensioni delle faglie attive nel sot-
tosuolo) e da quelle litologiche e mor-
fologiche del sito stesso. Così la perico-
losità è descritta abbastanza bene (1) dal-
la magnitudo massima ammissib ile
(confrontata con quella st orica dei
sismi precedenti per avere un riscontro
sperimentale e stimare un tempo medio
di ricorrenza), e (2) dag li effetti sit o
(amplificazione o attenuazione). Non
tutti i parametri coinvolti si possono
misurare con alta preci-
sione. Alcuni possono es-
sere solo stimati o ap-
prossimati. Altri sono
solo probabilistici (1 ter-
remoto ogni 100 oppure
ogni 1000 anni). Ma
quando una comunità
scientifica nazionale o so-
vranazionale concorda
fino al punto di pubblica-
re carte di per icolosità,
tutti sono tenuti a ricono-
scere oggettività scientifi-
ca a queg li elaborati. La
classificazione formale
che ufficializza i risultati
degli studi e ne der iva
prescrizioni obbligatorie può
intervenire anche a distanza
di tempo, per ragioni varie
(inerzia, opportunità, rischio
calcolato). Questo però non esime il
pubblico e gli operatori dal prendere
coscienza dei r isultati, ben di vulgati,
della ricerca scientifica. Basti pensare
all’amianto. Se la sua pericolosità, de-
nunciata dalla buona scienza decenni
prima dell’adeguamento normativo,
fosse stata ammessa da imprenditori e
sindacati, si sarebbero evitati migliaia
di morti. Leggi e norme, quando for-
mulate, vanno seguite. Ma la loro man-
canza non è sinonimo di mancanza di
problemi e non autorizza a trascurare
le acquisizioni scientifiche.
Già negli anni 1980 i geologi concorda-
vano che l’Appennino Settentrionale e
la Pianura Padana a S del Po sui piani
storico e strutturale avessero sismicità
crescente da W (M 4.5–5.5) a E (M 5–
6) con picchi in Garfagnana, Mugello,
alto Forlivese, Riminese, Ferrarese
(Elmi & Zecchi 1984; Achilli et al.
1990; Boschi et al. 1997; Valensise &
Pantosti 2001) tutti giustificati da faglie
attive delle dimensioni fino a qualche
decina di km. Per la fascia ferrarese ve-
Fig. 3 – Carta di pericolosità sismica d’Italia (CNR 1981)e Numero di effetti di VIII grado risentiti in Italia (Boschi et al. 1996), particolari.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 101
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX102
PERCORSI DIDATTICI
niva prevista una intensità max MCS
fino al grado IX-X (si noti che l’inten-
sità max cumulata del recente terremo-
to emiliano è stata dell’ VIII grado
MCS). A S del Po e sotto le sue alluvio-
ni, infatti, si era scoperta una vera e pro-
pria catena montuosa sepolta, quasi la
metà dell’Appennino Settentrionale,
che mostrava segni di essere ancora in
crescita (Fig. 2). La pericolosità sismica
che ne derivava era però inferiore a
quella del Friuli e ancor minore di quel-
la dell’Appennino Meridionale, Cala-
bria e Sicilia orientale (Fig. 3). Di fatto
poi la z ona del t erremoto emiliano
dal 2003 era legalmente classificata. E
come tale era considerata da almeno 20
anni prima, come appare da pubblica-
zioni scientifiche (Fig. 4) e dalle relazio-
ni geologiche dei piani regolatori di co-
muni della zona. Chi si vuole trincerare
dietro la giustificazione normativa sa di
mentire, per non do ver confessare la
propria ignoranza o mancata conside-
razione dei risultati scientifici.
Pericolosità e vulnerabilitàDiversamente dalla gran parte dei ter-
remoti italiani recenti questo della pia-
nura emiliana è stretto parente di quelli
del Friuli 1976. Stesso il movimento oriz-
zontale avanti e indiet ro avvertito a
Bologna, secondo la direttrice NS, che è
la direttrice di moto delle strutture del-
l’Appennino e delle Alpi Friulane, con
spostamento a N del pr imo e a S delle
seconde. E’ questa la risposta lungo
l’asse di massima c ompressione NS,
originato dalla spinta dell’Africa contro
l’Eurasia. Il movimento è contrapposto
perché le faglie appenniniche immergo-
no verso S e quelle alpine verso N (Fig.
3b). Ciò è stato confermato dalla solu-
zione focale delle scosse maggiori, tutte
in compressione pura NS, come in
Friuli. L’unica differenza è stata la ma-
gnitudo, là assai maggiore per le faglie
più lunghe, pronte a liberare più energia
e a provocare 1000 mor ti contro i 27
dell’Emilia. Ma per sc osse di questa
magnitudo in California e in Giappone
non ci sarebbero state vittime e i danni
sarebbero stati minori. Perché? Qui su-
bentra il concetto di vulnerabilità che,
a parità di magnitudo e altre condizioni,
fa la differenza. Costruzioni antisismiche
(basse, a intelaiatura metallica, in mate-
riali leggeri, in buon cemento armato,
elastiche, su cuscinetti assorbenti, ecc.)
saranno poco vulnerabili. Abitati in
sasso e malta, centri storici, edifici mo-
numentali antichi privi di tiranti metal-
lici, sopraelevazioni, ecc., cioè la situa-
zione comune in Italia) saranno molto
vulnerabili. La vulnerabilità può essere
mitigata dalla Provvidenza o dalla buona
sorte. Se la prima scossa di Domenica 20
Maggio fosse avvenuta alle 10 del mat-
tino anziché alle 4 di nott e, con le
Prime Comunioni ci sar ebbero stati
centinaia di morti. Non si deve tentare
Dio. I milioni di italiani che vanno in
chiesa meritano di avere chiese sicure,
non solo quelle nuove, ma anche quelle
antiche e rurali, vero simbolo dell’iden-
tità delle popolazioni diffuse nel terri-
torio. Anche la precarietà sismica degli
altri edifici pubblici (scuole, ospedali,
municipi, ecc.) non è ammissibile. Si
sono investiti patrimoni nell’adegua-
mento alla normativa antincendio. Non
meno e con più urgenza andava e va fat-
to per un adeguament o antisismico
(con vantaggi assai maggiori).
È criminale invece quanto è avvenuto
con i capannoni indust riali. Nessun
ancoraggio fra pali e travi. Nessun ap-
poggio a incastro. Appoggio bruto,
piano e liscio, a semplice gravità. «La tra-
ve è tanto pesante che nessuno la spo-
sterà, neppure il vento», era il retro pen-
siero dei progettisti. Eppure il terremoto
ne ha spostate centinaia, facendole crol-
lare come castelli di carte, e provocando
la maggior parte dei morti. Qui la vul-
nerabilità e le vittime le hanno provocate
Fig. 4 – (a) Intensità MCS massima prevista in Emilia-Romagna (da Elmi & Zecchi1984) e (b) sezione geologica schematica attraverso l’area del terremoto emilianoe friulano (da Castellarin & Vai 1986). Si noti che metà degli accavallamenti ap-penninici sono sepolti dalle alluvioni della Pianura Padana a S del Po (sinistra).
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:53 Pagina 102
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 103
PERCORSI DIDATTICI
i progettisti, assolutamente digiuni di
ogni cautela sismica, e anche carenti di
buone norme statiche e cinematiche del
costruire. Sarebbe come pretendere che
un ponteggio tubolare resti in piedi sen-
za dadi e senza flange. E’ bastata una
oscillazione orizzontale delle cime dei
pilastri per 20 cm a disar cionare le
travi e a farle crollare miseramente. Non
c’era neppure l’attrito a mitigar e lo
scorrimento fra le due superfici piane e
lisce al contatto. Speculazioni sulla sicu-
rezza, massicci ribassi d’asta, concorren-
za sleale, sete di guadagno, tutte concau-
se di una mentalità in cui il lavoro a re-
gola d’arte e l’affidabilità non sono più
obiettivi e tanto meno vanti. Mentalità
in cui solo costi e guadagni vengono
conteggiati, i rischi rimossi. Il tragico è
che di capannoni c ostruiti in quel
modo in Pianura Padana ce ne sono mi-
gliaia (compresi molti centri commer-
ciali). Rappresentano tutti bombe a
orologeria, pronte a crollare al prossimo
terremoto. E’ ovvio che dovranno essere
risanati e messi in sicurezza, anche con
il contributo e il lavoro delle imprese co-
struttrici e committenti, e con urgenza
seconda solo a quella della zona già col-
pita. Ma anche l’Ordine degli Ingegneri
e gli altri ordini tecnici interessati do-
vranno fare un serio esame di coscienza,
come autorevoli ingegneri hanno subito
sottolineato, a cominciare da una più at-
tenta e rispettosa considerazione dei la-
vori dei geologi e delle loro indicazioni,
rinunciando alla nef asta abitudine e
prassi di tanti ingegneri e architetti di
volersi sostituire in tutto e per tutto al
geologo.
Un salto di serietàQuesto dei capannoni sbriciolati non è
che uno dei troppi esempi di scarsa se-
rietà del Paese, frutto della «furbizia»ß
dei privati (committenti e esecutori) e
del controllo pubblico carente, e, quan-
do presente, inefficace perché burocra-
tico. Si pensi solo alla Casa dello Studen-
te all’Aquila, o alla scuola di S. Giuliano
di Puglia. Non se ne esce senza un’opera
di educazione sistematica e psicologi-
camente cruda ai rischi geologici, a co-
minciare da ogni ordine di scuola. Oc-
corre anche una pubblicità intelligente,
anche martellante, che promuova una
crescita scientifica del popolo, calibrata
sulle esigenze naturali del Paese.
Con tutto il rispetto per i cani, anche in
concomitanza di un terremoto che sta
avendo conseguenze drammatiche su
centinaia di mig liaia di uomini e la
perdita di 2 punti percentuali sul PIL del
Paese, in TV, di ogni sorta, si dedica più
spazio educativo agli amici dell’uomo
che agli uomini, terremotati in atto o in
potenza. Sempre in TV, la divulgazione
scientifica è per oltre il 90% dedicata a
medicina e salute. Che poi di terremoti,
eruzioni, frane si possa facilmente mo-
rire anzitempo, è trascurabile.
E così anche il Ferrarese diventa «area
non sismica», o, al massimo, «trascura-
bilmente sismica». Occorre cambiare re-
gistro e far e un salt o di ser ietà. Sono
molto curioso di vedere cosa capiterà in
Friuli, di cui si sta avvicinando il tempo
di ritorno sismico. È stato quello il mi-
glior esempio di ricostruzione in Italia
a seguito del terremoto del 1976, da tutti
i punti di vista (funzionale, economico,
storico, artistico e culturale). Se si dimo-
strerà anche efficace alla prova del ter-
remoto successivo, avremo finalmente
un caso esemplare di virtù italiche da
proporre e su cui fare scuola.
Gian Battista VaiMuseo Geologico Giovanni Capellini,
Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna
BIBLIOGRAFIA
V. Achilli, S. Arca, P. Baldi et al., Studio sismotettonico dell’Appennino Forlivese. Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, IGMI, 49, 319–361, 1990.E. Boschi, P. Favali, F. Frugoni, G. Scalera & G. Smriglio, Numero di effetti di VIII grado risentiti in Italia, carta in scala 1: 1.500.000. INGV,Salomone, Roma 1996.E. Boschi, E. Guidoboni, G. Ferrari, et al., Catalogue of Strong Italian Earthquakes, 461 B.C. to 1990. ING and SGA, Bologna 1997.A. Castellarin & G.B. Vai, Southalpine versus Apenninic Arcs. In: F.-C. Wezel (ed.), The Origins of Arcs, Elsevier Sc. Publ., Amsterdam 1986,253–280.CNR P.F. Geodinamica, Carta della pericolosità sismica d’Italia, scala 1:1.500.000. ESA Editrice, Roma 1981.C. Elmi & R. Zecchi, Sismicità storica e sismotettonica a confronto nell’Emilia-Romagna. La Mercanzia, Maggio-Giugno, 189–197, 1984. E. Guidoboni & G. Valensise, Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni. Centro euro-mediterraneo didocumentazione eventi estremi e disastri, INGV, Bononia 2011Univ. Press, Bologna 1. INGV, Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, 2004.G.B. Vai, Guida breve per immagini, Museo Geologico Giovanni Capellini, Labanti & Nanni, Crespellano-Bologna 2009.G. Valensise & D. Pantosti, Seismogenetic faulting, moment release patterns and seismic hazard along the central and southern Apenninesand the Calabrian arc. In: G.B. Vai and I.P. Martini (eds.) Anatomy of an Orogen: the Apennines and adjacent Mediterranean Basin, KluwerAc. Publ., Dordrecht 2001, 495–512.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:54 Pagina 103
«La comunità scientifica italiana, attornoalla metà dell’Ottocento, non era tra le piùimportanti del mondo , ...Tuttavia, purentro limiti complessivi angusti, gli studi dielettricità e magnetismo godettero da noi diuna particolare popolarità. All’inizio del se-colo vi era stata la celeberrima disputa traVolta e Galvani ….., e questa gloria patriaaveva orientato la maggior parte dei non nu-merosi cultori delle s cienze fisiche dellaPenisola verso i fenomeni elettrici e magne-tici».
Ci è sembrato interessante iniziare
questo breve scritto su Galileo
Ferraris, uno degli scienziati che
ha dato più lustro all’Italia nei primi cin-
quant’anni dopo l’unità, con questa ci-
tazione1 che ci pare definisca bene per
quali fortunate circostanze alcuni nomi
italiani (Volta, Galvani, Pacinotti, Ferra-
ris, Righi, Marconi) abbiano lasciato una
traccia tanto importante nella scienza
elettrica otto-novecentesca.
Quanta parte abbia avuto nella vicenda
di Ferraris il clima politico che fece se-
guito all’unità politica del paese non è
possibile analizzarlo in un breve articolo
come questo. Certamente la classe sociale
che sostenne il Risorgimento era media-
mente più sensibile ai temi della scienza,
in particolare della scienza applicata, e
dell’industria di quanto non lo fossero
stati i ceti prima dominanti. Un ruolo
importante ebbe la riforma dell’istruzio-
ne operata dalla Legge Casati (novembre
1859), la quale per la parte tecno-scien-
tifica prevedeva fra l’altro la formazione
a Torino di una Scuola d’Applicazione,
che doveva superare il precedente Regio
Istituto Tecnico. Questa scuola cominciò
a funzionare nel 1861 e ad essa si aggiun-
se l’anno successivo, sempre a Torino, il
Museo Industriale Italiano, nato per
l’iniziativa e con il sostegno degli ambien-
ti industriali torinesi. A dispetto del suo
nome si trattava anche in questo caso di
un istituto tecnico superiore, ispirato alla
esperienza del Kensington Museum di
Londra, che fra i suoi compiti aveva quel-
lo di impar tire agli allievi ingegneri
alcuni degli insegnamenti tecnologici
fondamentali del loro corso di studi2.
Galileo Ferraris si formò a Torino proprio
negli anni successivi a questa riforma, fre-
quentando prima il biennio propedeu-
tico presso la Regia Università e poi la
Scuola d’Applicazione, dove ebbe come
insegnante di fisica tecnica il lombardo
Giovanni Codazza, del quale seguì le
orme divenendo, subito dopo la laurea,
a soli 22 anni, assistente alla cattedra di
«fisica tecnologica» del Museo Industria-
le. L’interesse di Galileo F erraris per
l’energia elettrica nacque gradualmente,
ma già l’argomento della sua t esi di
laurea, che fu stampata come monografia
nel 1869, indicava una sua grande atten-
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX104
PERCORSI DIDATTICI
1. Si veda lo scritto di Roberto Maiocchi citato in biblio-grafia, p.155.2. Una seconda Scuola di Applicazione venne fondata aMilano nel 1863. Il quadro delle prime facoltà di ingegne-ria del nuovo stato italiano venne completato dalla fon-dazione della Scuola Palermitana di Ingegneria e dallariorganizzazione di quella già esist ente a Napoli (en-trambe nel 1866). Nel 1870, nacquero poi le scuole di in-gegneria di Padova e di Roma. Nel frattempo in varie cittàsorsero anche numerosi istituti tecnici secondari (eranouna settantina al termine del primo decennio unitario).
La Scuola d’Applicazione e il Museo Industriale sar eb-bero confluite a formare, nel 1906, il Politecnico di Torino.3. Si trattava di sistemi basati sulla trasmissione, nel rag-gio di qualche chilometro, dell’energia meccanica, me-diante cavi di acciaio . Hirn a veva realizzato diversesignificative applicazioni della sua idea, in particolare allecascate del Reno a Sciaffusa. L’idea era stata presa in con-siderazione anche per azionare le perforatrici della galle-ria ferroviaria del Frejus, che fu realizzata fra il 1857 e il1871, ma poi gli era stato preferito il sistema ad aria com-pressa.
Galileo Ferraris e i primordi dell’elettrotecnica italianaGianluca Lapini
GLI ULTIMI DUE DECENNI DELL’OTTOCENTO VIDERO IL GIUNGERE
A MATURITÀ E L’AFFERMARSI A LIVELLO INDUSTRIALE
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DEI FENOMENI ELETTRICI, CHE TANTO AVREBBERO CONTRIBUITO A RIVOLUZIONARE
IL MODO DI VIVERE, LAVORARE E DI PRODURRE DEL NOVECENTO. SUL FRONTE AVANZANTE DI QUESTA NUOVA TECNOLOGIA, IL PROFESSOR GALILEO FERRARIS, CON I SUOI STUDI
E CON LA SUA INVENZIONE DEL CAMPO MAGNETICO ROTANTE, FU UNA GUIDA ILLUSTRE E RICONOSCIUTA, NON SOLO IN ITALIA, MA ANCHE IN CAMPO INTERNAZIONALE.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:54 Pagina 104
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 105
PERCORSI DIDATTICI
zione ai problemi pratici dell’industria e
della moderna società civile, in particolare
al problema del trasporto dell’energia, al
quale avrebbe in seguito dedicato molta
della sua attività di docente e ricercatore.
La tesi consisteva infatti in una accurata
analisi dei vantaggi e limiti, dei sistemi
di trasmissione telodinamica3 dell’ener-
gia sviluppati dall’ingegnere alsaziano
Ferdinand Hirn, che in quegli anni ave-
vano ricevuto notevole interesse da
parte del mondo tecno-scientifico. Tre
anni più tardi, quando divenne dottore
aggregato alla facoltà di scienze fisiche,
matematiche e naturali della Regia Uni-
versità di Torino, la sua dissertazione ini-
ziale fu una estesa monografia sulla
teoria matematica della propagazione
dell’elettricità nei solidi, ma poi per
quasi un decennio i suoi interessi scien-
tifici si rivolsero non solo all’elettrologia
(con un forte interesse alle applicazioni
pratiche al telefono), ma anche all’ottica
geometrica ed alla tecnologia del calore;
quest’ultimi argomenti erano in effetti
organici al ruolo di professore di fisica
tecnologica che egli ricoprì, a partire dal
1877, presso il Museo Industriale, suc-
cedendo al suo maestro G. Codazza. L’in-
teresse del prof. Ferraris per l’elettricità
crebbe notevolmente dopo che egli ebbe
l’occasione di partecipare, come delegato
ufficiale del governo italiano, alla prima
esposizione ed al primo congresso inter-
nazionale degli «elettricisti» (come allora
si chiamavano i cultori di questa mate-
ria), che si tenne a Parigi nella primavera
del 1881. I contatti internazionali che
ebbe modo di iniziare in quell’occasione
e di ampliare nei due anni successivi, par-
tecipando ad altri simili eventi ancora a
Parigi ed a Vienna, furono per lui pre-
ziosissimi per organizzar e la sezione
internazionale elettrica della Esposizione
Generale Italiana di Torino del 1884 (fu
quella che lasciò in eredità il parco del
Valentino e il suo «finto» castello medie-
vale). Ma soprattutto, in quei due-t re
anni, Ferraris cominciò ad orientare la
sua attività di ricercatore verso uno dei
problemi che avrebbe profondamente
condizionato lo sviluppo dell’elettrotec-
nica. In effetti mentre l’utilizzo civile ed
industriale dell’elettricità aveva in quegli
anni cominciato a dare le prime dimo-
strazioni di fattibilità, in particolare ad
opera di Thomas Edison (Edison realizzò
la sua prima centrale ed i suoi primi si-
stmei di illuminazione elettrica a New
York nel 1882; il prof. Giuseppe Colom-
bo avviò la prima centrale europea, si-
stema Edison, a Milano, nel 1883) non
avrebbe potuto fornire la soluzione più
efficiente al trasporto dell’energia elet-
trica a distanze significative. In questo
senso Ferraris aveva iniziato ad interes-
sarsi alle correnti alternate ed ai trasfor-
matori elettrici, che pareva potessero of-
frire una soluzione efficiente al trasporto
a distanza. I trasformatori, che inizial-
mente venivano chiamati «generatori se-
condari», erano peraltro una invenzione
recentissima, presentata per la prima vol-
ta all’esposizione di Parigi del 1881 dal
tecnico francese Lucien Gaulard, che si
era poi associat o con l’inglese John
Gibbs: sui loro principi di funzionamen-
to si conosceva ancora poco e per la loro
costruzione venivano usati metodi del
tutto empirici. Ferraris compì sui trasfor-
matori delle r icerche sistematiche, sia
teoriche che sperimentali, pubblicando
fra il 1885 e il 1887 alcune fra le prime
memorie scientifiche su quest o argo-
mento4, ma prima ancora di far ciò, die-
de un contributo fondamentale alla or-
ganizzazione di una dimost razione di
trasporto di energia elettrica a distanza,
basata sui trasformatori, proprio in
concomitanza della Esposizione di To-
rino, alla quale abbiamo sopra accennato.
In quell’occasione fu appositament e
stesa una linea elettrica, fra i padiglioni
dell’esposizione e la cittadina di Lanzo,
situata a una quarantina di km distanza
(in gran parte appoggiandosi ai pali te-
legrafici della ferrovia Torino-Lanzo).
Così fu possibile illuminare la stazione
di Lanzo, mediante due trasformatori
forniti da Galuard, utilizzando la corren-
te aternata monofase prodotta da un ge-
neratore azionato da una macchina a va-
pore, elvata di tensione a Torino, e poi
ritrasformata in bassa tensione a Lanzo.
Se i trasformatori furono lo spunto dal
quale Ferraris iniziò ad occuparsi di cor-
renti alternate, i suoi precedenti studi di
ottica furono lo spunto dal quale gli ba-
lenò l’idea, del «campo magnetico rotan-
te» e del motore elettrico asincrono, per
i quali ebbe in seguito fama mondiale e
imperitura. Dagli studi di ottica, ma an-
che dalla sua grande familiarità con le
equazioni di Maxwell che avevano acco-
munato i fenomeni ottici ed elettroma-
gnetici, gli era infatti not o come la
combinazione di due moti armonici
semplici e uguali (come due onde lumi-
Generatore secondario di Gaulard e Gibbs.
4. G. Ferraris, Ricerche teoriche e sperimentali sul generatoresecondario di Gaulard e Gibbs, in Memorie della Regia Ac-cademia delle Scienze di Torino, 11 gennaio 1885; G. Ferra-ris, Sulla differenza di fase delle c orrenti sul ritar dodell’induzione e sulla dissipazione di energia nei trasforma-tori, in Memorie della Regia Accademia delle Scienze di To-rino, 4 dicembre 1887.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:54 Pagina 105
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX106
PERCORSI DIDATTICI
nose polarizzate), ma sfasate fra di loro
di un quarto di periodo, producesse un
moto circolare. Ebbe quindi l’idea, nel-
l’estate del 1885, che qualcosa di analogo
si potesse ottenere con due campi ma-
gnetici oscillanti, sfasati fra di loro.
Costruì dunque nel laboratorio del Mu-
seo Industriale un primissimo apparec-
chietto dimostrativo costituito da due
bobine elettromagnetiche poste a 90°
l’una dall’altra, che venivano alimentate
con due identic he correnti alternate
opportunamente sfasate fra di loro tra-
mite il passaggio in un trasformatore di
Gaulard; al centro di questo apparecchio
un cilindretto di rame, sospeso con un
filo si metteva in rotazione, come Ferraris
aveva intuito che sarebbe successo.
Era il primo rudimentale prototipo di al-
cuni piccoli motori, più perfezionati, che
egli realizzò nei mesi successivi, e sui qua-
li compì sistematici studi e misure, ca-
ratterizzandone il comportamento in ter-
mini di velocità, potenza e rendimento.
Si trattava di piccoli apparecchi da labo-
ratorio (a chi gli chiedeva quanti caval-
li-vapore di potenza avessero Ferraris ri-
spondeva scherzosamente che la potenza
era di «1/32 di coniglio vapore»), ma per-
fettamente in grado di dimostrare il prin-
cipio di funzionamento e le caratteristi-
che costruttive fondamentali del motore
asincrono a c orrente alternata, cioè
della macchina motrice di base che
allora ancora mancava, per far diventare
la produzione di corrente elettrica alter-
nata (con gli alternatori) e la sua trasmis-
sione a distanza (con i trasformatori) il
sistema vincente per la produzione e di-
stribuzione dell’energia elettrica5. Pur-
troppo, il Prof. Ferraris non pubblicò' su-
bito i risultati di questi suoi studi ed
esperimenti, che comparvero sotto for-
ma di memoria scientifica solamente nel
marzo del 1888 6. Questo ritardo nella
pubblicazione dei risultati del suo lavoro
fu all’origine di una polemica infinita
sulla progenitura dell’idea, che si sarebbe
in seguito scatenata con l’inventore Ni-
kola Tesla, di origini croate, ma trapian-
tato in America, il quale ottenne fra l’au-
tunno del 1887 e la primavera del 1888,
una serie di br evetti sui c oncetti di
campo magnetico rotante e su un mo-
tore asincrono molto simili a quelli
concepiti da Ferraris. Sarebbe troppo
lungo riferire sugli sviluppi di questa vi-
cenda7, dalla quale alcuni autori hanno
voluto trarre la conclusione che Ferraris
fosse una mente geniale, ma poco attenta
agli sviluppi pratici ed industriali della
scienza. In questo senso si trova spesso
citata una frase da lui scritta qualche
anno più tardi, quando la tecnologia del
trasporto a distanza della energia elet-
trica in corrente alternata ebbe una più
completa e convincente dimostrazione
durante l’esposizione c he si t enne a
Francoforte nell’agosto del 18918:
«… senza che io me ne sia occupato ho
visto a Francoforte che tutti attribuisco-
no a me la pr ima idea, il che mi basta.
Gli altri facciano pure i denari, a me ba-
sta quel che mi spetta: il nome».
In effetti non c ’è dubbio che nell’am-
biente tecno-scientifico nazionale e in-
ternazionale il professor Ferraris si fosse
creato una altissima reputazione.
Medaglia commemorativadella AEI nel cinquantenariodella fondazione. Sul recto ritratto di G. Ferraris in età matura; sul retro modello di motorea campo magnetico rotante.
5. Esisteva già, a quei tempi, il motore sincrono a correntealternata (in pratica un alternatore fatto funzionare alcontrario). Ma il fatto che questo motore non fosse auto-avviante e che necessitasse di un collettore lo rendevamolto meno adatto agli usi industriali, per i quali si dimo-strò invece ideale il motore asincrono, per la sua r obu-stezza e semplicità costruttiva.6. G. Ferraris, Rotazioni elettrodinamiche prodotte permezzo di correnti alternate, in Atti della Reale Accademiadelle Scienze di Torino, vol. XXIII, 1887-88.7. Una ricostruzione molto ben documentata degli eventi si
può trovare nell’articolo di G. Silva, citato nella bibliografia.8. Fu realizzata una linea di tr asmissione trifase a25.000 Volt, lunga 175 km, fra un impianto idroelettricosituato a Lauffen, sul fiume Neckar e la città di Franco-forte, trasmettendo una potenza di qualche centinaiodi kW c on perdite complessive dell’ordine del 25%.Due anni dopo la società americana Westinghose pre-sentò alla fiera di Chicago un perfezionamento di que-sto sistema, chiamato “sistema universale” che divennelo standard per il succ essivo sviluppo dei sist emi diproduzione, trasmissione ed utilizzo della corrente al-
ternata trifase, che nella sostanza sono tuttora in uso. 9. La fondazione della scuola elettrotecnica torinese fuquasi contemporanea a quella della analoga scuola dispecializzazione elettrotecnica milanese, che poté iniziaregrazie alla cospicua donazione dell’industriale chimicoCarlo Erba. A Milano, peraltro, già dal 1882-1883, era ini-ziato un corso di esercitazioni elettrotecniche per gli stu-denti di ingegneria industriale.10. Cfr. G. Lapini, Giuseppe Colombo, ingegnere, imprendi-tore e politico, «Nuova Secondaria», n. 3, novembre 2007,p. 94.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:54 Pagina 106
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 107
PERCORSI DIDATTICI
Lo si vide in particolare al Congresso In-
ternazionale di Elettricità di Chicago del
1893, svoltosi in concomitanza con la
Esposizione Colombiana Mondiale, al
quale Ferraris partecipò come delegato
unico del governo italiano, venendo an-
che eletto come vice-presidente. Ma in
realtà in lui non mancò mai un forte in-
teresse ai risvolti pratici della scienza
elettrica, come dimostra il suo coinvol-
gimento professionale in tanti par eri,
consulenze e pr ogetti, in var ie parti
d’Italia, in anni in cui nacque una mi-
riade di iniziative civili e industriali, spe-
cie nel campo dell’illuminazione pub-
blica, che segnarono l’inizio della prima
elettrificazione del paese. Ferraris era
stato attento a ciò fin dagli inizi; scriveva
per esempio nella sua relazione al mi-
nistro Berti, dopo la sua partecipazione
alle esposizione di Parigi del 1881:
«Da questa mostra io riportai la convin-
zione che alcune delle applicazioni più
grandiose della corrente elettrica….pos-
sono divenire in un prossimo avvenire,
pratiche ed economiche…permettendo
a noi di sostituire in molti casi l’energia
dei nostri torrenti e delle nostre cascate
a quella del carbon fossile che ci viene
oggidì venduta a carissimo prezzo….a
quella convinzione va associata in me la
speranza di un guadagno grandissimo
per l’industria del nostro paese».
Questa consapevolezza si esprimeva
anche nel suo modo di insegnare, che
dalla testimonianza dei suoi allievi sap-
piamo era non solo rigoroso nella espli-
cazione matematica dei concetti, ma an-
che pieno di osservazioni sottili ed ar-
gute, atte a formare il buon senso degli
ingegneri.
A questo proposito, in campo didattico
non si può fare a meno di ricordare che
il suo contributo al consolidamento del-
la nascente tecnologia elettrica italiana,
si concretizzò nella fondazione della
Scuola Superiore di Elettrotecnica (To-
rino, 18869), né si può tralasciare un bre-
ve accenno al fatto che fu fondamentale
il suo contributo alla nascita, nel 1896,
della Associazione Elettrotecnica Italiana
(AEI), della quale fu il primo presiden-
te.
Certamente, il disinteresse per il guada-
gno personale c he Ferraris esprime
nella sua frase sopra citata, ci fanno
comprendere che ci troviamo di fronte
ad uno spirito meno «imprenditoriale»
di quanto non fosse, per esempio, il suo
contemporaneo milanese, prof. Giusep-
pe Colombo10. Essa peraltro ci aiuta a
comprendere che si trattava di uno di
quei personaggi di altissima le vatura
morale, dei quali il Risorg imento è
ricco. Ne furono dimostrazione non solo
l’abnegazione con la quale trattò sempre
familiari ed amici, ma anche l’impegno
civile e politico, che lo vide impegnato
dai ruoli di amministratore locale fino
a quelli di senatore.
Qui si aprirebbero delle altre interessan-
tissime finestre su questa vita eccezio-
nale, alle quali non abbiamo purtroppo
lo spazio per affacciarci.
Vita che fu per altro assai br eve, in
quanto Galileo Ferraris morì a Torino,
non ancora cinquantenne, il 5 febbraio
del 1897 (era nato il 30 ottobre 1847 a
Livorno Vercellese, in seguito ribattez-
zato Livorno Ferraris in suo onore), per
i postumi di una influenza, probabil-
mente trascurata per i suoi tanti impe-
gni, che degenerò in polmonite.
Gianluca LapiniCultore di Storia della Tecnologia
Politecnico di Milano
BIBLIOGRAFIA
R. Maiocchi, La Ricerca in campo elettrotecnico, in G. Mori (a cura di), Storia dell’industria elettrica in Italia. Le Origini, 1882- 1914, EditoriLaterza, Roma-Bari 1992.C. G. Lacaita, Cultura Politecnica e modernizzazione nell’Italia di fine Ottocento. Galileo Ferraris e la Scuola Superiore di Elettrotecnicadi Torino, Olschki Editore, Firenze, 1999 (estratto da Physys, Rivista Internazionale di Storia della Scienza, Vol. XXXV, fasc. 2, pagg.431-450). S. Leschiutta, Galileo Ferraris. Portare energia nelle case della gente, in «Emmeciquadro», n. 23, Aprile 2005, pp. 81-94.A. Silvestri (a cura di), Galileo Ferraris e L’AEI. Uomini e sodalizi della scienza elettrica (Atti del convegno e catalogo della mostra, Mi-lano-Livorno Ferraris, 1997), Edizioni All’insegna del pesce d’oro, Milano 1998.M. Schmidt (a cura di), Forza Motrice. Il trasporto dell’energia da sogno a realtà- Omaggio alla modernità di Galileo Ferraris (catalogodella omonima mostra), BieBi Editrice, Biella 1999.G. Silva, Galileo Ferraris, il campo magnetico rotante e il motore asisncrono, in «L’Elettrotecnica», vol. XXXIV, n. 9, settembre 1947, pp.346-378.G. Zannini, Galileo Ferraris. Una grande mente, un grande cuore, Piemme, Casale Monferrato 1997.G. Zannini, Adamo Ferraris. Il medico di Garibaldi, Venilia Editrice, Montemerlo 1999.
NS5 74-107 percorsi scienze:Layout 1 15-11-2012 16:54 Pagina 107
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX108
LE PAROLE DI ORIGINE FRANCESE
ED INGLESE NELL’ITALIANO DEL
SETTECENTO CI RACCONTANO COME
I TERMINI, E QUINDI I CONCETTI,DELLA MODERNITÀ SONO GIUNTI A
NOI DALLE NAZIONI PIÙ PROGREDITE
IN AMBITO CIVILE, ECONOMICO E
SCIENTIFICO. SEGUIAMO QUESTO
PERCORSO ATTRAVERSO I SITI
INTERNET DEDICATI ALL’ETIMOLOGIA
E SCOPRIREMO CHE...
Gli strumenti: dai vocabolarietimologici ai siti internetGli strumenti a disposizione di chi si in-
teressa all’evoluzione della lingua si
sono oggi accresciuti tramite la tecno-
logia e la rete internet: è infatti possibile
ordinare on-line saggi, studi e vocabolari
etimologici, mentre, d’altra parte, si
sono moltiplicati i suppor ti digitali,
come i CD-Rom che consentono con-
sultazioni rapide e persino meta-ricer-
che nei medesimi repertori.
Prima, però, diamo un veloce sguardo
ai tradizionali vocabolari etimologici,
che restano sempre insostituibili: tra i
più diffusi vi sono il Dizionario etimo-
logico della lingua italiana [DELI], cu-
rato da M. Cortelazzo e P. Zolli1 ed il Di-
zionario etimologico di T. De Mauro e
M. Mancini2. Per chi si occupa di lin-
guistica è anche essenziale il classico Di-
zionario etimologico italiano [DEI] di C.
Battisti e G. Alessio3, cui si affianca l’in-
gente lavoro del Grande dizionario
della lingua italiana [GDLI] a cura di
S. Battaglia e G. Barberi Squarotti4.
Oggi è pos sibile affiancare a questi
anche la versione elettronica in CD-
Rom dello storico Dizionario della lin-
gua italiana di N. Tommaseo e B. Bel-
lini5; iniziato nel 1857 e pubblicato tra
il 1861 e il 1879, documenta la lingua
italiana durante gli anni del nostro Ri-
sorgimento.
Soprattutto, però, grazie all’alta velocità
di connessione e ai nuovi strumenti per
la digitalizzazione, si possono facilmente
consultare siti int ernet dedicati allo
studio della lingua e alla divulgazione
dei contenuti lessicografici. Il più auto-
revole di questi, dedicato al lessico del-
l’italiano, è la Lessicografia della Crusca
in Rete (http://www.lessicografia.it) che
pubblica sul web le cinque edizioni del
Vocabolario dell’Accademia della Crusca.
Le prime quattro (1612, 1623, 1691,
1729-1738) sono consultabili sia in tra-
scrizione elettronica che in for mato
immagine; della quinta (1863-1923)
per ora sono disponibili solo le imma-
gini digitalizzate. Questo sito consente
un agevole confronto dell’evoluzione dei
lemmi nel corso dei secoli, su dizionari
che è difficile r eperire in alt ro modo.
Non va, poi, trascurato il Vocabolario
Treccani online, che contempla nelle
sue definizioni una breve ma rigorosa
sezione etimologica (http://www.trec-
cani.it/vocabolario/).
Di queste ed altre possibilità informa-
tiche ci si può proficuamente avvalere,
come si è fatto in questo breve studio,
che vuole offrire un esempio di appli-
cazione.
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
a cura di Giovanni Gobber - Università Cattolica, Milano
Risorse in internet per la storia della lingua Inglese, francese ed italiano nell’etàdell’Illuminismo: quando la concorrenzaera francese e l’insurrezione americanaLuigi Beneduci
1. M. Cortelazzo - P. Zolli, Dizionario etimologico della lin-gua italiana, 1a ed., Zanichelli, Bologna 1979-1988; orariedito in 2a ed. con CD-ROM, 1999.2. T. De Mauro - M. Mancini, Dizionario etimologico, Gar-zanti, Milano 2000.3. C. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano,Barbera, Firenze 1950-1957, 5 voll. 4. S. Battaglia - G. Barberi Squarotti, Grande dizionariodella lingua italiana, UTET, Torino 1961-2004 in 21 voll.,con Appendice a cura di E. Sanguineti e Indice degli Au-
tori citati a cura di G. Ronco, 2004.5. N. Tommaseo e B. Bellini, Dizionario della lingua ita-liana, ed. origin., Unione Tipografico-Editrice Torinese,Torino1861-1879, 4 voll. in 8 tomi, poi riedito nel 1915,1924 e 1929; le edizioni recentiori sono una ristampanella BUR, Rizzoli, Milano 1977 in 20 volumetti e una ri-produzione anastatica, UTET, Torino 2006, 4 voll. in 8tomi, come l’originale; l’edizione in CD-ROM, Zanichelli,Bologna 2004.
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 108
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 109
ITINERARI DIDATTICI PER LE LINGUE STRANIERE
Il dibattito sulle regole: i puristi...Il Settecento è stato un secolo di ampie
discussioni sulla norma, le forme ed i
modelli linguistici6: i dibattiti più accesi
si innnescarono intorno alla necessità di
liberare la lingua da una normativa au-
toritaria, come quella codificata dall’Ac-
cademia della Crusca. Il dibattito lingui-
stico si inseriva, così, nell’alveo di una
cultura razionalista, antidogmatica e
civilmente impegnata, quale fu quella
dell’Illuminismo.
Le scelte codificate nel Vocabolario della
Crusca, che nel 1729-38 aveva raggiunto
la quarta edizione, erano interpretate
come strumento di astratto pedantismo
e di intollerabile oppressione verso la li-
bertà intellettuale. La Crusca, infatti, pro-
poneva ancora come modello lo “scriver
toscano” degli autori del Duecento e del
Trecento. Il Vocabolario raccoglieva, sul
piano lessicale, voci e locuzioni arcaiche
a scapito della lingua parlata, mentre, per
la sintassi, proponeva un periodare am-
pio e complesso, di gusto latineggiante.
Tra i sostenitori di tali posizioni, i cosid-
detti “puristi”, bisogna almeno citare la
scuola napoletana di Lionardo di Capua
e Niccolò Amenta, orientati ad un’eru-
dizione grammaticale fine a sé stessa che,
secondo il critico giudizio del Galiani7,
si riduceva a voler riproporre il «pretto
stringato idiotismo toscano».
... e gli innovatoriTra gli oppositori del purismo linguistico
vanno invece ricordati Francesco Alga-
rotti, secondo il quale «chi dice […] delle
cose utili e buone alla civile società, può
fare senza le belle parole»8, e Giuseppe Ba-
retti, con la distruttiva e feroce critica al-
l’accademismo condotta sul suo perio-
dico, la “Frusta letteraria”,
dove si chiedeva una «lingua
vivace, spedita, atta a espri-
mere i bisogni di tutta la na-
zione»9. A fine secolo, infine,
Melchiorre Cesarotti, facen-
do perno sul nuovo concetto
di «nazione», proponeva il
concorso di tutti gli intellet-
tuali d’Italia, organizzati in
una sorta di «r epubblica»,
per liberarsi della «gabella»
della Crusca, proprio come
avevano fatto «gl’insurgenti
d’America», secondo il prin-
cipio che «l’uso fa legge»
nella lingua, quando essa
sia «universale e comune agli scrittori e
al popolo»10.
L’opposizione più radicale al passatismo
della Crusca, però, fu realizzata dal
gruppo illuministico milanese. Il più si-
gnificativo articolo sull’argomento, pub-
blicato sul “Caffè”, è la “Rinunzia avanti
Notajo del presente Foglio periodico al
vocabolario della Crusca” (1764), redatto
da Alessandro Verri.
Vi si promuove una lingua moderna ed
aperta verso le innovazioni (neologismi
e forestierismi) che permettessero una di-
vulgazione più immediata delle idee. Il
tono antidogmatico dell’articolo risulta
ancora più efficace per il fatto di non es-
sere privo di un acuto sarcasmo: «Se Pe-
trarca, se Dante, se Boccaccio, se Casa, e
gli altri testi di lingua hanno avuto la fa-
coltà d’inventar parole nuove e buone,
così pretendiamo che tale libertà conven-
ga ancora a noi: conciossiaché abbiamo
due braccia, due gambe, un corpo, ed una
testa, fra due spalle com’eglino l’ebbero».
La lingua, infatti, avendo come fine il
vantaggio morale e materiale dei lettori,
deve accogliere i termini, anche stranieri,
che le permettano di essere chiara ed ef-
ficace: gli accademici dei Pugni, quindi,
considerando che «ch’ella è cosa ragio-
nevole, che le parole servano alle idee, ma
non le idee alle parole», ritengono giusto
voler «prendere il buono quand’anche
fosse ai confini dell’Universo, e se dall’in-
da, o dall’americana lingua ci si fornisse
qualche vocabolo ch’esprimesse un’idea
nostra, meglio che colla lingua Italiana,
noi lo adopereremo».
6. Sull’argomento cfr. B. Migliorini, Storia della LinguaItaliana, Sansoni, Firenze 1960, ora Milano, Bompiani,2001, in particolare il par. Discussioni sulla norma lin-guistica, pp. 459-466.7. Ivi, p. 460.8. Lettera ad A. Zanon, citata da Migliorini, p. 457.
9. Ivi, p. 463.10. Così si esprimeva Cesarotti nel suo trattato Saggiosulla filosofia delle lingue, citato da Migliorini, pp. 464-65.11. É un'espressione di Devoto, citato da Migliorini, p.474.12. Lo stralcio del documento è riportato in E. Levasseur,
Histoire des classes ouvrières et de l'Industrie en Franceavant 1789, Rousseau Éditeur, tomo 2, Paris 1901, p. 201,nota 2. 13. Cfr. Migliorini, par. Francesismi, pp. 518 segg.14. Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2aed. 1989 in 20 voll.
Il frontespizio di una pubblicazione dell’Accademia della Crusca.
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 109
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX110
L’influenza del francese:francesismi e cambiamentisemanticiL’ampia circolazione delle idee, tipica del
cosmopolitismo settecentesco, unita al-
l’arretratezza dell’Italia ed allo sviluppo
delle altre nazioni e uropee, porta un
marcato aumento dell’influenza stranie-
ra sull’italiano.
Molto rilevante risulta l’influsso della lin-
gua francese: questa, per l’espandersi del-
la filosofia razionalista, ma anche per la
diffusione della moda e del buon gusto,
si impone come modello egemone in
Europa, tanto da far parlare, per l’Italia
del Settecento, di un «n uovo bilingui-
smo»11. Alcuni termini settecenteschi
giunti dal fr ancese sono usati anc ora
oggi: appartengono ai campi della moda
(cravatta, ciniglia, flanella, bleu, lillà), del-
la musica (rondò, minuetto) e del cibo
(bignè, cotoletta, ragù, gattò, dessert).
Simili termini furono, talvolta, anche
espressione di un atteggiamento tutto
sommato provinciale, che portò ad un
“infranciosamento” dell’italiano, già in
quel tempo oggetto di critiche ed ironie.
Più significative risultano invece le alte-
razioni semantiche, ovvero i cambia-
menti di significato, di parole già esisten-
ti, dovute all’influenza del fr ancese:
sono questi che testimoniano quanto ab-
biano agito profondamente i mutamenti
in campo culturale, politico ed econo-
mico dell’epoca.
Dalla concorrenza in amorealla rivalità commercialePer lo studio delle alterazioni semanti-
che, si possono efficacemente applicare
le risorse in rete: un esempio può essere
costituito dai diversi significati assunti
dal termine concorrenza. Osserviamone
l’evoluzione attraverso le accezioni re-
gistrate dai dizionari in differenti periodi
e contesti.
La quarta edizione del Vocabolario
della Crusca (cfr. Crusca in R ete
http://www.lessicografia.it) indica i si-
gnificati impiegati nel corso della storia
letteraria ed ammessi dalla c omunità
colta all’inizio del Settecento. Qui con-
correnza presenta due accezioni: indica
la «competenza», che lo stesso vocabo-
lario definisce come il «competere», os-
sia il gareggiare o contendere, nel senso
della aemulatio latina. Gli esempi lette-
rari che accompagnano il termine, però,
testimoniano come tale “competizione”
fosse riferita soltanto ai campi semantici
dell’eleganza, della guer ra e persino
dell’amore (così il Berni nella riscrittura
dell’Orlando innamorato:«E non amor
al mondo, che si metta / A concorren-
za»), ma non all’economia.
L’evoluzione settecentesca del termine
si realizza quando concorrenza, sul mo-
dello della lingua francese, viene appli-
cato anche ai rapporti economici. Rea-
lizzatasi nel Settecento, l’accezione si af-
ferma in Italia nella prima metà dell’Ot-
tocento: infatti già il Tommaseo-Bellini
(è consultabile on-line il primo volume
al sito http://www.dizionario.org) ag-
giunge ai significati tradizionali la pre-
cisazione: «Nel senso commerciale e, più
in generale, nell’economia: libera con-
correnza».
Che l’accezione economica sia giunta dal
francese ce lo assicura un’altra risorsa di-
sponibile in rete: di tratta del sito web
del Centre National de Resources Textuel-
les et Lexicales (http://www.cnrtl.fr/ety-
mologie/). Creato nel 2005 dal CNRS
(Centre National de la Recherche Scien-
tifique) con la collaborazione dell’ATILF
(Analyse et Traitement Informatique de
la Langue F rançaise) - U niversità di
Nancy, il sito riunisce numerosi stru-
menti per l’elaborazione del linguaggio
(lessici, sinonimi, antonimi, ecc.) tra cui
un puntuale vocabolario etimologico.
Le etimologie del CNRTL fanno risalire
la prima attestazione di «concurrence»
intesa nel senso di «rivalité commerciale»
alle doléances della Délibération de la salle
de Saint-Louis datate 16 luglio 1648; già
nel XVII secolo in Francia ci si lamenta
che «La concurrence des drapieres d’An-
gleterre et de l’H ollande a réduit un
nombre infini de petit peuple à la men-
dicité»12.
Così nasce un termine che ancora segna
il linguaggio economico della nost ra
contemporaneità e che si potrebbe im-
maginare più collegato al “liberismo” in-
glese. La Francia, invece, inserita in un
contesto economico fortemente svilup-
pato, fu tra le prime nazioni a sperimen-
tare, e quindi ad avvertire l’esigenza di
nominare, la concorrenza come uno dei
più importanti fenomeni del capitalismo
moderno.
Migliorini offre numerosi suggerimenti
per condurre ricerche analoghe13: nel
Settecento il sostantivo genio acquista il
nuovo senso di uomo di alto ingegno; i
termini manifattura e stabilimento acqui-
stano il senso moder no di fabbr ica;
prodotto definisce il fr utto del la voro
umano in campo industriale; progresso
assume un senso ast ratto per indicare
l’avanzamento civile dell’umanità; pub-
blico da aggettivo diviene un sostantivo
indicante coloro cui si rivolge un’opera;
sensibile è detto di chi si commuove, se-
condo i principi del sensismo.
Gli anglo-italiani: inocularedalla botanica alla medicinaLa risorsa più rigorosa della rete per
quanto concerne l’inglese è la versione
on-line del classico dizionario Oxford
English Dictionary [OED]14 che presenta
una nutrita sezione etimologica. Pur-
troppo alla c onsultazione del sit o
(http://www.oed.com/) si accede me-
diante una costosa sottoscrizione.
Utilizzando, comunque, dizionari eti-
mologici, cartacei oppure on-line, si pos-
sono studiare i notevoli anglo-latinismi
settecenteschi in ambito scientifico e po-
litico, che testimoniano campi di eccel-
lenza della civiltà inglese.
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 110
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 111
In campo medico, ad esempio,
si può seguire l’evoluzione del
termine inoculare, dall’inglese
to inoculate, che deriva dal la-
tino inoculatus (da in+oculus,
col valore traslato di “fessura”,
al posto di quello originale di
“occhio”).
In Inghilterra nel Cinquecento
esso era ancora impiegato per
indicare l’atto di innestare una
gemma su un alber o, ma a
partire dal 1714 lo t roviamo
usato in patologia, per indicare
l’inserimento, in un c orpo
sano, di un agente patogeno al
fine di produrre immunizzazione.
Questa accezione nasce dall’interessa-
mento di Lady Mary Wortley Montagu,
moglie dell’ambasciatore inglese a Co-
stantinopoli. Ella, dopo aver osservato
tale pratica impiegata in T urchia per
provocare una rozza immunizzazione
dal vaiolo, e dopo averla fatta applicare
a suo figlio, la introdusse per la prima
volta in Inghilterra, dando origine così
alla sperimentazione medica in Europa.
In Italia inoculazione si affiancherà, at-
traverso l’inglese, all’italiano innesto: an-
ch’esso originariamente indicava l’inne-
sto botanico, ma poi passerà ad assume-
re un’accezione medica. Il più famoso
impiego con questo valore è testimonia-
to dall’ode di Parini L’innesto del vaiuolo
(1765); ma g ià Algarotti, prima del
1764, aveva usato in ambito medico-fi-
siologico inoculare ed innestare come si-
nonimi. Nel linguaggio medico attuale,
però, sarà il vocabolo di origine inglese
a prevalere, mentre l’innesto tornerà a
circoscriversi in ambito agricolo.
L’antica Roma rivive aFiladelfia: costituzione,presidente e insurrezioneIn campo politico, invece, è interessante
la storia del termine costituzionale: seb-
bene questo termine derivi dal latino con-
stitutionem, il suo moderno significato
e la sua diffusione nel mondo contem-
poraneo non transita attraverso l’italiano,
bensì dall’inglese constitutional.
Il termine italiano costituzione, secondo
l’edizione settecentesca della Crusca,
infatti, indica la «constituzione» intesa
come l’«ordine», il modo in cui qualcosa
è costituito; può indicare anche il «tem-
peramento» ossia lo «stato del corpo»,
definito anche «complessione»; e solo per
via indiretta, come sinonimo, infine,
equivale a «statuto», cioè «legge» valida
in un luogo (come i latini statutum, con-
stitutio, lex municipalis).
In Inghilterra, invece, a partire dal Sei-
cento constitution indica specificamente
l’organizzazione di uno Stato e dal Set-
tecento l’insieme dei principi che gover-
nano una società.
Il termine, infine, passerà a definire il do-
cumento che raccoglie le legg i fonda-
mentali di uno Stat o, quando la storia
politica si salda alla storia delle parole: ciò
avvenne quando dodici colonie inglesi ri-
belli diedero vita alla prima Costituzione,
appunto, quella degli Stati Uniti d’Ame-
rica (1787).
Attraverso un percorso simile, il latino
praesidentem (dal verbo latino praesidere)
dà luogo al termine inglese president, che
diviene in italiano presidente. Il primo
impiego del termine, per indicare chi de-
tiene il potere esecutivo in una Repubbli-
ca, si riscontra nella stessa Costituzione
degli Stati Uniti, dopo che aveva indicato
prima il r esponsabile del Cong resso
Continentale (1774), e precedentemente
i singoli governatori delle colonie (dal
1608) a partire dalla Virginia. Allo stesso
modo, dal latino insurrectio deriva l’ita-
liano insurrezione con la mediazione
dell’inglese insurrection, usata per indicare
proprio l’insurrezione americana. Questo
avvenimento dimostra così, anche per
verba, la sua c entralità nella storia del
mondo occidentale.
Di questi ed altri termini è interessante
confrontare le accezioni ammesse dalla
nostra tradizione letteraria con i significati
che maturano nel nuovo contesto stori-
co-sociale dell’età dell’Ill uminismo in
Francia e nel mondo anglosassone: la sto-
ria delle parole diviene così uno strumen-
to privilegiato per conoscere il percorso
della nostra modernità.
Luigi Beneduci ISIS “F.De Sarlo” di Lagonegro e “N.Miraglia” di Lauria (PZ)
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 111
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX112
IntroductionCLIL is an approach which has already
been widely developed throughout
Europe; in Italy, a law (Legge Moratti,
53/2003; D.L. 17.10.2010 n. 226) requires
its adoption during the final year of Liceo,
Istituto Tecnico non professionale and
from the thir d year of the Liceo
Linguistico. This law does not envisage the
language teacher as a CLIL expert, even
if over the years it has been mainly the
language professors that have advanced
the cause of CLIL and been convinced of
its validity. Despite that fac t that in
most European countries CLIL is carried
out by content teachers, the supporting
and collaborative role of the language
teacher is still m uch needed if this
approach – whic h calls for a balanc e
between content and language objectives
– is t o be e xploited in the best wa y
possible.
For the abo ve-mentioned reasons
language learning risks becoming of
secondary importance with respect to
content learning, given that c ontent
teachers tend, because of their education,
to give a prevalent role to the teaching of
the subject matter (Dafouz Milne, 2011).
It is very likely that the CLIL approach
adopted by content teachers will be
mainly based only on one t ype of
language learning, the so-called incidental
learning, which derives mainly fr om
the teacher’s input. Precisely for this
reason the input must be particularly well
prepared, and in this sense, language
teachers can play a supporting role for the
content teachers, guiding them towards
an awareness of the importance of this
support. The input – that is, the language
the learners are exposed to, is thus a
crucial aspect in CLIL, as it is in all
processes of teaching-learning.
This article is the result of a Doctorate in
Education in the UK, during which the
input presentation strategies used by
CLIL teachers were analysed.
The results from some 20 hours of
lesson transcriptions evidenced some
common input presentation strategies
found in the literature as well as others
that had not been explicitly mentioned
in the references. The results presented
in the present article started from this
data in order to see whether these new
input presentation strategies would be
judged positively by the students, as
well. In order to test these defamiliarising
input presentation strategies a v ery
straightforward questionnaire was given
to 126 students who had e xperienced
CLIL.
These new strategies (henceforth called
defamiliarising) are: the use of humour,
focusing on form (regarding grammar,
lexis and pr onunciation) and
codeswitching. They have been defined
as defamiliarising input presentation
strategies because, from the lesson
observations, it seemed the y were
adopted during moments of focus and
greater attention on the par t of the
students (see also section 2). These input
strategies, could be particularly useful for
emphasising conceptual and linguistic
aspects and maintaining in equilibrium
that continual balance of stance between
teacher and stud ent typical of school
contexts. To the best of my knowledge no
one has yet dealt with these categories in
the CLIL context.
Tenets of CLILCLIL (Content and Language Integrated
Learning) is an approach that calls for the
integrated teaching-learning of language
and content. It can be undertaken at any
school level, from primary school to
higher education, and can in volve any
language and non-linguistic content.
The term CLIL appeared in the 1990s on
the heels of a number of programmes
already in place in Europe.
1995 represented an important starting
point: a Council of Europe Resolution
stated that teaching a foreign language
through other disciplines constituted a
highly innovative approach and a
European Commission White Paper on
Education and Training spoke of a similar
concept. The growing influence of CLIL
is shown by the fact that since 2000 all
European Socrates programmes
sponsoring teachers and lea rners have
promoted CLIL, and that in 2003 th e
European Commission, in its 2004-2006
Action Plan, openly stated that CLIL
represented a valid methodolog y.
Moreover, there is an entire page on the
Council of Europe internet site devoted
to CLIL
(http://ec.europa.eu/education/languages/
language-teaching/doc236_it.htm).
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
Defamiliarising Input Presentation Strategies in CLIL
What do Students Think? Francesca Costa
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 112
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 113
ITINERARI DIDATTICI PER LE LINGUE STRANIERE
This is the definition that Llinar es,
Morton and Whittaker (2012, p. 1) use for
CLIL “a bilingual approach in which the
study of an academic content is combined
with the use and lear ning of a for eign
language”. First adopt ed to improve
language proficiency (Dalton-Puffer 2007),
experts have increasingly come around to
the view that content as well as language
are involved in the learning process
(Coonan 2007a,b) and that a “promise” is
intrinsic in the acronym CLIL: that is, “that
content be learnt through the language and
that language be learnt through content,
contemporaneously” (Coonan 2008, p. 14).
Research on the advantages of CLIL is still
fully underway, though increased
motivation (Coyle, Hood and M arsh
2010) certainly seems t o be a st rong
point for this method. Moreover, the value
added of CLIL could also be cognitive in
nature: that is, the fusion of language and
content. It is still not clear, however, what
this cognitive value exactly consists of. This
could well be what Dodman (2009, p. 55)
calls defamiliarisation as regards the
learning of technical vocabulary at school
level, though it could also be applied t o
input strategies as well. This discordance
surprise factor could make input more
noticeable and therefore lead to a deeper
learning process.This paper starts, in fact,
from this assumption.
Taxonomy of ReferenceBelow the input presentation strategies
examined in this paper will be illustrated,
beginning with focus on for m and
codeswitching, which is understood as
belonging to the focus on form category.
The other cat egory – h umour – w ill
then be analysed.
Focus on Form as a Type ofInput PresentationTwo of the most famous theor ies on
second language acquisition – the input
hypothesis and focus on form – share the
belief that the learning of a language is
optimised when it is undertaken within
a focus on meaning c ontext (Krashen
1985; Long 1991). CLIL is par excellence
such a context, and it is th us ideal for
learning language in addition to content.
By input it is meant the language the
students are exposed to. For Krashen
(1985) it is fundamental that the language
be understandable and pr esented at a
slightly higher level than that acquired by
the students in order to stimulate them
toward new learning. In Krashen’s view,
called Input Hypothesis, language
learning by the student should occur in
an incidental or implicit manner: that is,
directly from being e xposed to the
comprehensible input.
On the other hand, by focus on form it
is meant a particular attention to language
in meaning-focused contexts. Thus this
strategy is seen as moments dur ing
which the teacher focuses on a language
aspect during a c ontent lesson (Ellis,
Basturkmen and Loewen 2001). Such
focus on form moments represent times
when the language is viewed as an object
of learning and not as a vehicle. In this
paper focus on form is understood as a
form of comprehensible input.
In this sense focus on form is important
for CLIL since it could facilitate the so-
called fusion context between linguistic
and content objectives. In fact, focus on
form is, according to Lyster (2007), a way
to achieve a counterbalanced approach
through which form and c ontent are
integrated.
There are various types of focus on
form: phonological, grammatical and
lexical, according to the language aspect
in question. Moreover, focus on form can
be reactive or proactive, where reactive
(explicit) refers to moments of linguistic
focus that ar ise from communication
problems that gener ally concern the
students and pr oactive (implicit) t o
moments where it is the teacher himself
who perceives the need t o focus on
language even in the absence of any
student doubts. Focus on form should not
be confused with focus on forms that refer
to an explicit teaching of linguistic forms
for the entire teaching-learning process.
Few researchers have tried to list the
effective input st rategies used by CLIL
teachers in the presentation of input to the
students. Coonan (2002) lists the
following: using discourse markers, using
repetitions, using e xamples, using
synopsis/summaries, using definitions,
explaining, re-using lexis, using synonyms,
using paraphrasis, reformulating, asking
for questions, slowing down the pace of
speaking, emphasising thr ough
intonation, articulating words clearly.
The present paper will instead introduce
new strategies.
CodeswitchingThe concept of focus on for m also
includes codeswitching: that is, the
alternance between L1 and L2 typical in
contexts of bilingual speak ers (Cook
2001). Over time this concept has suffered
greatly because it was thoug ht to be
harmful to learning. During the last ten
years several studies ha ve instead
underscored its impor tance (Coonan
2007; Gajo 2001). That said, it is clear that
the amount of codeswitching must be
adjusted to the le vel of the students
(Costa 2009) and that ignoring this could
invalidate or impoverish the learning.
3.2. Humour Despite the fact that there have been many
studies on h umour and w it, especially
regarding psychology and lit erature,
almost all of these refer to and have as
their object nati ve speakers. There are
fewer studies on humour in education,
especially concerning non-native speakers.
Norrick (1993) held that in r eality the
various forms are all contained inside a
continuum. Humour has the advantage
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 113
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX114
of relieving the tension and it is a way to
recognise affiliation. Along the same lines,
anecdotes, especially if they are humorous,
strengthen relationships; funny stories
help to create a positive idea of the person
who tells them. Wordplays and puns, on
the other hand, are more difficult to find,
especially in the corpora of non-native
speakers. A year after Norrick, Stuart and
Bank (1994) under took a stud y of 195
students using a questionnaire. The results
demonstrate that humour makes the class
less formal, that negative humour should
not be used, as it is highly counterproductive,
and that a lack of humour is seen as a sign
of formality.If, as the studies presented here
show, humour is not only a pedagogical
motivator but also a wa y to enhance
understanding of content, then it is clear
that it should be widely used in CLIL
courses, though with the necessary caution,
since the teachers in this case are non-
native speaking.
What works?Starting from the assumption that CLIL
is a g rowing phenomenon and that
precisely for this reason there is need for
research into the strategies to implement
the approach, 126 students were asked to
give their o pinion on se veral
defamiliarising input presentation
strategies. The CLIL literature has studied
several common input pr esentation
strategies in depth while ignoring others
that have turned out inst ead to be
important. The present study in some
ways complements a pr eceding one
which noted, through a c orpus of
transcriptions and obser vations, that
several non-common strategies (use of
humour, focus on for m and
codeswitching) created discordant
moments in which the students appeared
to be more attentive, for which reason
they were called defamiliarising. Given
that the previous study was lacking the
opinion of the students regarding these
strategies, the decision was made t o
supply this missing information.
The results of the study reveal that all
these strategies are held to be important
by the students. In order of appreciation
there is the use of humour, all types of
focus on form (pronunciation, lexical,
grammatical) and codeswitching, which
is the most controversial strategy. Thus
all these less-common, though not for
that less effec tive, input pr esentation
strategies should be added to the
common input presentation strategies
presented in the reference literature.
Moreover, the impor tance of these
mainly linguistic categories can be very
important for CLIL language teachers in
that they could aid those content teachers
who perhaps are less a ware of the
importance of the input.
Francesca Costa Università Cattolica, sede di Milano
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
REFERENCES
V. Cook, Using the First Language in the Classroom, «The Canadian Modern Languages Review/La révue canadienne des langues vivan-tes», 57, 3, (2001), pp. 402-423.C. M. Coonan, La lingua straniera veicolare, UTET, Torino 2002.C. M. Coonan, How are Students Engaged in Subject Learning through the Foreign Language? Activities for Learning in a CLIL Environment,in D. Marsh, D. Wolff, (a cura di) Diverse Contexts-Converging Goals: CLIL in Europe, Peter Lang, Frankfürt 2007a.C. M. Coonan, Insider Views of the CLIL Class through Teacher Self-Observation-Introspection, «International Journal of Bilingual Educa-tion and Bilingualism», 10, 5, (2007b), pp. 625-646.C. M. Coonan, The Foreign Language in the CLIL lesson. Problems and Implications, in C. M. Coonan, (a cura di) CLIL e l’apprendimento dellelingue. Le sfide del nuovo ambiente di apprendimento, Libreria Editrice Ca’Foscarina, Venezia 2008.D. Coyle - P. Hood, - D. Marsh, CLIL Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, Cambridge 2010.F. Costa, Code-switching in CLIL Contexts, in C. Escobar Urmeneta, N. Evnitskaya, E. Moore, A. Patiño, (a cura di) AICLE – CLIL – EMILE: Edu-cació plurilingüe. Experiencias, research & polítiques, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona 2011.E. Dafouz Milne, English as a Medium of Instruction in Spanish Contexts, in Y. Ruiz de Zarobe, J. M. Sierra, F. Gallardo del Puerto, (a cura di)Content and Foreign Language Integrated Learning, Peter Lang, Bern 2011.C. Dalton-Puffer, Discourse in Content-and-Language-Integrated Learning (CLIL) Classrooms, John Benjamins Publishing Group, Am-sterdam/Philadelphia 2007.M. Dodman, La sperimentazione della L2 veicolare nella scuola primaria: verso il curricolo plurilingue, in S. Lucietto, (a cura di) Plurilingui-smo e innovazione del sistema, IPRASE Trentino, Trento 2009.S. Krashen, The Input Hypothesis Issues and Implications, Laredo Publishing, Lincolnwood, 1985.R. Lyster, Learnin g and Teaching Languages through Content, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2007.R. Ellis – H. Basturkmen – S. Lowen, Preemptive Focus on Form in the ESL Classroom, «TESOL Quarterly», 35, 3, (2001), pp. 407-432.L. Gajo, Immersion, bilinguisme et interaction en classe. Didier, Paris 2001.M. Long, Focus on Form: a Design Feature in Language Teaching Methodology, in Foreign Language research in Cross-Cultural Perspective,K. de Bot, R. Ginsberg, C. Kramsch (a cura di), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1991.R. Norrick, Conversational Joking in Everyday Talk, Indiana University Press, Bloomington 1993.W. D. Stuart - C. Bank, Student Perceptions of Teacher Humor and Classroom Climate, «Communication Research Reports», 11, 1, (1994), pp. 87-97.
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:43 Pagina 114
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 115
ITINERARI DIDATTICI PER LE LINGUE STRANIERE
Osservando le r epliche alle do-
mande nei dialoghi ci si può ren-
dere conto di come funzionino
certi processi della comunicazione verbale.
Spesso infatti la replica tiene conto di una
dimensione implicita che sottende all’im-
pianto del testo e si pone nel mondo con-
diviso dagli interlocutori. A volte questa
dimensione si cattura facilmente; altre vol-
te richiede un certo lavoro di analisi. Pe-
raltro, gli interlocutori di solito afferrano
rapidamente l’implicito, cioè colgono le
informazioni che la pratica quotidiana ha
loro insegnato a sc oprire dietro alle
forme linguistiche.
La strategia che vorrei qui illustrare è quel-
la delle domande implicite che vengono
inferite da domande esplicite. Nei testi let-
terari troviamo molti esempi che meri-
tano attenzione. L’insegnante potrà invi-
tare gli studenti ad analizzare i dialoghi
di un’opera in lingua, cercando di spiegare
le ragioni di una replica verbale, che a pri-
ma vista non sembr a rispondere alla
domanda che l’ha provocata. I procedi-
menti qui descritti si trovano in testi di
ogni genere e di ogni lingua d’Europa. Le
osservazioni che riguardano uno scambio
di battute in italiano si possono cioè esten-
dere a mosse dialogiche manifestate per
mezzo di altre lingue.
Occorre anzitutto precisare che, nei
testi «naturali», le domande si possono
presentare anche in mod o implicito,
come nell’ipotetico scambio che segue:
Luigi: Sarai stanco morto... / Pietro: No, anzi. Ho ancora energie da ven-dere.
Dalla battuta di Luigi, Pietro ritiene di de-
rivare una domanda (sei stanco, non è
vero?). La r isposta è c onseguenza di
un'ipotesi interpretativa che Pietro ha for-
mulato a torto o a ragione («[…] à tort
ou à raison», dice Sorin Stati (1990, p. 35).
Non è detto, infatti, che Luigi abbia
inteso comunicare una domanda impli-
cita. È piutt osto l’interpretazione del
testo fatta da Pietro a far emergere quel
sottinteso che si rivela decisivo per il pro-
sieguo del dialogo. Meno problematici
sono altri casi, nei quali un locutore fa una
domanda esplicita di verifica (in ingl. yes-
no question). L’interlocutore recupera
una domanda complementativa (wh-
question) implicita, che serve per orientare
la risposta.
1. In un primo tipo, la domanda inferita è
attivata sia con una risposta affermativa
sia con una negativa; in altre parole, non
si risponde in modo completo replicando
soltanto con un sì o con un no:
Stai via molto? [ ➛Per quanto tempo staivia?]Sì, sto via per un mese. / No, torno dopo-domani.
Come mostrano gli esempi che seguono,
la “profrase” nella risposta (cioè il sì o il
no) può essere omessa:
«C’è ancora molta strada?»«Non molta, forse due ore e mezzo, anchetre forse, di questo passo. Forse per mezzo-giorno ci siamo, effettivamente» (Buzzati,Il deserto dei Tartari, p. 13)
«Dove mi porti?» / «Ti porto dove dormo»./ «È lontano?» / «In fondo a corso Sempio-ne» (Vittorini, Uomini e no, p. 6)
Alla ricerca delle domandeimplicite nei dialoghi Proposte per un esercizio di analisiGiovanni Gobber
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:44 Pagina 115
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX116
2. In un secondo caso, se si risponde nega-
tivamente, basta che sia considerata solo
la domanda esplicita; invece, se la risposta
è affermativa occorre tener conto della
domanda implicita. La semplice replica
sì è avvertita come una risposta incom-
pleta o insoddisfacente
Pietro: È arrivato qualcuno? [Se sì ➛chi èarrivato?] Luigi: No [non è arrivato nessuno / alcuno]./ Sì, è arrivata Maria.
Rispondendo affermativamente, si può
tralasciare la profrase sì, come negli
esempi che seguono:
IL CAPOCOMICO (battendo le mani) Su,su cominciamo.Al Direttore di scena: Manca qualcuno?IL DIRETTORE DI SCEN A Manca laPrima Attrice.IL CAPOCOMICO Al solito! (guarderàl'orologio)(Pirandello, Sei personaggi in cerca d'au-tore, p. 26)
Ma in fondo, al nord, si vedrà bene qual-cosa?All'orizzonte di solito ci sono le nebbie – dis-se Morel [...] Ci sono le nebbie del nord che
non lasciano vedere (Buzzati, Il deserto deiTartari, p. 28)
Il dialogo procede in modo naturale,
come nella conversazione quotidiana.
Analoghe osservazioni si possono svol-
gere per altre lingue. Per esempio, con-
sideriamo l’inglese. Una serie di dialoghi
scritti, reperiti online (http://eng lish-
the-international-language.com) con-
tiene alcuni esempi c he fanno al caso
nostro:
- Are you married? - Yes, I am. - And do you have any children? - Yes, two.
- Do you have anything to declare, sir? - Just some wine and cigarettes.
La strategia è frequente nelle domande
che servono per offrire qualcosa:
- Would you like anything to drink? - Yes, a bottle of red wine please.
Vediamo alcuni esempi tratti da testi di
fiction:
“But, after all, brains are not the best thingsin the world”“Have you any?” enquired the Scarecrow.
“No, my head is quite empty”, answered theWoodman […](F. Baum, The wonderful wizard of Oz, p.58)
L’aggiunta my head is quite empty non ag-
giunge contenuto; è piuttosto una riela-
borazione della risposta no (non avere
cervello = avere il cranio bello vuoto...).
3. È possibile una strategia inversa: si ri-
sponde affermativamente alla domanda
esplicita, mentre la risposta negativa tie-
ne conto di una domanda complemen-
tativa implicita. Non è risposta completa
la semplice replica No:
Sei arrivato ieri? ➛ [Se no, quando?]Sì. / No, sono qui dalla settimana scorsa.
Esempi:
«Siete ebrei tutti e dieci?»«No, solo sei: io, le due donne, il giovane chesta sempre con la ragazza piccola, quello an-ziano che tu hai portato sulle code, e PavelJurevi, il più robusto di tutti [...]» (Primo Levi, Se non ora, quando?, p. 73)
La risposta può tralasciare la profrase No:
«Siete tedeschi?»
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:44 Pagina 116
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 117
ITINERARI DIDATTICI PER LE LINGUE STRANIERE
«Siamo russi» risposero i due (Primo Levi, Se non ora, quando?, p. 32)
«Dì loro che oggi non posso andare».«Andrai domani?»«Forse nemmeno domani. Andrò una voltao l’altra, ma tu non prendermi impegni.Andrò col treno» (Vittorini, Uomini e no, p. 192)
[…] some minutes later, when he turnedtowards me, I said, using one o f his ownexpressions in the Torres Straits:«An incident, Captain?»«No, sir; an accident this time».«Serious?»«Perhaps». (Jules Verne, 20,000 Leagues Under the Sea,p. 231)
«Is soldiering your regular profession, Mr.Hastings? »«No, before the war I was in Lloyd's».(Agatha Christie, The Mysterious Affair atStyles, p. 6)
Soprattutto una r isposta negativa è
spesso accompagnata da una spiegazio-
ne, che serve ad attenuare la negazione:
«Tell me, Ned», said I, «can you recognisewhat country she [si riferisce a una nave checompare all’orizzonte] belongs to?»The Canadian knitted his eyebrows,dropped his e yelids, and s crewed up thecorners of his eyes, and for a few momentsfixed a piercing look upon the vessel.«No, sir», he replied; «I cannot tell whatnation she belong s to, for she show s nocolours […]».(Verne, 20,000 Leagues Under the Sea, p.266)
4. A volte, una domanda pone esplicita-
mente una constatazione, che di per sé
è ovvia e dunque non giustifica l'appello
a rispondere. Tuttavia, chi risponde
tende spesso a cogliere una richiesta im-
plicita di spiegazione (Non hai fame? ➛Perché non hai fame?):
«Non bevi la tua birra con me? Già te nevai?»«All'albergo c'è molto da fare» (Vittorini, Uomini e no, p. 193)
«Yes, indeed, Mr. Naturalist», he replied;«and we are going to fight them, man tobeast». I looked at him. I thought I had not heardaright.«Man to beast?» I repeated.«Yes, sir. The screw is stopped. I think thatthe horny jaws of one of the cuttlefish isentangled in the blades. That is w hatprevents our moving». (Verne, 20,000 Leagues, pp. 251-252)
«Is it possible? My poor friend! You have notyet realized that it was Miss Howard whowent to the chemist’s shop?"«Miss Howard?"«But, certainly. Who else? It was most easyfor her.(Agatha Christie, The Mysterious Affair atStyles, p. 155)
5. In questi tipi di domande, le repliche ac-
cettabili tengono conto della domanda
implicita. L'inferenza è, per così dire, isti-
tuzionalizzata: gli interlocutori sono
consapevoli di gestire la comunicazione
avvalendosi di st rategie previste nella
prassi dialogica.
Certe repliche sono inac cettabili in
quanto non sono c ooperative: repli-
cando con un semplice sì alla domanda
Hai visto qualcuno? non si viene incontro
alle attese di chi interroga. In altri casi,
la domanda pertinente deve essere infe-
rita: Non mangi? ➛Perché non mangi?).
Poiché l'interrogante presume che il
proprio interlocutore conosca la strategia
adottata, la replica non cooperativa è in-
terpretata per lo più come polemica (ri-
fiuto di cooperare: No, non mangio). Ma
la violazione della massima può essere
solo apparente: è possibile che la replica
sia cooperativa, ma che richieda un'in-
ferenza ulteriore: A: Hai incontrato
qualcuno? B: Sì, certo (➛«Puoi immagi-
narti chi»).
L’ultimo tipo di domanda sopra consi-
derato (Hai visto qualcuno?) è una tipica
safe question: chi la usa evita di porre pre-
messe che il secondo locutore potrebbe
smentire. È possibile una semplice rispo-
sta affermativa, che sollecita la domanda
ulteriore chi hai visto?, basata sul presup-
posto «hai visto qualcuno».
Ma in uno scambio c ooperativo di
solito non è nec essario che questa sia
proferita: come abbiamo infatti visto, il
secondo locutore è invitato a inferirla di-
rettamente; così, alla eventuale risposta
affermativa (che può anche essere sot-
tintesa) segue direttamente la risposta
alla domanda complementativa. Tornia-
mo all’esempio dei Sei personaggi di Pi-
randello:
IL CAPOCOMICO […] Al Direttore discena: Manca qualcuno?IL DIRETTORE DI SCENA Manca la Pri-ma Attrice.
Con una domanda «sicura» il capoco-
mico gestisce in modo appropriato la
continuazione del dialogo e il direttore
di scena replica anticipando una mossa
successiva. Invece, avviando subito il dia-
logo con la domanda chi manca?, il ca-
pocomico potrebbe correre il rischio di
introdurre una premessa non condivisa
da chi risponde: infatti, se tutti fossero
presenti, non avrebbe senso presupporre
che manchi qualcuno. Per questo moti-
vo, chi manca? è una d omanda «ri-
schiosa» (risky, cfr. Wunderlich 1981).
Per casi simili, si è proposta un’interes-
sante analisi (F auconnier 1981). Po-
niamo che il locuot ore, proferendo
Manca qualcuno? compia con essa una
tipica safe question, che invita a inferirne
una “rischiosa”. Per cogliere questa fun-
zione della frase proferita, l'interlocutore
tiene conto dell'azione di vari fattori.
Vi è anzitutto un principio di interruzio-
ne: proferendo quella frase, si interroga
su una premessa positiva di una doman-
da “rischiosa” (Chi manca?); come è su-
bito evidente, la risposta positiva costi-
tuisce una situazione che permetterebbe
di proferire Chi manca?
Ma colui che risponde conosce tale
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:44 Pagina 117
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX118
procedimento e abbrevia («interrom-
pe») l’esecuzione del «rituale» reagendo
non alla frase «letterale», ma alla richie-
sta successiva: il principio di interruzio-
ne è connesso con un principio di eco-
nomia.
Si ha pure un’anticipazione sociale.
La frase Manca qualcuno? verte su una
condizione che, se è soddisfatta, attiva
la domanda implicita; l'interlocutore an-
ticipa il proferimento di Chi manca? ri-
spondendo fin da subito alla domanda
inferita.
La descrizione delle pratiche dialogiche
sopra considerate mette in luce valori
che hanno per tinenza all’interno di
uno specifico quadro di riferimento cul-
turale – nella fattispecie, quello della tra-
dizione europea occidentale in senso
ampio. In effetti, gli studiosi attenti alle
dinamiche della comunicazione inter-
culturale, pur muovendo da vari orien-
tamenti teorici, sono concordi nell’os-
servare che i valor i specifici di una
cultura non si lasciano ridurre a «mo-
nolingual universals or static g lobal
comparisons» (Clyne 1996, p. 196).
Piuttosto, questi vanno c ompresi ed
esplicitati all’interno della cultura in esa-
me e ad essa vanno ricondotti:
It is impossible for a human being to studyanything […] from a totally extra-culturalpoint of view […] We can find a point ofview which is universal and cultur al-independent, but we must look for such apoint of view not outside all humancultures […] but within our own culture,or within any other culture that we ar eintimately familiar w ith (Wierzbicka1991, p. 9).
A dire il v ero, attraverso l’esperienza
concreta della comunicazione tali valori
possono essere individuati anche da un
soggetto che non sia cresciuto in quella
cultura, a patto che quest’ultimo sia di-
sposto ad accogliere la diversità culturale
e a farne esperienza. Ma per compren-
dere e sperimentare la diversità delle cul-
ture nella comunicazione sembra ragio-
nevole porre come requisito una com-
prensione e una esperienza autentica
della propria cultura specifica. A tale
scopo può essere utile anche la descri-
zione delle domande implicite qui pro-
posta.
Giovanni GobberUniversità Cattolica,
sede di Milano
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
BIBLIOGRAFIA
M. Clyne, Inter-cultural communication at work. Cultural values in discourse. Cambridge University Press, Cambridge 1996 [1994].G. Fauconnier, Questions et actes indirects, «Langue Française» 52, 1981, 44-55.C. Kerbrat-Orecchioni (dir.), La question, PUF, Lyon 1991.D. Sperber e D. Wilson, Relevance. Communication and Cognition, Basil Blackwell, Oxford 1986.S. Stati, Le transphrastique, PUF, Paris 1990.A. Wierzbicka, Cross-Cultural Pragmatics, Mouton de Gruyter, Berlin 1989. D. Wunderlich, Questions About Questions, in W. Klein e W. Levelt (a cura di), Crossing the Boundaries in Linguistics. Studies Presentedto Manfred Bierwisch, Reidel, Dordrecht 1981, pp. 131-158.
OPERE LETTERARIE CITATE
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari [1940], Mondadori, Milano 1989. Primo Levi, Se non ora, quando?, Einaudi, Torino 1982.Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore [1921], Mondadori, Milano 1990. Elio Vittorini, Uomini e no [1945], Mondadori, Milano 1996.Frank Baum (with pictures by W.W. Denslow), The wonderful wizard of Oz, Geo M. Hill Co., Chicago 1900Agatha Christie, The Mysterious Affair at Styles, www.gutenberg.orgJules Verne, 20,000 Leagues Under the Sea, www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/julesverne/20000leagues.pdf
NS5 108-118 lingue:Layout 1 15-11-2012 16:44 Pagina 118
contaminato da un’«essenziale
ambiguità» (p. 145). Prova ne è
un tratto che tocca il cuore della
creazione in generale e di quella
artistica in particolare: la «recetti-
vità attiva» (p. 175).
Mettendo finalmente a fuoco il
tema della dignità umana, viene
detto che ad essa pertiene un
«principio misterioso» che può
essere enucleato solo a condizio-
ne di renderne esplicita «la quali-
tà propriamente sacrale», «quali-
tà» che si mostra tanto più chiara-
mente, quanto più l’essere uma-
no è considerato «nella sua nudi-
tà e nella sua debolezza» (p. 176).
Ne discende che la dignità uma-
na può essere pienamente rico-
nosciuta solo in quel regime di
«riconoscimento magnanimo
che si trova alla base della frater-
nità» e non dove domina la
«rivendicazione che suppone
l’eguaglianza» (p. 181).
In conclusione, è nel segno di
una connessione che Marcel
intende chiudere le sue riflessio-
ni: quella, appunto, fra creatività e
fraternità, la cui eco risuona nel
nostro cuore «non solamente
come un ricordo, ma come una
promessa d’eternità» (p. 225).
(Giuseppe D’Acunto)
X. Tilliette
Morte e immortalità
Morcelliana, Brescia 2012,
pp. 224, € 16.
Superata la svolta dei novan-
t’anni, con un fisico atletico e il
volto scarno ed etereo, austero e
dolce dell’asceta, Xavier Tilliette
non cessa di stupire, rammen-
tando con il suo slancio una vita
esemplare dedicata alla ricerca
no successivo un tema diviene,
per lui, centrale: la fedeltà. Tema
declinato ontologicamente, in
quanto vivere nel segno di essa si-
gnifica accedere alla sfera di «un
noi di comunione» (p. 108), ossia
«progredire in una direzione che è
quella stessa dell’essere» (p. 105).
Oltre la fedeltà, un altro tema che
ha giocato, per lui, un ruolo im-
portante è stato l’istanza di resti-
tuire alla nostra esperienza il suo
peso ontologico. A partire da
essa ha preso corpo la distinzio-
ne fra “problema” e “mistero”, fra
l’uno che ci sta davanti nella sua
totalità e l’altro in cui ci troviamo,
invece, coinvolti. «Il termine mi-
stero si applica a ciò che non può
essere problematizzato, a ciò che
rifiuta ogni problematizzazione».
Tuttavia, esso non è mai sinoni-
mo di oscurità, ma, in quanto è
qualcosa che ci avvolge, «deve
essere cercato più sul versante
della luce» (p. 124).
Giunti a questo punto, Marcel si
dichiara in grado di vedere più
chiaramente in che cosa consista
la dignità umana, di cui si parla
nel titolo. Il punto da cui partire ci
viene da qual dato esistenziale
che è la familiarità di ognuno con
il proprio corpo. Con quest’ulti-
mo, abbiamo un rapporto nel se-
gno dell’avere, anche se è in gio-
co qualcosa di più del semplice
possesso. E tuttavia sembra pro-
prio che sia a questo tipo di “ave-
re”, forse indefinibile, che si riferi-
sce ogni nostro possesso. Ci im-
battiamo, qui, in un paradosso:
«ogni possesso si riferisce in
qualche maniera ad un avere, che
a sua volta non si lascia definire
in termini di possesso» (p. 142).
L’avere sembra, letteralmente, ri-
solversi nell’essere, ad esempio,
nel caso della fede: un qualcosa
che appare essermi così consu-
stanziale da fare, veramente, cor-
po vivente con me stesso. Notan-
do come l’umano dimora, prefe-
ribilmente, nella zona intermedia
fra l’essere e l’avere, Marcel con-
clude che l’io non è mai puro, ma
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX 119
punto di vista esistenziale, signifi-
ca «cercare di correggere uno
stato di relativa indeterminazio-
ne» (p. 72). Ogni domanda, cioè,
implica un giudizio disgiuntivo
che può prospettare un’alternati-
va o anche più possibilità, fra cui
va esercitato un discernimento.
Ne discende che la coscienza ha
un profilo intersoggettivo e si
configura sempre come il terreno
d’incontro fra una domanda e
una risposta. Viene delineata,
così, un’«antropologia filosofica o
esistenziale», imperniata sulla
«distinzione fondamentale fra
esistenza ed oggettività»: le cose
non sono mera esteriorità, res ex-
tensa, ma la loro realtà è appresa
in funzione di quell’«essere incar-
nato» (p. 84) che sono io e che
sono gli altri. Già a livello della
semplice sensazione recepiamo
dei messaggi che non sono altro
che irradiazioni dell’essere-nel-
mondo di chi ci circonda. E nel-
mondo si è, innanzi tutto, a parti-
re dall’esperienza di essere-il-pro-
prio-corpo.Marcel, abbracciando
con uno sguardo comprensivo la
sua opera, nota come spesso, in
essa, la creazione drammatica ab-
bia anticipato il pensiero discorsi-
vo. E ciò sarebbe avvenuto del
tutto naturalmente, visto che «la
riflessione è sempre successiva
all’esperienza» (p. 99).
Il pensiero filosofico esistenziale,
sviluppato sistematicamente nei
saggi della maturità, avrebbe tro-
vato una prefigurazione in dram-
mi scritti dieci o quindici anni pri-
ma. In questo contesto, viene
svolta un’osservazione molto in-
teressante in sede di poetica del-
la composizione artistica. Poiché
«siamo anche ciò che non siamo
divenuti», da noi emana l’alone di
una «contro-realtà» che, non in-
carnandosi nelle nostre azioni,
ma proiettandosi su di esse
«come un’ombra», funge da
«suolo nutritizio della creazione
propriamente detta» (pp. 100-1).
Il 1929 segna la conversione di
Marcel al cattolicesimo e dall’an-
G. Marcel
La dignità umana e le sue radici
esistenziali a cura di E. Piscione,
Studium, Roma 2012, pp. 240,
€ 17,50.
Il volume, edito a Parigi nel 1964,
raccoglie un ciclo di lezioni che
Gabriel Marcel tenne ad Harvard
nel 1961. Nella «Prefazione», il
pensatore francese riflette sul ca-
rattere di «bipolarità» che percor-
re tutta la sua opera, ossia sul fat-
to che essa si è svolta su «due ver-
santi», «troppo spesso considerati
isolatamente»: «il versante filosofi-
co e il versante teatrale» (p. 26).
Se, infatti, il tema a cui si è dedi-
cato maggiormente è stato l’in-
tersoggettività, ebbene, essa è
pienamente riconosciuta solo se
la si traduce non in un linguag-
gio obiettivo, ma in una forma
drammatica: un’espressione che
è «esistenziale per eccellenza»,
dove «l’essere è trattato come
soggetto ed eventualmente
come colui che decide di sé». In
tal senso, è «del tutto normale
che il filosofo esistenziale diventi
drammaturgo». Anzi, è proprio
nel dramma che «il suo pensiero
si attualizza, diventa evidente,
non solamente al pubblico […],
ma anche a lui stesso» (p. 27).
Poiché all’epoca in cui tiene que-
ste lezioni Marcel, nato nel 1889,
può già vantare un lavoro filoso-
fico che copre l’arco di quasi
mezzo secolo, egli intende indivi-
duare le costanti che tale lavoro
hanno caratterizzato. Le rinviene
nell’idea dell’interrogarsi, che, dal
LIBRI a cura di Luigi Tonoli e Lucia Degiovanni
Esperienza, memoriae promessa d’eternità
NS5 119-120 libri:Layout 1 15-11-2012 16:21 Pagina 119
dice» (p. 10). Una poesia che, riap-
propriandosi di tutta la sua forza
e elevandosi dal mero livello di
parola scritta, diventa costruzio-
ne di modelli collettivi, occasione
per l’io di spingersi verso le re-
gioni dell’altro. Una “Forma reci-
tata”, appunto. (Mabel Giraldo)
M.T. Giuffrè
Per vie di mistero. Angelina
Lanza Damiani e la scrittura
di sé. Novecento rosminiano
in Sicilia
Edizioni Studium, Roma, 2012,
pp. 397, € 30,50.
Maria Teresa Giuffrè, siciliana di-
rettrice dell’omonima casa edi-
trice, pubblica Per vie di mistero.
Angelina Lanza Damiani e la
scrittura di sé. Novecento rosmi-
niano in Sicilia. Il testo presenta
la figura di Angelina Lanza Da-
miani (1879-1936) la cui ric-
chezza sia in termini di pensiero
che, in quantità di versi prodot-
ti, è tale da esigere maggiori
scavi e approfondimenti rispet-
to a quelli finora a lei dedicati. Il
volume offre la possibilità di ri-
leggere una delle più importan-
ti intellettuali di Palermo e della
Sicilia. Una vita, quella della
poetessa, caratterizzata fin dal-
l’infanzia da un forte interesse
per le arti e le scienze, ma so-
prattutto per la fede. Una fede
che le fornirà quel rifugio e
quella pace che la vita terrena
le nega, e che si fece sempre più
viva e intensa a partire dalla let-
tura di Rosmini, conosciuto at-
traverso le opere di Fogazzaro e
lo scambio epistolare con l’ami-
co e guida spirituale padre Boz-
zetti. (Mabel Giraldo)
mistero invisibile, propriamente
immemorabile se non attraver-
so la morte. Inoltre coglie un’af-
finità fra intuizione intellettuale
dell’io e morte. È questo il tema,
condotto sino alle sue estreme
conseguenze, della dotta igno-
ranza, da Socrate a Pascal, da
Cusano a Schelling, da Agostino
a Tilliette. Non si tratta della
smemoratezza dei troppo razio-
cinanti né di senili oblivioni di
poco mature riflessioni, bensì
del culmine estatico del sapere:
un uscire fuori di sé a vuoto,
senza ricongiunzioni o prensio-
ni, quindi pressoché mortale,
tuttavia nella cieca esperienza
intuitiva, nella obliosa memoria
dell’immemorabile capace di
sopravvivere.
H. Jonas
Materia, spirito e creazione
Morcelliana, Brescia 2012, pp.
104, € 10,00.
Da un sussurro, da un grido, da
un atto d'amore o da un gesto
di rabbia violenta? Nessuno sa
da dove sia uscito il mondo. Ma
l'ignoranza è madre del raccon-
to: meno conosciamo e più ci
piace ricamare parole ai bordi
del mistero. Hans Jonas, ebreo e
tedesco, ha le carte in regola per
fare bella figura anche in questo
campo. Nel saggio Materia, spiri-
to e creazione fa capire che il suo
demiurgo non si accontenta di
quanto si racconta ad Atene.
Nella realtà fisica è sopita una
voglia nascosta di bene, avversa
al male. Il vecchio dire dei profeti
di Gerusalemme qui assume
toni di inno cosmologico. «La di-
mensione interiore in quanto
tale va attribuita alla sostanza
Nuova Secondaria - n. 5 2013 - Anno XXX120
LIBRI a cura di Luigi Tonoli e Lucia Degiovanni
cosmica universale come presta-
zione propria». Il nostro destino
umano di perenne inquietudine
non ce lo siamo creati da soli, ed
è per questo che, da soli, non lo
sappiamo capire.
Incontri letterari
V. Moretti
Le forme recitate – aspetti
della letteratura tra Otto
e Novecento
Edizioni Studium, Roma, 2011,
pp. 224, € 18,50.
Poeta abruzzese, critico letterario
e, oggi, Professore presso l’Uni-
versità di Chieti, Vito Moretti nel
suo ultimo lavoro, Le forme recita-
te – aspetti della letteratura tra
Otto e Novecento, propone un
viaggio nella sua terra attraverso
le personalità che l’hanno resa
celebre. Queste figure, prove-
nienti dal mondo della letteratu-
ra e della cultura a cavallo tra
‘800 e ‘900, vengono raccontate
in forma sia di resoconti di incon-
tri, come quello di D’Annunzio
con Michetti e Vicoli, e di amici-
zie, come quella tra il poeta pe-
scarese e Laura Grappolo e Gan-
dolin, sia di immaginari storici
celati dietro un gesto che diven-
ta icona di altro, come il dito di
Fra Cristoforo nei Promessi Sposi,
o tra i versi e le strofe, come acca-
de nelle opere di Rossetti, simbo-
lo, secondo De Sanctis, degli
ideali di libertà del Risorgimento
italiano. Legami e panorami im-
portanti per gli equilibri del tem-
po, «in cui i materiali dell’essere
si innestarono ai paesaggi e ai
processi della storia, facendo di
essi quel che oggi si conosce e si
scientifica e alla meditazione fi-
losofico-teologica, alla carità fra-
terna e alla preghiera mistica,
alla raffinatissima scrittura e al-
l’esercizio di una sterminata me-
moria. Proprio alla memoria egli
ha dedicato uno dei suoi più ri-
fulgenti volumi, La Mémoire et
l’Invisible (2002), che esce in edi-
zione italiana alleggerita, rispet-
to alla ginevrina, di alcuni capi-
toli relativi a Goethe e Schelling,
Newmann e Dostoevskij, e con
un titolo che abbandona la me-
moria per indicare il nucleo teo-
reticamente più profondo del-
l’opera (Morte e immortalità).
La vivente memoria di Tilliette
non è rivolta a un remoto passa-
to semplicemente, nemmeno a
quel Chrónos ádelos, tempo
oscuro e immemorabile, vetusto
e non più visibile, che precede i
tempi storicamente ricostruibili.
Il passato scrutato dalla memo-
ria più vera e profonda è un
eterno passato, presupposto ad
ogni tempo antico, attuale o av-
venire. Il passato di cui è degna
la memoria autentica è quello
mai stato presente, reso tale,
passato eterno, dall’eternità in
cui Dio lo ha posto negandolo,
vincendolo, sottoponendoselo,
essendo egli eternamente posi-
tività presente, bene, essere, in
quanto tale escludente attiva-
mente la negatività, il male e il
non-essere, irrevocabilmente
per sempre. Tuttavia tale eterno
passato è quanto permette di
comprendere appieno l’unicità
di Dio, del Dio vivente che esclu-
de ogni altra realtà. Gettare lo
sguardo in tali eternamente re-
condite abissalità divine è dun-
que l’esercizio più vertiginoso,
ma anche istruttivo per la me-
moria. Confrontandosi soprat-
tutto con Schelling, ma anche
con Agostino e Bergson, Vico e
Freud, Rilke e Marcel, nonché
con tanti altri filosofi e teologi,
letterati e poeti, Tilliette illustra
innanzitutto come la memoria si
volga costantemente al proprio
NS5 119-120 libri:Layout 1 15-11-2012 16:21 Pagina 120