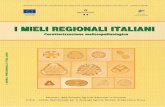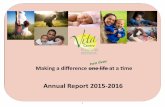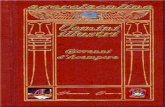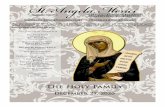"Litérature, politique et Pouvoir aux Antilles" (Ajimase Angela. A)
Una vita nell’utopia. Prime note di ricerca su Angela Zucconi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Una vita nell’utopia. Prime note di ricerca su Angela Zucconi
Una vita nell’utopia. Prime note di ricerca su Angela Zucconi*
di Vanessa Roghi
Quando Angela Zucconi è morta, il novembre del , da pochi giorni era stata pubblicata, per l’editore L’ancora del Mediterraneo di Napoli, la sua autobiografia: Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà. Il titolo, la Zucconi, lo aveva preso in prestito da un’idea di Emilio Sereni per un convegno del : L’utopia di oggi sarà la politica di domani. Protagonista della ricostruzione repubblicana, non a caso aveva voluto scegliere proprio quello slogan, così datato, per parlare di sé, e di una vita che era proseguita ben oltre quegli anni: perché allora, nell’imme-diato dopoguerra, con Sereni come con Manlio Rossi Doria, Adriano Olivetti, Guido Calogero, Angela Zucconi aveva inseguito, nel segno di questa utopia, la strada dell’impegno sociale, in costante dialogo con quella fede cattolica che faceva rispuntare come casualmente nel titolo della sua autobiografia e, comunque, a libro (e vita) conclusi, nel segno di un’autrice a lei vicinissima, Simone Weil: «Il Signore è vicino a chi lo cerca», scriveva, «Dio non si occupa della storia. Lascia all’Homo faber il compito di fare e disfare». Erano i cinquant’anni nell’utopia, dunque, l’oggetto della narrazione.
Scriveva, allora, uno dei suoi, postumi, recensori:
Non credo che il nome di Angela Zucconi dica molto alla maggioranza. Eppure leggerne l’autobiografia è emozionante, testimonianza di un secolo, ma non basta: testimonianza di un secolo vissuto. Con passione, senza risparmio, alimentando una speranza di progresso civile per tutti, tra fatiche, delusioni, compensi e la voglia sempre di operare, di fare, di costruire, senza retorica, nella modestia.
Non sottolineava, il recensore, uomo come tutti i recensori del libro, come questa modestia nella narrazione fosse il tono costante, non ca-suale, la cifra narrativa della Zucconi. Come questa modestia, insomma, nascondesse quel pudore, per non dire disabitudine, femminile a calarsi con tutto il proprio vissuto entro la storia più generale e, con atto poli-tico, rileggerla.
Eppure la vita della Zucconi si è snodata attraverso tappe quasi pa-
Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. /
radigmatiche, per la vita degli intellettuali italiani (non solo cattolici) del Novecento. Negli anni Trenta poetessa e traduttrice dal tedesco e dal danese, inviata per reportage dal nord Europa per “L’Avvenire d’Italia”, poi per “Omnibus”, grazie a Leo Longanesi. Presenza costante nella vita di don Giuseppe De Luca fino al , anno della morte di lui. Negli anni Quaranta alla casa editrice Einaudi, dove conoscerà e si legherà a Natalia Ginzburg in un rapporto di profonda amicizia. Nell’immediato dopoguerra animatrice del primo servizio sociale insieme a Guido e Maria Calogero, direttrice per venti anni del Cepas, la prima scuola di assistenti sociali di matrice laica, compagna di progetti e lavoro nel breve viaggio di Adriano Olivetti, impegnata nello sviluppo locale con un’attenzione agli individui che ha lasciato traccia nei numerosi corsi di formazione e alfabetizzazione per adulti da lei realizzati, e che avrebbe dato, nel tempo, studi metodologicamente fondanti sulle comunità locali e lo sviluppo partecipato. Cattolica, mai legata alla DC, praticante, ma mai in seno alla chiesa ufficiale. Nubile, legata da profonde amicizie a persone che le saranno vicine tutta la vita.
Avvicinarsi alla figura di Angela Zucconi ha significato innanzitutto tentare di approfondire pagine della sua autobiografia dove un fatto, all’apparenza uguale agli altri, era invece un momento fondamentale di passaggio per la storia privata come per quella pubblica: le poesie e il giornalismo, le amicizie e le esperienze pubbliche e private. E poi il rapporto con don Giuseppe De Luca, al quale accenna in brevi note, quasi di cronaca, fatta eccezione per la pagina dedicata alla sua morte al Fatebenefratelli nel , e invece molla e specchio di tante decisioni, tutte forse, prese conversando con lui, all’interno di un rapporto di (tentata) direzione spirituale da parte di De Luca e di fughe e ritorni da parte di Angela.
Questo è stato possibile grazie alle testimonianze di amiche che, all’unisono, anche se con diverse sfumature, hanno sottolineato i suoi silenzi. Da loro, dalle domande che non trovavano risposta nell’auto-biografia, è iniziata la ricerca delle fonti, resa difficilissima dalla stessa Angela che con una cura particolare ha, negli anni, sistematicamente distrutto lettere e diari, gettati nell’oceano Atlantico, i taccuini dalle pagine tagliate, recise da tagliacarte, da forbici, da un gesto rapido della mano (si riconoscono dai bordi seghettati in modo diverso). Soprattutto riguardanti gli anni Trenta: su di essi si è soffermata questa ricerca, perché anni di formazione per lei, e per tutta la generazione che, attraversato il fascismo in un’età così particolare come la gioventù, parteciperà appunto alla ricostruzione repubblicana. Le fonti impiegate sono state dunque, a parte la sua autobiografia, usata come traccia, alcune fonti dirette: tre taccuini, una cinquantina di lettere scritte a don Giuseppe De Luca, le
VANESSA ROGHI
fotografie, conservate con cura in tre album, gli articoli pubblicati su giornali e riviste. E molte fonti indirette: testimonianze orali, il carteggio De Luca-Romana Guarnieri, iniziato in nome di Angela, i diari della stessa Guarnieri, il carteggio De Luca-Fausto Minelli dove Angela appare più volte.
Del resto, e sia detto per inciso, data la rilevanza storiografica del tema, non è facile inserire la vita di una donna entro quella storia degli intellettuali non a caso da sempre declinata e scritta interamente al ma-schile, anche perché, e il percorso umano di A. Z. ne è una dimostrazione lampante, in gioco non c’è soltanto un paragrafo nell’histoire des savants ma la gestione di spazi di potere che la Zucconi, come tante sue coetanee, ha sempre avuto grande difficoltà e pudore a gestire, come da ultima ha sottolineato la storica francese F. Rochefort in un numero della rivista “Clio” interamente dedicato alle intellettuali:
Remettre en question la masculinité supposée de l’intellectuel interroge non seulement les procédés d’occultation des femmes dans l’histoire et dans la culture mais pointe aussi le rapport ambigu de la sphère intellectuelle avec le pouvoir. Que l’on envisage l’intellectuel d’un point de vue sociologique où politique. Qu’on le désigne comme intellectuel organique ou spécifique, c’est bien un certain espace politique et culturel qui se dessine ci s’autoréprésente à travers les media comme à travers les savoirs.
Partendo dalla sua biografia si è cercato di tracciare la storia dei suoi incontri e della sua formazione fino agli anni della guerra, che per lei, come per molte altre donne e uomini, hanno significato la fine dell’età degli studi, e spesso hanno coinciso con l’assunzione in prima persona di ruoli e responsabilità politiche e sociali. A che prezzo e con quali esiti, per la Zucconi, sarebbe altresì interessante ricostruirlo, se lei stessa individua in quella data una vera e propria morte e rinascita a nuova vita. La fine di questo percorso di ricerca dunque coincide con la pubblicazione, nel , di Lodovico innamorato, forse il testo più importante in assoluto della Zucconi, che, appena pubblicato, rimane sepolto sotto le macerie del bombardamento di Milano: «Quando arrivò la notizia del bombar-damento di Milano la notte tra il e il agosto, Leo Longanesi mi spedì a Milano per avere notizie […]. Arrivata non so come […] vidi una cascata di carta bruciata che usciva dalle finestre annerite senza infissi. Il mio libro era stato sorpreso dal bombardamento di quella notte […]. Si erano salvati i piombi e il libro uscirà, ma più tardi, in un certo senso, “dopo la morte dell’autore”».
UNA VITA NELL’UTOPIA
«Ero così occupata con i giochi e l’immaginazione che non ho mai letto un libro fino a quattordici anni»:
le prime esperienze formative.
I ricordi di Angela Zucconi iniziano con un viaggio:
Era appena finita la Grande guerra. Il viaggio in piroscafo da Siracusa a Bengasi durava tre giorni, si parlava oscuramente di mine vaganti. In questa sinistra at-mosfera il mio gioco consisteva nel tenere un discorso sui caduti in guerra. Alcuni passeggeri piangevano. A Bengasi non c’era un porto e dalla nave si arrivava a terra dopo il trasbordo in una maona.
Il padre, procuratore del re in Libia, era stato destinato a una veloce carriera in colonia, come molte famiglie italiane della burocrazia e delle professioni dopo il . La madre, umbra colta e profondamente cat-tolica lo aveva seguito con due bambini piccoli, conservando sempre la nostalgia verso la terra d’origine, al punto da organizzare nel cortile interno «un tentativo di lavorazione del maiale […] sotto i dettami di un vero norcino ternano che si chiamava Palamidesio». A Bengasi la prima formazione di Angela, nel solco della tradizione, eppure resa eccezionale dalla presenza, dentro una scuola cattolica, di bambini di estrazione, non solo sociale, ma anche culturale e religiosa, diversa:
Due anni di asilo e cinque di elementari sempre dalle suore. Ricordo benissimo il grande stanzone buio dell’asilo al pianterreno con grosse inferriate alle fine-stre e suor Ambrosina, che ci distribuiva le matite girando per i banchi con un barattolo pieno di mozziconi mangiucchiati e scorticati da varie generazioni di bambini. Suor Ambrosina aveva nel panneggio della gonna delle tasche pro-fondissime da cui tirava fuori come dal fondo di un pozzo qualcosa di buono per chi piangeva. Per chi era senza fazzoletto c’era appeso accanto alla cattedra un grande asciugamano di cotone grezzo dove andavamo a soffiarci il naso. La classe era composta di armeni, greci, ebrei, italiani, maschi e femmine. L’unica conflittualità si presentava all’ora della siesta obbligatoria (tutti con le braccia e la testa sul banco) tra chi voleva dormire e chi voleva chiacchierare.
Della scuola elementare ricordo la lettura della vita dei martiri durante l’ora di cucito e il terrore che un giorno dovesse toccare a me di scegliere tra tortura e abiura. Della scuola elementare ricordo il momento solenne di bruciare in un braciere “i fioretti” che avevamo fatto durante qualche novena o forse in tempo di quaresima. In grande segreto, giorno dopo giorno, dovevamo scrivere ogni fioretto che avevamo fatto in un pezzetto di carta; i rotolini venivano poi versati sul braciere e bruciavano come un’unica offerta alla fine della novena.
Poi il rientro in Italia, per il radicalizzarsi delle tensioni fra il governo locale e il nuovo governo fascista e il trasferimento a Trieste dove An-gela viene iscritta al ginnasio Dante Alighieri: «ci abituavano a scrivere
VANESSA ROGHI
su grossi quaderni rilegati senza righe, a imparare a memoria i vocaboli latini e tedeschi perché i compiti in classe si facevano senza dizionario». Lì l’inizio di quella passione per il mondo germanico che resterà un filo tenace in tutta la sua vita:
Quanto alla storia mi devono aver spiegato così bene la cultura ottoniana che mi capitò di scrivere per Ottone I la mia prima poesia e da allora il rapporto tra mondo germanico e mondo latino doveva rimanere come un filo sempre presente nel tessuto della mia vita. Molti insegnanti erano allora, o sarebbero divenuti, noti per aver curato edizioni scientifiche di classici greci, latini, o testi di filologia germanica.
Trieste è in quegli anni fucina di traduttori e intellettuali, che porteranno la cultura tedesca a un livello di divulgazione mai avvenuto prima in Ita-lia; da Trieste provengono Alberto Spaini e Bobi Bazlen, Ervino Pocar e Giani Stuparich: la giovane respira e si forma in questa atmosfera, trovando nello studio, come tante donne che non si sentono destinate al matrimonio, il luogo della sua realizzazione: «I capelli cresciuti e i temi di italiano letti a voce alta dal professore in classe mi dettero una certa lena e mi trovai così bene da ricordare per tutto il resto della mia vita ciò che avevo imparato in quella scuola».
Il trasferimento a Roma, e la frequenza del liceo Mamiani, dove la Zucconi terminerà il ciclo obbligatorio e comporrà le sue prime poesie, segneranno un’altra tappa importante nella presa di coscienza del suo “destino” di intellettuale.
Ilaria di Campello
Il luglio del cinque donne, dall’aria dimessa e un po’ malandata, salgono all’eremo abbandonato di Campello sul Clitunno per abitarvi e fondare una comunità spirituale sul modello francescano, ma senza regola. Scrive Maria, una di loro, la prima fra loro:
Siamo semplicemente un cenobio fraterno, una famiglia cristiana, ossia donne che viviamo insieme come sorelle, e francescanamente, per necessità, quanto per amore: quasi tutte orfane e senza appoggio nella vita. Vestiamo dimesse, che ciò conviene a donne cristiane, e la povertà non ci consente altrimenti. Siamo quasi tutte terziarie, ma l’esserlo o no è per noi secondario, cioè la nostra non è una “famiglia di terziarie” che ciò sarebbe abusivo; abbiamo devozione a san Francesco e umile volontà di vivere qualcosa del suo pensiero, questo sì.
La lettera è indirizzata all’amico don Orione, ma, scorrendo i nomi degli amici dell’eremo di quegli anni il nome di Orione non stupisce,
UNA VITA NELL’UTOPIA
assidua la corrispondenza con Ernesto Buonaiuti, Primo Mazzolari e Brizio Casciola, frequenti le visite di Barbara Allason, parente della “minore”, Maria.
Angela Zucconi inizia a frequentare l’eremo negli anni della sua adolescenza, complice la vicinanza della sua casa di vacanze di Campel-lo, e non deve essere difficile immaginare il richiamo verso una giovane donna cattolica ma disinteressata a cosa fosse «dentro e fuori la chiesa», ufficialmente, esercitato da quel cenacolo mistico di donne.
In quelle prime visite all’eremo per me c’era il piacere della gita, c’era forse una ricerca di Dio, c’era il piacere di godere un incontro perfetto tra natura rustica e architettura povera, ma c’era anche una sfumatura di gusto della trasgressione, date le voci che correvano in paese sull’eremo.
L’eremo di Campello non è soltanto il luogo in cui Angela entra in contatto con un ambiente culturale “altro” rispetto a quello fascista, lì conoscerà infatti B. Allason, traduttrice dal tedesco e antifascista, che le aprirà le porte di casa Croce; ma anche rispetto a quello rappresentato negli stessi anni da don Giuseppe De Luca, la cui battaglia contro il modernismo non ha niente dei toni apocalittici della curia, eppure mantiene quella condanna inappellabile di sottofondo maturata negli anni del seminario, e che traduce in termini intellettuali richiamandosi alla perdita di fede nella quale, alla fine, tutti i modernisti erano incorsi.
I nomi di Buonaiuti, Mazzolari e Casciola non aiutano certo l’eremo a conquistare le simpatie delle locali autorità ecclesiastiche, tutti i sospetti di modernismo infatti ricadono sull’attività delle “minori” al punto da provocarne la condanna nel .
Al tempo delle mie prime visite all’eremo, a Campello correvano tante voci. Le sorelle erano conosciute con il nome di Allodole, il che era già gravissimo in un paese di cacciatori fanatici. Si diceva che fossero in corrispondenza con Gandhi ma anche con Greta Garbo. Si diceva soprattutto che erano protestanti, forse perché nel gruppo stabile all’eremo c’era una sorella inglese appartenente alla Chiesa Anglicana, […] e tra gli ospiti abituali c’era una bostoniana della Chiesa episcopale, una diaconessa tedesca e un’altra ospite tedesca appartenente alla Chiesa Evangelica.
Da Campello Angela ritorna con un soprannome, Ilaria, che userà negli anni come pseudonimo nelle sue collaborazioni con “L’Avvenire d’Italia” e una passione, quel Jacopone da Todi che le sarà di ispirazione per tutta la vita, le cui poesie conserverà, piegate in foglietti, come compagne di passeggiata, onde impararle a mente insieme a quelle di E. Dickinson.O amore de povertate / regno di tranquillitate / povertate via secura / non ha lite né rancura / de latron non ha paura / né di nulla tempestate. / Povertate muore
VANESSA ROGHI
in pace / nullo testamento face / lascia il mondo come iace / e le genti concor-date. / Non ha giudice né notaro / a corte non porta salaro / ridese dell’ommo avaro / che vive in tanta ansietate. / Povertà alto sapere / a nulla cosa soiacere / in disprezzo possedere / tutte le cose create. / Povertade è nulla avere / e nulla cosa volere / ed ogni cosa possedere / in spirito di libertade.
Angela, che dal andrà sempre di meno in Umbria per impegni di studio e di lavoro, tornerà a frequentare l’eremo dopo la guerra e sarà per tutta la vita, «nella spirale del mio cammino, un’altra grande resti-tuzione».
«Il mondo non sa che farsene della poesia».
La scrittura, le letture
In Italia, una buona sarta guadagna sempre più di una buona scrittrice affati-candosi meno.
Ho detto sempre di fare per sempre il vagabondo, ma da tutte le strade del mondo ho pensato di ritornare.
Che la sua strada fosse, fin dagli anni dell’adolescenza, quella del lavoro intellettuale era chiaro a tutti, anche a sua madre: «Mia madre era molto orgogliosa della mia vocazione poetica e mi invitava con insistenza a legge-re a voce alta le mie poesie agli amici che venivano a trovarci e che spesso erano gli amici degli anni di Bengasi. Uno di questi ebbe l’infelice idea di pubblicare le poesie e io acconsentii, pensando che il volumetto avrebbe fatto buona impressione al varco ormai vicino della licenza liceale».
Angela Zucconi esordì, nel mondo delle lettere, nel , a anni, pubblicando, per l’editore Airoldi, un libro di poesie dal titolo Viaggi senza approdo, con una epigrafe presa in prestito da Lao Tze: «Non c’è meta, soltanto la strada».
La pratica della scrittura era ormai assai diffusa tra le giovani donne di buona cultura e di famiglia borghese, e non si deve essere dunque sviati dal dato occasionale per cui, appunto, le sue poesie furono pubblicate da un amico per far buona impressione su una commissione di esame. In esse uno stile discorsivo, che sembra scartare volutamente ogni richiamo all’ermetismo, e a ogni tipo di sperimentalismo, per indagare una scrittura pacata, vicina a quella della preghiera, e che ricorda quello di un’altra poetessa cattolica che inizierà a scrivere pochi anni dopo, Margherita Guidacci, e che a proposito delle sue scelte stilistiche dirà «La nota fondamentale […] [delle poesie, nda] era religiosa, almeno come può esserlo una umana pietas e consapevolezza del mistero. Usai versetti lunghi, di tipo biblico (anche quando le asserzioni erano brevissime) e
UNA VITA NELL’UTOPIA
parlai quasi sempre al plurale, sottintendendo una coralità e rifuggendo dal lirismo monodico».
Anche se non si può fare a meno di sentire, dietro assonanze marca-te, l’adesione a una musicalità del linguaggio poetico, vicina agli Ossi di seppia di E. Montale finiti di comporre nel , come nel componimento Su la Via Appia:
Di tutto quell’ardente fiammeggiare / del tramonto, non resta che un pallore / d’ombra nel cielo: la campagna è un mare / senz’onde, immoto: un’ala di dolore / sembra che spazi solitaria e pare / che rifletta la sua ombra sul cuore / del mondo. Nel crepuscolo un errare / di rondini e di sogni, ed un tremore / di brivido fra i rami di un cipresso / come un ultimo anelito di vita / rimane. Il mondo sembra che nel nulla / sia spento, e tutto qui sembra riflesso / di nulla e tombe e pini e l’infinita / sonnolenza in cui l’anima si culla.
E, chiaramente, a Leopardi. In Angela Zucconi infatti, le buone letture liceali, una consuetudine affinata negli anni all’abitudine dell’estraniamen-to datale dai numerosi spostamenti, e una sua sensibilità un po’ lunare senza mai essere macabra, come in tante scritture femminili post-deca-dentismo, producono dei versi dove l’elemento naturale sovrasta spesso, nella sua immensità leopardiana, l’essere umano, eppure, sullo sfondo o protagonista, l’elemento divino, la scelta di fede è predominante, come nel componimento Attesa:
Stasera, / sei Tu che mi porti per mano / e apri per me, per me sola, un varco segreto. Signore, che io veda. / Forse ho viaggiato in un paese senza cielo, forse / ho inteso su gli occhi spenti bruciante, la bellezza delle valli al sole, forse / ho inteso, fra le mie mani, variare il mondo a primavera, e i cieli nei crepuscoli, ma non ho / ancora veduto. / Il tramonto è acceso, e violento: / pioverà sangue su gli uomini, / o Tu verrai su le nuvole / a purificare il mondo col fuoco? / Ma non ho paura: / tu mi porti per mano, / Tu m’apri il passo fra le siepi / Tu mi dici soltanto / di sperare e d’esser buona. / E stasera la speranza / dominio chiuso e segreto / di chi non conquista / è il dono splendido / di un amore lontano e ignoto! / Signore, sei tu l’amore lontano?
Anche se, dalla sensualità di certi versi, si intuisce come, per la giovane donna, l’estasi dell’amore sia una soltanto, in terra e in cielo, richiamando discretamente, perché il gioco dei rimandi sarebbe troppo semplice in questo caso, la poesia di Emily Dickinson, che sarà sempre una delle sue passioni, fra l’altro condivise con don Giuseppe De Luca. Così nella poesia Educande, dedicate a due fra le sue compagne più amate, Crista Winsloe e Dorothea Wieck:
Vanno in silenzio nell’ora del sole, / a due per due come i quieti cipressi / dei viali, che il vento per brevi, sommessi / colloqui, avvicina in un raggio di sole. /
VANESSA ROGHI
Pallide, buone, ogni giorno di festa / danno un po’ d’aria all’adolescenza: / è il loro segreto l’adolescenza; segreto che svela ogni giorno di festa. /Mute sorelle dall’anima chiusa / che non vi tocchi il male d’autunno, / è tutto il mondo malato in autunno / compagne perdute in un giorno di sole. / Una mi guarda: si, t’ho veduta / non so più in quale città lontana, / non so più su quale riva lontana, / sorella triste t’ho conosciuta. / Oggi sei forse più pallida, è vero? / lo so porti il peso nell’animo inquieto / di una dolcezza repressa in segreto, / di un tuo velato, dolce mistero. / Vieni, ci sono strade nel mondo / aperte alla nostra libera gioia, / hai tanto bisogno di sole e di gioia / come la vena di un pozzo profondo. / Ma non ci parliamo; dolce, sottile / tuo desiderio di un attimo.., a sera / sei tu che dopo la vostra preghiera / ascolti la fonte che canta in cortile?
Scrive nella sua autobiografia:
Le poesie erano molto tristi e io le leggevo con un tono così lamentoso da turbare gli ascoltatori. Con mia grande rabbia, mia madre, come per giustificarsi, diceva «Ma se vedeste che piattoni di spaghetti mangia la poetessa». Lo diceva a chi restava sconvolto o forse soltanto perplesso. Così all’imbarazzo di quella lettura a voce alta si aggiungeva lo scorno di questo intervento così pedestre.
Tra i tanti componimenti, molti di occasione, veri e propri esercizi di scrittura, spicca ancora oggi, come testimonianza di una sensibilità ge-nerazionale, ma anche come prova ulteriore della ricezione intensissima del romanzo Una donna, pubblicato nel , la poesia dedicata a Sibilla Aleramo, che si apre con una citazione di D’Annunzio: «dicono che nel folto delle chiome / voi abbiate una ciocca rossa / come una fiamma».
A Sibilla Aleramo: Dite, che sogno pallido è passato / un giorno all’alba sulla vostra vita? / l’ala di un sogno, forse l’infinita / ala di un canto triste vi ha sfiorato? // Dite, che mano immensamente buona / carezzò in una sera dolorosa / il vostro capo? foste voi obliosa / sotto una dolce mano che perdona? // Non so, penso a quel piccolo candore... / scia di un sogno, bontà di una parola / che vi cadde nell’anima e che sola / vi piacque come un piccolo chiarore? // Io so che in cuore voi avete la gioia / trionfante, so che voi avete sul mondo / gettata la risata e che fu il mondo / il piedistallo della vostra gioia; // so che voi amate il tacito mistero / di strade ignote... eppure ho ricordato / di voi, forse soltanto ho ricordato / quel candore... “che sia forse un pensiero / di stanchezza, pensavo ieri sera, / forse il primo pensiero di stanchezza / che vi ha toccato, forse una tristezza / espirata nell’aria di una sera?” // Ma ieri, c’era solo nel mio cuore / quell’infinito senso di abbandono, / un bisogno di chiedere perdono / a tutto... ero velata dal dolore // di non so quale lungo errare, quale / lungo silenzio, ma oggi che risento / il sole, una certezza come il vento / in faccia mi ravviva: “nulla vale / come questo saluto dell’aurora” / e voi siete lo spirito di questa / aurora, e splende su la vostra testa / meravigliosa il segno, che, Signora, / ieri m’apparve come una carezza /
UNA VITA NELL’UTOPIA
dolorosa ma oggi che vi sento / nell’alba come il Segno del tormento / che v’arde e plasma in voi la giovinezza.
Il libro della Aleramo arriva nel a una tiratura di . copie, la sua voce rappresenta per le giovani donne, e non solo le giovani, un modello mitico di comportamento, la sua vita è infatti inimitabile, così la sua bellezza; Angela Zucconi vede in lei un’icona di donna pensosa e tormentata, l’icona dell’intellettuale potremmo dire, che spicca fra le letture di questi anni, anche se, come al solito, non viene ricordata nella sua autobiografia. Altro dato che emerge dalle poesie è la scrittura come momento da condividere, le dediche numerose, i temi familiari, e se lo è la scrittura tanto più lo è la lettura: «Tra i primi libri che ho letto ce ne fu uno che mi avvicinò per la prima volta a mio fratello grande e che ebbe un esito importante, Martin Eden di Jack London, e poi Così parlò Zarathustra. Non capisco come mai noi due potessimo identificarci con Martin Eden, in ogni modo fu Martin Eden che ci suggerì di andare alla scoperta della biblioteca nazionale e della solenne intimità di una sala di pubblica lettura». La strada per divenire un’intellettuale è stata aper-ta, a darle un seguito sarà la guida di don Giuseppe De Luca: «Le mie poesie dovevano essere piuttosto insolite se mi procurarono l’incontro e l’amicizia di don Giuseppe De Luca che doveva diventare un altro dei fili sempre presenti e invisibili nel tessuto della mia vita».
“Il centauro triste”. Don Giuseppe De Luca
Ebbene, sì, mi sarebbe piaciuto che nella presente occasione qualcuno avesse affrontato il tema [De Luca e le donne, N.d.A.] nelle sue molte sfaccettature. Basti pensare […] alle tantissime donne sostenute da lui nelle loro tante difficoltà, anche familiari, e valorizzate in attività intellettuali di vario genere; […] per tacere – fuori catalogo – dei suoi rapporti con la Zucconi, la Bargellini, la Frassati.
È il , don Giuseppe De Luca non è ancora il noto giornalista e po-lemista che sarebbe diventato negli anni Trenta, scrive regolarmente su “L’Avvenire d’Italia” e “Il Carroccio”, entrambi giornali appartenenti all’Opera Cardinal Ferrari, e collabora con “Il Frontespizio”. Ma è co-munque già al centro di relazioni eccellenti, amico di Papini, e Prezzolini, Bargellini e Bugiani, per parlare soltanto dei laici, con i quali corrisponde con regolarità da anni; il suo studio, vicino al Colosseo, è un punto di passaggio ineludibile, anche se discreto, per tutto un universo culturale in fermento. Di molti amici, e soprattutto di tutte le amiche, è confes-sore, e come tale tenta di instaurare veri e propri rapporti di direzione spirituale.
VANESSA ROGHI
«Da don Giuseppe De Luca mi condusse la prima volta don Giulio Ghetta, che dopo essersi laureato in ingegneria, era venuto a Roma da Brescia, e studiava nel seminario lombardo per diventare prete». La giovane con ambizioni intellettuali non può non rimanere colpita dalla figura eccezionale del prete che legge tutto: «leggo Voltaire. Sta bene […] Non però per semplice sensualità letteraria, seppure non senza questa. Io tendo all’enfasi, e il periodo è rigido. Posso continuare, caro Papini, a leggere classici e Bossuet per curarmi? Miro a farmi leggere, e a non permettere, mai, che nessuno dei miei amici non credenti possa credere che io credo perché non ho letto».
Scrive Angela: «Proprio per la sua vocazione di prete in “missione speciale” aveva esplorato i terreni reputati più laici della letteratura e della filosofia, da Voltaire di cui, senza tema di esagerare, possiamo dire che lesse tutto, da Hegel a Renan a Rousseau, a Barres e a Gide». E ricorda: «Quando gli fui presentata aveva scoperto nelle mie poesie un’anima da coltivare e per lui la cultura era la coltura dell’anima». Ma non racconta tutto, perché materia di confessione, certo, ma anche perché grande ri-mosso in tutta la sua narrazione, non racconta per esempio i suoi amori di giovinetta che preoccupano De Luca al punto che: «Il primo segno della sua corrispondenza è del ed è una cartolina con il busto di Saffo del Museo Archeologico di Napoli». La cartolina datata Napoli agosto reca scritta questa lapidaria frase «Saluti e coraggio». Le pulsioni omosessuali di Angela, ancorché temperate da ortodossi innamoramenti eterosessuali, sono motivo di grande trepidazione per il prete romano, che incita la giovane a portare con «coraggio» questa sua croce, e tuttavia a fare di tutto per liberarsene. Al punto che è la Zucconi stessa a richiamare De Luca a occuparsi anche di lei come letterata: «le invio anche alcune mie liriche […] perché vorrei che lei tenesse presente non solo la mia vita ma anche un pochino la mia “letteratura” mentre per me ancora rimangono oscuri i rapporti tra l’una e l’altra». L’argomento è motivo di discussioni e (a volte) scherzi, ma non impedisce, anzi stimola De Luca a rieducare la giovane in un modo abbastanza poco ortodosso, segno ulteriore della sua grande singolarità e apertura in quegli anni:
Don Giuseppe De Luca cominciò con l’orientare le mie letture che allora (a parte il Così parlò Zarathustra) non erano andate più in là dei romanzi che ci scambia-vamo negli anni del liceo tra compagne di scuola: Babbit, Il pozzo della solitudine, Il caso Mauritius, Piccolo mondo antico, La montagna incantata. Don Giuseppe mi fece leggere i classici russi, Péguy, Rimbaud, Gide, Huxley e una volta che si accorse di certe letture piccanti e scadenti che avevo fatto su suggerimento di una cugina “scafata” preoccupata della mia ignoranza in materia di sesso, passò al “crudo” e mi fece leggere L’amante di Lady Chatterley.
UNA VITA NELL’UTOPIA
Niente a che vedere, dunque, con la biblioteca ideale delle giovani signori-ne cattoliche regalata nel , dal pontefice Pio XI, alla nipote, contessina Ratti, per le sue nozze: malgrado su autori siano francesi, la scelta cade molto lontano dai testi prescelti da De Luca, «Dupanloup, Gratry, Tissier, Lendriot», e «Féminisme et Christianisme di Sertillanges che ricorda che i tempi sono percorsi da inquietudini anche per le forti e pie spose cattoliche». Cade, del resto, la distinzione operata in seno anche alle famiglie borghesi, e nella propagandistica cattolica più “democratica”, fra i libri di pietà e i libri di “coltura”, ma cade anche, ed è l’eccezionalità di De Luca, ogni distinzione e discriminazione di genere.
De Luca, da subito, coinvolge Angela nei suoi progetti intellettuali, e se da un lato la indirizza spiritualmente, non senza difficoltà, dall’altra la mette al lavoro: fin dal le affida incarichi di traduzione e cura editoriale come l’edizione di un testo di De Berulle con prefazione di H. Bremond.
La Zucconi dal canto suo, iscrittasi alla facoltà di Lettere (), fa conoscere a De Luca un mondo nascosto a Roma: quello degli studiosi con i quali ha conversazioni per tenere vivo il tedesco, avendo deciso di laurearsi in germanistica, come quelle con Ephraim Urbach, studioso della Bibbia che la mette a conoscenza della questione ebraica, dei sio-nisti e dell’antisemitismo; mentre il prete la introduce fra i fuoriusciti dalla Russia rivoluzionaria: «Don Giuseppe De Luca mi fece conoscere Venceslao Ivanov, poeta simbolista russo convertito al cattolicesimo: abitava in una casa, (poi demolita) in cima al Campidoglio, da questa casa passavano poeti e scrittori russi che Lunaciarski aveva messo in salvo» e condivide con lei il lavoro di erudizione, o di letture, che va compiendo in questi anni, come emerge dagli articoli pubblicati da Angela su “L’Av-venire”. Inoltre la aiuta e la indirizza nel suo lavoro di tesi, assegnatale da Giuseppe Gabetti:
Durante una delle vacanze a Campello un’amica mi raccontò che a casa dei parenti Francesconi a Casco dell’Acqua, una frazione di Trevi sul Clitunno, erano conservate tante lettere che forse potevano servire da spunto per una tesi di laurea in germanistica. Così avvenne infatti, con le lettere che la marchesa Florenzi, amica e amante di Lodovico I di Baviera, aveva indirizzato al professor Francesconi.
Scrive Angela a don Giuseppe:
Le mando altri particolari intorno alla mia fortunata scoperta, della quale le ho parlato nell’ultima mia. Dunque le lettere autografe inedite trovate nell’archivio di certi miei amici, in una campagna qui vicino, sono: di Rosmini […], di Tommaseo, della Marchesa Florenzi, della Brunamoschi (fondamentali), alcune del Fiorentino, altre di Alessandro Pestalozza (tra cui una in cui descrive
VANESSA ROGHI
le giornate di Milano) […] Che ne dice? “Pan”? “La Nuova Antologia”? Ho molta voglia di lavorarci sopra sul serio.
Ma don De Luca ha altri progetti per lei, innanzitutto la tesi, e le lettere finiscono smistate ai vari specialisti. Il rapporto lavorativo fra i due continua malgrado i ritardi di Angela, che, dopo aver fatto cadere il progetto su De Berulle, non porta avanti neanche un’altra idea di don Giuseppe, la biografia di una poetessa cattolica per una nuova collana della Morcelliana. La poetessa, Annette von Dröste-Hülschoff (-), è particolarmente vicina alla sensibilità della Zucconi, perché, scrive De Luca «donna, come la Dickinson, sorella di Saffo, e sorella di Maria Maddalena: poeta squisito e cristiana che della sua fede tutto sa e patisce». Ma i numerosi impegni accumulati nel soggiorno in Germania che Angela intraprende nel grazie a una borsa di studio di Gabetti, faranno abortire anche questa collaborazione.
Tuttavia De Luca non demorderà nello spronarla verso la carriera di studiosa e nel scriverà a Minelli:
Caro Fausto […] L’Angela Zucconi, che tu già conosci, ha terminato un libro (formidabile) su Lodovico II di Baviera e la Marchesa Florenzi. È un capitolo di storia dell’Ottocento, trattato con esatto dominio delle fonti e soprattutto con una vivezza di spirito da far onore a chiunque. Lo vuol Longanesi per Rizzoli, e Cova lo prenderebbe per Laterza: tu lo vuoi? Ma non è cosa religiosa, te lo dico subito: è di quei “confidenziali” storici, che io mi proponevo. Il libro è tutto pronto: - pp. (cioè fitte cartelle dattilografate), e un compenso tra le -. lire semel pro semper, e una diecina di illustrazioni, e bisognerebbe curarne la veste tipografica. Guadagni un’autrice che darà molto, e vale già molto; ed entri nell’editoria che ti proponevo. Non ti posso, ora spedire il manoscritto, che sto rivedendolo io; ma direi che potresti fidarti di me, se accetti in massima il principio di far libri intelligenti, se si vuol far onore alla nostra fede. Proprio oggi scrivendo a Croce, scrivevo (e a te posso ripeterlo in stretta confidenza): «Invece di essere cattolici e fare tutto quel che un uomo deve fare, noi facciamo i cattolici e con questo ci dispensiamo dall’essere qualcosa, qualsivoglia cosa, anche cattolici».
Così nel , a proposito di un volume su Andersen: «La Zucconi è oggi la migliore competente: scrivile subito […]. Dico subito, perché l’autrice va a Napoli ed ho paura che il libro glielo chieda Croce per Laterza; e poi torna in Danimarca per un terzo anno di studio». In questo caso sarà l’autrice nuovamente a deludere le attese di De Luca, visto che Minelli risponderà: «Sta bene per l’Andersen della Zucconi, alla quale ricorde-remo l’impegno per la Von Dröste non mai venuto alla luce».
L’esperienza giornalistica
UNA VITA NELL’UTOPIA
Le donne, le collaboratrici, in generale poche e operose, presso i giornali redatti in prevalenza da uomini, portano nelle colonne quotidiane un largo soffio di poesia. Arrivano al giornale quasi tutte e quasi sempre sorridendo, lasciando alla porta il loro fardello di pene segrete. Hanno nell’aspetto la felicità del loro lavoro, che le accomuna all’uomo, pur non privandole della loro femminilità. Hanno nel gesto e nelle parole il gusto della fatica intrapresa, l’entusiasmo del continuare, la grazia soddisfatta del sentirsi prescelte.
Ma in stragrande maggioranza, le circa cinquecento donne che dichiara-vano la professione di scrittrice si limitavano a collaborazioni occasionali alle riviste femminili, e vivevano di altre occupazioni, dei guadagni del marito o di rendita.
Don Giuseppe, che non dubitava della mia vocazione letteraria, aveva co-minciato a sciogliere il groppo della lirica procurandomi la collaborazione alla terza pagina di un quotidiano cattolico: “l’Avvenire d’Italia”. Questo mi consentì di cominciare prestissimo a non chiedere soldi a casa e più tardi a pagarmi gli studi universitari.
Accanto agli studi, come un percorso parallelo, Angela Zucconi inizia la sua collaborazione a “L’Avvenire d’Italia”, l’importante quotidiano cat-tolico di Bologna, nel , per intercessione di don Giuseppe De Luca: anno centrale per la sua vita, l’indipendenza economica e le collaborazioni con il quotidiano, infatti, le consentiranno di partire per un viaggio ad Amburgo da dove invierà numerose corrispondenze. Ma, per tornare all’esordio su “L’Avvenire”, questo diventa subito terreno di pratica della scrittura e di messa a punto del confronto, costante e serrato, con De Luca che “coltiva” la giovane amica con una dedizione che riconosciamo dagli stessi articoli e dalle lettere rimaste.
Gli articoli della Zucconi sono distanti anni luce, e certo per questa direzione spirituale eccellente, dalle scritture delle donne cattoliche, an-che più mature di lei, che si alternano nella terza pagina del quotidiano: i nomi di Emilia Salvioni, Bianca Paolucci (critica d’arte), Carla Cadorna, Peppina Dore, Maria Sticco stanno lì a segnalare l’identificazione della scrittura femminile con quel «soffio di poesia», e quelle buone virtù do-mestiche indispensabili in chi deve comunque sempre ricordare di essere stata prescelta e per questo ringraziare. La differenza generazionale, e un abito ancora intriso di letture liceali, il Mamiani, a differenza delle più anziane educate alla scuola privata cattolica, danno alla giovane Angela una spigliatezza quasi sfrontata anche se messa in relazione con colossi della cultura del tempo come Emilio Cecchi e, tema ricorrente delle pagine di cultura de “L’Avvenire”, Alessandro Manzoni.
Colpisce, comunque, l’elemento di casualità che emerge dalla nar-razione della sua vita, in questa circostanza come in altre simili, teso a eliminare ogni ricordo di emozione, e stupore, nel trovare le sue parole, di giovane donna, nelle stesse pagine che ospitano, per citarne solo al-
VANESSA ROGHI
cuni, Bargellini, Ricciotti e Papini, i nomi più influenti dell’intellettualità cattolica del tempo: scriverà, prendendosi in giro «è una delle solite que-stioni di prestigio… io porto gli occhiali, e dovunque mi presenti tutti mi prendono sul serio». Ma del resto, a rileggere quegli articoli, emergono, come in una pagina scritta con inchiostro simpatico, la voce, la penna di De Luca, a dare forza e spessore alla voce di questa firma, Ilaria, unico pseudonimo femminile su “L’Avvenire”, per tutti gli anni Trenta, dietro la quale lui, don Petronio, può forse dire le stesse cose ma in modo più piano e semplice, diretto, come è documentato anche dall’epistolario fra De Luca e R. Manzini, direttore de “L’Avvenire” che scrive: «Caro Don Giuseppe, iniziando le feste del centenario leopardiano che cosa hai meditato di fare per l’Avvenire? Immagino che ti sarà quasi odiosa l’idea di scrivere sotto l’assillo di un centenario; ma d’altronde non potremo rimanere zitti in questo frangente. […] La signorina Ilaria non potrebbe fare qualche cosa?». E Ilaria scrive due articoli su Leopardi. Così an-che per Manzoni, nel giugno del , a proposito di una nuova edizione dei Promessi sposi:
L’ultima lodevole novità di questa completa e organica presentazione dei Promessi sposi è l’assenza di ogni commento. Non aveva una volta detto il Manzoni che «le parole hanno da dire da sé, a prima giunta, quel che vogliono dire e quelle che hanno bisogno di interpretazione non la meritano»? E, onestamente, all’infuori di note di ordine filologico, (perché un testo perfetto non ci fu neanche per il Manzoni, nonostante le ventiquattro edizioni che uscirono lui vivente) all’infuori dunque di queste note, non ci sembra che in ordine estetico ci possano essere scoperte o rivelazioni improvvise da fare. A meno che, per dire qualche cosa di nuovo, non si voglia postillare i Promessi sposi a uso del Tommaseo, il quale però questa volta arrivò a farne ammenda.[…] Per arrivare a dire questo il Tommaseo la doveva aver fatta grossa. Ma ancora, ancora a lui si poté perdonare perché Tommaseo fu grande a dirla col Pistelli «se non per quelle chiose, nonostante quelle chiose».
Manzoni e Tommaseo, assi di uno stesso discorso che De Luca, a partire dagli anni Trenta non cesserà mai di approfondire e che L. Mangoni ha ricostruito nel suo lavoro sul «prete romano»: «il troppo cauto Manzoni e il troppo esplicito Tommaseo cominciavano a costituire uno dei binomi che andranno riproponendosi, fra gli altri, negli anni ’, e su cui non c’è da sbagliare: a ogni richiamo a Manzoni, qualche riga più sotto nello stesso testo segue un richiamo a Tommaseo, o viceversa».
E ancora a Ilaria-Angela verrà affidata la recensione di una nuova edizione degli Inni Sacri, per l’editore Signorelli, ad opera di Mario Chi-ni: dove, oltre all’elogio verso la riedizione di un testo così “grande”, si sottolinea, non senza una punta di ironia, nel lavoro erudito del curatore
UNA VITA NELL’UTOPIA
motivo di grande interesse anche per il lettore più distratto che altro non può essere colto se non da «sgomento» di fronte alle «sedici pagine intro-duttive e alle ottanta note di commento al Nome di Maria, e davanti alle centocinquanta note in commento alla Pentecoste», note peraltro «tanto complete» da togliere al lettore «la speranza di una qualche scoperta», fino a costituire una vera e propria «impenetrabile muraglia intorno alla poesia», considerata più come uno scalino in più verso una rigenerazione spirituale che non lirica in sé. Ma, continua Ilaria, introducendo il tema di che cosa debba essere, e sia, in fondo, il vero credente quando scrive, «La lodevole preoccupazione del Chini è dimostrare quanto sentimento e pensiero fossero indissolubilmente uniti in quella sua meditazione religiosa» al punto da scontentare tutti:
deluse gli amatori di smancerie sentimentali che speravano di poter trovare nei riti della Chiesa Cattolica qualcosa di più riposante, deluse quanti mormoravano e volevano vedere nella conversione del Manzoni, reduce da molte pericolose esperienze intellettuali, un atto di “stanchezza disperata”.
E ancora, recensendo la vita di Nicola Fabri di Peiresc, ad opera di Pierre Humbert:
Savait tout, ci dicono i suoi biografi, eppure non ci lasciò neanche un libro. E forse fu proprio questa libido sciendi senza ambizione, che lo disperse su un campo troppo vasto, che lo portò a incominciare una infinità di cose e a non finirne nessuna. Eppure, oggi che sappiamo tanto razionalmente arginare queste avidità nobili, ma pericolose per l’immortalità di un’opera, oggi che sappiamo tanto razionalmente mutilare un uomo, per farne piuttosto un bravo professo-re, riandiamo con una specie di nostalgia al lavoro di questi, ormai scomparsi, hommes de liaison.
Se, come scrive L. Mangoni, per De Luca, «Confessare un’ambizione di santità non era possibile se non attraverso la rilettura e la riproposta della vita dei santi […]», così, l’articolo su Nicola Fabri, rimanda a una figura ideale che il prete romano evocherà tutta la vita, costantemente pressato da problemi economici, che in parte supera accettando, fin dal , il ruolo di cappellano dei vecchi poveri nella chiesa delle Piccole Suore dei Poveri, a San Pietro in Vincoli. Scrive infatti, pochi anni dopo, nella sua rubrica, “Umori del tempo”, don Petronio:
chi studia, o studia per farsi una posizione o per crearsi un titolo […] Leggere e studiare disinteressatamente, per ozio, non usa più […] uno che studii per sé stesso, che non pubblichi, che non scriva né un libro né un articolo, è definito un ozioso […] È invece l’unico uomo che meriti l’epiteto di homo sapiens.
VANESSA ROGHI
Ancora una volta per mano di Ilaria, sua voce e penna, don Petronio reclama ascolto, dando spazio però a questa giovane donna che, grazie a questi interventi, non solo si rende indipendente dalla famiglia, ma acqui-sta una certa notorietà negli ambienti familiari e non solo, se è vero che, come lei stessa racconta: «Conoscevo da giovane un professore di storia della medicina che mi tormentava perché per ogni libro che pubblicava mi chiedeva una recensione su “L’Avvenire d’Italia” (abitava al piano di sotto e quindi c’erano i tête à tête in ascensore). Il libro era sempre lo stesso, cambiavano solo i titoli: I santi nella storia della medicina, La storia della medicina e i santi, I santi medici nella storia».
Gli articoli di Ilaria escono con una certa regolarità fino al , af-frontando vari argomenti, fra i quali spiccano quelli a soggetto francese, come la storia dell’Accademia di Francia, alla quale dedica un’attenta ricostruzione, senza tralasciare i commenti antilluministi: «L’idea di fare dei problemi letterari una questione di Stato, parve a quei tempi ad al-cuni ridicola, ad altri tirannica»; o gli appunti di M.me de Maintenon, pubblicati grazie alla cura dello studioso Marcel Langlois, dove si rico-struisce la storia del tradimento nei confronti di Fénelon e del pietismo ai suoi albori, condannati dalla Maintenon, malgrado la sua ignoranza in questioni teologiche, «quattro anni prima di Roma! : «Fénelon in fondo, in fondo, aveva deluso Madame de Maintenon, che era donna sinceramente pia, ma un po’ ristretta di mente, un po’ sul genere di donna Prassede». Costante in questo articolo il richiamo a Henri Bremond, punto di riferimento inevitabile per ogni discorso sulla storia della pietà francese è vero, ma anche corrispondente, e in qualche modo “maestro”, di De Luca, e che la Zucconi inizia a conoscere tramite lui.
Ma insieme alla voce di De Luca, la voce di Angela inizia a cambiare di timbro, acquista sicurezza e cresce in autonomia, nelle recensioni dap-prima, nei reportages poi; la sua cifra stilistica inizia ad acquistare quel tratto personale, di esperienza, che non ha niente di impressionistico o romantico ma è semplicemente attento a cogliere le sollecitazioni esterne per rielaborarle durante la lettura di un testo che la incuriosisca, e De Luca rimane più nell’ombra, a indicare strade da percorrere, incontri da fare, come nel richiamo a Peguy, nella recensione di un libro di Gibbons; magari a correggere storture stilistiche (anche se non restano tracce in questo senso, mentre rimangono per gli articoli scritti per “L’Avvenire” da Romana Guarnieri, alla quale De Luca raccomanda, in rapide note a matita, di «eliminare personalismi», «fare più attenzione ai costumi del luogo, alle persone», nel tentativo di insegnarle il modo di scrivere di Angela). Scrive, infatti, Ilaria, recensendo un libro che parla di un pel-legrinaggio: «Per darvi almeno un’idea vi dovrei confessare anch’io che in una calda giornata di luglio ho fatto tre chilometri di strada asfaltata
UNA VITA NELL’UTOPIA
soltanto per vedere il mare, mentre lateralmente alla strada correva una ferrovia (tre lire andata e ritorno). Vi dovrei confessare che anch’io ho conosciuto la serena fatica di andare a piedi, di paese in paese, con il “rucksack” sulle spalle. Vi dovrei confessare che, fin dagli anni più remoti della mia infanzia ho sempre provato una fiduciosa ammirazione per i globetrotter, i pellegrini vagabondi (la parola vagabondo non ha mai avuto per me senso dispregiativo). Vi dovrei confessare che ho sempre pensato, pure ingenuamente, al giro del mondo a piedi come la grande soluzione della vita quotidiana. Per anni e anni non ho mai parlato di questa idea […] Avevo paura che un bel giorno ci impedissero di andare in giro per il mondo senza un soldo, perché (esperienza fatta dal Vagabond de Notre Dame) “con quattro pence sei un gentleman che va studiando la vita, ma senza i quattro pence passi per un disgraziato senza un letto”, e la curiosità del gentleman non è pericolosa come l’indifferenza del vagabondo».
Nei suoi articoli nasconde le sue esperienze più importanti, come l’incontro con J. R. M. appunto, che emerge fra altri cento in un appun-to sui compagni di viaggio, nel treno per Amburgo: «E quel signorotto distinto che assomigliava a (Victor) Jeckill. Sapeva di essere coltissimo, leggeva “Anch ent Man Leben”. Ieri ho rivisto il biglietto da visita di quel signore: norvegese che importa sale da Trapani», insieme a notazioni su un paese letto nella sua normalità un po’ allucinata «Ma pure nelle grandi stazioni ci sono ore di calma […]. E tu scendi, cammini lungo il treno già vuoto, ti guardi intorno È proibito attraversare i binari, Quello che tu dai per l’assistenza invernale non va al partito, ma al popolo tedesco, Uscita consegna bagagli». Del resto non manca l’adesione al proprio tempo, in una prospettiva in cui la critica è indirizzata dall’esperienza fascista e dal filogermanesimo più alle “conseguenze ingiuste” del trattato di Versailles, che non alla violenta presa del potere di Hitler: «Anche i più acidi Kritikaster vi diranno che il partito nazionalsocialista ha fatto miracoli per l’assistenza alle classi disagiate. A ogni angolo di strada, in ogni caffè, in ogni ristorante, incontrate quel tipo dall’impermeabile grigio e rosso: gira con una cassettina appesa al collo, e vende i biglietti della lotteria per l’assistenza invernale. Le famiglie che si sono quotate per una cifra non inferiore ai cinque marchi al mese, possono tenere fuori dalla porta uno speciale distintivo delle opere assistenziali». E ancora «La Hitler Jugend (Opera Nazionale Balilla) è mobilitata, i soldati girano con le carrette per la raccolta dei vestiari e dei viveri; gli iscritti al partito ogni domenica vanno questuando per le strade, un milione e mezzo di tedeschi offre la sua attività per il Winterhilfswerk, e il Winterhilfswerk assiste diciotto milioni di poveri, vale a dire un quarto dell’intera po-polazione». Mentre scrive, recensendo un volume sull’uomo del nella Russia sovietica, che lì ciò che ancora salva il popolo e dà speranze è
VANESSA ROGHI
l’animo cristiano dei russi. E già matura quel punto di vista sul mondo, nemico della modernità come attitudine consumistica verso i luoghi e le cose: «Del resto tutte le grandi città viste da un aeroplano hanno l’aria di un eczema. Vi avverto che si tratta di una osservazione profonda, perché le grandi città sono veramente una malattia della terra». In questo senso la collocazione della scrittura sul giornale cattolico e filofascista non è alla base di questi giudizi, la Zucconi conserverà questo sguardo critico sulla modernità, sempre, in sintonia con De Luca.
Compagne di viaggio
L’unico privilegio della donna è di potersi permettere l’amicizia, che tra donne è assai più comune che tra gli uomini. E l’altro, più grande ma dello stesso genere: la facilità con cui si affida a Dio e lo serve.
Nel Romana Guarnieri si iscrive alla facoltà di Lettere di Roma, e segue i corsi di germanistica di G. Gabetti: la scelta è in qualche modo segnata, perfettamente bilingue, figlia di un italiano, Romano Guarnieri, professore di italiano alla facoltà di Utrecht, e di una olandese, parla perfettamente il tedesco ed è cresciuta in un ambiente intellettuale e co-smopolita, senza alcuna educazione di tipo religioso. Si sente apolide, e un po’ disorientata, anche per il trasferimento in Italia, avvenuto negli anni del liceo, il Visconti, data la separazione dei suoi e la nuova convivenza della madre con il noto architetto razionalista Gaetano Minnucci. Legge tutto, senza alcun indirizzo, si innamora di A. Soffici (al quale dedica una prosa), scopre in Angela il suo esatto opposto e ne è profondamente col-pita e attratta. Il marzo Romana Guarnieri alza il telefono e chiede un appuntamento a De Luca, ma De Luca vede in lei una nuova anima da coltivare. Il marzo la prima lettera: «Caro don Giuseppe, salto la tappa del “molto reverendo signore”! Sono grata al mio impulso, lei lo chiamerebbe diversamente, ma la sostanza rimane la stessa –, che mi ha fatto telefonare iersera, e al mio coraggio che non mi ha permesso di tirarmi indietro stamattina. Confido che lei mi vorrà concedere un poco di quella amicizia che sempre mi è tanto mancata. Mi perdoni se non le dico di più. Cerco di non pensare, per non soffocare quello che sento deve maturarsi dentro. Se avrà la forza di vivere. E intanto rileggo gli articoli di Ireneo Speranza. Mi aiuteranno anche se parlano di poeti, rinascimenti, vocabolari o burleschi. Sono stata in chiesa. E ho pianto: la testa vuota, e il cuore troppo pieno. Dopo i primi dieci minuti lei ha avuto tutta la mia fiducia». Romana capitola immediatamente di fronte al prete, ma anche di fronte al fascino dell’intellettuale. Don Giuseppe consiglia a Romana
UNA VITA NELL’UTOPIA
di non porre i suoi sentimenti, anzi «un suo sentimento», al di sopra della sua anima, e, in breve, di chiudere ogni rapporto con Angela, di dedicarsi solo allo studio e di non seguire Angela nelle sue inquietudini. Nel giro di un mese questo è fatto. «L’altro giorno, con un breve biglietto – stile lettera d’affari – ho richiesto ad Angela il Burckardt che le avevo pre-stato. Insieme al libro mi ha mandato un cordiale biglietto – stile lettera amichevole – che mi ha fatto il piacere che lei si può immaginare. Solo la seguente frase mi dà un poco da fare “Se avremo tre o quattro giorni di vacanza per la venuta di Hitler telefonami: a meno che Don De Luca non ti consigli di procrastinare il nostro incontro, o tu non voglia turbare il tuo lavoro (ma non ti credo così santamente fedele ai principi dell’igiene mentale)”». Romana inizia a collaborare a “L’Avvenire d’Italia”, ma sono soltanto pochi articoli, in lei più che della giornalista, De Luca coltiva la studiosa: le corrispondenze per il quotidiano bolognese risalgono al periodo -, e hanno inizio con il viaggio di Romana in Svezia, per una borsa di studio: nel tragitto Romana si ferma a Monaco di Baviera dove, dopo un anno dal biglietto «stile lettera d’affari», incontra Angela, lì per approfondire la ricerca su Lodovico I. Al distacco fra le due amiche si unisce il progressivo allontanamento da don De Luca che legge nelle difficoltà di Angela a perseguire fino in fondo la via dello studio più una mancanza di fede e coraggio che una necessità di concretezza e lavoro. Dall’autobiografia di Angela Zucconi: «Trascorsi a Monaco un anno assai strano: passavo la giornata a leggere una dopo l’altra le duemila lettere che la marchesa Florenzi aveva scritto al suo Re, e a consultare i tanti carteggi che il Re Lodovico per mezzo secolo ebbe con varie personalità italiane. Ma nello stesso tempo avevo occasione di conoscere cose che anni dopo i tedeschi diranno di avere ignorato. Mi avventurai in bicicletta perfino a Dachau insieme a un’amica che era venuta a trovarmi. Mercoledì luglio . Con Romana Guarnieri le due fotografie prese nel campo di concentramento: il cartello di legno scolpito e dipinto a vivaci colori rappresenta un SS che prende a calci un recalcitrante che non vuole camminare, e sotto la freccia. Zum Konzentrationslager. Nell’altra foto uomini bocconi per terra che fingono di fare qualcosa».
Dal diario di Romana Guarnieri: «Sabato luglio . Partenza per il nord. La sera sono a Monaco Angela è alla stazione. […] Mercoledì : pom. In bicicletta a Dachau – bagno, campo di concentramento – Sch-leissheim – Stanchezza e tristezza».
Scrive Romana a De Luca il luglio del : «Carissimo Don Giuseppe, la cronaca minuta del viaggio la apprenderà da Nuccia. A Lei ancora un saluto a parte. Per ora tutto è in ordine. Salvo certe ma-linconie inevitabili. L’amicizia con Angela è salva. Ma un certo rodio nel cuore me lo ha lasciato […]», risponde De Luca: «Mia cara Romana,
VANESSA ROGHI
[…] Ho piacere che cammini. Dalle tue, che leggo sempre, anche tra le righe, non veggo novità che mi addolorino». Romana segue fedelmente la strada indicata da De Luca. Angela se ne allontana sempre di più: il bisogno di stare in mezzo agli altri trova nell’antifascismo un momento di realizzazione. Infatti, con la guerra le strade delle due amiche si riu-niscono; Romana trova un lavoro presso l’Istituto delle Suore di Nevers, dove insegna storia dell’arte; Angela invece compie un percorso più complesso: parte per Copenaghen, dove ha la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua danese grazie a un lavoro ottenuto da Rizzo-li, sicuramente per intercessione di Leo Longanesi: la traduzione del romanzo appena uscito e grande successo di Jorgen-Franz Jacobsen, Barbara; e assiste all’occupazione tedesca. È durante l’occupazione che la conoscenza del danese diventa per lei un modo di confondersi ancora di più con la resistenza all’occupazione, abbandona il tedesco e si sforza di parlare soltanto danese e in poco tempo ci riesce.
Partecipai con il caschetto bianco e rosso degli universitari (un caschetto simile a quello dei ragazzi della via Paal) alla prima grande manifestazione contro il filo-nazista Scavenius, nominato ministro degli Esteri in questi frangenti, nel luglio del ’. La dimostrazione si svolse sotto le finestre del palazzo reale ad Amalienborg, perché re Cristiano fin dal aprile era riconosciuto come capo della resistenza disarmata dei danesi. Non venne neppure istituita la censura sulla stampa e sulla radio, l’unico provvedimento fu lo scioglimento del partito comunista, ma solo un anno dopo avvennero i primi arresti e l’internamento di duecento membri del partito.
Rientra a casa nell’estate del , passando attraverso la Germania «imbandierata a festa». Ma non rimane molto; malgrado infatti il con-flitto sia ormai esteso su tutto il continente, A. riparte per Copenaghen: «l’università di Copenaghen, date le circostanze, mi aveva rinnovato la borsa di studio e Adriano Olivetti, che insieme a Bobi Bazlen aveva preparato i piani per le Nuove Edizioni di Ivrea […] mi aveva proposto un contratto per la traduzione di varie opere di Kierkegaard». A Co-penaghen, A. Z. frequenta anche il più illustre dei danesi del suo tempo, il premio Nobel per la fisica Niels Bohr, al quale viene introdotta da una lettera di presentazione di Giancarlo Wick, figlio di Barbara Allason: «Niels Bohr era un buon ascoltatore e, pure nel suo perenne stato di concentrazione, avrebbe voluto sapere tante cose sul fascismo, sulle leggi razziali, sui comuni amici, su Kierkegaard e il cattolicesimo. Io parlavo pochissimo per timidezza e anche perché ero ignorante e non sapevo che dire. […] Non sapevo che dire, anche perché ero e sono il servo che ha ricevuto un solo talento dal padrone al momento della sua partenza e non ha saputo far altro che quello che dice la parabola: «Chi ne aveva
UNA VITA NELL’UTOPIA
ricevuto uno, se ne andò a fare una buca in terra e vi sotterrò il danaro del suo padrone».
Ma nel gennaio del , con le elezioni che danno al partito nazista solo il % dei voti la “protezione” tedesca cambia di segno e inizia l’occu-pazione vera e propria: «Lasciai definitivamente la Danimarca nell’aprile del ’. Mesi prima ero riuscita a spedire, profittando di un carico spe-ciale, la bicicletta e una scrivania imbottita dei tanti libri acquistati per i vari progetti di studio avviati. Alcuni mesi prima avevo potuto spedire il manoscritto definitivo del mio “Lodovico” per corriere diplomatico. I miei amici danesi, sapendo la fame che mi aspettava in Italia, mi carica-rono di provviste, io spesi gli ultimi soldi della ricca borsa di studio per acquistare capi di vestiario di lana, che da noi erano scomparsi da anni. Così mi misi in viaggio per un’avventurosa traversata della Germania con tredici valigie e due enormi catene provviste di grossi lucchetti». Rientra a Roma, però, come molti sfollati, nell’agosto del : «A ot-tobre potei avere un posto di insegnante al liceo delle Suore di Nevers, grazie a quell’amica, di cui non avevo saputo più nulla dopo quella nostra gita in bicicletta a Dachau». Con De Luca riprende subito il difficile rapporto, che trova un momento di grande unità in seguito alla morte della madre di Angela, nel febbraio del : «Passai dei giorni chiusa in casa senza vedere nessuno. […] Don Giuseppe De Luca, che non era mai venuto a casa mia, intuì ogni cosa e venne per strapparmi da questo nido di compiacimento del dolore». Ma per De Luca Angela è sempre più un’anima da redimere: «Roma, dicembre . Via delle sette sale . Cara Romana, buon Natale. Oggi è venuta, dunque, Angela. Forse, e alla fine, è anche lei sulla via stretta, la via dell’Amore. Se Cristo mi avesse contentato di questo: uno degli Argomenti miei (o Suoi), più gravi, è stato: non può, chi è stato strumento, ad altra (e cioè tu), di misericor-dia, restar nelle tenebre esteriori. Forse è tornata. Prega, dunque, per lei. Aiuta il ritorno». Scrive Romana, un anno dopo: «Roma, novembre . Caro Peppino, […] Domenica mattina ho lavorato a Hadewych, indi, per mezz’ora, ho visto Angela, meno acida di quanto tu mi avessi annunciato. I discorsi tuttavia restarono sempre sopra sopra, e senza un reale impegno». La Zucconi si distacca dalla sua guida spirituale e intellettuale e cambia completamente percorso, fedele al motto di Lao Tze, «non c’è meta, soltanto la strada», inizia a lavorare alla scuola di assistenti sociali di Guido e Maria Calogero.
Sappiamo, da testimonianze dirette, che l’amicizia con De Luca con-tinuò sempre, amicizia burrascosa e intensa, se è vero che, come racconta Adriano Ossicini «Quando De Luca e la Zucconi litigavano, le loro urla si sentivano fino al Colosseo». Tuttavia resta la curiosità di andare più a fondo in questa amicizia particolare, relazione eccellente, fra un uomo
VANESSA ROGHI
e una donna così vicini eppure per tutta la vita, in lotta.
L’amicizia e la cura di don Giuseppe De Luca, malgrado i miei lunghi intervalli di silenzio, le mie fughe e infedeltà, mi accompagnerà fino alla sua ultima stretta di mano sul suo letto di morte nell’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Era stato sempre il suo modo di congedarmi: allungava il braccio sulla scrivania fino a me che gli sedevo di fronte: era il gesto di uno che ti aiuta a saltare un fosso, o tirarti fuori dall’acqua, era il gesto di farti uscire dal caos, ma certamente era il modo tutto suo di fare il prete e di mettermi in pace con Dio.
Don Giuseppe tanti anni prima mi aveva scritto una volta (e fu “una volta per sempre”): «Tu sai che se non ti seguo e ti inseguo non è certo perché non ti voglio presente. Ti ho presente sempre, ma con dolore. Tu credi che Cristo sia sempre là alla porta dove tu lo lasci, sicura sempre di ritrovarlo intirizzito dal freddo, dal buio e dalla solitudine. Di rado, tu lo sai, io parlo e intervengo. Non aspettare più, non tergiversare più. Egli è ancora alla porta, ma ricordi la parabola? .
Note
* Questo articolo non avrebbe potuto essere scritto senza la preziosa collaborazione di chi ha conservato, negli anni, fonti e documenti, ad oggi inediti, relativi ad A. Zucconi (d’ora in poi A. Z.) e li ha messi a disposizione per questa mia ricerca. In primo luogo vorrei ringraziare Florita Botts, che di A. Z. ha condiviso vita e impegno dal e che custodisce l’archivio Zucconi con grande cura. Inoltre, Anna Maria Levi, Marcella Rinal-di, Alma Maria e Giovanni Tantillo che mi hanno aiutato con preziosi ricordi e consigli. E inoltre il prof. Adriano Ossicini che mi ha assistito nella lettura di alcune importanti questioni interpretative.
. Terni - Anguillara Sabazia (Roma) .. N. Ferrari, A. Zucconi, Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà, , p. ,
dattiloscritto conservato in archivio A. Z. . N. Ajello, L’utopia pragmatica di A. Zucconi, in “la Repubblica”, marzo . . O. Pivetta, Una vita attiva. L’esempio di una rara virtù civile, in “Il Diario della
settimana”, marzo , p. .. Cfr. Ajello, L’utopia pragmatica di Angela Zucconi, cit.; C. Tognonato, Nel mondo,
con passo leggero, in “Il Manifesto”, febbraio ; G. Russo, Angela Zucconi, la vita come utopia, in “Il Corriere della sera”, settembre .
. Tratto evidente anche nelle autobiografie di donne coetanee e a lei in qualche modo vicine come B. Allason, Memorie di una antifascista: -, Avanti, Milano , e G. Benzoni, Una vita ribelle, il Mulino, Bologna .
. «L’histoire des femmes et les études sur le genre ne se sont guère posé directement la question de l’intellectuelle. Les analyses de la domination masculine, de la séparation des sphères privée et publique et de la construction sociale du masculin et du féminin consti-tutifs de ces champs de recherche – ont cependant mis au jour les rouages de l’exclusion des femmes du savoir et des lieux d’exercice du pouvoir politique et intellectuel. […] Nous avons souhaité poser la question de leur statut et de leur parcours d’intellectuelle afin de suspendre un moment cette spécialisation disciplinaire et thématique et de jeter sur elles un autre regard. Ne cesse de progresser parallélement la découverte de celles qui, malgré tout, ont eu accès à la connaissance, à la sciences, à la culture et à l’écriture et ont pleinement enrichi la vie intellectuelle. Ces figures ont le plus souvent éré étudiécs à travers leur domaine d’intervention tour d’abord la littérature et le féminisme mais aussi la philosophie, la science, la psychanalyse on encore la politique». F. Rochefort, À la découverte
UNA VITA NELL’UTOPIA
des intellectuelles, in “Clio. Historie, Femmes et Sociétés”, , , pp. -.. A. Z., F. Giuntella (a cura di), Fabbrica, Comunità, Democrazia, Fondazione A.
Olivetti, Roma ; Biblioteche a Roma, Taccuino del centro studi Fondazione A. Olivetti, Roma ; Per una memoria storica delle comunità locali, , Taccuino del centro studi Fondazione A. Olivetti, Roma ; Per una memoria storica delle comunità locali: come salvaguardare le fonti, , Taccuino del centro studi Fondazione A. Olivetti, Roma ; Regioni e servizi sociali. Quaderni di studi regionali, centro studi della Fondazione A. Olivetti, Milano ; I Servizi sociali nel decentramento amministrativo a Roma, Milano, Bologna, Quaderno n. , , supplemento al n. , di “Assistenza d’Oggi”; Les Re-sponsabilités de la femme dans la vie sociale, Conseil de la cooperation culturelle, Conseil d’Europe, Strasbourg ; Gli Assistenti sociali nei paesi scandinavi: Introduzione, Centro Sociale, Roma ; Il Progetto Avigliano: Il comprensorio del progetto ed i primi interventi, Il programma, conclusioni, Centro Sociale, n. -, Roma ; La Formazione di operatori sociali nell‘Italia meridionale, in “International Journal of Adult Education”, Unesco, Paris ; Il Progetto Pilota per I‘Abruzzo - Un biennio di lavoro, in “Centro Sociale”, n. , Roma ; Il Progetto Pilota per I’Abruzzo: Descrizione generale del Progetto, in “Centro Sociale”, nn. -, ; Un centro europeo di formazione per assistenti sociali, in “Comuni d’Europa”, ottobre ; Centri sociali e problemi del lavoro di gruppo, in “Comunità, rivista del Movimento Comunità”, anno VI, n. , Milano .
. Fra queste quella con R. Guarnieri, importante per il peso che esercita nel mettere in discussione il rapporto di A. Z. con don Giuseppe De Luca. Amicizia ricostruita intera-mente dalle carte conservate da R. Guarnieri, storica della pietà, vicina a don Giuseppe De Luca, figura ancora tutta da studiare, malgrado le numerose testimonianze da lei pubblicate nel corso degli anni. Ultima Con occhi di beghina. Sguardi sull’oggi, Marietti, Genova . Ma cfr. anche Don Giuseppe De Luca. Tra cronaca e storia, Edizioni Paoline, Milano e Una singolare amicizia. Ricordando don Giuseppe De Luca, Marietti, Genova .
. Come la storia d’amore durata per molti anni con lo svedese J. M. R., il cui nome è sempre cifrato.
. Romana Guarnieri, di cui si parlerà più avanti nel testo, conosce A. Z. al corso di germanistica del prof. G. Gabetti, nel . Cfr. Guarnieri, Una singolare amicizia, cit., pp. -.
. Fausto Minelli (-), fin da giovane impegnato nell’associazionismo giovanile cattolico, fondò nel , e diresse fino alla morte, la casa editrice Morcelliana di Brescia, una delle più importanti case editrici cattoliche. Nel fondò la rivista “Humanitas”. Fu presidente dal al dell’Unione editori cattolici italiani.
. Rochefort, À la découverte des intellectuelles, cit.. Lodovico innamorato esce nella collana di Rizzoli, Il sofà delle muse, curata da
Longanesi dopo un lungo lavoro di ricerca partito dalla tesi di laurea. Sarà L. Longanesi, ideatore della collana, a sollecitarne la pubblicazione.
. A. Z., Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà, L’ancora del mediterraneo, Napoli , p. .
. Ivi, p. . . Mario Zucconi: Pordenone agosto - Campello sul Clitunno agosto
.. Virginia Cecca (deceduta nel ).. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Ivi, pp. -.. «Poco prima di partire da Bengasi per sempre, ci fu assegnata d’ufficio una grande
casa arredata all’italiana e fuori dal quartiere arabo. All’ingresso dove iniziava la scala c’era la statua di un negretto con il turbante che reggeva una lampada. Al primo piano un balcone che si affacciava sul corso Italia, in alto una terrazza grandissima dove passavo molte ore solitarie. All’orizzonte per lunghi periodi si vedeva un anello di fuoco: erano gli incendi che i ribelli senussiti appiccavano alle piantagioni di orzo delle tribù arabe amiche
VANESSA ROGHI
degli italiani. I grandi giochi collettivi erano finiti. C’era solo per me la paura che quei fuochi che circondavano la città arrivassero fino a noi e io spaziavo nella terrazza deserta fingendo di buttarmi in acqua e di nuotare per salvarmi. Ero così occupata con i giochi e l’immaginazione che non ho mai letto un libro fino a quattordici anni. A differenza di mio fratello grande che leggeva moltissimo e studiava malvolentieri, io andavo bene a scuola e non avevo interesse per altri libri». Ivi, p. .
. Ivi, p. .. Ivi, p. .. «Come è stato più volte evidenziato nella storiografia letteraria, gran parte di questi
intellettuali provenivano da Trieste e dagli altri centri della Venezia Giulia che fino al avevano rappresentato l’estrema propaggine sud-occidentale dell’impero austro-ungarico […]. Tutti sensibili in gioventù agli ideali dell’irredentismo, molti di essi lasciarono la loro regione […] per stabilirsi in grandi città italiane come Milano e Roma, da dove svolsero la loro attività di critici letterari, traduttori, consulenti editoriali», L. Giusti, Aspetti della ricezione della letteratura tedesca moderna in Italia negli anni Venti e Trenta, in L. Finocchi, A. Gigli Marchetti, Editori e lettori. La produzione libraria in Italia nella prima metà del Novecento, FrancoAngeli, Milano , p. .
. Sugli intellettuali triestini cfr. il saggio di Giusti, Aspetti della ricezione della letteratura tedesca, cit., pp. -, soprattutto riguardo a Spaini, sul quale ancora non esiste una monografia. Sugli altri cfr. N. Dacrema, Ritratto di un germanista: Ervino Pocar, Tipografia sociale, Gorizia ; G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Garzanti, Milano ; M. La Ferla, Diritto al silenzio. Vita e scritti di Roberto Bazlen, Sellerio, Palermo . A. Z. conoscerà Bazlen durante la sua collaborazione con le Edizioni di Comunità di A. Olivetti, sarà lei a presentarlo a De Luca che subito lo proporrà per traduzioni a F. Minelli della Morcelliana; cfr. G. De Luca, F. Minelli, Carteggio, III, -, a cura di M. Roncalli, cit., p. , n. e A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
. Ivi, p. . . «Maria di salute precaria, Jacopa cieca dalla nascita, Immacolatella e Angeluccia,
giovani calabresi analfabete, Rosa di origine toscana», R. Morozzo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello. Un’avventura spirituale nell’Italia del Novecento, Guerini e As-sociati, Milano , p. .
. Terziarie francescane. . Morozzo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello, cit., p. .. La bibliografia su Buonaiuti e il modernismo in Italia è ormai vastissima, si rimanda
dunque alle opere di sintesi di M. Guasco, Modernismo. I fatti le idee i personaggi, San Paolo, Cinisello Balsamo , e di G. Forni Rosa, Il dibattito sul modernismo religioso, Laterza, Roma-Bari . Anche se è ormai un classico lo studio di P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, il Mulino, Bologna .
. Torinese, vicina a P. Gobetti e al movimento Giustizia e libertà. Traduttrice dal tedesco e antifascista, perderà l’insegnamento durante il ventennio e sarà messa in prigione. La sua vicenda, come già riportato, è contenuta nelle sue note biografiche Memorie di una antifascista -, cit. Cfr. G. De Luna, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società italiana, -, Bollati Boringhieri, Torino . Cfr. anche J. Slaughter, Barbara Allason, voce in Dizionario del fascismo, vol. I, Einaudi, Torino .
. «Sì, devozione sincera per questa Chiesa dove hanno vissuto i nostri Padri; ma nessuna smania di dimostrare che si è dentro o fuori», nota Jacopa nel , cit. in Morozzo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello, cit., p. .
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Su B. Allason traduttrice cfr. Giusti, Aspetti della ricezione della letteratura tedesca
moderna in Italia, cit., pp. -.. L’incontro con Benedetto Croce avverrà quando, dopo la tesi di laurea su Lud-
ovico I di Baviera, Longanesi le offre la possibilità di pubblicare un libro che diventerà Lodovico innamorato, Rizzoli (poi ripubblicato da Longanesi nel )... «In una nota
UNA VITA NELL’UTOPIA
della Critica Croce aveva espresso l’augurio che qualcuno facesse una “pubblicazione documentaria” sulla marchesa Florenzi. Fu lieto quindi di mettere a mia disposizione un diario della stessa e vari carteggi connessi all’amicizia della Florenzi con il filosofo napoletano Francesco Fiorentino. Così passai il mese di dicembre ’ a Napoli». A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
. Che De Luca conoscesse l’attività dell’eremo appare certo, se non dalle testimo-nianze di A. Z., sicuramente dal legame che univa don G. Sandri, amico carissimo di De Luca, a don Brizio Casciola. In questo senso cfr. anche la testimonianza di R. Guarnieri, che conserva nel suo archivio una busta su Sandri, sulla cui figura non esiste ancora uno studio soddisfacente. «Di lui dirò solo che fu il discepolo prediletto di De Luca, il prete più vicino alla sua anima e al suo cuore, finché non lasciò il sacerdozio, scegliendo per sé la vita dell’eremita e dell’apostolo itinerante e un poco vagabondo», R. Guarnieri, Don Giuseppe De Luca. Tra cronaca e storia, Edizioni Paoline, Milano , p. .
. Cfr. L. Mangoni, In partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento, Einaudi, Torino , pp. , -.
. Morozzo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello, cit., pp. -.. Per la corrispondenza di suor Maria con Gandhi cfr. ivi, pp. - e Frammenti
di un’amicizia senza confini. Gandhi e sorella Maria, Eremo di Campello sul Clitunno, Roma .
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Le sorelle, ma anche gli ospiti dell’eremo, ricevono, consuetudine tipica in una
congregazione religiosa, un nuovo nome. I nomi vengono scelti, di preferenza, tra le «sorelle del cosiddetto Albero di Santa Chiara, ossia dai cinquanta nomi delle prime compagne di Chiara», Morozzo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello, cit., p. .
. Testo ricopiato da un foglio manoscritto, in caratteri grandi e stampatello, chiuso in una busta di plastica per essere portato in tasca e consultato spesso. Conservato da F. Botts.
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Jolanda, Eva Regina. Consigli e norme di vita contemporanea, Casa Editrice Ita-
liana, Firenze , p. , cit. in M. de Giorgio, Le Italiane dall’Unità ad oggi, Laterza, Roma-Bari , p. .
. A. Z., Oltre la siepe, in Viaggi senza approdo. Poesie, Airoldi, Roma , p. .. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. La casa editrice Airoldi non appare fra le case editrici studiate da N. Tranfaglia,
A. Vittoria nella Storia degli editori italiani, Laterza, Roma-Bari . . Scrive al riguardo a don De Luca: «Ho pensato di scriverle anche per darle una
notizia che tuttavia non credo la interessi molto se non riesce ad interessare molto neanche me: la pubblicazione delle liriche più presentabili. Su quest’affare io non c’entro; non me ne sono voluta occupare perché la ritengo una cosa perfettamente inutile se non dannosa. So benissimo che il mio libro non richiamerà l’attenzione di nessuno, che nell’insieme è terribilmente monotono, e che in questo momento poi il mondo non sa che farsene della poesia», Archivio De Luca (d’ora in poi ADL), Corr., c. A. Z., lettera del agosto .
. Su Margherita Guidacci (-), poetessa e traduttrice, nipote di N. Lisi e allieva di G. De Robertis, ha scritto M. Ghilardi nel catalogo Margherita Guidacci. La parola e le immagini, mostra documentaria e catalogo a cura di M. Ghilardi, Polistampa, Firenze .
. M. Guidacci, in Poeti a Roma (-), cit. in Ghilardi (a cura di), Margherita Guidacci, cit., p. .
. A. Z., Su la via Appia, in Viaggi senza approdo. Poesie, cit., p. .. A. Z., Attesa, in Viaggi senza approdo. Poesie, cit., p. .. La fortuna italiana della Dickinson, come di molti altri scrittori americani, risale
agli anni Trenta: è G. Prampolini a tradurre per primo le sue poesie in una antologia sulla Moderna poesia nordamericana, Circoli, anno III, n. , ; quindi M. Praz la inserirà nella
VANESSA ROGHI
sua Antologia Anglo-americana, pubblicata da Principato nel . Sarà però E. Cecchi a renderla nota con un articolo sul “Corriere della Sera” del ottobre e, infine, con una monografia scritta a quattro mani con la figlia Giuditta nel per l’editrice Mor-celliana di Brescia: E. Cecchi, G. Cecchi, Emily Dickinson, Morcelliana, Brescia, . A tal riguardo e in riferimento al cenno a don De Luca nel testo, cfr. anche G. De Luca, F. Minnelli, Carteggio, a cura di M. Roncalli, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma , ad indicem.
. Su De Luca e la Dickinson cfr. nota . A. Z., Educande, in Viaggi senza approdo. Poesie, cit., p. .. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. S. Aleramo, Una donna. Romanzo, Società tipografica editrice nazionale, Roma
Torino . . «La lunga elaborazione di Una donna si conclude con la prima edizione del testo:
l’opera che, tra il e , diede origine ad un vivace, e variegato, insieme di letture, di consensi e di critiche, e, negli stessi anni, a sei traduzioni in lingue straniere, che, vivente l’autrice, ebbe sei riedizioni Treves ; Bemporad ; Mondadori , , Feltrinelli , rimarrà, salvo piccoli ritocchi formali, immutata negli anni», M. Zancan, Una donna di Sibilla Aleramo, in Letteratura italiana, Le opere, IV, Il Novecento, t. I, L’età della crisi, Einaudi, Torino , pp. -. La Zancan tuttavia non dà conto delle due edizioni del romanzo proposte durante il fascismo e delle loro particolarità in relazione al periodo, se ce ne sono.
. A. Z., Viaggi senza approdo. Poesie, cit., pp. -.. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del ventennio,
Editori Riuniti, Roma , p. .. A tal proposito cfr. l’utile studio di G. Pagliano, Testimonianze di lettura (-
) da memorie e autobiografie, in Finocchi, Marchetti (a cura di), Editori e lettori, cit., pp. -.
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. . Ibid. . “Il centauro triste” è il titolo del capitolo in cui A. Z. parla della morte di don
Giuseppe De Luca; nell’autobiografia l’immagine del centauro è riferita a sé stessa, tuttavia la figura del centauro è evocata da De Luca, per parlare di sé, in un articolo su “L’Avvenire” del novembre . Cfr. Don Petronio, Umori del tempo, in “L’Avvenire d’Italia”, novembre .
. R. Guarnieri, De Luca e gli affetti, in Don Giuseppe De Luca e la cultura italiana del novecento, Edizioni di storia e letteratura, Roma , p. .
. Cfr. R. Guarnieri, Una lettera di “direzione spirituale”, in Una singolare amicizia, cit. pp. -.
. A. Z., Tirando i capelli al centauro triste, in P. Vian (a cura di), Don Giuseppe De Luca a cento anni dalla nascita, Edizioni di storia e letteratura, Roma , p. .
. Cit. in Mangoni, In partibus, cit. p. . Da notare la sottolineatura a questa frase nel volume appartenuto alla Zucconi.
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. . La Zucconi virgoletta nella sua autobiografia le parole di G. De Rosa, Don Giuseppe De Luca, Edizioni di Istituto Sturzo, Roma , p. .
. A. Z., Cinquant’anni, cit. p. .. Ibid.. E continua «So che un tempo scrivevo per vivere (sott. di A. Z.) ossia la finzione
artistica era diventata vita, e vivevo nell’orto segreto affondando nel pallore di crepuscoli senza fine e senza speranza. So che un tempo vivevo per scrivere, ossia ero ossessionata dal pensiero di accumulare esperienze su esperienze da trasformare in libri», ADL, Corr., c. A. Z. lettera agosto .
. Qualche anno dopo (dicembre ) A. Z. invierà a don Giuseppe una cartolina
UNA VITA NELL’UTOPIA
dal Museo nazionale di Napoli, raffigurante il dipinto di P. Brueghel Il falso devoto e il diavolo che gli ruba la borsa, con queste parole «Una volta, tanti anni fa lei mi mandò dal Museo Nazionale di Napoli una cartolina con l’immagine dolce e ridente di Saffo. Come vede sono vendicativa. Ma non me ne voglia male», ADL, Corr., c. A. Z.
. A tal proposito le uniche riflessioni rimangono quelle di Romana Guarnieri, cfr. C. Militello, Intervista a Romana Guarnieri, in “Ricerche teologiche”, anno X, , n. , Edizioni Dehoniane, Roma .
. A. Z., Cinquant’anni, cit. pp. -.. de Giorgio, Le Italiane dall’unità a oggi, cit., p. .. Cardinale francese vissuto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo. Fondò l’Oratorio di
Gesù e di Maria Immacolata. Ritenuto l’iniziatore della riforma sacerdotale in Francia, attirò molte polemiche di gesuiti e carmelitani per la sua devozione al Verbo.
. Uno dei lavori mai finiti della Zucconi. G. De Luca-F. Minelli, Carteggio, I, -, a cura di M. Roncalli, cit., p. . Il testo in questione era S. Maddalena, cfr. ivi, p. , n. . Su H. Bremond (-) cfr. H. Bernard-Maitre, R. Guarnieri, Don Giuseppe De Luca e l’abbè Henri Bremond, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma .
. «Era di Breslavia. Lavorava più o meno segretamente a Roma con un gruppo di sionisti, che abitavano in Campo marzio. […] A un certo punto scomparve. Riemerse nel maggio del […] in divisa di maggiore della brigata israeliana della V armata. […] più tardi scrisse una lettera da Gerusalemme, dove insegnava filosofia all’Università. Mi proposi di rispondere con una lunga lettera, anch’io per raccontare quegli anni. Non lo feci, come al solito, perché c’era troppo da dire, la bottiglia aveva il collo troppo stretto», A. Z., Cinquant’anni, cit. p.
. Su di lui l’articolo di Ilaria (A. Z.), Venceslao Ivanov a Roma, in “L’Avvenire d’Italia”, agosto .
. «Davanti al professore mi rattrappivo per la timidezza, ma Flamingo, una musa che svolazzava per quella casa, attenta a soccorrere la salute dell’anima e del corpo dei familiari e degli ospiti, era portavoce del professore e per suo tramite ricevevo grandi segni di amicizia e l’incoraggiamento a scrivere non solo le poesie ma anche gli articoli che cominciai a pubblicare sulla stampa quotidiana», A. Z., Cinquant’anni, cit. p. .
. La tesi è occasione per conoscere Leo Longanesi, «maestro nel lungo cammino dalla tesi alla pubblicazione del libro, Lodovico innamorato, e successivamente per molti anni. Grazie a lui fui promossa dalla terza pagina de “L’Avvenire d’Italia” alle riviste che curava in quegli anni, i primi rotocalchi, “Omnibus”, “Storia”, “Oggi”». Ivi, p. .
. La figura di G. Gabetti (-) è fondamentale nella vita di A. Z.; direttore dell’istituto di Studi germanici di villa Sciarra e della rivista “Studi Germanici”, fondata nel , dove A. Z. pubblica il primo estratto su Ludovico I. Al suo corso di specializzazione inoltre ha la possibilità di frequentare i corsi di D. Cantimori e C. Antoni e, grazie a una sua borsa di studio, parte per la Germania nel .
. Marianna Florenzi Waddington (-) fu una delle donne più celebrate del-l’Ottocento, il suo salotto ospitò patrioti e cospiratori, durante il Risorgimento, e letterati e filosofi dopo l’Unità. Su di lei F. Bozzi, Marianna allo specchio. Spigolature sulla vita e i pensieri della Marchesa Florenzi Waddington, Ellera Umbra, Perugia .
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. ADL, Corr., c. A. Z., lettera del ottobre .. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Cfr. G. De Luca, F. Minelli, Carteggio, II, -, a cura di M. Roncalli, cit., p.
.. Ivi, p. .. È Lodovico I; l’errore di don Giuseppe è rilevato dal curatore del carteggio nella
nota successiva, cfr. ivi, p. , n. .. Ivi, pp. -, lettera del agosto . Risponderà Minelli, rifiutando di fatto
il libro che, come abbiamo visto, uscirà per Rizzoli: «Carissimo De Luca, certamente
VANESSA ROGHI
attraentissima l’opera di A. Z. su Lodovico di Baviera. Ma come si fa a cominciare una nuova collezione – e di molto impegno – quando ci sono altre iniziative che non seguono col ritmo desiderato», ivi, p. , lettera del settembre .
. Come vedremo oltre, A. Z. passa i primi tre anni di guerra in Danimarca in seguito a due borse di studio e impegni di traduzione, ivi, p. , lettera del dicembre .
. Ivi, p. , lettera del gennaio .. L. Santandrea, La donna e la stampa, in “Fiamma viva”, maggio , cit. in de
Giorgio, Le Italiane dall’Unità a oggi, cit., p. .. V. de Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia , p. .. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Sul De Luca giornalista ha scritto R. Guarnieri, Don Giuseppe De Luca. Fra
cronaca e storia, Edizioni Paoline, Milano , pp. - e Mangoni, In partibus, cit., in particolare pp. -.
. Le corrispondenze sono tutte pubblicate nella terza pagina de “L’Avvenire” (anni -).
. Nata a Bologna nel , collaboratrice de “L’Avvenire d’Italia”, “Il Corrierino”, “Lettura” e “Fiamma viva”, scrive romanzi per ragazzi.
. Una delle più note e apprezzate, in ambienti curiali, scrittrici cattoliche. Dal Ragguaglio del risulta nata nel in Sardegna e già collaboratrice de “L’Avvenire d’Italia”, della “Festa” e della “Fiorita”, autrice di opere agiografiche.
. Ilaria (A. Z.), Scrittori inglesi e americani, in “L’Avvenire”, gennaio , p. , recensione al volume di E. Cecchi, Scrittori inglesi e americani, Carabba, Lanciano . «Se un futuro catalogo a soggetto […] potesse un giorno configurarsi con criteri gastronomici, questo libro di Cecchi potrebbe figurare tra gli antipasti».
. Ilaria (A. Z.), In giro per San Pauli, in “L’Avvenire d’Italia”, maggio . ADL, Corr., c. Manzini, marzo .. Leopardi e Gogol cercano un impiego, maggio ; Il soggiorno romano di
Giacomo Leopardi, maggio in “L’Avvenire d’Italia”.. Ilaria (A. Z.), Nuove edizioni dei Promessi Sposi, in “L’Avvenire d’Italia”, giugno
, p. .. Mangoni, In partibus infidelium, cit., pp. -.. Ilaria (A. Z.), Commento a gli Inni Sacri, in “L’Avvenire d’Italia”, giugno
.. Ilaria (A. Z.), Nicola Fabri di Peiresc, in “L’Avvenire d’Italia”, , p. . . Mangoni, In partibus infidelium, cit., p. .. Guarnieri, Don Giuseppe De Luca tra cronaca e storia, cit., p. .. Don Petronio, Umori del tempo, in “L’Avvenire d’Italia”, maggio , p. . Cfr.
Mangoni, In partibus infidelium, cit., p. . Da notare che il volume della Mangoni appar-tenuto ad A. Z. è, nelle pagine in cui si citano queste riflessioni di De Luca, sottolineato, sicuramente nella fase di scrittura del capitolo a lui dedicato di Cinquant’anni nell’utopia, visti riferimenti ivi presenti.
. Ilaria (A. Z.), Tre secoli di storia dell’Accademia di Francia, in “L’Avvenire d’Italia”, gennaio , p. .
. Ilaria (A. Z.), Gli appunti di Madame de Maintenon, in “L’Avvenire d’Italia”, aprile , p. .
. Altra traccia della mano di De Luca anche in questo articolo Fénelon e Francesco di Sales, argomento affrontato da De Luca in un articolo sull’“Avvenire” il gennaio , San Francesco di Sales scrittore.
. J. Gibbons, Le vagabond de Notre Dame, Desclée de Brouwer , recensito da Ilaria (A. Z.), Vagabondi di Nostra Signora, in “L’Avvenire d’Italia”, gennaio , p. .
. Appunti di don G. De Luca conservati presso l’archivio personale di R. Guar-nieri.
. «Mio fratello grande e io, i primi tempi, ce ne stavamo seduti spesso sul davanzale
UNA VITA NELL’UTOPIA
della finestra nella sala da pranzo con le gambe penzoloni a guardare la gente che passava. Erano sempre le stesse persone. Passava l’imam della vicina moschea, sembrava san Giu-seppe. Si fermava e ci salutava con un sorriso pio mormorando qualcosa che poteva essere una benedizione. […] A una certa ora passava “sant’Alipio”, così era stato soprannominato un tale che pareva uno stilita appena sceso dalla colonna. […] Mi è rimasto bene impresso questo personaggio e ancora oggi lo rivedo ogni volta che mi capita di leggere quel passo della donna di Sunem che diceva al marito: “Io so che è un uomo di Dio, un santo colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, una lampada, sì che venendo da noi si possa ritirare”». La citazione è tratta da Il libro dei Re, , pp. -, in A. Z., Cinquant’anni, cit.
. Ilaria (A. Z.), Vagabondi di Nostra Signora, in “L’Avvenire d’Italia”, gennaio , p. .
. Ilaria (A. Z.), Compagni di viaggio, in “L’Avvenire d’Italia”, febbraio , p. .
. Ibid.. «Non so chi disse una volta che l’orario ferroviario è il più bel libro di viaggi:
credo che il più tragico dei libri verdi sia il trattato di Versailles. A guerra finita i vincitori mandarono il conto ai vinti. […] L’intesa ordinò una perizia: intanto portò via, sotto gli occhi avidi della popolazione affamata . mucche da latte, .. pecore, .. maiali, .. cavalli, .. capi di pollame…Tornarono in patria dalle zone occupate e dalle colonie perdute i profughi (più di un milione e centomila profughi) e videro le fortezze smantellate, le bandiere dell’Intesa sui grandi transatlantici della Hapag, le corazze e i cannoni delle navi ammucchiate come rottami di ferro […]», Ilaria, Una domenica ad Amburgo, in “L’Avvenire d’Italia”, marzo , p. .
. Traduzione della Zucconi.. Ibid.. Tuttavia le esperienze di questi anni sono vastissime: «Ebbi un invito dalle Fer-
rovie svizzere, viaggio e ospitalità, per scrivere una serie di articoli sulle stazioni invernali e così conobbi […] la vita dei grandi alberghi internazionali, i modi di vita dei ricchi, ma a corto di argomenti in questo ambiente, andai anche a Zurigo e intervistai il calzolaio che aveva ospitato Lenin […], e a Sils Maria andai nella casa del maestro di scuola che aveva ospitato Nietzsche», A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
. Ilaria (A. Z.), Primo incontro con la città tentacolare, in “L’Avvenire d’Italia”, luglio .
. A. Z., Taccuini, miscellanea senza data (messi a disposizione da F. Botts).. R. Guarnieri a don G. De Luca, lettera del marzo . Carteggio inedito
conservato presso l’archivio privato di R. Guarnieri.. Don G. De Luca a R. Guarnieri, lettera del marzo . Carteggio inedito
conservato presso l’archivio privato di R. Guarnieri.. R. Guarnieri a don G. De Luca, lettera senza data (ma aprile ). Carteggio
inedito conservato presso l’archivio privato di R. Guarnieri.. Da una lista compilata dalla stessa Guarnieri, riportante i titoli delle sue col-
laborazioni a “L’Avvenire”: «, senza data, La celebrazione dei gamberi a Stocccolma; dic. , La profonda eco della parola pontificia tra i protestanti della Svezia; agosto , Itinerario breve verso il nord; genn. , Santa Lucia in cotta e maglia; febb. , Tiro a segno a sotto zero. Il nuovo sport alla moda degli svedesi».
. Delle fotografie dovrebbe esserci traccia nell’archivio della Guarnieri.. «Ci infilammo con le biciclette in una strada sterrata che passava lungo un muro
dove ogni tanto si affacciavano le torrette di vigilanza. La strada fiancheggiava i campi dove lavoravano gli internati. A un certo punto ci trovammo davanti un mitra spianato. Mostrammo alle SS il nostro passaporto dell’Asse Roma-Berlino e lui senza dire una pa-rola ci riaccompagnò fuori della strada sterrata fino al piazzale dove c’era il cartello con l’indicazione», A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
VANESSA ROGHI
. R. Guarnieri, Taccuini. Inediti conservati presso l’archivio personale di R. Guarnieri. La Guarnieri ricorda di aver scritto su questa esperienza un articolo per “L’Avvenire”.
. R. Guarnieri a don G. De Luca, lettera del luglio . Carteggio inedito conservato presso l’archivio privato di R. Guarnieri.
. Don G. De Luca a R. Guarnieri, lettera del agosto . Carteggio inedito conservato presso l’archivio privato di R. Guarnieri.
. Il prof. Rivasecchi, insegnante di storia dell’arte al liceo Visconti, chiama Romana, non ancora laureata, a sostituirlo presso l’istituto ecclesiastico.
. Sulla Rizzoli di quegli anni cfr. Tranfaglia, Vittoria, Storia degli editori italiani, cit., dove si danno anche indicazioni sull’attività di Leo Longanesi.
. «Il re Cristiano X volle uscire per il suo giro a cavallo come tutte le mattine. Muto e grave passò davanti ai soldati, alle mitragliatrici e ai camion tedeschi, e ai danesi che lo guardavano, chiedeva fedeltà e non violenza, come aveva scritto nel proclama delle prime luci dell’alba, mentre gli aeroplani sorvolavano la città addormentata. Scese la sera su una città completamente buia e deserta. Tutti aspettavano dietro le finestre che succedesse qualcosa, invece non successe niente né allora, né dopo, fino all’estate del ’. La Danimarca era l’ultima riserva agricola e i tedeschi cercarono di non dare nell’occhio e anzi perfino di chiudere un occhio sui tanti ebrei che circolavano, molti dei quali erano addirittura profughi della Germania fino allora fiduciosi della neutralità scandinava», A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
. «Con sorpresa di tutti, abbandonato il tedesco, imparai in pochi giomi a parlare danese, e gli amici mi guardavano come se fossi un cane parlante», A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .
. Ivi, pp. -.. Ivi, p. . «Le facilitazioni che avevo per lo studio erano illimitate. Passavo dalla
Biblioteca reale, dove coltivavo il progetto Kierkegaard, al museo Thorwaldsen per certi inediti che interessavano il mio libro su Re Lodovico; per un periodo mi fu perfino concesso di leggere il manoscritto dei viaggi in Italia di H. C. Andersen, un altro inedito sul quale pensavo di lavorare, che si trovava nella sede moderna della facoltà di Scienze, perché era dotata di un profondo rifugio antiaereo», ivi, p. .
. Ancora una volta Campello si rivela un luogo di relazioni centrale fra i cattolici e non solo di quegli anni. Su N. Bohr, cfr. A. Pais, Il danese tranquillo, Bollati Boringhieri, Torino .
. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Ivi, p. .. Ivi, p. .. Don G. De Luca a Romana Guarnieri, dicembre , lettera inedita conservata
da R. Guarnieri nel suo archivio privato.. Romana Guarnieri a don G. De Luca, novembre , lettera inedita conservata
da R. Guarnieri nel suo archivio privato.. Intervista con A. Ossicini raccolta e registrata dall’autrice nel maggio .. A. Z., Cinquant’anni, cit., p. .. Ivi, p. .
UNA VITA NELL’UTOPIA