Scultura barocca romana in Slesia. Un busto di Bernardino Fioriti nella cattedrale di Breslavia
Architettura e scultura dell'alto Medioevo nell'arco alpino occidentale
Transcript of Architettura e scultura dell'alto Medioevo nell'arco alpino occidentale
ARCHITETTURA E SCULTURADELL’ALTO MEDIOEVO NELL’ARCO ALPINO
OCCIDENTALE
Negli studi sull’architettura italiana dell’altomedioevo manca og-gi una sintesi di ampio respiro che superi la rassegna tentata più disessant’anni fa da Paolo Verzone, con il suo volume L’architetturareligiosa dell’Altomedioevo nell’Italia settentrionale, edito in cinque-cento copie a spese dell’Autore nel 1942: un’opera scritta e pubblica-ta con le grandi difficoltà che si possono immaginare data la situa-zione del momento, soprattutto se si pensa che essa raccoglie e di-scute tutto quanto era noto fino a quel momento sugli edifici dellaTarda Antichità e dell’Altomedioevo norditaliano 1.
Con quest’opera pionieristica – stimolata, occorre ricordarlo, dal-la Lombard Architecture di Arthur Kingsley Porter – Verzone si ac-collava l’onere di una ricognizione a vasto raggio (seppur limitata,per così dire, alla sola area settentrionale della penisola) di edificispesso allo stato frammentario, o anche solo citati da documenti, onascosti sotto vesti edilizie più tarde, nell’intento di mettere a di-sposizione degli studiosi dati oggettivi, materiale disperso e assaispesso non accessibile: e tuttavia sempre fornendo ben più di unamera registrazione dei dati, pur meticolosa e intelligente. Le brevi,a volte brevissime schede (con l’eccezione dell’ampia trattazione delSanto Stefano di Verona) concentrano l’attenzione sui dati planime-trici e dell’alzato, quando leggibile, e li integrano agli eventuali datidocumentari e all’osservazione diretta delle tecniche murarie, for-nendo così una precoce indicazione di metodo agli studi a venire.
1 P. VERZONE, L’architettura religiosa dell’Altomedioevo nell’Italia settentrionale,Milano, 1942.
SAVERIO LOMARTIRE300
Solo al termine di questa ricognizione Verzone delinea una visionedi insieme cercando di fornire un panorama sull’evoluzione di sche-mi planimetrici, tecniche costruttive, decorazione 2.
In epoche più recenti, e certo in condizioni meno disagevoli, èmancato per l’area italiana un simile sforzo di sintesi, forse ancheperché non ve ne è stata l’occasione. Dico subito che nemmeno nel-l’occasione presente verrà tentato qualcosa anche solo di lontana-mente simile all’opera meritoria di Verzone, che attende piuttosto diessere riedita con gli opportuni ampliamenti e aggiornamenti. Vasegnalato piuttosto che da qualche anno è stato messo in cantiereda diversi enti e studiosi un ampio corpus dell’architettura altome-dievale: un progetto europeo già avviato che vedrà in tempi forsenon lontani anche un volume dedicato alle architetture italiane.
Non bisogna però dimenticare che in ambito europeo sono statiprodotti da tempo ricognizioni e studi su ampie aree geografiche, co-me il fondamentale repertorio dei Vorromanischen Kirchenbauten,dedicato agli edifici di area svizzero-tedesca, curato da Hans RudolfSennhauser con la collaborazione di altri studiosi già nel 1966 e poiin successive edizioni, con il recente aggiornamento del 1991 3. Alprof. Sennhauser dobbiamo poi diversi studi anche di sintesi ed orail recentissimo corpus delle architetture altomedievali dell’arco alpi-no centro-orientale, pubblicato nel 2003 in due volumi, che interessai versanti italiano, sloveno, austriaco, tedesco fino a quello dellaSvizzera romanda 4.
Sarebbe certo auspicabile che si potesse arrivare ad un simile ri-sultato anche per l’area alpina centro occidentale; la situazione at-tuale degli studi infatti inizia a mostrare un progresso nella raccol-ta di dati in buona misura affidabili.
2 Ibid., pp. 161-189.3 F. OSWALD, L. SCHAEFER, H. R. SENNHAUSER, Vorromanischen Kirchenbauten: Kata-
log der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, München, 1966 (Veröffentlichungendes Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, III); W. JACOBSEN, L. SCHAEFER,H. R. SENNHAUSER, Vorromanischen Kirchenbauten: Katalog der Denkmäler bis ZumAusgang der Ottonen, München, 1991 (Veröffentlichungen des Zentralinstituts fürKunstgeschichte in München, III/2).
4 Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonischeZeit, Hrsg. von HANS RUDOL SENNHAUSER, 2 voll., München, 2003; in part.: H. R. SEN-NHAUSER, Typen, Formen und Tendenzen im frühen Kinchenbau des östlichen Alpenge-bietes: Versuch einer Übersicht, ibid., pp. 919-980.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 301
Va infatti riconosciuto che negli ultimi anni si sono prodotte al-cune indagini ad ampio raggio su singole aree geografiche, spessoconfluite in atti di convegni o in raccolte di sintesi 5. Spetta agli ar-cheologi aver raccolto negli ultimi anni la sfida di dipanare le fila diuna mole sempre più abbondante di dati che emergono dal moltipli-carsi di scavi e di ricerche anche in ambito documentario; è un datodi fatto che ciò è avvenuto con maggior frequenza in alcune aree,mentre altre restano ancora prive di dati aggiornati. Fra queste ul-time cito solo, a titolo di esempio, l’area pavese. Per una città comePavia, del rango di una capitale dal VII almeno fino agli inizi delXII secolo, conosciamo infatti ben poco in confronto ad altri più for-tunati contesti 6.
Per l’area piemontese la situazione è in un certo senso diversa;qui, grazie all’attività delle Soprintendenze, e in particolare, per gliaspetti che qui ci interessano, della Soprintendenza Archeologica,nell’ultimo ventennio si sono potuti raccogliere molti nuovi dati suedifici già noti e studiati, come San Giusto di Susa, la cattedrale diIvrea, il Duomo di Acqui ed altri, come pure su edifici “minori” o an-che “minimi”, a comporre un panorama più completo ed affidabile,anche in relazione alle dinamiche sociali economiche politiche e la-tamente culturali dei territori a cui gli edifici appartenevano.
Tra i complessi architettonici di maggiore rilievo proprio quellodell’abbazia della Novalesa, che è una delle sedi del presente con-gresso, ha visto nel 1978 l’inizio di indagini di archeologia medieva-le in Piemonte. Sotto la guida di Gisella Cantino Wataghin gli scavihanno interessato la chiesa, il complesso abbaziale e alcune dellecappelle esterne, vedendo all’opera almeno due generazioni di ar-
5 S. LUSUARDI SIENA et al., Le tracce materiali del Cristianesimo dal tardo antico alMille, in Il Veneto nel Medioevo. Dalla Venetia alla Marca Veronese, a cura di A. CA-STAGNETTI e G. M. VARANINI, Verona, 1989, II, pp. 87-328; Le chiese rurali tra VII e VIIIsecolo in Italia settentrionale. Atti dell’8° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioe-vo in Italia Settentrionale (Garda, 8-10 aprile 2000) a cura di G. P. BROGIOLO, Manto-va, 2001 (in part. i saggi di A. CROSETTO, P. M. DE MARCHI, H. R. SENNHAUSER, G. P.BROGIOLO); Chiese e insediamenti nelle campagne tra V e VI secolo. Atti del 9° Semina-rio sul tardo Antico e l’Alto Medioevo (Garlate, 28-28 settembre 2002), a cura di G. P.BROGIOLO, Mantova, 2003 (in part. i contributi di G. P. BROGIOLO, L. PEJRANI BARICCO, G.PANTÒ, E. MICHELETTO, A. CROSETTO, E. CAVADA, H. NOTHDURFTER, A. CAGNANA).
6 Per una sintesi sul caso pavese nell’altomedioevo: D. VICINI, La civiltà artistica:L’architettura, in Storia di Pavia, II. L’altomedioevo, Milano, 1987, pp. 317-371.
SAVERIO LOMARTIRE302
cheologi che sul cantiere di scavo novaliciense si sono formati e han-no poi costituito un gruppo di studiosi molto attivi e competenti, an-che nella Soprintendenza Archeologica, nello studio delle testimo-nianze architettoniche e scultoree della regione. Quello del Piemon-te è stato fino ad ora un caso fortunato di collaborazione di un grup-po di archeologi medievisti, attivi nella tutela e nello studio, che haprodotto risultati su tutto il territorio regionale, a differenza diquanto accade in taluni altri contesti territoriali italiani.
Anche per la Valle d’Aosta l’attività di scavo e di indagine dellaSoprintendenza ha permesso già da molti anni, a partire dalle inda-gini di Renato Perinetti e Charles Bonnet, la pianificazione e l’avviodi campagne conoscitive sugli edifici della regione, sull’esempio diquanto da tempo è consuetudine in altre aree europee.
Questa fortunata situazione permette così di poter contare suuna serie cospicua di dati, ricavata da un campione non esiguo degliedifici soprattutto religiosi, ma anche su contesti civili o funerari,dalla Tarda Antichità al Medioevo. Dai contesti urbani anche piùimportanti – si pensi ai recenti risultati prodotti dagli scavi dellaCattedrale di Torino 7 – per arrivare ai complessi monastici e alleloro dipendenze, e poi all’architettura religiosa rurale e ai resti diinsediamenti o di necropoli, la percezione del tessuto originario cosìcome è rappresentato delle testimonianze superstiti, anche solo a li-vello delle planimetrie riportate in luce, si è negli ultimi anni moltoarricchita in Piemonte e in Valle d’Aosta, e ne è prova una ricca earticolata bibliografia, che verrà richiamata più oltre.
Se la serie esaminata dal Verzone per lo stesso arco cronologicopoteva considerare solo otto complessi monumentali piemontesi 8,dei quali nessuno veramente in area alpina, ora i dati riguardano
7 L. PEJRANI BARICCO, La basilica del Salvatore e la cattedrale di Torino: considera-zioni su uno scavo in corso, in Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, a cura di L.MERCANDO e E. MICHELETTO, Torino, 1998, pp. 133-149; EAD., L’isolato del complessoepiscopale fino all’età longobarda, in Archeologia a Torino. Dall’età preromana all’Al-to Medioevo, a cura di L. MERCANDO, Torino, 2003, pp. 301-317.
8 VERZONE, L’architettura cit., (nota 1), nell’ordine: Piane Sesia, Santa Maria diNaula (pp. 17-18); Torino, Antica Cattedrale (pp. 37-38); Vercelli, SS. Trinità (pp. 58-59); Novara Battistero (pp. 73-74); Settimo Vittone, S. Lorenzo e Battistero (pp. 131-133); Ivrea, presbiterio della Cattedrale (pp. 147-150); Spigno, San Quintino (pp. 153-154); Asti, Cripta di S. Secondo (pp. 156-157).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 303
un numero considerevole di edifici, dei quali oltre una ventina nellasola area delle Alpi occidentali (Fig. 1).
Il mio compito in questa sede non vuole certo essere quello di ri-discutere i singoli casi, ma piuttosto quello di farne una rapida ras-segna, per vedere quali primi risultati si possa tentare di ricavarein un’ottica regionale più ampia, pur rinunciando ad ogni velleità diricavare dai dati, relativamente numerosi nel complesso ma tutta-via necessariamente sintomatici, qualunque conclusione di carattereassoluto. L’arco cronologico interessato è quello altomedievale, finoal X secolo; gli accenni ai complessi di arredo scultoreo saranno fattinell’ottica del valore che a tale elemento può talora essere attribuitoper la conferma dei dati archeologici. La rassegna si basa su quantoè stato finora edito a seguito di ricognizioni mirate o di scavi, oppu-re si basa su dati consolidati nella letteratura, e non tiene invececonto delle indagini ancora in atto; gli edifici menzionati saranno in-fatti principalmente quelli sui quali sono disponibili dati attendibiliforniti dalle indagini più recenti 9.
I casi presi qui in esame appartengono ad un’area alpina intesain senso molto ampio, ma limitata al solo versante italiano proprioper sottolineare il valore provvisorio di ogni considerazione e in at-tesa che si possano confrontare i dati con altri contesti territoria-li 10. L’area considerata esclude le Alpi Marittime e comprende inve-ce i territori corrispondenti alle Alpi Cozie, Graie e in parte allePennine. Il panorama non può e non vuole essere completo – e d’al-tra parte non tiene nemmeno conto, per ragioni legate alla presenteoccasione, della opportuna integrazione con le testimonianze dellapianura – ma rappresenta tutt’al più una campionatura, in ragionedella provvisorietà che deriva dal fatto che le ricerche archeologichenon sono state sempre effettuate in base ad un piano sistematico,
9 Devo alla cortesia della dott.ssa Egle Micheletto, funzionario di zona per la pro-vincia di Cuneo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, alcuni ragguagli re-lativi a Villar San Costanzo e a Caraglio, oltre che un utile scambio di opinioni; desi-dero inoltre ringraziare la collega prof.ssa Gisella Cantino Wataghin e le dott.sse So-fia Uggé, Eleonora Destefanis, Marta Spini e Lorenza Boni per avermi assistito nelladifficoltosa raccolta dei materiali e per aver discusso con me i non pochi problemi.
10 Atlas Culturel des Alpes Occidentales. De la Prehistoire à la fin du Moyen Age,dir. C. JOURDAIN-ANNEQUIN, Paris, 2004; si veda anche: D’une montagne à l’autre. Étu-des comparées, dir. D. RIGAUX, Grenoble, 2002 (Cahiers du CHRIPA, n. 6).
SAVERIO LOMARTIRE304
bensì spesso, o piuttosto quasi sempre, in concomitanza con inter-venti di salvaguardia, talora anche “di urgenza”, ai complessi monu-mentali odierni.
Fatta questa doverosa premessa, e attribuito prudentemente va-lore di campione auspicabilmente rappresentativo ai complessi ar-chitettonici presi in esame, si può facilmente constatare come gliesempi noti si accentrino in buona parte lungo gli importanti assiviari di comunicazione con direzione nord-sud, ma soprattutto lungoquelli che conducono ai valichi alpini del Colle di Tenda, del Colledella Maddalena, del Monginevro, del Piccolo San Bernardo e delGran San Bernardo, del Moncenisio, del Sempione.
La valenza degli edifici religiosi, soprattutto di quelli monastici,quale presidio territoriale sul percorso viario verso i valichi è statapiù volte sottolineata, e, per quest’area, anche in relazione al siste-ma delle fortificazioni tardoantiche e altomedievali 11; fa inoltre fededell’antichità di una simile situazione il frequente rinvenimento divestigia risalenti almeno ai primi secoli della cristianizzazione, senon addirittura ad epoche precedenti 12.
11 M. NEGRO PONZI, Romani, Bizantini e Longobardi: le fortificazioni tardoantiche ealtomedievali nelle Alpi occidentali, in Archeologia Medievale, XVII (1990), pp. 137-154. Sui problemi dei tracciati viari alpini nel medioevo: G. WATAGHIN CANTINO, Proble-mi e prospettive dell’archeologia cristiana in Piemonte. Atti del V congresso nazionaledi archeologia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Nova-ra, 22-29 settembre 1979), Roma, 1982, pp. 67-81; Tra pianura e valichi alpini. Attidel Convegno (Galliate, 20 marzo 1999), a cura di G. CANTINO WATAGHIN e E. DESTEFA-NIS, Vercelli, 2001; G. CANTINO WATAGHIN, Santuari e città: vie di pellegrinaggio e dina-miche insediative in Italia settentrionale tra tarda antichità e altomedioevo, in Fontiarcheologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti nell’altome-dioevo. Atti delle giornate di studio (Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002), a cura di S.LUSUARDI SIENA, Milano, 2003, pp. 125-132; S. UGGÉ, Culti santorali in ambito piemon-tese: il ruolo delle fondazioni monastiche altomedievali, ibid., pp. 173-198; Aux origi-nes de la transhumance. Les Alpes et le vie pastorale d’hier à aujourd’hui, dir. C.JOURDAIN-ANNEQUIN et J.-C. DUCLOS, Paris, 2006; G. CANTINO WATAGHIN, Strade e luoghisi strada, in Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al centro del Medioevo. Catalogo dellaMostra, a cura di F. CRIVELLO e C. SEGRE MONTEL, Milano, 2006, pp. 57-71; E. DESTEFA-NIS, Pellegrini e reliquie, ibid., p. 81. Rinvio inoltre al saggio di Gisella Cantino Wata-ghin in questo volume.
12 Come nel caso del San Saturnino di Susa: [L. PEJRANI BARICCO], Una passeggiatanei dintorni di Susa. Il tempio romano e il priorato di San Saturnino, scheda s.n. inArcheologia. Una risorsa per la Valle di Susa. Atti della Giornata di Studi (Susa, 30novembre 2001), Susa, 2001; per altri esempi in area piemontese v. inoltre E. MICHE-
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 305
La suddivisione lungo le direttrici verso i valichi consiglia di pro-cedere per singoli settori territoriali, a partire dall’area più orienta-le qui presa in esame, corrispondente alla odierna Val d’Ossola e al-le attuali provincie di Verbania, Novara, Biella e Vercelli.
In questa zona si conserva peraltro un numero consistente di te-stimonianze, già in parte prese in esame dalle ricognizioni confluitenel 1980 nel catalogo Novara e la sua terra nei secoli XI e XII 13 eregolarmente aggiornate attraverso prospezioni archeologiche. Larelativa abbondanza di contesti riportati in luce è segnale di unacristianizzazione capillare e relativamente precoce dell’area delleantiche diocesi di Vercelli e Novara – in una situazione analoga aquanto si è riscontrato per la diocesi di Torino – della quale fa fedeuna serie di strutture anche battesimali 14.
Per edifici come il S. Vincenzo di Pieve Vergonte, citato nel 962in un diploma di Ottone I e documentato come pieve nel 1006 15, oper il S. Giorgio di Varzo, noto per i frammenti di affreschi dell’XIsecolo, nel quale gli scavi hanno portato alla scoperta dei resti diuna struttura absidata di incerta cronologia 16, non sussistono ele-menti significativi per una datazione all’altomedioevo dei resti og-
LETTO, Chiese e città romane “abbandonate”: alcuni esempi in Piemonte, in Chiese e in-sediamenti cit. (nota 5), pp. 109-118.
13 Novara e la sua terra nei secoli XI e XII, a cura di M. L. GAVAZZOLI TOMEA, Nova-ra, 1980.
14 G. CANTINO WATAGHIN, Gli apporti archeologici per la conoscenza delle origini cri-stiane di Novara, in Il cristianesimo a Novara e sul territorio: le origini. Atti del Con-vegno (Novara, 10 ottobre 1998), Novara, 1999, pp. 55-70; L. PEJRANI BARICCO, Edificipaleocristiani nella diocesi di Novara: un aggiornamento, ibid., pp. 71-103; EAD.,Chiese rurali in Piemonte tra V e VI secolo, in Chiese e insediamenti cit. (nota 5), pp.57-85.
15 G. ANDENNA, La funzione della pieve nella campagna novarese, in Novara e lasua terra cit. (nota 13), pp. 26-27; M. T. MAZZILLI, Gli edifici di culto dell’XI e XII seco-lo. L’alto Verbano e le valli Ossolane, ibid., p. 235.
16 L. PEJRANI BARICCO, Varzo. Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in Quaderni dellaSoprintendenza Archeologica del Piemonte, 10 (1991), pp. 170-171; sui resti di decora-zione pittorica: C. BERTELLI, Scheda 15. Frammenti di affreschi (cinque teste e unbraccio), in La Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII. Catalogo della Mostra(Milano, 15 aprile - 11 luglio 1993), a cura di C. BERTELLI, Cinisello Balsamo, 1993,pp. 267-268; C. SEGRE MONTEL, La pittura medievale in Piemonte e Valle d’Aosta, inLa pittura medievale in Lombardia, in La Pittura in Italia. L’altomedioevo, a cura diC. BERTELLI, Milano, 1994, pp. 33-46 (33).
SAVERIO LOMARTIRE306
getto di indagini archeologiche. Tra gli edifici più rilevanti della fa-scia geografica inclusa nella presente ricognizione va invece menzio-nato il San Giovanni in Montorfano a Mergozzo (VB), citato in undocumento dell’885 17, dove gli scavi condotti nella piccola chiesa ro-manica attuale da Luisella Pejrani Baricco hanno individuato uncomplesso battesimale riconducibile al V-VI secolo – sorto forse qua-le chiesa privata di un proprietario terriero 18 – costituito da dueaule absidate di dimensioni simili (Fig. 2), una delle quali, quella anord, adibita a battistero secondo un tipo planimetrico noto in altricasi (a Lione, Ginevra, Grenoble, a S. Giovanni dell’Isola Comacina,a Noli) 19 e con indizi di un ridimensionamento in una successiva fa-se della vasca battesimale, fino alla ricostruzione dell’edificio conpianta cruciforme nel XII secolo. L’aula adiacente a sud 20 venneampliata in epoca successiva, verosimilmente tra VIII e IX secolo,con la formazione di un edificio triabsidato, successivamente di-strutto al momento della costruzione dell’edificio romanico che neoccupò in parte l’area (Fig. 3). Il notevole scalamento in profonditàdell’abside maggiore rispetto alle laterali, insieme all’ampiezza del-l’intero invaso interno, di circa 11 metri, fa pensare che qui si siatrattato di un edificio a tre navate, sebbene le risultanze dello scavonon appaiano risolutive al proposito.
Le ricerche recenti hanno confermato il ruolo svolto dall’isola diSan Giulio sul Lago d’Orta nella Tarda Antichità quale sede di unimportante castrum, citato per la prima volta in un diploma di Be-rengario I del 911 e poi nel citato diploma di Ottone I del 962, macertamente allestito nel V secolo e attivo anche in età longobarda 21.
17 D. BIANCOLINI FEA, Montorfano di Mergozzo. S. Giovanni, in Novara e la sua ter-ra cit. (nota 13), pp. 244-247; L. PEJRANI BARICCO, Mergozzo: complesso battesimale diSan Giovanni di Montorfano, in Milano capitale dell’impero romano, 286-402 d.C..Catalogo della Mostra (Milano, 24 gennaio - 22 aprile 1990), a cura di, pp. 195-196;EAD., Edifici paleocristiani cit. (nota 14), pp. 78-80.
18 G. ANDENNA, Riflessioni sull’ordinamento ecclesiale dell’Alto Novarese tra tardaantichità e medioevo, in Verbanus, 10 (1989), pp. 275-294 (287-288).
19 PEJRANI BARICCO, Edifici paleocristiani cit. (nota 14), p. 79.20 Allo stato attuale delle conoscenze non è nota l’originaria dedicazione di questo
edificio; si può ipotizzare però un prima intitolazione a S. Maria, titolo che più tardisarà preso dalla chiesa pievana nel centro abitato di Mergozzo.
21 ANDENNA, Riflessioni sull’ordinamento ecclesiale cit. (nota 18); L. PEJRANI BARICCO,Isola d’Orta: basilica di San Giulio, in Milano capitale dell’impero cit. (nota 17), pp. 297-
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 307
Se è dubbio che tale struttura possa essere ricondotta al sistema difortificazioni citato nel V secolo come “Tractus Italiae circa Alpes”dalla Notitia Dignitatum, è pur vero che ad essa potrebbe invece ri-ferirsi la citazione di Ennodio circa il castrum fatto costruire dal ve-scovo novarese Onorato 22. Nel 553 un altro vescovo novarese, Fila-crio, si fece seppellire sull’isola, e un frammento del suo epitaffiovenne ritrovato durante i lavori di costruzione della cripta nel1697 23; nel 590 il castrum fu poi sede del duca longobardo Mimul-fo 24. Gli scavi intrapresi dal 1983 e proseguiti fino al 1998 hannoprogressivamente fatto luce sulle strutture del castrum e della chie-sa che ha preceduto l’attuale struttura romanica (Fig. 4). Pur tra lemolte difficoltà di lettura causate dalla interferenza delle struttureromaniche e dagli sconvolgimenti del piano di calpestio documentatinei secoli successivi, gli scavi hanno evidenziato la presenza di unaprima struttura con abside disposta a nord, presto cancellata dauna grande struttura orientata come l’edificio attuale, databile al VIsecolo in base ai reperti di scavo; della chiesa, che come abbiamo vi-sto ha un riferimento ante quem al 553, restano frammenti decorati-vi di pregio, tra i quali i resti delle tarsie marmoree che decoravanoil cenotafio di San Giulio, oltre ad una lastra frammentaria con pa-voni forse dell’inizio del VII secolo (Fig. 5) 25, ricondotti da Luisella
298; EAD., Edifici paleocristiani cit. (nota 14), pp. 83-94; S. LUSUARDI SIENA, Committenzalaica ed ecclesiastica in Italia settentrionale nel regno goto, in Committenti e produzioneartistico-letteraria nell’alto medioevo occidentale, Spoleto, 1992 (Settimane di studio delCentro italiano di studi sull’alto medioevo, XXXIX), pp. 222-223 (224-226).
22 Ennodius, Opera, ed. F. VOGEL, in M.G.H., A.A., Berolini, 1885, p. 201, n. 260.23 PEJRANI BARICCO, Edifici paleocristiani cit. (nota 14), pp. 86-87.24 G. ANDENNA, Andar per castelli: da Novara tutto intorno, Torino, 1982, p. 623; G.
SERGI, Un’area del Novarese dall’inquadramento pubblico alla signoria vescovile: Ortafino al principio del XIII secolo, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino,LXXXVI (1988); pp. 171-193; L. PEJRANI BARICCO, Orta S. Giulio. Il castrum sull’isola,in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 16 (1999), pp. 234-237;A. BERTANI, Il ‘castrum’ dell’isola di San Giulio d’Orta in età longobarda, in Fonti ar-cheologiche e iconografiche cit. (nota 11), pp. 247-271.
25 Pejrani Baricco, Edifici paleocristiani cit. (nota 14), p. 91; R. CROSETTO, Croci eintrecci: la scultura altomedievale, in Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, a cura diL. MERCANDO e E. MICHELETTO, Torino, 1998, pp. 309-323 (311); L. PEJRANI BARICCO, Lefonti archeologiche per la storia dell’isola, in San Giulio e la sua isola nel XVI cente-nario di San Giulio, Novara, 2000, pp. 85-111 (ripubblicato in I colori ritrovati. Ilcontributo dell’archeologia alla conoscenza degli elementi di arredo nell’architettura
SAVERIO LOMARTIRE308
Pejrani Baricco alla cultura artistica milanese dell’epoca del vescovoLorenzo I 26. Le indagini hanno poi confermato che la chiesa era instretta connessione con le strutture fortificate del castrum. L’edifi-cio, significativamente a pianta cruciforme, dovette rimanere in fun-zione pressoché inalterato fino alla costruzione dell’edificio romani-co, che ne riprese l’impianto a croce, salvo eventuali interventi diaggiornamento dell’arredo interno tra VIII e IX secolo, sebbene nonrisulti il ritrovamento di frammenti scultorei databili a quell’epoca.È stato anche proposto che in età ottoniana l’edificio sia stato dotatodi un campanile, il quale però poteva anche svolgere funzione di tor-re connessa alla cortina del castrum 27.
Tra IX e XVI secolo è probabile che le funzioni parrocchiali sullago d’Orta siano state svolte dalla chiesa di San Nicolao, sullasponda orientale del lago. Recenti scavi (Fig. 6) hanno permesso diriconoscere sotto le strutture attuali i resti dell’edificio altomedieva-le, presumibilmente databile al IX secolo, ad aula con unica absideforse quadrangolare, la cui forma molto irregolare è stata ricondottaalla natura accidentata del terreno, sebbene, per lo stesso motivo,mi pare che si possa anche pensare ad un’abside semicircolare. Lefondazioni longitudinali all’interno della navata e i due plinti super-stiti hanno fatto pensare alla partizione dell’aula in tre navate 28.
Forti irregolarità sono state anche evidenziate nel tracciato delSan Pietro di Gargallo (Novara), con l’individuazione di strutturegenericamente preromaniche al di sotto della struttura attuale (Fig.7); i resti rinvenuti a seguito di uno scavo parziale non hanno peròpotuto chiarire se la struttura ad aula unica fosse conclusa daun’abside a pianta quadrangolare o semicircolare 29. Una planime-tria ad aula con abside semicircolare non distinta dalle pareti peri-
tra Tarda Antichità e Medioevo, a cura di S. LUSUARDI SIENA e F. SACCHI, Milano, 2004,pp. 117-143, della lastra di Orta si parla alle pp. 122 e 124).
26 PEJRANI BARICCO, Edifici paleocristiani cit. (nota 14), p. 91; sul vescovo milaneseLorenzo I e sulla sua attività di costruttore: LUSUARDI SIENA, Committenza laica ed ec-clesiastica cit. (nota 21), pp. 228-236.
27 PEJRANI BARICCO, Orta S. Giulio cit. (nota 24); EAD., Edifici paleocristiani cit. (no-ta 14), p. 89.
28 L. PEJRANI BARICCO, Orta. Chiesa di San Nicolao, in Quaderni della Soprinten-denza Archeologica del Piemonte, 12 (1994), pp. 319-320.
29 L. PEJRANI BARICCO, Gargallo. Intervento di scavo nella chiesa di San Pietro, inQuaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 13 (1995), pp. 354-355.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 309
metrali è invece stata individuata all’interno dell’oratorio di S. Se-bastiano a Postua (Vercelli) come resto di una fase edilizia prece-dente la ricostruzione romanica 30 (Fig. 8).
La chiesa inferiore di Santa Maria del Piaggio a Villadossola pre-senta un tipo planimetrico non frequente nell’area di cui ci stiamo oc-cupando, presentando un impianto ad aula unica fornito di doppia ab-side, che nella stessa area geografica si associa in un certo senso alloschema a doppia navata del S. Remigio di Pallanza; in assenza tutta-via di dati certi risultanti da indagini e prospezioni mirate, i problemicronologici che riguardano la struttura, espressi dalla letteratura conuna oscillazione tra VIII e XI secolo 31, consigliano cautela nel valutarel’edificio come altomedievale; nell’area di pianura una datazione all’al-tomedioevo è invece stata dimostrata da Paolo Demeglio per la pievedi San Giovanni di Mediliano a Lu Monferrato, in provincia di Ales-sandria 32. La concentrazione di questo tipo planimetrico nella vicinaarea del Cantone Ticino permette certo di istituire confronti; ma pro-prio la comparazione con edifici ticinesi concordemente considerati al-tomedievali, come S. Martino di Mendrisio e S. Pietro di Sureggio, in-dicano per il tipo rappresentato a Villadossola una datazione più tar-da; le modalità di connessione tra le absidi, non ad arco oltrepassato eseparate da una parete poco aggettante rispetto agli esempi altomedie-vali, mostra maggiori affinità ad esempio con la chiesa dei Ss. Ambro-gio e Maurizio di Chironico, concordemente riferita alla fine del X seco-lo o all’inizio dell’XI 33, una datazione questa che si potrà riferire ancheall’esempio di San Remigio di Pallanza, che presenta la variante delladoppia navata 34.
Meglio riferibili a esempi diffusi soprattutto nell’altomedioevosono invece alcuni edifici di Roccapietra, di Cavaglià, di Pombia e,dubitativamente, di Luzzara. Essi sembrano tutti appartenere al ti-
30 G. PANTÒ, Postua. Oratorio di S. Sebastiano, in Quaderni della SoprintendenzaArcheologica del Piemonte, 18 (2001), pp. 137-138.
31 MAZZILLI, Gli edifici di culto cit. (nota 15), pp. 235-238.32 La pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu. Indagini archeologiche (1991-
1998), a cura di P. DEMEGLIO, Roma, 2004.33 Sul problema delle absidi binate: S. GHIGONETTO. Storia dell’architettura medie-
vale. Una tipologia riscoperta: le chiese a doppia-abside (forme e funzioni), Paris,2000; v. inoltre SENNHAUSER, Typen, Formen und Tendenzen cit. (nota 4), pp. 924-930.
34 MAZZILLI, Gli edifici di culto cit. (nota 15), pp. 255-258; M. P. ZOCCHI, Affreschimedioevali: San Remigio di Pallanza, Milano, 1986.
SAVERIO LOMARTIRE310
po planimetrico della sala unica triabsidata, nella quale tre absididi dimensioni quasi uguali, con una eventuale accentuazione dell’ab-side maggiore, si aprono su un unico vano di grande ampiezza 35.Gli studi sulla diffusione del tipo hanno preso in esame un numerocospicuo di testimonianze in area altoadriatica, retica e lombarda,mettendolo anche in relazione con possibili prototipi del vicinoOriente e comunque dell’area mediterranea; il tipo è noto per l’e-sempio monumentale di San Giovanni di Müstair, a San Lucio eSan Martino di Coira e nelle fasi più recenti di Santa Maria e diSan Martino di Disentis, tutti di età carolingia, ma in area più vici-na è rappresentato anche a Pavia in due casi dell’VIII secolo (SanSalvatore, poi San Felice; Santa Maria della Pusterla) e in un casodel X secolo (Santa Maria Gualtieri), e a Milano in un altro esempiodella metà dell’VIII secolo (Santa Maria d’Aurona), ma si ritrovaanche in esempi più tardi 36.
Gli scavi condotti nella chiesa di San Martino nella frazione Roc-capietra a Varallo Sesia (Fig. 9) hanno riportato in luce i resti di unimpianto ad aula unica con abside semicircolare databile al V-VI se-colo, al quale venne presto affiancato un corpo longitudinale; in unafase ulteriore, verosimilmente da collocare nel corso dell’VIII o delIX secolo (anche sulla base del rinvenimento di sepolture adiacentil’edificio) all’abside esistente ne furono affiancate due di ampiezza eprofondità simili. Lo scavo si è limitato alla sola area presbiterialedell’edificio odierno, costruito nel corso del XIV, secolo ma la se-quenza delle tre absidi, tutte obliterate nella fase edilizia più tarda,e i rapporti proporzionali che ancora si osservano nell’edificio attua-le, rendono convincente l’ipotesi di Gabriella Pantò che in questo ca-so possa trattarsi di un impianto altomedievale a sala triabsidata 37.
Nella stessa area geografica sono da tempo noti altri esempi in
35 Per un riesame del problema rimando a: SENNHAUSER, Typen, Formen und Ten-denzen cit. (nota 4), pp. 933-945.
36 S. LOMARTIRE, Riflessioni sulla diffusione del tipo Dreiapsiden-Saalkirche nell’ar-chitettura lombarda dell’altomedioevo. Atti del Convegno internazionale L’edifice deculte entre les périodes paléochretienne et carolingienne (Porec, 17-21 maggio 2002),in Hortus Artium Medieaevalium. Journal of the International Research Center forLate Antique and Middle Ages, 9 (2003), pp. 417-432.
37 G. PANTÒ, Varallo Sesia, fraz. Roccapietra. Chiesa di S. Martino, in Quadernidella Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 11 (1993), pp. 308-309; EAD., Lachiesa di San Martino a Roccapietra. L’indagine archeologica, in Bollettino Storico
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 311
un certo senso riconducibili ad un simile tipo planimetrico: la picco-la chiesa di Santa Maria di Luzzara, nei dintorni di Gozzano (Nova-ra) presenta infatti uno schema di questo tipo, sebbene i risultatidegli scavi condotti da Luisella Pejrani Baricco consiglino di consi-derare l’edificio come di costruzione assai tarda, certamente succes-siva all’XI secolo 38. Riguardo al riconoscimento di un impianto pla-nimetrico simile nella Santa Maria di Armeno (NO), mi pare chenon vi siano elementi determinanti; l’edificio del XII secolo fu am-pliato alla metà del XIX secolo con l’aggiunta di un nuovo capocroceche cancellò la originaria terminazione a tre absidi, che tuttavia po-trebbero verosimilmente considerarsi omogenee all’impianto romani-co a tre navate senza transetto.
Un impianto triabsidato su unica sala è invece percepibile conmaggiore sicurezza nei pur scarni resti dell’assetto originario dellachiesa di San Michele di Cavaglià (Biella), dove gli scavi diretti daGabriella Pantò nel 1992 all’esterno dell’area orientale della chiesaattuale, costruita nel XVII secolo, hanno evidenziato i resti dell’edi-ficio costruito nel XV secolo e quelli della struttura più antica, rap-presentati da una serie di tre absidi di uguali proporzioni e da trattidi muratura relativi ad un’aula di circa dodici metri di larghezza(Fig. 10). La situazione dei resti potrebbe lasciare alcuni margini diincertezza relativamente allo sviluppo in profondità delle absidi, icui muri di innesto appaiono tagliati dai plinti di fondazione dell’e-dificio quattrocentesco e appoggiati ad una struttura che attraversale absidi meridionale e centrale, interpretato come muro di catenadelle absidi stesse. Non vi è dubbio però, occorre ripetere, che loschema dell’aula triabsidata trovi qui uno dei suoi esempi più plau-sibili nell’area che stiamo esaminando, la cui datazione si è propostoche possa ascriversi ai secoli VIII-IX 39. Ulteriori elementi di rifles-sione potranno però certo giungere dallo scavo in corso, sempre a
Vercellese, 42 (1994), pp. 27-52; EAD., Chiese rurali della diocesi di Vercelli, in Chiesee insediamenti cit. (nota 5), pp. 87-107 (97).
38 M. DI GIOVANNI, Gli edifici di culto dell’XI e XII secolo. La collina, il Cusio e ilmedio Verbano, in Novara e la sua terra cit. (nota 13), pp. 142-230 (197-198); L. PE-JRANI BARICCO, Gozzano (NO). Chiesa di Santa Maria di Luzzara, in Quaderni dellaSoprintendenza Archeologica del Piemonte, 5 (1986), pp. 214-214.
39 G. PANTÒ, San Michele di Cavaglià: una chiesa ritrovata, in Quaderni della So-printendenza Archeologica del Piemonte, 12 (1994), pp. 243-253.
SAVERIO LOMARTIRE312
Cavaglià, nell’area del Castello, dove sono state rinvenute estesetracce del cestello ascrivibile al conte Aimone di Vercelli, che nel963 è investito da Ottone I della curtis di Cavaglià. La costruzionedella poderosa struttura in un’area altrimenti priva di preesistenzeabitative ed edilizie significative, ma posta a presidio della confluen-za della Valle d’Aosta nella pianura, avrà peraltro ben presto unimpatto decisivo sul territorio, determinando uno slittamento a norddel lago di Viverone dell’asse viario antico da Ivrea verso la pianu-ra, che invece passava a sud del lago e costituendo il nuovo traccia-to di quella che sarà la via Francigena 40.
Con queste premesse credo che sarebbe allora possibile formula-re una proposta di datazione più tarda per l’impianto triabsidato diCavaglià e riferirlo ad un intervento, forse anche sollecitato dal con-te Aimone, della seconda metà del X secolo; una datazione attardatache peraltro è compatibile con altri confronti, e in particolare la pri-ma chiesa di Santa Maria detta “Gualtieri” di Pavia, fondata neglianni ’70 del X secolo da Waltarius giudice del Sacro Palazzo 41.
L’area geografica in questione presenta dunque, pur tenendoconto dei problemi interpretativi, alcune significative testimonianzedel tipo planimetrico a sala triabsidata; vorrei solo ricordare a que-sto proposito che un altro esempio è costituito dal San Giorgio diPombia, un edificio ormai in rovina nel quale si conservano ancoralabili tracce di decorazione pittorica e che non è ancora stato oggettodi indagini archeologiche, ma nel quale l’applicazione di questo par-ticolare schema planimetrico ad una data anche piuttosto alta, forsetra VII e IX secolo, deve correlarsi con l’importanza di Pombia, laFlavia Plumbia sede comitale in età longobarda e carolingia 42.
A Ivrea le indagini archeologiche compiute di recente nella catte-drale, hanno esplorato parzialmente il sito dell’antica cattedrale delV o VI secolo e si sono concentrate invece sull’area della cripta e delsoprastante deambulatorio a occidente del corpo basilicale, (Fig. 11),
40 Ringrazio la dott.ssa Lorenza Boni, che sta conducendo le indagini con la super-visione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, per avermi cortesementefatto partecipe dei primi, pur provvisori, risultati delle indagini in atto.
41 S. LOMARTIRE, L’edificio e la sua decorazione, in La chiesa di S. Maria Gualtieriin Pavia. Indagini, analisi e metodologie di restauro, Como, 1991, pp. 81-90; ID., Ri-flessioni sulla diffusione del tipo Dreiapsiden-Saalkirche cit. (nota 36), p. 428.
42 DI GIOVANNI, Gli edifici di culto cit. (nota 38), pp. 176-177.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 313
riconoscendo in esso con ogni verosimiglianza un’aggiunta al prece-dente edificio promossa alla fine del X secolo dal vescovo Warmondoe ricordata da una celebre iscrizione monumentale; al tempo stessoLuisella Pejrani Baricco ha avanzato la proposta di riconoscere inquesta zona non la terminazione absidale dell’edificio ma una sortadi avancorpo, di atrio a due piani, fiancheggiato da due campanili,che aveva la funzione di consentire la deambulazione dei fedeli at-torno al sarcofago antico contenente le reliquie dei Santi Tegolo eBesso 43. La questione potrebbe essere chiarita estendendo le indagi-ni al corpo basilicale e all’area antistante l’attuale facciata, sotto laquale potrebbe trovarsi l’antica terminazione absidale, mentre moltoresta ancora da fare per rintracciare i resti del corpo delle navate edella terminazione orientale dell’edificio, oltre che del battistero. Maintanto va registrato che anche in questo caso prima delle trasfor-mazioni warmondiane, probabilmente nella seconda metà del IX se-colo, l’antica cattedrale era stata oggetto di rinnovamenti dell’arredoliturgico: la documentazione settecentesca dell’archivio capitolare hainfatti restituito il rilievo di due plutei con relativi pilastrini nel“sacellum beati Teguli”, cioè nella cripta (Fig. 12) 44.
Nel Canavese, in direzione della Valle d’Aosta, il complesso bat-tesimale di Settimo Vittone merita qui almeno un richiamo, se nonproprio per pertinenza al territorio alpino in senso ampio, almenoper la particolarità della pianta cruciforme (Fig. 13), che non risultadiffusa in quest’area geografica; la datazione al IX secolo, più volteribadita, rimane probabile, sebbene restino da compiere indagini piùparticolareggiate 45.
43 L. PEJRANI BARICCO, La crypte occidentale de la cathédrale d’Ivrée, in Avant-nefset espaces d’accueil dans l’église entre le IVe et le XIIe siècle. Atti del convegno inter-nazionale (Auxerre, Abbaye Saint-Germain, 17-20 giugno 1999), a cura di CH. SAPIN,Paris, 2002, pp. 386-395.
44 C. MARITANO, Warmondo d’Ivrea vescovo e committente, in Bollettino Storico-Bi-bliografico Subalpino, XCVIII (2000), pp. 77-104 (97-98); A. CROSETTO, Una traccia: laproduzione scultorea della piena età Carolingia in Piemonte, in Alle origini del roma-nico. Atti delle III Giornate di studi medievali (Castiglione delle Stiviere, 25-27 set-tembre 2003), a cura di R. SALVARANI, G. ANDENNA, G. P. BROGIOLO, Brescia, 2005, pp.165-188 (177).
45 VERZONE, L’architettura cit. (nota 1), pp. pp. 131-133; G. PANTÒ, Settimo Vittone(Torino). Pieve di San Lorenzo e battistero. Atti del V congresso nazionale di archeo-logia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29
SAVERIO LOMARTIRE314
Nella Valle d’Aosta la conoscenza delle architetture tardoantiche ealtomedievali ha registrato un notevole progresso in anni recenti. Apartire dagli scavi condotti a partire dal 1972 da Charles Bonnet e Re-nato Perinetti alla Cattedrale, a San Lorenzo, a Santo Stefano, a San-t’Orso di Aosta, l’indagine ha progressivamente coinvolto altri edificidella valle: a Villeneuve, Morgex e Courmayeur.
Per la Cattedrale aostana i dati disponibili sono ancora da inter-pretare compiutamente (Fig. 14), ma indicano con sufficiente chia-rezza i dati relativi alle fasi dell’edificio relative all’XI secolo, checonfigurano una basilica ad absidi contrapposte; inoltre gli scavihanno messo in luce estesi resti della cattedrale paleocristiana, in-stallata su un complesso residenziale di fine IV secolo con tre fasitra la fine del IV e il VI secolo, durante le quali vengono anche col-locati e poi modificati due fonti battesimali 46. Per l’altomedioevo èstato rilevato il solo rifacimento del recinto presbiteriale, del qualerimangono scarsi resti scultorei (Fig. 15), oltre che interventi minorinella zona della vasca battesimale nel vano nord dell’edificio, a se-gnale di una situazione che deve essere stata piuttosto diffusa, quel-la cioè della permanenza in uso per lungo tempo di strutture anti-che le quali vengono di volta in volta aggiornate ad esigenze liturgi-che, o anche solo estetiche, attraverso la riconfigurazione dell’arredoo l’aggiunta di una nuova veste decorativa, ad esempio di ciclipittorici.
Caso diverso è la chiesa di S. Lorenzo; edificato nel V secolo inun’area funeraria a est della città, l’edificio venne strutturato conimpianto cruciforme affine a quello della ambrosiana Basilica Apo-stolorum milanese e ricevette al suo interno sepolture importanti(Fig. 16). L’edificio subì nel corso del medioevo una progressiva ri-duzione strutturale a favore della vicina chiesa di Sant’Orso; nella
settembre 1979), Roma, 1982, pp. 157-161; sulle piante cruciformi: SENNHAUSER,Typen, Formen und Tendenzen cit. (nota 4), pp. 951-955.
46 CH. BONNET, R. PERINETTI, Aosta. I primi monumenti cristiani, Quart (Aosta),1986, pp. 13-32; R. PERINETTI, La cattedrale medievale di Aosta, in Medioevo Aostano.La pittura intorno all’anno Mille in Cattedrale e in Sant’Orso. Atti del Convegno in-ternazionale (Aosta, 15-16 maggio 1992), Torino, 2000, pp. 31-46; R. PERINETTI, Valled’Aosta - Le chiese altomedievali, in Alle origini del romanico. Atti delle III Giornatedi studi medievali (Castiglione delle Stiviere, 25-27 settembre 2003), a cura di R.SALVARANI, G. ANDENNA, G. P. BROGIOLO, Brescia, 2005, pp. 149-164 (151-152).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 315
fase altomedievale, databile verosimilmente nel IX secolo in conse-guenza di un incendio che dovette gravemente danneggiare la strut-tura antica nella seconda metà dell’VIII secolo, verrà mantenuta inessere solo l’abside orientale, di profilo circolare all’interno e poligo-nale all’esterno, quale terminazione di una piccola aula dotata di unbreve avancorpo, allungata in seguito in età romanica e poi oblitera-ta dalla struttura gotica attuale con orientamento opposto 47.
La chiesa di Sant’Orso dovette costituire insieme a San Lorenzo uneccezionale complesso monumentale tra V e VIII secolo. Come San Lo-renzo, anche S. Orso fu oggetto di una pressoché totale ricostruzionenel IX secolo (Fig. 17) 48. L’asse dell’edificio del V secolo, al quale in etàaltomedievale era stato aggiunto un portico su tre lati, venne infinetraslato verso sud con la creazione di un edificio triabsidato e moltoprobabilmente diviso in tre navate, sebbene non siano stati rinvenutiresti dei pilastri interni; questa struttura verso la fine del X secolovenne dotata di un avancorpo a ovest conformato a tour-porche; la da-tazione dendrocronologica di un trave ligneo indica infatti l’anno 989.Nel IX secolo l’area presbiteriale venne dotata di una recinzione in plu-tei e pilastrini di cui restano frammenti e che doveva sostituire quellaprecedente (Fig. 18).
Sul lato nord della città gli scavi avviati nel 2000 all’interno dellachiesa di Santo Stefano 49 hanno portato al rinvenimento di resti di unedificio tardoantico presto dotato di funzioni funerarie e in seguito, nel
47 CH. BONNET, L’Église cruciforme de Saint-Laurent d’Aoste. Rapport préliminaireaprès les fouilles de 1972 à 1979. Atti del V congresso nazionale di archeologia cri-stiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29 settem-bre 1979), Roma, 1982, pp. 271-317; R. PERINETTI, La chiesa di San Lorenzo ad Aosta.Appunti per una tipologia delle tombe, ibid., pp. 297-317; BONNET, PERINETTI, Aosta cit.(nota 46), pp. 35-44; PERINETTI, Valle d’Aosta cit. (nota 46), pp. 152-153.
48 CH. BONNET, R. PERINETTI, La Collegiata di Sant’Orso dalle origini al XIII secolo,in Sant’Orso di Aosta. Il complesso monumentale, a cura di B. ORLANDONI e E. ROSSETTI
BREZZI, Aosta, 2001, pp. 9-36; PERINETTI, Valle d’Aosta cit. (nota 46), pp. 153-155.49 CH. BONNET, R. PERINETTI, Deux nouvelles églises paléochrétiennes de la Vallée
d’Aoste, in Rivista di Archeologia Cristiana, LXXX (2004), pp. 159-194 (162-180); PE-RINETTI, Valle d’Aosta cit. (nota 46), pp. 155-156; sulle basiliche a deambulatorio, conriferimento anche agli esempi valdostani e piemontesi, vedi da ultimo: G. CANTINO
WATAGHIN, Le basiliche di Monastero e di Beligna: forme e funzioni, in Aquileia dalleorigini alla costituzione del ducato longobardo. L’arte ad Aquileia dal sec. IV al IX.Atti della XXXVI Settimana di studi aquileiesi (Aquileia, 18-21 maggio 2005), a curadi G. CUSCITO, Trieste, 2006 (“Antichità Altoadriatiche”, LXII), pp. 303-333.
SAVERIO LOMARTIRE316
V secolo, adibito a edificio di culto dapprima con la costruzione diun’ampia abside a profilo semicircolare oltrepassato entro la quale benpresto verrà costruita una seconda abside più piccola, con la costituzio-ne di un deambulatorio destinato a ricevere sepolture privilegiate; aquesto deambulatorio si accedeva per mezzo di passaggi ai lati del co-ro. Tra VII e VIII il deambulatorio venne sopraelevato per la colloca-zione di altre sepolture; fu inoltre aggiunto un annesso sul fianco nord.In epoca carolingia, pur rimanendo sostanzialmente invariate le strut-ture perimetrali, l’aula fu fortemente ridotta in lunghezza e dotata dipilastri che la suddividono in tre navate; all’esterno è probabile che siastato aggiunto un nartece (Fig. 19).
La vicenda del S. Stefano di Aosta così come è stata verificata daBonnet e Perinetti – che, sia detto per inciso, mi pare possegga al-cuni elementi in comune, a parte una diversa organizzazione del-l’impianto perimetrale, con quella della chiesa veronese pure intito-lata a Santo Stefano sulla quale a suo tempo ha compiuto interes-santi valutazioni Paolo Verzone (il quale però non poteva conoscerel’esempio aostano) 50 – è stata ricondotta ad un tipo planimetricoparticolare, che trova un confronto significativo proprio sul versanteopposto del Gran San Bernardo, a Sion, nella chiesa di Notre-Dame-sous-le-Scex, scavata in anni recenti da Alessandra Antonini 51. Mavorrei qui solo rapidamente porre la questione se la situazione veri-ficata recentemente con gli scavi nel San Vittore di Sizzano e nelSan Lorenzo di Gozzano, entrambe nella pianura novarese, non siariconducibile ad un simile tipo planimetrico 52.
Un altro esempio di tale tipo è stato individuato ancora nella Valled’Aosta, nella chiesa di Santa Maria a Morgex, dove ad un primo edifi-cio a impianto rettangolare dell’inizio del V secolo vennero aggiunti
50 VERZONE, L’architettura religiosa cit. (nota 1), pp. 20-24, 137-145; v. anche G. VA-LENZANO, Il problema del doppio ambulacro di Santo Stefano a Verona, in Medioevo:arte lombarda. Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 26-29 settembre2001), a cura di A. C. QUINTAVALLE, Milano, 2004, pp. 240-246.
51 A. ANTONINI, Sion. Sous-le-Scex (VS). I. Ein spatäntik-frühmittelalterliches Be-stattungspaltz: Gräber und Bauten, Lausanne, 2002 (Cahiers d’Archéologie romande,89 / Archeologia Vallesiana 1); BONNET, PERINETTI, Deux nouvelles églises cit. (nota 49),p. 178; SENNHAUSER, Typen, Formen und Tendenzen cit. (nota 4), p. 958-959.
52 PEJRANI BARICCO, Chiese rurali in Piemonte cit. (nota 14), pp. 63-70 (S. Vittore diSizzano), 72-73 (S. Lorenzo di Gozzano); inoltre, per S. Lorenzo di Gozzano: PEJRANI
BARICCO, Edifici paleocristiani cit. (nota 14), pp. 94-96.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 317
un’abside e annessi laterali, uno dei quali ospitava un fonte battesima-le; nel corso del VI secolo fu riformata l’area presbiteriale, delimitatada setti divisori, e modificato il perimetro dell’abside, che assunse pro-filo ad arco oltrepassato; entro la nuova abside restano tracce di unaseconda più piccola struttura semicircolare che fa pensare anche quialla formazione di un vano anulare per sepolture privilegiate, come ne-gli esempi di S. Stefano di Aosta e di Sion appena visti. In età carolin-gia (Fig. 20) questo impianto fu sostituito da una semplice abside se-micircolare poco sopraelevata alla quale si accedeva tramite gradini,mentre l’area presbiteriale venne ampliata attraverso la costruzione diuna recinzione in muratura; in posizione centrale nell’aula è stata an-che rinvenuta una fossa di fusione per campane anch’essa datata adetà carolingia 53. In epoca romanica la struttura fu poi ricostruita conun impianto a tre navate, una successiva ricostruzione si ebbe ancoranel XV secolo 54.
La chiesa di Santa Maria Assunta a Villeneuve (Aosta) 55 pre-senta una situazione differente (Fig. 21), dal momento gli scavi, ini-ziati nel 1982, hanno appurato che il complesso paleocristiano si eravenuto formando nel V secolo tramite l’aggregazione ad un’aula ret-tangolare di una struttura ad aula absidata; i due edifici erano staticollegati successivamente, ma sempre entro lo stesso secolo, da unvano di pianta irregolare adibito a battistero con vasca a perimetroottagonale. Della fase altomedievale si possono solo leggere alcunetracce marginali quasi del tutto obliterate dalle fondazioni dell’edifi-cio romanico attuale; si tratta di resti delle fondazioni di tre absidiche Renato Perinetti ha ipotizzato potessero innestarsi su un’unicaampia aula, costituendo in tal modo un ulteriore esempio del tipoDreiapsiden Saalkirche.
L’ultimo esempio che possiamo brevemente citare della Valle
53 R. PERINETTI, M. CORTELAZZO, La fusione e la produzione di campane in Val d’Ao-sta tra IX e XVII sec., in Del fondere campane. Dall’archeologia alla produzione. Qua-dri regionali per l’Italia settentrionale. Atti del Convegno (Milano, 23-25 febbraio2006) [in corso di stampa].
54 BONNET, PERINETTI, Deux nouvelles églises cit. (nota 49), pp. 180-194; PERINETTI,Valle d’Aosta cit. (nota 46), pp. 157-158. V. inoltre: CANTINO WATAGHIN, Le basiliche cit.(nota 49).
55 R. PERINETTI, Chiesa di S. Maria di Villeneuve, in Bollettino dell’Accademia diSant’Anselmo, I N.S. (1985), pp. 160-174; ID., Valle d’Aosta cit. (nota 46), pp. 156-157.
SAVERIO LOMARTIRE318
d’Aosta è il San Pantaleone di Courmayeur, la cui fase più antica,per la quale è stata proposta una datazione agli inizi dell’XI seco-lo 56, è costituita da un impianto a nave unica con abside semicirco-lare, che segnalo, nonostante appaia eccedere i limiti cronologici del-la presente trattazione, unicamente per la peculiarità dei rapportiproporzionali, che configurano un’aula molto allungata, del tipo chesi ritrova nei vani aggregati ad aule di maggiori dimensioni, comenel caso degli annessi di San Giovanni di Müstair 57, sebbene nelSan Pantaleone per questa fase non siano state rinvenute tracce diedifici adiacenti; tale proporzione, con misure maggiori, sarà peral-tro riproposta nelle successive ricostruzioni dell’edificio (XII e XVsecolo).
Lungo la direttrice che da Torino conduceva alle Gallie attraver-so il Monginevro la chiesa di San Massimo di Collegno ad QuintumLapidem, che non includo – e forse a torto, si potrà obiettare – nellapresente ricognizione, rappresenta una testimonianza importante distruttura architettonica che conserva per secoli il suo aspetto origi-nario, alla quale si associa, a differenza della quasi totalità degliedifici sin qui esaminati, la sopravvivenza di un numero non esiguodi reperti scultorei piuttosto facilmente databili tra VIII e IX secolo,studiati da Silvana Casartelli e quindi parzialmente ripresi da Al-berto Crosetto, che forniscono, oltre che un saggio dell’alto livelloqualitativo delle officine scultoree locali, un appiglio per la ricostru-zione della fase altomedievale dell’edificio, nella quale l’impianto pa-leocristiano venne aggiornato solo tramite un nuovo e ricco arredoliturgico, come d’altra parte deve essere accaduto in molti altri casi,come peraltro in alcuni degli esempi già citati 58.
56 M. C. RONC, Lo scavo archeologico: una storia di “lesioni”, in N. DUFOUR, L. PIZZI,M. C. RONC, La chiesa San Pantaleone di Courmayeur: indagini, progetti, interventi,in Bollettino della Soprintendenza per i Beni Culturali della Valle d’Aosta, 1(2003/2004), pp. 102-109 (102-105).
57 SENNHAUSER, Typen, Formen und Tendenzen cit. (nota 4), pp. 930-933, 957-961.58 S. CASARTELLI NOVELLI, Corpus della scultura altomedievale. VI. La Diocesi di To-
rino, Spoleto, 1974, pp. 89-130 (nn. 27-65); Collegno, compresa mostra Longobardi etesto A. CROSETTO La chiesa di S. Massimo “ad quintum”: fasi paleocristiane e altome-dievali, in Presenze longobarde. Collegno nell’alto medioevo. Catalogo della Mostra, acura di L. PEJRANI BARICCO, Torino, 2004, pp. 249-270 (261-266); ID., La chiesa “SanctiMaximi ad quintum” di Collegno, in Chiese e insediamenti cit. (nota 5), pp. 119-130;ID., Una traccia: la produzione scultorea cit. (nota 44), pp. 171-172.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 319
Nell’intera area della Valle di Susa le testimonianze di architetturaaltomedievale non risultano al momento numerose. Pressoché nulla sisa di strutture materiali certamente riconducibili all’Ospitium delMoncenisio per la cui costruzione l’imperatore Ludovico il Pio avevaespropriato beni dell’abbazia della Novalesa 59. Se il San Saturnino diSusa pare essere un edificio romanico innestato direttamente su unedificio votivo pagano 60, gli scavi condotti nella cappella di San Nicolanella frazione di Jovenceaux di Sauze d’Oulx, hanno dimostrato che l’e-dificio religioso fu tardivamente impiantato su un nucleo edilizio alto-medievale, ma di uso civile abitativo: ciò che comunque costituisce diper sé un elemento significativo quanto raro tra le testimonianze che cisono pervenute 61.
Preesistenze altomedievali non sono emerse dagli scavi e dalleindagini recentemente condotti nella cattedrale di Susa, così che èstato possibile corroborare le informazioni trasmesse dalle fonti cir-ca la fondazione ab imo dell’edificio, ancor oggi ben conservato nellastruttura complessiva al di sotto delle intonacature più tarde, daparte del marchese di Torino Olderico Manfredi nel 1027 62.
Certamente l’emergenza monumentale di maggiore rilevanza peril periodo che qui esaminiamo è rappresentata dal monastero deiSS. Pietro e Andrea della Novalesa nella Val Cenischia (Fig. 22).Tra gli edifici che consideriamo esso è uno dei meglio conosciuti, so-prattutto grazie una meticolosa campagna di scavi iniziati e condot-ti da Gisella Cantino Wataghin a partire dal 1978. Fatalmente è an-che il complesso architettonico che corrisponde più fedelmente al te-ma del presente convegno, in ragione dei sicuri riferimenti cronolo-gici, che lo testimoniano esistente e pienamente in funzione al tem-po in cui Carlo Magno attraversò le Alpi valicando il Monginevro.
59 G. SERGI, “Domus Montis Cenisii”. Lo sviluppo di un ente ospedaliero in unacompetizione di potere, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, LXX (1972), pp.435-488 (441-443).
60 Vedi sopra, nota 12.61 L. PEJRANI BARICCO, F. BOSMAN, Sauze d’Oulx, fraz. Jovenceaux. Indagine nella
cappella di S. Antonio Abate, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Pie-monte, 18 (2001), pp. 110-111.
62 La Basilica di San Giusto. La memoria millenaria della Cattedrale segusina.Atti del Convegno (Susa, 21 ottobre 2000), Bussoleno, 2002; L. PEJRANI BARICCO, Docu-menti di archeologia in Valle di Susa tra VI e XI secolo, in Valle di Susa. Tesori d’ar-te, Torino, 2005, pp. 71-82 (80-81).
SAVERIO LOMARTIRE320
La serie di interventi analitici sul complesso, pubblicati di paripasso con il procedere delle indagini, è assai ricca e articolata, ecomprende contributi anche molto recenti, per cui si può dire che levicende, anche edilizie e decorative del monastero, anche nelle suefasi medievali, siano in gran parte chiarite 63. Qui ricorderò solo chesussistono i documenti di fondazione e di dotazione del monastero,oltre al cartario e al Chronicon Novaliciense, la maggiore fonte perla storia del cenobio 64; il Chronicon, redatto verso la metà dell’XIsecolo, riporta dati significativi dai quali si sono potute dedurre in-formazioni che hanno aiutato anche la comprensione di alcuni tra iprincipali interventi architettonici del monastero. Fondatore ne funel 726 il patricius Abbone, alto funzionario del regno franco e rec-tor di Susa e di Moriana, che con il suo testamento del 739 lasciò alcenobio tutte le sue proprietà, distribuite in Provenza e anche inItalia, avviando la fortuna economica e politica del monastero: unafortuna che si consolidò ben presto 65, con i benefici concessi da Car-lo Martello nel 763, e poi in età carolingia per motivi ben compren-sibili, legati al suo ruolo di presidio sulla passo del Moncenisio. Giànella seconda metà del secolo il cenobio poteva ben dirsi, di fatto edi diritto, di patrocinio regio. La comunità ebbe vita fiorente fino alprimo ventennio del X secolo, quando a causa delle frequenti incur-sioni saracene (ma in realtà di predoni non necessariamente orien-tali, come ha indicato Aldo Settia 66) la comunità abbandonò il ceno-
63 Per un aggiornamento sullo stato degli studi e la disamina della ricca bibliogra-fia rinvio al volume: Novalesa: nuove luci dall’Abbazia, a cura di M. G. CERRI, Milano,2004, e in particolare ai saggi di G. SERGI, Novalesa fra storia e storiografia, ibid., pp.21-34; G. CANTINO WATAGHIN, L’abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa: il con-tributo delle indagini archeologiche al recupero della sua memoria, ibid., pp. 35-59,cui si rimanda anche per l’ampia bibliografia precedente.
64 C. CIPOLLA, Monumenta Novalicensia Vetustiora, I-II, Roma, 1898 (Fonti per laStoria d’Italia, XXXI-XXXII); Chronicon Novaliciense, ed. a cura di G. C. ALESSIO, To-rino, 1981. Circa i problemi interpretativi del Chronicon si veda però: P. J. GEARY,Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millen-nium, Princeton, 1994.
65 Rinvio alla lezione di G. ALBERTONI, La politica alpina dei Carolingi, in questiAtti.
66 A. A. SETTIA, Monasteri subalpini e presenza saracena, in Nel millenario di SanMichele della Chiusa. Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella societàmedievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985),Torino, 1988, pp. 293-310 (302).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 321
bio per trasferirsi con il tesoro e la biblioteca dapprima a Torino epoi a Breme, in Lomellina, dove venne fondata l’abbazia di San Pie-tro, che oggi attende anch’essa di essere indagata attraverso unacampagna di scavi come quella che ha interessato l’antica casamadre.
La comunità fece ritorno alla Novalesa verso la fine del X secolo,per costituire un priorato dipendente da Breme. In quella occasione,su impulso dell’abate Bruningo, si provvide gradualmente alla risi-stemazione del complesso cenobitico; una risistemazione attuata at-traverso la ricostruzione della chiesa abbaziale e interventi di ripa-razione e ammodernamento di strutture altomedievali che sono an-cor oggi conservate in misura rilevante.
Gli interventi che interessano nella presente occasione sono per-tanto tutti da riconoscere nelle fasi iniziali del complesso monastico,che oltre alla chiesa e agli edifici abbaziali comprendeva anche ungruppo di cappelle esterne, attualmente quattro, tutte in qualchemodo già esistenti nella fase altomedievale, oggetto forse di percorsirituali, ma certo anche adibite in vario modo ad uso funerario. Lestrutture sono rimaste in diverso grado riconoscibili, tranne la chie-sa abbaziale, totalmente trasformata agli inizi del XVIII secolo dainterventi che hanno inglobato le strutture della chiesa dell’XI seco-lo. Le indagini hanno inizialmente riguardato proprio la chiesa e poigli edifici monastici (Fig. 23). Gli scavi hanno potuto individuarechiaramente due fasi precedenti l’abbandono del X secolo e poi in-terventi relativi alle risistemazioni databili alla fine dello stesso se-colo e al secolo seguente 67.
67 Nel rinviare alla sintesi di CANTINO WATAGHIN, L’abbazia cit. (nota 63), ricordo,anche ai fini di un confronto dei dati, la serie articolata di interventi sulla fase ini-ziale delle indagini archeologiche al complesso monastico prodotto nel 1979 per il VCongresso nazionale di Archeologia Cristiana: G. WATAGHIN CANTINO, Seconda campa-gna di scavo nella chiesa dei SS. Pietro e Andrea dell’abbazia della Novalesa. Rap-porto preliminare. Le fasi preromaniche. Atti del V congresso nazionale di archeolo-gia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29settembre 1979), Roma, 1982, pp. 89-100; E. MICHELETTO, Le cappelle dell’abbazia del-la Novalesa. Architettura e sistema distributivo, ibid., pp. 103-112; A. CROSETTO, Abba-zia della Novalesa. La cappella di Sant’Eldrado, ibid., pp. 115-122; v. inoltre G. CAN-TINO WATAGHIN, “In loco nunccopante Novelicis”: la Novalesa dall’età romana alla fon-dazione di Abbone, in Novalesa una storia tra fede e arte. Atti del Convegno (Novale-sa, 1999), Beinasco ,2000, pp. 11-31; EAD., Strade cit. (nota 11), Scheda II.4. Novale-
SAVERIO LOMARTIRE322
Emerge chiaramente dal contesto il perimetro della chiesa più anti-ca, che doveva essere già in buono stato di avanzamento nel 739, dalmomento che nel testamento di Abbone, che troverà poi verosimilmen-te sepoltura in corrispondenza del perimetrale sud dell’abbaziale, lachiesa è detta “usque ad culminis consummationis” 68.
L’abbaziale (Fig. 24) aveva impianto a sala unica dotato di uncoro quadrangolare dalla forma irregolare; alcuni vani si addossava-no sui fianchi nord e sud, fra i quali, a nord del coro, una cappellaprobabilmente adibita a repositorio di reliquie. Un’altra struttura sitrovava a occidente in prossimità della facciata, apparentemente aformare una sorta di avancorpo, il cui asse era però fortemente ruo-tato rispetto a quello della chiesa, la quale di per sé venne orientatain modo canonico. Ci si può giustamente interrogare sulla funzionedi questa struttura il cui disassamento, che pare corrispondere aquello del percorso viario esterno, non presenta in sé particolari pro-blemi interpretativi, se si pensa che lo scavo nell’area degli edificimonastici ha messo in evidenza diversi di corpi di fabbrica varia-mente orientati 69, tutti riferibili alla prima fase edilizia, la qualeperaltro potrebbe forse spiegarsi con la eventuale sopravvivenza, al-meno a livello planimetrico, di strutture o percorsi più antichi: adesempio, come ha proposto Gisella Cantino, eventuali strutture dariferire ad una statio della via del Moncenisio 70; ad una simile eve-nienza farebbero riferimento i ritrovamenti di materiali frammenta-ri lapidei o ceramici di età romana nell’area del monastero 71. Allostesso modo mi pare che resti il quesito circa l’identificazione dellastruttura edilizia ad occidente della chiesa come avancorpo addossa-to o come parete o struttura che piuttosto delimitava il sagrato, purcon un andamento irregolare rispetto all’asse della chiesa.
Ad ogni modo, questa dislocazione apparentemente disordinatapuò costituire la testimonianza del fatto, accertata dai documenti
sa, pp. 64-65; inoltre, S. SAVI, Architettura preromanica e romanica a Novalesa, “Se-gusium”, X (1973), pp. 80-103.
68 CANTINO WATAGHIN, L’abbazia cit. (nota 63), pp. 35, 40.69 Ibid., pp. 46-47.70 Ibid., p. 55.71 G. CANTINO WATAGHIN, Monasteri in Piemonte dalla tarda antichità al medioevo,
in Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, a cura di L. MERCANDO e E. MICHELETTO, Tori-no, 1998, pp. 161-185 (177); EAD., “In loco nunccopante Novelicis” cit. (nota 67).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 323
coevi, che la comunità monastica si fosse installata in un periodoprecedente la fondazione ufficiale del 726 72.
In epoca carolingia si attua una più razionale regolarizzazione e re-distribuzione degli spazi claustrali e di servizio adeguandone l’orienta-mento a quello della chiesa, la quale per converso fu oggetto interventidi portata alquanto minore: il coro venne rimodellato su un perimetrocurvilineo con il riutilizzo sostanziale delle pareti laterali del coro qua-drato e lo sfondamento della parete orientale; probabilmente questaoperazione era collegata a qualche altro intervento finalizzato a monu-mentalizzare l’area del coro. Parallelamente, diversi elementi indicanoche dovette essere allestito un avancorpo addossato alla facciata origi-naria a formare una struttura forse in qualche modo paragonabile adun Westwerk. L’edificio dovette inoltre ricevere sepolture privilegiate,delle quali restano numerose evidenze all’interno del corpo occidentale,anche se non è possibile confermare la notizia riportata dal ChroniconNovaliciense secondo il quale nel IX secolo nell’abbaziale sarebbero sta-ti sepolti i vescovi di Moriana 73. In questa fase dovette essere ancheattuata la riforma dell’arredo liturgico a costituire il segnale più tangi-bile del rinnovamento dell’abbaziale, certo anche con il complemento dipitture murali che si aggiungevano alle precedenti o le sostituivano; èstato in ogni caso osservato che i numerosissimi frammenti di intonacidipinti ritrovati negli scavi e in parte ancora aderenti a resti delle mu-rature altomedievali segnalano un ambiente decorato con una certa so-brietà, con elementi decorativi principalmente in rosso su intonacochiaro 74.
Dei diversi allestimenti degli arredi liturgici della chiesa abbazialefa fede una serie di circa settanta frammenti scolpiti, rinvenuti a varieriprese anche negli scavi e di recente studiati da Sofia Uggé 75. L’insie-me si presta ad una suddivisione in gruppi scalabili cronologicamente
72 CANTINO WATAGHIN, L’abbazia cit. (nota 63), p. 55.73 Ibid., p. 40; sulle sepolture altomedievali nel complesso novaliciense; R. GRILLET-
TO, G. LAMBERT, Le sepolture e il cimitero della chiesa abbaziale della Novalesa, in Ar-cheologia medievale, XVI (1989), pp. 329-356.
74 G. CANTINO WATAGHIN, M. COLONNA DURANDO, Classement et étude des fragmentsd’enduit peints trouvés en fouille à l’abbaye de Novalèse (Italie), in Edifices et peintu-res aux IVe-XIe siècles. Actes du colloque C.N.R.S. (Auxerre, 7-8 novembre 1992), dir.DE C. SAPIN, Auxerre, 1994, pp. 134-153.
75 S. UGGÉ, I reperti scultorei di epoca altomedievale, in Novalesa: nuove luci cit.(nota 63), pp. 59-71.
SAVERIO LOMARTIRE324
con buona approssimazione — pur tenendo conto della labilità di seria-zioni basate su criteri stilistici o morfologici — tra la prima metà del-l’VIII e il IX secolo, fornendo in tal modo una migliore percezione delletrasformazioni cui fu sottoposta la chiesa abbaziale. Alla fase più anti-ca dovrebbero appartenere tanto frammenti con motivi comuni allacultura figurativa merovingia, come il resto di una lastra con croci in-castrate (Fig. 25), quanto frammenti più comuni al repertorio dell’Ita-lia longobarda (Fig. 26). Il ritrovamento di tre piccoli frammenti sculto-rei (due dalla cappella esterna di S. Maria e uno dal chiostro; Fig. 27)appartenenti ad una transenna lavorata sulle due facce verosimilmen-te un tempo pertinenti all’arredo della chiesa abbaziale dell’VIII secolo,ha poi permesso un confronto diretto con due analoghi pezzi conservatial Museo Civico di Arte Antica a Torino (Fig. 28). I pezzi torinesi sonostati a suo tempo riferiti da Silvana Casartelli Novelli al san Massimodi Collegno, in ragione del confronto con due piccoli frammenti muratisu una parete di quell’edificio 76. Il ritrovamento della Novalesa aprenuove prospettive circa la effettiva originaria pertinenza dei pezzi tori-nesi, di cui peraltro non è certa la provenienza, o in alternativa sull’at-tività di botteghe di scultori operanti su un ampio territorio 77.
I frammenti novaliciensi riferibili al IX secolo ripresentano in al-tri termini lo stesso problema, dal momento che alcuni di essi mani-festano connotati compositivi e qualitativi (Fig. 29) in un certo sen-so confrontabili con la straordinaria produzione scultorea pertinenteal gruppo episcopale di Torino, come è stato di recente proposto daAlberto Crosetto 78.
Come abbiamo detto, la possibilità, tutta da verificare, che iframmenti scultorei provengano tutti dalle differenti fasi di costru-
76 CASARTELLI NOVELLI, Corpus cit. (nota 58), nn. 28-31; EAD. I marmi altomedievali,in Nuove scoperte alla Novalesa, Raccolta di studi presentati al Convegno per il1250esimo dell’atto di donazione di Abbone alla abbazia benedettina, numero specia-le di “Segusium” XV (1979), pp. 47-67; EAD., Nota su due nuovi frammenti relativi al-l’abbazia merovingia, in Novalesa. Fonti documentarie - ricerche archeologiche – re-stauri. Atti del convengo-dibattito (Abbazia della Novalesa, 10-12 luglio 1981), Susa,1988, pp. 25-60; CROSETTO, La chiesa di S. Massimo cit. (nota 58). Nell’attuale allesti-mento dei pezzi del Museo Civico di Palazzo Madama a Torino (dicembre 2006) i pez-zi sono segnalati come provenienti dal San Salvatore di Torino e datati agli inizi delIX secolo, all’età del vescovo Claudio; cfr. nota 74.
77 Per una compiuta disamina della questione: UGGÉ, I reperti scultorei cit. (nota75), passim.
78 CROSETTO, Una traccia: la produzione scultorea cit. (nota 44), pp. 167-171.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 325
zione e di arredo della chiesa abbaziale pone il problema dell’assettooriginario della serie di cappelle collocate all’esterno del nucleo degliedifici monastici (Fig. 22 e 30).
L’aspetto attuale degli edifici molto deve alle risistemazioni attuateal tempo del rientro della comunità alla Novalesa tra X e XI secolo.Per converso, le cappelle, nel loro stato attuale, forniscono l’unica pos-sibilità di risalire, fosse anche per suggestione, ai caratteri formali siadell’abbaziale dell’XI secolo che di quella altomedievale.
La cappella di S. Salvatore (Figg. 30, 31) mostra più chiaramentecaratteri che la qualificano come una probabile totale ricostruzione at-tuata verso la metà dell’XI secolo, sebbene il suo avancorpo sia costi-tuito da un corpo di fabbrica altomedievale, talora identificato comeuna sorta di torre; è interessante il dato trasmesso dal Chronicon No-valiciense, che indica questo edificio la residenza degli abati 79.
Anche la cappella di S. Eldrado, celebre per il ciclo di affreschidella fine dell’XI secolo con storie di S. Eldrado e di S. Nicola, pre-senta caratteri riconducibili certamente ad una datazione tarda.Tuttavia, gli scavi effettuati all’interno dell’edificio hanno permessodi appurare che l’aula absidata attuale, alla quale nel XVII secolo fuaggiunto un piccolo atrio aperto (Figg. 30, 32), rappresenta la rico-struzione di una più antica cappella dotata di abside quadrangolare,della quale sono state rinvenute le fondamenta, realizzate conte-stualmente alla formazione di un sepolcro che è stato ricondotto allasepoltura di Eldrado 80, abate della Novalesa nella seconda metà delIX secolo, del quale è testimoniata la precoce venerazione 81. Il pri-mo allestimento di questa cappella troverebbe dunque un appiglio cro-nologico per la sua costruzione ex novo nella tarda età carolingia 82.
79 G. CANTINO WATAGHIN, L’abbazia dei SS. Pietro e Andrea di Novalesa: gli edificimonastici nell’alto medioevo, in Wohn- und Wirtschaftsbauten frühmittelalterlicherKloster. Internationales Symposium (Zurzach-Müstair, 29/9 - 1/10 1995), hrsg. von R.H. SENNHAUSER, Zürich, 1996, pp. 17-26 (22-23).
80 Ringrazio Gisella Cantino Wataghin per avermi fornito informazioni su aspettidell’indagine archeologica ancora inediti e per avermi permesso di darne qui conto;per ogni precisazione e approfondimento si rimanda al relativo studio di prossimapubblicazione. Per il momento: CANTINO WATAGHIN, L’abbazia cit. (nota 63), p. 38.
81 Su Eldrado, v. ora: L. PROVERO, L’abbaziato di Eldrado a Novalesa e il confrontocon la società valsusina (secolo IX), in Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino,XCIX (2001), pp. 381-403.
82 A. CROSETTO, La cappella di Sant’Eldrado nell’Abbazia della Novalesa. Atti del
SAVERIO LOMARTIRE326
La cappella di San Michele (Figg. 30, 33) sorge sulla cima delcolle, giustificando in tal modo la dedicazione all’arcangelo. In que-sto caso l’edificio mantiene l’impianto planimetrico originario conabside quadrangolare. Il paramento esterno dell’aula presenta unapartitura in specchiature, che in facciata sono concluse da archi,mentre sul fianco nord – l’unico decorato probabilmente in ragionedella sua visibilità rispetto al percorso di accesso – la terminazionerettilinea fa pensare ad un intervento di sistemazione tardo che haobliterato le arcature originarie. La partitura esterna ricorda così inmodo diretto casi analoghi databili tra VIII e IX secolo 83 e induce apensare che l’edificio non abbia subito interventi radicali di ammo-dernamento formale al momento del ritorno della comunità mona-stica alla Novalesa.
A differenza delle tre cappelle esaminate, la cappella di SantaMaria si trova a circa duecento metri a nord del monastero (Fig.22). L’edificio, anch’esso ad aula con abside quadrangolare (Fig. 34),presenta sulle pareti nord e sud dell’aula una partitura esterna aspecchiature concluse da archetti binati, segnale di una ricostruzio-ne o di una ristrutturazione databile, sulla base dei possibili con-fronti, tra X e XI secolo, che interessò la parte sommitale del fiancosud e invece tutto il fianco nord, a partire dalle fondamenta; in ef-fetti, le operazioni di restauro agli intonaci interni hanno qui evi-denziato la presenza di bruciature, segno forse di eventi traumaticiper la struttura. Alla stessa fase di ristrutturazione protoromanicadovrebbe datarsi la copertura del vano absidale con una volta a bot-te, il cui profilo esterno non è estradossato, ma direttamente pla-smato a configurare gli spioventi, sui quali restano le impronte dellescandole applicate direttamente sulla malta di riempimento; le pa-reti esterne dell’abside (Fig. 35) sono invece organizzate in specchia-ture concluse da una sola arcata, a probabile segnale del manteni-mento della partitura altomedievale; una simile articolazione della
V congresso nazionale di archeologia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti -Valle d’Aosta - Novara, 22-29 settembre 1979), Roma, 1982, pp. 115-122.
83 A. PERONI, Per la tipologia architettonica dell’età carolingia nell’area lombarda,in Roma e l’età carolingia. Atti delle giornate di studi (Roma, 3-8 Maggio 1976), Ro-ma, 1976, pp. 87-101; H. R. SENNHAUSER, Zur Aussengestaltung frühmittelalterlicherSakralbauten im schweizer Alpengebiet, in Frühe Kirchen im östlichen Alpengebietcit. (nota 4), pp. 899-913.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 327
parete unita allo stesso tipo di impianto planimetrico si trova, sem-pre in area alpina, nella chiesa di San Martino a Deggio, nel Canto-ne Ticino 84. Sulle pareti esterne dell’abside di S. Maria restanoinoltre tracce dell’originario complemento pittorico a profilature etracciati a zig-zag in ocra rossa sul fondo bianco. Resti dell’anticadecorazione pittorica sono peraltro presenti anche sulle pareti del-l’interno 85. Gli scavi e le indagini condotte sulla cappella, pubblicatigià nel 1979, hanno qui evidenziato il sussistere di resti murari piùantichi rispetto alla fase edilizia carolingia 86.
La ricognizione del gruppo delle cappelle ha così portato allaconstatazione che in tutte quelle per le quali è riconoscibile una fasealtomedievale (S. Eldrado, S. Michele, S. Maria) è applicato lo sche-ma planimetrico ad aula con abside quadrangolare che parimenti siosservava nella chiesa abbaziale dell’VIII secolo. Due di questi edifi-ci, San Michele e S. Maria, erano già state prese in considerazionein tal senso, sebbene ancora non fossero disponibili i dati su S. El-drado e soprattutto sull’abbaziale, da Mariaclotilde Magni, che inuno studio pubblicato già nel 1965 richiamava l’attenzione su que-sto tipo di pianta nell’arco alpino, associando alle cappelle novali-ciensi il San Martino di Deggio 87.
Nel gruppo delle cappelle della Novalesa, quella di S. Michele ap-pare quella ad avere conservato più delle altre i suoi caratteri altome-dievali; si può forse supporre, inoltre, che essa sia stata la prima ad es-sere edificata, e ciò in ragione sia della sua collocazione, sia dei rappor-ti proporzionali tra aula e abside, molto più simili a quelli della cappel-la annessa alla chiesa abbaziale che a quelli di S. Maria e anche, perquello che si può capire, di S. Eldrado nella sua prima formulazione.So che questo è un elemento argomentativo debole, ma vorrei sottoli-
84 H. R. SENNHAUSER, Katalog der frühchlistichen und frühmittelalterlichen kirchli-chen Bauten in der Diözese Chur und in den nördlich und südlich angrenzendenLandschaften (A1-A125), in Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet cit. (nota 4), pp.43-221 (A29, pp. 79-80).
85 G. CANTINO WATAGHIN, M. COLONNA DURANDO, Classement et étude cit. (nota 74), p.138 e fig. 4.
86 E. MICHELETTO, L. PITTARELLO, G. CANTINO WATAGHIN, Restauri e ricerche alla cap-pella di Santa Maria dell’abbazia di S. Pietro di Novalesa, in Bollettino d’Arte, S. VI,LXIV, 4 (1979), pp. 45-62 (49-52).
87 M. MAGNI, Cappelle ad abside quadra anteriori al Mille nell’arco alpino, in Bol-lettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, n.s. XX (1966), pp. 47-63.
SAVERIO LOMARTIRE328
neare che almeno in un caso, cioè nella prima cappella di S. Eldrado,siamo certi che lo schema ad abside quadrangolare fu applicato anchequando la riconfigurazione carolingia dell’abbaziale prevedeva invecel’abbandono del vecchio schema in favore di un profilo semicircolare.Sebbene la modifica del profilo absidale non portasse ad un incrementoapprezzabile della superficie utile del coro, tuttavia l’operazione fu rite-nuta indispensabile o anche solo opportuna, e la spiegazione potrebbericercarsi nella volontà di pervenire ad un allestimento monumentaleche, se si vuole, in ultima analisi si può anche definire “romano”, so-prattutto se si immagina la nuova abside fornita di una volta a semi-catino, magari dipinta con una teofania come nel San Giovanni di Mü-stair. A questa riconfigurazione monumentale d’altra parte dovetteroconcorrere consistenti opere di ammodernamento nell’arredo e forseanche nell’apparato decorativo.
In ogni caso dobbiamo registrare il fatto che per un certo perio-do, nelle fasi edilizie più antiche, le chiese del cenobio novaliciensefurono concepite secondo uno schema planimetrico peculiare, quelload aula con abside quadrangolare; ciò doveva avere probabilmenteun suo significato, che però al momento ci sfugge.
Sarebbe interessante verificare se, a poca distanza della Novale-sa possa essere interpretata come eco di una simile situazione lachiesa di S. Pietro ad Avigliana (Torino), di cui è forse è riconoscibi-le la struttura altomedievale, come ha suggerito Costanza SegreMontel (Fig. 36) 88, ma la mancanza di dati sicuri consiglia per ilmomento di considerare questa evenienza solo come ipotetica.
Tra gli edifici altomedievali della Valle di Susa resta ancora iltempo per un rapido accenno alle prime fasi della abbazia di SanMichele della Chiusa, fondata da Ugo d’Alvernia tra il 983 e il 987.Possiamo già considerare romanica, in un certo senso, la basilica atre navate individuata agli inizi del Novecento da Alfredo D’Andra-de sotto la chiesa attuale, edificata con ambizioni monumentali apartire dalla prima metà del XII secolo (Fig. 37). Nondimeno, an-dranno prese in considerazione le recenti ricerche archeologiche con-dotte da Luisella Pejrani Baricco, che stanno gradatamente facendo
88 C. SEGRE MONTEL, Affreschi medievali alla Novalesa e in Valle di Susa. Testimo-nianze di pittura murale tra VIII e XII secolo, in Novalesa. Fonti documentarie - ri-cerche archeologiche - restauri. Atti del convengo-dibattito (Abbazia della Novalesa,10-12 luglio 1981), Susa, 1988, pp. 61-181 (74, 139).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 329
luce sulle strutture più antiche e su quelle del cosiddetto monasteronuovo a nord-ovest della chiesa 89.
Parti della struttura riferibili alla prima edificazione del cenobio so-no inoltre, mi pare, ancora individuabili nelle strutture a quota piùbassa del corpo meridionale del complesso monastico e sono rappresen-tate da murature in pietre apparecchiate con cura e da porte e monofo-re a profilo centinato con larghe ghiere in conci squadrati e spesso mu-nite di un bardellone (Fig. 38); altri elementi strutturali riferibili alleprime fasi si osservano chiaramente sulla sommità del monte Pirchi-riano, dove nelle strutture dell’attuale cripta sono già state riconosciu-te le evidenze del primo nucleo di edifici sacri, organizzato probabil-mente in origine, come ha suggerito Carlo Tosco, per aggregazione dicappelle e di celle 90. Resti appartenenti alla terminazione orientale diedifici più antichi sono d’altra parte ben riconoscibili nella parte ovestdel vano oggi chiamato “scalone dei Morti”, così da far pensare che lagrande struttura di sostruzione voltata, costruita verso la metà del XIIsecolo per fornire la cima del monte di un’ampia piattaforma su cui co-struire la nuova chiesa, corrisponda alla volontà di monumentalizza-zione di un antico percorso che portava alle cappelle alla cima delmonte, sempre ammesso che non fossero presenti già da tempo strut-ture anche di tipo eremitico.
La ricognizione delle architetture altomedievali dell’area alpinaoccidentale si conclude con un rapido ma doveroso cenno ad impor-tanti strutture monastiche nell’area del cuneese, dove alcuni edifici,soprattutto monastici, sono stati interessati in anni recenti da inda-gini approfondite, in qualche caso ancora in corso.
Resta poco da dire, allo stato attuale delle conoscenza, dellachiesa del monastero dei SS. Pietro e Colombano di Pagno (Cuneo),che in un documento del 14 febbraio 825 l’imperatore Lotario I dona
89 L. PEJRANI BARICCO, F. BOSMAN, S. Ambrogio. Abbazia di San Michele della Chiu-sa. Analisi stratigrafica degli elevati e scavi nell’area dei « ruderi del monastero nuo-vo », in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 18 (2001), pp. 117-119; PEJRANI BARICCO, Documenti di archeologia cit. (nota 62), pp. 78-80.
90 C. TOSCO, La circolazione dei modelli architettonici nel romanico subalpino: ilruolo della Sacra nei secoli X e XI, in La Sacra di San Michele simbolo del Piemonteeuropeo. Atti del Quarto Convegno Sacrense (Sacra di San Michele, 26-27 maggio1995), Torino, 1996, pp. 201-228. Per le vicende edilizie del complesso clusino, v. an-che: C. VERZÀR, Die romanischen Skulpturen der Abtei Sacra di San Michele, Bern,1968.
SAVERIO LOMARTIRE330
alla Novalesa a risarcimento dei beni espropriati all’abbazia da Lu-dovico il Pio per la costruzione dell’Ospitium del Moncenisio 91. Se-condo il Chronicon Novaliciense, che lo indica come “quondam ditis-simum et regalem”, il monastero di Pagno sarebbe stato fondato trail 749 e il 756 da re Astolfo, il quale lo avrebbe dotato di numerosibeni, dislocati anche al di là delle Alpi, fino alla Linguadoca 92. L’in-titolazione a S. Pietro potrebbe anche essere coeva all’unione delmonastero alla Novalesa, mentre quella a S. Colombano è invececon ogni probabilità tarda 93. Gli scavi del 1976 hanno potuto soloindagare l’area orientale dell’edificio, del quale è riconoscibile lastruttura romanica a tre navate dotata di un cripta. Alla chiesa fuin epoca tarda rovesciato l’orientamento distruggendo la zona absi-dale per trasformarla in facciata; gli scavi hanno potuto individuarei resti di tre absidi con murature in parte slegate fra loro e tracce diuna struttura interpretabile come un campanile addossato al latonord in adiacenza all’abside maggiore quale rielaborazione della te-stata orientale operata nel XII secolo sull’edificio ricostruito nel se-colo precedente; indagini archeologiche attualmente ancora in corsosembrano però segnalare in misura consistente un impianto plani-metrico altomedievale a sala unica triabsidata 94. La serie di sepol-ture esterne alle absidi sembra comunque indicare una datazionealtomedievale, come già indicato da Giulia Molli Boffa 95, confer-mando l’antichità dell’impianto, con una probabile datazione all’VIIIo al IX secolo ulteriormente corroborata da una lastra frammentariamurata sulla facciata attuale, pubblicata a suo tempo da Silvana
91 CIPOLLA, Monumenta Novaliciensia cit. (nota 64), doc. XXVII, pp. 71-75; v. inol-tre sopra, alla nota 59.
92 Chronicon Novaliciense, I,6; III,26, (ed. a cura di G. C. ALESSIO, Torino, 1981,pp. 37-39, 176).
93 D. BIANCOLINI, La chiesa dei SS. Pietro e Colombano di Pagno. Appunti di Storia erestauro. Atti del V congresso nazionale di archeologia cristiana (Torino - Valle di Susa -Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29 settembre 1979), Roma, 1982, pp. 175-185.
94 Ringrazio per l’informazione la dott.ssa Egle Micheletto, che sta conducendo loscavo. E. MICHELETTO, Pagno. Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Colombano, in Qua-derni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 21 (2006), pp. 259-260.
95 G. MOLLI BOFFA, Ricerche nel monastero dei SS. Pietro e Colombano in Pagno.Atti del V congresso nazionale di archeologia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cu-neo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29 settembre 1979), Roma, 1982, pp. 187-197.
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 331
Casartelli (Fig. 39), che ne fornisce una plausibile datazione allostesso periodo 96.
La chiesa del monastero di San Dalmazzo di Pedona, attualechiesa parrocchiale dell’odierna Borgo San Dalmazzo (Cuneo), sorgein una zona importante dal punto di vista territoriale, ponendosi suun nodo stradale strategico per il controllo dell’imboccatura dellevalli Stura, Gesso e Vermenagna, che fin dall’antichità permetteva-no il transito rispettivamente con il versante alpino francese, con laProvenza e con la Liguria. La chiesa sorse nel VI secolo sulla tombadel martire Dalmazzo, in prossimità della città romana scomparsadi Pedona, e gli scavi avviati da Egle Micheletto nel 1995 ne hannoriportato in luce la struttura ad aula monoabsidata 97. Sebbene laprima menzione del complesso monastico si dati al 902, con un di-ploma di Ludovico III, la tradizione riferisce la fondazione del ceno-bio ad epoca longobarda, probabilmente all’epoca di Ariperto II 98.Della fase databile dunque forse all’inizio dell’VIII secolo è stato in-dividuato il perimetro della chiesa, che si presentava con corpo basi-licale a tre navate (Fig. 40). Di questa fase fanno fede importantiresti scultorei (Fig. 41), segnalati già da tempo da Silvana Casartel-li 99, che dovevano decorare il sepolcro del santo nell’abside princi-pale e della pergula di recinzione presbiteriale, della quale è statoproposto in disegni ricostruttivi 100 (Fig. 42). Il declino dell’abbazia ini-zia alla metà del X secolo con il trasferimento delle reliquie di SanDalmazzo a Quargnento: un trasferimento che, formalmente motivato
96 CASARTELLI NOVELLI, Corpus cit. (nota 58), pp. 145-146, n. 81.97 E. MICHELETTO, San Dalmazzo di Pedona. Il Museo dell’Abbazia, Borgo San Dal-
mazzo, 2005, pp. 22-23 (tomba), 50-51 (recinzione presbiteriale); v. inoltre: E. MICHE-LETTO, Indagini archeologiche nell’abbazia di “fondazione longobarda” di Borgo SanDalmazzo (CN). Atti del I Congresso di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio1997), a cura di S. GELICHI, Firenze, 1997, pp. 308-314; La chiesa di San Dalmazzo aPedona, a cura di E. MICHELETTO, Cuneo, 1999.
98 Per il documento del 902 e per la tradizione della fondazione longobarda de ce-nobio: A. M. RIBERI, S. Dalmazzo di Pedona e la sua abazia (Borgo San Dalmazzo),Torino, 1929 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CX), pp. 145-153, 177-179;E. MICHELETTO, La chiesa di San Dalmazzo e la sua cripta. L’intervento archeologico elo studio degli elevati, in La chiesa di San Dalmazzo cit. (nota 96), pp. 43-107 (43).
99 CASARTELLI NOVELLI, Corpus cit. (nota 58), pp. 61-78, nn. 2-18.100 I disegni sono pubblicati in MICHELETTO, San Dalmazzo di Pedona cit. (nota 96),
pp. 22-23 (tomba), 50-51 (recinzione presbiteriale).
SAVERIO LOMARTIRE332
con la necessità di proteggere il corpo santo dalle scorrerie saracene, èstato però ricondotto da Aldo Settia più verosimilmente alla volontà dipromuovere il mercato di Quargnento 101. La rinnovata importanza delcenobio si documenta a partire dal secolo XI, quando la chiesa viene ri-costruita e dotata di una cripta, ampliata poi nel XII secolo.
A Villar San Costanzo (Cuneo), la chiesa di San Costanzo alMonte, dipendente un tempo dal vicino monastero di San Costanzodel Villar, sorge sul Monte Bernardo sul luogo tradizionalmente in-dicato come il luogo del martirio di S. Costanzo. La struttura attua-le è databile alla metà del XII secolo, come hanno riconosciuto alcu-ni studi recenti e le indagini in parte già pubblicate, di Egle Miche-letto e Sofia Uggé 102. L’edificio possiede una interessante struttura adoppio livello estesa per gran parte del piano basilicale a tre navate(Fig. 43): un assetto questo risultante da una serie di successivecampagne edilizie scalatesi a partire dall’aggiunta all’edificio alto-medievale di un avancorpo occidentale databile alla metà del secoloXI, come potrebbero suggerire i caratteri di un frammento di pitturemurali, ora pressoché perdute 103, che rivelano un diretto contatto
101 SETTIA, Monasteri subalpini cit. (nota 64), pp. 298-302; v. anche: ID., « Per forosItalie ». Le aree extraurbane fra Alpi e Appennini, in Mercati e mercanti nell’alto me-dioevo: l’area euroasiatica e l’area mediterranea, Spoleto, 1993 (Settimane di studiodel Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XL), pp. 187-233 (ora anche in A. A.SETTIA, Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, Ro-ma, 1999, pp. 103-142), p. 213 n. 93.
102 E. MICHELETTO, Villar S. Costanzo. Chiesa abbaziale sul monte Bernardo, inQuaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 13 (1995), pp. 346-347; E.MICHELETTO, S. UGGÉ, La chiesa di San Costanzo sul Monte Bernardo (Piemonte, Cu-neo) e il suo arredo scultoreo. Atti del Convegno internazionale L’edifice de culte entreles périodes paléochretienne et carolingienne (Porec, 17-21 maggio 2002), in HortusArtium Medieaevalium. Journal of the International Research Center for Late Anti-que and Middle Ages, 9 (2003), pp. 383-400; v. inoltre: M. NEGRO PONZI, Villar SanCostanzo (Cuneo). San Costanzo al Monte. Atti del V congresso nazionale di archeolo-gia cristiana (Torino - Valle di Susa - Cuneo - Asti - Valle d’Aosta - Novara, 22-29settembre 1979), Roma, 1982, pp. 169-173; sulla fase romanica: G. ROMANO, Cantieridi aggiornamento: San Costanzo al Monte e Orta San Giulio, in Piemonte Romanico,a cura di G. ROMANO, Torino, 1994, pp. 153-157.
103 N. GABRIELLI, Pitture medievali piemontesi, in Civiltà del Piemonte. Studi in ono-re di Renzo Gandolfo nel suo settantacinquesimo compleanno, a cura di G. P. CLIVIO eR. MASSANO, Torino, 1975, pp. 97-108 (102); H. P. AUTENRIETH, B. AUTENRIETH, Die Wan-dmalerei des 11. Jahrhunderts in der Kathedrale Aosta, in Medioevo Aostano. La pit-
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 333
con i coevi cantieri pittorici di S. Orso e della Cattedrale di Aosta.Dell’importanza della fase altomedievale fa fede un cospicuo gruppodi sculture databili all’VIII-IX secolo reimpiegate in varie zone dellastruttura (Fig. 44) e studiate a suo tempo da Silvana Casartelli erecentemente da Sofia Uggé. I risultati delle ultime ricerche sugge-riscono che nel nucleo più antico dell’edificio monastico, databiledunque tra VIII e IX secolo, vada riconosciuto un impianto a salaunica triabsidata, che si aggiunge così ai casi già esaminati in pre-cedenza (Fig. 45). Ciò mi dà l’occasione per segnalare (e ringrazio ladott.ssa Micheletto per avermene informato), che ricerche in corsonella chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Caraglio (Cuneo) paiono indica-re anche per quell’edificio un impianto a sala triabsidata 104.
La ricognizione sulle testimonianze di architettura e sculturadell’altomedioevo che abbiamo compiuto richiederebbe ora di ricava-re qualche conclusione: cosa certo non semplice.
La prima conclusione, persino ovvia, è che, sulla base di quello chesi è esaminato e tenendo conto delle inevitabili e certo numerosissimeperdite, si cercherebbe invano un tipo architettonico “alpino” per anto-nomasia. Né d’altra parte avrebbe senso parlare in termini assoluti di“tipologie architettoniche”: un concetto tanto vago quanto pericoloso.Per converso, l’area alpina non si lascia definire attraverso tipi archi-tettonici o decorativi peculiari, dal momento che abbiamo osservato lapiù ampia varietà di organizzazioni spaziali e planimetriche.
Né forse avrebbe veramente senso parlare di diversità legate allediverse aree di influenza. Per fare un esempio, il fatto che negli edi-fici religiosi del complesso della Novalesa si prediligano in un primotempo gli impianti con abside quadrangolare, può anche essere ri-condotto ad una contiguità, che sembrerebbe persino necessaria, conl’orizzonte culturale merovingio. Esempi vicini, sempre nel settorealpino, come le chiese di Notre-Dame du Bourg a Digne e di Notre-Dame de Salagon a Mane, entrambe nelle Alpes-de-Haute-Provence,
tura intorno all’anno Mille in Cattedrale e in Sant’Orso. Atti del Convegno interna-zionale (Aosta, 15-16 maggio 1992), Torino, 2000, pp. 59-136 (106).
104 Sui SS. Pietro e Paolo di Caraglio: E. MICHELETTO, Impianti per la produzionedelle campane in Piemonte: dati archeologici a confronto, in Del fondere campane.Dall’archeologia alla produzione. Quadri regionali per l’Italia settentrionale. Atti delConvegno (Milano, 23-25 febbraio 2006) [in corso di stampa].
SAVERIO LOMARTIRE334
parrebbero confermarlo 105. Eppure un simile tipo planimetrico è ri-scontrabile in un’area molto vasta, non solo di ambito alpino e nonsolo di tipo funerario, come mostrano le indagini a vasto raggio con-dotte di recente in area alpina e non solo 106.
In tal modo, ogni eventuale ipotesi di corrispondenza a tipi re-gionali definiti sembra venire meno, o se non altro richiederà piùmeditate puntualizzazioni. D’altra parte, pur rimanendo in ambitoper così dire merovingio, si è visto che la situazione per la Valled’Aosta è invece diversa, e i tipi planimetrici risultano gravitare giàprecocemente su altri modelli, persino milanesi, come si è visto peril San Lorenzo di Aosta.
Per la scultura si evidenziano poi scambi frequenti, che possonoanche far pensare a gruppi itineranti di scultori o a botteghe cheproducono per diversi edifici, fra le quali va almeno ricordata quella“bottega delle Alpi marittime” che Silvana Casartelli ha a suo tem-po suggerito di individuare con riferimento ad alcuni edifici dell’a-rea qui presa in esame 107. Come si è visto, la produzione scultorea èapparsa ad esempio legata ora a realizzazioni più orientate verso laproduzione padana centrale, come quella pavese, ad esempio, ora acantieri come quello della cattedrale di Torino al tempo del vescovoClaudio agli inizi del IX secolo 108.
Per quanto riguarda gli sviluppi planimetrici emergono alcunequestioni di fondo sulle quali proporre una riflessione finale. La pri-ma riguarda la possibilità di definire gli edifici altomedievali me-
105 G. DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Digne. Notre-Dame du Bourg, in Atlas Culturel des Al-pes Occidentales cit. (nota 10), pp. 186-187; R. GUILD, Mane. Notre-Dame de Salagon,ibid., pp. 180-191.
106 SENNHAUSER, Typen, Formen und Tendenzen cit. (nota 4), pp. 924-930; per unacampionatura dell’applicazione di questo schema ad edifici funerari v. ad es.: G. P.BROGIOLO, Oratori funerari tra VII e VIII secolo nelle campagne transpadane, in Hor-tus Artium Medieaevalium. Journal of the International Research Center for Late An-tique and Middle Ages, 8 (2002), pp. 9-31.
107 S. CASARTELLI NOVELLI, Confini e bottega “provinciale” delle Marittime nel diveni-re della scultura longobarda dai primi del secolo VIII all’anno 774, in Storia dell’ar-te, 32 (1978), pp. 11-22; CROSETTO, Croci e intrecci cit. (nota 25), pp. 313-318.
108 Sui problemi delle maestranze di scultori attive nell’altomedioevo nell’area pie-montese v. inoltre: CROSETTO, Una traccia: la produzione scultorea cit. (nota 44), pp.171-176 (in particolare per l’espansione dell’attività delle maestranze attive alla cat-tedrale torinese); ID., La chiesa di S. Massimo cit. (nota 58), pp. 264-265; UGGÉ, I re-perti scultorei cit. (nota 75), pp. 60-63 (in relazione ai pezzi novaliciensi).
ARCHITETTURA E SCULTURA DELL’ALTO MEDIOEVO 335
diante l’applicazione di tipi planimetrici peculiari. Qui bisogna ricor-dare, e il discorso vale per l’area alpina allo stesso modo che le altrearee, che si constata come, in edifici per i quali sia riconoscibile unacontinuità dall’epoca paleocristiana fino almeno al periodo romanico,possano anche mancare fasi edilizie altomedievali vere e proprie, al-meno per quanto riguarda la riedificazione di strutture murarie.Fermo restando che questa è una variabile condizionata dalla vicen-da di ogni singola struttura, si deve ammettere che ogni discorsosull’espansione e persino sulla formazione di tipi planimetrici devetenere conto della materiale sopravvivenza di schemi più antichi,che si integrano necessariamente nell’uso e, per così dire, nell’oriz-zonte architettonico altomedievale. È il caso di edifici del V o VI se-colo, ad esempio, che in epoca altomedievale abbiano ricevuto, qualesegno di un ammodernamento o di un adeguamento liturgico, unnuovo assetto dell’arredo scultoreo o rinnovamenti solo parziali del-la struttura, come abbiamo visto nelle cattedrali di Aosta e di Ivrea.Peraltro non diverso è il caso dell’abbaziale della Novalesa, solo sca-lato in un arco cronologico più ristretto.
Dall’esame delle evidenze nell’area che abbiamo preso in con-siderazione emerge piuttosto un altro dato significativo, e cioèla frequenza di impianti ad aula unica triabsidata (Fig. 46), fino-ra noti limitatamente alle aree altoadriatica, retica e padana. Scar-tati i casi dubbi e senza escludere ulteriori verifiche, gli edifici rife-ribili a questo tipo risultano essere sei, tutti di plausibile datazionealtomedievale, senza contare altre eventuali occorrenze nella pianu-ra. I riferimenti possibili per questa situazione andranno presi inconsiderazione caso per caso verificare se essi siano riconducibili asituazioni peculiari. Ma intanto ci si può chiedere per quali vie sisia verificata l’espansione del tipo in quest’area. Piuttosto che a tra-pianti diretti dall’area altoadriatica o retica attraverso l’area alpina,credo probabile che tale diffusione sia avvenuta attraverso gli esem-pi lombardi, attestati a Pavia, Sirmione e altrove già dall’età longo-barda. D’altro canto è più probabile che proprio dalla Lombardia,piuttosto che dall’area altoadriatica, l’impianto chiesastico ad aulatriabsidata di sia diffuso anche in area retica, come riportano studirecenti 109.
109 Vedi sopra, alle note 35 e 36.
SAVERIO LOMARTIRE336
Quello che si è qui presentato è solo un saggio del bilancio, purparziale e provvisorio, che possiamo trarre dalla ricognizione effet-tuata nell’architettura dell’area alpina occidentale. L’auspicio è siavvicini il momento in cui tutti i dati possano confluire in un corpusche integri e completi quello appena prodotto relativamente all’arcoalpino centrale e orientale.
SAVERIO LOMARTIRE
S. LOMARTIRE TAV. I
Fig. 1 - Carta schematica dell’Italia nord-occidentale con individuazione dei complessiarchitettonici riconducibili all’altomedioevo nell’arco alpino occidentale
(dis. Saverio Lomartire).
TAV. II S. LOMARTIRE
Fig. 2 - Mergozzo (Novara). Complesso di San Giovanni in Montorfano, planimetrie:a) fase di V-VI sec.; b) successiva fase di risistemazione del fonte battesimale
e del recinto presbiteriale nel battistero (da PEJRANI BARICCO 1999).
Fig. 3 - Mergozzo (Novara). Complesso di San Giovanni in Montorfano, planimetriadella fase altomedievale. A destra in colore scuro i resti dell’edificio con probabileimpianto ad aula unica triabsidata (rielaborazione da PEJRANI BARICCO, 1999).
S. LOMARTIRE TAV. III
Fig. 4 - Orta (Novara), Isola di San Giulio. Basilica di San Giulio,planimetria delle fasi di VI e VII secolo (da PEJRANI BARICCO 1999).
Fig. 5 - Orta (Novara), Isola di San Giulio. Basilicadi San Giulio, pluteo frammentario, VII secolo
(da PEJRANI BARICCO 1999).
TAV. IV S. LOMARTIRE
Fig. 6 - Orta (Novara). Chiesa di San Nicolao, planimetria degli scavi; con la linea continuagrigia sono evidenziati i resti della chiesa altomedievale secondo l’ipotesi di planimetria
ad abside quadrangolare (rielaborazione da PEJRANI BARICCO 1994).
Fig. 7 - Gargallo (Novara), San Pietro. Planimetria dello scavo (da PEJRANI BARICCO 1995).
S. LOMARTIRE TAV. V
Fig. 8 - Postua (Novara), San Sebastiano. Planimetria dello scavo;in retino grigio i resti dell’edificio altomedievale (da PANTÒ 2001).
Fig. 9 - Varallo Sesia (Vercelli), fraz. Roccapietra, San Martino. Schema delle fasi costruttivetra V-VI sec. e VIII-IX sec. ipotizzabili dai dati di scavo (da PANTÒ 2003).
Fig. 8 - Postua (Novara), San Sebastiano. Planimetria dello scavo;in retino grigio i resti dell’edificio altomedievale (da PANTÒ 2001).
F
TAV. VI S. LOMARTIRE
Fig. 10 - Cavaglià (Vercelli). Chiesa parrocchiale di San Michele, planimetria degli scavi. A destra,in colore scuro, i resti dei perimetrali dell’edificio altomedievale a sala unica triabsidata
(rielaborazione da PANTÒ 1994).
Fig. 11 - Ivrea (Torino), Cattedrale di Santa Maria. Testata occidentale, planimetrie deldeambulatorio superiore e della cripta di età warmondiana (da PEJRANI BARICCO 2002).
Fig. 10 - Cavaglià (Vercelli). Chiesa parrocchiale di San Michele, planimetria degli scavi. A destra,in colore scuro, i resti dei perimetrali dell’edificio altomedievale a sala unica triabsidata
(rielaborazione da PANTÒ 1994).
F
S. LOMARTIRE TAV. VII
Fig. 12 - Eugenio de Levis, Miscellanea eporegiensa. Disegno raffigurantedue plutei altomedievale « in sacello B(eati) Teguli » della cattedraledi Ivrea. Torino, Biblioteca Reale, ms. st. p. 681, dis. in pagina senza
numero (da MARITANO 2000).
Fig. 13 - Settimo Vittone (Torino), Complesso battesimale (da PANTÒ 1982).
TAV. VIII S. LOMARTIRE
Fig. 14 - Aosta, Cattedrale di Santa Maria. Planimetria delle fasi fino all’VIII secolo(da BONNET, PERINETTI 1986).
Fig. 15 - Aosta, Cattedrale di Santa Maria. Frammento scul-toreo appartenente al recinto presbiteriale altomedievale
(da BONNET, PERINETTI 1986).
Fig. 14 - Aosta, Cattedrale di Santa Maria. Planimetria delle fasi fino all’VIII secolo(da BONNET, PERINETTI 1986).
F
S. LOMARTIRE TAV. IX
Fig. 16 - Aosta, San Lorenzo. Planimetrie delle fasi tardoantiche e medievali(da BONNET, PERINETTI 1986).
TAV. X S. LOMARTIRE
Fig. 17 - Aosta, Sant’Orso e San Lorenzo. Planimetria delle fasi di IX e X secolo(da BONNET, PERINETTI 2001).
Fig. 18 - Aosta, Sant’Orso, Frammento di pluteo di transenna altomedievale(da BONNET, PERINETTI 2001).
Fig. 17 - Aosta, Sant’Orso e San Lorenzo. Planimetria delle fasi di IX e X secolo(da BONNET, PERINETTI 2001).
F
S. LOMARTIRE TAV. XI
Fig. 19 - Aosta, Santo Stefano. Planimetria della fase carolingia (da BONNET, PERINETTI 2004).
Fig. 20 - Morgex (Aosta), Santa Maria. Planimetria della fase carolingia(da BONNET, PERINETTI 2004).
Fig. 19 - Aosta, Santo Stefano. Planimetria della fase carolingia (da BONNET, PERINETTI 2004).
F
TAV. XII S. LOMARTIRE
Fig. 21 - Villeneuve (Aosta), Santa Maria, planimetria delle fasi fino ai secc. XI-XII(rielaborazione da BONNET, PERINETTI 1986).
Fig.
21-V
illen
euve
(Aos
ta),
Sant
aM
aria
,pla
nim
etri
ade
llefa
sifin
oai
secc
.XI-
XII
(rie
labo
razi
one
daB
ON
NE
T,PE
RIN
ETT
I19
86).
S. LOMARTIRE TAV. XIII
Fig. 22 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Planimetria generaledel complesso monastico (da CANTINO WATAGHIN 1988).
Fig. 23 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Planimetria delle fasidel monastero (rielaborazione da CANTINO WATAGHIN 2004).
TAV. XIV S. LOMARTIRE
Fig. 24 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Planimetria delle fasidella chiesa abbaziale (rielaborazione da CANTINO WATAGHIN 2004).
Fig. 25 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Frammento di lastracon croci incastrate (da UGGÉ 2004).
S. LOMARTIRE TAV. XV
Fig. 26 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Frammenti di pluteo,ricostruzione dell’aspetto originario della lastra. Disegno di Sofia Uggé (da UGGÉ 2004).
Fig. 27 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Frammenti di transennaprovenienti da Santa Maria e dal settore ovest del chiostro (da UGGÉ 2004).
TAV. XVI S. LOMARTIRE
Fig. 28 - Torino, Museo Civico di Arte Antica. Pluteo ad arcatelle lavorato sui due lati(da UGGÉ 2004).
Fig. 29 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Pluteo frammentario (da UGGÉ 2004).
Fig. 28 - Torino, Museo Civico di Arte Antica. Pluteo ad arcatelle lavorato sui due lati(da UGGÉ 2004).
S. LOMARTIRE TAV. XVII
Fig. 30 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Planimetrie delle cappelle esterne(rielaborazione da SAVI 1973).
TAV. XVIII S. LOMARTIRE
Fig. 31 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella di S. Salvatore, part. dell’esterno.
Fig. 32 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Planimetria della cappella di Sant’Eldrado (da CROSETTO 1982).
Fig. 31 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella di S. Salvatore, part. dell’esterno.
F
S. LOMARTIRE TAV. XIX
Fig. 33 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella di San Michele, veduta esterna da ovest-nordovest.
Fig. 34 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea. Planimetriadella cappella di Santa Maria (da MICHELETTO, PITTARELLO, CANTINO WATAGHIN 1979).
Fig. 33 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella di San Michele, veduta esterna da ovest-nordovest.
F
TAV. XX S. LOMARTIRE
Fig. 35 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella da Santa Maria, veduta esterna da sud).
Fig. 36 - Avigliana (Torino), San Pietro. Planimetria della chiesa, con ricostruzionedella planimetria dell’edificio altomedievale (da SEGRE MONTEL 1981).
Fig. 35 - Novalesa (Torino), Abbazia dei Santi Pietro e Andrea.Cappella da Santa Maria, veduta esterna da sud).
F
S. LOMARTIRE TAV. XXI
Fig. 37 - Sant’Ambrogio di Avigliana (Torino), Abbazia di San Michele della Chiusa.Planimetria generale del complesso monastico (da VERZÀR 1968).
Fig. 38 - Sant’Ambrogio di Avigliana (Torino), Abbazia diSan Michele della Chiusa. Elementi architettonici riferibiliprobabilmente alla prima fase edilizia del monastero (fine
del X secolo).
Fig. 37 - Sant’Ambrogio di Avigliana (Torino), Abbazia di San Michele della Chiusa.Planimetria generale del complesso monastico (da VERZÀR 1968).
F
TAV. XXII S. LOMARTIRE
Fig. 39 - Pagno (Cuneo), Chiesa dei Santi Pietro e Colombano.Lastra frammentaria dall’antico complesso monastico (da CASARTELLI NOVELLI 1974).
Fig. 40 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Chiesa di San Dalmazzo di Pedona.Planimetria delle fasi edilizie. Con il tratteggio è evidenziata la fase di VIII secolo
(rielaborazione da MICHELETTO 2005).
S. LOMARTIRE TAV. XXIII
Fig. 41 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Chiesa di San Dalmazzo di Pedona.Lastra frammentaria altomedievale (da CASARTELLI NOVELLI 1974).
Fig. 42 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Chiesa di San Dalmazzodi Pedona. Disegno ricostruttivo dell’antica recinzione presbiteriale
(da MICHELETTO 2005).
Fig. 41 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Chiesa di San Dalmazzo di Pedona.Lastra frammentaria altomedievale (da CASARTELLI NOVELLI 1974).
F
TAV. XXIV S. LOMARTIRE
Fig. 43 - Villar San Costanzo (Cuneo). Chiesa di San Costanzo al Monte.Planimetria delle fasi edilizie (da MICHELETTO, UGGÉ 2003).
Fig. 44 - Villar San Costanzo (Cuneo). Chiesa di SanCostanzo al Monte. Resti di elementi scultorei (quielementi di pergula) reimpiegati nell’attuale chiesa
inferiore (da MICHELETTO, UGGÉ 2003).
Fig. 43 - Villar San Costanzo (Cuneo). Chiesa di San Costanzo al Monte.Planimetria delle fasi edilizie (da MICHELETTO, UGGÉ 2003).
F







































































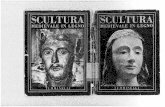




![Il pensiero filosofico occidentale e la morte [Western Philosophy on Death]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a0bb63847156ac06b685/il-pensiero-filosofico-occidentale-e-la-morte-western-philosophy-on-death.jpg)









