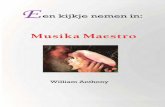Tabernacoli dipinti e scultura lignea in Abruzzo. Il Maestro di Fossa e il Maestro del Crocifisso
Transcript of Tabernacoli dipinti e scultura lignea in Abruzzo. Il Maestro di Fossa e il Maestro del Crocifisso
STEFANIA PAONE
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO Il Maestro di Fossa e il Maestro del Crocifisso d’Argento
In Occidente la Madonna in trono è genericamente considerata l’erededella ben più antica categoria delle Sedes Sapientiae1, sculture raffiguranti laMadonna regina con il Bambino assisa sul trono con allusione a quello salo-monico2. Se i primi esemplari di cui si ha testimonianza sono veri e proprireliquiari come la Madonna di Clermont-Ferrand del 946 circa, successiva-mente i manufatti lignei scolpiti si presentano rivestiti in lamina d’oro e pie-tre preziose come la Madonna di Hildesheim (Diözesanmus) dell’inizio delXI secolo. Immediata è dunque l’analogia sia con i reliquiari non figurali, acassetta, sia con quelli ‘parlanti’ aventi la forma della parte del corpo delsanto in esso contenuto, ma complessa è invece la questione relativa allamancanza di reliquie corporali della Vergine, la cui statua in origine ne con-teneva di appartenenti ai santi3.
E come i reliquiari posti dietro gli altari, anche la statua della Madonnacon il Bambino, soprattutto se inserita all’interno di altaroli a sportelli, scol-piti o dipinti, poteva essere efficacemente mostrata ai fedeli in determinatefestività dell’anno4. In Italia troviamo, tra gli esempi più antichi, il celebregruppo nella chiesa di Santa Maria Maggiore ad Alatri5, databile ai primi del
45
SMM 1-2/2011
1 H. BELTING, Il culto delle immagini: storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma,Carocci, 2001 pp. 363-379, 429.
2 Si veda il contributo di Gaetano Curzi in questi atti.3 Su questo argomento e sugli esempi citati la bibliografia di riferimento è ingente, si veda da ulti-
mo G. CURZI, Immagine del culto e memoria dell’antico nella scultura lignea medievale: una traccia, inMedioevo: Immagine e memoria, Atti del convegno (Parma, 2008), a cura di A. C. Quintavalle, Milano,Electa, 2009, pp. 345-357(con bibliografia precedente).
4 M. BACCI, L’effigie sacra e il suo spettatore, in Arti e Storia nel Medioevo, a cura di E. Castelnuovo,G. Sergi, III, Del vedere: pubblici, forme, funzioni, Torino, Einaudi, 2004, pp. 199-252 e G. GENTILE,Sculture per l’immaginario religioso, ivi, pp. 253-270: 254.
5 Sulla Madonna di Alatri G. CAPONE, Santa Maria Maggiore: storia di una chiesa e della vita religiosa diAlatri dal protocenobio della Regula magistri al XIV secolo, Alatri, Hetea,1991 (con bibliografia precedente).
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 45
XIII secolo, ora composto da tre parti disconnesse, la Madonna con ilBambino e i due laterali con le Storie cristologiche scolpite.
Ma la Madonna con il Bambino scolpita deve necessariamente fare i conticon la sua versione dipinta e con il genere dell’icona di nascita orientale, conle sue trasformazioni e trasferimenti in Occidente e con le evoluzioni del suouso liturgico e devozionale6. Il riferimento non è solo all’icona mariana maanche quel particolare genere agiografico, la cosiddetta vita-icon7, che si dif-fonde nel XII secolo e che presenta l’immagine a figura intera del santo intor-no al quale si dispongono le scene relative alla sua biografia, come nell’iconadi Santa Caterina del monastero sinaitico. Gli episodi narrativi più frequen-temente, stando alle testimonianze superstiti, sono organizzati ai lati dell’im-magine isolata del santo; in questo secondo caso l’icona può adottare laforma cuspidata dalla quale, in alcuni esemplari, emerge o viene tagliata l’au-reola della figura. Questa, inoltre, poggia i piedi su una base ottenuta con uncolore diverso da quello del fondo della tavola oppure coincidente con la cor-nice stessa del manufatto. Elementi che non solo fanno risaltare la monu-mentalità del personaggio centrale ma che gli conferiscono una dimensionereale, ‘fisica’, la quale rimanda, come si diceva, all’analogia o forse, per gliesemplari tardo duecenteschi e del secolo successivo, ad una probabile deri-vazione da più antiche sculture-reliquiario. In quest’ottica potremmo legge-re le immagini di San Francesco circondato dalle storie della sua vita nellacappella Bardi in Santa Croce a Firenze e la tavola di BonaventuraBerlinghieri nel San Francesco a Pescia e quella del San Francesco di Pisa(Museo Nazionale, fig. 1)8. E spiegare così anche il forte aggetto dell’aureolache in alcuni esempi si sovrappone alla cornice, con la conseguenza di ‘stac-care’ la figura dal supporto dipinto del fondo, come nel caso di particolarimanufatti in legno, a rilievo bassissimo e pittura, tra i quali la celebreMadonna di Santa Maria Maggiore a Firenze che, ispirandosi alla tradizioneromanica della Maestà scolpita, sembra guardare proprio ad un’immagineplastica9.
46
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
6 H. BELTING, Il culto delle immagini cit., passim.7 Ibidem, pp. 304-317 e M. BACCI, La nuova iconografia religiosa, Storia delle arti in Toscana. Il
Trecento, a cura di M. Seidel, Firenze, Edifir Edizioni, 1999, pp. 147-170: 163.8 A. TARTUFERI, La pittura a Firenze nel Duecento, Firenze, Bruschi, 1990, figg. 24 e 50.9 M BOSKOVITS, Ancora sulla Madonna del Carmine in Santa Maria Maggiore a Firenze, in
Medioevo: immagini e ideologie, Atti del Convegno Internazionale (Parma 2002), a cura di A.C.Quintavalle, Milano, Electa, 2005, pp. 302-312; M. CIATTI, Il restauro del significato: dalla Maestà diSanta Maria Maggiore alla Croce di Santa Maria Novella, ivi, pp. 313-324.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 46
Ancora poco sappiamo dellavita quotidiana di questi taberna-coli10: in molti casi documentatidalle fonti venivano aperti in par-ticolari festività, ma probabil-mente alcuni possedevano antelaterali fisse e quindi non richiu-dibili, stato attestato anche permolti trittici dipinti, lasciandocisupporre che la scultura fosse sta-bilmente ospitata nel suo taber-nacolo e costantemente espostaalla venerazione dei fedeli. Nonsono molte le testimonianzescritte o figurative che documen-tino con esattezza l’esistenza e lacollocazione dei tabernacoli nellospazio sacro, ad esempio nelleminiature delle Cantigas diAlfonso X (Firenze, Biblioteca
Nazionale, ms. BR 20), si nota che la scultura priva di supporti o contenito-ri è raffigurata su un altare11. Al contrario, un’interessante incisionedell’Ottocento mostra l’interno della Cattedrale di Arras12 dove, oltre alcosiddetto Altare Reliquiario, sono ben visibili tre tabernacoli dal corona-mento tipicamente gattonato e con le ante aperte e decorate, al cui internosi vedono delle sculture. Certo gli esemplari abruzzesi, come si dirà, essendodi dimensioni non proprio ridotte, si fatica ad immaginarli stabilmente sualtari di chiese tra l’altro molto piccole.
Alcune di queste sculture, inoltre, sono ancor oggi addossate ad un tavo-la che però solo in pochi casi può essere considerata con certezza come parte
47
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
10 H. HAGER, Die Anfänge des italienischen Altarbildes. Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte destoskanischen Hochaltarretabels, München, Schroll, 1962; H.W. VAN OS, Sienese Altapieces, 1215-1460.Form, Content, Function, 2 voll., Groningen, Bouma’s Boekhuis, 1984-1990; M. BACCI, L’effigie sacracit., p. 220ss; ID. Lo spazio dell’anima: vita di una chiesa medievale, Roma, Laterza, 2005, pp. 111-113e passim (con bibliografia precedente).
11 A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, P. TREVIÑO GAJARDO, Las Cantigas de Santa María: formas e imáge-nes Madrid, AyN Ediciones, 2007. Certo è necessario tenere ben presente la finalità didascalico-illu-strativa delle miniature che raffigurano la scultura che ‘si anima’ sull’altare.
12 A. DIDRON AINÉ, Autel des reliques dans l’ancienne cathédral d’Arras, in «Annales archéologiques»,8, 1848, p. 180.
Fig. 1: Pisa, Museo Nazionale (da Pisa, SanFrancesco), San Francesco e sei miracoli.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 47
superstite di un tabernacolo. Ildubbio può essere fugato soloquando la tavola mostri i segni ole tracce più consistenti di gancimetallici laterali che suggerisconol’esistenza di sportelli. Ma èaltrettanto lecito supporre chemolte di queste sculture fosseroprogettate e create con il solodossale. Ad incidere sulla confor-mazione di queste opere è statosicuramente l’uso cultuale, quelloparaliturgico nelle sacre rappre-sentazioni e in primis la pratica direcare in processione la scultura:pratica come si sa antichissima,ben documentata per le icone e lecosiddette immagini acheropitedella Cristianità.
Un’interessante testimonianzadi primo Trecento di questo usosi trova nell’aquilano, a Sulmona,nella chiesa di San Francescodella Scarpa la cui attuale contro-facciata ospita un affresco raffi-gurante un finto polittico a spor-telli con le Storie di San Ludovico
di Tolosa13. Si tratta della trasposizione pittorica di un tabernacolo14 che inorigine, come si vede dalla nicchia moderna ricavata nel muro, ospitava pre-sumibilmente la figura stante del santo eponimo dipinta o forse scolpita. Unadelle scene, quella che illustra la Processione dell’icona di San Ludovico aMarsiglia (fig. 2 ), mostra una tavola cuspidata con l’ancora visibile aggetto
48
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
13 I. CARLETTINI, Le storie di San Ludovico di Tolosa nella chiesa di San Francesco a Sulmona, inL’Abruzzo in età angioina. Arte di frontiera tra Medioevo e Rinascimento, Atti del convegno (Chieti2004), a cura di D. Benati, A. Tomei, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2005, pp. 107-123; S.PAONE, Il Trecento angioino: la via degli Abruzzi e i rapporti con Napoli capitale, in S. PAONE, A. TOMEI,La pittura medievale nell’Abruzzo aquilano, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2010, pp. 71-109:83-87 (con bibliografia precedente).
14 Sui finti polittici si veda da ultimo A. DE MARCHI, La tavola d’altare, in Storia delle arti inToscana cit., pp. 15-44: 41-43 e M. BACCI, La nuova iconografia religiosa cit., pp. 167-168.
Fig. 2: Sulmona, San Francesco della Scarpa,Storie di San Ludovico di Tolosa, La processionedell’icona del santo a Marsiglia, particolare.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 48
della figura del santo, forse scolpitacome confermerebbe il cordone del saiotaumaturgicamente stretto dalla fedele.L’immagine testimonia l’esistenza di ungenere diffuso nel Trecento, quello del-l’icona a rilievo, come la cosiddettaMadonna dei Bimbi di Cigoli15, datataintorno al 1330, il cui basso rilievoinduce a leggervi la derivazione o il rife-rimento ad un esemplare pittorico forserealmente esistito.
L’Abruzzo, in particolare aquilano,ricchissimo di manufatti lignei, conser-va alcuni straordinari esempi di questemacchine plastico-pittoriche, integre osmembrate, che la critica ha riunito subase essenzialmente stilistica, anche inrelazione alle pitture degli sportelli late-rali in alcuni casi rinvenute. Si tratta ditre Madonne regine con il Bambino introno, quella della parrocchiale diScurcola Marsicana (fig. 3), ma prove-niente dalla distrutta chiesa di SantaMaria della Vittoria nella stessa localitàe quelle in origine nelle chiese di SantaMaria ad Cryptas a Fossa (fig. 4) e di SanSilvestro a L’Aquila (fig. 5), conservatepresso il Museo Nazionale d’Abruzzodello stesso capoluogo; una SantaCaterina (fig. 6) e una Santa Balbina(fig. 18), anch’esse nello stesso museo ecollocate in origine rispettivamente laprima, nella chiesa di Santa Caterinadelle Mura a L’Aquila e la seconda inquella di San Michele Arcangelo aPizzoli (San Vittorino). E ancora la
49
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
15 M. BACCI, Le sculture lignee nel folklore religioso: alcune considerazioni, in Scultura lignea. Lucca1200-1245, catalogo della mostra (Lucca 1995-1996), a cura di C. Baracchini, I, Firenze, Studio perEdizioni Scelte, 1995, pp. 31-41: 32.
Fig. 3: Scurcola Marsicana, parrocchiale(da Scurcola Marsicana, Santa Maria dellaVittoria), Madonna con il Bambino.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 49
Madonna con il Bambino della chiesa di San Berardo a Pescina, ora in quelladi Santa Maria delle Grazie (fig. 10), la Madonna con il Bambino del Museodi Rieti, ma proveniente da Torano, la Santa Giusta dell’omonima chiesa diBazzano (fig. 19), la Madonna della Natività nella chiesa di Santa MariaAssunta ad Assergi (fig. 20) e infine i davvero problematici San GiovanniEvangelista della Santissima Annunziata di Rocca di Cambio e San MicheleArcangelo della omonima chiesa di Città Sant’Angelo, nel pescarese.
Foto del gruppo di Fossa anteriori al 1979, anno del furto dell’opera, atte-stano l’esistenza della scultura lignea all’interno del tabernacolo, le cui ante late-rali sulla faccia interna erano dipinte con Storie Cristologiche. A seguito del furtole tempere sono state smembrate e disperse nel mercato antiquario; successiva-
50
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
Fig. 4: Già Fossa, SantaMaria ad Cryptas, Madonnacon il Bambino e Storie cri-stologiche.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 50
mente sono stati recuperati la sculturaaddossata alla tavola posteriore, muni-ta di cuspide raffigurante il Redentore ela Presentazione al Tempio dell’origina-ria anta sinistra, entrambe al MuseoNazionale d’Abruzzo (figg. 4, 13).
Anche le due tavole con Storie diSanta Caterina (figg. 6, 14), general-mente accostate alla scultura lignearaffigurante la santa, sono state rico-nosciute come le ante dell’originariotabernacolo che la conteneva16, cosìcome dotata di tabernacolo era laMadonna di Scurcola (fig. 3), realiz-zata per la celebre fondazione cister-cense di Santa Maria della Vittoria.Questa era inserita all’interno di untabernacolo cinquecentesco, conStorie cristologiche dipinte sugli spor-telli17, che verosimilmente ricalcavaquello originario perduto come testi-monia anche il fondo dipinto con igigli angioini, mentre sulla sculturadi Pescina si vedono ancora gliocchielli di metallo all’altezza deltrono e il dossale resecato18.
Tutte le sculture del gruppo, adesclusione del San Michele di CittàSant’Angelo, mostrano alcune caratte-
ristiche tecniche comuni. Innanzitutto lo svuotamento della parte posteriore,solitamente spiegato, come per tantissimi altri manufatti di aree e periodi diver-si, con la necessità di rendere più leggero il pezzo per il trasporto e la mobilita-
51
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
16 La scultura raffigurante Santa Caterina faceva parte della collezione Rivera, ma già Moretti ipo-tizzava una sua originaria collocazione nella chiesa aquilana di Santa Caterina delle mura dalla qualeprovengono le due tavole con Storie di Santa Caterina probabili sportelli del tabernacolo che racchiu-deva la scultura. M. MORETTI, Museo Nazionale d’Abruzzo nel Castello cinquecentesco dell’Aquila,L’Aquila, Japadre, 1968, p. 26.
17 Sul tabernacolo cinquecentesco si veda Archittettura e Arte nella Marsica, catalogo della mostra(L’Aquila 1987), II, L’Aquila, Japadre, 1987, pp. 138-149.
18 Elementi emersi nel restauro del 1985, Ivi, pp. 122-124.
Fig. 5: L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo(da L’Aquila, San Silvestro), Madonna con ilBambino.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 51
zione cultuali. Questo svuotamento significa necessariamente che esse eranoaddossate ad una tavola di fondo, non sappiamo se facente parte di una strut-tura fissa o effimera. A questo elemento si associa anche un caratteristicoaggetto poco pronunciato dell’intaglio, un certo evidente verticalismo19, cheha come corollario un contenimento della larghezza della metà inferiore dellafigura seduta della Madonna in trono.
In particolare quelle di Scurcola, di San Silvestro e di Fossa, nonché le ver-sioni più corsive rappresentate dalle Madonne di Pescina e di Rieti20, mostra-
52
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
19 Le misure delle sculture del gruppo sono: Santa Caterina, cm 138; Madonna di San Silvestro,cm 153; quella di Fossa 225 x 78 x 50.
20 Sulla Madonna di Pescina (cm. 135 x 35 x 24) G. PREVITALI, Studi sulla scultura gotica in Italia:storia e geografia, Torino, Einaudi, 1991, p. 11; E. CARLI, Arte in Abruzzo, Milano, Electa, 1998, p.53ss; R. MANCINI, in Architettura e Arte cit., II, pp. 122-124. Su quella del Museo di Rieti (cm 133x20x 35) ma in origine nella parrocchiale di Torano, al confine tra il Cigolano e la Marsica, si vedano icontributi di Luisa Mortari che definiva il pezzo di scuola abruzzese degli inizi del XIV secolo: L.
Fig. 6: L’Aquila, MuseoNazionale d’Abruzzo (daL’Aquila, Santa Caterinadelle mura), Santa Caterinad’Alessandria e Storie dellasua vita.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 52
no di essere assise su un trono ricava-to dallo stesso tronco. Esso appareparzialmente coperto dalla veste ed èassolutamente pensato in rapporto alsuo completamento in pittura; ciò èparticolarmente evidente quando siosservi il rapporto tra trono scolpitoe trono dipinto nel gruppo di Fossa(fig. 7). Il legame inscindibile trasuperficie pittorica e struttura deltabernacolo è ancor più sottolineatonella Madonna di San Silvestro la cuischiena è tagliata di netto, piuttostoche scolpita, fino a causare un evi-dente deformazione del braccio edella mano appoggiata sulla spalladel Bambino.
Un tabernacolo quindi che man-tiene sicuramente la funzione di con-tenitore ma che non ha alcuna neces-sità di essere ‘profondo’ e che forse faparte di una tipologia ben precisadiffusa nell’aquilano e che noi
moderni siamo portati ad interpretare come una sorta di gioco intellettualetra generi diversi ovvero tra contenitori e contenuti. Da questo punto di vistadunque la scultura lignea in sé - intendo l’oggetto tridimensionale - travali-ca in un certo senso la propria natura materiale, inserendosi in un contestoben più articolato in cui pieni e vuoti dialogano dando vita ad un meccani-smo nuovo ed originale. Quanto originale esso sia è questione critica ancoraaperta.
Queste sculture potrebbero essere frutto dell’evoluzione della statuarialignea di età romanica e recare in sé il corredo genetico della tradizione loca-le nell’ambito della quale troviamo anche, tra i primi esemplari con taberna-colo, il San Pellegrino in origine nell’oratorio omonimo di Bominaco.21
53
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
MORTARI, Opere d’arte in Sabina dal XI al XVII secolo, Roma, De Luca, 1957 pp. 69-70, fig. 59; MuseoCivico di Rieti: dal Medieovo al XX secolo, a cura di L. Mortari, Roma, De Luca, 1960, p. 47; ID., Rieti,in La Sabina medievale, a cura di M. Righetti Tosti-Croce, Cinisello Balsamo, Silvane Editoriale, 1985,pp. 104-155: 142.
21 Il San Pellegrino di Bominaco (L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo) è stato restaurato daElisabetta Sonnino.
Fig. 7: L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo(da Fossa, Santa Maria ad Cryptas), Madonnacon il Bambino, particolare.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 53
Al contrario, questa tipologia potrebbe essere il risultato della diffusionedi più moderne tendenze che da Sud o da Nord portavano nei territori abruz-zesi le nuove cadenze del gotico e con esso nuovi manufatti e generi. Chequeste sculture, tutte, abbondino di elementi goticizzanti, che si ispirano omeglio derivano da manufatti e modelli francesi circolanti sul territorio,appare ormai acclarato dal trattamento linearistico del panneggio, dalla faciescortese e aulica dell’impostazione, fin anche dal trattamento fisiognomicosolitamente accostato ai citatissimi avori francesi con i quali però i confron-ti appaiono comunque generici (figg. 8-10).
Il dibattito critico è costituito dalle voci di autorevoli studiosi che, comesi è soliti dire, pioneristicamente hanno per primi studiato queste sculturefornendone letture stilistiche ancor oggi molto condivise. Da un lato la ‘lineanapoletana’ che ha portato Causa e Bologna nel 195022 ad inserire in questocontesto alcuni pezzi campani, la Madonna giacente del Museo di SanMartino a Napoli e la Madonna con il Bambino del santuario di Pugliano
54
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
22 Sculture lignee della Campania, catalogo della mostra (Napoli 1950), a cura di F. Bologna, R.Causa, Napoli, Stabilimento Tipografico Montanino, 1950, pp. 76-77, 89-90.
Fig. 9: L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo(da Fossa, Santa Maria ad Cryptas), Madonnacon il Bambino, particolare.
Fig. 8: Scurcola Marsicana, parrocchiale (daScurcola Marsicana, Santa Maria della Vittoria),Madonna con il Bambino, particolare.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 54
(fig. 11). Dall’altra, ‘la linea umbra’che ha ricevuto maggiori consensidopo i contributi di Previtali il qualeincludeva la Madonna con ilBambino del Duomo di Spoleto (fig.12) ritenendola la prima voce, l’ori-gine, dell’intero gruppo e facendodipende da questa le sculture aquila-ne che attribuiva ad un anonimoscultore umbro denominato Maestrodella Madonna del Duomo diSpoleto23. Il catalogo di questo sculto-re, generalmente confermato daglistudiosi successivi24, anche sotto l’eti-chetta di bottega, ha acquisito altrevoci come il celebre gruppo delPresepe di Tolentino25. Enzo Carliinvece diversificava la penetrazionein Abruzzo di elementi del goticod’Oltralpe, da Sud attraverso laNapoli angioina con particolare rife-
55
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
23 G. PREVITALI, Sulle tracce di una scultura umbra del Trecento, in «Paragone», 181, 1965, pp. 16-25; ID., Un’ipotesi italiana per le due Sant’Agnese di Fenway Court, in «Fenway Cort, Isabella StewartGardner Museum», 1976, pp. 36-41; ID. Tra Spoleto e L’Aquila: il ‘Maestro della Madonna del Duomodi Spoleto’ e quello ‘del Crocifisso di Visso’, in «Prospettiva», 44, 1986, pp. 9-15; ristampati in ID., Studisulla scultura gotica cit., pp. 5-11, 40-44, 73-82.
24 F. ACETO, Pittura e scultura dal tardo-antico al Trecento, in Storia del Mezzogiorno: storia di Napoli,del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, XI Aspetti e problemi del Medioevo e dell’età moderna, Napoli,Edizioni del Sole, 1993, pp. 299-366: 362. E. LUNGHI, La scultura trecentesca della Madonna colBambino, in La cappella delle reliquie. Una sacrestia cinquecentesca nel Duomo di Spoleto, a cura di G.Benazzi, Assisi, Editrice Minerva, 1994, pp. 38-41; C. FRATINI, Per un riesame della Pittura Trecentescae Quattrocentesca nell’Umbria meridioanale, in Piermatteo d’Amelia. Pittura in Umbria meridionale fra‘300 e ‘500, Todi, Ediart, 1996, pp. 285-375: 291, 297-300; F. ABBATE, Storia dell’Arte nell’ItaliaMeridionale, II, Il Sud angioino e aragonese, Roma, Progetto Donzelli, 1998, pp. 76-77; C. TROPEA, LaMadonna di San Silvestro nel Museo Nazionale d’Abruzzo, in Abruzzo: giubileo tra fede e arte, Lanciano,Itinerari, 1999, pp. 121-163: 138-139; P. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Trecento nell’Abruzzo terama-no: appendice, in Teramo e la valle del Tordino, Teramo, Fondazione della Cassa di Risparmio di Teramo,2006, (Documenti dell’Abruzzo Teramano, I, 7) pp. 440-453: 446-447.
25 E. NERI LUSANNA, Il gruppo ligneo della natività di San Nicola a Tolentino e la scultura marchigia-na, in Arte e spiritualità negli Ordini Mendicanti: gli Agostiniani e il Cappellone di San Nicola a Tolentino,Atti del convegno (Tolentino 1991), Roma, Àrgos, 1992, pp. 105-124. La studiosa attribuisce dubitati-vamente il gruppo di Tolentino al Maestro della Madonna di Spoleto sottolineando però le profonde dif-ferenze tra le sculture marchigiane e quelle umbro-abruzzesi. L’accostamento più stringente sarebbe con
Fig. 10: Pescina, Santa Maria delle Grazie(da Pescina, San Berardo), Madonna con ilBambino, particolare
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 55
rimento alle opere di Tino di Camaino la cui influenza vedeva anche nelleMadonne di San Silvestro e di Scurcola Marsicana e da Nord, attraversol’Umbria, ovvero con la mediazione del cantiere del Duomo di Orvieto peropere come la Santa Balbina di Pizzoli26.
Più difficile, ammetto forse per me impensabile, è stabilire debiti e credi-ti e scalare nel tempo questi manufatti distanziandoli l’uno dall’altro di diecio venti anni come parte della critica ha già inteso fare. Le affinità stilistichesono infatti molto significative, ma altrettanto significativi sono gli elementiche allontanano dai prodotti aquilani in esame sia la Madonna di Pugliano(fig. 11) sia quella di Spoleto (fig. 12).
Il volto della Madonna spoletina è molto simile a quello delle Madonnedi Scurcola Marsicana e soprattutto di San Silvestro e di Fossa27, così come irispettivi Bambini per impostazione e tratti fisionomici. Ben diverso è inve-ce il panneggio. Quello della Madonna di Scurcola (fig. 3) ha un andamen-to che isola il pezzo e che di certo non si ritrova nella Madonna di Spoleto eneanche in quelle aquilane le quali, però, come quella di Scurcola, manten-gono identico verticalismo. La scultura umbra mostra un trattamento piùplastico e classico e la sua struttura complessiva prevede uno sviluppo stero-metrico in orizzontale estraneo ai manufatti aquilani. Su un piano più stret-tamente tecnico a distinguerla è il maggiore spessore del pezzo, benchécomunque poco aggettante e sicuramente in origine anch’esso racchiuso inun tabernacolo, nonchè la rifinitura della testa anche nella parte posteriore28.
Più recentemente Alessandro Tomei ha dedicato un contributo specificoalla Madonna di Scurcola Marsicana il cui trattamento caratteristico del pan-neggio è stato interpretato come indice di maggiore antichità del manufatto,ancorabile alla fine del Duecento, da imputare ad uno scultore francese o ad
56
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
la sola Madonna di Scurcola Marsicana, ipotesi decisamente negata da A. TOMEI, Materia e colore nellascultura lignea medievale, in Scultura lignea. Per una Storia dei sistemi costruttivi e decorativi, Atti del con-vegno (Serra San Quirico-Pergola 2007), a cura di G.B. Fidanza, in corso di stampa.
26 E. CARLI, Per la scultura lignea del trecento in Abruzzo, estr. da «L’Arte», a. III, f. VI, XIX, 1941,rist. in ID., Arte in Abruzzo cit., pp. 50-59; ID., La scultura lignea italiana dal XII al XVI secolo, Milano,Electa, 1960, pp. 44-46; ID., Per il “Maestro della Santa Caterina Gualino”, estr. da Studi in onore diGiulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica editrice 1984, rist. in ID., Arte in Abruzzo cit., pp. 65-70; ID.,La scultura lignea, in «Abruzzo», I, 1998-2000, pp. 307-325: Ma già M. GABBRIELLI, Plastica ligneaabruzzese, in «Rassegna marchigiana», XI, 1933, pp. 114-123 riteneva la Madonna di San Silvestro diprovenienza napoletana, anche se di ambito tinesco; riferimento ripreso anche da M. MORETTI, MuseoNazionale cit., p. 17; O. LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen und Molise: Kunst und Geschichte, München,Prestel, 1983, p. 358.
27 Alle quali va accostata sicuramente la Madonna con il Bambino in collezione privata fiorentinapubblicata da G. PREVITALI, Studi sulla scultura cit., fig. 28.
28 Il pezzo è alto 153 cm. Cfr. E. LUNGHI, La scultura trecentesca, p. 38.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 56
uno locale in stretto contatto con le maestranze oltremontane del cantierecistercense dell’Abbazia di Santa Maria della Vittoria, consacrata nel 127829.
Come si sa a seguito della Battaglia dei Piani Palentini del 1268 commit-tenti, feudalità e sicuramente opere francesi circolano in grande abbondanzasul territorio, anche abruzzese. E l’ipotesi che la Madonna di Scurcola possaessere assunta come il modello di riferimento per gli altri pezzi aquilani èmolto seducente, ma è altrettanto probabile che anch’essa faccia riferimentoad un modello più autenticamente francese e che ne costituisca una sua riela-borazione, probabilmente la più antica del gruppo entro il primo decenniodel Trecento.
57
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
29 A. TOMEI, Materia e colore cit, in corso di stampa.
Fig. 11: Pugliano, Santa Maria, Madonnacon il Bambino.
Fig. 12: Spoleto, duomo, Madonna con ilBambino.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 57
Non appaiono stringenti i rapporti con la Madonna di Pugliano (fig. 11)soprattutto se vogliamo ritenerla l’origine del gruppo30 solo perché Puglianoè più vicina a Napoli di quanto non lo sia L’Aquila. Il pezzo campano, puressendo caratterizzato da inconfutabili elementi francesizzanti, appare bendiverso dai manufatti aquilani, in primis per il possente busto della figura, ilvolto pieno e tondo della stessa e per la posa del Bambino, in piedi privo dellacaratteristica torsione del busto, quindi per il trattamento del panneggio.Questo è infatti costituito dalle pieghe corpose del manto che si addensanoformando un vuoto tra le ginocchia e che aggettano dalle stesse scendendodritte; anche il bel motivo del lembo che dalla spalla scende morbido a for-mare una conca d’ombra ha un valore ‘spaziale’ che non notiamo nell’analo-go motivo della Madonna di San Silvestro (fig. 5), certamente più piatto e lacui visibilità è resa in termini quasi esclusivamente pittorici attraverso il verdescuro adottato per rendere la stoffa interna del manto dorato all’esterno.
Le importanti ricerche di Previtali sulla statuaria lignea umbra seguonoalmeno in parte la traccia fornita da Longhi il quale, negli anni Cinquantadel Novecento, individuando i caratteri specifici della pittura medievale dellaregione, inglobava in essa anche alcuni episodi abruzzesi. Le nuove indivi-dualità di pittori umbri scoperte dallo studioso, il Maestro del Crocifissod’Argento, il Maestro di Fossa ed altri, venivano strettamente ancorate allacultura figurativa del territorio di appartenenza la cui appendice si veniva atrovare, senza soluzione di continuità, in quello abruzzese31.
L’aggiustamento critico di questi corpora non può essere affrontato in que-sta sede, ma nell’ambito di questa ricerca è stato necessario ripensare alleopere citate da Longhi e presenti sul territorio abruzzese o da esso prove-nienti. Un lavoro che in realtà è cominciato anni fa, quelli nei quali è statopossibile realizzare un censimento delle opere pittoriche dell’attuale territo-rio aquilano32. Un territorio mai indagato sistematicamente a fronte della
58
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
30 Sculture lignee della Campania cit., pp. 76-77. Causa ritiene che il gruppo abruzzese dipendadalla Madonna di Pugliano; F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, e un riesa-me dell’arte nell’eta fridericiana Roma, U. Bozzi, 1969, p. 283, nota 49 pensa che la Madonna diPugliano dipenda da quelle abruzzesi di Scurcola, San Silvestro, Fossa e Spoleto per le quali abbraccial’ipotesi umbra di Previtali. Secondo P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze,Cantini, 1986, pp. 162-163 e nota 70, il gruppo si legge come dipendenza da Napoli; Sulla Madonnadi Pugliano e il recente restauro E. FERRARO, La scultura della Madonna di Pugliano. La storia artisticadell’opera, in La Madonna di Pugliano, Il restauro e il santuario, Castellamare di Stabia, Longobardi,2007, pp. 11-15 (con bibliografia precedente).
31 R. LONGHI, La pittura umbra della prima metà del Trecento nelle dispense redatte da M. Gregori,Firenze, Sansoni, 1973.
32S. PAONE, L’Aquila magnifica citade. Pittura gotica e tardogotica a L’Aquila e nel suo territorio,Roma, Campisano Editore, 2009 e S. PAONE, A. TOMEI, La pittura medievale, cit.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 58
conoscenza di alcuni monumenti-cardine del Duecento, i complessi dell’ora-torio di San Pellegrino a Bominaco e di Santa Maria ad Cryptas a Fossa e dipoche opere di primo Trecento, tra le quali figurano anche le tavole dipintedei tabernacoli di Fossa, di Rocca di Cambio e dell’Aquila.
Il rivestimento pittorico della scultura lignea, come si sa, è inscindibiledalla parte scolpita per la natura stessa del manufatto soggetto a processi diantropomorfizzazione e di movimentazione cultuale; ma è soprattutto nelbasso Medioevo che la policromia assume un ruolo decisivo lasciando ipotiz-zare l’intervento di un pittore distinto dallo scultore. Questo intervento èdocumentato in molti casi che mettono in evidenza anche la scelta di servirsidi un maestro ben qualificato se non famoso, in altri è invece lecito supporreche si tratti di una vera e propria collaborazione tra intagliatore e pittore33. Sitratta di un argomento che va oltre la più semplice questione del rapporto trascultura lignea e policromia andando a toccare il tema ben più ampio dellerelazioni stilistiche e tecniche tra scultura lignea, anzi scultura tout-court epittura34. La strada più spesso percorsa è quella del confronto stilistico trascultura lignea e coeva pittura, metodo sempre foriero di risultati, ma insi-dioso e a volte ingannevole, che permette di creare delle utili griglie di riferi-mento per barcamenarsi nel buio in cui sono avvolte le sculture lignee.
Lo studio dei nostri tabernacoli aquilani reca in sé queste problematicheche potrebbero condurre, come suggerito da Bologna, a riconoscere l’indivi-dualità di una sola personalità di scultore e pittore35. A complicare l’indagi-
59
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
33 Si vedano le riflessioni, anche sui procedimenti tecnici, di C. FRATINI, Nuove acquisizioni per lascultura “umbra” trecentesca, in Scultura e arredo in legno fra Marche e Umbria, Atti del convegno(Pergola 1997), a cura di G.B. Fidanza, Ponte San Giovanni, Quattroemme, 1999, pp. 43-56: 43-44.Sempre controversa è l’interpretazione delle iscrizioni e firme doppie sulle opere d’arte, a riguardo siveda Le opere e i nomi : prospettive sulla “firma” medievale; in margine ai lavori per il Corpus delle operefirmate del medioevo italiano, a cura di M.M. Donato, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2000.In particolare per la statuaria lignea suggestiva è l’ipotesi di Tomei il quale suggerisce che i due nomiattestati dalla problematica iscrizione sulla Madonna delle Concanelle di Bugnara (si veda ancora ilcontributo di G. Curzi in questi atti) siano quelli dell’intagliatore e del pittore. Cfr. A. TOMEI, Materiae colore cit., in corso di stampa. Anche M. MASSA, Scultura lignea e cultura figurativa: spunti di riflessio-ne, in Scultura e arredo cit, pp. 33-42: 33-34 propone la stessa chiave di lettura per l’iscrizione delCrocifisso della chiesa di San Salvatore di Arquata del Tronto.
34 Sulla questione e per l’ambito abruzzese S. PAONE, Pittura e scultura lignea: da trittico di AlbaFucens a Giovanni da Sulmona, in S. PAONE, A. TOMEI, La pittura medievale cit., pp. 153-165.
35 La proposta è di F. BOLOGNA, Per una storia delle arti medievali e moderne nel Mezzogiorno con-tinentale, in Storia del Mezzogiorno, XI Aspetti e problemi cit.., pp. 219-242: 231; condivisa tra gli altrida C. TROPEA, Statua di San Michele Arcangelo; coppia di sportelli con i Santi Bartolomeo, Quirico eGiulitta. Chiesa di San Michele Arcangelo, Città Sant’Angelo, in Dalla valle del Piomba alla valle del bassoPescara, Pescara, Carsa, 2001, (Documenti dell’Abruzzo Teramano, V, 1), pp. 299-305, C. FRATINI, Perun riesame della pittura trecentesca e quattrocentesca nell’Umbria meridionale, in Piermatteo d’Amelia cit.,pp. 290-291 e P. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Trecento cit., pp. 446.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 59
ne sulle sculture lignee ‘francesizzanti’ dell’aquilano è sopraggiunto infatti iltentativo di collocare stilisticamente anche i dipinti degli sportelli ascriven-doli all’ambito culturale umbro, secondo l’inquadramento longhiano maimesso in discussione dalla critica successiva36.
L’analisi approfondita delle persistenze figurative nel territorio aquilano,consente oggi di ridimensionare l’ipotesi secondo la quale l’introduzione dielementi gotici sia avvenuta attraverso l’intermediazione dell’Umbria; nume-rosi esempi dichiarano infatti un rapporto significativo con la Napoli angioi-na, in termini più strettamente stilistici e anche di committenza. Le pitturedei tabernacoli (figg. 13-14) appaiono intrise di una cultura decisamente
60
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
36 R. LONGHI, La piitura umbra cit. Sulla bibliografia successiva e la storia critica delle tavole dipin-te dei tabernacoli aquilani si veda S. PAONE, L’Aquila magnifica citade cit., pp. 29-38.
Fig. 13: L’Aquila, MuseoNazionale d’Abruzzo (giàFossa, Santa Maria adCryptas), Crocifissione.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 60
dipendente da Napoli e dai suoiprincipali monumenti e maestranze,come già Toesca notava definendoledi ‘scuola napoletana’.37
Il riferimento ai decenni centralidel Trecento è invece da confermare,anche se, come si diceva, è difficilescalare le sculture del gruppo. Ladistrutta chiesa di Santa Caterinadelle Mura, dalla quale proviene iltabernacolo con la santa eponima,risale a prima del 1335 quando in unatto si menziona esplicitamente ilmonastero come già esistente e fon-dato da Gemma della famigliaPretatti38. Anche la collocazione cro-nologica del tabernacolo di Fossaintorno alla metà del XIV secolocontinua ad essere la più plausibile. Inoti affreschi duecenteschi che cam-peggiano sulle pareti della chiesa diSanta Maria ad Cryptas sono total-mente perduti sulla parete sinistra,probabilmente a causa del terremotodel 1349. Le trecentesce Storie dellaVergine39 che vi sono state realizzateappaiono significative per il legame
fisico - reale - con il tabernacolo che in origine si trovava nell’edificio e anchein termini di linguaggio, rivelando un altro importante tassello della pitturaaquilana del tempo, in contiguità con i dipinti dei tabernacoli anche se al dilà di confronti stilistici stretti.
Altre tavole sono coinvolte in questo nodo stilistico in primis quelle giàpubblicate da Todini che le riferiva al Maestro del Crocifisso d’argento e chepiù recentemente Tropea ha riconosciuto come le ante laterali di un taberna-
61
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
37 P. TOESCA, Storia dell’Arte italiana, II, Il Trecento, Torino, Einaudi, 1951, p. 378. Per il dettagliodei confronti stilistici tra le pitture dei tabernacoli e la coeva pittura e miniatura napoletane si veda S.PAONE, L’Aquila magnifica citade cit., pp. 29-38 e ID., Il Trecento angioino: la via degli Abruzzi e i rap-porti con Napoli capitale, in S. PAONE, A. TOMEI, La pittura cit., pp. 71-82 (con bibliografia precedente)
38 Ibidem, pp. 71, 73 e nota 10.39 Ibidem, pp. 77-83.
Fig. 14: L’Aquila, Museo Nazionaled’Abruzzo (da L’Aquila, Santa Caterina dellemura), Il martirio dei filosofi convertiti.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 61
colo, con annessa scultura lignea,nella chiesa della SantissimaAnnunziata a Rocca di Cambio gra-zie al ritrovamento di una vecchiacartolina40. Le tempere, raffigurantibusti di profeti e santi stanti (fig. 15),mostrano stringenti affinità stilisti-che con alcune delle opere general-mente ritenute dello stesso anonimoumbro, ovvero i quattro pannellidivisi tra il Museo Fesch di Ajaccio ela Fondazione Cini di Venezia (fig.16) e due opere di accertata prove-nienza aquilana: un trittico con unbassorilievo in argento sbalzato alcentro, già pubblicato da Longhi eun polittico (fig. 17) reso noto daZeri che lo riferiva a Bitino daFaenza41.
Che si tratti dello stesso maestrotrecentesco lo confermano gli strin-genti confronti tra le figure perimpostazione, volumetria, tratta-mento fisionomico e dei contorni.Ma il dato comune interessantissimoè anche tecnico rappresentato daifondi punzonati e dal raffinato gustodegli ornati nelle tavole di Rocca di
Cambio in stretta analogia con la tecnica delle tempere Fesch e Cini, per lequali i riferimenti proposti in passato oscillano dalla citazione delle soluzio-ni assisiati, per le inquadrature architettoniche con gli archetti trilobi, a piùstretti riferimenti all’arte francese.
Proprio il tabernacolo di Rocca di Cambio ha indotto a inserire nel grup-po di sculture lignee in esame anche il santo che vi si trovava all’interno e cheun restauro recente42 ha rivelato essere l’effigie di una figura imberbe con
62
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
Fig. 15: Già Firenze, collezione privata (daRocca di Cambio, Santissima Annunziata),San Paolo, particolare.
40 C. TROPEA, Statua di San Michele Arcangelo cit., pp. 304-305. 41 Su queste tavole e la bibliografia pregressa si veda S. PAONE, L’Aquila magnifica citade cit., pp.
35-38.42 La scultura è stata restaurata da Pietro Scandurra nel 2000.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 62
libro, forse San Giovanni Evangelista, camuffato da Santa Lucia43. Non aven-do potuto visionare il pezzo non dispongo di elementi attendibili per poter-ne discutere in modo approfondito anche se dubito fortemente che lo sipossa accostare alle Madonne francesizzanti di Fossa e L’Aquila44. È infattiprobabile che la scultura e il tabernacolo siano stati assemblati successiva-mente: nella cartolina si vede che la scultura aggetta dal contenitore e ciò nonsembra dovuto esclusivamente al basamento su cui poggia, sicuramenteaggiunto in epoca successiva. La figura, pur essendo segnata da uno spessoreridotto e da un impostazione frontale, comune ai pezzi aquilani esaminati,appare caratterizzata da pieghe ben più corpose di quelle delle Madonne esante aquilane.
63
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
43 C. TROPEA, Statua di San Michele Arcangelo cit., 304-305. 44 Ibidem, pp. 299-305.
Fig. 16: Venezia,Fondazione Cini,Santi GiovanniEvangelista, Pietromartire, Nicola (?),particolare.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 63
Il San Michele Arcangelo della collegiata di Città Sant’Angelo, un’operadi straordinaria qualità, è stato accostato a due tavole dipinte raffiguranti iSanti Bartolomeo, Quirico e Giulitta del Museo Nazionale d’Abruzzo, pro-venienti dalla stessa collegiata, riconosciute come le ante del tabernacolo ori-ginale che conteneva la scultura45.
Al di là di ragionevoli dubbi sull’identificazione dei soggetti e della man-canza di prove a sostegno dell’accostamento tra i dipinti e la scultura lignea,anche per ragioni tecniche determinate dalla rifilatura delle tavole, questaproposta difficilmente può essere condivisa sul piano critico quando si avan-
64
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
Fig. 17: già L’Aquila, collezione privata, polittico.
45Ibidem, p. 304; e M. ANDALORO, Connessioni artistiche fra Umbria meridionale e Abruzzo nelTrecento, in Dall’Albornoz all’età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa nell’Umbria meridionale, Atti delConvegno di Studi (Amelia 1987), Todi, Ediart, 1990, pp. 305-346: 309. Carli pensa alla stessa corren-te: E. CARLI, Arte in Abruzzo cit., p. 70; esclude che si tratti del Maestro di Fossa, ma conferma l’ambitoumbro-spoletino e una cronologia intorno alla metà del Trecento M.T. TANCREDI, scheda, in L’Arte sve-lata. Le opere restaurate dalla Fondazione Pescarabruzzo, Pescara, Edizione Tracce, 2007, pp. 183-186.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 64
zi il nome del Maestro di Fossa sia come artefice delle tavole e della scultura,sia come autore dell’una o dell’altra46.
I pannelli dipinti sono più ragionevolmente collocabili nell’ambito dellatemperie tardogotica47, mentre davvero improponibile è il riferimento algruppo di sculture lignee in oggetto innanzitutto per questioni cronologiche.Numerosi elementi del San Michele infatti sono meglio contestualizzabili nelsecondo Trecento48, se non ai primi del secolo successivo, dall’impostazionedella figura alla ricchissima decorazione della corazza, dal trattamento dei ric-cioli della capigliatura alla resa delle ali, finanche quelle del drago quasi car-nevalesco.
Il restauro del 200049 ha fugato ogni dubbio, a riprova di quanto i detta-gli tecnici siano fondamentali per lo studio della statuaria lignea. La scultu-ra in origine difficilmente poteva essere ospitata all’interno di un tabernaco-lo essendo rifinita in ogni sua parte, come confermano la parte posteriore,anche quella del drago, con il bel motivo scolpito a squame di pesce del copri-capo del santo al di sotto del’elmo moderno. Il pezzo doveva occupare unospazio maggiore come si ricava dall’osservazione dell’impugnatura della lanciamoderna troppo corta e dal taglio della coda del drago, modifiche di elemen-ti che evidentemente in origine esaltavano lo scatto dinamico della posadell’Arcangelo che uccide il demonio. A ciò si aggiunga il dato tecnico piùsignificativo che, escludendo la possibilità di aggregare il pezzo pescarese aquelli aquilani, si impone su tutti: «la scultura è ritagliata da un tronco d’al-bero fatto a metà in senso verticale, una parte forma il guscio posteriore, l’al-tra quello anteriore. Verso l’alto la forma si strema e al centro è inserita la testa,lavorata separatamente. Lateralmente sono inseriti altri due pezzi, dai quali siprotaggono le braccia. Le gambe sono eseguite separatamente e fissate all’in-terno della gonna»50.
Al contrario, la Santa Balbina di Pizzoli, la Santa Giusta di Bazzano e laMadonna di Assergi, mostrano qualche affinità con il gruppo aquilano.
65
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
46 C. PASQUALETTI, Per la pittura tardogotica ai confini settentrionali del Regno di Napoli: sulle trac-ce del ‘Maestro del Giudizio di Loreto Aprutino. I, in « Prospettiva», 109, 2003, pp. 3-26: 19, 20, 25.
47 L. LORENZI, Scultura lignea e arte orafa al tempo di Ladislao. La ‘via degli Abruzzi’, in Universitates eBaronie. Arte e architettura in Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo, Atti del Convegno (Guardiagrele-Chieti 2006), a cura di P.F. Pistilli, F. Manzari, G. Curzi, Pescara, Edizioni Zip, 2008, pp. 137-148:144-146. Lo studioso pensa ad una dipendenza, della seconda metà del Trecento, dall’opera di NinoPisano.
48 Il restauro è stato condotto da Cornelia Dittmar, Relazione tecnica, in L’Arte svelata cit. pp. 186-189.49 Ibidem, p. 189.50 La scultura è alta 140 cm, O. LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen und Molise cit., passim; E. CARLI,
La scultura lignea cit., p. 46.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 65
La Santa Balbina (fig. 18) della chiesa di San Michele Arcangelo è priva dipolicromia, un elemento che ha reso ancora più evanescente l’esile ed elegan-te figura della santa. Dopo gli accostamenti di Venturi e Carli alle Virtù caria-tidi delle tombe napoletane di Tino di Camaino, più convincentemente èstata affiancata alle sculture in questione51 quanto meno per le caratteristiche
66
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
51 D. CATALANO, Sculture in legno policromo dal territorio molisano: qualche novità e qualche rifles-sione, in L’Abruzzo in età angioina cit., pp. 147-165: 161. La studiosa propone un accostamento tra lascultura bazzanese, la Santa Caterina d’Alessandria dell’Aquila e la Santa Lucia di Castelverrino nelMolise. In verità attribuire alla stessa bottega anche la scultura molisana non è forse possibile, viste lemarcate differenze del panneggio e del trattamento della testa, pur restando valide le affinità tra certimanufatti molisani e la produzione lignea abruzzese. Qualche similarità di impostazione e di panneg-
Fig. 18: L’Aquila,Museo Nazionaled’Abruzzo (da Piz-zoli, San MicheleArcangelo), SantaBalbina.
Fig. 19: Bazzano,Santa Giusta, San-ta Giusta.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 66
tecniche, l’impostazione, l’andamento delle pieghe del panneggio, anche sequesto manufatto sembra mostrare qualche raffinatezza in più nel modellatoe nel volto affilato. Il trattamento del panneggio a pieghe sottili ricorda anchela Santa Giusta di Bazzano (fig. 19), un pezzo meno raffinato ma che puremostra tangenze con la Santa Caterina dell’Aquila52 e sul quale si è potutorecentemente far luce con un ipotetico riferimento cronologico intorno al1330, anno del ritrovamento delle reliquie della santa e della conseguente affre-scatura delle storie della sua vita sulla parete sinistra della chiesa bazzanese, conla probabile committenza del vescovo aquilano Angelo Acciaiuoli53.
La Madonna puerpera di Assergi (fig. 20), più che probabilmente quantorimane di un gruppo della Natività, è stata oggetto in passato di segnalazio-ni e più recentemente di uno studio specifico per la particolarità del sogget-to, accostato alle Madonne distese di Tolentino e del Museo di San Martinoa Napoli54. I caratteri stilistici francesizzanti sono però più difficili da circo-scrivere e guardano in direzioni diverse con rimandi a prodotti umbri eabruzzesi, aggregati al cosidetto gruppo ‘Gualino’ o molisani come laMadonna della Libera di Cercemaggiore55. Da questi riferimenti non è pos-sibile escludere le sculture aquilane in esame, sia per la cadenza ritmica delle
67
SMM 1-2/2011
TABERNACOLI DIPINTI E SCULTURA LIGNEA IN ABRUZZO
gio mostra pure la Sant’Agnese (Boston, Isabella and Stewart Gardner Museum) pubblicata da G.PREVITALI, Studi sulla scultura cit., fig. 32, mentre inaccettabile è l’inclusione nel gruppo della Santamartire di ubiazione ignota, ibidem, fig. 30.
52 Sulla scultura e gli affreschi della chiesa di Bazzano si veda S. PAONE, L’aquila magnifica citadecit., pp. 46-47 e ID., Pittura e scultura lignea cit., p. 157.
53 G. CURZI, Statue da palcoscenico: la “Madonna della Natività” di Assergi, in L’Abruzzo in etàangioina cit., pp. 125-145 (con bibliografia precedente).
54 Ibidem.
Fig. 20: Assergi, Santa Maria Assunta, Madonna della Natività, particolare.
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 67
pieghe, che ricordano la Santa Balbina, sia per la policromia. Le oscillazionisono anche cronologiche in quanto la datazione alla fine del XIII secoloappare troppo alta e forse le ascendenze gotiche che caratterizzano anche lastatua assergina sono meglio contestualizzabili nei primi decenni delTrecento.
Ascendenze gotiche che possiamo scegliere di spiegare, ancora una volta,con il prestito o che forse più correttamente vanno lasciate sullo sfondo diuna produzione diffusa nel Regno angioino di Napoli. Regno di Napoli chenon coincide con la sola capitale, ma include geograficamente, politicamen-te e culturalmente anche l’Abruzzo, più specificatamente aquilano.
68
SMM 1-2/2011
STEFANIA PAONE
01 IV Bozza La scultura SMM 1-2011_ III Bozza Alvaro/Città morta 20/10/11 16.45 Pagina 68