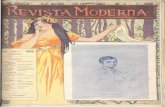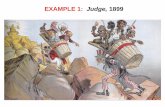L'incanto malefico. L'Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'incanto malefico. L'Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
66
L’incanto malefico.
L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Silvia Mauro
Pistoia è apparsa una città interamente rinnovata: luce elettrica, alberghi, restau-rants, e più ancora per le vie, il movimento di una folla lieta, numerosa, che trae un frutto adeguato del proprio lavoro. E si tratta di una città di 13.000 abitanti!1
Così, sulle colonne romane de «Il don Chisciotte» fu dipinta la città all’indomani dell’inaugurazione dell’Esposizione circondariale per l’industria, la floricoltura e l’or-ticoltura del 1899: una delle più complesse e ambiziose imprese in cui Pistoia e, in particolare, la sua nuova classe imprenditoriale, impegnò le proprie forze migliori sul finire dell’Ottocento; punto di arrivo di manifestazioni espositive analoghe – seppure di portata e tono minore – nelle quali, già a partire dal 1838, avevano fatto bella mostra di sé le manifatture e le opere d’arte della città.Una crescita tanto rapida quanto cospicua, quella della piccola Pistoia, che pure al tempo appariva quotidianamente scossa da violenti scontri e tensioni: la sua classe dirigente, composta sia da esponenti della nobiltà terriera che da una ricca borghe-sia di stampo liberale2 – due fronti contrapposti e spesso inconciliabili – era infatti a tal punto fortemente spaccata e divisa, da minare, con quotidiane e aspre battaglie politiche, la stabilità stessa delle istituzioni amministrative della città.Benché il potere fosse stato infatti, soltanto fino al decennio precedente, saldamen-te in mano alla ristretta oligarchia della nobiltà terriera, i cui illustri rappresentanti si tramandavano da generazioni sia il comando del consiglio comunale che la dirigen-za della locale Cassa di Risparmio, un inesorabile processo di rinnovamento degli equilibri economici e produttivi si era ormai, da tempo, messo in moto in città e, a partire dagli anni Ottanta, un esercito di piccoli imprenditori – fonderie industriali e artistiche, cartiere, officine per la lavorazione della seta e per la produzione di carrozze, di organi, di mattoni e di terrecotte – dediti alla realizzazione di prodotti di alta qualità artistica e artigianale, aveva cominciato ad affacciarsi gradualmente sul proscenio cittadino e a reclamare pertanto spazio e visibilità3.Nonostante le aspre lotte e gli accesi contrasti, la città sembrava tuttavia ormai prossima ad afferrare il benessere economico e tutte le differenti fazioni, che erano solite scontrarsi quotidianamente nell’agorà pubblica, si ritrovarono dunque con-cordi e insolitamente unite di fronte al comune intento proclamato dall’Esposizione: incoraggiare e promuovere la produzione industriale pistoiese, sotto lo sguardo protettivo del nume tutelare Niccolò Puccini, di cui nel 1899 ricorreva per l’appunto il centenario della nascita.Del resto anche le Esposizioni universali, che a partire dalla prima Great Exhibition di Londra del 1851 si erano susseguite da mezzo secolo nell’emisfero occidentale,
1. «Il don Chisciotte di Roma», VII, n. 210, Roma, 1 agosto 1899.2. Nobili e borghesi erano equamente presenti all’interno dei due schieramenti del “partito della città” e “della campagna”.3. Cfr. A. Ottanelli, Gli anni del cambiamento (1878-1914), in Storia di Pistoia. IV. Nell’età delle rivoluzioni 1777-1940, a cura di G. Petracchi, Firenze, Le Monnier 2000, pp. 361-402.
storialocale 67
altro non erano – almeno nelle intenzioni e nei pubblici proclami – che inni alla fra-tellanza, alla concordia e alla cooperazione fra i popoli e le nazioni del mondo. Nate su modello di quelle internazionali, le esposizioni italiane avevano per di più l’ulte-riore scopo di esorcizzare le violente tensioni sociali del giovane Stato, occultando i frequenti scontri che scuotevano le sue tante e diverse anime. Fu questo lo scenario in cui l’Esposizione circondariale del 1899 prese vita a Pisto-ia, accompagnata, esattamente come per le molte altre mostre universali, italiane e internazionali, sia da uno scopo smaccatamente promozionale e propagandisti-co, di natura squisitamente commerciale, che da un preciso intento pedagogico: quello di addestrare e formare una manodopera qualificata ed istruita all’esercizio del bello, seguendo fedelmente, in tal modo, proprio le orme dell’insegnamento pucciniano. «Offrire agli industriali e agli operai il mezzo di formarsi il gusto e lo stile e d’imparare le regole tecniche del loro mestiere»4, aveva predicato al riguardo perfino l’arciduca Ranieri Ferdinando, presidente della Commissione imperiale per l’Esposizione di Vienna del 1873.E a tale imperativo rispondeva anche la Società Utile e Diletto, alla quale Pistoia doveva l’organizzazione della propria ambiziosa Expo di fine secolo, oltre che della precedente mostra industriale del 1886.Istituita nel 1881 per iniziativa di «alcuni industriali pistoiesi che poco prima eransi recati a visitare in comitiva l’Esposizione Nazionale di Milano»5, la Utile e Diletto af-fondava le proprie radici – proprio come il partito dal quale traeva origine, l’Unione Liberale – nel cuore produttivo e pulsante della città, ripromettendosi di
promuovere in Pistoia il progresso industriale, agricolo, manifatturiero, sviluppan-do con letture e conferenze le questioni attinenti ai principî economici ed educa-tivi per l’artigiano ed utili all’incremento professionale, proponendosi di effettuare viaggi a scopo istruttivo, di conferire premi ai migliori artigiani, iniziare ed appog-giare esposizioni locali, e la formazione di società industriali6.
Foriera di continue iniziative e proposte, la nuova classe imprenditoriale era infatti mossa sia dal desiderio di affermare se stessa, quanto dalla volontà di far uscire Pi-stoia dal proprio immobilismo economico e culturale: non a caso, è proprio a questi stessi protagonisti – primo fra tutti, il deputato dell’Unione Liberale Cino Michelozzi – che si deve, in quegli anni, l’introduzione a Pistoia dell’illuminazione elettrica e la costruzione del nuovo palazzo della Cassa di Risparmio di via Francesco Magni, ora via Roma.
4. Citato in P. Colombo, Le Esposizioni Universali. I mestieri d’arte sulla scena del mondo (1851-2010), Vene-zia, Marsilio 2012, p. 19.5. La società Utile-Diletto per gli operai, industriali e professionisti di Pistoia. Brevi notizie, a cura di N. Niccolai, Pistoia, Tip. Niccolai 1899, p. 3.6. L. Bargiacchi, Rendiconto morale-economico della Esposizione circondariale Pistoiese del 1886. Compilato dal Vice-Presidente della Commissione Ordinatrice Luigi Bargiacchi, Pistoia, Tip. Niccolai 1887, p. 3.
68
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Fu così che, con siffatti propositi e dietro tali premesse, già nel 1886, grazie all’im-pegno della Società Utile e Diletto da poco creata, l’Esposizione artistica, industriale ed agricola in Pistoia poté finalmente guadagnare la scena pubblica, «prima vera prova della presa di coscienza del mondo industriale pistoiese»7.«Un’impresa da molti non creduta attuabile, da altri motteggiata, e da non pochi osteggiata»8, i cui «promotori, ed io era fra questi – annotava, non senza amarez-za, il suo vicepresidente Luigi Bargiacchi – furono qualificati per poeti, visionarii e peggio»9.Agli organizzatori, accusati di aver anteposto l’ambizione personale al decoro del paese e addirittura alla sicurezza pubblica, si rimproverava l’inattuabilità dell’im-presa, visto e considerato che anche la precedente Esposizione regionale del 1870, allestita negli spazi della Fortezza Santa Barbara di Pistoia con l’ambizioso intento di non far sostenere alla Toscana un confronto svantaggioso, che la facesse «appa-rire neghittosa al cospetto delle altre consorelle»10, si era poi di fatto chiusa con un vistoso disavanzo economico, a dispetto degli entusiasmi iniziali11.
Mi diedi a tutt’uomo con piena concordia dei miei egregi colleghi tutti zelanti nelle rispettive ingerenze, a procurare che andassero fallite le aspirazioni degli oppositori, che quella impresa tutta di iniziativa privata riuscisse decorosa per la Città, fosse campo a viepiù conoscere e apprezzare la valentìa dei nostri bravi industriali e ma-nifattori, ed insieme a procurare loro il maggiore interesse. Splendida fu la riuscita12,
rivendicava perciò con orgoglio, a conclusione dell’iniziativa, nel settembre del 1886, Luigi Bargiacchi. Senza alcun dubbio un personaggio smaliziato e potente, il vicepresidente dell’E-sposizione – onnipresente com’era in ogni centro nevralgico della Pistoia ottocen-tesca, nonché noto affiliato alla loggia massonica Ferruccio13 –, eppure, cionono-stante, l’organizzazione dell’Esposizione del 1886 non fu cosa da poco nemmeno per lui e – dal trovare sostegno economico, all’ottenere in uso i luoghi e gli spazi
7. A. Ottanelli, Gli anni del cambiamento (1878-1914), cit., p. 377.8. Esposizione Artistica, Industriale ed Agricola del circondario di Pistoia 1886. Notizie, cataloghi e pianta, Pistoia, Tip. Niccolai 1886, p. 6.9. L. Bargiacchi, Rendiconto morale-economico, cit., pp. 5-6.10. Esposizione Regionale Agraria, Industriale e di Belle Arti delle Provincie toscane da tenersi in Pistoia nel 1870. Circolare e regolamento, s.l., s.e. 1870, p. 4.11. L. Bargiacchi, Rendiconto morale-economico, cit., p. 4.12. L. Bargiacchi, La Esposizione circondariale Pistoiese del 1886. Luigi Bargiacchi ed i suoi scritti sulle instituzi-oni e previdenza, Pistoia, Tip. Pia Casa di Patronato 1886, p. 6.13. V. Capponi, Biografia pistoiese o Notizie della vita e delle opere dei pistoiesi illustri, Pistoia, Tip. Rossetti 1878, p. 437; A. Ottanelli, L’associazionismo popolare e le società di mutuo soccorso. Liberali, socialisti e cat-tolici alla prova della solidarietà, in Pistoia nell’Italia unita. Identità cittadina e coscienza nazionale, a cura di A. Cipriani, A. Ottanelli e C. Vivoli, Pistoia, Gli Ori 2012, p. 156; F. Conti, L’associazionismo massonico dall’Unità al fascismo, in Pistoia nell’Italia unita, cit., p. 250.
69
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
prescelti in piazza del Carmine, fino al renderli adeguati allo scopo – l’impresa mo-strò, in nuce, tutti i complessi passaggi e le difficoltà, che in seguito dovettero es-sere analogamente affrontati per la successiva e ancor più complicata realizzazione dell’Esposizione circondariale del 1899. Effettivamente «splendida» fu tuttavia la riuscita, e tra i lavori degni di nota di questa «piccola ma bellissima Esposizione»14 del 1886, Iacopo Piermei, inviato del giornale letterario e politico “Velatri” di Volterra, annoverò senza indugio i dipinti di Giuseppe Ciaranfi, di Ugo Casanuova e di Francesco Bartolini, le realizzazioni in ferro battuto e ghisa della ditta Michelucci – «una delle cose più ammirabili della esposizione»15, seppure fuori concorso vista la fama già raggiunta dalla fonderia –, i prodotti degli ebanisti intagliatori Angiolo Chiti, Emidio Arcangioli e Benedetto Romagnani, i lavori in bronzo di Emilio Rafanelli e della fonderia Conversini e le sculture di Pietro Arcangioli, di Guido e Vittorio Marcucci e del professor Cesare Pagnini16 (fig. 1).
14. «Velatri. Giornale letterario politico», I, nn. 17-18, Volterra, 31 luglio 1886-7 agosto 1886.15. Ibidem.16. Ibidem.
1. Pistoia. Esposizione circondariale del 1886. Il padiglione delle fonderie Michelucci nel giardino Tonelli adiacente a piazza del Carmine (Biblioteca Comunale Forteguerriana, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico IV. Pistoia città in occasioni particolari, 6, fotografia di Pirro Fellini).
70
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
A questi, per “Il Popolo Pistoiese”, si aggiungevano gli spilli della fabbrica Ponsard di Limestre, «sorta da poco nel nostro circondario»17, i lavori in ferro di Arcadio Benvenuti, le collezione di carte della fabbrica Cini, le «molte macchine di recen-te invenzione» di Tranquillo Pacini, stabilimento ormai da mesi «illuminato a luce elettrica»18, nonché una strabiliante macchina per lavare e asciugare il grano, opera di Orazio Nenciarini di Candeglia, andata subito a ruba tra gli acquirenti19.Chiudeva, infine, l’Esposizione il «grandioso organo del Tronci, la maraviglia della Esposizione»20, costruito per la Cattedrale di Bastia e alto undici metri, largo otto e profondo due, composto da due tastiere e duemilacinquecento canne di ogni dimensione.L’Esposizione del 1886, come giustamente reclamava Luigi Bargiacchi, fu dunque un successo: fruttò il titolo di cavaliere al suo presidente Aiace Trinci – il titolare della più importante fabbrica di carrozze della città –, si chiuse in attivo, lasciando alla Società Utile e Diletto un discreto avanzo di cassa, ma soprattutto pose le basi e creò i presupposti per la realizzazione, tredici anni più tardi, della più grande ma-nifestazione pubblica che Pistoia avesse mai avuto, l’Esposizione circondariale per l’industria, la floricoltura e l’orticoltura del 1899.
Quanto progresso, quanto cammino si è fatto dal 1886 ad oggi. Eppure anche allora noi pistoiesi non credevamo che vi fosse tanta attività industriale nel nostro paese. […] Oggi si è fatto un bel passo avanti. Evviva Pistoia laboriosa21!Domani il bel sole d’Italia bacerà coi suoi raggi la Piazza di San Francesco, ridotta a superbo giardino22,
così si rallegrava «Il Popolo Pistoiese», spandendo parole piene di patrio orgoglio dalle proprie colonne alla vigilia dell’inaugurazione. Ed effettivamente l’indomani, più precisamente il 23 luglio, dopo essere stata rimandata di una settimana a causa dell’eccessivo protrarsi dei preparativi, l’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899 vide effettivamente sorgere la sua alba.A capo di tutto, ancora una volta l’attivissimo Aiace Trinci, già presidente della società promotrice, la Utile e Diletto, nonché erede e proprietario della principale industria di carrozze cittadina – ben 46 gli operai in forza, secondo il censimento del 189523 –, un settore produttivo, questo, estremamente avanzato e all’avanguardia nella piccola Pistoia del tempo.
17. «Il Popolo Pistoiese», VI, n. 31, Pistoia, 31 luglio 1886.18. Ibidem.19. Ibidem.20. «Velatri. Giornale letterario politico», I, nn. 17-18, Volterra, 31 luglio 1886-7 agosto 1886.21. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 28, Pistoia, 15 luglio 1899.22. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 29, Pistoia, 22 luglio 1899.23. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Annali di Statistica. Statistica Industriale. LV. Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Firenze, Roma, Tip. Nazionale Bertero 1895, p. 110.
71
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Il Trinci è sempre dello stesso umore; solamente siccome è minacciato da una nuo-va onorificenza, pende alquanto dalla parte destra, quando cammina. Immagina già il peso della seconda croce24,
lo canzonava, dalle pagine della rivista fiorentina «Arte, industria e commercio», il direttore Marco Visciola, che immaginava per lui un ulteriore riconoscimento gover-nativo, come premio per l’organizzazione dell’Esposizione del 1899.Le cose però non andarono esattamente così: scarso interesse, in realtà, suscitò negli organismi amministrativi, sia nazionali che locali, la manifestazione pistoiese. Nata da un’iniziativa privata, come tutte le altre esposizioni italiane successive a quella fiorentina dell’Unità – a partire quindi da quella di Milano del 1881, per finire a quella recentissima di Torino del 189825 –, anche la mostra pistoiese poté contare molto poco sugli aiuti finanziari dello Stato e del Comune, e, come già era accaduto nel 1870 e nel 1886, i suoi organizzatori dovettero prodigarsi per racimolare altrove quanti più fondi possibile.Cinquecento azioni di 10 lire ciascuna, pagabili all’atto della sottoscrizione o a rate mensili, furono perciò emesse dal comitato esecutivo in cerca di finanziamento26: benché non si fosse arrivati agli eccessi di Londra, che nel 1851 aveva stabilito che il nome di chi non si fosse deciso a pagare sarebbe stato scritto su liste nere nel Pa-lazzo di Cristallo27, gli inviti rivolti alla buona società pistoiese perché contribuisse al buon esito dell’iniziativa, si moltiplicarono tuttavia da ogni dove, sempre più risoluti e pressanti.Le 539 azioni vendute, latrici di un incasso di 5.390 lire28, non furono tuttavia suf-ficienti e di fondamentale importanza si rivelò, pertanto, l’intervento del deputato dell’Unione Liberale Cino Michelozzi: fu infatti grazie alla sua intercessione che la Cassa di Risparmio contribuì in modo significativo alla realizzazione del progetto, versando la cospicua somma di 15.000 lire, mentre ulteriori elargizioni vennero, seppure in misura minore, dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla Provincia, dalla stessa Società Utile e Diletto, e infine dal piccolo ma partecipe Comune di Lamporecchio29.
24. M. Visciola, L’Esposizione di Pistoia. Lettere a Maria III, in «Arte, industria e commercio. Rivista Setti-manale», I, n. 13, Firenze, 11 agosto 1899, p. VI.25. M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, in M. Picone Petrusa, M.R. Pessolano e A. Bianco, Le grandi esposizioni in Italia 1861-1911. La competizione culturale con l’Europa e la ricerca dello stile nazionale, Napoli, Liguori 1988, p. 13; L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali 1851-1900. Il progresso in scena, Torino, Allemandi 1990, p. 23.26. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 3, Pistoia, 21 gennaio 1899.27. P. Colombo, Le Esposizioni Universali, cit., p. 64 nota 47.28. «Il Pistoia», III, n. 18, Pistoia, 6 maggio 1899.29. Esposizione Circondariale di Pistoia. Regionale Toscana per l’Orticultura e la Floricultura. Mostra d’Arte Antica e Arte Sacra. Elenco Ufficiale dei premiati, Pistoia, Tip. Niccolai 1899, pp. 4-5; “La Penna”, IV, n. 19, Pistoia, 5 marzo 1899; «La Nazione», XLI, n. 203, Firenze, 22 luglio 1899.
72
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Con il bilancio del 1899 già approvato, il Comune di Pistoia inizialmente negò il proprio aiuto, ma alla fine, dietro suggerimento dell’ingegnoso deputato, ispirato a sua volta dall’Esposizione torinese dell’anno precedente30, capitolò anch’esso: l’am-ministrazione concesse così la maggiorazione nei normali incassi del dazio consumo – la tassa applicata alle merci in ingresso in città – che si fosse verificata tra maggio e ottobre, ovvero nel periodo dell’Esposizione, «per l’affluenza dei forestieri»31.Una volta trovati i soldi, il comitato centrale poté dunque mettere finalmente mano alla complessa organizzazione dell’Esposizione: non una cosa da poco, viste le nu-merose sezioni espositive e la gran quantità di oggetti di differente e svariata tipo-logia da mettere in mostra.
Industrie meccaniche e manifatturiere; Orticoltura e floricoltura; Enologia; Prodotti forestali e attrezzi rurali; Opere pie e Beneficenza; Letteratura, didattica e lavori femminili; Belle arti, composizioni musicali e fotografia; Ricordi del risorgimento nazionale32,
queste, infatti, le tante divisioni e sezioni, nelle quali si dispiegava l’intera mostra. Non meno esteso, oltretutto, anche l’elenco degli espositori che, nonostante le ini-ziali ritrosie, avevano in seguito aderito in massa agli appelli del comitato centrale: superato l’iniziale imbarazzo, lo spirito di competizione fra i cittadini aveva potuto, infine, più di mille appelli e la quantità dei beni da mettere in bella mostra era an-data oltre ogni più rosea previsione.Lo spazio dell’ex convento delle Benedettine o monastero da Sala, suggerito in un primo momento da Aiace Trinci per ospitare l’intera Esposizione, si rivelò perciò ben presto del tutto insufficiente. Una volta collocati nello spazio esterno di piazza Mazzini gli stand degli orticoltori – la sezione più gremita, in quanto l’unica ad avere una valenza regionale e a richiamare quindi espositori da tutta la Toscana –, per le opere d’arte e gli altri oggetti manifatturieri e artigianali, che non potevano certo essere lasciati all’aperto senza copertura né protezione, la soluzione dell’ex conven-to tornò tuttavia a essere presa in considerazione33.Anche dal punto di vista spaziale l’Esposizione doveva infatti essere un’unica unità: «per non correre il rischio che venga preferita questa a quella»34, era necessario che tutte le sezioni fossero ospitate in luoghi ed edifici confinanti fra loro. Perciò, sebbene in altre occasioni espositive italiane fosse stata scelta una divisione netta nell’emissione dei biglietti di ingresso, differenziando tra belle arti e prodotti
30. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 3, Pistoia, 21 gennaio 1899.31. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 4, Pistoia, 4 febbraio 1899.32. «Il Popolo Pistoiese», XIX, n. 48, Pistoia, 26 novembre 1898.33. Vedi Verbali della Commissione di Arte Antica, 10 febbraio 1899 (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Manoscritti, 92.47).34. Vedi Verbali della Commissione di Arte Antica, 20 febbraio 1899 (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Manoscritti, 92.47).
73
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
industriali35, a Pistoia si optò, al contrario, per un tagliando unico, che desse accesso ad uno spazio ben circoscritto e delimitato e introducesse ad un percorso di visita obbligato. L’opinione diffusa, infatti, era che la vera «great attraction»36 dell’Espo-sizione, che avrebbe attirato nella piccola Pistoia «i forestieri e i passionisti di cose antiche»37, sarebbe stata, in effetti proprio la Mostra di Arte Antica, e l’intento degli organizzatori fu dunque proprio quello di sfruttare le molte curiosità e le aspettative generate da quest’ultima, per incentivare la visita anche alle altre sezioni (fig. 2).Le attese del pubblico non andarono deluse: più di tremila furono infine gli oggetti d’arte antica, esposti nel 1899 nel monastero da Sala dopo essere stati paziente-mente scovati – battendo letteralmente a tappeto dimore private, chiese e istituti pubblici dell’intero circondario – da Alberto Chiappelli e dagli altri soci fondatori della neonata Società Pistoiese di Storia Patria, cui era stata affidata l’organizzazio-ne di questa «Speciale Divisione».«Un uomo che parla poco e pensa molto»38: così il critico d’arte e architetto Alfre-
35. M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, cit., p. 20.36. «Il Pistoia», III, n. 10, Pistoia, 11 marzo 1899.37. Ibidem.38. A. Melani, L’Esposizione di Pistoia, in «Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte, letteratura, scienze e
2. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Il biglietto di ingresso. Una volta staccata la matrice all’ingresso dell’Esposizione, la parte restante, rimasta in possesso dei visitatori, veniva poi forata nell’accesso all’ex convento da Sala (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Manoscritti, 92.71.4).
74
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
do Melani – lodandone il lavoro svolto per l’Esposizione – aveva definito Alberto Chiappelli, medico affermato ma soprattutto storico e grande collezionista, nonché artefice del grande successo della sezione di Arte Antica. Nelle diciannove sale39 del piano nobile dell’ex convento da Sala facevano infatti bella mostra di sé non solo sculture e quadri antichi dai soggetti più disparati – moltissimi quelli di argomento religioso, così come ritratti, marine, nature morte, scene di caccia e di battaglia – ma anche «paramenti sacri e costumi da ballo, mobili intagliati ed intarsiati, pizzi antichi ed arazzi, libri corali miniati […], paci in rame o smaltate e i reliquiari della Cattedrale e d’altre chiese, collezioni pregevoli di utensili domestici e di armi, di monete e di medaglie»40. Dagli oggetti d’uso quotidiano – ceramiche, argenterie, pettini e ventagli – a quelli dedicati al culto religioso – come crocifissi, pianete, croci e acquasantiere –, dalle carte da gioco alle trine, dai costumi da ballo ai manoscritti, ricchissima fu la varietà dei beni in mostra. Non mancarono nemmeno un papiro, degli idoletti e alcuni amuleti egiziani41.Le famiglie nobili della città custodivano infatti nelle loro case «cose mirabili»42, mai esposte prima se non allo sguardo di pochi eletti, ma anche la nascente borghesia non sembrava essere da meno, con appassionati collezionisti come lo stesso Alber-to Chiappelli o i fratelli Antonio e Tommaso Gelli, per non dire della gran quantità di beni di proprietà comunale, ecclesiastica, o in possesso di istituti ed enti morali della città – come le Scuole Leopoldine, il Liceo Forteguerri o l’Orfanotrofio Puccini –, che per la prima volta si svelavano agli occhi dei molti visitatori.Beni pregevolissimi e, in alcuni casi, di inestimabile valore, dei quali spesso non era nota ai più neppure l’esistenza: perfino lo stesso Ispettore regionale ai Monumenti Guido Carocci, a detta de “Il Popolo Pistoiese”, era rimasto stupito di fronte all’en-tità del patrimonio conservato nelle chiese della campagna pistoiese43 (figg. 3 e 4).«L’esposizione avrà delle grandi curiosità, giacché forse neanche noi sappiamo cosa di prezioso abbiamo nelle nostre case»44, rincarava «Il Pistoia».
Dalle chiese al Municipio, dalle grandi famiglie aristocratiche alla minor borghesia, tutti, si vede evidentemente, hanno sentito il dovere e il piacere di non lasciar di-sperdere quei documenti che ciascuno aveva l’invidiata fortuna di possedere. Ora, di questa affettuosa sollecitudine, che è come una tenerezza superba pel patrimo-
varietà», X, n. 56, 1899, p. 154.39. Le Sale, inizialmente solo diciotto, diventarono infatti diciannove probabilmente grazie all’utilizzo di uno dei corridoi del piano nobile, allestito all’ultimo momento per sopperire alla mancanza di spazi espositivi. L’aggiunta della diciannovesima sala è segnalata a matita sulla piantina dell’Esposizione della collezione priva-ta di Mario Lucarelli, ma la stessa aggiunta manoscritta vi è anche in una delle copie del catalogo generale conservata presso la Biblioteca Forteguerriana (BCFP, Raccolta Alessandro Sozzifanti, Sala IV.4.10.24).40. [Guglielmo Volpi], Cronaca, in «Bullettino Storico Pistoiese», I, n. 4, 1899, p. 158.41. Vedi Esposizione di Arte Antica. Pistoia. Catalogo. 1899, Pistoia, Begliuomini e Turi 1899.42. «Il Pistoia», III, n. 10, Pistoia, 11 marzo 1899.43. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 17, Pistoia, 29 aprile 1899.44. «Il Pistoia», III, n. 10, Pistoia, 11 marzo 1899.
75
x L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
3. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La Sala I e la Sala III della Mostra di Arte Antica allestita al primo piano dell’ex convento da Sala (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Materiale fotografico, Album Ricordo dell’Esposizione di Arte Antica, fotografie di Cesare Borgiotti).
76
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
nio di famiglia, non si ha traccia, purtroppo che nella Toscana45,
spiegava Luigi Lodi, firmandosi Il Saraceno, dalle colonne de “Il don Chisciotte di Roma”.Ed effettivamente i nobili casati pistoiesi erano così tanto fieri delle proprie prezio-sità, che all’interno dell’ex convento avevano addirittura preteso sale specificata-mente dedicate e riservate alle loro collezioni: un’«affettuosa sollecitudine» – o, per meglio dire, un desiderio di autocelebrazione – che, insieme al poco spazio e alla grande quantità di oggetti, rese purtroppo impossibile l’applicazione di qualsivoglia criterio espositivo, vanificando i timidi sforzi di ordinamento cronologico o per tipo-logia che, qua e là, furono comunque tentati.Alessandro Chiappelli spiegava:
45. «Il don Chisciotte di Roma«, VII, n. 210, Roma, 1 agosto 1899.
4. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Una delle vetrine che contenevano gli oggetti di proprietà del Capitolo della Cattedrale esposti nella Sala V della Mostra di Arte Antica. Nella fotografia è possibile distinguere il Reliquiario di San Jacopo, oggi attribuito a Lorenzo Ghiberti e alla sua bottega (1407) e conservato nel Museo della Cattedrale di San Zeno dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Materiale fotografico, 8, fotografia di Pirro Fellini).
77
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
molti di essi [i privati cittadini, N.d.A.], i quali più specialmente appartengono al patriziato locale, posero per condizione del loro contributo, l’avere per sé una sala speciale, affinché questa portasse il nome della famiglia di cui raccoglieva le avite memorie e le anticaglie46.
«La disposizione del locale diviso in molte stanzette e il desiderio degli espositori privati di voler formare distinti e speciali gruppi hanno cagionato un certo tal quale disordine nella disposizione che avrebbe potuto essere più razionale»47, concordava “Il Popolo Pistoiese”, mentre “Il Pistoia” cercava con ostinazione di giustificare il risultato allestitivo: «di quanto ci perde l’esigenza metodica, di tanto ci guadagna il gusto e la fantasia»48.Se altrove, sul finire del secolo, nelle mostre d’arte già si cominciava ad adottare principi di selezione e rarefazione, nonché di ordinamento cronologico o tematico, a Pistoia l’horror vacui e l’accumulo indiscriminato – come era accaduto nelle Espo-sizioni universali e nazionali antecedenti – la facevano ancora da padroni e le pareti, le vetrine e le superfici calpestabili dell’ex monastero si mostrarono ingombre di beni, tanto che «pretendere di girare tutto minutamente, fermandosi innanzi a tutti gli oggetti meritevoli di attenzione troppo sarebbe»49.Eppure le premesse erano state ottime: anche a Pistoia la suddivisione illumini-stica tra il bello dell’arte antica e l’utile dell’arte industriale, propria delle Mostre ottocentesche, era stata infatti perfettamente rispettata. La separazione dei tesori dell’antichità dal resto degli oggetti aveva consentito di conferire a questi ultimi la giusta importanza ed evidenza: ovunque l’intento di questo tipo di allestimenti era infatti quello di innalzare lo spirito ed educare il gusto del popolo e, in particolare, della nuova classe imprenditoriale, interessata alla produzione di un artigianato che fosse di elevata qualità artistica50. L’arte, che a sua volta traeva il proprio so-stentamento dalla circolazione del denaro e dall’affermazione della classe borghe-se – tutta intenta a nobilitarsi collezionando ogni tipo di bene –, aveva il compito didattico ed etico di perfezionare i prodotti delle nascenti industrie: lo scopo, in ul-tima istanza, era comunque sempre quello di favorire il progresso e il commercio.Tuttavia, se l’allestimento delle opere non fu del tutto impeccabile, la Mostra di Arte Antica pistoiese non mancò di produrre gli sperati effetti educativi, non solo sull’éli-te culturale, ma sull’intera cittadinanza: l’aver rivelato per la prima volta l’esatta entità e l’indiscutibile pregio del cospicuo patrimonio artistico fino a quel momento gelosamente custodito e nascosto, portò infatti alla maturazione, anche a Pistoia, di un inedito sentimento di orgoglio per i propri tesori e preziosità.
46. A. Chiappelli, Per la Mostra Pistoiese d’Arte Antica, Roma, Direzione della Nuova Antologia 1899, p. 4.47. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 30, Pistoia, 29 luglio 1899.48. «Il Pistoia», III, n. 29, Pistoia, 22 luglio 1899.49. «Gazzetta del Popolo della Domenica», XVII, n. 40, Torino, 1 ottobre 1899.50. M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, cit., p. 20; P. Colombo, Le Esposizioni Universali, cit., p. 19.
78
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Se scarsi erano stati, fino a quel momento, l’interesse per lo studio e la valorizzazio-ne delle radici storiche e culturali della città e delle sue ricchezze artistiche – quello che può essere considerato il nucleo primigenio del Museo Civico, conservato nel Capitolo della chiesa di San Francesco, infatti, altro non era che un deposito di materiali lapidei –, con la Mostra tutto cambiò e quel fenomeno di maturazione di un’inedita consapevolezza e volontà di approfondimento delle conoscenze – già in-nescato dall’istituzione della Società Pistoiese di Storia Patria – ricevette un’ulteriore e decisa spinta per venire finalmente e pienamente alla luce.
[Alberto Chiappelli, N.d.A.] propone di fare un voto al Municipio perché dopo l’Esposizione venga rilasciata una stanza da adibire come Museo. Tale proposta è accettata in massima ma la presidenza è d’avviso di soprassedere per ora, e pren-dere una definitiva deliberazione ad una prossima adunanza51.
riferivano i Verbali della Commissione di Arte Antica, in prossimità della chiusura della Mostra. Del resto analoghi tentativi avevano conosciuto, già in precedenza, nel resto d’Europa, esiti più che positivi: dai proventi e dal materiale recuperato dall’Esposizione londinese del 1851, ad esempio, sei anni più tardi, era stato crea-to il South Kensington Museum of Industrial Arts, che, trasformato in seguito nel Victoria and Albert Museum, divenne ben presto uno straordinario strumento per l’educazione della popolazione e per il miglioramento della produzione industriale, oltre che un modello di museo replicato poi ovunque nel mondo.Nonostante i buoni propositi, tuttavia, a Pistoia la questione non fu più nuovamen-te affrontata e il Museo Civico poté finalmente vedere la luce, nelle Sale del Palazzo Comunale, solo nel 1922.Ad ogni modo, anche se l’idea si concretizzò solo alcuni anni più tardi, l’impulso all’istituzione di un vero istituto museale cittadino cominciò ad originarsi proprio a partire da questo nuovo sentimento collettivo.Al riguardo, così rifletteva sul “Bullettino Storico Pistoiese” – la rivista di studi della Società – il direttore Guglielmo Volpi:
Se anche i nomi di antichi orefici pistoiesi vi figuravano assai degnamente, come Andrea Braccini orafo e i pittori fra Paolino, Bernardino Detti, Gerino, il Volponi, Bernardino del Signoraccio, il Cristiani, il Gimignani, questa mostra artistica dimo-strò sempre più come Pistoia in tutti i secoli del Rinascimento fosse liberale ospita-trice di artefici venutivi dal di fuori, e raccogliesse, nelle case private e nelle chiese e nei palagi pubblici, tesori d’arte. […] questa mostra è stata anche occasione e incitamento a studi e ricerche di storia dell’arte pistoiese, e di notizie concernenti oggetti esposti in essa52.
51. Vedi Verbali della Commissione di Arte Antica, 22 settembre 1899 (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Manoscritti, 92.47).52. [Gglielmo Volpi], Cronaca, in “Bullettino Storico Pistoiese”, I, n. 4, 1899, pp. 158-159.
79
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Non altrettanto encomiata fu, invece, la rassegna di Arte Moderna, ospitata anch’essa all’interno dell’ex convento da Sala e in alcuni locali provvisori costruiti appositamente nel suo cortile esterno: «non si può dire che non sia modesta, molto modesta – la stroncò “Il Pistoia” – e certamente i nostri artisti avrebbero potuto fare di più»53.La città sembrava essere rimasta del tutto indifferente, in effetti, alle nuove corren-ti che sul finire dell’Ottocento avevano cominciato a spirare nel mondo dell’arte: se Firenze, con l’Esposizione Promotrice del 1891, aveva visto affacciarsi tendenze postimpressioniste e divisioniste e, in seguito, nella Festa dell’Arte e dei Fiori del 1896, aveva perfino salutato la decisa affermazione delle correnti simboliste, la vicina Pistoia era invece rimasta ferma alla produzione tradizionale di stampo na-turalista di pittori come Giuseppe Ciaranfi54, che un tagliente Alfredo Melani non aveva mancato di bollare come degno di un «museo del Risorgimento» e capace di deliziare «solo giudici vincolati alle idee del quarantotto o – siamo generosi! – del cinquantanove»55.Anche a detta di Melani, tuttavia, qualche opera degna di nota non mancò neppure nella sezione di Arte Moderna: fu il caso di Giuseppe Magni, che con la sua La ven-demmia diceva cose «belle e piacevoli»56 e faceva concepire le più belle speranze sulle [sue] sorti future»57, mentre, tra gli scultori, spiccava già Lorenzo Guazzini, all’epoca appena ventiseienne. “Il Comune di Pistoia” ne elogiò in special modo l’o-pera La prima Crudeltà, nella quale l’artista aveva ritratto un bambino colto nell’at-to di strappare le ali ad una farfalla58.La sezione di Arte Moderna non si limitava però alla sola pittura: nei diversi stand che la componevano includeva infatti anche le stampe e gli ingrandimenti foto-grafici, sia di professionisti del calibro di Cesare Borgiotti e Pirro Fellini, che di mol-ti insospettabili amatori, affascinati dalle possibilità espressive offerte dalla nuova tecnologia: tra questi, il priore Domenico Pelleschi, l’aristocratico Emiliano Orsucci Pesenti e, con riproduzioni di manoscritti e lavori artistici e ritratti di spettacoli di varietà, il notaio Piermei59, «il quale tra un rogito e l’altro trova tempo per darsi alla Poupée»60. «Il dilettantismo fotografico dilata e prende delle proporzioni assoluta-mente allarmanti; non rammentiamo tutti perché la macchina fotografica è oggi
53. «Il Pistoia», III, n. 36, Pistoia, 9 settembre 1899.54. C. d’Afflitto, Le arti figurative, dall’esposizione del 1899 alla Prima Mostra Provinciale del 1928, in Storia di Pistoia, a cura di G. Petracchi, cit., pp. 645-646.55. A. Melani, L’Esposizione di Pistoia, in «Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte, letteratura, scienze e varietà», X, n. 56, 1899, p. 152.56. Ibidem.57. «Il Comune di Pistoia», I, n. 18, Pistoia, 6 agosto 1899.58. Ibidem.59. Ibidem; Esposizione di Arte Moderna. Pistoia 1899. Catalogo, Pistoia, Begliuomini e Turi 1899, p. 14.60. «Il Pistoia», III, n. 36, Pistoia, 9 settembre 1899.
80
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
diventata uno strumento di prima necessità»61, si domandava con stupore e un certo disappunto “Il Pistoia” (fig, 5).Non molto distante dalle due mostre artistiche – allestita in un unico ambiente rica-vato nel loggiato al pian terreno dell’ex convento da Sala – se ne trovava un’altra, contenente anch’essa quadri, statue e fotografie, oltre a stampe, documenti auto-grafi e altri cimeli della più svariata natura: era la Mostra dei Ricordi Storici dell’Indi-pendenza Italiana, organizzata dal maggiore Lodovico Canini, esponente di punta della loggia massonica cittadina62, per celebrare il ruolo svolto nelle lotte risorgimen-tali da Pistoia, soprannominata all’epoca «la piccola Brescia della Toscana».Il Comune, da parte sua, concesse alla particolare sezione espositiva ben ventinove
61. Ibidem.62. F. Conti, L’associazionismo massonico dall’Unità al fascismo, cit., pp. 252-253.
5. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La Mostra di Arte Moderna, che comprendeva anche una rilevante sezione dedicata alle opere fotografiche (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 11, fotografia di Pirro Fellini).
81
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
6. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La Mostra di Ricordi Storici dell’Indipendenza Italiana, allestita nell’ex convento da Sala (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 22, fotografia di Pirro Fellini).
82
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
«documenti manoscritti ed a stampa»63, selezionati per l’occasione da Lodovico Canini tra quelli della collezione della soppressa Guardia Nazionale di Pistoia, depo-sitata al tempo presso l’archivio municipale.Ma particolarmente pronta ed entusiasta fu, soprattutto, la risposta e la collabora-zione dei cittadini, ai quali era stato chiesto di esporre nei locali dell’ex convento i ricordi delle recenti guerre e battaglie da loro amorevolmente conservati.Una sentita partecipazione aveva suscitato, infatti, l’iniziativa fra la cittadinanza – nella quale ancora recente era il ricordo di quei fatti e l’orgoglio per il ruolo svolto – e moltissimi furono i cimeli raccolti tra le famiglie pistoiesi: ovviamente fucili, sciabole e palle di moschetto, ma anche opuscoli, volumi e giornali, così come lettere, autografi e ritratti dei soldati volontari; per non dire, infine, dei «fiori raccolti dalle Signore Mantovane a Montanara e Curtatone»64 e del pezzo di sigaro fumato da Garibaldi, dopo l’estrazione della pallottola con cui era stato ferito in Aspromonte65 (fig, 6).Una sezione dai natali forse meno nobili, ma ancor più varia e stracolma di oggetti, aveva infine riempito i restanti spazi chiusi dell’ex convento da Sala: era la Mostra Industriale, con i suoi stand ricolmi dei frutti della fiorente imprenditoria locale. Cu-riose, in quest’ultima divisione, le classi di concorso chiamate a competere tra loro per l’aggiudicazione dei diplomi e delle medaglie: dai Cordami agli Zolfanelli, dagli Inchiostri ai Busti, dalle Biblioteche circolanti alle Bruscole66.
Dai lavori in ferro, come strumenti e macchine agricole, fusioni in ghisa ed oggetti in ferro battuto, ai lavori in legno, che vanno dalle porte e finestre e dai mobili dozzinali ai mobili artistici per intaglio e intarsio; dai materiali da costruzione, mat-toni, mattonelle, in cemento, ecc., ai lavori artistici ornamentali in terra cotta; poi i prodotti delle cartiere, utensili domestici, vasi vinari di ogni foggia e grandezza, eleganti lavori in tappezzeria, biliardi, finissimi lavori in paglia, ombrelli, stoffe di seta e lana, strumenti musicali, pesi di precisione e bilance comuni, e... non finirei più se tutto volessi enumerare67,
(fig. 7 e 8) riferiva la “Gazzetta del Popolo della Domenica”, mentre Silvio Ghelli su “Il don Chisciotte di Roma” più dettagliatamente elogiava, uno ad uno, gli esposi-tori secondo lui maggiormente meritevoli:
Nell’arte del ferro e nelle costruzioni di macchine, […] accanto al cavaliere Giu-seppe Michelucci […] una delle più grandi officine d’Italia, debbo registrare i nomi di Arcadio Benvenuti specialista in serrature, del Gargini, che nella sua umiltà ha
63. Vedi richiesta di Alfredo Chiti al sindaco del 1 giugno 1899 (ASCP, Sezione Postunitario, Documenti al-legati al Protocollo Generale, 26, 4, 1899).64. Catalogo della Mostra dei Ricordi Storici dell’Indipendenza Italiana dal 1796 al 1870. Tenuta in Pistoia nell’estate 1899, Pistoia, Tip. di Giuseppe Flori 1899, p. 11.65. Ivi, p. 13.66. Vedi Esposizione di Arte Moderna, cit.67. «Gazzetta del Popolo della Domenica», XVII, n. 40, Torino, 1 ottobre 1899.
8383
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
In alto, fig. 7, Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Stand di oggetti lavorati in ferro (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 7, fotografia di Pirro Fellini).In basso, fig. 8, Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La sezione espositiva dei mobili e delle tappezzerie all’interno della Divisione IV, dedicata alla industrie meccaniche e manifatturiere (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 26, fotografia di Pirro Fellini).
84
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
quasi voluto nascondere all’ammirazione dei visitatori le sue trine in ferro battuto, di Garibaldo Ricciarelli, celebre per le forme da pasta alimentari, […] e di molti altri, dei quali disgraziatamente sfuggemi il nome. E col Lippi, che, appresa l’arte del fondere il bronzo in una officina di arcimodestissime proporzioni, oggi rivaleggia con tutte le fonderie italiane, vengono in fila: Alberto Carradori, continuatore della ditta del padre, rinomata per la fabbricazione di piatti musicali che fan concorren-za a quelli turchi, il Marradi-Benti, il Bresci, e poi i due Rafanelli, l’uno celebre per la fusione delle campane da Chiesa, l’altro per quelle da teatro. […] Michele Billi, coi suoi macinelli da caffè ed i forni da campagna fa concorrenza ai prodotti esteri e ci riesce meravigliosamente68.
Così proseguiva “Il don Chisciotte”:
Insomma, da qualunque parte in questa esposizione si volga lo sguardo si passa di meraviglia in meraviglia e ci si domanda: come, a Pistoia, si fabbrica anche questo? L’industria del vetro era quasi defunta, ed oggi orgogliosa risorge con Serafino Nic-colai. Gaetano Guazzini colla sua importante fabbrica di paste alimentari fa concor-renza a quelle di Genova e di Gragnano. E, come ultima nota, mi sia permesso un plauso alla ditta di Angiolo Chiti e figlio, la quale ha destato l’ammirazione di tutti gli intelligenti coi suoi mobili artistici […]; e un mi rallegro all’Arcangioli per i suoi stipi in stile del 500 sposati ad altorilievi in bronzo69.
Nella parte dell’ex convento da Sala destinata ai prodotti alimentari la facevano, inoltre, da padroni i produttori di vino, in parte esponenti delle famiglie aristocrati-che pistoiesi proprietarie di terreni e fattorie, come la nobil Casa Ganucci Cancellie-ri: fu in questa sezione che si distinsero alcuni degli espositori più ingegnosi e intra-prendenti, i cui stand furono fra i più fantasiosi dell’intera Esposizione. Raccontava Marco Visciola:
Entrando nelle sale destinate alla vinicultura, il primo oggetto che ti si presenta allo sguardo è un carro carico di casse di vini in fiaschi di diverse dimensioni, pronto alla partenza. Non manca che agganciarlo ad una locomotiva, perché i numerosi fiaschi passino la frontiera, destinate alle più lontane regioni del vecchio e del nuovo mondo. È la casa Magni (antica casa Thyrion) che vuol dare un’idea della grande esportazione dei suoi vini [...]. Adolfo Giannini uno dei più importanti esportatori ha occupata quasi una stanza dell’Esposizione […]. E a dimostrare la gran quantità di vino che spande in Italia ed all’Estero si è servito di un’allegoria. In un gran fiasco sono rinchiusi una quantità di altri fiaschi più piccoli. Non ti pare che voglia dire che il fiasco generi continuamente fiaschettini a migliaia, senza mai esaurirsi? Peccato che i fiaschettini son vuoti... pel pubblico e specialmente per la stampa70! (fig. 9)
68. «Il don Chisciotte di Roma», VII, n. 213, Roma, 4 agosto 1899.69. Ibidem.70. M. Visciola, L’Esposizione di Pistoia. Lettere a Maria III, in «Arte, industria e commercio. Rivista Setti-
85
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Una sezione, quella dedicata al vino, molto nutrita e affollata di espositori: «saran-no una trentina e molti hanno esposto tre o quattro qualità per ciascuno – riferiva Marco Visciola – non avrei voluto essere nei panni dei componenti la Giuria i quali si sono imposti l’enorme sacrifizio di pronunziarsi, dopo il saggio, in poco più di due ore»71.Non erano, infine da dimenticare, al piano mezzanino dello stesso ex convento, le esposizioni delle opere di didattica delle numerose scuole pistoiesi – tra tutte, il Conservatorio delle Crocifissine e il Liceo Forteguerri – e i cosiddetti lavori femminili o, per dirla come Alfredo Melani, donneschi.Nonostante l’architetto pistoiese ne criticasse la qualità artistica – «dovrebbe esse-
manale», I, n. 13, Firenze, 11 agosto 1899, p. VII.71. M. Visciola, L’Esposizione di Pistoia. Lettere a Maria IV, in «Arte, industria e commercio. Rivista Setti-manale», I, n. 14, Firenze, 21 agosto 1899, p. VI.
9. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Il carretto espositivo della casa vinicola Francesco Magni all’interno della sezione dedicata alla produzione ed al commercio del vino (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 41, fotografia di Pirro Fellini).
86
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
re un paradiso per noi esteti, invece non è l’inferno, ma il purgatorio sì»72 – molti furono gli apprezzamenti ricevuti da questa sezione, soprattutto per quel che ri-guardava lo stand della «scuola di merletti, impiantata a Lucciano dalla bellissima, intellettuale contessa Rasponi-Spalletti»73. Altrettanto lodata fu anche la nuova at-tività di lavorazione della paglia, che da poco era sorta nella «piccola e industriosa Tizzana»: «non si crederebbe che quelle trine esposte al pubblico, quelle tende da finestra, ricamate a colori fossero di paglia se non si toccassero colle dita! Questa stessa vetrina figurerà pure a Parigi»74. Era, questo, un esempio di quei piccoli me-stieri – come veniva definito in gergo l’artigianato minuto, i cui mezzi produttivi non erano nient’altro che l’operaio e i suoi utensili – nei quali la Toscana sembrava
72. A. Melani, L’Esposizione di Pistoia, in «Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte, letteratura, scienze e varietà», X, n. 56, 1899, p. 151.73. «Il don Chisciotte di Roma», VII, n. 213, Roma, 4 agosto 1899.74. Ibidem.
10. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. L’esposizione delle carrozze all’interno della chiesa di San Francesco (BCFP, Raccolta Alberto Chiappelli, Materiale fotografico, 32, fotografia di Pirro Fellini).
87
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
essere particolarmente abile, e che, effettivamente, la capitale francese aveva dimo-strato di amare in modo particolare già a partire dall’Esposizione del 1867, dove un grande successo era stato riscosso proprio dai cappelli di paglia toscani75.Ma la sezione dei prodotti industriali non si esauriva negli spazi allestiti nell’ex con-vento, estendendosi anche all’interno della vicina chiesa di San Francesco – già all’epoca di proprietà comunale –, dove aveva trovato posto la mostra delle carroz-ze e degli oggetti della sezione di Beneficenza, Previdenza e Igiene: nella sala del Capitolo si trovava, infatti, il primo embrionale nucleo del Museo Civico, progettato ed allestito da Francesco Bartolini già nel 1893, e l’ispettore ai monumenti della Toscana Guido Carocci aveva affidato allo stesso ingegnere e architetto pistoiese il compito di vigilare affinché nessun oggetto artistico moderno fosse esposto insie-me agli antichi reperti, ritenendolo un accostamento poco opportuno. Fu così che – con una scelta singolare e ampiamente criticata anche dalla stampa del tempo – fu consentito che la tenda della Croce Rossa e le carrozze, i barroccini e i carri dei rinomati fabbricanti pistoiesi facessero bella mostra di sé nientemeno che all’inter-no della chiesa di San Francesco (fig 10).Primeggiava indiscussa in questa sezione la ditta Trinci, che si distingueva grazie a prodotti di un livello qualitativo ed estetico molto avanzato, ma anche per le innovazioni tecnologiche estremamente sofisticate sempre presenti nella sua pro-duzione. Perfino il principe di Napoli, capo guardia della Misericordia di Firenze e di quella di Pistoia, aveva elargito a quest’ultima la bellezza di 500 lire purché fossero «destinate all’acquisto di una lettiga del numero di quelle che solamente il Trinci sa fabbricare e di cui un campione si ammira all’Esposizione»76.
Così scriveva Silvio Ghelli su “Il don Chisciotte di Roma”:
Nella fabbrica di carrozze emerge sovrano il cav. Aiace Trinci, che, per la sua qualità di presidente dell’Esposizione, è fuori concorso. Egli espone dei magnifici carri-lettiga a moto cardanico automatico per trasporto di malati, che il ministero della marina ha acquistato per mandarne uno ad ogni dipartimento77.Carrozze di ogni specie, di vario modello, nuove, fiammanti all’esterno, elastiche, sfarzosamente addobbate all’interno. Per un poeta che ama fantasticare e sognare ad occhi aperti, deve essere una dolce cosa farsi cullare in quelle carrozze dalle molle elastiche, dalle ruote silenziose. Peccato che mi è mancato l’animo di dirgli: – Amico Trinci, perché non facciamo un contratto in senso, dirò così, di compen-sazione? Io pubblicherò, ogni anno, ogni mese, ogni settimana, e tu dammi in contraccambio un break78,
75. P. Colombo, Le Esposizioni Universali, cit., pp. 81-82.76. M. Visciola, L’Esposizione di Pistoia. Lettere a Maria V, in “Arte, industria e commercio. Rivista Setti-manale”, I, n. 15, Firenze, 31 agosto 1899, pp. IV-V.77. «Il don Chisciotte di Roma», VII, n. 213, Roma, 4 agosto 1899.78. M. Visciola, L’Esposizione di Pistoia. Lettere a Maria III, in «Arte, industria e commercio. Rivista Setti-manale», I, n. 13, Firenze, 11 agosto 1899, p. VI.
88
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
vagheggiava, invece, Marco Visciola dalle colonne di «Arte, industria e commercio».L’Esposizione del 1899 era infine completata dalla sezione di Floricoltura e Orticol-tura, l’unica, tra la tante divisioni, ad avere una valenza regionale e non solo circon-dariale79. A dispetto dell’importanza economica che avrebbe rivestito per la città ne-gli anni a venire, quello vivaistico all’epoca dei fatti era un settore produttivo ancora agli albori – nato in città appena pochi decenni prima, alla metà dell’Ottocento –, e pochi furono gli espositori pistoiesi che si disputarono i premi in palio nelle molte classi di concorso. Fra questi, si distinsero soprattutto la ditta dei fratelli Bartolini per «le splendide collezioni di arbusti, di palme, di Ilex»80 e la «superba collezione
79. “Il Popolo Pistoiese», XX, n. 10, Pistoia, 11 marzo 1899.80. «Il Pistoia», III, n. 33, Pistoia, 19 agosto 1899.
11. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Il chiostro dell’ex convento da Sala, che ospitava gli stand di piante e fiori degli orticoltori. Al lato della fotografia si può notare parte del cartellone della ditta di Martino Bianchi (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 44, fotografia di Pirro Fellini).
89
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
di Pelargonii»81, di Bianco Bianchi, «che ne ha una rarissima di magnolie dall’Holba stellata fino alla Grandiflora»82, di Pietro e Martino Bianchi e di Bartolomeo Lotti e Raffaello Nerozzi per «le conifere, le magnolie, gli agrumi, gli olivi, i frutti coltivati in vaso, le piante ornamentali e da imboscamento»83 (fig.11).Tuttavia, considerata l’apertura del concorso agli orticoltori provenienti da tutta la Toscana, lo spazio di piazza Mazzini era apparso fin da subito insufficiente, tanto che piante e fiori erano stati ospitati anche nel cortile esterno e nel chiostro dell’ex convento da Sala, così come in quello di San Francesco. I «coniugi Signori Marchet-ti-Ducceschi [con] offerta cortese»84, avevano infine concesso l’uso del giardino della loro nobile dimora, confinante con il giardino esterno dell’ex monastero.Il piccolo parco, nascosto dietro le alte mura del Palazzo, era stato sistemato e adeguato al gusto moderno dei primi decenni dell’Ottocento dal botanico Antonio Targioni Tozzetti, su commissione dell’allora proprietario Orazio Marchetti. Lo stile romantico la faceva ovviamente da padrone e il giardino, all’epoca dell’Esposizio-ne circondariale, appariva decorato da un elegante laghetto, con tanto di piccolo pontile in legno, nonché «ombreggiato da alberi bene intrecciati, da sorprendenti piante arrampicanti, con serpeggianti stradelle che si insinuano ora nel folto della verzura»85. Una sistemazione, questa, che andò del tutto distrutta quando, il 24 ottobre 1943, Pistoia subì il suo primo bombardamento aereo e il laghetto con l’antica gora che lo alimentava andarono perduti per sempre. I fortunati pistoiesi del 1899 potevano, tuttavia, apprezzarlo ancora in tutto il suo splendore: «si ammirano specialmente delle piante di frutti i cui rami, dagli esperti loro cultori, sono cresciuti in modo da formare dei curiosi disegni»86, riportava “La Nazione” descrivendo alcu-ni esempi di quella che sarebbe poi diventata una specialità del vivaismo pistoiese, ovvero la cosiddetta arte topiaria. «Meraviglioso, si potrebbe dire fatato, degno de’ favolosi racconti delle Mille e una notte. [...] il giardino Marchetti è veramente una delle meraviglie dell’Esposizione»87, concludeva quindi il quotidiano.Ma i coltivatori pistoiesi, quell’estate del 1899, non si erano limitati ad allestire i propri stand di piante e fiori: era al loro impegno disinteressato, infatti, che si do-veva lo spettacolo stupefacente e incantevole che si era aperto alla vista dei molti visitatori il giorno dell’inaugurazione dell’Esposizione. «Le coup d’oeil che offr[iva] la Piazza Mazzini, dalla sapiente mano di orticultori pistoiesi ridotta ad un vero e proprio Eden»88, in chi quel giorno aveva avuto la fortuna di assistere all’apertura
81. «La Penna«, IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.82. Ibidem.83. «Il Pistoia», III, n. 33, Pistoia, 19 agosto 1899.84. «Il Popolo Pistoiese«, XX, n. 10, Pistoia, 11 marzo 1899.85. «La Nazione», XLI, n. 203, Firenze, 22 luglio 1899.86. «La Nazione», XLI, n. 204, Firenze, 23 luglio 1899.87. «La Nazione», XLI, n. 203, Firenze, 22 luglio 1899.88. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.
90
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
della manifestazione, non poté che suscitare «un oooh!! pieno di soddisfazione»89.
È necessario fermarsi un po’ per abituare l’occhio al bello spettacolo che ci colpi-sce. D’ogni parte aiuole fiorite, olezzanti grati profumi, il verde cupo degli alberi frondosi90,
proseguiva “La Penna” nella sua descrizione, mentre “La Nazione” riportava con un’affascinante vividezza ogni più minuto dettaglio di una piazza Mazzini
ridotta ad un grandioso, incantevole giardino chiuso. Nel centro è una vasca assai grande ed elegante, in mezzo a cui sorge potente e dritta come una colonna metallica l’acqua della fontana, che elevandosi per molti metri si allarga come a formare un rosone e poi ricade in una pioggia lucida, ma così fine da parere filato d’argento. L’orlo della vasca è adorno di vaghissimi disegni e dell’iscrizione: Agosto 1899, il tutto resultante da un’abile disposizione di pianticelle multicolori. Ai lati della vasca sono grandi e graziose aiuole, pure di effetto magnifico per i dettagli eleganti e sottili da parere ricami, composti anche questi di piante e fiori91.
La vasca di piazza Mazzini, con i suoi potenti fiotti, agghindata di piante e fiori da Bartolomeo Lotti92, doveva davvero apparire bella e allettante come non mai, nell’afa della calura agostana. Quello dello zampillio, nelle esposizioni universali di tutto il mondo, era del resto un topos ricorrente: dalla fontana costruita con quattro tonnellate di cristallo a Londra nel 1851, a quella che, nella stessa Great Exhibition d’oltremanica, spruzzava tè very english93 al posto dell’acqua, dalle fontane giap-ponesi di porcellana, che adornavano i lati del padiglione nipponico a Parigi nel 187894, alla creazione monumentale posta davanti alla triplice facciata dell’Esposi-zione di Torino del 1898.Ma l’elemento di decoro della piazza senz’altro più significativo, che accomunò Pistoia a tutte le altre esperienze sia nazionali che universali, apponendo definitiva-mente il sigillo della modernità all’Esposizione del 1899 e ai suoi promotori, fu lo scintillio di lucenti barbagli portato dalla recentissima innovazione dell’illuminazio-ne: «lo splendore delle lampade elettriche – per dirla con “La Penna” – che fra il bel verde, fra le aiuole, insinua[va]no raggi argentini dando all’ambiente un aspetto fantastico, nuovo»95.Ben sedici lampade ad arco e ottanta a incandescenza sfavillavano fra la vegeta-
89. «Il Pistoia», III, n. 33, Pistoia, 19 agosto 1899.90. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.91. «La Nazione», XLI, n. 203, Firenze, 22 luglio 1899.92. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.93. P. Colombo, Le Esposizioni Universali, cit., p. 53.94. Ivi, p. 120.95. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.
91
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
12. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Negli scorci del giardino di piazza Mazzini sono visibili alcune delle lampade usate per l’illuminazione degli spazi all’aperto (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 1 e 39, fotografie di Pirro Fellini).
92
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
zione – in «una festa di fiori e di luce»96 – secondo il progetto della ditta Banti e Torrigiani, l’impresa che, seppure con un discusso contratto, si era in ogni caso aggiudicata l’appalto della fornitura di luce per la città (fig. 12).A partire da Parigi 1881, l’Esposizione internazionale interamente dedicata all’il-luminazione, e, in Italia, Torino 1884, la cui Galleria dell’Elettricità aveva ospitato produttori provenienti da tutto il mondo97, quello tra le Esposizioni e la luce elet-trica era un connubio inscindibile: del resto, non poteva esserci ultimo ritrovato migliore per magnificare ed esaltare queste enormi e vistose vetrine, dove i sim-boli del progresso e della produzione industriale – come la scienza e la tecnica – spadroneggiavano indiscusse. Per questo motivo spesso, a corredo delle Espo-sizioni di fine secolo, non era potuta mancare l’illuminazione serale e notturna dei grandi spazi cittadini all’aperto, come i giardini pubblici e le eleganti vie dei centri storici.A Pistoia nel 1899, tuttavia, gli interventi di sistemazione della piazza e dei locali confinanti non si erano fermati agli abbellimenti ed agli allestimenti decorativi, per quanto spettacolari e sorprendenti fossero: in vista dell’Esposizione si erano purtroppo resi necessari lavori di restauro e risanamento ben più risolutivi e ra-dicali.Non solo si era dovuti intervenire, infatti, sull’ex convento da Sala98 e sulla chiesa – «il Chiostro di San Francesco restaurato e pavimentato ha perduto il suo tetro e miserando aspetto»99, riferiva al riguardo “Il Popolo Pistoiese” –, ma anche la piazza stessa era stata oggetto di importanti lavori di restauro: oltre alla vasca centrale, che era stata rialzata100, furono soprattutto sottoposti ad interventi di risanamento – dovendo ospitare i punti di ristoro per i visitatori – sia il Parterre, la zona sopraelevata del giardino, che la sua quinta scenica costituita dal Pantheon, «che era stato lasciato in un abbandono deplorevole e che minacciava di finire in un monte di sassi»101. In quell’occasione furono recuperate anche le pitture di Bartolomeo Valiani che erano conservate all’interno: «rovinate e corrose dal-le filtrazioni della pioggia, sono ritornate alla luce, per intelligente ed amorosa opera dei pittori Ugo e Fabio Casanova»102. Quest’ultimo – ricordato e celebrato
96. «La Nazione», XLI, n. 205, Firenze, 24 luglio 1899.97.«Torino e l’Esposizione Italiana del 1884. Cronaca illustrata della Esposizione Nazionale-Industriale ed Artistica del 1884», nn. 15, 19, Torino, Fratelli Treves 1884; P. Meardi, L’elettricità e le sue applicazioni all’Esposizione di Torino del 1884, Milano, Ulrico Hoepli 1885, pp. 7-8.98. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 11, Pistoia, 18 marzo 1899; “Il Popolo Pistoiese”, XX, n. 14, Pistoia, 8 aprile 1899.99. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 23, Pistoia, 10 giugno 1899.100. G. Chelucci, L’identità perduta. Il complesso di S. Francesco nel XIX e XX secolo tra ipotesi di destinazione civica e recupero mistico-devozionale, in San Francesco. La chiesa e il convento a Pistoia, a cura di L. Gai, Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 1993, p. 306 nota 53.101. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 23, Pistoia, 10 giugno 1899.102. Ibidem.
93
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
in seguito per essere stato il fondatore nel 1919 della Scuola d’Arte di Pistoia, da lui poi diretta per lungo tempo – non si era limitato, tra l’altro, ad affiancare il padre Ugo nel restauro degli affreschi, ma aveva anche preso attivamente parte all’Esposizione, presentando ben quindici opere – perlopiù acquerelli raffiguranti impressioni dal vero – all’interno della sezione di Arte Moderna103. «Una speranza certa dell’arte, che, giova sperarlo, non ci serberà delle delusioni in avvenire»104, aveva annunciato con lungimiranza “Il Comune di Pistoia”, predicendo l’avvenire del giovane pittore all’epoca appena ventiduenne (fig. 13).Al lato del Parterre fu, infine, sgombrato il Gioco del Pallone, lo sferisterio costruito fra il 1847 e il 1851105 e usato a quel tempo come deposito dei materiali per la co-
103. Esposizione di Arte Moderna, cit., p. 12; La città e gli artisti. Pistoia tra avanguardie e Novecento, a cura di M. C. Mazzi e C. Sisi, Firenze, Nuova Italia 1980, p. 218.104. «Il Comune di Pistoia», I, n. 18, Pistoia, 6 agosto 1899.105. G. Beneforti, Appunti e documenti per una storia urbanistica di Pistoia 1840-1940, Pistoia, Tellini 1979,
13. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Lo stand della sezione di Arte Moderna che ospitò le opere di Fabio Casanova. Nella fotografia è facilmente riconoscibile il quadro Piazza del Duomo in giorno di mercato dell’artista pistoiese (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 36, fotografia di Pirro Fellini).
94
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
struzione del nuovo palazzo della Cassa di Risparmio: nel suo spazio circolare aveva trovato posto, infatti, l’allestimento del teatro all’aperto dell’Esposizione, che con i suoi spettacoli, concerti e gare di scherma rispondeva al delicato compito di attrarre ed intrattenere il pubblico in visita, offrendogli meritate pause distensive nel turbi-nio della manifestazione. «Istruire divertendo»: questo sarebbe del resto diventato lo slogan della più gaudente tra tutte le Expo, quella parigina del 1900. Ma ciò che probabilmente attirava i visitatori nello spazio sopraelevato del giardino assai più del teatro di legno – accolto in verità con una certa freddezza: «un teatro appartato, e rinchiuso, al quale si accede per un ingresso indecoroso, o meglio ap-pena decente per un teatro da burattini!»106, scriveva il periodico “Il Pistoia” –, era il servizio ristoro che, al riparo di «una piccola foresta dagli alberi secolari»107, aveva qui trovato il suo luogo privilegiato nell’afa estiva pistoiese.«Ai lati di questo [il Pantheon, N.d.A.] due eleganti chalets destinati, oh! gradevole scoperta, al ristoro delle arse fauci»108, riferiva con il consueto trasporto “La Penna”, descrivendo nient’altro che il chiosco per il servizio-caffè di Galileo Melani e quello per il ristorante a buffet dei signori Mini e Ferroni. «Questi conduttori nulla hanno risparmiato per rendere elegantissimo l’addobbo – assicurava “Il Popolo Pistoiese” – ed il pubblico vi troverà servizio inappuntabile e prezzi moderati»109.Un’ulteriore meraviglia attendeva poi di deliziare il pubblico in fondo al Parterre:
Un qualche cosa di grandioso, di monumentale si innalza là fra il folto delle an-nose piante... – È la botte!... esclama un signore, volgendosi alla metà... La vedi? – La domanda mi pare oziosa... È veramente una botte... da orbi. – Mi avvicino all’immenso recipiente... Oh! cielo! esso è pieno di belle signore, sorridenti, che alle labbra coralline accostano il bicchiere scintillante... L’interno del gran vaso è una saletta elegante, dipinta con gusto, sfarzosamente illuminata... È uno spirito di... vino110.
Costruita dal falegname Alfonso Natali e capace di ospitare ben 364.000 litri di vino, la botte altro non era, in effetti, che l’originale stand di uno dei più impor-tanti commercianti di vino di Pistoia, Giuseppe Pacini: un tipico esempio di quella tendenza al gigantismo e alla continua ricerca di stratagemmi strabilianti e mera-vigliosi, che fin dagli esordi aveva caratterizzato le Expo di tutto il mondo (fig. 14).Tuttavia, benché la botte avesse certamente colpito l’immaginazione dei pistoiesi – il periodico “La Penna” dedicò alla curiosa installazione una copertina illustra-
pp. 150-151.106. «Il Pistoia», III, n. 33, Pistoia, 19 agosto 1899.107. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.108. Ibidem.109 «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 29, Pistoia, 22 luglio 1899.110. «La Penna», IV, n. 60, Pistoia, 30 luglio 1899.
95
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
ta111 e perfino uno scherzoso componimento poetico112 – furono in realtà due le macroscopiche costruzioni, appositamente realizzate per l’Esposizione, che più di ogni altra trovata o invenzione suscitarono lo stupore generale: il cavalcavia, che collegava San Francesco con il cortile esterno dell’ex convento da Sala, e la monu-mentale porta di ingresso, che introduceva al giardino di piazza Mazzini e quindi all’intera Esposizione. Quest’ultima, in particolare, acquistò velocemente la valenza di un’icona e ben presto la sua raffigurazione a matita – duplicata su carta da lette-re, volantini e cartoline – fu eletta a sineddoche dell’intera manifestazione.
Un’opera di puro stile romanzo in perfetta armonia colla vicina chiesa di S. France-sco che è del periodo di transizione113.
111. «La Penna», IV, n. 64, Pistoia, 13 agosto 1899.112. «La Penna», IV, n. 67, Pistoia, 23 agosto 1899.113. «Il Pistoia», III, n. 33, Pistoia, 19 agosto 1899.
14. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La botte di Giuseppe Pacini al lato del Parterre nel giardino dell’Esposizione (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 18, fotografia di Pirro Fellini).
96
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
Così fu definita la porta dal periodico “Il Pistoia”, che si unì agli elogi generali, men-tre “La Nazione” spiegava nel dettaglio il motivo di tanto successo:
L’ingresso principale è un felicissimo esempio dello stile di transizione che segnò il passaggio fra «basso medio evo» e l’«Arco acuto». Esso si compone di tre corpi: quello centrale che sovrasta gli altri serve da atrio, i due laterali sono destinati uno alla direzione, l’altro all’Ispettorato della Mostra. Il disegno di codesto prospetto, la linea degli ornamenti non potevano essere più semplici né più eleganti114.
Il gruppo di tre figure muliebri, dipinte sulla cupola da Ugo Casanova – spiega-
114. «La Nazione», Firenze, 23 luglio 1899.
15. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. La porta di ingresso dell’Esposizione (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 45, fotografia di Pirro Fellini).
97
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
va il quotidiano – rappresentava la città di Pistoia, «maestosa per le forme e la sovranità»115, nell’atto di premiare, da una parte, l’Agricoltura e la Meccanica e, dall’altra, l’Arte («una ballerina nell’atto di fare una piruletta», secondo il giorna-le umoristico “La Penna”116). Un gusto per la decorazione allegorica e didascalica molto in voga all’epoca e già sparso a piene mani da Tito Azzolini nel progetto della Cassa di Risparmio117 (fig. 15).Anche la foggia neorinascimentale e moresca adottata per la porta non nasceva, del resto, da un capriccio del suo architetto Roberto Giannini, ma si poneva nel sol-co di quella ricerca di uno stile nazionale che, dopo l’unità politica del Paese, aveva segnato il volto urbanistico di molte città d’Italia. Le Esposizioni italiane, di fatto il modello in scala dell’urbe ottocentesca, furono il luogo della sperimentazione più stravagante: strutture disparate e assai disinvolte, caratterizzate da sequenze e combinazioni di stili fra i più diversi – pastiches eclettici e quanto mai sconnessi – sorsero come tante scenografie teatrali in occasione delle grandi manifestazioni espositive nazionali.E al pari dei posticci allestimenti scenici, gli edifici appositamente progettati e co-struiti per le Esposizioni nascevano già con la tara della caducità: era infatti un topos ormai assodato, a partire dalle esperienze di rilevanza internazionale, quello della prematura demolizione di tali strutture, che nella migliore delle ipotesi potevano al massimo aspirare ad un destino di riutilizzo e riciclo con funzioni del tutto diverse rispetto a quelle per le quali erano stati originate. Un esempio emblematico fu proprio il Crystal Palace londinese: la struttura temporanea, costituita da segmenti metallici e lastre di vetro prefabbricati118, a fine esposizione, dietro le insistenti ri-chieste della cittadinanza, fu convertita a Palazzo d’Inverno. Smontata e ricostruita a Sydenham Hill, divenne il simbolo dello svago dell’Inghilterra vittoriana, per finire poi bruciata nel 1936119.Eccezione illustre – e dunque passata alla storia – fu, al contrario, la Tour Eiffel, au-dace e spettacolare struttura architettonica costruita in occasione dell’Esposizione parigina del 1889, miracolosamente scampata alla distruzione e rimasta saldamen-te ancorata al suo posto, nonostante i continui e ripetuti attacchi delle élite arti-stiche e letterarie della città: «inutile e mostruosa», «disonore di Parigi», «odiosa colonna di ferro imbullonata», la definirono tra gli altri anche Maupassant e Zola120.A differenza di Paesi come l’Inghilterra e la Francia, l’Italia dal canto suo – in ri-tardo com’era sulla via dell’industrializzazione – limitò fortemente l’uso del ferro
115. Ibidem.116. «La Penna», IV, n. 63, Pistoia, 9 agosto 1899.117. G. Chelucci, Il Palazzo e la città, in «Un Palazzo nuovo di Stile vecchio». La Sede della Cassa di Risparmio di Pistoia (1897-1931), a cura di G. Chelucci, Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 2005, pp. 40-44.118. M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, cit., p. 25 nota 4.119. L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali 1851-1900, cit., pp. 43-44.120. Ivi, p. 34; M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-1911, cit., p. 9.
98
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
nelle proprie strutture espositive, privilegiando la costruzione di padiglioni ancor più provvisori ed effimeri: spesso realizzati in legno o addirittura – incredibilmente – in tela e in cartapesta, gli edifici delle esposizioni italiane avevano una durata straordi-nariamente limitata e circoscritta nel tempo.L’uso di materiali poveri, e la conseguente mancanza di sperimentazione e di in-venzione progettuale e architettonica, fecero sì che tutti gli sforzi fossero perciò concentrati nella ricchezza e nella fastosità delle decorazioni e degli ornamenti: lo scopo era la meraviglia fugace di un attimo – pochi giorni o settimane – e, come accadde anche con la finta pietra della porta e del cavalcavia pistoiese del 1899, il senso di durevolezza e di solidità, nella migliore delle ipotesi, veniva tuttalpiù de-mandato all’illusione di un semplice effetto trompe l’oeil121.A differenza della porta di ingresso e nonostante le buone intenzioni, la struttura che collegava San Francesco e il monastero da Sala – forse eretta a imitazione del ponte della recente Esposizione torinese del 1898 – non riuscì però soddisfacente nemmeno dal lato estetico: “La Penna” criticò la scarsa qualità artistica del lavoro che definì monotono, mentre “Il Comune di Pistoia” ribattezzò il cavalcavia «orri-bile ponte dei sospiri e delle bandierine»122. “Il Popolo Pistoiese”, dal canto suo, ne addossò infine la responsabilità all’Ispettore regionale ai Monumenti Guido Carocci e ai suoi numerosi veti tecnici123 (fig.16).La continua ricerca della soddisfazione estetica, della meraviglia e dello stupore del pubblico era, in effetti, un elemento a tal punto irrinunciabile nelle Esposizioni ottocentesche, che spesso, nell’esigenza di rincorrere i propri strabilianti obiettivi, i promotori finivano per affliggere pesantemente le casse delle manifestazioni, de-cretandone, talvolta, perfino la disfatta economica.Un destino dal quale purtroppo non fu immune nemmeno l’Esposizione pistoiese: nonostante l’impegno profuso dagli organizzatori, infatti, il pubblico pagante fu in-feriore alle aspettative e – cosa ancor più grave – innegabilmente scarso fu il ritorno pubblicitario per le ditte pistoiesi, a causa della poca e inadeguata réclame di cui si poté fregiare la manifestazione. L’«incanto malefico»124 fu perciò il beffardo nomignolo affibbiato all’impresa dai suoi detrattori, che in conclusione non si lasciarono sfuggire l’occasione per rin-facciare pubblicamente ogni pecca e mancanza al partito dell’Unione Liberale, dal quale l’iniziativa si era in ultima analisi originata.Nel bene e nel male, la Mostra circondariale rappresentò, in ogni caso, un momento saliente nello scenario economico, politico e sociale della città. Basti solo pensare che la ditta di carrozze di Aiace Trinci, il presidente dell’Esposizione, solo otto anni
121. M. R. Pessolano, L’Architettura e le Esposizioni italiane, in M. Picone Petrusa, M.R. Pessolano e A. Bianco, Le grandi esposizioni in Italia 1861-1911, cit., pp. 29, 46-47.122. «Il Comune di Pistoia», I, n. 18, Pistoia, 6 agosto 1899.123. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 22, Pistoia, 3 giugno 1899.124. «Il Popolo Pistoiese», XX, n. 43, Pistoia, 28 ottobre 1899.
99
L’incanto malefico. L’Esposizione circondariale di Pistoia del 1899
più tardi sarebbe stata acquisita dalla San Giorgio di Genova; ma in realtà già in pre-cedenza, fra il 1901 e il 1902, Pistoia avrebbe conosciuto sia la nascita della Camera del Lavoro, che il primo sciopero ad opera della Lega dei carrozzieri. Con il successivo deflagrare della prima guerra mondiale, infine, quest’epoca così tanto ricca di contraddizioni e contrasti, ma anche di fermento, entusiasmo e spe-ranza si sarebbe quindi chiusa definitivamente, tanto per l’Italia, quanto per la pic-cola città di Pistoia.
16. Pistoia. Esposizione circondariale del 1899. Il ponte o cavalcavia che collegava la chiesa di San Francesco al cortile esterno dell’ex convento da Sala (BCFP, Raccolta Alfredo Chiti, Materiale fotografico I, 1. Esposizione Circondariale a Pistoia 1899, 23, fotografia di Pirro Fellini).