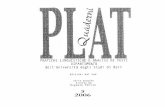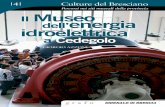F. Casalin (2010), “Il contributo della Guangxuehui al dibattito economico di fine Ottocento: il...
Transcript of F. Casalin (2010), “Il contributo della Guangxuehui al dibattito economico di fine Ottocento: il...
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMAFACOLTÀ DI STUDI ORIENTALI
LA CINA E IL MONDO
Atti dell’XI Convegno dell’Associazione Italiana Studi Cinesi
Roma, 22-24 Febbraio 2007
a cura di Paolo De Troia
COPIA PER L'AUTORE
Descrizione Collana di testi della Facoltà di Studi Orientali, della Sapienza Università di Roma, creata e di-retta da Angelo Arioli, si articola in diverse sezioni concernenti studi originali, ricerche, testi letterari, documenti, traduzioni, sussidi didattici, dizionari bilingue, miscellanee, atti congres-suali ecc. È uno spazio libero messo a disposizione degli studiosi, non soltanto della Facoltà di Studi Orientali e non necessariamente inquadrati nei ruoli universitari, anzi particolarmente ricettivo e ospitale soprattutto nei confronti di lavori presentati da giovani studiosi impegnati nella ricerca. I testi finora pubblicati e quelli che continuano a essere proposti hanno come ambito d’interesse il ventaglio di aree di ricerca connesse con le lingue, le civiltà, le culture, le società dei paesi dell’Asia e dell’Africa. I volumi finora pubblicati, ventidue in tre anni, riguar-dano prevalentemente il mondo arabo, la Cina, la Corea, l’Iran. Questa collana, grazie alla pre-ziosa collaborazione e al supporto tecnico delle Edizioni Nuova Cultura, si avvale del sistema di edizione print on demand che consente la rapida pubblicazione dei testi con costi pressoché inesistenti e sprechi di materiali e di tempi ridottissimi. “La Sapienza Orientale” non ha mai chiesto alcun finanziamento e funziona con l’impegno volontario di alcuni docenti che ne for-mano il corpo redazionale. Responsabile scientifico Angelo Arioli Comitato scientifico Angelo Arioli, Antonietta Lucia Bruno, Federico Masini, Paola Orsatti, Maria Teresa Orsi, Raffaele Torella Copyright © 2010 Edizioni Nuova Cultura - Roma ISBN: 9788861344921 Progetto editoriale: Angelo Arioli Grafica di copertina: Angelo Arioli. Redazione: Angelo Arioli, Arianna D’Ottone, Elisa Freschi, Daniela Pioppi. Si ringraziano Miriam Castorina, Luisa Paternicò e Emanuele Raini per l’aiuto prestato in fase di impaginazione ed editing. È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.
Questo volume è stato Stampato con tecnologia “print on demand” presso centro stampa Nuova Cultura - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma www.nuovacultura.it - per ordini: [email protected]
COPIA PER L'AUTORE
Indice
Premessa ............................................................................................................................……….9
PARTE 1 - STORIA 1.1. DAVOR ANTONUCCI
La “Tartaria” nelle fonti dei missionari gesuiti in Cina tra il XVI e il XVII secolo ........13 1.2. FEDERICA CASALIN
Il contributo della Guangxuehui al dibattito economico di fine Ottocento: il Wanguo gongbao ed altre pubblicazioni.................................................................................25 1.3. ELISA GIUNIPERO
Controversia sul termine cinese Kong-Kiao (Catholica religio) ............................................37 1.4. SOFIA GRAZIANI
“Per fare della nostra gioventù una gioventù rivoluzionaria”: la Lega della Gioventù Comunista negli anni 1962-1966...........................................................................49 1.5. ALESSANDRA C. LAVAGNINO
Mao e la Rivoluzione Culturale nella Cina di oggi: anniversari dimenticati? ................63 1.6. FLAVIA SOLIERI
Gennaio-febbraio 1949: la politica estera della nuova Cina in alcuni aspetti attuativi......................................................................................................................................77
PARTE 2 - CINEMA 2.1. CORRADO NERI
Chang Tso-chi: i nuovi occhi del cinema taiwanese...........................................................91
PARTE 3 - DIRITTO 3.1. AGLAIA DE ANGELI
Il codice penale della Repubblica Cinese e gli influssi occidentali.................................103
COPIA PER L'AUTORE
6 Indice
3.2. BETTINA MOTTURA
Esempi di scrittura amministrativa in materia di reclutamento dei funzionari pubblici in Cina (1994-2005) .................................................................................................115
PARTE 4 – ARTE E ARCHEOLOGIA 4.1. MICHELA BUSSOTTI
Rappresentazioni femminili nelle statuette religiose dell’Hunan centrale di epoca moderna e contemporanea...................................................................................129 4.2. PAOLA MORTARI VERGARA CAFFARELLI
Archeologia cristiana in Mongolia Interna. Una testimonianza dell’incontro tra la Cina e l’Occidente nel Medioevo. ..............................................................................141
PARTE 5 – LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA 5.1. MARCO FUMIAN
Un fenomeno letterario “con caratteristiche cinesi”: le origini del concorso Xin Gainian................................................................................................................................165 5.2. ANNAMARIA PAOLUZZI
Così lontano, così vicino: problemi di localizzazione nelle traduzioni italiane di opere narrative cinesi .......................................................................................................175 5.3. FEDERICA PASSI
Shanghai-Taibei (e ritorno): la corrente modernista nel XX secolo sulle due sponde dello stretto di Taiwan.....................................................................................187 5.4. NICOLETTA PESARO
Scrivere di narrativa: osservazioni sull’impostazione metodologica di alcuni manuali di narrativa cinese moderna.................................................................................199 5.5. SILVIA POZZI
Il letto di sabbia: Ge Hongbing e la scrittura del corpo al maschile...............................219 5.6. GIUSI TAMBURELLO
Shi tansuo: una rivista di poesia contemporanea...............................................................231 5.7. SERENA ZUCCHERI
Il fenomeno generazionale Xin xin renlei (La Più Nuova Umanità) e la nascita della letteratura web nella Cina contemporanea................................................253
PARTE 6 – CINA CONTEMPORANEA 6.1. ALESSANDRA ARESU
La salute sessuale e riproduttiva in Cina: sinergie nazionali e internazionali.............267 6.2. VALDO FERRETTI
Taiwan come problema strategico e militare per la RPC.................................................283 6.3. MARINA MIRANDA
Il “maoismo” di Hu Jintao .....................................................................................................2936.4. GIOVANNA PUPPIN
Il volto “nascosto” di Pechino: immagini e slogan dalla metropolitana.......................305
COPIA PER L'AUTORE
Indice 7
6.5. VALERIA ZANIER
Il discorso sul WTO nella stampa cinese.............................................................................325 6.6. LIVIO ZANINI
Tocca a te bere! Giochi conviviali e consumo delle bevande alcoliche in Cina ...........341
PARTE 7 – RELIGIONI E FILOSOFIE 7.1. ESTER BIANCHI, ARIANNA RINALDO
Cina e Tibet: Wutaishan come luogo di incontro..............................................................359 7.2. DANIELA CAMPO
Biografia del maestro Miaoxin Foyuan (1922/23- ), monaco eminente della Cina contemporanea ....................................................................................................3837.3. AMINA CRISMA
È possibile pensare la relazione con il pensiero cinese al di fuori della dicotomia Oriente/Occidente? Una quérelle ermeneutica nello scenario della globalizzazione..............................................................................................................395 7.4. MAURIZIO PAOLILLO
Un ragazzo venuto da lontano. Origine, fortuna e ruolo nel simbolismo spaziale di Pechino di Nezha, fanciullo divino ..................................................................411
PARTE 8 – ITALIA E CINA 8.1. MIRIAM CASTORINA
Guo Liancheng e il viaggio in Italia del 1859......................................................................427 8.2. BARBARA LEONESI
La Cina, la letteratura italiana e Lü Tongliu. Un progetto di traduzione lungo una vita.....................................................................................................................................441 8.3. ROSA LOMBARDI
La Cina d’inizio novecento nelle memorie e diari di viaggio di ufficiali della marina e aristocratiche italiane...........................................................................................451 8.4. VALENTINA PEDONE
Alcune analogie tra l’immagine pubblica degli immigrati cinesi di oggi in Italia e degli emigrati italiani del XX secolo nel mondo ............................................................463 8.5. GUIDO SAMARANI
Italia e Repubblica Popolare Cinese negli anni Cinquanta. Alcune considerazioni preliminari ...................................................................................................4858.6. VALERIA VARRIANO
Gli italiani nell’immaginario cinese: scene di un serial televisivo .................................495
PARTE 9 – LETTERATURA CLASSICA 9.1. BARBARA BISETTO
Memorie di mondi amorosi: raccolta letteraria ed enciclopedismo nel Qingshi leilüe………………... .......................................................................................................................519
COPIA PER L'AUTORE
8 Indice
9.2. PAOLO DE TROIA
L'imago mundi europea nella Cina del XVI e XVII secolo: alcuni problemi relativi alla traduzione del Zhifang waiji .............................................................................531 9.3. DONATELLA GUIDA
L’uso e le diverse accezioni di ài in tre romanzi di epoca mancese..........................541 9.4. FEDERICO MASINI
Note sulla Sinicae Historiae Decas Prima di Martino Martini .............................................555 9.5. ELISA SABATTINI
Dettami per il buon governo: analisi preliminare dell’etica di Jia Yi (200-168)..................................................................................................................................567 9.6. PAOLO SANTANGELO
Aggiornamenti su un progetto: dalla banca dati alla Encyclopaedia of Emotions and States of Mind. Più di un decennio di lavoro.................................................................581
PARTE 10 – LINGUISTICA E DIDATTICA 10.1. EMANUELE BANFI, GIORGIO FRANCESCO ARCODIA
Fenomeni di grammaticalizzazione in cinese mandarino e questioni di deriva tipologica ................................................................................................................599 10.2. ANTONELLA CECCAGNO, BIANCA BASCIANO
Complessità della morfologia del cinese ............................................................................617 10.3. MARIA ROSARIA GIANNINOTO
I repertori di cenemi di epoca tardo imperiale: il Jingzhuan shici...................................645 10.4. EMANUELE RAINI
Osservazioni sulla ridondanza fonologica e prosodica del putonghua.........................659 10.5. CHIARA ROMAGNOLI
Il Corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure in Cina ......................................673
COPIA PER L'AUTORE
FEDERICA CASALIN
Il contributo della Guangxuehui al dibattito economico di fine Ottocento: il Wanguo gongbao ed altre pubblicazioni.*
Breve storia della Guangxuehui
La Guangxuehui (Associazione per la diffusione del sapere) fu fondata a Shanghai nel 1894 sulle ceneri della Tongwen shuhui (Associazione libraria per il sapere congiunto), istituita nel 1887. Nota con il nome inglese di Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese, la Guangxuehui si prefiggeva il compito di tradurre, pubblicare e distribuire in Cina opere di carattere religioso e secolare, per diffondervi informazioni aggiornate sull'occidente e conoscenze scientifiche utili alla modernizzazione del Paese.
Figura chiave nella storia di questa istituzione fu il missionario Timothy Richard (1845-1919), che ne fu segretario generale per venticinque anni sotto la direzione di Sir Robert Hart (1835-1911). Oltre a missionari di spicco quali Allen Young (1836-1907), anche diversi commercianti, funzionari, medici, insegnanti e diplomatici provenienti dall'occidente contribuirono al lavoro della Guangxuehui,sostenendola finanziariamente e partecipando alle sue scelte editoriali.
Con la sua fervente attività pubblicistica, la Guangxuehui contribuì alla diffusione del sapere occidentale in Cina, cui già si dedicavano, fin dagli anni '60 del XIX secolo, due importanti organismi governativi, la Beijing Tongwenguan
(Scuola di lingue di Pechino) e il Jiangnan zhizaoju (Arsenale di
* Le ricerche svolte per la stesura di questo articolo hanno beneficiato del sostegno della Chiang-Ching Kuo Foundation, che ha assegnato all'autrice una borsa biennale di post-dottorato.
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 26
Shanghai).Poiché gli annali dell’associazione sono lacunosi per alcune annate, è difficile
stabilire il numero esatto delle opere pubblicate dalla Tongwen shuhui prima, dalla Guangxuehui poi. Secondo uno degli studi più dettagliati in materia,1 dal 1887 al 1900 sarebbero stati pubblicati 176 testi; dal 1900 al 1911 altri 461. Tra di essi una parte sono traduzioni, altri sono opere originali; di questi ultimi, il 29,93% riguardano la sola religione, il 51,63% sono di argomento secolare ed il restante 18,44% di carattere misto. Dall'inizio del XX secolo la proporzione di pubblicazioni di carattere religioso crebbe progressivamente a discapito delle pubblicazioni scientifiche; ciò contribuì al lento declino della Guangxuehui quale centro nevralgico per la diffusione del sapere scientifico occidentale in Cina.
Fra le opere secolari pubblicate entro la fine dell'Ottocento è possibile annoverare otto testi in parte o integralmente di argomento economico. Tra di essi si distinguono quattro testi di autori occidentali, su cui si concentrerà l'analisi a seguire. I testi di autori cinesi saranno auspicabilmente trattati in seguito.2
Alcune pubblicazioni di argomento economico della Guangxuehui.
Il primo testo in parte legato ad argomenti di carattere economico scritto in cinese da un occidentale per la Guangxuehui risale al 1895. Intitolato Xin zhengce
(Politica nuova), è frutto dell'elaborazione concettuale di Timothy Richard e si articola in quattro sezioni, dedicate rispettivamente all'educazione del popolo (jiaomin ), al suo sostentamento (yangmin ), al mantenimento della pace (anmin ) e al “rinnovamento” (xinmin ), inteso come modo per ridefinire ed aggiornare la concezione che i cinesi ancora avevano degli occidentali. Solo la seconda sezione tocca argomenti attinenti all'economia: vi vengono elencate dieci modalità utili a favorire la prosperità nazionale, tra le quali migliorare le vie di comunicazione, incrementare l'estrazione mineraria, lavorare le terre incolte, stimolare il lavoro, produrre macchinari, aprire banche, coniare moneta argentea, proteggere i commercianti, tenere un promemoria delle azioni intraprese e
1 Wang Shuhuai (1971: 365-396). 2 Rientrano in questo gruppo le seguenti opere: Yangmin youfa shuo
(Discorso sui metodi per nutrire il popolo, 1892), Fuguo yangmin shuo (Discorso su [come] arricchire il Paese e nutrire il popolo, 1893), Li shuikou yi li tongshang(Migliorare l'accesso alle vie fluviali per migliorare il commercio, 1894), Yingguo banxing gongsi dingli (Statuto della società di emissione inglese, 1895. Questo testo, ad oggi irreperibile, parla forse della Zecca di Stato).
COPIA PER L'AUTORE
Federica Casalin 27
ancora da compiere.3
Una riflessione più originale su argomenti di vera e propria teoria economica è contenuta nell'opera Shengli fenli zhi bie lun (Sulla distinzione tra produzione e consumo), pubblicata nel 1897.4 Il testo, di circa seimila caratteri suddivisi in due juan, è firmato da Timothy Richard e propone una riflessione approfondita su due componenti fondamentali del meccanismo economico, la “produzione” e il “consumo”, resi rispettivamente con i composti shengli e fenli .
Il primo juan definisce il concetto di “ricchezza” (li ) e analizza i modi per produrla. A tal proposito Richard afferma che essa è generalmente frutto del lavoro di diverse persone, non di una sola; egli sostiene poi che, salvo rare eccezioni, il lavoro non produce ricchezza in modo diretto o immediato; pertanto anche chi produce macchinari e utensili o sposta beni da un luogo all'altro contribuisce a produrre ricchezza; allo stesso modo, vi contribuiscono tanto il lavoro manuale che quello intellettuale. L'autore sottolinea poi che, per produrre ricchezza, occorre prendersi cura della “forza lavoro”, provvedendo alla sua formazione, alla sua educazione e al mantenimento delle sue qualità fisiche ed intellettuali; illustra infine come la produzione di ricchezza possa trarre beneficio dall’innovazione tecnologica. Nel secondo juan Richard definisce il concetto di fenli, da intendersi - per contrapposizione al bisillabo fencai (consumo) - come “consumo improduttivo”. 5 L'autore chiude il testo augurandosi una riduzione dei consumi non produttivi e l'aumento della produzione per il benessere individuale e collettivo.
Di natura molto meno speculativa è l'opera Zhongguo duozhi kao(Indagine sul sistema fiscale cinese), stampata nel 1897 dalla Meihua shuguan
su richiesta della Guangxuehui.6 Il testo, tradotto da Allen Young e firmato dal
3 Data la natura ibrida del testo, Liang Qichao (1896: , 2) scelse di catalogarlo nella
sezione intitolata Xiren yilun (Dibattiti degli occidentali) anziché in quella Shangzheng (letteralmente “politica commerciale”, da intendersi forse come una prima resa lessicale
del concetto di “economia politica”). 4 Come si avrà modo di leggere in seguito, i contenuti dell'opera erano già stati
formulati qualche anno prima. 5 Richard Timothy (1897: 7). Rientra in questa categoria l'acquisto di beni di lusso come
gioielli. 6 Per ristrettezze finanziarie, nel 1890 la Guangxuehui dovette riunciare alla stampa
autonoma. Le sue pubblicazioni furono da allora stampate dalla Meihua shuguan con sede a Shanghai.
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 28
Console inglese di Shanghai George Jiamieson,7 consta di 37 capitoli ed esamina con dovizia di dati numerici il complesso di tasse, imposte e balzelli applicati all'epoca nell'Impero Qing. Esso offre, nella seconda metà, una disamina dello stato delle finanze delle varie province. Più che di un'opera di teoria economica, si tratta di un rapporto analitico sul funzionamento e sullo stato di salute del fisco cinese.8
Riflessioni originali ed innovative in materia economica sono infine contenute nel volume Fuguo zhenli (Principi per arricchire il Paese), pubblicato dalla Guangxuehui nel 1899. L'opera, composta di quindici capitoli, è firmata da Christopher. T. Gardner, all'epoca Console di Xiamen. Non si riscontrano riferimenti a fonti straniere, il che induce ad ipotizzare che i contenuti siano stati formulati dallo stesso Gardner e dettati oralmente al traduttore, un inglese chiamato Shan Yagu , la cui identità non è nota.
Fin dalla premessa l'autore mette in evidenza l'approccio liberista che sottende alla sua analisi: partendo dal presupposto che “sebbene nessuno debba rimanere senza cibo, tuttavia gli abitanti di un Paese non possono godere di uguale ricchezza” (fan ren bu neng wu shiyong, dan guozhong zhi min, pinfu bi bu neng jun ), Gardner invita i suoi lettori a “pensare prima a come arricchire il Paese e a considerare solo in un secondo momento come distribuire la ricchezza” (qing xian si fuguo zhi fa, zai si fenqian zhi fa
). Egli elenca poi dodici suggerimenti per arricchire il Paese, facendo affidamento sulla divisione del lavoro, sulla libera circolazione dei beni e delle persone, sulla specializzazione dei lavoratori, sullo sviluppo degli strumenti bancari e creditizi e, in particolar modo, sull'istruzione. Solo gli ultimi cinque capitoli del Fuguo zhenli affrontano il problema della distribuzione. Vi domina l'idea, confermata nel capitolo intitolato Junfu(Sull'equa distribuzione della ricchezza), che le differenze economiche siano inevitabili e che solo la carità dei ricchi, unita all'intervento statale, possa
7 Lo stesso Jamieson risulta essere l'autore del testo Revenue and Expenditure, with an
Appendix on Indian Salt, pubblicato dalla Guangxuehui a Shanghai nel 1903. Non è stato ancora possibile confrontare il testo in lingua inglese con il Zhongguo duozhi kao. Un'edizione di quest'ultimo del 1903 contiene il frontespizio del volume in lingua inglese. Ciò induce ad ipotizzare una sostanziale affinità tra i contenuti delle due opere.
8 Data la natura del testo, Xu Weize (1899: 6. Ed. 1902: juan I, 15) colloca l'opera nella sezione Zhengzhi falü (Politica e legge), sottosezione Zhengzhi (Politica), per poi spostarlo, nell'edizione aggiornata del 1902, all’interno della sezione relativa alla Storia (shizhi
), sottosezione Politica.
COPIA PER L'AUTORE
Federica Casalin 29
alleviare la miseria dei poveri.
Articoli di teoria economica nel Wanguo gongbao .
Nel 1889 la Guangxuehui assunse la direzione del Wanguo gongbao (di seguito abbreviato in WGGB), pubblicato con il titolo inglese The Chinese Globe Magazine. Il periodico era stato fondato a Shanghai il 5 settembre del 1874, come continuazione del settimanale Jiaohui xinbao , o The Church News.Quest'ultimo, inaugurato a Shanghai nel 1868 da Allen Young, era inizialmente concepito per i cinesi convertiti al cristianesimo ed era pertanto connotato, soprattutto nei primi tempi, da un forte accento religioso.9
Rispetto al predecessore, il WGGB conteneva pochi articoli di argomento religioso e più notizie di attualità. Secondo Allen, che assunse la direzione della nuova testata, essa doveva essere dedicata “alla diffusione della conoscenza relativa alla geografia, alla storia, alla cultura, alla politica, alla religione, alla scienza, all'arte, all'industria e al generale progresso dei Paesi occidentali.”10 La pubblicazione del WGGB continuò fino al luglio del 1883, quando fu temporaneamente sospesa per insufficienza di fondi. Il WGGB tornò a circolare nel febbraio del 1889 grazie al sostegno della Guangxuehui, continuando poi senza ulteriori interruzioni fino al dicembre del 1907.
Fin dai primi numeri, il WGGB ospitò diversi articoli sull'andamento del commercio internazionale e sull'economia dei Paesi stranieri, limitandosi però a riportare informazioni di carattere quantitativo ed evitando generalmente riflessioni di natura teorica.
Il periodico iniziò a trattare diffusamente di economia sotto la direzione editoriale della Guangxuehui, con particolare frequenza a partire dal 1892. Ad esclusione di pochi articoli scritti da letterati cinesi, tra i quali spicca per frequenza il nome di Wang Tao (1828–1897), gli autori di tali articoli erano generalmente stranieri residenti in Cina, per la maggior parte missionari, più raramente funzionari del governo britannico. La maggior frequenza di articoli firmati da autori occidentali si riscontra nel 1893, '94 e '95, con un nuovo picco nel 1898 ed un progressivo declino negli anni successivi. Con l'inizio del XX secolo la pubblicazione di articoli di economia si esaurisce (tabella 1).
Al giugno del 1892 risale il primo articolo significativo: firmato dal missionario
9 Benett Adrian Arthur (1983: 122-123, 135-137). 10 Britton Roswell (1976: 53).
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 30
Joseph Edkins (1823-1905), si occupa di tassazione, richiamando brevemente il pensiero di due economisti definiti “tedeschi”.11 Al lavoro di traduzione di Joseph Edkins va attribuito anche un lungo testo pubblicato a puntate a partire dal n. 43 dell'agosto 1892 fino al n. 88 del maggio 1896, in modo pressoché continuativo, con sole tre interruzioni (nei numeri 45, 61 e 63, usciti rispettivamente nell'ottobre del 1892, nel febbraio e aprile del 1894), per un totale di 43 puntate.12
Il testo in questione si intitola Fuguo yangmince (Strategie per rendere ricco il paese e per nutrire il popolo), ed è la traduzione di un breve manuale di economia politica di William S. Jevons (1835-1882) pubblicato nel 1878 con il titolo di Political Economy.13 La traduzione era stata realizzata dallo stesso Edkins per conto dello Zong shuiwusi nel 1886. La pubblicazione del FGYMC a puntate sul WGGB si protrasse per quasi quattro anni: su ogni numero, infatti, venivano riportati solo tre o quattro dei cento paragrafi in cui è suddiviso il testo di Jevons, con tendenza a ridurli progressivamente ad uno o due a partire dal '94.
Negli stessi anni il WGGB ospitò anche altri articoli di argomento economico di autori diversi, a partire da due pezzi pubblicati nell'aprile e maggio del 1893 con titoli tra loro affini: il primo, intitolato Shengli fenli zhi fa (Sui metodi per produrre e consumare) è firmato da Timothy Richard; del secondo, intitolato Lun shengli fenli zhi bie (Sulla differenza fra produzione e consumo) non si conosce l'autore; è tuttavia ragionevole supporre che si tratti dello stesso Richard. Questa ipotesi è suffragata dal confronto con il libercolo pubblicato dalla Guangxuehui nel giugno del 1897 con il titolo Shengli fenli zhi bie lun
, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Attribuito integralmente a Richard, esso risulta essere la collazione dei due articoli del 1893, che vengono però presentati nell'ordine inverso, così da trattare prima della produzione e poi del consumo.
I numeri del WGGB del 1894, oltre alle puntate del FGYMC, contengono altri due articoli di economia firmati da autori stranieri; entrambi parlano di
11 WGGB (1892: 12854-12856). Il primo, il cui nome cinese è Sasi , è molto
probabilmente Emil Sax (1845-1927), economista e studioso di scienza delle finanze austriaco, tra i primi ad applicare la teoria dell'utilità marginale allo studio della finanza pubblica. Il secondo, chiamato Fu Kaiwei , è di identità ancora incerta.
12 Vedi anche Yang Daichun (2002: 133). 13 Salito alla ribalta per un manuale pubblicato nel 1871 con il titolo di Theory of Political
Economy, Jevons è considerato uno dei padri fondatori della cosiddetta “scuola marginalista”. Sul Fuguo yangmince vedi Casalin (2006: 101-116). Yang Daichun (2002:133) ritiene erroneamente che Edkins abbia “tradotto la teoria esposta da Adam Smith ne La ricchezza delle nazioni,aggiungendovi la propria opinione su alcuni problemi economici della Cina”.
COPIA PER L'AUTORE
Federica Casalin 31
tassazione.Pubblicato ad agosto con il titolo Shuihan yaoli (nel sommario in
inglese reso come On taxation),14 il primo dei due contributi è firmato da Bu Fangji , nome cinese del missionario americano Francis Lister Hawks Pott (1864-
1947). Il testo introduce il pensiero di Adam Smith sulla tassazione, che deve essere: a) equa, ovvero proporzionata alla ricchezza del singolo (xu zhaogong nashui ); b) applicata secondo tempi fissi (nashui xu you dingshi
); c) riscossa tenendo conto dei tempi più favorevoli per il cittadino (zhengshui zhi shi ying cheng min bian ); d) non onerosa nella sua applicazione (shuili jingfei bu ke yue fen ).
Pott spiega poi che esistono diversi sistemi fiscali e che ogni Paese deve scegliere quello che più gli è consono. In particolare, esistono otto metodi di tassazione, ovvero: 1) sul reddito annuale individuale (cha ren meinian suoru zhi shu
); 2) sulle successioni (jiexu yichan ); 3) sul prodotto agricolo (tianchan yi yi nashui ); 4) sui beni immobili e sui beni preziosi (chakan minjian huawu ji caiwu furao ) ; 5) sulla persona (chakan rending ); 6) sull'importazione ed esportazione (guanshui
); 7) sulla licenza per lo svolgimento di alcune attività commerciali (you ji xiang shengyi xu gou juanpiao ), come la gestione di teatri, locande e simili; 8) sul servizio postale e telegrafico nazionale (guo zhong xu she youzhengju, dianbaoju ) attraverso l'applicazione di ticket (yinpiao ) per gli utenti. Dopo aver rilevato come la Cina – pur essendo più grande e più popolosa di qualsiasi paese europeo – avesse un gettito fiscale minore, Pott conclude il suo articolo invitando l'amministrazione Qing ad applicare almeno uno dei metodi di tassazione proposti, suggerendo in particolare quello sul reddito individuale o quello sulle successioni, o ancora quello sulle attività commerciali particolari e sui servizi postali. Pott esclude la tassa sul prodotto agricolo.
Di diversa opinione è il secondo articolo sulla tassazione, pubblicato nel 1894 con il titolo Yi dizu zhengshui lun (Sulla tassazione attraverso la rendita fondiaria).15 Il pezzo è firmato da William Macklin (1860-1947), un medico canadese inviato in missione in Cina negli anni '80. L'autore introduce la sua riflessione sul sistema fiscale proprio osservando come l'articolo di Pott “trascuri solo [un metodo, ovvero] la tassazione della rendita fondiaria (shao dan zheng dizu yifa ). Tale metodo consiste nell'esazione di denaro e derrate alimentari sulla rendita (zai dizu shang qu qianliang ye ).
14 WGGB (1894: 14576-14580). 15 WGGB (1894: 14844-14846).
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 32
L'ammontare del contributo non deve variare in funzione della estensione del fondo, quanto piuttosto del suo valore.
È questo il primo di tanti interventi in materia economica da parte di Macklin che, nel decennio preso in esame, risulta essere uno degli articolisti più prolifici, con dieci pezzi al suo attivo. Risultano strettamente legati al primo intervento del 1894 altri due articoli, uno del luglio 1897 (Zai lun yi di zheng shui zhi yi
, ovvero “Nuovamente sui vantaggi di tassare la terra”)16 e uno del giugno 1899, su “I vantaggi della cessione al pubblico della rendita fondiaria” (Lun dizu gui gong zhi yi ).17 Nel primo l'autore ribadisce i vantaggi derivanti dalla determinazione di una rendita per tutti i terreni, mentre nel secondo espone i fondamenti teorici della sua tesi, cercando di coniugare la tradizione filosofica cinese con il pensiero economico occidentale. Con sapiente equilibrio egli richiama da una parte la teoria del jingtian (le terre a pozzo), il pensiero di Mencio e quello di Confucio, dall'altra la teoria di Ricardo sulla rendita fondiaria, che traduce come tianzu lun e quella di Malthus, che riassume nella locuzione ren duo shi shao zhi yu .18
Mentre i nomi di Ricardo e Malthus non erano completamente estranei ai lettori cinesi, ancora totalmente sconosciuto in Cina era invece Henry George (Zhuoerjishi ), che Macklin nomina per la prima volta nel WGGB nel 1897 e, più diffusamente, in una serie di articoli apparsi sul WGGB nel 1899. Macklin doveva peraltro conoscere in dettaglio il pensiero dell'economista americano, considerato il fatto che si sarebbe occupato personalmente di tradurre per intero il saggio di George On Progress and Poverty e lo avrebbe pubblicato – presumibilmente tra il 1898 ed il 1899 - con il titolo di Zumince (noto anche come Fumince ).19
Nessun riferimento ad economisti occidentali si riscontra invece nella serie intitolata Fuguo xince (Nuove strategie per arricchire il Paese) pubblicata a puntate sul WGGB tra il febbraio del 1898 e il gennaio dell'anno seguente, con un solo numero di interruzione. Il titolo della serie viene reso, nel sommario in
16 WGGB (1894: 16991-16993). 17 WGGB (1894: 18550-18554). 18 Sia Ricardo che Malthus erano già stati presentati ai lettori cinesi nel 1880 dal Fuguoce
, un manuale di economia politica tradotto in cinese nel 1880 per conto della BeijingTongwenguan.
19 Non mi è stato ancora possibile consultare l'opera, che non figura nei cataloghi di traduzioni pubblicati ad inizio secolo e risulta difficile da rintracciare. Alcuni storici, tra cui Bernal Martin (1976) e Xia Liangcai (1986) hanno già messo in evidenza come il pensiero di Henry George abbia fortemente condizionato quello di Sun Yat-sen.
COPIA PER L'AUTORE
Federica Casalin 33
lingua inglese con cui si aprono quasi tutti i numeri del WGGB, come PoliticalEconomy. La collazione degli articoli, il primo dei quali è firmato dal console C. T. Gardner, risulta essere una versione parziale dell'opera pubblicata dalla Guangxuehui nel 1899 con il titolo di Fuguo zhenli .20
Le posizioni fortemente liberiste espresse da Gardner nella serie Fuguo xinceindussero Macklin ad intervenire polemicamente, proponendo un punto di vista opposto. Così si legge nella “Premessa al Zumince”, pubblicata sul WGGB nel luglio del 1898: “in Occidente vi sono sostanzialmente due modi per creare ricchezza: uno consiste nell'accumulo di denaro da parte dei ricchi per creare società e imprese […], l'altro nella creazione di unioni dei lavoratori per migliorare il proprio status. […] Poiché fino ad ora la traduzione di opere in lingua cinese ha privilegiato il primo modo, io sosterrò il secondo”.21
Il medico canadese approfondisce il suo punto di vista in una serie di quattro articoli pubblicati sul WGGB all'inizio del 1899,22 subito dopo la conclusione della serie Fuguo xince di Gardner. Citando Smith, Ricardo, Mill e MacCulloch, Macklin dapprima critica “la maggioranza degli economisti contemporanei, che sovrastimano il capitale sottostimando il lavoro […].23 “Sebbene il capitale non debba mancare, è un grosso errore affermare che gli operai siano colpiti dalla povertà perché non c'è abbastanza capitale per nutrirli. La loro povertà dipende dai bassi salari, il che a sua volta dipende dal fatto che il limite alla proprietà terriera è troppo basso. I salari dipendono dalla terra. Quando il limite posto sulla proprietà terriera diminuisce, la tassa fondiaria aumenta e di conseguenza i salari diminuiscono progressivamente”.24
La lunga disquisizione di Macklin sul rapporto tra i tre fattori produttivi in qualche modo chiuse il dibattito in materia economica sulle pagine del WGGB. Gli articoli del medico canadese, accomunati nel frontespizio in lingua inglese dal titolo complessivo di Discussion on Political Economy, furono seguiti solo da una breve serie intitolata Licai jielüe , resa in inglese come On Financial Reforms. Pubblicata tra il febbraio e il giugno del 1900, essa si compone di cinque numeri, tutti firmati da F. E. Tayler, all'epoca Segretario statistico delle Dogane
20 Oltre a qualche variazione nella struttura interna, si riscontra nel WGGB l'assenza dei
cinque capitoli relativi alla distribuzione della ricchezza.21 WGGB (1898: 17810). 22 Secondo Bernal Martin (1976) solo gli ultimi due articoli della serie fanno parte del
Fumince. Per Xia Liangcai (1986: 41-42), invece, il volume coinciderebbe con la serie completa di quattro articoli, inclusa la premessa apparsa sul WGGB nel 1898.
23 WGGB (1899: 18412). 24 WGGB (1899: 18417).
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 34
cinesi. Più che di concetti e teorie, gli articoli di Tayler sono densi di dati statistici volti a dimostrare l'importanza del commercio con l'estero per il benessere del Paese.
Conclusioni
Considerato il numero e la varietà delle sue pubblicazioni, la Guangxuehui sidistinse nella vita culturale cinese di fine Ottocento come un istituto particolarmente attivo e prolifico. Alcune delle opere di argomento economico da essa pubblicate riscossero l'apprezzamento di autorevoli letterati coinvolti nel progetto di modernizzazione del Paese, incluso il giovane Liang Qichao (1873-1929).25 A ciò contribuì forse la strategia adottata dalla Guangxuehui per garantire una buona diffusione alle proprie pubblicazioni, le quali non solo venivano distribuite gratuitamente in occasione degli esami ufficiali, ma venivano spesso anche pubblicizzate o recensite sulle pagine del WGGB, il più famoso dei periodici editi dalla Guangxuehui.
Così, ad esempio, il WGGB funse da cassa di risonanza per il Fuguo yangmince,un testo innovativo che forse pochi avevano avuto modo di leggere integralmente nell'edizione originaria del 1886. Oltre a garantire maggior diffusione a testi esistenti, il WGGB funse anche da trampolino di lancio per pubblicazioni imminenti. Questo fu ad esempio il caso dello Shengli fenli zhi bie lun di Richard, le cui riflessioni apparvero una prima volta sul mensile nel 1893 per poi essere riordinate e rielaborate in un testo unico a cura della Guangxuehui quattro anni dopo. Casi analoghi sono quelli del Fuguo xince di Gardner e dello Zumince diMacklin, di cui si è parlato prima. Un cenno va fatto anche, a questo proposito, al Zhongguo duozhi kao, di cui il WGGB pubblicò in anteprima nel 1897 la prefazione e la postfazione, quest'ultima firmata dal traduttore Allen Young.26
In termini quantitativi, la maggioranza degli articoli di argomento economico pubblicati sul WGGB uscirono tra il 1892 ed il 1896, quando fu riportato a puntate l'intero testo del Fuguo yangmince. Va però osservato che la fase più vivace del dibattito si colloca tra il 1898 ed il 1900, ove si riscontra un vero e proprio confronto, con toni a volte polemici, su argomenti economici di varia natura.
25 Oltre al già citato volume intitolato Xin zhengce, egli incluse nella sua “Bibliografia del sapere occidentale” anche il testo di Richard sulla produzione e consumo; vedi Liang (1896). Da questo Liang avrebbe tratto ispirazione per una propria riflessione in materia, intitolata Lun shengli fenli , pubblicata nel 1902.
26 WGGB (1897: 17147-52).
COPIA PER L'AUTORE
Federica Casalin 35
Il fermento di quegli anni non durò però a lungo: con l'inizio del nuovo secolo le pubblicazioni di economia della Guangxuehui si ridussero drasticamente. Fenomeno analogo si registra fra le pagine del WGGB.27 Contemporaneamente cominciavano a diffondersi nell'Impero Qing testi di economia tradotti dal giapponese, i quali avrebbero presto scalzato il monopolio degli istituti di traduzione fioriti in Cina nell'Ottocento, Guangxuehui compresa.
Tabella 1: articoli di economia sul WGGB tra il 1892 e il 1902.
27 Yang Daichun (2002) concorda su questo aspetto.
18921893189418951896189718981899190019011902
0 2 4 6 8 10 12 14 16
COPIA PER L'AUTORE
La Cina e il Mondo Storia 36
Bibliografia
BENNETT A. A., (1983) Missionary Journalist in China: Young Allen and his Magazines,1860-1883, Athens.
BERNAL M., (1976 ) Chinese Socialism to 1907, Ithaca and London.
BRITTON R. S., (1933) The Chinese Periodical Press, 1800-1912, Shanghai. (Ristampa: Taibei 1976).
CASALIN F., (2006) L’introduzione del pensiero economico occidentale in Cina e il suo impatto sulla formazione del lessico cinese moderno (1818-1898), Roma.
LIANG QICHAO , (1896) Xixue shumu biao (Bibliografia del sapere occidentale), in Zhixue congshu shuji (Prima collezione di testi di scienze applicate), Wuchang, Appendice, 9-10.
RICHARD T., (1897) Shengli fenli zhi bie lun (Discorso sulla distinzione fra produzione e consumo), Shanghai.
WANG SHUHUAI , (1971) “Jidujiao jiaoyuhui ji qi chuban shiye ” (L'associazione pedagogica protestante e la sua attività
pubblicistica), in Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan, 2, pp. 365-96.
Wanguo gongbao (WGGB), Young A. (a cura di), Shanghai 1874- 1882; 1889-1907. (Ristampa: Taibei 1968).
XIA LIANGCAI , (1986) “Lun Sun Zhongshan yu Hengli Qiaozhi · ”, in Jindaishi yanjiu , 36, pp. 38-55.
XU WEIZE , (1899) Dongxixue shulu (Bibliografia del sapere orientale e occidentale); (edizione aggiornata: 1902).
YANG DAICHUN , (2002) «Wanguo gongbao» yu wan Qing Zhongxi wenhua jiaoliu (Il Wanguo gongbao e l'interscambio
culturale tardo Qing), Changsha.
COPIA PER L'AUTORE