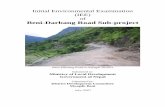STANCO F., TANASI D., La computergrafica nella ricerca archeologica. Dal 3D Modeling alla Digital...
Transcript of STANCO F., TANASI D., La computergrafica nella ricerca archeologica. Dal 3D Modeling alla Digital...
F
LU.Jlu!lu di l\Iatcmatica e
S . .A.A.S. Universit?t di ]~xinc\
Abstract
The recent
brought new tools can be
features of an archaeological site with the creauon
tnodel including every data the
605
Pel-
a nmltidimensional
606
the research focused on the
particular on the 'v'''"L"·'
the research of
archaeo!~gy, 3D Polizzdlo.
nomo definito
T I
607
ciose e assai raramente si avvicinano con esattezza alla realta archeologica. Ben alti·a cosa sono i modelli tridimensionali realizzati da equipe congiunte eli informatici e archeologi, in seno ad alcuni progetti di ricerca, con lo scopo eli fornire ricostruzioni esatte sulla base eli tutte le classi cu dati ricavabili da uno scavo archeologico. Alcuni lavori cu questo tipo applicati alla preistoria del Mediterraneo centrale sono, ad esempio, quelli prodotti dall'U niversita eli Bristol su Malta (Chalmers e Debattista, 2005) e dall'Universita cu Southampton in Sicilia (Sturt et al., 2007). Gli obiettivi eli questo, che appunto si pU<) chiamare an:haeolo,gical 3D mode/i,zg, so no quincli aumentare le possibilita interpretative dell'archeologo attraverso la realizzazione eli paesaggi virtuali e superare la tradizionale documentazione archeologica grafica e fotografica con l'archiviazione eli modelli tridimensionali upgradabili.
Su questa linea si pone il programma eli ricerca eli d~g,ital archaeolo,_gy chiamat:o progetto Archeomatica (ww\v.archeomatica.unict.it), nato dall'incontro sinergico tra due organi eli ricerca dell'lJniversita di Catania, il Centro eli Archeologia Cretese (ww\v.tmict.it/ cac.ct), diretto da Vincenzo La Rosa e dall'b;tt(ge ProceJJin,g Lab (www.dmi.unict.it/iplab), direrto da Giovanni Gallo. Il progetto, coorclinato dagli autori, ha lo scopo eli investire nello sviluppo eli nuovi applicativi informatici per la ricerca archeologica in modo cla aumentare il processo di integrazione e eli mmuo scambio eli esperienze tra le due discipline, con una particolare attenzione alle tematiche dell'archeologia pre-protostorica. L'attivita eli ricerca attualmente si articola in tre principali tematiche eli studio.
1) L' r~rchaeolo_gical 3D modelitzg applicato alle architetture pre-protost:oriche con approccio eli tipo filologico che tenga in considerazione tutte le classi eli dati provenienti dallo scavo archeologico;
2) L'applicazione eli tecniche eli comp11!er !Ji.rion e pat/ern tt?i/(J,_gnilion per la realizzazione cu un sistema automatizzato per lo studio della ceramica dello stile Kamares (Farinella et al., 2008);
.3) L'utilizzo de1/a.rencanner per 1a realizzazione eli repliche tridimensionali eli manufatti e per integrare e completare i m.odelli architett:onici virtuali.
Nel presente contributo si illustreranno in manicra preliminare i primi risultati ottenuti nel campo della modellazione tridimensionale presentando i due casi studio di lhghia Triada (Creta) e J'vlontagna eli Polizzello eli Mussomeli (Sicilia). Come strumento di 3D modelz~g si e scelto eli utilizzare Blendt?r (www. blender.org), un software multi-piattaforma e open .roun.:e per la modellazione,
601;
il cs trernamcnte
aperto ad implementazioni in base
scttori.
la creazione e la
1. - Piarrla eli 'friada con 1\uea aper1a tra b Villa e iJ in evidenza.
609
L'esistenza eli un'area aperta a Nord della Villa e eli un edificio certamente non abitativo nello st:esso settore, lasciava insoluto sia il problema della sistemazione eli tale spazio e della sua funzione che quello delle possibilita eli accesso al villaggio. Preliminarmente alla ricostruzione 3D e stato svolta un'indagine dettagliata delle caratteristiche fondanti dell'architetture minoica (Shaw, 1971; H.itchcock, 2000) sulla base dei repertori rappresentati sui vasi in pietra (\'V'arren, 1969) e sugli affreschi (Hue, 1989; Boulotis, 1990) contemporanei aile strutture oggetto dello studio.
La ripulitura nella campagna eli scavo del2006 eli akune strutture nell' area in questione, gia indagate ma non interpretate nel primo decennio del secolo scorso, ha consentito eli localizzare l'esistenza eli un ingresso monument:ale sistemato con unpropylon (La Rosa, 2006).
La necessiti eli analizzare l'organizzazione complessiva eli questo settore del complesso monumentale ha t:rovato soluzione nell'applicazione della tecnica del JD nzodelif{~, secondo un approccio il piu possibile filologico. Quasi esattamente al centro dellato nord dell'area aperta si ergeva il propylon (Militello, 2008) che aveva la sua faccia piu monumentale, provvista verisimilmente eli due colonne, proprio rivolta verso lo spazio aperto e la Villa stessa (l''igura 2a).
Il prospetto posteriore prevedeva invece un sernplice ingresso, non allineato, che clava su una rarnpa in dolce penclio che rappresentava l'asse straclale piu importante del villaggio (Figura 2b).
l'igura 2- (a) Pianta del prop)'lon; (b) il proj?y!on vis to da Sud.
6!0
La versione vettorializzata della pianta c stata
state eseguite le integrazioni
grafici. ll successivo ha
proponendc1 fedelmente la tessitura muraria dei filari
scomparsi, e 1a creazione a parte come le coionne
H riesame delle evidcnze archeologiche,
3 -· JJcU'area aperta, il
In mentano
turc dei due
e la .•iorJ
b
cdifiu
611
e che sulla fronte del ;"?ropy/on aggettassero le testate delle travi lignee che dovevano sostenere il soffitt:o, ricoperte di stucco policromo. Dopo l'estrusione dell'oggetto bidin1cnsionale si e proceduto all'applicazione di specifiche texttt
re al rnodello wireframe, che sono state generate proceduralmente a partite da texture primi.tjve cmnbinate tra loro al fine di ottenere i diversi materiali come, stucco, legno, pietra e terra battuta. Oltre ad indicate il colore delle superfici le texture hanno suggerito al renderer delle piccole variazioni sull'angolazione della superficie al fine eli simulate la granularita specifica dei singoli materiali. Nella meta orientale dellato nord, l'area aperta era delimitata da una possente struttura in grossi blocchi squadrati che i primi scavatori avevano enoneamente interpretato come un bastione clifensivo e che va piuttosto intesa corne magazzino direttament:e collegato alia Villa reale. J_,a restituzione del prospetto del cosiddetto bastione e stato realizzato creando dei solidi inclividuali relativi ad ogni singolo hlocco. Le dimensioni eli ogni solido sono state generate all'interno del rmzge che e stato calcolato in base alla pianta eli strato relativa al filare eli fondazione. Perla generazione dei filari dell'elevato si e riproposto lo schema della fondazione con l'applicazione di un elernento di dist:urbo ricavato dalle funzioni eli Kenneth Perlin (Perlin, 2002). lnolt:re alle pietre del bastione e stato aggiunto un effetto di suddivisione delle superfici per smussare gli spigoli vivi. Relativamente alle fonti di luce, per esigenze di cakolo, si e utilizzato pet gli .rcreembot il programma eli rqytradn.g Yajl\a_y (Shirley e Morley, 2003) che offre una qualita dell'immagine prossima al realismo, n1entre pet il video, che vedrem.o, si e preferito il motore eli renderin.g interno eli Blender che pur proponendo una resa qualitativa di poco inferiore garantisce un processo generativo piu rapido. I modelli 3D del propylon e della .rtoa in questo caso sono stati inseriti in un paesaggio virtuale astratto in cui il rnodello e stato creato pattendo da una griglia forrnata da vertici equidist:anti a cui e stato applicato un di.~p/aceme11tsub-poligonale, che ha utilizzato come input una texture generata tramite l'algoritmo eli Musgrave (Erbert et al., 1998) (F'igura 4). Tra le molte conquiste ottenute, spendibili anche nei carnpi della valorizzazione dei beni culturali o della didattica, il pili importante risultato conseguito testa innanzitutto la possibilita da parte degli archeologi eli comprendere meglio la natura delle strutture pottate in luce, attraverso un processo di semplice osservazione del modello multidim.ensionale, suggerendo significativi spunti all'attivita di ricostmzione del passato.
612
Figura 4- Modello 3D cttJo/o d't4etd!o dell' area apcrta tra Villa e villaggio, il pro;?JJon e b .rtor't.
II sacello B di Polizzello (Sicilia)
Un significativo riscontro delle possibilita dell' an:haeolosira/ 3D mode!in,g c stato offerto dall'applicazione sulle evidenze scoperte nd sito siciliano della Montagna di Polizzello, presso Mussomeli, oggetto dall'anno 2000 delle ricerche di una missione congiunta della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta e dell'Universita di Catania, sotto la direzione scientifica di Rosalba Panvini e Dario Palermo (Palermo, 2006; Tanasi, 2007) .
. Arroccato su una montagna alta oltre 880 m (Ji'igura 5), il sito articolato in diverse tcrrazze, ha conosciuto una continuita di frec1ucntazione clal X fino al IV sccolo a.C., con un momento eli massima fioritura intorno al VII-V[ secolo a.C. quando sull'acropoli si sviluppo un importante santuario indigeno, caratterizzato chlla presenza eli graneli recinti sacri a pianta circolare e mistilinea, comunemcnte chiamari sacelli e denorninati con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E. Uno degli edifici piu in1portanti del santuario eli VII-VI secolo a.C., e senza dubbio il cosiddetto sacello B (Palermo, 2006; Tanasi, 2007). Si tratta eli un grande recinto sprovvisto eli copertura, di circa 10 m di diamet:ro, con accesso dallato sud, cui si addossa ad l~st: un piccolo ambiente annesso semicircolare dotato eli vestibolo (F-'igura 7 e 8a). Costruito con pictnme a secco e tecnica a doppia cortina catnpita a emp!ecton, al cent1·o presentava un grande focolare c lungo i muri vi crano dementi eli arredo in pietra, come bancl1ine o arc. All'estcrno, in corrispondenza dell'ingresso, e st:ato rnesso in
613
luce un ampio tratto sul
sono rivenuti stato conservazmne 182 oggetti, tra em
vasi, armamenti, nwdellini fittili e ornarnenti in ambra, avorio e in 17 gn1ppi, chiarnati l)i estrerno interesse sono
nn·n·P•i"h. di CUltCJ in terracotta e metalio rinvenuti, che
religiosita rninoica, tra la
zello e (· attestato
con rappresentazione
fernminili eburnee di
. ., - Pianta
di oplita
subdedalico
la
del saccllo B . 8-3D '''lCeHo
interna cd cstcrna.
6!4
durale una fcJto aerca
applicate le nate txa loro al fine di ottenerc i diversi materiali ccJme terra e
9). ;\
em erano 1rnrncrs1
getti riunificate in un unico fine al modeHo dei
eli generate un
Figura 9 .. Ricostrm:ione 3D del sa cello B con i l' alta
re e la
Riferirnenti
Boulotis C., 1990, bitat egeen prehistoriCjliC'',
1990, 421459,
615
la ad una luce diuma,
Paris
6!6
Chalrners
Kaufmann Publisher, San
Evans ·r.L., P., Ar Bridging method
h. Natick, 193 pp.
Militello P., 2008, mtoJJopropylon ad · red!!lali
Antica 9,