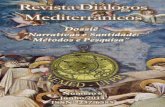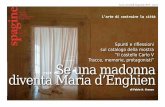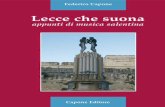TESTIMONIANZE CULTURALI E FUNERARIE NEL TERRITORIO DI SALVE (LECCE)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of TESTIMONIANZE CULTURALI E FUNERARIE NEL TERRITORIO DI SALVE (LECCE)
Dal 2005, in seguito alla segnalazione dei nostri collaboratori Paolo Cosi e Nicola Feb-braro, è stato avviato un lavoro sul terreno in località Macchie Don Cesare cosiddetta dal-l’omonima masseria, non lontana dal centro di Salve (fig. 1).Il territorio di Salve è noto in letteratura per avere restituito importanti testimonianze
pre e protostoriche, che hanno permesso di ricostruire a grandi linee le modalità di po-polamento dalle fasi più antiche fino a epoche recenti (fig. 2).Grotta Montani (Cremonesi 1980) conservava, nella sua pur ridotta stratigrafia, stru-
menti litici attribuibili a una fase arcaica del musteriano salentino e, in superficie, altri ma-nufatti genericamente riferibili al paleolitico superiore.A Grotta Triscioli I (Febbraro 2005-06), pressoMasseria Cantoro, furono rinvenuti, ol-
tre a molti frammenti ceramici, un vaso in stile Serra d’Alto e una tazza monoansata del-l’età del bronzo, prelevati direttamente dalla Soprintendenza.Masseria Spigolizzi (Ingravallo, Piccinno 1983) ha rivelato i resti di un insediamento
protoappenninico e tracce di un altro più o meno coevo vennero alla luce durante lo sca-vo del sito messapico di Masseria Fano (Descoeudres, Robinson 1993), meglio noto co-me La Chiusa.Si conoscono, inoltre, alcune grandi specchie ridotte ormai a ruderi: tali sono la spec-
chia Cantoro, la specchia di Spigolizzi e quella dei Fersini o Cucuruzzi (Febbraro 2005-06).Da ultimo, nonmeno importanti, sono stati individuati due dolmen (Febbraro 2005-06):
il dolmen Cosi in cui furono rinvenuti ossa umane e due vasi probabilmente protoappenni-nici, consegnati alla Soprintendenza al momento della scoperta, e il dolmen Argentina-Gra-ziadei svuotato in antico.Si è trattato, dunque, di intervenire in una situazione in parte nota nelle sue dinami-
7
TESTIMONIANZE CULTURALI E FUNERARIE NEL TERRITORIO
DI SALVE (LECCE)
Elettra Ingravallo* – LecceIda Tiberi* – Lecce
Norma Lonoce* – LeccePier Francesco Fabbri* – Lecce
SOMMARIOAlcuni tumuli in territorio di Salve (Lecce) atte-stano il rito dell’incinerazione entro vasi nel Sa-lento del III millennio con forme ceramiche rife-ribili a Laterza e Gaudo.Contemporaneamente, sempre nel Salento, è do-cumentata l’inumazione in grotticelle naturali oartificiali con deposizioni plurime e forme vasco-lari di tipo Laterza-Cellino.
ABSTRACTSome tumuli in the territory of Salve (Lecce) attestthe ritual of cremation in pots in Salento in thethird millennium BC with ceramic forms related toLaterza and Gaudo. In the same period, always inSalento, it is testified the inhumation in natural orartificial caves with multiple burials and vascularforms of the Laterza-Cellino type.
XXIX, Nuova Serie IV, 2007, pp. 7-31ORIGINI
8
Ingravallo et alii
Fig. 1 – Localizzazione del sito di Salve (LE).
che insediative ma che, tuttavia, ha ancora bisogno di essere meglio definita anche in rap-porto alle vicende che hanno interessato l’intero Salento durante la preistoria.Nello specifico, la località Macchie Don Cesare si rivela interessante per la presenza dif-
fusa di formazioni tumuliformi costituite da accumuli di pietre, di forma subcircolare edimensioni variabili ma mediamente con diametro di 8-10 m e altezza di 50-60 cm.L’intera area è interessata dalle ultime pendici della Serra Casavecchia e Fontane che,
localmente, corrispondono a quella nota come Serra di Spigolizzi dall’omonima masse-ria, in corrispondenza della quale raggiunge il punto più elevato (110 m slm).Il versante nord-orientale della Serra di Spigolizzi è delimitato, fino al mare, dalla valle del
Canale del Fano, un’incisione che si sviluppa lungo due rami pressoché paralleli. Il versantemeridionale, invece, degrada verso il mare con la presenza di numerosi fenomeni carsici, trai quali la Grotta Montani.
ITUMULI
Un primo sguardo di insieme sui tumuli sparsi in un ampio raggio e spesso occulta-ti da una bassa vegetazione di macchia, rivelava leggere differenze morfologiche dal mo-mento che alcuni si presentavano più compatti e raccolti con una accentuata forma co-nica e base circolare, altri più espansi e schiacciati avevano un perimetro in gran parteovale.
Complessivamente ne sono stati indagati sei, scelti sulla base delle due differenti tipo-logie. Nella prima, in quella della maggiore regolarità (circolari e ben compattati) rientranodue (nn. 3, 5), a circa 500 m SO dalla Masseria Don Cesare, che si sono rivelati privi diinteresse archeologico perché dovuti a opere di spietramento recente.L’intera zona, infatti, fu sottoposta a bonifica nel secondo dopoguerra e non è impro-
babile che molti dei tumuli censiti derivino dal lavoro di pulizia del terreno da destinarea usi agricoli.Altri due tumuli (nn. 2, 4, anch’essi nell’area distante circa 500 m SO dalla masseria
Don Cesare), invece, di forma allungata e a distanza di 16 m uno dall’altro, rispettivamentedi m 5 x 4 e di m 8 x 5, orientamento EO, presentavano una sistemazione di base a gran-di blocchi regolarmente giustapposti e frammenti di ceramica di impasto sparsi alla base.In particolare, il tumulo 4 era contornato da grandi blocchi posti di taglio lungo tutto
il perimetro esterno. Nella sua parte centrale, una volta liberata dalle pietre di superficie,emergeva una struttura costituita da grossi massi posti in una cavità naturale della rocciala cui base era stata regolarizzata con uno spesso pacco di terra rossa profondo dagli 80 ai60 cm dal piano di campagna. Qui erano numerosi frammenti di impasto comprenden-ti non solo pareti ma anche orli, fondi e bugne, genericamente attribuibili all’età dei me-talli.Due, infine (nn.1, 6), si sono rivelati monumenti funerari.Entrambi di forma oblunga, hanno restituito vasi in ceramica e resti umani combusti.
9
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Fig. 2 – Evidenze pre-protostoriche del territorio di Salve: 1, insediamento di Spigolizzi; 2, La Chiusa alla Masseria Fa-no; 3,Dolmen Cosi; 4,Dolmen Argentina – Graziadei; 5, Grotte Triscioli I e II; 6, Tumulo 6; 7, Tumulo loc. MasseriaDon Cesare (da indagare); 8, Tumuli 2 – 3 – 4 – 5; 9, Tumulo 1; 10, Tumulo loc. Masseria Palicelli (da indagare); 11,Tumulo loc. Masseria Profichi (da indagare); 12, Grotta Montani; 13, Specchia Cantoro; 14, Specchia Spigolizzi; 15,Specchia Fersini (a cura di N. Febbraro).
Tumulo 1 (fig. 3)
Il tumulo 1, a circa 300 m SO di Masseria Don Cesare, lungo 10 m, largo 6 m e altocirca 60 cm, con orientamento EO lungo il suo asse maggiore, aveva il perimetro circon-dato da blocchi di medie e grandi dimensioni. Tolte le pietre di superficie, ha rivelato unapiattaforma basale di grandi massi sistemati in un’ampia cavità della roccia: la tipologia èmolto simile a quella del tumulo 4. All’estremità occidentale, ai margini del tumulo, ad-dossato a un lastrone era uno scodellone ovoide contenente un altro vaso molto deterio-rato decorato con fasci di incisioni: in esso, oltre a terra, erano le ossa combuste di un adul-to probabilmente di sesso femminile e di un bambino di età compresa tra i 5 e i 9 anni.Appoggiato allo scodellone era, inoltre, altra parete di grande vaso tronco-conico di cui è
10
Ingravallo et alii
Fig. 3 – Salve (LE), Tumulo 1: prima e dopo lo scavo (foto di S. Pellegrino).
difficile dire se rotto in antico o in gran parte perso per cause postdeposizionali. Sparsa sulresto della superficie, ma maggiormente concentrata verso sud, era una grande quantitàdi minuscoli frammenti, alcuni dei quali hanno restituito parte di brocchette con alto col-lo tronco-conico e corpo globulare decorate con leggere solcature.Tumulo 6 (fig. 4)
Il tumulo 6, a circa 700 m a nord dal tumulo 1, si trova in località l’Aparo di Valen-tini, cosiddetta per la presenza di un apiario, probabilmente risalente all’800, dalla ti-pica conformazione a giardino chiuso e difeso da alti muri con dentro una costruzionerurale, una parte della quale adibita ad alveare. È uno dei pochi esemplari rimasti deitanti censiti nel Salento, a testimoniare l’importanza della produzione di miele nell’e-conomia salentina tra ‘700 e ‘800 (Imbriani, Mainardi 1997).Il tumulo è a circa 20 m NO dall’apiario, ha profilo circolare, diametro 10 m, altez-
za circa 60 cm. Anch’esso, una volta liberato dalle pietre di superficie, ha rivelato unastruttura basale a grandi blocchi dal profilo ellissoidale, con orientamento EO. Nel la-to meridionale erano tre vasi impilati: il primo, ovoidale, conteneva un vaso troncoco-nico con, dentro, un altro vasetto.Nella parte centrale, una ciotola a calotta conteneva denti appartenenti a un bambino
di età compresa tra 3 e 5 anni. Intorno erano denti di tre adulti e una fibula di giovane di11-13 anni insieme ad altre ossa e frammenti ceramici, alcuni dei quali hanno restituitoforme ricostruibili.
Si è in presenza, dunque, di due tipi di monumenti accomunati da una piattaforma ba-sale a grandi blocchi coperta con terra e pietre: alcuni, privi di resti umani ma con ma-nufatti ceramici forse rotti intenzionalmente, potrebbero essere interpretati come luoghidi culto.Altri sono monumenti sepolcrali in cui è attestato il rito incineratorio con l’uso di
impilare presumibilmente tre vasi presso una delle estremità del tumulo e di depornealtri nelle vicinanze o verso il margine opposto. Nel tumulo 1 resti bruciati erano chia-ramente contenuti in uno dei vasi posti all’estremità occidentale, nel tumulo 6 eranosparsi nella zona centrale apparentemente senza ordine o, meglio, in parte contenuti inalcuni dei vasi frammentari.Le tipologie vascolari rinviano agli aspetti di Laterza e del Gaudo.La datazione ricavata da un osso umano del tumulo 6 è: 2600-2300 a. C.
L’ENEOLITICO TRA IV E III MILLENNIO
Una rapida rassegna delle consuetudini funerarie del III millennio con il relativo trat-tamento dei defunti nell’Italia centro-meridionale evidenzia la peculiarità delle testimo-nianze appena esaminate.I rimandi ovvii sono agli aspetti del Gaudo (Bailo Modesti 2003), Laterza e Rinaldone
(Cazzella 2003; Cazzella, Silvestrini 2005; Dolfini 2004) con cui si è soliti nominare gliaspetti dell’Italia meridionale e centrale, ben sapendo che nessuna delle tre denominazio-ni esaurisce la complessità dei territori di pertinenza.
11
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Fatte salve le differenze che, inevitabilmente, si riscontrano nelle relative tipologie, sipuò affermare, tuttavia, che l’insieme dei tre aspetti è accomunato dall’uso di sepolturemultiple o singole che prevedono l’inumazione dei defunti con deposizioni primarie e se-condarie e ulteriori manipolazioni quali ossilegio o sconnessione.Il Gaudo viene normalmente identificato con la consuetudine di seppellire gruppi pro-
babilmente parentelari in grotticelle artificiali dotate di pozzetto d’accesso. È un aspettoabbastanza circoscritto come areale, ricorrendo in ambito esclusivamente campano.Più sfuggente è la realtà di Laterza forse anche per la sua maggiore estensione geografi-
ca: è attestata, infatti, oltre che in Puglia, in Basilicata, Lazio e Campania. In essa coesi-stono tombe a grotticella artificiale con elementi strutturali meno definibili rispetto al poz-zetto del Gaudo, grotte naturali e tombe a fossa.
12
Ingravallo et alii
Fig. 4 – Salve (LE), Tumulo 6: prima e dopo lo scavo (foto di S. Pellegrino).
Ugualmente articolato è l’aspetto di Rinaldone, che presenta anch’esso la combinazio-ne di grotte naturali, artificiali e tombe a fossa.Qualora si voglia affrontare il problema dell’insorgenza delle nuove sensibilità che han-
no condotto agli esiti sopra accennati, è noto che le datazioni di molti siti marchigiani e,in parte, laziali fanno risalire al IV millennio le prime manifestazioni eneolitiche legate alcomplesso rinaldoniano.Eguale antichità possono, probabilmente, vantare gli altri aspetti, per i quali, però, la
maggior parte delle date disponibili si addensa attorno al III millennio.In realtà la transizione neo-eneolitico è ovunque avvenuta nel IV millennio senza rot-
ture vistose sul piano archeologico ma che hanno agito in profondità se è vero che nel IIImillennio niente rimane del vecchio mondo neolitico.Se fosse possibile circoscrivere gli ambiti territoriali in cui seguire genesi e sviluppo dei
rispettivi mutamenti culturali, al IV millennio bisognerebbe rivolgersi dal momento chenel III il cambiamento appare già compiuto.In un arco compreso tra 2800 e 2300 a.C. si assiste a una tale mescolanza di tipologie
differenti – siano esse ceramiche o funerarie – da rendere impossibile una loro perimetra-zione geografica oltre che cronologica. Le presumibili “aree nucleari” diventano esse stes-se evanescenti. I tumuli di Salve, per fare un esempio, sembrano privi di un retroterra cul-turale che li giustifichi e ne spieghi il raccordo con le tradizioni locali. Anche essi, proba-bilmente, sono il portato di quel rimescolamento che seguì alla fine del neolitico, quan-do – sotto l’urto di più fattori alcuni dei quali imponderabili – si verificò dappertutto unariorganizzazione dei vecchi assetti socio-economici.Abituati a considerare il rito incineratorio come dovuto alle comunità del medio bron-
zo, la sua scoperta nel III millennio sorprende e induce a guardare al passato con occhimeno schematici.Si viene scoprendo, così, un quadro estremamente mosso in cui la prospettiva della lun-
ga distanza impedisce di riconoscere ciò che nel III millennio si presenta con caratteri diinnovazione o di conservazione, come dire che perdono valore diagnostico elementi untempo ritenuti di sicura attribuzione crono-tipologica.Ciò che è dato cogliere, al momento, del III millennio è la grande porosità delle sin-
gole comunità, la loro capacità di assorbire e rielaborare tutto ciò che circola, le identitàmultiple e fluide che ne derivano.
SITI DI ABITATO E NECROPOLI
Molto difficile è – allo stato attuale – rintracciare i nessi tra siti abitati e necropoli, nelsenso di annodare legami tra gli uni e le altre che, oltre al rapporto geografico, ricostrui-scano la rete dei significati e delle connessioni culturali.Ad allargare lo sguardo oltre la dimensione funeraria per tentare di renderla meno avul-
sa dalle concrete realtà territoriali, contribuisce la scoperta dei siti d’abitato.A questo riguardo l’Italia centrale offre, attualmente, il maggior numero di evidenze,
tra le quali sono da privilegiare quelle che alludono all’organizzazione sociale di cui sonoespressione.Nell’area a sud est di Roma è da segnalare una fitta rete di insediamenti nell’area di Mac-
13
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
carese, in particolare Le Cerquete-Fianello (Manfredini 2002) con la ricchezza straordi-naria di documentazione, tra cui la sepoltura di cavallo, il più antico finora conosciuto inambito peninsulare (3370-3040 a. C.).I materiali hanno una forte impronta locale, pur ispirandosi a forme e ornati largamente
diffusi nel centro peninsulare.Cerquete, sorto su una penisola protesa su uno stagno, può essere considerato un’area-
campione delle scelte insediative e delle strategie di sopravvivenza di una delle tante co-munità che, più o meno contemporaneamente, abitarono l’intera zona.L’architettura delle capanne a pianta ellittica con partizioni interne, la distribuzione de-
gli spazi esterni allestiti per attività quotidiane, la probabile destinazione a cimitero, o co-munque a luogo di culto, di una parte del villaggio come lascia supporre il rinvenimentodi una tomba a fossa e di un cranio nella parte meridionale, rivelano una consumata artedell’abitare in cui habitat e sua manipolazione concorrevano a un efficace modo di pro-duzione autosufficiente e in cui un ruolo di primo piano spettava all’attività rituale: nonlontana dalla sepoltura del cavallo, infatti, è la sepoltura di un neonato in un fondo di va-so coperto da un altro fondo capovolto.A sud-est di Roma la presenza di tre siti pressoché contemporanei – Piscina di Torre
Spaccata (Bietti Sestieri, Gianni 1988), Quadrato di Torre Spaccata (Anzidei, Carboni2007) e Osteria del Curato (Anzidei et alii 2007) – fornisce motivo di riflessione su: lapresenza diffusa di Laterza con strutture d’abitato in una regione tradizionalmente rite-nuta lontana dal suo areale d’origine (il sud-est peninsulare) dove, invece, latita sotto que-sto aspetto; la prossimità di aspetti culturali diversi con la comunanza di forme e di ornatiche travalica i confini geografici loro convenzionalmente attribuiti.Laterza, Rinaldone, Gaudo, Ortucchio si rivelano, così, per quello che sono: strumen-
ti euristici, come tali semplificazioni, con cui cercare di rendere intelligibile una realtà po-limorfa, altrimenti imprendibile.Nelle Marche, oltre a numerosi siti posti in aree interne come Conelle, i quali però con-
servano scarsi resti delle strutture abitative, è da menzionare la particolarità di Maddale-na di Muccia (Manfredini et alii 2005) dove è venuta in luce, oltre a strutture accessorie,una serie di capanne absidate all’interno di uno spazio organizzato per lo svolgimento diattività artigianali. Tra i materiali è significativa la presenza di vasi con decorazione di ti-po Laterza e la frequentazione del sito si pone tra 2800 e 2300 a.C.In Italia meridionale, all’assenza di evidenze abitative fa eccezione il villaggio di facies
Laterza dell’area “Forum” di Gricignano (Fugazzola et alii 2003) con la vicina necropoli.Il villaggio si compone di numerose capanne dal profilo subellittico con i lati brevi absi-dati e molte altre strutture come recinti e pozzi. Sorprendente è l’affinità con le capannedi Muccia con la quale Gricignano condivide anche l’arco cronologico che è compreso,egualmente, tra 2800 e 2300 a. C.La necropoli, in parte posteriore ad alcune capanne, è fatta di tombe a fossa rettango-
lare, di tombe a fossetta subellittica e di tombe a “pseudo-grotticella”. Tutte con deposi-zione singola. Le prime contenevano individui in connessione anatomica con un vaso percorredo, quasi mai ricomponibile per intero, per cui è da pensare che venisse rotto primadel seppellimento; le seconde solo resti sconnessi; le tombe a “pseudo-grotticella” eranocaratterizzate da uno sgrotto per la deposizione di un singolo inumato.
14
Ingravallo et alii
Un villaggio analogo a quello dell’area “Forum” è stato scoperto, sempre a Gricignano,nell’area “Centro commerciale US Navy” con tombe, anche qui, di diversa tipologia (Fu-gazzola et alii 2007).In sostanza, Gricignano, Cerquete, Maddalena di Muccia costituiscono, per ora, gli
esempi più significativi, in Italia centro-meridionale, di quale poteva essere il modello abi-tativo di alcune comunità tra IV e III millennio con caratteristiche strutturali abbastanzasimili e con una scansione degli spazi interni che lascia immaginare lo svolgimento di sva-riate attività artigianali accompagnato dall’osservanza di regole condivise e interiorizzate.A cementare lo spirito di appartenenza e a rinvigorire l’ordine sociale provvedevano le mol-teplici pratiche del rituale che – come in tutti i consessi di vita associata – avrà contem-plato anche lo scherzo, il gioco, la festa la cui perdita rientra nel novero delle esperienzeinconoscibili dell’umanità.
LATERZA E IL SUD-EST ITALIANO
In riferimento alle attività rituali e alle possibili informazioni sulla struttura socia-le ricavabili dalle caratteristiche antropologiche e culturali delle necropoli, c’è da os-servare che Laterza, al momento, offre il minor numero di elementi a riguardo, poi-ché – se si esclude il sito eponimo – non si hanno evidenze di necropoli propriamen-te dette.Nel Salento, per esempio, era nota finora sotto l’aspetto Cellino San Marco, quando le
uniche evidenze sembravano riferibili esclusivamente alle grotticelle artificiali o naturalicon deposizioni multiple (Ingravallo 2002). La datazione di Salve attesta, invece, la pre-senza pressoché contemporanea di un’altra forma di rituale.Il fatto che le due modalità siano coesistite pone interrogativi circa la loro vera o pre-
sunta contrapposizione in tema di concezione dell’al di là.Normalmente si tende a vedere nel rito inumatorio la credenza in una qualche forma
di sopravvivenza nell’oltretomba, dove il corredo (vasellame soprattutto) garantisce le fun-zioni elementari. Il rito incineratorio, invece, annullerebbe l’inumato e con lui ogni resi-duo di materialità per proiettarlo direttamente nella sfera ultraterrena.La presenza del corredo, tuttavia, nei tumuli di Salve renderebbe meno drastica l’op-
posizione dal momento che la quantità di vasi per cibi e bevande suggerirebbe, anche qui,la credenza in una sorta di continuità oltre la morte.Nel resto della regione si hanno esempi paragonabili a Grotta Cappuccini come Grot-
ta Nisco (Venturo 2004; Radina 2006) o ritrovamenti singoli come la tomba della minieradi Valle Sbernia (Tunzi Sisto 1991) o quella di Gioia del Colle (Gervasio 1913) o la tom-ba di Casone (De Juliis 1975). Non sempre è riportato il numero esatto di individui se-polti o la distinzione per sesso ed età, per cui – di fronte alla difformità dei dati – è im-possibile delineare un quadro sia pure approssimativo della distribuzione territoriale digruppi in possesso di specifiche modalità rituali.I tumuli di Salve introducono un ulteriore elemento di novità qual è il rito incineratorio.Per trovare esempi in qualche modo assimilabili ad esso in Italia centro-meridionale oc-
corre rimanere in ambito campano ma in contesti differenti: si tratta di Succivo (Mar-zocchella 1998) e Taurasi (Talamo 1998; 2004; 2006).
15
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
16
Ingravallo et alii
A Succivo – in occasione dei lavori Treno Alta Velocità – furono trovati due vasi inte-gri contenenti resti incinerati.A Taurasi – all’interno di strutture delimitate da pietre o da buche da palo– vennero in
luce incinerazioni entro vasi o in fossa.Nell’uno e nell’altro caso le forme ceramiche hanno affinità con Gaudo.Senza confronti rimane, però, l’uso dell’incinerazione entro tumulo.È un fatto inedito che apre nuovi scenari sulle società del III millennio nel Salento, ri-
proponendo il problema delle loro ideologie con i rispettivi modi di vita.e. i.
I MATERIALI
I manufatti rinvenuti nei tumuli di Salve sono quasi esclusivamente ceramici.Nei tumuli interpretati come luoghi di culto (nn. 2-4) questi erano relativamente ab-
bondanti ma non è stato possibile risalire ad alcuna forma vascolare. Nel tumulo 2, in par-ticolare, furono recuperati esclusivamente frammenti di parete mentre nel tumulo 4 eranoanche elementi tipologici quali orli, bugne, frammenti di prese e un probabile coperchio.Dalla piattaforma basale del tumulo 4 provengono, inoltre, un elemento di probabile pic-cone su calcare a profilo trapezoidale con incavo alla base per l’immanicatura e un pestel-lo rettangolare su ciottolo con margini levigati e tracce di picchiettatura su un’estremità.Diverso il discorso per i tumuli sepolcrali (nn. 1-6) dove sono state recuperate forme
integre e frammenti riferibili a recipienti in parte ricostruibili. I recipienti vascolari, in im-pasto semifine e fine di colore bruno rossiccio, con superfici levigate, talora lucidate, era-no così distribuiti:
Tumulo 1 (fig. 5)
All’estremità occidentale, addossato a un lastrone:1. Uno scodellone ovoidale inornato (h.19,5 cm; diam. orlo 26 cm; sp. pareti 0,6 cm) conorlo non distinto e labbro appiattito, ansa verticale con profilo ad anello impostata sulcorpo e fondo piatto ombelicato.
2. All’interno, vaso dalla forma non ricostruibile perché molto deteriorato contenenteossa combuste; di esso restano l’orlo leggermente estroflesso con labbro appiattito el’attacco di un’ansa a nastro verticale. L’orlo è decorato con una coppia di linee inci-se orizzontali da cui pendono, sul corpo, triangoli campiti a tratteggio obliquo e pa-rallelo.
3. Appoggiato allo scodellone ovoidale, grossa parete di scodellone troncoconico.
Sul lato meridionale:4.-5. Grande concentrazione di minuscoli frammenti da cui è stato possibile ricostruire so-
lo il profilo di alcune brocchette globulari. Esse hanno collo troncoconico alto 5 cmdecorato a sottili solcature orizzontali parallele, orlo non distinto (diam. di 9 cm) conlabbro arrotondato, spalle convesse decorate a solcature con andamento verticale o obli-quo, ansa verticale impostata tra collo e spalla, fondo convesso.
17
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Fig. 5 – Salve (LE), Tumulo 1: i materiali (scala in cm; dis. A. Guercia, A. Potenza).
Confronti e considerazioni
Anche se ricostruibili solo parzialmente, le brocchette rinvenute nel tumulo 1 sono ri-conducibili, per forma e decorazione, a recipienti analoghi rinvenuti in contesti funeraridella facies del Gaudo come, ad esempio, Pontecagnano, Buccino, Mirabella Eclano, Pae-stum, Piano di Sorrento (si tratta del tipo n. 70 A-B-D, Bailo Modesti, Salerno 1998: fig.49), Taurasi (Bailo Modesti et alii 1999: fig. 6).A differenza delle brocchette globulari tipiche del Gaudo, gli scodelloni, siano essi ovoi-
dali o troncoconici, sono forme che trovano ampia diffusione nell’eneolitico dell’Italia cen-tro-meridionale. Si possono istituire, dunque, solo confronti generici per quanto riguar-da la morfologia di questi recipienti. Per fare alcuni esempi, si ricordino, nel Salento, legrotte Trinità (Cremonesi 1978: fig. 1, 3-4, fig. 2, 1, 3-5; Ingrosso 1997b, nn. 24-27), Cap-puccini (Ingravallo 2002, nn. 46-47), Veneri (Ventura 1997: n. 45), Grotta Grande delCiolo (Ingrosso 1997a: n. 3) e, sempre in Puglia, la tomba 2 di Laterza (Biancofiore 1967:fig. 12) e Grotta Pacelli (Striccoli 1988: fig. 57, 6). Come esempi nelle altre regioni si ve-dano: in Campania i contesti funerari della facies del Gaudo come Piano di Sorrento, Pon-tecagnano, Mirabella Eclano (si tratta del tipo n.160 B1-B2-B3, Bailo Modesti, Salerno1998: fig. 53) e Taurasi (Bailo Modesti et alii 1999: fig. 6); nel Lazio, l’abitato di Macca-rese (Manfredini 2002: fig. 40, 2; fig. 44, 1; fig. 45, 1) e, nelle Marche, le necropoli di Ca-merano (Baroni, Recchia 2005: fig. 3, 3-7) e di Fontenoce – area Guzzini (Silvestrini etalii 2005: fig. 2, 3).Per quanto riguarda le decorazioni, oltre alle solcature sulle brocchette va ricordata an-
che la decorazione incisa a fasci di linee parallele sul vaso contenente l’incinerazione, rea-lizzata probabilmente con uno strumento a pettine.La tecnica a pettine trascinato, tradizionalmente attribuito alla facies di Ortucchio, è
largamente utilizzata in tutta l’Italia centrale, oltre che nella produzione di Laterza, comenella tomba 3 (Biancofiore 1967: fig. 45, 3-4).
Tumulo 6 (fig. 6)
Sul lato sud-orientale, erano tre vasi impilati (a-b):1. Una scodella a pareti troncoconiche (h. 15 cm; diam. orlo 24 cm; sp. pareti 0,8 cm)con orlo non distinto, labbro arrotondato, fondo piatto e breve piede a tacco.
2. All’interno, vaso troncoconico (h.18,5 cm; diam. orlo 17 cm; sp. pareti 0,7 cm) conorlo non distinto, labbro appiattito decorato a tacche, due anse verticali e fondo piat-to con breve piede a tacco.
3. Contenuto nel vaso tronco-conico, vasetto (h. 5,8 cm; diam. orlo 5 cm; sp. pareti 0,5cm) con profilo ellissoidale schiacciato, brevissimo colletto con orlo assottigliato e fon-do piatto, decorato con tre bande orizzontali parallele incise campite a tratteggio verti-cale (di cui una sul colletto, una sulla spalla, l’altra sul corpo) e, al di sotto, zig-zag oriz-zontale parallelo ad esse. Il vasetto era, probabilmente, un bricco: sul corpo presenta,infatti, un foro del diam. di 2 cm, forse traccia di un beccuccio intenzionalmente stac-cato per consentirne l’inserimento nel vaso troncoconico e, sulla spalla opposta, è trac-cia di un’ansa verticale. Un beccuccio del diam. di 2 cm e della lunghezza di 3,4 cm
18
Ingravallo et alii
19
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Fig. 6 – Salve (LE), Tumulo 6: i materiali (scala in cm; dis. A. Guercia, A. Potenza).
rinvenuto a poca distanza da questo recipiente non sembra appartenervi, date le gran-di dimensioni.
Poco più a nord, nella parte centrale del tumulo, allo stato frammentario:4. Una ciotola a calotta (h.12,5 cm; diam. orlo 13 cm; sp. pareti 0,8 cm), contenentealcuni denti, con orlo non distinto, labbro arrotondato e fondo piatto.
5.-6. Due brocchette a corpo globulare molto simili, nella forma, a quelle rinvenute neltumulo 1, di cui una con collo troncoconico alto 5,4 cm, orlo non distinto (del diam.di 6,5 cm), labbro arrotondato e spalla convessa; in un caso l’ansa a nastro verticaleè impostata sulla spalla, nell’altro tra collo e spalla.
Nella parte centrale del tumulo erano, inoltre, gli orli di una ciotola e di un vaso tron-coconico non ricostruibili: a poca distanza erano altri denti insieme a frammenti ossei. L’or-lo della ciotola ha un diametro di 18 cm: è di tipo non distinto con labbro appiattito edè caratterizzato da un’ansetta ad anello sottostante. L’orlo del vaso troncoconico è di tiponon distinto con labbro appiattito.Sparsi nel tumulo erano, inoltre, numerosi frammenti di parete e generici elementi ti-
pologici.
Confronti e considerazioni
Il profilo del vasetto con orlo a colletto rimanda genericamente ad alcune ciotoline do-cumentate alla Grotta della Trinità (Cremonesi 1978: fig. 2, 10-15) e a Grotta Cappuc-cini (Ingravallo 2002: fig. 37) ma se ne distacca per la presenza di elementi strutturali qua-li ansa e beccuccio.La decorazione rimanda direttamente a Laterza.Una forma comune, presente in numerosi contesti abitativi e nelle grotte funerarie, è
il vaso dal rigido profilo troncoconico in cui era stato inserito il vasetto: si veda, ad esem-pio, Maccarese (Manfredini 2002: fig. 40, 6).Abbastanza diffusa anche la morfologia della scodella a pareti troncoconiche e della cio-
tola a calotta: entrambe trovano confronti ad esempio a Cappuccini (Ingravallo 2002: nn.30-33, nn. 43-45), Trinità (Cremonesi 1978: n. 14), Grotta Pacelli (Striccoli 1988: fig.56, 4, fig. 54, 5).Altrettanto diffusa la decorazione a impressioni a tacche sull’orlo del vaso troncoconico.
Le impressioni a tacche sono attestate, ad esempio, a Grotta Cappuccini (Ingravallo 2002:60), a Maccarese, nel Lazio (Manfredini 2002: fig. 48, 9, 11), a Maddalena di Muccia, nel-le Marche (Manfredini et alii 2005: 435), e in diversi siti Laterza del territorio di Roma co-me Piscina di Torre Spaccata (Bietti Sestieri, Gianni 1988: 581); esse si ritrovano anche sul-l’orlo di vari tipi di vasi della facies del Gaudo (Bailo Modesti, Salerno 1998: fig. 43A.3).
Eccettuate le forme vascolari che richiamano direttamente la tipologia Gaudo, per il re-sto si tratta di un complesso abbastanza standardizzato la cui morfologia di base è presentenell’intera Italia centro-meridionale.I rimandi, infatti, sono generici e mai puntuali. Gli stessi confronti con i siti salentini
non consentono di registrare strette analogie, pur essendo evidente quel sostrato comuneravvisabile ovunque.
20
Ingravallo et alii
21
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Rispetto alle situazioni pressoché contemporanee e riferibili all’aspetto Cellino, la pro-duzione di Salve è ben lontana dal riprodurne la ricchezza dell’ornato o la peculiarità diforme quali boccali o bicchieri. La stessa Laterza è appena evocata dalla decorazione sulvasetto con beccuccio mentre è assente sugli altri la varietà dei suoi decori, pure largamenteattestati nel Salento.Le evidenze finora note delle tombe collettive in grotta documentano, infatti, accanto
a vasi inornati, una produzione caratterizzata da una sintassi decorativa che pur disponendodi pochi elementi (bande e linee) trova sempre il modo di organizzarli in varianti diversecon un sapiente equilibrio tra forma e decorazione. Domina il classico boccale o la tipicaansa con bottone applicata su tazze o, ancora, l’orlo sopraelevato su ciotole e scodelle. Èun repertorio variamente combinato che ricorre in tutte le grotte note: Cappuccini, Ser-ra Cicora, Grotta del Fico, Grotta Durante (inedita), Veneri, Trinità alle quali si è aggiuntaGrotta della Campana d’Oro (Poggiardo) i cui materiali, inediti, riproducono in tutto latipologia di Grotta Cappuccini.I due tumuli di Salve sembrano quasi estranei a questo mondo, anzi a rimarcarne la sin-
golarità è la presenza delle brocchette Gaudo che sono la vera novità nella produzione va-scolare del Salento del III millennio.È difficile rintracciare le ragioni di tale diversità rispetto a quanto finora noto nel Sa-
lento, diversità riscontrabile anche nel rituale e nell’architettura funeraria.
IL RITUALE E L’ARCHITETTURA FUNERARIA
Nei due tumuli funerari è documentato un rituale che consiste nell’impilare, presso unmargine, tre vasi e disporne altri sul resto della superficie, ridotti in minuti frammenti chenon sempre permettono la ricostruzione delle forme o, in molti casi, danno forme in-complete cui, per esempio, manca il fondo o parte del corpo.Si può ritenere, trattandosi di vasi che non si ricompongono mai integralmente, che ve-
nissero rotti all’esterno dei tumuli per poi essere deposti, in frammenti, all’interno dellestrutture funerarie, secondo una pratica ampiamente attestata in Italia centro-meridiona-le nel corso dell’eneolitico. Frantumazione intenzionale del corredo ceramico e dispersionedei frammenti accomunano, infatti, i gruppi Laterza, Gaudo, Rinaldone.La rottura intenzionale del corredo ceramico è documentata, ad esempio, nelle tombe di
facies Laterza di Osteria del Curato-via Cinquefrondi (Anzidei et alii 2007), in quelle del-l’area “Forum” di Gricignano (Fugazzola Delpino et alii 2003), oltre che nel corridoio del-la tomba 3 di Laterza (Biancofiore 1967: 240). Sia per Osteria del Curato- via Cinquefron-di che per Gricignano, si è ipotizzato che la frammentazione dei manufatti ceramici avve-nisse al di fuori delle tombe dato che, accanto al defunto, solitamente presso la testa o ai pie-di, erano vasi che non si ricompongono mai per intero. All’ipotesi della frantumazione ri-tuale svolta all’esterno della tomba contribuisce anche il rinvenimento di frammenti di ollein parte ricomponibili nelle canalette che circondavano due delle sepolture di Gricignano.Frammentazione e dispersione in più ambienti degli oggetti usati a scopo cerimoniale
sono pratiche documentate anche in contesti Gaudo: si ricordino la t. 97 di ContradaMa-donnelle a Policoro Heraclea nel materano in cui, ai piedi dell’inumato, erano due vasiintegri e uno in frammenti (Bianco 1981); la t. 548 di Pontecagnano il cui corredo con-
sisteva di due vasi, uno integro deposto presso il cranio dell’inumato, l’altro ricompostocon due parti prive però di attacco, presso le ginocchia (D’Agostino 1964) e le tre tombea grotticella di Tor Pagnotta, nel territorio di Roma (Anzidei, Carboni 2006).Nella terra di riempimento dei pozzetti di numerose tombe riferibili sempre al Gaudo –
soprattutto quelle contenenti resti sconnessi- erano vasi frammentati intenzionalmente eframmenti di vasi che si ricomponevano con altri della cella o di tombe vicine. Secondo Bai-lo Modesti (Bailo Modesti, Salerno 1998) si intendeva, con questo rituale, onorare non so-lo gli ultimi inumati ma anche le precedenti deposizioni private della loro integrità. Altri au-tori (Cocchi Genick 2001) ritengono che tale pratica debba essere interpretata come una for-ma di culto degli antenati in quanto finalizzata a rimarcare, attraverso atti simbolici, gli stret-ti legami tra i defunti. L’ipotesi di un culto rivolto agli antenati per i ripetuti atti sacrificalisvolti sulle tombe e in apposite fosse votive è stata avanzata anche per la necropoli di PianoVento in Sicilia, riferibile all’aspetto di San Cono-Piano Notaro: le fosse votive collegate al-le tombe erano ricche di materiali, anche di pregio, in frammenti, e contenevano, inoltre,ceneri e ossa animali combuste: che alla frantumazione facesse seguito la disseminazione deiframmenti è dimostrato da unmodellino fittile le cui parti furono rinvenute in due fosse di-stinte (Castellana 1995).Altri esempi provengono dalle necropoli rinaldoniane di Le Calle, Poggialti Vallelunga
e la Romanina in cui vasi, a volte frantumati, erano deposti davanti all’apertura della cel-la (Negroni Catacchio 1988; Anzidei, Carboni 2006).Tracce di pratiche rituali che comportavano l’accensione di fuochi, la frantumazione di
recipienti e la dispersione dei frammenti ceramici sono state riconosciute anche nell’areamegalitica di età campaniforme di Velturno, in Trentino (Tecchiati 1998).Se il rituale della frantumazione e della dispersione del corredo ceramico rilevato per i
tumuli di Salve trova confronti, dunque, in numerosi siti italiani coevi, la stessa cosa nonsi può dire per l’architettura funeraria. Molto generici sono, infatti, i rimandi ai pochi tu-muli eneolitici scoperti nella Penisola, per i quali non sempre è accertata la destinazionefuneraria.Nel caso della già citata area megalitica di Velturno datata alla metà del III millennio
a. C., al di sotto del tumulo principale erano, oltre a frammenti ceramici, ossa umane eanimali combuste.I resti umani sono stati riferiti a quattro individui: due giovani adulti, una femmina e
unmaschio, un bambino e un individuo di sesso ed età non determinabile (Tecchiati 1998;2006).Mostrano analogie con il complesso di Velturno i santuari megalitici lombardi di Os-
simo-Pat e Caven di Teglio, utilizzati a scopo cultuale a partire dall’età del rame (Poggia-ni Keller 2006) e il complesso funerario di Sovizzo (Vicenza) (Bianchin Citton 2006).Il santuario megalitico di Ossimo-Pat, il cui impianto risale alla prima metà del IV mil-
lennio a.C., è caratterizzato da allineamenti di stele incise e massi-menhir e due aree con tu-muli. In uno dei tumuli, al di sotto di una distesa di sassi, erano state deposte delle offerte: sitrattava di un vaso troncoconico e una collana. Attestano la pratica rituale dell’accensione difuochi alcune fosse contenenti carboni rinvenute sotto il livello di fondazione del tumulo.Fu frequentata per scopi cerimoniali anche l’area megalitica di Caven di Teglio: all’in-
terno di un recinto di pietre erano due piattaforme una delle quali a struttura tumulifor-
22
Ingravallo et alii
me con connessi piani acciottolati. Alcuni carboni furono rinvenuti sparsi tra i sassi dellapiattaforma.A Sovizzo, su una piattaforma delimitata da un fossato, erano tumuli funerari conte-
nenti inumazioni in fossa riferibili alla tarda età del rame. Un altro tumulo, rinvenuto invia Alfieri, ricopriva anch’esso una inumazione datata al 3349-2905 a.C.Il tumulo di Via Bruschi a Sesto Fiorentino, datato tra il 2600 e il 2400 a.C. e conte-
nente scarsi materiali ceramici di tipo campaniforme, è stato interpretato come una co-struzione a carattere funerario per l’analogia con strutture sepolcrali di fine III – inizi IImillennio a.C. localizzate in Europa nord-occidentale, ma al suo interno non sono staterecuperate sepolture (Sarti, Martini 1998).Più numerosi i tumuli funerari documentati, nel III millennio a. C., nelle aree balcaniche.Tumuli funerari con urne contenenti ossa cremate sono attestati nella cultura di Baden
e in quelle tardo-eneolitiche di Kostolac e Vucedol (Tasic 1988).Tra eneolitico ed età del Bronzo è diffusa in Albania la pratica del seppellimento entro tu-
mulo, però sotto forma di inumazione e non di incinerazione, come per esempio nella cul-tura diMaliq III (Andrea 2002). Analogo rituale, infine, è documentato inMontenegro do-ve, a volte, gli inumati erano deposti in ciste litiche coperte da terra e pietre (Bulatovic, Lu-tovac 2003).
CRONOLOGIA
Dal tumulo 6 un osso ha dato la seguente datazione: LTL 1687A: 3941±50 BP, cal.2580-2290 a.C.Finora nel Salento le uniche datazioni relative al III millennio erano quelle di Grotta
Cappuccini: KIA 16833: 3937±29 BP, cal. 2500-2300 a.C.; KIA 16835: 3936±28 BP, cal.2500-2330 a.C.; KIA 16834: 3955±28 BP, cal. 2500-2390 a.C. (Ingravallo 2002).In seguito alla scoperta casuale della Grotta della Campana d’Oro (Poggiardo) dovuta
a uno scavo clandestino che l’ha in parte depredata, sono stati recuperati materiali riferi-bili alla facies Cellino e ossa umane.Il rituale – da quanto è stato possibile ricostruire – era in tutto simile a quello di Grotta
Cappuccini: sepolture plurime in una grotta naturale accompagnate da vasi in ceramica.Un osso umano è stato datato: LTL 1063 A: 3937±50 BP, cal. 2580-2280 a.C.Si dispone, al momento, di tre date relative al III millennio: in un medesimo arco di
tempo, quindi, si assiste al dispiegarsi di usi funerari differenti e all’uso di una suppellet-tile ceramica anch’essa in parte diversificata (fig. 7).Le datazioni dell’eneolitico dell’Italia centro-meridionale restituiscono una situazione
variegata dalla quale risulta che l’aspetto Rinaldone, attualmente, è il più antico risalen-do agli inizi del IV millennio. Gaudo è attestato fin dalla metà del IV, anche se Taurasisembra anticiparlo di qualche secolo, ma per ora non va oltre la metà del III, mentre La-terza inizia e continua per tutto il III (fig. 8).Il quadro sopra descritto risente di inevitabili forzature dal momento che in molti con-
testi i vari aspetti si sovrappongono e si influenzano.Il IV millennio si pone, in ogni caso, come punto di snodo dei processi formativi del-
le singole facies archeologiche che soppiantarono il mondo neolitico.
23
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
24
Ingravallo et alii
Fig. 7 – Cronologia dell’eneolitico salentino (in grigio scuro è indicato l’intervallo a 1 σ, in grigio chiaro quello a 2 σ.OxCal v4.0.1 Bronk Ramsey (2006); r.5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et alii 2004)).
Fig. 8 – Cronologia dell’eneolitico dell’Italia centro-meridionale (sono riportate le datazioni al radiocarbonio calibra-te a 2 σ. OxCal v4.0.1 Bronk Ramsey (2006); r.5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et alii 2004)).
Crisi ambientali, innovazioni tecnologiche, influssi esterni possono aver contribuito alcambiamento (Barfield 2002) ma sfugge il modo con cui concretamente le realtà regio-nali affrontarono la nuova temperie. Nel III millennio esse appaiono in possesso di unapluralità di tradizioni ormai sedimentate attraverso un complesso meccanismo di ibrida-zioni e di scambi.
i. t.
I RESTI SCHELETRICI UMANI
Tumulo 1
Nel tumulo 1 le ossa combuste sono state rinvenute all’interno di un vaso. Il peso com-plessivo è di 1432,54 grammi. Presentano un tipo di combustione incompleta in cui so-no rimasti frammenti di ossa; si riscontra una riduzione volumetrica, le ossa risultano defor-mate e presentano le tipiche fessurazioni trasversali ad andamento conoide e fratture lon-gitudinali (Mayne Correia 1997). Il colore dominante è il bianco corrispondente ad unatemperatura media di esposizione al calore superiore ai 650°; la colorazione grigio-blu èstata riscontrata su pochi frammenti, fra cui l’estremità prossimale di un omero sinistro,caratteristica questa di un’esposizione a temperature minori (Mays 1998). Sono stati ri-conosciuti soprattutto frammenti di calvario e diafisi di ossa lunghe (omeri, femori e ti-bie).In base ai resti combusti rinvenuti nel tumulo 1 il numero minimo di individui è due
(T1A e T1B), dato dalla presenza di due processi mastoidei destri.L’individuo T1A, a cui sono state assegnate la maggior parte delle ossa lunghe, è un adul-
to di età non determinabile e probabilmente di sesso femminile. Il processo mastoideo as-segnatogli è piccolo e poco rugoso (Brothwell 1981), carattere tipico degli individui di ses-so femminile anche se meno valore nella determinazione del sesso assumono le caratteri-stiche morfologiche del cranio rispetto al coxale.L’individuo denominato T1B è un individuo giovanile, rappresentato dal processo ma-
stoideo più piccolo e da parte dell’estremità superiore di un femore sinistro. Il confrontocon una serie di reperti di individui di differenti età ha evidenziato che l’individuo in que-stione ha un’età di 7 anni ± 24 mesi (Ubelaker 1978). Non è stato possibile assegnare al-l’individuo giovanile altri reperti.
Tumulo 6
Nel tumulo 6 sono stati rinvenuti sia resti umani combusti o che comunque presenta-vano tracce di bruciato, sia resti non combusti, per il peso totale di 421,85 grammi.I reperti combusti (g. 206,14) presentano un tipo di combustione incompleta e fra que-
sti è stato possibile riconoscere frammenti di calvario, di diafisi di ossa lunghe ed una 2ªfalange della mano. Nella maggioranza dei casi, i reperti presentano tracce di combustio-ne in nero-marrone, riscontrata in g. 120,76 dei frammenti che è tipica di una tempera-tura media di esposizione al calore di circa 285°; in g. 16,31 dei frammenti è evidente lacolorazione grigio- blu, tipica di una temperatura di circa 440°; più alta (oltre i 650°) è la
25
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
temperatura dei resti che presentano colore bianco (g. 91,58) (Mays 1998). Questi ulti-mi presentano fessurazioni trasversali e quadrettatura superficiale (Mayne Correia 1997).Meglio conservati e di dimensioni maggiori si presentano, invece, i resti non com-
busti (g. 215,71). Tra questi sono stati riconosciuti 22 denti (Tab. 1), parte di una dia-fisi superiore di radio destro, un 1° metatarso destro, il corpo di un metatarso, diver-si frammenti di calvario, omero, femore e tibia, parte di una diafisi inferiore di fibuladestra pertinente a un individuo giovanile. In base alla totalità dei resti scheletrici rin-venuti, il numero minimo di individui presenti nel tumulo 6 è cinque, denominatiT6A, T6B, T6C, T6D e T6E.Il confronto tra i tredici denti (dal n° 10 al n° 22), assegnati all’individuo T6A, e le den-
tizioni proposte nello schema dell’eruzione e maturazione dentaria (Ubelaker 1978) in-dica che aveva un’età di 4 anni ± 12 mesi.L’individuo T6B è rappresentato da un frammento di diafisi inferiore di fibula destra,
pertinente a un individuo giovanile. Il frammento di diafisi è stato confrontato con fibu-le intere di differente maturazione. In base al confronto l’individuo in questione ha un’etàcompresa tra gli 11 e i 13 anni (Stloukal, Hanakova 1978).Gli individui T6C, T6D e T6E sono individui adulti di sesso ed età non determinabile.L’individuo T6C è rappresentato dal canino inferiore sinistro n° 2.
26
Ingravallo et alii
Tab. 1 – Elenco dei denti, con relativo grado di usura, la presenza di carie, il numero delle linee di ipoplasia dello smal-to (LIS) e l’età di insorgenza.
n° Dente Usura (Molnar 1978) Carie n° LIS età LIS (Goodman et alii 1980) Individui1 P1 inf. s 2 - - - -2 C inf. s 2 - - - T6C3 M2 sup. d 4 colletto M - - -4 C sup. d 2 - - - -5 M3 inf. d 2 colletto V - - -6 C inf. s 1 - 4 2,5; 4; 5,5; 6 T6D7 C inf. d 1 - 4 2,5; 4; 5,5; 6 T6D8 I1 sup. s 4 - - - T6E9 I ? 3 - - - -10 m1 inf. d 1 - - - T6A11 m2 inf. d 1 - - - "12 M1 inf. d 1 - - - "13 I2 inf. d 1 - - - "14 m1 inf. s 3 - - - "15 m2 inf. s 1 - - - "16 M1 inf. s 1 - - - "17 m1 sup. d 1 - - - "18 M1 sup. d 1 - - - "19 C sup. d 1 - - - "20 C sup. s 1 - - - "21 M1 sup. s 1 - - - "22 I ? 1 - - - "
All’individuo T6D sono stati assegnati i canini inferiori n° 6 e 7, che sono antimeri eassai simili nelle dimensioni. La somiglianza è avvalorata dai diametri medio-distali(MD), vestibolo-linguali (VL), dall’area della superficie dei denti (Tab. 2) e soprattuttodalla presenza sulla superficie anteriore di entrambe le corone di quattro linee di ipopla-sia dello smalto che fanno riferimento a quattro differenti momenti di stress occorsi quan-do l’individuo era in vita: il primo intorno a 2,5 anni, il secondo intorno ai 4, il terzo in-torno ai 5,5, l’ultimo intorno ai 6 anni.Nel campione di denti rinvenuto il tartaro è assente, probabilmente a causa dello stato
di conservazione, mentre la carie è evidente sul lato mediale del M2 e su quello vestibola-re del M3 destri. La maggior parte dei denti presenta grado di usura lieve (1-2), pochi so-no i denti che presentano grado di usura più alto (3-4) (Tab. 1).L’individuo T6E è rappresentato dal I1 sinistro n° 8, che non può essere assegnato agli
individui T6C e T6D a causa del differente grado di usura.
27
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
Tab. 2 – Dimensioni dei canini rinvenuti nel Tumulo 6.
n° Dente MD VL Area4 C’ sup. d 7,25 7,10 51,482 C inf. s 8,05 6,75 54,346 C inf. s 7,40 6,65 49,217 C inf. d 7,40 6,70 49,58
Tra i frammenti combusti, che presentano colorazione bianca, è stato rinvenuto un fram-mento di processo zigomatico. Il fatto che abbia colorazione bianca vuol dire ovviamen-te che la temperatura di esposizione al calore era assai alta, per cui è presumibile che i den-ti relativi a questo individuo siano andati perduti. Il frammento, quindi, non può essereassegnato agli individui rappresentati dai denti (T6A, T6C, T6D e T6E) ma solo even-tualmente all’individuo giovanile T6B, rappresentato dalla fibula, per cui, se ciò fosse ve-ro, si può supporre che l’individuo T6B sia stato esposto ad una temperatura maggiorenella zona della testa e minore in quella delle gambe.Tra i resti combusti rinvenuti nel tumulo 6 sono stati identificati frammenti di molari
di Bos che presentano la colorazione nero-marrone, simile a quella dei frammenti osseiumani. Ciò indica che sia i frammenti umani sia quelli animali sono stati combusti allamedesima temperatura e probabilmente nel medesimo contesto. Sembra che la presenzadi animali sia collegata a offerte di cibo o a gesti sacrificali (Mays 1998).
Confronti e considerazioni
Entrambi i tumuli hanno restituito resti pertinenti a più individui. Le difficoltà a cuiin genere si va incontro nel rilevare tra i resti ad incinerazione la presenza di più indivi-dui, è stata compensata nel presente studio dalla presenza di reperti di differenti dimen-sioni o in diversa fase di accrescimento.I reperti analizzati sono stati confrontati con quelli provenienti da necropoli ad inci-
nerazione dell’età del bronzo.
Nelle necropoli ad incinerazione la sepoltura singola è la più attestata. Poche infatti so-no in proporzione le sepolture multiple e tra queste la sepoltura bisoma è sicuramente lameglio rappresentata (Bondioli et alii 1994; Drusini et alii 2001; Vanzetti, Borgognini Tar-li 2003; Minozzi et alii 2005; Colonna 2006), generalmente con la combinazione adul-to, in prevalenza di sesso femminile, e bambino, come nel caso del tumulo 1.Le colorazioni riscontrate sui reperti ossei di Salve vanno dal nero-marrone, al grigio-
blu al bianco. Colorazioni riscontrate anche nel campione di confronto (Drusini et alii2001; Minozzi et alii 2005) dove meno presente è la colorazione nero-marrone evidente,invece, nella parte più consistente dei resti combusti del tumulo 6.Il peso complessivo dei reperti del tumulo 1 è di g. 1432,54; nel tumulo 6 g. 421,85.
In cremazioni moderne il peso totale dei reperti ossei di un individuo cremato adulto ècompreso tra i 1000 e i 2400 g., con una media di circa 1625 g. (McKinley 1993). Inaltri casi si è trovato un peso medio di 2700 g per i soggetti maschili adulti e un pesomedio di 1840 g. per quelli femminili (Holck 1997). Il peso ottenuto per i reperti rin-venuti nel tumulo 1 è inferiore alle medie ottenute nelle cremazioni moderne, nono-stante sia stata comunque accertata la presenza di due individui. Di moltissimo inferioreè evidentemente il peso dei resti del tumulo 6. Il confronto con il campione di crema-zioni antiche evidenzia come in effetti pochissimi siano i resti combusti di un singoloindividuo che arrivino a pesare intorno ai 1500 grammi (Bondioli et alii 1994; Mays1998; Drusini et alii 2001; Minozzi et alii 2005).
n. l., p. f. f.
* Dipartimento di Beni Culturali,Università del Salento – Lec-
ce
28
Ingravallo et alii
29
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
ANDREA Z. 2002 – Des éléments Balkaniquesdans la culture du Bronze ancien en Albanie,in L’Albanie dans l’Europe préhistorique, a cu-ra di Touchais G. Renard J., Actes du Collo-que (Lorient 2000), BCH Supplément 42,Athènes: 163-170.
ANZIDEI A. P., CARBONI G. 2006 – Nuovi con-testi funerari eneolitici dal territorio di Roma,in La cultura del morire nelle società preistori-che e protostoriche italiane, a cura di Martini F.,Origines, Firenze: 177-186.
- - : 2007 – Il villaggio neo-eneolitico di Qua-drato di Torre Spaccata (Roma): nuovi datidagli scavi del Giubileo 2000, Atti XL Riun.Sc. IIPP, Firenze: 421-435.
ANZIDEI A. P., CARBONI G., CASTAGNA M. A.,CELANT A., CIANCA M., EGIDI R., FAVORITOS., FUNICIELLO R., GIORDANO G., MALVONEM., TAGLIACOZZO A. 2007 – L’abitato eneo-litico di Osteria del Curato – via Cinquefron-di: nuovi dati sulle facies archeologiche di La-terza e Ortucchio nel territorio di Roma, AttiXL Riun. Sc. IIPP, Firenze: 425-456.
BAILOMODESTI G. 2003 – Rituali funerari eneo-litici nell’Italia peninsulare. L’Italia meridio-nale, Atti XXXV Riun. Sc. IIPP, I, Firenze:283-297.
BAILO MODESTI G., SALERNO A. 1998 – Ponte-cagnano II.5. La necropoli eneolitica. L’età delrame in Campania nei villaggi dei morti,AION, Quad. 11, Napoli.
BAILO MODESTI G., SALERNO A., TALAMO P.1999 – L’eneolitico in Campania: criteri peruna definizione tipologica e terminologica delrepertorio vascolare, in Criteri di nomenclatu-ra e di terminologia inerente alla definizione del-le norme vascolari del neolitico/eneolitico e delBronzo/Ferro, a cura di Cocchi Genick D.,Atti del Congresso, I, Firenze: 207-215.
BARFIELD L.H. 2002 – L’Europa nel 3500 a.C.:una congiuntura tra diffusione e crisi am-bientale?, in Il declino del mondo neolitico. Ri-cerche in Italia centro-settentrionale fra aspettipeninsulari, occidentali e nord-alpini, Atti del
Convegno, a cura di Ferrari A., Visentini P.,Pordenone 2002: 11-18.
BARONI I., RECCHIA G. 2005 – Comportamentifunerari durante l’eneolitico nelle Marche, At-ti XXXVIII Riun. Sc. IIPP, I, Firenze: 445-456.
BIANCHIN CITTON E. 2006 – Il complesso fune-rario e cultuale di tipo monumentale di SanDaniele di Sovizzo (Vicenza), in La cultura delmorire nelle società preistoriche e protostoricheitaliane, a cura di MARTINI F., Origines, Fi-renze: 164-168.
BIANCO S. 1981 – Aspetti culturali dell’Eneoliti-co e della prima età del Bronzo sulla costa io-nica della Basilicata, Studi di Antichità, 2: 13-72.
BIANCOFIORE F. 1967 – La necropoli eneoliticadi Laterza, Origini, I: 195-299
BIETTI SESTIERI A. M., GIANNI A. 1988 – L’in-sediamento eneolitico di Piscina di TorreSpaccata (Roma), Rassegna Archeologia, 7:580-582.
BONDIOLI L., FORMENTI D., SALVADEI L., 1994– Metodologie di analisi quantitativa di restiumani combusti, Bullettino di Paletnologia Ita-liana, 85: 385-398.
BROTHWELL D. R. 1981 – Digging up bones,Oxford.
BULATOVIC L. S., LUTOVAC P. 2003 – Zlatno do-ba Crne Gore. The golden Age of Montenegro,Podgorica.
CASTELLANA G. 1995 – La necropoli protoeneoli-tica di Piano Vento nel territorio di Palma diMontechiaro, Agrigento.
CAZZELLA A. 2003 – Rituali funerari eneoliticinell’Italia peninsulare. L’Italia centrale, AttiXXXV Riun. Sc., I, Firenze: 275-282.
CAZZELLA A., SILVESTRINI M. 2005 – L’eneoliti-co delle Marche nel contesto degli sviluppiculturali dell’Italia centrale, Atti XXXVIIIRiun. Sc., Firenze: 371-386.
COCCHI GENICK D., 2001 – Considerazioni sul-le forme del rituale funerario dell’Eneoliticoitaliano, in Studi di Preistoria e Protostoria in
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
30
Ingravallo et alii
onore di Luigi Bernabò Brea, a cura di MARTI-NELLI M. C., SPIGO U., Messina: 113-144.
COLONNA C. 2006 – Aspetti del rito funerarionelle necropoli dell’età del Bronzo finale del-l’area padana, in Studi di Preistoria in onore diRenato Peroni, All’insegna del Giglio, Firenze:575-580.
CREMONESI G. 1978 – Gli scavi nella Grotta del-la Trinità (Ruffano, Lecce), Quaderni RicercaScientifica, 100, CNR: 131-148.
- - : 1980 – Saggio di scavo a Grotta Montani(Salve), Studi di Antichità, 2: 45-55.
D’AGOSTINO B. 1964 – Di alcuni rinvenimentipreistorici a Pontecagnano (Salerno), Bulletti-no di Paletnologia Italiana: 89-108.
DE JULIIS E. 1975 – Recenti rinvenimenti dell’etàdei metalli nella Daunia: tombe a grotticelladel tardo Eneolitico a S. Severo e della fine del-la media età del Bronzo a Trinitapoli, inAA.VV., Civiltà preistoriche e protostoriche del-la Daunia, Firenze: 235-243.
DESCOEUDRES J. P., ROBINSON E. 1993 – La“Chiusa” alla masseria del Fano. Un sito messa-pico arcaico presso Salve in provincia di Lecce,Lecce.
DOLFINI A. 2004 – La necropoli di Rinaldone(Montefiascone, Viterbo): rituale funerario edinamiche sociali di una comunità eneoliticain Italia centrale, Bullettino di Paletnologia Ita-liana, 95: 127-278.
DRUSINI A. G., CRIVELLARO F., CARRARA N.,2001 – Studio antropologico dei resti osseicremati di Colombara (VR), Padusa, XXXVIIn.s.: 137-148.
FEBBRARO N. 2005-2006 – Ricognizioni di inte-resse paletnologico nel territorio di Salve, Te-si di laurea in Paletnologia, Università degliStudi di Lecce, Anno Accademico 2005-2006.
FUGAZZOLA DELPINO M. A., SALERNO A., TA-GLIACOZZO A., TINÉ V., VANZETTI A. 2003 –Una comunità della facies di Laterza nella pia-nura campana: l’area “Forum” di Gricignano– US Navy (Ce), Atti XXXV Riun. Sc., Fi-renze: 199-214.
FUGAZZOLA DELPINO M. A., SALERNO A., TINÉV. 2007 – Villaggi e necropoli dell’area “Cen-tro commerciale” di Gricignano d’Aversa –US Navy (Caserta), Atti XL Riun. Sc., Firen-ze: 521-537.
GERVASIO M. 1913 – I dolmen e la civiltà delbronzo nelle Puglie, Bari.
HOLCK P., 1997 – Cremated bones, in A medi-cal-anthropological study of an archaeologicalmaterial on cremation burials, Third edition,Antropologiske skrifter nr.1c, Anatomical In-stitute, University of Oslo.
IMBRIANI E., MAINARDIM.1997 – L’apicoltura interra d’Otranto nella società tradizionale, Lec-ce.
INGRAVALLO E. 2002 – Grotta Cappuccini (Ga-latone) tra eneolitico e primo bronzo, Galatina.
INGRAVALLO E., PICCINNO A. 1983 – L’insedia-mento protoappenninico di Spigolizzi (Salve),Studi di Antichità, 4: 37-66.
INGROSSO M. D. 1997a – Grotta Grande delCiolo (Gagliano del Capo). La ceramica, in Lapassione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ri-cerca preistorica nel Salento, a cura di Ingraval-lo E., Lecce: 160-162.
- - : 1997b – Grotta della Trinità (Ruffano). Imateriali, in La passione dell’origine. GiulianoCremonesi e la ricerca preistorica nel Salento, acura di Ingravallo E., Lecce: 238-252.
MANFREDINI A., a cura di, 2002 – Le dune, il la-go, il mare. Una comunità di villaggio dell’etàdel rame a Maccarese, Origines, Firenze.
MANFREDINI A., CARBONI G., CONATI BARBA-RO C., SILVESTRINI. M., FIORENTINO G.,CORRIDI C. 2005 – La frequentazione eneo-litica di Maddalena di Muccia (Macerata),Atti XXXVIII Riun. Sc. IIPP, Firenze: 433-444.
MARZOCCHELLA A. 1998, Tutela archeologica epreistoria nella pianura campana, in Archeolo-gia e Vulcanologia in Campania, a cura di Guz-zo P. G., PERONI R., Atti del Convegno, Na-poli: 97-133.
MAYNE CORREIA P. M., 1997 – Fire Modifica-tion of Bone: A Review of Literature, Foren-sic Taphonomy, in The postmortem fate of hu-man remains: 275-293.
MAYS S., 1998 – Cremated Bone, in The Ar-cheology of human bones: 207-224.
MCKINLEY J.I., 1993 – Bone Fragment Size andWeights of Bone from Modern British Cre-mations and the Implications for the Interpre-tation of Archaeological Cremations, Interna-tional Journal of Osteoarchaeology, 3: 283-287.
MINOZZI S., VANZETTI A., BORGOGNINI TARLI
31
Testimonianze culturali e funerarie nel territorio di Salve (Lecce)
S. M., 2006 – Il sepolcreto a cremazione delPozzillo (Canosa, Bari) dell’età del Bronzo:esame antropologico dei resti incinerati, Attidel XVI Congresso degli Antropologi Italiani(Genova 2005), Milano: 701-710.
NEGRONI CATACCHIO N., a cura di, 1988 – IlMuseo di Preistoria e Protostoria della valle delFiume Fiora, Manciano.
POGGIANI KELLER R. 2006 – Santuari megaliticinelle valli lombarde, in Preistoria dell’ItaliaSettentrionale. Studi in ricordo di BernardinoBagolini, a cura di Pessina A., Visentini P., At-ti del Convegno, Udine: 243-266.
RADINA F. 2006 – Alcune considerazioni sull’e-neolitico della Puglia in rapporto al rituale fu-nerario, in La cultura del morire nelle societàpreistoriche e protostoriche italiane, a cura diMartini F., Firenze: 198-208.
SARTI L., MARTINI F. 1998 – Il tumulo di ViaBruschi a Sesto Fiorentino, in Simbolo edEnigma. Il bicchiere campaniforme e l’Italianella preistoria europea del III millennio a.C., acura di Nicolis F., Mottes E., Catalogo dellamostra, Trento: 168-173.
SILVESTRINI M., CAZZELLA A., PIGNOCCHI G.2005 – L’organizzazione interna della necro-poli di Fontenoce – area Guzzini, Atti XXX-VIII Riun. Sc. IIPP, Firenze: 457-468.
STLOUKAL M., HANAKOVA H., 1978 – Die län-ge der Längknochen altslawisher Bevölkerun-gen. Unter besonderer berücksichtigung vonwachstumsfragen, Homo, 29: 53-69.
STRICCOLI R. 1988 – Le culture preistoriche diGrotta Pacelli (Castellana Grotte-Bari), Fasano.
TASIC N. 1988 – The middle and late Eneolithicin Yugoslavia,Rassegna di Archeologia, 7: 51-62.
TALAMO P. 1998 – Taurasi (AV): strutture conincinerazioni, Atti XIII Congresso UISPP, 4,Abaco, Forlì: 85-89.
- - : 2004, a cura di, – Taurasi. Un nuovo aspettodell’Eneolitico in Campania, Guida alla mo-stra, Salerno.
- - : 2006 – Taurasi – Contrada San Martino(Avellino): aspetti del rituale funerario, in Lacultura del morire nelle società preistoriche eprotostoriche italiane, a cura di Martini F.,Origines, Firenze: 193-197.
TECCHIATI U. 1998 – Velturno – loc. Tanzgas-se: un’area megalitica di età campaniforme inVal d’Isarco (Bolzano), in Simbolo ed Enigma.Il bicchiere campaniforme e l’Italia nella prei-storia europea del III millennio a. C., a cura diNicolis F., Mottes E., Catalogo della mostra,Trento: 69-72.
- - : 2006 – Il luogo di culto della tarda età delrame di Velturno – Tanzgasse (Bolzano).Aspetti sepolcrali e affermazione territoriale al-le soglie della protostoria in Alto Adige, in Lacultura del morire nelle società preistoriche eprotostoriche italiane, a cura di Martini F.,Origines, Firenze: 161-163.
TUNZI SISTO A. M. 1991 – Nuova miniera prei-storica nel Gargano, Atti XII Convegno diPreistoria- Protostoria – Storia della Daunia,Foggia: 63-72.
UBELAKER D.H., 1978 –Human skeletal remains.Excavations, analysis, interpretation, Chicago.
VANZETTI A., BORGOGNINI TARLI S. 2003 – Al-cuni problemi relativi alle sepolture ad inci-nerazione della tarda età del Bronzo in Italiacentrale e meridionale, affrontati a partiredalle determinazioni antropologiche, Attidella XXXVI Riun. Sc. IIPP, Firenze: 345-365.
VENTURA V. 1997 – Grotta delle Veneri (Para-bita). La ceramica, in La passione dell’origine.Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica nelSalento, a cura di Ingravallo E., Lecce: 198-220.
VENTUROD. 2004 – Rame, il primometallo. Gliornamenti dell’età del rame, in Ornamenta.Arte e linguaggio dell’ornarsi nella Puglia prei-storica, a cura di Radina F., Catalogo della mo-stra, Bari.