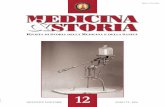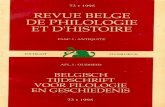Per una rivisitazione dell'arte letteraria di Scipione Maffei
Un ufficiale italiano in Ungheria: Giuseppe Ariosti, in Epigrafi romane di Transilvania raccolte da...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Un ufficiale italiano in Ungheria: Giuseppe Ariosti, in Epigrafi romane di Transilvania raccolte da...
65
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Un ufficiale italiano in Ungheria: Giuseppe Ariosti1
Cenni biografici
Giuseppe Ariosti viene definito – nel primo contributo biografico che lo riguarda, ma già nei manoscritti di epigrafi da lui stesso trascritte – nobile «bolognese, ferrarese e senese»2. Un primo problema, quindi, si pone pro-prio in relazione a quale sia la sua patria d’origine. È interessante constata-re come Grosseto lo rivendichi tra i componenti del suo modesto pantheon di uomini illustri:
La biografia di Grosseto in poche linee si chiude. – In santità può nominarsi il beato Andrea da Grosseto Minore Osservante; in dignità Mons. Francesco Boldrini prelato alla Corte di Vienna; in arme Giuseppe Ariosti che militò sotto il principe Eugenio di Savoia, e fu generale della Casa d’Austria; in lettere quell’Andrea da Grosseto che tradusse in Pari-gi in lingua italiana prima del 1280 i Trattati di Albertano da Brescia, un codice del quale conservasi nella biblioteca Magliabechiana di Firenze; in scienze fisiche potrebbe Grosseto vantare un suo benemerito medico in Gio. Antonio Pizzetti, che tenne cotesta città per sua seconda patria, se la Terra dell’Abbadia S. Salvadore non lo rivendicasse come suo al pari dell’autore delle Antichità Toscane, Pietro Paolo Pizzetti di lui fratello. Finalmente in giurisprudenza, in politica, in erudizione sacra e profana supplisce per molti il nome di Giovanni Valeri, morto in Siena nel 1827, e il di cui sepolcro esiste nel duomo di Grosseto3.
Non ci sono dubbi nell’identificare il personaggio citato con il nostro conte Ariosti. A favore della sua origine o comunque dei suoi possedimen-ti nella città toscana, parrebbe deporre anche un documento dell’Archivio Vescovile di Grosseto (ms. 1723, cc. 239-241), un inventario dei beni della Badia di S. Galgano in cui rientra la descrizione dei confini delle terre di sua competenza:
Moggia tre e stara 18 di terra in detta corte e luogo detto Barbanella
1 Il presente contributo nasce da una stretta collaborazione, in ambiti diversi, ma spesso contigui; nello specifico, però, i paragrafi Cenni biografici e Reportage dalla guerra-austroturca del 1716-1718 sono di Simona Cappellari, i restanti, inclusa l’Appendice, di Cristina Cappelletti.
2 Gianola 1931, p. 94.3 repetti 1835, p. 538.
065_092_UNUFFICIALE.indd 65 09/11/10 15:12
66
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
alle quali confinano a tramontana e levante un fosso chiamato il Fosso-ne, da mezzo giorno Signor Lorenzo e Giuseppe Ariosti ora generale di S.M. l’Imperatrice Regina di Ungheria e di Boemia (c. 240) 4.
Anche in questo caso, del tutto certa appare l’identificazione con Giu-seppe Ariosti, che in effetti nel 1751, anno di stesura del documento, era ancora al servizio della casa regnante austriaca. Se l’appartenenza alla no-biltà senese trova riscontro nelle proprietà fondiarie legate a investiture feudali, più difficile risulta accertare la portata delle rivendicazioni di titoli di nobiltà riferiti a Bologna e Ferrara, da ricondurre piuttosto, come vedre-mo, al desiderio dell’Ariosti di accreditare la propria parentela con i due rami cadetti della famiglia, residenti rispettivamente nelle due città.
Scarne le notizie biografiche che lo riguardano. Nacque nel 1689 o nel 1690; secondo alcune fonti il luogo di nascita è indicato in Bologna5, secon-do altre più attendibili in Siena o Grosseto6. Come molti nobili, in partico-lare cadetti, intraprese la carriera delle armi. Entrato al servizio di Carlo vi, prese parte alla guerra contro i Turchi del 1716-1718, a quella di succes-sione polacca del 1733-1735 e a un nuovo conflitto contro gli Ottomani del 1736-1739.
Significative notizie sulle sue vicende si ricavano dalle oltre duecento lettere che egli scrisse al senatore Alberto Corradino Ariosti di Bologna. La corrispondenza inizia proprio con il tentativo di stabilire una paren-tela con il ben più illustre ramo felsineo della famiglia. Corradino Ario-sti, saputo che un ufficiale di stanza in Ungheria, Giuseppe Ariosti, si fregiava del titolo di conte, volle appurare che fosse veramente – come egli dichiarava – di famiglia nobile; si rivolse a tal fine al generale Ercole Montecuccoli, che nel 1716 aveva l’Ariosti tra gli ufficiali ai suoi ordini a Temesvár (Timisoara) e favorì i primi scambi epistolari tra i due parenti. Il senatore Ariosti, nel frattempo, chiese informazioni anche alla principes-sa Violante di Baviera, governatrice di Siena, la quale lo rassicurò, soste-nendo che il conte Giuseppe, appartenente a una delle «primarie» fami-
4 Cfr. aniChini 1996.5 Winkler 1975, p. 304, ricostruisce in breve la sua carriera militare: Giuseppe Ariosti, nato a Bologna
nel 1689 o nel 1690, comparve per la prima volta nei protocolli dell’alto tribunale di guerra nel 1724 come capitano del reggimento Gaier (corrispondente al successivo reggimento interno di infanteria austriaco n° 43, sciolto all’inizio del xix secolo). Tra il 1732 e il 1733 fu promosso maggiore e nel 1735 sottotenente colonnello. La nomina ufficiale di colonnello fu confermata il 12 luglio 1738; il 24 gennaio 1744 ottenne la nomina di ufficiale generale (corrispondente al grado di maggiore generale) e il 26 luglio 1754 quella di sottotenente generale. Morì di un colpo apoplettico alle ore 22 del giorno 28 settembre 1766 all’età di 76 anni nel sobborgo Mariahilf (oggi nella zona Vienna iv, Mariahilferstrasse, 61) nella casa «Beim grünen Fassel» («Registro dei morti nell’archivio della città di Vienna»).
6 Propendono per l’origine grossetana anche Calore 1957, p. 153 e hanlon 1997, p. 98.
065_092_UNUFFICIALE.indd 66 09/11/10 15:12
67
GiuSeppe arioSti
glie della città di Grosseto, era conosciuto come «tanto gradita persona»7. Fin dalle prime lettere, l’Ariosti esprime il desiderio di informare re-
golarmente il conte Corradino delle «poche novità che corron in queste contrade», inviate «infallibilmente tutte le settimane», dietro esplicita ri-chiesta del congiunto8. Giuseppe Ariosti era per altro sempre scrupoloso nei suoi resoconti, fino al punto di accludere alle proprie lettere, al fine di assicurare maggior credibilità alle sue relazioni, fogli e foglietti di mano diversa dalla sua. E così un cartiglio (purtroppo anonimo), unito a una lettera inviata dal campo di Temesvár il 16 agosto 1716, registra la notizia di una lusinghiera promozione:
Vostra Eccellenza sappia che qui alla corte si è parlato con molto van-taggio del signor Colonnello Ariosti, tanto si è portato bene in Ungaria, e per questo il Duca di Lorena ne parla con stima, anzi è stato fatto co-lonnello pel suo merito.
L’ufficiale non perdeva occasione per dichiarare il suo ossequio al sena-tore Corradino, riconosciuto come il «capo della nostra famiglia Ariosto». Una delle prime lettere a lui inviate registra il tentativo di coinvolgere l’in-fluente congiunto in una trattativa matrimoniale che riguardava il fratello Lorenzo e una dama di chiara nobiltà, unica erede del barone Clemente di Kemeter, che poteva contare su ingenti rendite annue. Una buona dote era evidentemente considerata condizione imprescindibile per un buon matrimonio. Anche in questa circostanza Giuseppe Ariosti dimostrò una particolare attenzione agli interessi familiari e patrimoniali, anteposti alle effettive propensioni del fratello, come egli stesso metteva in rilievo: «le condizioni della dama sono angeliche, benché non troppo bella»9.
L’ufficiale si rivelò sempre molto attento alle vicende patrimoniali dei parenti, veri o presunti, cercando di trovare un legame anche con gli Ario-sti di Ferrara: il casato infatti, dopo una divisione in due rami principali, l’uno bolognese e l’altro ferrarese, sul principio del xviii secolo rischiava di estinguersi. E forse anche per questo motivo Giuseppe registrò con or-goglio la felice ascrizione alla nobiltà senese della sua propria famiglia, dandone notizia in questi termini al senatore Corradino in una lettera del 20 dicembre 1720:
7 A riferire con dovizia di particolari la conoscenza e i rapporti familiari tra Giuseppe Ariosti e il senatore bolognese è Calore 1957.
8 Archivio di Stato di Bologna, Eredità Dante Ugolini, Fondo Gozzadini-Caprara, Ariosti, Instrumenti e lettere (aSbo), missiva inviata dal Campo di Futak il 24 luglio 1716.
9 aSbo, lettera inviata da Napoli il 3 luglio 1714.
065_092_UNUFFICIALE.indd 67 09/11/10 15:12
68
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Il 3 del presente passò per questo Gran Collegio di Balia10 la famiglia Ariosto habitante in Grosseto, e con tutti voti favorevoli (cosa non più udita) passò e fu con tutte le solennità aggregata a questa nobiltà. Il che spero Vostra Signoria Illustrissima si rallegrerà, essendo un bellissimo avvantaggio per la Famiglia, già che vi sono più di 300 cariche ottime con le quali può aiutarsi una Famiglia.
[…] Il Illustrissimo [sic] Gran Duca mi fece non solo un bellissimo di-ploma, ma di più una bellissima raccomandazione alla corte di Wienna fondata sopra l’operato costì in Bologna; sì come anche questo Collegio di Balia, che ci ha aggregato con tanto applauso e questo è ciò che voleva sapere. […] Circa il diploma delle Aquile Imperialj, e del titolo di Conti del Sagro Romano Imperio (non Palatini) io li starò attendendo11.
In effetti «Giuseppe Ariosti, capitano, di Grosseto, discendente dai con-ti Ariosti bolognesi e ferraresi», venne aggregato alla nobiltà senese il 6 dicembre 1720, come attesta la documentazione d’archivio12.
Il tentativo di rinsaldare i legami della nobile discendenza degli Ariosti sembrava dettato, però, soprattutto dal desiderio di trovare nel senato-re Corradino un appoggio autorevole per propiziare l’avanzamento nella carriera militare. In una lettera del 1718 si legge ad esempio:
Adesso carissimo signor conte Corradino è tempo di mostrarvi chi è vero mio amico e padrone con fare il possibile di trovar tutti i mezzi di salir il più difficile scalino delle nostre truppe, che è a Maggiore, io mi lascerò in questo particolare con la fortuna di supplicarla di alcune possenti raccomandazioni13.
E l’argomento torna in primo piano anche in lettere successive, in cui con insistenza l’Ariosti chiedeva al ben più illustre conte bolognese di in-terporsi per convincere il fratello a sostenere finanziariamente la sua asce-sa ai più alti ranghi militari, dandogli la parte di eredità che per diritto gli spettava, cosa che per altro poteva essere vantaggiosa per tutta la famiglia:
io non lascio però di supplicar Vostra Signoria Illustrissima farmi la grazia di dispore mio fratello a trovarmi un fondo per i consaputi due mila fiorini già che altrimenti sarò forzato a riconoscere quello che è mio
10 Si tratta del Gran Collegio di Balia di Siena.11 aSbo, lettera inviata da Siena il 20 dicembre 1720.12 Archivio di Stato di Siena, fondo della Balia (n. 2664, cc. 259-264). 13 aSbo, lettera scritta da Hermannstadt (rumeno Sibiu, ungherese Nagy Szeben) in Transilvania, il 18
settembre 1718.
065_092_UNUFFICIALE.indd 68 09/11/10 15:12
69
GiuSeppe arioSti
e a venderlo, già che carissimo Signor conte Corradino è naturalissimo che io cerchi i miei avvantaggi, molto più che avanzato al grado di Ser-gente Maggiore, e dandomi Dio la vita, è infallibile che arrivo ad esser generale; e in tal caso posso aiutare poi il signor mio Fratello, senza ha-ver bisogno di nessuno giacché la maggioria porta senza difficoltà per rango i gradi superiori14.
La presente missiva risulta di particolare interesse perché costituisce una delle prime testimonianze dei contrasti che Giuseppe Ariosti ebbe con il fratello Lorenzo. Lontano dall’Italia per seguire l’esercito del principe Eugenio di Savoia, infatti, il militare non poteva sovrintendere personal-mente alla divisione del patrimonio avito, che il fratello, stando a quanto si deduce dal carteggio, andava dissipando. Per questo motivo l’Ariosti, che nel frattempo aveva ottenuto la licenza di portarsi in Italia per evi-tare la peste, si recò in Toscana, dove dichiarò: «Io vengo espressamente per prender il mio», ossia per riappropriarsi del patrimonio familiare15. La situazione che egli trovò, però, apparve ben più grave di quanto non credesse: il fratello, difatti, aveva «dissipato, non solo il suo», «ma anche la maggior parte» del patrimonio spettante a Giuseppe16. E ancora una volta il senatore Corradino Ariosti venne chiamato in causa quale «arbitro e mezzano»17 per porre fine alla diatriba ereditaria. Pur non avendo al ri-guardo notizie più particolareggiate, è presumibile che il lodo fosse stato accettato, visto che spesso il nostro chiederà conto al parente dello stato di salute del fratello, e lo pregherà di inviare al medesimo lettere accluse a quelle indirizzate al bolognese.
Tra le poche notizie biografiche che il carteggio restituisce, risulta di certo rilievo quella relativa al matrimonio del conte Giuseppe, che avrebbe dovuto dar lustro – visti i nobili natali della sposa – sia a lui che alla fami-glia del senatore Corradino:
La presente servirà per notificare a Vostra Signoria Illustrissima e all’Illustrissima signora Contessa Virginia il mio concluso accasamen-to con la signora Francesca Baronessa di Mordax e Portendorf, dama principalissima della Carintia, e Carniola, per la parte di Padre, de-scendente dalli Antichi Duchi di Carintia, da quella di Madre de Conti Tourx, essendo la medesima sorella del Eccellentissimo signor Conte Si-gifrido della Torre Vicedomino di Carniola, imparentata con li Principi
14 aSbo, lettera datata da Hermannstadt, il 7 gennaio 1719.15 aSbo, anche in questo caso la lettera è inviata dal campo di Hermannstadt il 13 settembre del 1719.16 aSbo, Siena, 5 agosto 1720.17 aSbo, Belgrado, 29 gennaio 1720.
065_092_UNUFFICIALE.indd 69 09/11/10 15:12
70
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
di Arnsberg, Conti di Schrottenbach, Conti Bari e simili, dama povera di beni, ma ricchissima di Virtù. […] Sua Maestà l’Imperatrice Amalia m’ha di propria bocca promessa la crociera per la Illustrissima Signora Contessa, e l’haveremo la seconda promozione infallibilmente. Vengo in Italia con patenti grandissime per reclutare le famiglie per habitare il Banato di Temeswar18.
Le notizie di carattere familiare si accompagnano a continue solleci-tazioni intese a ottenere raccomandazioni in vista di una promozione, impossibile senza l’interessamento di qualche illustre patrono. Si veda la lettera del 12 dicembre 1719:
io adesso faccio il possibile per un avanzamento passando tutti i modi immaginabili per poter alla corte di Vienna spuntare una maggio-ria sotto qualche reggimento nel regno di Sicilia; e poiché per tal affare ci vuol bezzi, e raccomandazioni, quello tocca i primi già li troverò; ma per quello toccano le raccomandazioni bisogna che li amici e parenti mi aiu-tino, e nessuno può farlo meglio che Vostra Signoria Illustrissima quan-do veramente si vogli<a> impegnare, e ciò potrebbe esser per il mezzo di cotesto signor Legato potendone staccar una efficacissima lettera di raccomandazione di Sua Santità per la Corte di Wienna, o pure per il General Mercy19. Carissimo signor conte Corradino, arrivando uno nel servizio del Imperatore [sic] ad esser Maggiore è già montato lo scalino sicurissimo per arrivare ad esser Generale.
Pochi mesi dopo l’Ariosti ribadiva la possibilità di una successiva pro-mozione: «Con la presente – scriveva – le notifico il mio arrivo qui in Napoli, di dove, subbito senza perder tempo mi porterò in Sicilia per con-cludere il trattato, che io ho con un certo Generale per una maggioria»20. Ma anche in questo caso, non tralasciava di pregare il parente affinché gli concedesse la sua protezione. Le tanto auspicate raccomandazioni, ol-tre che il valore dimostrato durante le lunghe campagne al servizio delle truppe imperiali, procurarono all’Ariosti una nomina a Sergente, arrivata forse più tardi di quanto non avesse sperato, nel 173321. Evidentemente,
18 aSbo, lettera scritta da Liechinwald (in realtà Lichtenwald) in Stiria il 24 aprile 1724. 19 Si tratta del generale francese, naturalizzato austriaco, Florimund d’Argenteau conte di Mercy (1666-
1734), che partecipò alla guerra austro-turca sotto il comando di Eugenio di Savoia, contribuendo alla vittoria di Petervaradino e alla conquista di Temesvár. Terminata la guerra in Sicilia contro gli Spagnoli, venne nominato Governatore del Banato di Temesvár. Cfr. bérenGer 2003, pp. 41-44, 80 e matuSChka 1900b, p. 23.
20 aSbo, lettera inviata da Napoli il 10 aprile 1720.21 Si veda al riguardo la lettera invita da Vienna il 18 settembre 1733 (aSbo): «Sapendo quanto Vostra
065_092_UNUFFICIALE.indd 70 09/11/10 15:12
71
GiuSeppe arioSti
non pago del grado acquisito, il nostro continuò a sollecitare avanzamenti di carriera:
Per il mio avanzamento non manca altro che il placent [sic] di Sua Maestà, ma questo Dio sa quando lo darà perché ancora è pertinace in non voler far Colonnelli Governatori di Riggimento. Il mio Generale però mi fa sperare che si supererà questo punto, e se ciò segue, il conte Kollobratt, che se le fa servo, sarà Maggiore, havendone la promessa di detto Generale22.
Anche in questo caso la promozione si fece attendere più del previsto: la nomina a Colonnello nel 1738, Maggiore Generale nel 1744 e «General di battaglia», infine, nel 1754. La documentazione relativa a questi ultimi anni della sua carriera militare è ridotta a causa dell’interruzione degli scambi epistolari con Corradino Ariosti. I rapporti con il senatore bolo-gnese si erano incrinati a causa di una vicenda legata all’educazione dei loro figli: Giuseppe desiderava infatti che il proprio figlio, Corradino, fos-se ammesso al prestigioso collegio dei Nobili di Parma23, e per questo pro-pose al parente di farsene carico, mentre lui avrebbe fatto educare insieme alle sue due figlie presso l’Imperial Collegio delle Orsoline di Pressburg (Bratislava/Pozsony) Costanza, figlia del senatore bolognese. Nonostante le continue rassicurazioni di Giuseppe Ariosti sul buono stato di salute e sui progressi scolastici della «Costanzina», ben presto si manifestarono le prime difficoltà: i costi forse eccessivi del tenore di vita delle educande di Pressburg, tutti a carico del militare, convinsero lui e la moglie ad adottare restrizioni non adatte allo status sociale della ragazza, mettendo così in grande apprensione i genitori a Bologna. Nel 1739 la situazione precipitò: la decisione di seguire il marito in Transilvania spinse Francesca Ariosti a destinare Costanza a un altro collegio, non potendo – o non volendo – portarla con sé. La rapidità con cui avvenne il trasferimento non lasciò il tempo di trovare una nuova e adeguata collocazione alla giovane, che si
Signoria Illustrissima s’interessi della mia fortuna, e lustro della famiglia, così mi avanzo con la presente a notificarle come hoggi in Anticamera di Sua Maestà Cesarea e Cattolica il signor mio generale Marchese di Valparayso mi ha dichiarato Sergente Maggiore del suo Reggimento. Caso sì avvantaggioso e difficile nelle truppe imperiali che non si può dir di più».
22 aSbo, lettera datata Sermide, 24 aprile 1736.23 Il collegio dei Nobili di Parma, fondato nel 1601, venne ben presto affidato ai Gesuiti (1606) e
divenne una delle scuole più prestigiose del Settecento. Vi studiarono infatti personaggi di grande rilievo, quali Scipione Maffei, Cesare Beccaria e Pietro Verri, ma anche Benedetto Odescalchi, che divenne poi papa Innocenzo xi, e rampolli della nobiltà straniera. Lo studio più esaustivo sul Collegio dei Nobili di Parma, anche se datato, rimane quello di CapaSSo 1901, pp. 1-285; più recenti, ma meno dettagliati, sono invece i contributi di bolondi 1987, pp. 53-57 e di di noto marrella 1997, pp. 133-138.
065_092_UNUFFICIALE.indd 71 09/11/10 15:12
72
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
vide costretta a ritornare in patria. I genitori, preoccupati per le condizioni di salute della figlia, non appena la ritrovarono «sana e salva, e garbatissi-ma», ma «con abiti che le erano diventati stretti da far vergogna», decisero di interrompere definitivamente i rapporti con Giuseppe Ariosti24.
I tentativi di Giuseppe Zanardi, cameriere al servizio dell’Ariosti, il quale nell’aprile del 1744 cercò di interporsi come paciere tra i due paren-ti, non ebbero esito positivo. Benché egli supplicasse il conte Corradino di perdonare il suo padrone, che, nonostante i «disgusti» intercorsi tra i due, manifestava sempre una venerazione per lui, e non mancava di informar-lo sull’esito delle sue promozioni25, i contatti tra le due famiglie ripresero solo nel 1762, quando Giuseppe inviò a Niccolò Ariosti, figlio di Corradi-no, una lettera di cordoglio per la morte del padre.
Di lì a qualche anno, il 28 settembre del 1766, morì anche Giuseppe Ariosti di un colpo apoplettico, all’età di 76 anni, nel sobborgo di Mariahilf a Vienna26.
‘Erudizione’ militare e collezionismo
La pratica delle armi, secondo quanto vuole la tradizione, non era il solo interesse dei militari, soprattutto a partire dal Cinquecento. Infatti, la formazione degli ufficiali di carriera prevedeva l’acquisizione di com-petenze diverse, anche in settori non solamente legati alla sfera bellica. È molto radicata, per esempio, la tradizione degli architetti militari, come dimostra il caso della fortezza di Giavarino in Ungheria, la cui realizzazio-ne si deve in massima parte proprio agli architetti militari italiani, ma non è l’unico esempio riscontrato in terra magiara, come dimostrano alcuni studi bene documentati, benché di non recente pubblicazione27. Anche la formazione letteraria aveva un suo peso, e infatti il binomio letteratura e guerra ha tradizioni antichissime: è forse superfluo ricordare l’alto valore letterario dell’opera di Giulio Cesare; magari meno immediato, ma certo non oscuro, l’esempio del Machiavelli, che della prassi militare, cioè del compito che il Soderini gli aveva affidato di riordinare le milizie fiorentine, ha lasciato una pregevole testimonianza nel trattato Dell’arte della guerra.
24 Ricostruisce l’episodio con dovizia di particolari Calore 1957, a cui si rimanda, in particolare alle pp. 155-159 (desumo le citazioni da p. 159).
25 Cfr. la lettera dello Zanardi, datata 1 aprile 1744 (aSbo): «Deto mio Padrone è statto da Sua Maestà dichiarato suo General di Battaglia e suo attual Gentilhuomo di camera, e nell’istesso tempo li ha dato gli ordini di andare a servire sotto gli ordini del signor maresciallo duca di Arenberg nella grande armata degli alleati in Fiandra, verso dove già siamo in marcia».
26 Winkler 1975, p. 304.27 Si vedano al proposito maGGiorotti 1930 e holik-barabaS 1932.
065_092_UNUFFICIALE.indd 72 09/11/10 15:12
73
GiuSeppe arioSti
Sono poi annoverate tra le opere letterarie di maggior interesse del xvii se-colo il trattato Dell’arte della guerra e gli Aforismi dell’arte bellica di Raimon-do Montecuccoli; e con l’Ariosti egli ha in comune almeno la militanza in Ungheria durante la guerra contro i Turchi, anche se in anni differenti. Il Montecuccoli, infatti, prese parte alla guerra austro-turca del 1663-64 in qualità di Comandante in capo, e di questa esperienza lasciò una vivida testimonianza nei suoi scritti. In occasione della vittoriosa battaglia di Mo-gersdorf, egli ricorda anche i preziosi trofei di guerra: «Molti stendardi e bandiere furono per noi conquistate, e ricchissimo ne fu il bottino di arnesi dorati e d’argento, di danari, di sciabole, cavalli, armi gioiellate, vesti pre-ziose e molte altre siffatte cose»28.
Fatte le dovute proporzioni, possiamo però dire che anche l’Ariosti ebbe esperienze militari analoghe a quelle del Montecuccoli, e lui pure non si sottrasse all’uso di inviare in patria i trofei conquistati, forse più per il loro significato simbolico o per il loro valore venale che per l’effetti-vo pregio artistico. Numerose sono le lettere in cui il militare menziona il
28 monteCuCColi 1987, p. 12.
Trofei con armi turchesche nella Porta dei Bombardieri di Verona.
065_092_UNUFFICIALE.indd 73 09/11/10 15:13
74
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
bottino di guerra (in particolare bandiere, stendardi, cavalli), destinato per la più parte ad essere mandato in dono a Corradino Ariosti. Esemplare in questo senso risulta uno stralcio della lettera inviata da Essegg il 9 gennaio del 1717:
Di novità o per dir meglio rarità di questi paesi in caso che venga in Italia mi pare che non potrei portar altro che una dozzina di camel-li, schiavi, caffè, qualche buona damaschina29, e cavalli; dico in caso mi capitino poiché quest’anno di tutto ho hauto in abbondanza, per la Dio grazia. La supplico per tanto dirmi se sono cose stimabili in coteste no-stre parti […]; perciò mi avvisi per tempo poiché questo se siamo fortu-nati sarà nel principio della campagna, di dove subbito spedirò il mio cameriere in Italia con tutto quello posso metter insieme di raro.
Il senatore Corradino Ariosti pareva interessato soprattutto all’invio dal fronte turco di cavalli pregiati; del resto quella per i cavalli era una passione diffusa nel secolo, come testimonia anche l’«ippofilia» di Vittorio Alfieri30. Il militare, però, si poneva spesso il problema di inviare animali di pregio, il cui valore non fosse inficiato da qualche difetto, come gli capi-ta con un cavallo sauro («zauro» per il nostro), che è incerto se mandare in Italia per via di una “menomazione”:
Nella campagna passata io feci un cavallo zauro di bottino, corridore
in sommo grado, e bene fatto, quello sì posso dire; havendolo però fatto vedere a molti nostri paesani se era cosa da mandarsi in Italia, mi dicono tutti che lo sarebbe se fosse intiero, ma per esser castrato non haverebbe la stima ricercata; che è veramente un peccato poiché per correre s’è pro-vato in tutta l’Armata per singolar ben fatto, color baio castagno, coda ed estremità negre, vivo quanto dir si possa ed infine al giudizio di tutti è cosa singolare; ma come le dico, è castrato31.
Per ovviare all’inconveniente del cavallo sauro, Giuseppe Ariosti si proponeva in un breve tempo di inviare un esemplare di uguali qualità, ma di maggior valore, e più appetibile per un esponente di spicco della
29 Dovrebbe qui intendere una sciabola di lama damaschina. Vale forse la pena di ricordare che Aristarco Scannabue, alias Giuseppe Baretti, compilatore della «Frusta letteraria» era – nella finzione letteraria – un soldato che aveva militato «in Ungheria ne’ dragoni dell’invincibile Principe Eugenio», sfregiato da «qualche difetto nel labbro inferiore, baciatogli quasi tutto via in Erzerum dalla dammaschina sciabla d’un soldato circasso» (baretti 1932, vol. i, pp. 5-6).
30 azzolini 2005, pp. 41-53 e marChi 2003.31 aSbo, lettera inviata da Essegg il 9 gennaio 171‹7›.
065_092_UNUFFICIALE.indd 74 09/11/10 15:13
75
GiuSeppe arioSti
nobiltà italiana quale egli considera il parente. Per questo rassicurava Cor-radino del fatto che il suo spostamento in Transilvania gli avrebbe fornito occasioni utili per inviare in Italia animali di un qualche valore:
con fretta le notifico la nostra marcia in Transilvania, di dove potrò con miglior occasione servirla per il cavallo tartaro ricercato, quale stia per sicuro (che infallibilmente alla mia venuta in Italia che spero dop-po la campagna seguirà) riceverà ancor che dovessi imbrogliar mezzo mondo. La bandiera è appresso di me che però è certo; e mi creda che se mi capiterà cosa di raro io non lascierò farne parte a Vostra Signoria Illustrissima, essendo ben ragione che i rampolli della nostra famiglia facciano il loro dovere a chi <è> il lustro, e il capo della medesma32.
Se l’invio di trofei ‘equestri’ a Corradino Ariosti rappresentava per il militare un omaggio al «lustro» del capofamiglia, egli però dovette ave-re anche dei piccoli interessi commerciali, legati probabilmente agli stessi cavalli, ma attestati nel carteggio soprattutto in relazione a una partita di cammelli, come si evince dalla già ricordata lettera del 9 gennaio 1717: «quest’anno con un fiorino ne ho comprati quattro [di cammelli] e poi li ho venduti ai Turchi di Temeswar 30 ducati d’oro l’uno». L’ostilità nei confronti dell’odiato nemico turco, che emergeva in maniera evidente da quasi tutte le lettere inviate dal fronte, era stata quindi accantonata a van-taggio di più o meno cospicui interessi commerciali.
Larga parte del carteggio testimonia poi la continua ricerca da parte di Giuseppe Ariosti di rarità e curiosità da inviare dal fronte bellico: oltre ai cavalli spesso venivano ricordate bandiere, stendardi e code di cavallo33. Trofei questi ultimi particolarmente ambiti, visto che spesso l’invio era reso impossibile dal principe Eugenio di Savoia, che si riservava la scelta degli esemplari più belli:
32 aSbo, lettera scritta durante la «marcia per la Transilvania» del 20 marzo 1717.33 Per code di cavallo si devono intendere le insegne militari poste sopra gli stendardi: possono essere
strisce di stoffa ad essi legate, oppure essere dipinte direttamente sopra il medesimo, in tutti i colori meno che in verde. La tradizione attesta che questa insegna ebbe origine durante una sfortunata battaglia tra cristiani e Turchi, che vedeva questi ultimi in grave difficoltà, tanto da perdere la loro bandiera con la mezza luna; un generale turco, allora, tagliò la coda a un cavallo e la pose sopra una picca, incitando i suoi a seguirlo. Rianimati dal coraggioso gesto, i soldati turchi ripresero vigore e riuscirono a rivolgere le sorti della battaglia. Le code di cavallo appese al serraglio imperiale avevano lo stesso valore che presso gli antichi romani aveva l’apertura delle porte del tempio di Giano: indicavano cioè i periodi di guerra. Il sultano in battaglia era facilmente riconoscibile, perché il suo stendardo era l’unico a portare sette code, che rappresentavano le sette parti in cui, secondo la concezione orientale, sarebbe stato diviso il mondo, e sopra le quali avrebbe regnato come unico re proprio il sultano. Cfr. moroni 1856, vol. lxxxi, p. 231.
065_092_UNUFFICIALE.indd 75 09/11/10 15:13
76
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Circa la bandiera ricercatami in verità io ne buscai una alla batta-glia di Pietro Waradino, ed un’altra ne ho buscata in una picciola partita dove habbiamo fatti 113 schiavi, però non mi pare doverla arrischiare di mandarla per terza persona essendo cosa pericolosa ed esser nascoste, o rubbate per dir meglio; il Sergente della mia propria compagnia mi portò ancora una bella coda di cavallo, ma il mio generale mi ha proibito il torla via senza licenza di Sua Altezza Reale il signor Principe Eugenio; spero però che intanto si scorderanno di ciò che nella campagna passata è seguito quando cominciaremo la nuova. Intanto Vostra Signoria Illu-strissima si assicuri che sarà infallibilmente servita di dette due bandiere delle quali prenderà una a suo gusto, e l’altra la manderà a suo fratello34.
Le code di cavallo, insegne appartenenti solo alla tradizione turca, dovevano essere di particolare pregio e molto ambite, visto che anche in seguito l’Ariosti narrava al parente di aver trovato una «coda di caval-lo assai bella, e delle principali», di cui – ancora una volta – non poteva però disporre liberamente, perché il principe Eugenio voleva per sé tutti gli esemplari migliori35.
Accanto a interessi che potremmo definire collezionistici, come quelli appena ricordati di bandiere e stendardi, il carteggio restituisce attestazio-ne anche di una prassi che per il tempo doveva essere abbastanza comune e probabilmente non disdicevole: cioè l’invio in patria di prigionieri di guerra fatti schiavi, in particolare donne e bambini, che venivano poi im-piegati come valletti, cameriere e servitori. Lo stesso Giuseppe Ariosti pro-metteva al parente di mandare in Italia, al servizio di sua moglie Vittoria, una schiava che gli era toccata in sorte, la quale non aveva ancora avuto modo di pagare il riscatto per la sua liberazione:
Nella partita mi è toccato una femina gravida con un figliolino di quattro in cinque anni che si chiama Assan, la madre l’ho mandata in Bosnia con passaporto dicendo che vuol darmi cento ducati d’oro per il riscato, è assai bella ed è ritornata di Bosnia ma non ha portato beni, adesso vuol ritornare. Se non li porta la seconda volta per infallibile la manderò in Italia alla signora Vittoria36.
Giuseppe Ariosti, oltre che per le rarità conquistate in battaglia, dimo-strava un qualche interesse anche per un altro studio molto in voga nel
34 aSbo, lettera inviata da Essegg il 9 gennaio 171‹7›.35 aSbo, lettera scritta da Illock il 31 gennaio 1717.36 aSbo, lettera datata Essegg, 9 gennaio 171‹7›.
065_092_UNUFFICIALE.indd 76 09/11/10 15:13
77
GiuSeppe arioSti
xviii secolo, quello delle medaglie. In una lettera del 17 ottobre 1720, infatti, egli chiede al parente di recuperare un volume raro con la riproduzione della collezione di medaglie del Duca di Parma:
Mi scordai a lasciar indietro la memoria di quel libro di Parma, che perciò fo la supplica far diligenza. È un trattato di Medaglie del studio del Duca di Parma in 7 tomi in foglio fatto dal padre Petrusio Gesuita, il quale non si vende in nessun luogo; ma lo dona l’istesso Duca. In questo momento parto per la volta di Firenze37.
L’opera cui fa riferimento l’Ariosti è indubbiamente la collezione de I Cesari… raccolti nel Farnese Museo, e pubblicati colle loro congrue inter-pretazioni, voluminoso studio di Paolo Pedrusi (e non Petrusio), in cui il gesuita illustrava il Gabinetto di Medaglie del duca di Parma Fran-cesco Maria Farnese, effigiate dall’incisore bolognese Giacomo Maria Giovannini38. Non è però chiaro se il militare nutrisse reali interessi per l’argomento trattato, o piuttosto se ritenesse i sette volumi in folio solo un oggetto di pregio librario, degno di essere collezionato o inviato a qualche personaggio di spicco. È però vero che già Apostolo Zeno ricor-dava di aver visto in casa dell’Ariosti a Vienna delle medaglie d’argento ascrivibili all’età imperiale romana («Io le ho vedute in Vienna [si parla delle medaglie raffiguranti Ostiliano ed Etruscilla] appresso il Conte Giuseppe Ariosti, Capitano allora nei Reggimenti di S.M. Cesarea»)39.
Durante le campagne militari in Transilvania, il generale Ariosti si de-
37 aSbo, lettera scritta da Bologna il 17 ottobre 1720.38 L’Ariosti parla di sette volumi, mentre il Pedrusi (Mantova 1644 - Parma 1720) ne realizzò otto,
l’ultimo dei quali, però, edito nel 1721, cioè un anno dopo la stesura della presente lettera. Altri due volumi vennero pubblicati postumi nel 1724-1727 da Pietro Piovene. Le incisioni dei primi sette volumi furono affidate, come appena accennato, a Giacomo Maria Giovannini (Bologna 1667- Parma 1717), che ne realizzò con molta esattezza e fedeltà 2000; l’ultimo volume venne invece affidato all’incisore Giovanni Battista Sintes (Roma 1680 - ivi 1760). Per notizie sul Giovannini e sul Pedrusi, cfr. laSaGni 1999, vol. iii, pp. 12-13 e 841; per il Sintes si veda invece mammuCari 2005, p. 348. Questo il piano dettagliato dei volumi che compongo l’opera: i. I Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo e pubblicati colle loro congrue interpretazioni (Parma, nella Stamperia di S.A.S., 1694); ii. I Cesari in argento da Giulio Cesare sino a’ Trajano raccolti nel Farnese Museo e pubblicati colle loro congrue interpretazioni (ivi, 1701); iii. I Cesari in argento da Adriano sino a Caracalla, e Geta (ivi, 1703); iv. I Cesari in argento da Macrino, sino a Eraclio (ivi, 1704); v. I Cesari in medaglioni (ivi, 1709); vi. I Cesari in metallo grande, da Giulio Cesare sino a L. Elio, (ivi, 1714); vii. I Cesari in metallo grande da Antonino Pio fino a Gordiano (ivi, 1717); viii. I Cesari in metallo grande, proseguendo da M.G. Filippo, fino a Postumo, con parte de’ Cesari in metallo mezzano, e piccolo, incominciando da Alessandro Magno, fino a Tito (ivi, 1721).
39 zeno 1785, vol. vi, p. 151. Analoghe indicazioni in tal senso si leggono anche nella biografia che Francesco Negri dedica allo Zeno: «Egli [scil. Ariosti] è assai dilettante delle cose dell’antichità erudita, e in Ungheria, Transilvania e Valachia ha avuto modo di raccogliere un gran numero di medaglie imperiali Greche e Latine, molte delle quali sono rarissime e singolari» (neGri 1816, p. 475).
065_092_UNUFFICIALE.indd 77 09/11/10 15:13
78
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
dicò poi alla trascrizione di molte iscrizioni d’epoca romana per inviarle a Scipione Maffei, come ricordava lo stesso erudito veronese nelle sue «Os-servazioni letterarie»:
Copia di tutte mandò [Giuseppe Ariosti] al Marchese Maffei, che si tratteneva allora in Firenze, dolendosi nelle sue lettere, che alcune si sper-dessero, usate quasi pietre comuni nei lavori che si andavan facendo40.
Dall’epistolario maffeiano sappiamo che il marchese soggiornò a Firen-ze per oltre un anno, dal 1720 al 172241, e quindi l’invio del codice epigrafi-co dovrebbe risalire agli ultimi mesi di questo soggiorno. L’anno successi-vo, il 1723, il Maffei si trasferì temporaneamente a Torino, per il noto affare del museo di antichità sotto il loggiato del nuovo palazzo dell’Università, che Vittorio Amedeo ii gli chiese di riordinare42. Anche l’Ariosti risedette in città nello stesso periodo, ed ebbe modo di allestire un codice di epigrafi torinesi, Lapidales inscriptiones sub antiquis Taurini moenibus reperte, codice di cui poi entrò in possesso il Maffei, e che si conserva ancora presso la Biblioteca Capitolare di Verona (CClxviii). Anche questa raccolta potrebbe fare pensare a un qualche interesse dell’Ariosti per l’epigrafia, come so-stiene Angelo Giaccaria:
È anche degno di nota il fatto che egli abbia voluto testimoniare sto-ricamente il ritrovamento di un numero così elevato di epigrafi, dando la precedenza, nella sua raccolta, a quelle ancora inedite. Il suo apporto alla ricerca epigrafica deve pertanto ritenersi di grandissima importan-za, non solo per le iscrizioni descritte per la prima volta, ma anche per-ché consente di seguire gli spostamenti nel tempo delle altre già note43.
Pur essendo indubbia l’importanza delle due raccolte epigrafiche rea-lizzate dal militare senese, in quel che resta del suo epistolario non com-paiono mai riferimenti al reperimento e alla trascrizione di iscrizioni. L’incarico di copiare le epigrafi della Transilvania, affidatogli dall’Impe-ratore, e in qualche modo auspicato – o per lo meno approvato con entu-siasmo – dallo Zeno prima, e dal Maffei in un secondo tempo44, potreb-be sembrare per certi versi paragonabile alle richieste di inviare cavalli,
40 maffei 1737, p. 168.41 La prima lettera è data 5 ottobre 1720, l’ultima 18 agosto 1722. Cfr. maffei 1955, vol. i, pp. 361-430. 42 Cfr. romaGnani 1986.43 GiaCCaria 1992, pp. 51-52.44 Gli interessi di Zeno e Maffei, e a latere del Muratori, per il codice epigrafico realizzato dall’Ariosti
sono ricostruiti in questo stesso volume da Michela Fantato, al cui saggio si rinvia.
065_092_UNUFFICIALE.indd 78 09/11/10 15:13
79
GiuSeppe arioSti
bandiere e altri trofei di guerra, richieste che per altro il nostro cercava puntualmente di soddisfare.
Reportage dalla guerra austro-turca del 1716-1718
Lungi dal voler ricostruire in maniera scrupolosa e puntuale le note vicende della guerra austro-turca, vicende per altro illustrate nei minimi dettagli dagli studi ad esempio di Ludwig Matuschka, in questa sede si intende fornire una testimonianza diretta del conflitto, così come descritto da un punto di vista privilegiato, quello cioè di chi registrava avvenimenti e impressioni in tempo reale. Giuseppe Ariosti, capitano del reggimento Gaier al seguito del principe Eugenio di Savoia, prese infatti parte alla lunga, vittoriosa guerra contro i Turchi del 1716-1718, e nelle sue lettere ricostruì fedelmente le battaglie che lo videro direttamente coinvolto.
Dopo che i Turchi nel 1715 occuparono i possedimenti veneti in Grecia, il 13 aprile dell’anno successivo la Repubblica di Venezia rinnovò il patto di alleanza con l’imperatore Carlo vi, per difendersi dal comune nemico. La data sancì per certi versi l’inizio del conflitto austro-turco, che prese fattivamente le mosse nel luglio del 1716. Eugenio di Savoia, che aveva già partecipato alle guerre contro gli Ottomani del 1683-1699, dando un con-tributo fondamentale durante la vittoriosa battaglia di Mohács, si preparò attivamente al nuovo scontro bellico.
Giuseppe Ariosti registrò puntualmente l’arrivo delle armate imperiali nella zona di Pétervárad (Novi Sad), e comunicò al senatore Corradino i lavori che precedettero l’avvio delle ostilità: «il 16 fece la rivista di 16 bat-taglioni esistenti nel campo di Futach; ed il 17 di 3 reggimenti di cavalleria. Il 19 Sua Altezza […] fece la rivista di 8 reggimenti di cavalleria, e dell’arti-glieria di campagna». Con il passare dei giorni si infittirono i preparativi, e aumentò il numero dei militari nella zona in cui era prossima la battaglia: «il 23 entrò in questo campo Sua Eccellenza il signor General Tenente Conte di Falchenstain45 con 18 battaglioni, e 10 reggimenti di cavalleria seguitato il giorno appresso da […] 3 reggimenti di cavalleria; con che tutta la grand’ar-mata forte di 67 battaglioni e di 34 reggimenti di cavalleria, senza 11 batta-glioni di granattieri, e 15 squadroni di granattieri a cheval, e di carabinieri»46.
Il 5 di agosto ebbe luogo la prima grande battaglia, a Pétervárad: la vit-toria delle truppe imperiali comportò ingenti perdite, soprattutto da par-te turca. In una lettera inviata dal campo di Temesvár pochi giorni dopo
45 Si tratta del barone Federico Leopoldo von Falkenstein. Cfr. paoletti 2001, p. 620.46 aSbo, lettera scritta da Futak il 24 luglio 1716.
065_092_UNUFFICIALE.indd 79 09/11/10 15:13
80
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
(16 agosto 1716), il comandante Ariosti descrisse l’esito della battaglia e l’ingente bottino, prospettando fiducioso ulteriori successi per la grande armata austriaca:
La passata vittoria di sotto Pietro Waradino e di cui glie ne diedi succinte notizie con altra mia in data delli 5 corrente sempre più fassi maggiore poiché è certa la morte del Gran Visir dell’Agà de Gianizzeri e di più di 30mila turchi restati sul campo. Si sono ritrovati di nuovo 40 pezzi di artiglieria da battere aquattati dentro certe cave. In fine i carri di munizioni presi non sono da numerarsi e più di 500 bandiere. Che però è tale il timore dei barbari che credono essere arrivata la loro fine. È altresì certo che un’armata bella come la nostra […] non si è veduta da gran tempo in qua, ed è altrettanto capace con l’aiuto di Dio di metter alla ragione questo indegno nemico che ha fatto tali barbarie non solo con li nostri schiavi.
Il principe Eugenio decise di approfittare della defaillance turca per espugnare la fortezza di Belgrado. L’azione era però ardua senza la previa conquista della piazza di Temesvár, che avrebbe reso possibile l’occupa-zione del Banato, ultima regione dell’antico regno d’Ungheria ancora in mano turca. Come si evince dalla missiva ora richiamata, in agosto l’eser-cito si trovava a Temesvár, dove iniziò un breve, ma efficace assedio, che vide la capitolazione della guarnigione turca nel mese di ottobre. Seguì quindi l’assedio alla fortezza della Palánka, città dell’attuale Serbia (serbo Бачка Паланка, ungherese Palánka, tedesco Plankenburg), mossa strategica per l’avvicinamento al Banato. Delle fasi salienti dell’operazione abbiamo memoria in una lettera di Giuseppe Ariosti del 10 ottobre 1716:
L’aqquisto [sic] della Palanca azione così ardita, non ha costato che 444 morti e 1560 feriti. Tra i morti di distinzione sono un conte Caziano Maggiore, un conte di Taytemback Maggiore, un Barone Beck47 ed altri tra i feriti tutti i Generali comandati in tal azione, e una gran quantità di ofiziali. Il primo di ottobre si prese posto tirandosi una linea obliqua al ridosso del bastione della detta Palanca, il 2 si tirò una biscia48, la quale venne perfezionata il 6, nel qual giorno si risanò i lavori già fatti per esser stati alquanto deboli, il settimo si die’ principio alle nostre batterie
47 Trattasi in realtà del conte maggiore Katzianer, del conte Tattenbach e del barone von Beck. Cfr. matuSChka 1900a, p. 198.
48 Biscia: «En zig-zag. A sghimbescio, tortuosamente; e dicesi in particolare delle trincee o rami di trincea scavati sotto le offese dell’inimico e che si fanno a questo modo per ripararsi di suoi tiri» (medini 1847, p. 36).
065_092_UNUFFICIALE.indd 80 09/11/10 15:13
81
GiuSeppe arioSti
per 60 pezzi e 48 mortari, queste il giorno 8 cominciò a giocare, e quelle questa mattina facendosi da ambe le parti un fuoco non mai già udito, poiché per esser tutta la città e la Palanca di legname no‹n› può credersi il terribil fuoco che continuamente si accende dalle freccie del Turco e dalle nostre carcasse49. Il 6 di questo si è preso un spione escito dalla piazza con lettere al Gran Wizir a Belgrado con le quali notificava questo Bascià il suo gran bisogno, e che quando non fosse soccorso in breve si vedeva all’u‹l›timi esterminii; e certo non è cosa di poca considerazione il gran numero di gente che si ritrova dentro della città il dover soffrire un fuoco di tanti mortari e artiglieria.
La testimonianza, da un punto di vista storico, è certo interessante, visto che il “bollettino ufficiale di guerra” registra 455 morti e 1592 feri-ti50; è però altrettanto evidente come la concitazione della battaglia spinse l’Ariosti a stendere dei comunicati di battaglia altrettanto concitati e incu-ranti delle regole grammaticali e sintattiche. Con eguale enfasi il nostro rievocò i momenti decisivi della successiva conquista di Temesvár:
Il 10 perfezionata la batteria grande di 24 pezzi cominciò a far fuoco con tal successo, che in 10 hore proibì al inimico il suo cannone. In questa notte si diede principio a due zappe51 per entrar ad alloggiarci nel fosso del loro rivellino. Restarono un alfiere e 22 morti e 79 feriti. […] Il 11 cominciarono a far fuoco 2 batterie poste alla dritta della gran batteria, una di 12 pezzi ed altra di sette. Il fuoco di questo giorno accompagnato dal getto delle bombe di 3 batterie, una di 21 mortar‹i›, 1 di 14 e una di otto, fu così terribile contro la Piazza che non è da esplicarsi, e verso la sera prese fuoco nella città durando per ben 5 ore corrisposto tutta la notte dalle nostre batterie. […] Il 12 entrando di trinciera l’invitto Prin-cipe Alessandro di Wirtemberg General d’artiglieria, il generale Tenente Daun e il General Maggiore conte di Wallis52. Seguitando da nostri il terribile incominciato fuoco, li barbari esposero bandiera bianca, chie-dendo honesta capitolazione53.
49 Carcassa: «Grossa palla fatta di un sacco tondo di tela, empiuto di una mistura artifiziata, rinforzato da uno scheletro di cerchi di ferro, e da una cordella intrecciatale tutto attorno a modo di rete. Si scaglia per lo più coi mortai petrieri, e serve negli assedi come le palle di fuoco. Dicesi anche da alcuni pallone di fuoco» (medini 1847, p. 167).
50 matuSChka 1900b, p. 199.51 Zappa: «trincea bassa e stretta scavata in prossimità delle fortificazioni nemiche durante le
operazioni d’assedio» (GDLI, 21, 1056; cfr. medini 1847, p. 782).52 Sulle figure di Karl I Alexander Herzog von Württemberg, Heinrich Joseph Daun e Wallis, cfr.
matuSChka 1900b, pp. 15, 44 e bérenGer 2003, p. 44.53 aSbo, lettera scritta dal campo di Temesvár il 13 ottobre del 1716.
065_092_UNUFFICIALE.indd 81 09/11/10 15:13
82
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Il resoconto del militare italiano, riportato quasi in presa diretta, risul-ta in linea con quanto emerge dalle ricostruzioni storiche dell’episodio, puntualizzando le date e la successione delle fasi d’attacco54. Conquistata la fortezza di Temesvár, i Turchi (definiti dal nostro «barbari») furono co-stretti a chiedere la resa, che prontamente venne concessa, tanto che il 16 ottobre poterono uscire onorevolmente dalla Piazza, «tamburo battente, e bandiere spiegate», sotto gli occhi quasi increduli dell’esercito imperiale, perché – stando alla testimonianza del nostro – sembrava impossibile in questa campagna «espugnare una fortezza così terribile»55.
La resa della città permise a Eugenio di Savoia di procedere all’assal-to della fortezza di Belgrado, dove infatti si diresse anche il comandante Ariosti, al quale venne tuttavia impedito di svernare in Ungheria, come egli stesso comunicò tempestivamente al parente:
Appunto ero entrato comandante di due compagnie del nostro regi-mento nel comitato d’Alba Reale, per ivi svernare, quando mi è giunto ordine di dover con tutta prontezza portarmi con le medesme nella Syr-mia turca, in quella striscia di paese appunto, che con tanta poca avve-dutezza fu nella ultima pace concessa al turco di qua dal Danubio; che però messomi in marcia, sono arrivato in 16 giorni in questa piazza, di dove mi partirò dimani per detti posti56.
Le fasi di preparazione del nuovo assedio di Belgrado57 dovettero es-sere più lunghe del previsto, forse anche a causa della stagione inverna-le che non favoriva i lavori di scavo delle trincee e di fortificazione. Se i libri di storia dedicati all’argomento trascurano di solito il periodo che va dal dicembre 1716 al maggio dell’anno successivo, quando il principe Eugenio lasciò Vienna per guidare il suo esercito e riprendere la marcia su Belgrado, il nostro cronista di guerra offrì invece un resoconto piuttosto dettagliato degli spostamenti dell’armata imperiale. Il 19 gennaio del 1717 il battaglione del conte Pállfy58 giunse in Sirmia, presso la famosa fortezza di Illock:
Con la presente le notifico come il 19 del presente arrivai al comando di questo castello, tutto rovinato, e aperto, dove però spero di non restar lungo tempo. I Turchi hanno giuntati 10 mila Turchi Bosniacki e si sono
54 Si confronti a tal proposito matuSChka 1900a, pp. 200-203.55 aSbo, lettera inviata da Temesvár il 19 ottobre 1716.56 aSbo, missiva datata da Essegg il 10 novembre 1716.57 Sul passaggio del Danubio e l’assedio di Belgrado, cfr. matuSChka 1900b, pp. 56-109.58 Sul conte Erdöd, cfr. pálffy 1858, p. 105 e matuSChka 1900b, p. 15.
065_092_UNUFFICIALE.indd 82 09/11/10 15:13
83
GiuSeppe arioSti
messi a portata d’impedire al general Merci il passaggio del Danubio in caso che si agghiacciasse il medemo59.
In una lettera successiva l’Ariosti precisò il numero di uomini ai suoi ordini, e le mansioni loro affidate, mentre tutto l’esercito si preparava alla grande presa di Belgrado60:
Non lascio di avvisar Vostra Signoria Illustrissima come io mi ritrovo Comandante qui in Illock dove ho sotto il mio comando 100 cesarei, 150 hussari, e 200 ayduchi61 con i quali devo guardare questo Ducato di Syr-mia, dove però in ogni villaggio sono salvaguardie turche e cristiane per la conservazione dei villani, i quali devono contribuire da ambe la parti con grosse somme di denari, foraggi, ed altri viveri. […] I preparativi per il futuro assedio di Belgrado sono indicibili, facendosi tutto il possibile per esser sotto detta piazza per il principio di aprile. Il che seguendo, non si dubita un buon effetto già che il turco non può esser con le sue forze in Bosnia fino alla fine di luglio.
All’assedio vero e proprio e alla battaglia (16 agosto 1717), però, l’Ariosti non prese parte, perché il 19 marzo dello stesso anno inizierà la marcia con il suo reggimento verso la Transilvania, «dove d’ordine della corte marcia-no i Reggimenti, che più hanno patito nella campagna passata», mentre il resto dell’esercito, «30 mila fanti e 8 mila cavalli», ebbe l’ordine di «met-tersi in marcia per il randevous [sic] a Futach per poi investire Belgrado»62.
Per quanto sia possibile ricostruire dal carteggio superstite, sembra che l’invio di notizie da parte del militare registri in questo torno di tempo una battuta d’arresto, forse perché egli non era più direttamente coinvolto nelle azioni militari di primo piano, ma si trovava a Karlsburg (Alba Iulia), donde comunque inviava notizie rilevanti sull’andamento del conflitto: la fortezza di Panzowa (Pancevo) venne messa a ferro e fuoco dall’arma-ta turca, e durante uno di questi attacchi l’esercito imperiale subì ingenti perdite. Continuò poi l’opera di fortificazione dei siti già occupati, come Klauserburg (Kolozsvár/Cluj-Napoca):
59 aSbo, lettera scritta da Illock il 20 gennaio 1717.60 aSbo, missiva inviata sempre da Illock il 31 gennaio dello stesso anno.61 Gli Aiduchi erano fanti ungheresi. Inizialmente popolo di pastori, divennero poi guerrieri; devono
il loro nome al distretto di Haiduki, a nord di Debrecen, in Ungheria, dove si stabilirono all’inizio del XVII secolo. Cfr. köpeCzi-Sárközy 1982, p. 158; paSSerini 1916, p. 238. Il termine è utilizzato da D’Annunzio nell’Ode alla nazione serba del 1915 (d’annunzio 1984, pp. 785-798, vv. 36, 69, 153, 318, 346).
62 La lettera fu scritta da Illock il 4 marzo 1717, mentre l’Ariosti era in procinto di partire per la nuova destinazione.
065_092_UNUFFICIALE.indd 83 09/11/10 15:13
84
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Le fortificazioni della cittadella di Clausembourgh sono in buon stato di avanzamento sì come quelle di Teva. Qui travagliano giornalmente fino a 3000 persone. Si spera che dopo 9 anni sarà perfezionata. […] Il principe di Wallachia si è accordato contribuire all’imperatore 100 mila fiorini annui fino che l’imperatore sia padrone di Belgrado63.
La guerra era però ormai quasi sopita, viste le brillanti vittorie dell’eser-cito imperiale, tanto che, in una lettera scritta da Karlsburg il 12 dicembre del 1717, Giuseppe Ariosti accennò già alle condizioni per stipulare una possibile pace con i Turchi; pace che si concretizzò solo il 21 luglio dell’an-no successivo, quando a Passarowitz venne firmato un trattato che sancì le posizioni acquisite: il Banato, la Valacchia occidentale, la Serbia settentrio-nale e Belgrado e parte della Bosnia passarono sotto il dominio austriaco, mentre Venezia – pur rinunciando alla Morea – poteva conservare le Isole Ionie e i domini in Dalmazia:
N. 1. La retenzione di Temeswar con tutto il Banato di detta Teme-swar.
N. 2. La retenzione della Syrmia nel ultima [sic] Pace di Carlowitz dal Marsigli64 lasciata ai turchi tra il Danubio e la Sava.
N. 3. La ritenzione di Belgrado con la restituzione di tutte le perti-nenze di detta Belgrado, che sono il Sanghiacciato [sic] di Bosnia e regno di Sermia con abbandonare i turchi Sworneck [Zvornik] e Wisnowitza [croato Virovitica, tedesco Wirowititz, ungherese Verőce] e ceder la comu-nicazione per terra fino al mare Adriatico ed ivi provedere l’imperatore di uno dei migliori porti di mare atto a coprire una flotta.
N. 4. La cessione della nomina dei principi di Moldavia e di Walla-ckia e con la total renunzia a Sua Maestà Cesarea di tutti i tributi, ricavati dal turco fin hora, e ciò si deve intendere per l’estensione di dette pro-vincie fino al Mar Negro.
N. 5. Una equivalente somma di contante per le spese di questa guer-ra, per essersi rotta dal turco contro ogni legge di ragione la tregua e trattato di Carlowitz.
Le condizioni di pace prospettate dall’ufficiale bolognese furono, in linea di massima, applicate dopo il trattato di Passarowitz, ma la deli-
63 Lettera inviata da Karlsburg il 7 agosto 1717.64 Luigi Ferdinando Marsigli fu eletto plenipotenziario per definire i confini tra la Turchia, la Polonia,
Venezia e l’Austria. Per una biografia del Marsigli si rimanda al contributo di Stoye 1994. Sul ruolo ricoperto dal bolognese durante le trattative di pace, si vedano invece i due studi di molnár 2005, pp. 38-50, e di bene 2006, pp. 113-146.
065_092_UNUFFICIALE.indd 84 09/11/10 15:13
85
GiuSeppe arioSti
mitazione dei confini – anche dopo la resa turca – rimase una questio-ne complessa e delicata, come traspare da una lettera del 19 novembre 1718, quindi ben successiva alla stipula della pace: «I nostri commissari dei confini sono ritornati, per non essersi potuti accordare con i Turchi nella detta limitazione delle finanze, che per ciò si sta in attenzione ciò sia per risolversi dalla Corte. I mercanti turchi però vanno e vengono senza altro ritegno portando qui molte merci». Nonostante la ripresa dei traffici commerciali, la situazione era in effetti segnata da forte miseria e povertà, a cui si aggiunse anche il crescente dilagare della peste, che decimò la po-polazione sopravvissuta alla guerra: «in tutta la Transilvania non si trova un carro di fieno, né di paglia, e il grano è indicibilmente caro, di modo che le genti che non sono toccate dalla peste muoiono di fame»65. Anche le lettere dell’anno successivo delineano un quadro della situazione per nul-la rassicurante, segnato dal persistere della carestia, e quindi anche della peste, nonché da tutte le violazioni dei confini da parte turca. Per sottrarsi al contagio, Giuseppe Ariosti ottenne la licenza di portarsi in Italia, dove – come già ricordato – fu chiamato a dirimere pressanti questioni patrimo-niali con il fratello.
Guerra di successione polacca e nuova campagna austro-turca
Nel gennaio del 1720 Giuseppe Ariosti si apprestava a lasciare Belgra-do, diretto verso Fiume, dove si sarebbe imbarcato per Napoli, per poi passare in Toscana e in seguito a Bologna: qui finalmente avrebbe potuto conoscere di persona Corradino Ariosti66. Rientrato in patria, egli cercò di ottenere un avanzamento di grado militare, come già accennato, ma so-prattutto fu costretto ad occuparsi di questioni che riguardavano il patri-monio familiare, favorito anche dalla situazione politica: le grandi potenze europee, infatti, conobbero un periodo di pace che durò quasi tre lustri.
Anche il Principe Eugenio di Savoia, al cui servizio militava l’Ariosti, consacrò gli anni che andavano dal 1720 al 1733 al riordino dell’esercito e alla vita diplomatica, stipulando importanti alleanze con Russia e Dani-marca prima, e con l’Inghilterra poi. Il nostro, conclusi felicemente gli af-fari di famiglia e ricuciti i rapporti con il fratello, tornò a vivere in Austria, in particolare a Vienna, come testimoniano le pochissime lettere relative a questi anni che ci sono pervenute.
L’equilibrio politico, fortemente voluto dai maggiori regni europei, si
65 Come già ricordato, la lettera è inviata da Hermannstadt, in Transilvania, il 19 novembre 1718.66 Le notizie si desumono da una lettera del 29 gennaio 1720, sempre conservata presso l’aSbo.
065_092_UNUFFICIALE.indd 85 09/11/10 15:13
86
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
dimostrò per altro assai fragile. Nonostante i numerosi accordi stipulati in quegli anni, esso venne infatti messo in seria discussione nel 1731, in seguito all’estinzione di casa Farnese, che consegnò il Ducato di Parma e Piacenza in seguito al trattato di Siviglia (1729) nelle mani di Don Carlos, e quindi dei Borboni. L’Austria, che pure nutriva la speranza di annette-re ai propri possedimenti italiani il ducato, gli mosse guerra, riuscendo ad occupare militarmente i territori parmigiani. Il non interventismo di Francia e Inghilterra favorì infine un accordo tra Spagna e Austria, che permise di risolvere il contenzioso in breve e senza troppe perdite, asse-gnando a Don Carlos Parma, Piacenza e la Toscana in cambio del ricono-scimento della prammatica sanzione, e quindi della legittima successio-ne al trono asburgico di Maria Teresa. Questa, però, fu solo la prima av-visaglia di quello che sarebbe avvenuto in seguito alla vacanza di un ben più importante trono, cioè quello polacco: alla morte di Augusto ii Wettin (1733), infatti, Russia, Prussia e Austria da un lato, e Francia e Spagna dall’altro, cercarono di far eleggere dalla Dieta polacca un sovrano che favorisse le rispettive alleanze, e che in caso di conflitto, naturalmente, si schierasse quale loro alleato. Stanislao Leszczyński, appoggiato dai fran-cesi, riuscì ad entrare di nascosto in Polonia e a farsi proclamare re; ma il partito di Federico Augusto ii, elettore di Sassonia, figlio di Augusto ii, convinse quest’ultimo ad entrare a sua volta in Polonia, cosa che egli fece sostenuto militarmente dalla Russia, costringendo l’avversario a fuggire. La Francia immediatamente mosse un attacco all’impero asburgico in quello che era il suo punto debole, cioè i possedimenti nell’Italia setten-trionale: la successione polacca diveniva così il casus belli per un nuovo conflitto tra i grandi d’Europa. Se da un lato il principe Eugenio di Sa-voia era impegnato sul fronte militare renano, parte del suo esercito era invece stato inviato in Italia, dove i Francesi, alleati con la Spagna e il re-gno di Sardegna, espugnavano con certa facilità i possedimenti austriaci nella penisola, Milano e la Toscana, per poi giungere al regno delle Due Sicilie. La battaglia decisiva sul fronte italiano venne combattuta a Biton-to il 25 maggio del 1734, e ad essa prese parte anche Giuseppe Ariosti, inviato dalla corte di Vienna al seguito del principe di Francavilla con 2000 uomini, e qui sconfitto e fatto prigioniero:
Venuto poi nella fatal giornata di Bitonto ivi difesi il convento dei Francescani, luogo aperto e senza difese, e doppo 8 hore doppo la lot-ta e resa di Bitonto con una onorevole capitolazione, fui necessitato a rendermi prigioniero di guerra, ma havuto il passaporto per andare in Germania su requisizione del detto Francavilla fui arrestato, e a forza di calunnie, e infamità dal medesimo addossatemi, mi ritrovo per anche
065_092_UNUFFICIALE.indd 86 09/11/10 15:13
87
GiuSeppe arioSti
qui in Napoli prigioniero. Spero però che quanto prima sarò spicciato e che mi porterò in Germania67.
In effetti la prigionia non dovette durare a lungo, dal momento che già il 6 maggio dell’anno successivo si trovava a Parma, in attesa di ripartire per la Germania. La situazione politica doveva essere però piuttosto con-fusa, e questo aveva ripercussioni anche nella vita dei militari, sottoposti ad ordini contradditori, e a marce continue che li portavano a disfar di notte quel che facevano di giorno, come Penelope con la sua tela:
Ma nella vita militare bisogna far tutto quello che gli altri vogliono e comandano. Eccole una riprova. Eravamo già in marcia per la volta del Tyrolo quando per strada ci è giunto l’ordine di cambiar tutta la mar-cia, e in vece d’andar per terra per detto Tirolo ci è convenuto venir qui ad imbarcarci sul Po fino al Porto di Gori, dove ci attende la flotta per transportarci a Trieste di dove il Colonnello con i due battaglioni va a dirittura al campo ed io vado a Vienna, e di lì a Leopoldstadt a comandar quel battaglione68.
Ma il poscritto alla presente lettera spiegava in parte la causa del repen-tino cambio di ordini: «in questo momento che sigillo la presente, arriva un corriero con il quale si sollecita la nostra marcia per l’Armata, essendo già dichiarata guerra al Turco, le nostre truppe sono già tutte in marcia per la volta di Vidino, del quale si pretende far la conquista in questa campa-gna». Un altro attacco turco, quindi, costrinse l’armata a rientrare il prima possibile, per iniziare – questa volta però al fianco dell’esercito russo – una nuova e lunga guerra contro gli Ottomani. Arrivato a Vienna il 28 di settembre, Giuseppe Ariosti venne destinato a raggiungere i confini della Bosnia e della Croazia in novembre, in condizioni piuttosto difficili, visto che lo aspettavano 40 giorni di marcia in pieno inverno con la «quaran-tana addosso». Come ricompensa per i servizi resi, nell’attesa di potergli conferire il grado meritato, il suo «Augustissimo Padrone» gli aveva asse-gnato 450 ungheri all’anno di pensione, fino a quando non fosse divenuto colonnello69.
Giuseppe Ariosti raggiunse infine Craitz70, in Croazia, nel febbraio del
67 La lettera è scritta da Napoli il 6 marzo 1735.68 Lettera inviata da Stellata il 10 agosto 1736.69 Ci si riferisce rispettivamente alle lettere datate Vienna, 19 novembre 1736, e Possonia (italianizzazione
del toponimo ungherese Pozsony, attuale Bratislava, che l’Ariosti indica spesso con il nome tedesco Pressburg), 23 novembre dello stesso anno.
70 Dovrebbe riferirsi alla città croata di Krajici.
065_092_UNUFFICIALE.indd 87 09/11/10 15:13
88
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
173771, di dove passò a Segna, per unirsi poi alla Grande Armata72. La nuo-va guerra austro-turca ripercorreva scenari già noti: nel novembre dello stesso anno si combatté ancora una volta a Essegg, dove il conte Platz ven-ne nominato generale, mentre all’Ariosti si prospettava la possibilità di una promozione a «Colonnello e comandante del reggimento». Le sorti avverse della battaglia spinsero l’esercito imperiale a sospettare un tradi-mento; per arginare le perdite il nostro fu inviato al Gran Varadino (attuale Oradea) e ad Arad73. In dicembre l’Ariosti prese la via di Edembourg74, sede dei quartieri d’inverno, distante solo otto leghe da Vienna; la ritirata strategica sottolineava il cattivo andamento della guerra:
circa le nostre cose di guerra vanno sempre di male in peggio haven-do i Turchi di nuovo tagliati a pezzi un battaglione e due squadroni in Vallacchia, e 3 battaglioni nel Banato di Temesvar essendosi adesso per-duta tutta affatto la detta Vallacchia e tutto il Banato di qua dal Danubio e sempre fanno aqquisti [sic] e ci è convenuto mandar a fondo due navi di guerra di 89 pezzi l’una75.
Scoperto il tradimento ordito da alcuni generali ai danni dell’Armata imperiale, venne riorganizzato l’esercito e si preparò una nuova offensiva contro il nemico turco, e questa volta anche la Polonia appoggiava la causa austriaca:
Io ho già l’ordine di tenermi pronto con il reggimento per marciar alla Grand’Armata, e credo per infallibile che in 15 giorni ci metteremo in movimento. L’Armata sarà forse di 140 mila homini e non si faranno distaccamenti, ma si agirà unitamente. La Polonia è entrata in Alleanza76.
Questa nuova offensiva, però, ebbe ben altro esito da quello annunciato dallo squillante incipit di una lettera del conte Ariosti: «Ottime nuove!». A partire dal due di giugno, infatti, l’armata marciava da Belgrado verso le montagne del Banato di Temesvár, per liberare dall’assedio la roccafor-te di «Orciova» (Orşova). L’esercito, giunto a «Caniza»77, fu inizialmente sorpreso dai Turchi, che il 4 luglio attaccano «con tal furore che gli riuscì
71 Lettera inviata il 4 febbraio 1737 (aSbo).72 aSbo, missiva scritta da Segna del 24 aprile 1737.73 aSbo, lettera inviata da Essegg il 15 novembre 1737.74 Nome dell’odierna Sopron, in tedesco Ödenburg.75 La lettera, scritta durante la marcia, risale al 2 dicembre del 1737 (aSbo).76 aSbo, lettera inviata da Eissenstadt il 23 marzo 1738.77 Kanjiža, attuale città della Serbia.
065_092_UNUFFICIALE.indd 88 09/11/10 15:13
89
GiuSeppe arioSti
penetrare nel centro del Armata [sic] nei bagagli, ma gli costò caro, perché tutti quei che vi penetrarono furono tagliati a pezzi». Il nemico li assalì poi sul fianco sinistro per più di quattro ore, e «due volte li repulsarono, ma alla fine arrivata la brigata dove io comandavo il mio Reggimento ci riuscì grazie a Dio di respingere l’inimico e di metterlo in rotta di tal modo che scappò abbandonando tutto il suo cannone tenda e bagagli. Questa azione mi ha fruttato il mio avanzamento a colonnello». L’azione dovette essere veramente importante, visto che fu il solo ad ottenere l’agognata promo-zione.
I Turchi in fuga da Orşova lasciarono in balia del nemico una grande quantità di armi, ma l’arrivo del Gran Visir con la sua Armata costrinse l’esercito asburgico ad abbandonare la città e a lasciare in mano turca parte del bottino. Il Gran Visir passò il Danubio insieme a quarantamila uomini scelti, che misero gli imperiali in seria difficoltà; a Mehadia vennero nuo-vamente attaccati con gravi perdite di uomini. Ciononostante l’esercito tedesco, mai domo, mosse un nuovo attacco, sostenuto anche dall’arrivo di rinforzi, cosa questa che propiziò una netta vittoria – anche se solo tem-poranea – e la conquista di un cospicuo bottino78.
La guerra però non volgeva ancora alla fine, anzi, dopo un iniziale ot-timismo per le «due gloriose vittorie di Cornia79 e di Mehadia», per paura che le forze non fossero sufficienti, l’armata asburgica si lanciò in «una riti-rata sfortunatissima, con la quale si die’ tanto animo al nemico che messosi di nuovo ad assediar Orşova ed a batterla con 96 pezzi alla fine il coman-dante perse coraggio, benché pochi giorni prima vi entrasse il soccorso con gran gloria si rese e con questa resa si perdé l’Antimurale del Banato di Temesvar». Il nuovo successo ridonava infatti coraggio all’esercito turco:
si fecero così arditi i Turchi che ci hanno seguitato fino a farci rin-chiuder in questa Piazza dove il 17 di settembre entrassimo con tutta l’infanteria e un hora doppo 10 mila turchi a cavallo vennero ad insul-tarci fin sotto le muraglie tagliando a pezzi tutti quei che trovò fuori di città, fino che attaccati dalla cavalleria furono scacciati. Semendria80 e Huypalanca81 si sono rese a patti. […] In Orciova abbiamo perduta tutta l’artiglieria e munizioni destinate per far l’assedio di Vidino che è senza prezzo. Per più grande disgrazia la peste si è attaccata nel Armata [sic]
78 Lettera scritta dal Campo di «Caranzeles» il 20 luglio 1738. Non è stato possibile identificare il luogo, ma forse potrebbe trattarsi una traslitterazione approssimativa di Caraş-Severin.
79 Cornea o Caraş-Severin, città dell’attuale Romania.80 Nome latino della città serba di Smederevo.81 Attualmente in Serbia, Bačka Palanka (in ungherese Palánka o Új-Palánka), fu una importante
fortezza militare dal 1702 al 1744.
065_092_UNUFFICIALE.indd 89 09/11/10 15:13
90
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
e crepano ogni giorno molte centinaria d’huomini del mio reggimento, solo son morti in pochi giorni più di 700 huomini.
Nonostante l’invio di «30 mila moscoviti di soccorzo ed altre truppe», il nemico continuava a minacciare i possedimenti imperiali; per di più l’avanzare dell’inverno rendeva difficoltosa ogni manovra, e per questo le operazioni subirono un arresto sino ai primi mesi dell’anno successivo82. Il 16 dicembre, poi, l’Ariosti da Leopoldstadt – nell’«Ungheria superiore» – si mise in marcia alla volta della Croazia, «havendo oltre il comando d’un battaglione la recruta di 170 huomini qui e 946 in Vienna». Per i servizi svolti, otteneva dall’imperatore una pensione di 400 zecchini l’anno83.
A questo punto i resoconti sull’andamento della guerra si interrompo-no, a causa dei dissidi tra Giuseppe e Corradino Ariosti, di cui si è già dato conto. La guerra si concluse per altro nel 1739, dopo che Olivier Wal-lis, presso il quale prestava servizio anche il nostro, ottenuto il comando supremo dell’armata, subì pesanti sconfitte a Grocka prima e successiva-mente a Pancsova (luglio 1739). Questo permise ai Turchi di porre l’asse-dio a Belgrado e di costringere l’esercito asburgico, ormai allo sfinimen-to, a firmare un armistizio che sanciva la perdita di quasi tutti i territori assegnati all’Austria con la pace di Passarowitz. Gli alleati russi, che nel conflitto coi Turchi avevano invece riportato importanti vittorie, videro la resa austriaca quasi come un tradimento.
appendiCeLa maggior parte delle missive superstiti del carteggio dell’Ariosti ri-
guardano la vita militare, le battaglie, in particolare la guerra contro i tur-chi del 1716-1718. A titolo di esempio si propone di seguito una lettera, un significativo resoconto di guerra, un reportage in tempo reale della batta-glia che incalza, quella contro i Turchi del 1716 (la lettera è infatti scritta dal Campo di Temesvár il 28 settembre 1716).
Con questo ordinario ricevo una sua che mi è di molta mia consola-zione, non lascierò per tanto di far il possibile per servirla di qualche ca-vallo di suo gusto e se sarà possibile nella presa di Temeswar, se Dio ce la concede, spero servirla di qualche stendardo. Delle novità della battaglia, non potevano [non] esser così sincere, per haverli io scritto dal campo di battaglia nel istesso momento che era seguita.
Adesso però dico che i cannoni presi sono 172. Mortari 21. Turchi restati
82 Questa e le precedenti citazioni sono desunte da una lettera scritta da Belgrado l’8 ottobre 1738.83 Lepoldstadt in Ungheria superiore, 16 dicembre 1738.
065_092_UNUFFICIALE.indd 90 09/11/10 15:13
91
GiuSeppe arioSti
sul campo 30.000, per quello che si è possuto sapere fin hora e tra li altri il Gran Wizir. Stendardi presi 350, mandati a Sua Maestà i più belli, 163. Code di Cavallo 4. Timpali84 13. La tenda del Gran Wizir con tutto il campo intiero, caffè, riso, e altre provisioni infinite, camelli, buffali, bovi, muli, castrati etc. senza numero; cavalli però né pure un solo. Monizioni da farci deci assedii.
Dei nostri sono restati nella prima azione del Palfi il general Conte Brayner prigioniero, trovato decollato nella tenda del Wizir. Il Colonnello di Palfi, 2 Maggiori, 6 Capitani, 9 Tenenti, 3 Cornetti e 400 huomini.
Nei 3 giorni d’attacco e di linea aperta fu ucciso il Conte Palfi, aiutante Generale, il Quartier Mastro Generale, e circa 400 persone in tutto.
Nella grand’azzione il General Conte Canyen, il General Conte Wellen-staix, il General Conte Gellen, Colonnelli 9, Tenenti Colonnelli 5, Maggiori 1, 40 Capitani, 98 Tenenti e 40 Alfieri, e 3584 huomini restati sul campo e feriti di condizione oltre molti altri offiziali furono il General Onduard, il General Bonewall, il Colonnello Franzan. Questo è quello che è infallibile della grave battaglia.
Nel nostro assedio qui già li ho mandato il diario di cancelleria di guer-ra; quello [che] posso aggiungerli è dal 23 settembre si avanzò una para-lella incominciata al bordo del fosso dove si cominciò a costruire 3 galle-rie. Restò un Capitano, 3 Tenenti e 150 huomini morti e feriti. Il General di battaglia Duca d’Arembergh restò ferito in faccia. Il Capitan ingegnere Hündert Walecken restò morto.
Il 24 si perfezziaro [sic] 2 gallerie con perdite di 3 offiziali e 95 tra morti e feriti. Il Conte Ilisciano, unico figlio del Generale di tal nome, volontario, restò morto colpito di fucile. 2 ingegneri mortalmente feriti, il Principe di Portogallo venne nelli approcci doppo la sua ferita per la prima volta.
Circa 30.000 spahi85 e tartari attaccarono il campo del Marescial Palfi, credendo sforzarlo, furono però respinti con loro grossa perdita, e tra li altri restavano 2 Bascià morti e uno prigione. Che però la Piazza fu delusa della speranza di soccorso. Restarono dei nostri 150 morti e alcuni feriti.
Il 25 si disposero le gallerie per dar la mattina del 26 l’assalto, ma i Turchi essendo avvisati da un disertore lasciavano l’escluse alla fossa, rovinando tutto il travaglio; di più venuti alcuni Turchi in una Picciola barchetta per il fosso, attaccata la prima galleria tagliarono a pezzi 10 huomini, e fecero 4 teste ritornandosene nella Piazza. In questa notte fu ucciso un Capitano, 1 Tenente, un Ingegniere, e 96 tra feriti e morti. E la mattina al lato di Sua Altezza fu ucciso il Capitan Maixner.
84 Timpani, tamburi.85 Truppe scelte della cavalleria ottomana; anche in matuSChka 1900a si parla di «spai e tartari» (p.
191).
065_092_UNUFFICIALE.indd 91 09/11/10 15:13
92
Simona Cappellari - CriStina Cappelletti
Il 26, il 27 si travagliò in perfezionare le nominate gallerie; la notte del 27 fu un allarme dentro la Piazza senza effetto.
Noi speriamo che dimani si darà l’assalto alla Palanca. Con la futura, se sarò vivo, darò più novità, di conseguenza quello però posso dire: è grandissima l’influenza delle infermità che corrono, particolarmente dis-senterie; muorendo in gran quantità le genti.
In questo momento li barbari ci hanno bruciati tutti i nostri ponti e gal-lerie, con che non vi è più speranza di dar l’assalto che in 4 giorni. Fin hora si fa ascender la nostra perdita a 3000 huomini e non si è anche aggiustato niente, e di Italia mi scrivono che Temeswar non è cosa di considerazio-ne; vorrei che quei tali venissero qua a provare, e veder che negozio è. Le accludo qui un abozo dei nostri travagli e attacchi accertandola che il nu-mero 10, 11 e 17, per essersi perfezionato in questi 2 giorni, l’ho tirato per la fretta io stesso, e si intende al bordo del fosso le batterie sono già notate. Tutto il parapetto del inimico è uguale in grandezza, e la Palanca circonda la Città tutta all’intorno. Per la fretta, montando un giorno sì e un giorno no la trinciera, non posso scriverli meglio e con più distinzione: montiamo la trinciera quotidianamente.
ABSTRACT
The very frequent correspondence of the army officer Giuseppe Ariosti with his relative Alberto Corradino, a Senator from Bologna, helps us to reconstruct part of Ariosti’s biogra-phy. He was born at the end of the 17th century and fought with the Austrian army under Charles vi; he took part to the war against the Turks between 1716-1718, the Polish civil war (1733-1735) and a further conflict between 1736-1739.He spent all his life in the Austrian army and obtained the title of “Generale di Battaglia”. His letters offer a picture of his family life, in particular the problems with his bother Lorenzo, who dissipated their patrimony. These problems were solved thanks to the help of Corradino, who favoured the marriage of Lorenzo with Francesca, Baroness of Mordax and Pontendorf, who bore him a son and two daughters. Corradino had sent his daughter to Austria to be educated under the supervision of Ariosti and his wife; however, when the family had to leave for Transylvania, Costanza was quickly sent home. As a consequence, the last years of Ariosti’s career are less documented, since the correspondence with his relative Corradino became less frequent. Ariosti died in Mariahilfestrasse in Vienna. In his epistolary writings he underlined his interests for war chests, such as banners, flags and horses, which he also sent to Corradino as a gift. During his stay in Transyilvania he transcribed the Roman inscriptions which were discovered during the construction of the town fortifications and he sent them to Scipione Maffei. This same interest is shown by the realization of a codex of inscriptions which he prepared in Turin. Maffei finally came into possession of this manuscript which is now preserved at the Capitolare Library in Verona.
065_092_UNUFFICIALE.indd 92 09/11/10 15:13