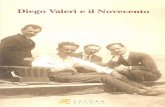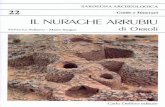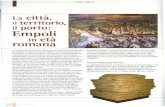15.La «Merope» in prosa, in Il letterato e la città. Cultura e istituzioni nell’esperienza di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 15.La «Merope» in prosa, in Il letterato e la città. Cultura e istituzioni nell’esperienza di...
Fu in fatti origine di una importante rivoluzione nel
teatro quello scrittore, che non volendosi adattare
agli usi correnti levossi di terra con tanto nerbo che
s’ebbe a meritare l’ammirazione del suo secolo e del-
la posterità1.
Antonio Piazza , giornalista, romanziere, ma anche drammaturgo, ri-volgeva nel romanzo Il teatro, datato al 1794, il suo omaggio all’«immor-tale» marchese Maffei e alla sua Merope, ancora rappresentata sul fi nire del xviii secolo. L’omaggio era, però, accompagnato da un rimprovero polemico alle compagnie di comici che malamente tentavano di mettere in scena azioni tragiche. Questo il testo del Piazza :
Fummo a Verona. […] Rappresentavasi la Merope dell’immortale Maffei.
Quello che faceva da Egisto era un ragazzo di quaranta anni in circa e la
donna, che la parte facea di sua madre, non arrivava ai venticinque nem-
meno. Come ponno piacere le teatrali rappresentazioni, quando i comme-
dianti medesimi, il più delle volte per i loro particolari puntigli, distrug-
gono la illusione del popolo con queste mostruose disuggualianze? Oltre
il dispiacere che diedemi quella inconvenienza, trovai che un’azione seria
eccitare non può meraviglia e diletto quando le manchi il favore della notte
e de’ lumi. Invece d’essere ad ascoltare una tragedia, mi pareva di vedere
tanti ciarlatani sul palco che vendessero il loro balsamo2.
1 Così si riferiva a Maffei Antonio Beduschi nel suo Sullo stato attuale della tragedia in Italia. Discorso, Parma, Bodoni, 1827, p. 20.
2 Antonio Piazza , L’attrice, a cura di Roberta Turchi , Napoli, Guida, 1984, pp. 37-38. Il romanzo venne pubblicato a Venezia, senza indicazione dell’autore, presso Giammaria Bassaglia (1754), come Il teatro, ovvero fatti di una veneziana che lo fanno
Cristina Cappelletti
La Merope in prosa
Cristina Cappelletti184
Numerosi, oltre a quello segnalato ora, sono gli episodi che attesta-no la fortuna letteraria della tragedia maffeiana, i più clamorosi e noti dei quali sono ovviamente legati alle riprese polemiche di Voltaire e Alfi eri 3. Tra la letteratura di consumo, quantomeno curiosi appaiono due esperimenti di stesura in prosa della Merope (entrambi settecen-teschi), interessanti non tanto per il loro valore letterario intrinseco, quanto piuttosto per il fatto di essere documenti e della fortuna del testo maffeiano e di innovazioni formali, volte a svecchiare e a rendere più fruibile il genere tragico. Mi riferisco per la precisione all’edizione apparsa anonima presso lo stampatore Longhi di Bologna nel 1723, e alla successiva, edita dalla Stamperia Reale di Napoli nel 1774, Merope, Tragedia del Maffei, per Sovrano comando ridotta in prosa e rappresentata nel Reale Teatro di Caserta4.
È quanto mai singolare rilevare come in un secolo, quale è il Settecento, caratterizzato da dispute teoriche tese a stabilire quale me-tro meglio si confaccesse al genere tragico, si trovino attestazioni di tragedie in prosa. Sull’argomento – va detto subito – non esistono studi specifi ci, forse perché il genere tragico, già per sua defi nizione alto, vie-ne di norma associato al verso, almeno sino al Novecento. Se moderna-mente la defi nizione condivisa di tragedia è quella di «opera dramma-
conoscere; la curatrice della più recente edizione, Roberta Turchi , ha preferito am-modernare il titolo in L’attrice. Relativamente ad Antonio Piazza si veda almeno il contributo monografi co di Aldo Maria Morace , Il prisma dell’apparenza. La narra-tiva di Antonio Piazza, Napoli, Liguori, 2002.
3 Sulla querelle che coinvolse Maffei, Voltaire e Alfi eri i contributi critici sono numerosi; si vedano almeno Mario Del Corso , Tra Verona, Parigi e Venezia, in Sci-pione Maffei nell’Europa del Settecento, Atti del Convegno, Verona 23-25 settembre 1996, a cura di Gian Paolo Romagnani , Verona, Cierre, 1998, pp. 527-549; Franco Longoni , «Ecco il tiranno». Quale edizione della Merope maffeiana lesse l’Alfi eri , «Studi settecenteschi», 21, 2001, pp. 111-140; Gian Paolo Marchi , Voltaire , Lessing e Alfi eri di fronte alla «Merope» di Scipione Maffei, in XXIII Simposio Internazionale di Studi Italo-Tedeschi: «Vittorio Alfi eri . Il Poeta del mito», Merano, Accademia di Studi Italo-Tede-schi, 2002, pp. 141-168; e inoltre, anche se l’interesse principale è alfi eriano, Simona Costa , Merope, «La Rassegna della Letteratura italiana», 2, 2003, pp. 564-582.
4 Le due riscritture erano già state segnalate rispettivamente da Laura Sannia Nowé nella sua Introduzione premessa a De’ teatri antichi e moderni e altri scritti tea-trali di Scipione Maffei (Modena, Mucchi, 1988, p. lvi), e da Gian Paolo Marchi in occasione del convegno Il verso tragico dal Cinquecento e il Settecento, Verona, 14-15 maggio 2003; la relazione tenuta in quella occasione, La Merope del Maffei, non è però confl uita nel volume di atti pubblicati a cura di Gilberto Lonardi e Stefano Verdino (Padova, Esedra, 2005).
La Merope in prosa 185
tica, destinata alla rappresentazione scenica, in stile e tono elevato»5, dove la vox media «opera» giustifi ca l’esistenza di componimenti tanto in prosa quanto in verso, così non è, ancora per tutto l’Ottocento, come facilmente si desume da uno spoglio lessicale fatto sui principali dizio-nari: il testo tragico viene difatti descritto quale «poema drammatico» o «poema rappresentativo», venendo quindi insita, nella defi nizione stessa, l’idea della composizione in versi6.
È innegabile che una tradizione tragica in prosa – se pur marginale, o forse, sarebbe meglio dire, priva di esiti incisivi – esistesse già a par-tire dalla metà del xvi secolo; e anche lo stesso Maffei dimostrava di averne conoscenza, citando – nel suo trattato De’ teatri antichi e moderni – il Cianippo di Agostino Michele , edito a Bergamo, per Comin Ventura, nel 1596, che nel sottotitolo specifi cava, con un certo vanto, Et è la prima fra tutte l’altre fi no ad hora publicate dalle stampe, che sia scritta in prosa7.
Un rapido accenno all’uso della prosa nei componimenti tragici si
5 Desumo questa defi nizione dal Grande dizionario della lingua italiana di Salva-tore Battaglia , Torino, Utet, 1961-2004, ad vocem.
6 Sono stati consultati numerosi, e di norma autorevoli, vocabolari: le principali edizioni compilate dagli Accademici della Crusca (Venezia, Alberti, 1612 e successi-ve); il Dizionario della Lingua Italiana di Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini , To-rino, Pomba, 1861-1864; il Novo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Firenze ordinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, compilato sotto la presidenza di Emilio Broglio dai Sign. Bianciardi Stanislao et alii, Firenze, Cellini, 1870-1890; si è te-nuto conto inoltre del Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana dell’abate d’Alberti di Villanuova , Lucca, Marescandoli, 1797-1805; del Vocabolario della lingua italiana, compilato da Pietro Fanfani , Firenze, Le Monnier, 1855; e del Novo dizionario scolastico della lingua italiana dell’uso e del fuori uso, con la pronunzia, le fl essioni dei nomi, compilato da Policarpo Petrocchi , Milano, Treves, 1897.
7 Maffei, De’ teatri antichi e moderni..., p. 24. Esigue sono le informazioni su Agostino Michele . Giovanni degli Agostini ricorda che il Michele , nobile venezia-no, dottore in Filosofi a, spiegava presso l’ateneo patavino Diritto ecclesiastico (cfr. Giovanni degli Agostini , Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli Scrit-tori Viniziani, Venezia, Occhi, 1752, t. i, pp. ix-x; t. ii, pp. 52 e 58-59). Tra i pochi che se ne sono occupati in tempi più recenti (mai però in relazione alla biografi a), oltre ai teorici di storia del teatro, si possono citare Umberto Cosmo , Con Dante attraver-so il Seicento, Bari, Laterza, 1973, p. 12; Pasquale Ventrice , La questione della gran-dezza della terra ecc., in Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale di studio Giovan Battista Benedetti e il suo tempo, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1987, pp. 423-450, in cui viene ricostruita la disputa tra il Michele e Giovan Battista Benedetti in relazione alla grandezza del globo terrestre (pp. 439-443); Ettore Bonora , Retorica e invenzione. Studi sulla letteratura italiana del Rinascimento, Milano, Rizzoli, 1970, p. 173.
Cristina Cappelletti186
legge nel Quadrio , secondo il quale «[V]i sono anche i capricciosi [scil. uomini], e strani; così fi n nel Secolo xvi cadde ad alcuni bizzarri poeti in pensiero di scrivere le loro Tragedie in Prosa più tosto, che in Verso, su questa ragione fondati, che inverisimile sia, che gli Uomini parlino in Versi»8. Lo studioso settecentesco cita, poi, un cospicuo numero di titoli, senza tralasciare, però, un giudizio negativo sull’esperimento, e scrivendo: «Come che siano lodevoli per altri capi, per quello però, che al prosastico parlato s’aspetta, col quale sono stese, non si possono in verun modo approvare. La esperienza conferma questo mio detto: poi-ché tali opere composte in prosa meno assai piacciono ai leggitori, che quelle composte in verso»9. Più recentemente Nicola Mangini liquida con ancora maggiore sinteticità il problema: «A parte vanno ricordate la Tamar del vicentino G.B. De Velo e il Cianippo di Agostino Michele , tragedie scritte polemicamente in prosa (in versi solo il coro), che era un’innovazione che, pur destinata all’insuccesso, rappresentava un’ul-teriore testimonianza dell’insofferenza e dell’inquietudine che serpeg-giava negli ambienti letterari in quegli anni di crisi»10. Vista l’impor-tanza dell’argomento ai nostri fi ni, non sembra inopportuno dedicarvi una breve digressione.
Tra i primi a osteggiare la possibilità di comporre in prosa le proprie tragedie fu Giambattista Giraldi Cinzio 11, che nella Lettera sulla tragedia (1543) ribatteva le accuse mosse alla sua Didone, tra le quali fi gurava anche quella della stesura in versi: «Venendo alle opposizioni fattemi, la prima è che sarebbe meglio ch’io avessi composta questa tragedia in prosa che in verso»12. Il tragediografo difendeva le proprie scelte poe-tiche appellandosi all’auctoritas aristotelica e agli exempla di recenti, ma già celebri, testi drammatici:
8 Francesco Saverio Quadrio , Della storia e ragione d’ogni poesia, Milano, Agnel-li, 1753, vol. iii, p. 110.
9 Ibi, p. 118.10 Cfr. Nicola Mangini , La tragedia e la commedia, in Storia della cultura veneta,
diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi , Vicenza, Neri Pozza, vol. 4/i, Il Seicento, 1983, pp. 297-326 (la citazione si trova a p. 305).
11 Per una sintesi relativa alle questioni teoriche e alla prassi drammaturgica del Giraldi Cinzio si rinvia al recente saggio di Laura Riccò , Il teatro ‘secondo le correnti occasioni’, «Studi italiani», 2, 2005, pp. 5-39.
12 Giambattista Giraldi Cinzio , Lettera sulla tragedia, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di Bernard Weinberg , Roma-Bari, Laterza, 1970-1974, vol. i, pp. 468-486, a p. 471.
La Merope in prosa 187
io non so come questo gran censore voglia che si compongan le tragedie
in prosa, veggendo che non solamente Aristotele nella sua Poetica le vuol
composte in verso, e mostra quali debbano essere i versi loro, ma che il me-
desimo si legge in Orazio ; e si vede oltre a ciò che i tragici tutti ci hanno da-
te le lor tragedie in versi. […] Come parve anche al Signor Trissino ch’ella
punto non convenisse alla tragedia, onde compose la sua Sofonisba in quella
maniera di versi ch’egli, prima di ognuno, diede convenevolissimamente
alla scena, in luogo del iambo ch’usano i Greci et i Latini nelle scene. […]
Alla opinione di questo eccellente tragico si accostò il Ruscelli nella sua Ro-smonda, che uscì con molta loda e poco dopo la Sofonisba. E credo che anche
nell’avenire vi si accosteranno tutti coloro che a tali composizioni si daran-
no e ne cercheranno onore. E questo potrà anche bastare per rispondere a
quell’altro che, per favorire la costui opinione, disse che la nostra lingua
non have versi che alla scena si convenissero, e che perciò noi devevamo
comporre queste favole in prosa.13
Il richiamo alle ‘norme’, perché in effetti tali erano considerate, ari-stoteliche è una costante dei sostenitori della tragedia ‘regolare’; va però osservato che il testo della Poetica letto e commentato nel Cinquecento non era fi lologicamente ineccepibile – come avranno modo di consta-tare anche alcuni commentatori successivi, tra i quali Paolo Beni – e ciò dava adito a fraintendimenti interpretativi. Tra i passi più discussi e sottoposti a critiche, si può certamente citare il 1450b (la numerazione è naturalmente quella moderna), secondo cui
Tevtarton de; tw'n ejn lovgw/ hJ levxi": levgw dev, w{sper provteron ei[rhtai, levxin ei\nai th;n dia; th`" ojnomasiva" eJrmhneivan, o} ˚ai; ejpi; tw'n ejmmevtrwn kai; ejpi; tw'n lovgwn e[cei th;n aujth;n duvnamin14.
Dove «ejpi; tw'n ejmmevtrwn» e «ejpi; tw'n lovgwn» esautorerebbero sia i so-stenitori del verso tragico, sia gli innovatori e sperimentatori della prosa, a vantaggio della sola «duvnamin», cioè dell’effi cacia del dettato tragico, indipendentemente dalla forma cui esso è legato. Nell’arco di pochi anni
13 Ibi, pp. 472-474.14 Per il testo greco si è fatto riferimento all’edizione critica di John Hardy , Paris,
Belles Lettres, 1961; Guido Paduano , curatore dell’edizione laterziana del 1998, tra-duce così il passo: «Al quarto viene la dizione […]: intendo, come ho detto prima, l’espressione che si realizza attraverso le parole, e ha la stessa effi cacia naturalmen-te in versi o in prosa».
Cristina Cappelletti188
si passò dalla teoria alla prassi, e nel 1546 il bassanese Francesco Negri pubblicò la tragedia Il libero arbitrio, stesa interamente in prosa15. È però da notare che questo testo di tragedia ha il solo nome, perché in realtà si tratta di una satira, in cui l’autore sbeffeggia le invenzioni teologiche del papato, e allo stesso tempo critica i metodi con i quali l’Inquisizione riesce a estorcere confessioni. Lo stesso Negri rivela poi, nella prefazione alla tragedia, che la scelta del genere è dettata dalla volontà di dare larga diffusione alle idee religiose di cui si fa propugnatore16.
Alcuni degli studiosi che si sono occupati del teatro cinquecentesco individuano quale primo esempio di tragedia in prosa – in virtù delle anomalie del Libero arbitrio – il testo del vicentino Giambattista De Velo , Tamar17. Leggendo l’azione tragica, però, si nota come almeno i cori, che
15 Francesco Buonamonte detto il Negri (Bassano 1500 - Pinczòw [Polonia] 1563); entrato a far parte dell’ordine benedettino, ma ben presto aderì alle idee luterane, e si trasferì in Germania e a Strasburgo; passò poi in Polonia, dove si de-dicò all’attività di insegnante presso l’esigua comunità italiana. Cfr. Giambattista Roberti , Notizie storico-critiche della vita e delle opere di Francesco Negri apostata bassa-nese del secolo XVI, con una dissertazione intorno alla di lui tragedia del Libero arbitrio, Bassano, Baseggio, 1839. Pubblicata per la prima volta nel 1546 (Basileae, Johann Oporinus), la Tragedia intitolata Libero arbitrio venne nuovamente edita l’anno suc-cessivo (probabilmente Venezia, Brucioli), e infi ne ampliata dall’autore nel 1550. Il testo conobbe un successo insperato sia in Italia che all’estero, grazie alle versioni in francese, latino e inglese; nel 1548 la congregazione dell’Indice inserì l’opera del Negri tra i libri proibiti. Cfr. Francesco Millocca , La tragedia Libero arbitrio di Francesco Negri Bassanese (sec. XVI), «Esperienze letterarie», xvi, 1, 1991, pp. 51-64; Massimo Sturiale , La traduzione inglese del Libero arbitrio di Francesco Negri, «Ae-vum», lxxi, 3, 1997, pp. 731-740.
16 Della tragedia Libero Arbitrio..., Christiano lectore salute, pagine non numerate [A1-2]: «Questa medesima cagione, et non alcun’altra, carissimo lettore, mosse an-chor me da principio a scrivere di simil cose sotto nome di Tragedia: persuadendo-mi che forse per tal via alquanto dilettevole, se ben di non di molta arte poetica, ne di molto bel parlare ornata, più facilmente gli uomini potrebbono leggendola ave-dersi de gli errori già molti anni introdotti dalla Chiesa di Christo, de quali in quel la se ne fa longa mentione: et conosciuti essi errori con la gratia di Dio veder poi et abbracciare la sola verità della sinciera religione Christiana a gloria del signor Dio, a laude di Gesù Christo, et a salute loro». Cito il testo presente, e i successivi, senza portare ammodernamenti all’originale.
17 Oltre a Ferdinando Neri , La tragedia italiana del Cinquecento, Torino, Bottega d’Erasmo, 1961 (ristampa anastatica dell’edizione Firenze, Galletti e Cocci, 1904), pp. 130-132, cfr. anche [Joseph Cooper Walzer ], Historical Memoir on Italian Trag-edy from the earliest Period to the present Time, illustrated with Specimens and Analyses of the most celebrated Tragedies, London, E. Harding, 1799, p. 93: «another species of tragedy, (if I may so term it) was invented in this age; I mean the prose tragedy,
La Merope in prosa 189
dall’introduzione sappiamo essere stati accompagnati da musiche di Leone Leoni , maestro di cappella nel Duomo di Vicenza, fossero com-posti in verso. In una postfazione A’ lettori, inoltre, viene spiegato come il De Velo non intendeva dare alle stampe la propria opera, e per questo motivo la stesura in prosa si giustifi cava non nei termini della scelta stilistica, ma della necessità:
Né alcun prenda ammiratione s’egli non l’ha composta in verso, perché per
due cause principali l’ha fatto; l’una è, che ei l’ha tessuta in poche hore, et
astretto da gli amici, l’altra è, per comodità dei recitanti; perché non tutti
conoscono il verso: poscia ch’egli sa bene (che in vero è persona assai litte-
rata) che le cose Tragiche devonsi scriver in verso; et perciò abbiamo voluto
avvertirvi, acciò non pigliaste qualche errore, et sinistra opinione di lui. Et
se fra tanto conosceremo che essa vi sia stata fatta, per l’avenire procurere-
mo di farvi vedere altri frutti che vansi di giorno in giorno maturando nel
giardino del suo ingegno18.
Di particolare interesse mi pare il problema della preparazione degli attori, che sarà – sino a tutto il Settecento – non secondario, e condizio-nerà sia, a monte, le scelte formali che gli esiti di numerose tragedie. Taluni autori drammatici, per cominciare, proponevano direttamente l’adozione di un verso che tendesse alla prosa, non solo per il principio della verosimiglianza, quanto, soprattutto, per facilitare il compito de-gli attori e favorire così il buon esito della rappresentazione scenica.
Sul fi nire del xvi secolo si moltiplicarono le trattazioni teoriche in-torno al genere tragico, proponendo – accanto ai commenti del testo aristotelico – elaborazioni originali di nuove poetiche. Di particolare interesse sono i Discorsi intorno alla Tragedia dell’accademico olimpico Nicolò Rossi (1590)19, in cui ampio spazio è dedicato alla trattazione dei
or drame. According to Baretti , the fi rst Italian tragedy in prose, was the Tamar of Giambattista de Velo , which appeared in Vicenza, 1586. Riccoboni , who never saw this tragedy, erroneously observes, that the Cianippo of Agostino Michele , which was printed in Bergamo in 1596, was the fi rst and only prose tragedy of this age».
18 A’ Lettori, post fazione alla Tamar. Attione tragica di Giovanni Battista De Velo . Rappresentata nella città di Vicenza dalla Compagnia Nova l’anno MDLXXXVI, in Vicenza, appresso Agostino della Noce, 1586, pagine non numerate.
19 Nicolò Rossi (Vicenza, sec. xvi), studioso di letteratura italiana, latina e greca, si interessò soprattutto di questioni legate ai generi teatrali. Oltre al Discorso intor-no alla Tragedia, compose anche una Lettera sulla Commedia (premessa a La schiava. Comedia di Giovanni Battista Calderari , Verona, Discepolo, 1589) e dei Discorsi
Cristina Cappelletti190
metri tragici in uso presso gli antichi e i moderni. Nonostante i primi esempi di tragedie in prosa, il Rossi , ancorché vicentino, come l’autore della Tamar, non prendeva nemmeno in considerazione l’ipotesi che si potessero comporre testi tragici non in verso20. Nei medesimi anni Francesco Patrizi da Cherso 21 componeva la propria Poetica, in cui po-lemizzava con quanti sostenevano la possibilità di comporre poesia in prosa, interpretando in maniera critica il testo aristotelico. Egli scrive-va: «A’ dì nostri uomini di non picciolo sapere si sono scoverti, i quali hanno tanta di arditezza avuto, ch’hanno detto e scritto che il verso non sia essenziale, ma accidentale della poesia, fabricando eglino que-sta dottrina così nuova sopra quattro luoghi di Aristotile , come oracoli ricevuti»22. Il riferimento alla tragedia non è diretto; ma possiamo de-sumere da alcune Deche del Patrizi , rimaste manoscritte sino al secolo scorso, la volontà dell’autore di cimentarsi nello stile tragico (cosa che poi non fece)23. Appurate le posizioni difese nell’opera maggiore, non è diffi cile credere che il letterato greco-veneto si sarebbe decisamente schierato a sfavore dell’uso di stendere in prosa i drammi.
È di soli due anni successivi il Discorso di Agostino Michele in cui contra l’oppinione di tutti i più illustri Scrittori dell’Arte Poetica si dimostra come si possono scrivere con molta lode le Commedie e le Tragedie in prosa24. L’autore, secondo si evince programmaticamente già dal titolo, cerca di detrarre valore normativo alla prassi di comporre testi drammaturgici in verso, poiché – sostiene – esistono esempi di prosa letteraria alto-mimetica degni di divenire modelli per la composizione di commedie e tragedie. Il motivo principale di tale scelta si può ravvisare nel modus
sopra la Commedia. Fu inoltre autore di numerosi madrigali. Cfr. Gianfranco Cru-pi , s.v. Rossi, Nicolò, in Letteratura italiana. Gli autori, diretta da Alberto Asor Rosa , Torino, Einaudi, 1991, vol. ii, pp. 1538-1539.
20 Cfr. Nicolò Rossi , Discorsi intorno alla tragedia, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento..., vol. iv, pp. 59-120, a p. 167.
21 Numerosi sono gli studi relativi al Patrizi e alla sua opera fi losofi co-letteraria; si vedano almeno Lina Bolzoni , La ‘Poetica’ del Patrizi e la cultura veneta del primo Cinquecento, in L’Umanesimo in Istria, a cura di Vittore Branca - Sante Graciotti , Fi-renze, Olschki, 1983, pp. 19-36; Cesare Vasoli , Francesco Patrizi da Cherso, Roma, Bulzoni, 1989; Micaela Rinaldi , Torquato Tasso e Francesco Patrizi: tra polemiche let-terarie e incontri intellettuali, Ravenna, Longo, 2001.
22 Francesco Patrizi da Cherso , Della poetica, edizione critica a cura di Danilo Aguzzi Barbagli , Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1969-71, 3 voll., ii, l. v, p. 91.
23 Ibi, i, pp. xiii-xiv.24 Edito in Venezia, presso Giovanni Battista Ciotti, nel 1592.
La Merope in prosa 191
rappresentativo delle tragedie «in verso toscano», che non vengono più accompagnate da musica, come accadeva per i drammi antichi, ma sono soggette alla sola declamazione dell’attore, che deve suggerire all’ascoltatore l’idea della comunicazione referenziale: per tanto appare più semplice comporre questi testi direttamente in prosa, piuttosto che in versi che cerchino di imitarla. Più volte il Michele (o Michiel, come pure si trova in alcune edizioni) fa riferimento a un suo contempora-neo, estensore egli pure, pochi anni addietro, di trattazioni teoriche re-lative alle commedie e alle tragedie. Leggiamo: «Giason Denores 25 con molti altri maestri dell’arte Poetica facendoci palese il modo di rappre-sentarle dicono; che bisogna, che colui, che recita i versi loro, li vada l’un con l’altro in maniera congiugnendo, che paiano Prosa»26. La com-plessa frase non è però desunta dalla Poetica dell’autore convocato, da un’opera, preciso, in cui tutta la Parte prima è naturalmente dedicata alle composizioni tragiche, per le quali viene vivamente suggerito l’uso dell’endecasillabo27. Il testo di cui il Michele si serve per avvalorare la propria idea sulla stesura in prosa delle tragedie è invece un’altro, il Discorso intorno a que’ principii, cause et accrescimenti che la comedia, la tragedia et il poema eroico ricevono dalla fi losofi a morale e civile e da’ governa-tori delle repubbliche (1586), in cui a più riprese il Denores fa riferimento alla necessità di ricorrere a versi che nella declamazione ricordino un discorso in prosa, a benefi cio del principio di verosimiglianza, visto che – come affermano i sostenitori della tragedia in prosa – gli uomini nella realtà si avvalgono, nel parlare, della prosa. Ascoltiamo il passo:
La tragedia potrà ancor essa commodamente essere tessuta con versi en-
decasillabi, per aver in questa lingua tutti que’ privileggi che ha già avuti
25 Giason Denores (Nicosia c.a 1530 - Padova 1590) si formò a Padova, dove ebbe come maestro Sperone Speroni . Le notizie sulla biografi a del Denores si de-sumono dalla voce di Giorgio Patrizi , in DBI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. xxxviii, 1990, pp. 768-773. Sul Denores e la sua poetica si vedano al-meno i paragrafi a lui dedicati nel volume Storia delle poetiche occidentali, a cura di Jean Bessière , Eva Kushner , Roland Mortier , Jean Weisgeber , Roma, Meltemi, 2001, pp. 153-155.
26 Discorso di Agostino Michele ..., p. 9r.27 Poetica di Iason Denores nella quale per via di defi nitione et divisione si tratta
secondo l’opinione d’Aristotile della Tragedia, del Poema Heroico et della Commedia, Pa-dova, Meietti, 1588, p. 7r: «con parole altiere, et gravi, et con versi sciolti; ò endeca-sillabi; ò per il più di sette, et di cinque sillabi; ò con ambidue mescolatamente, et ne’ chori con canzoni, et con madrigali».
Cristina Cappelletti192
nella lingua greca; ma in questi endecasillabi tragici doveranno i concetti
terminar, non nel fi n del verso, il che deve essere proprio del poema eroico,
ma nel mezzo; onde averà di più questa altra maraviglia, che sarà fatta in
versi sonori e, nondimeno, pareranno simili alla prosa, per il che conseguirà
ella et il verso sonoro, conveniente alla grandezza delle sue illustri persone,
e questa apparenza di prosa, conveniente al suo modo di proceder non per
via di narrazione ma per via di rappresentazione28.
Agostino Michele giustifi ca inoltre la sua scelta della prosa anche at-traverso la constatazione che molte tragicommedie, tenute ai suoi tempi in una qualche considerazione, non erano state composte in verso, senza per questo compromettere l’esito felice della rappresentazione. Tanto era infatti accaduto per la Quintilia di Dionisio Guazzoni 29 e La conversione del peccatore di Giovanni Battista Leoni 30, citate quali exempla anche nel Verato di Guarini . Egli indica in aggiunta la Tamar, «intitolata attione tragica dal signor Giovanni Battista De Velo , e io credo ch’egli non habbia voluto nomarla Tragedia per fuggir questa contesa, se bene egli non ne fugge il modo»31. Parte del discorso teorico è, dunque, volto a giustifi care quanto il Michiel fa nella prassi, componendo il suo Cianippo, prima tragedia – come abbiamo già ricordato – ad essere stata scritta in prosa.
Il soggetto di questo ircocervo, sia concessa un po’ di ironia, viene tratto – per dichiarazione dello stesso Michele – dalla storia di Suida e da Plutarco : Cianippo, sacerdote di Bacco a Siracusa, avendo offeso il dio, durante una cerimonia cade in uno stato di ubriachezza tale da violen-
28 Cfr. Giason Denores , Discorso intorno a que’ principii, cause et accrescimenti che la comedia, la tragedia et il poema eroico ricevono dalla fi losofi a morale e civile e da’ governatori delle republiche, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento..., vol. iii, pp. 373-419, a pp. 408-410; i corsivi sono miei.
29 Si tratta in realtà di Diomisso (e non Dionisio) Guazzoni , poeta e drammatur-go cremonese, vissuto tra il xvi e il xvii secolo. Fu autore di due tragicommedie, la Quintilia, appunto, e l’Andromeda, d’ambientazione boschereccia. Cfr. Dizionario degli scrittori d’Italia dalle origini fi no ai viventi, a cura di Giovanni Casati , Milano, Ghirlanda, 1924, vol. iii, p. 246.
30 Giovanni Battista Leoni (1542-1613), probabilmente di origini padovane, svolse la propria attività di poligrafo e storico prevalentemente a Venezia nella seconda metà del sec. xvi, dove fu uno dei fondatori, nel 1593, della ‘seconda’ Ac-cademia veneziana. Con lo pseudonimo di Lauro Settizonio fi rmò drammi e favole morali, tra cui la Roselmina (Venezia, Ciotti, 1595) e La falsa riputazione della fortuna (ibid. 1597). Cfr. Paola Rocchi , s.v. Leoni, Giovanni Battista, in Letteratura italiana. Gli autori…, vol. ii, p. 1048.
31 Discorso di Agostino Michele ..., pp. 2v-3r.
La Merope in prosa 193
tare, senza avvedersene, la propria fi glia Ciàne. L’intera Sicilia, allora, analogamente a quanto già accaduto alla Tebe di Edipo, viene affl itta da una terribile pestilenza, provocata dal dio, indignato per il terribile incesto. Interrogato (la fi ligrana sofoclea è costante), l’Oracolo risponde che solo il sacrifi cio del responsabile della violenza avrebbe potuto de-bellare il castigo divino. Attraverso un anello, sottratto da Ciane al suo aggressore, si scopre che il colpevole è Cianippo: la fi glia stessa lo sacri-fi ca, allora, agli dèi, per porre fi ne alla calamità, e, subito dopo, immola sull’ara anche se stessa, trafi ggendosi col medesimo ferro.
L’alba del nuovo secolo non vede attenuarsi le dispute. Nel 1601, in-fatti, Paolo Beni dà alle stampe la sua Disputatio in qua ostenditur praestare Comoediam atque Tragoediam metrorum vinculis soluere, nella quale sottoli-nea come Aristotele sia vago e poco coerente in ordine al problema del verso e della prosa32. La scelta della prosa, avallata dal Beni , viene, inol-tre, giustifi cata – come già avveniva per il Michele – in obbedienza a un principio di mimesi: se la poesia è imitazione del reale, nella realtà anche personaggi nobili e illustri parlano in «oratio soluta» e non in verso. L’uso della metrica, osserva il Beni , si adatta al genere della lirica, ma non al dramma, il cui valore non si può misurare in base alla sola composizione in verso, ma anche, e soprattutto, per la felicità relativa alla scelta del plot dell’azione tragica. La preferenza accordata alla prosa è ulteriormente autorizzata dalla considerazione che la poesia deve prefi ggersi il fi ne di impartire lezioni morali e civili agli spettatori, e per questo è necessario che la tragedia rispetti il più possibile i criteri di verosimiglianza, e possa essere facilmente fruibile dagli spettatori33.
Paolo Beni , noto soprattutto per essere stato uno tra i più importanti commentatori della Poetica di Aristotele , tornerà sull’argomento proprio traducendo e splanando il già citato passo 1450b del testo aristotelico:
Nam si metrum seu carmen esset ex Aristotele cuicunque poemati neces-
sarium, temere rursus et otiose nos admonuisset Tragoediam metris esse
peragendam. Quis enim de hoc dubitare potuisset, aut cur fuisset cur id in
32 La più recente monografi a sul professore padovano è opera di Paul B. Dif-fley , Paolo Beni: A Biographical and Critical Study, Oxford, Clarendon Press, 1988. Il capitolo relativo alla Disputatio si trova alle pp. 65-69.
33 Paolo Beni , Disputatio in qua ostenditur praestare Comoediam atqueTragoediam metrorum vinculis soluere; nec posse satis, nisi soluta oratione, aut illarum decorum ac di-gnitatem retineri; aut honestam inde voluptatem solidamque utilitatem percipi, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento..., vol. iv, pp. 345-395, a p. 435.
Cristina Cappelletti194
defi nitione Tragoediae tam diligenter nos admoneret, si de poemate quo-
cumque iam antea fuerat constitutum? Itaque cum de hoc in Tragoediae
defi nitione et explicatione nos admoneat Aristoteles, iustius est affi rmare
id fecisse quia cum iam antea quandam etiam poematis formam metro et
carmine exemisset, par erat hic nos admonere Tragoediam metro esse con-
fl andam. Ut propterea Aristoteles, ut ad hunc locum redeam, metri rursus
mentionem fecerit ijs in Tragoediae defi nitione et explicitatione maximè
verò in particula xxxvi34.
Anche qui il commentatore insiste sull’effi cacia del dettato tragico, a prescindere dall’uso della prosa o di forme metriche; del resto la stessa auctoritas aristotelica giustifi ca le posizione del professore padovano. Lo scritto del Beni , ma era facilmente prevedibile, suscitò da subito polemiche e contestazioni. Nello stesso anno, infatti, Lucio Scarani metteva in luce un Dialogus volto a restituire forma metrica a comme-die e tragedie. Il compilatore controbatteva alla proposta del Beni di introdurre l’uso della prosa per un principio di maggiore aderenza alla realtà, sostenendo che «non modo soluta, sed etiam dissoluta, popula-ri, incondita, ut in buccam venit, effutiunt, ac denique casu quodam, et fortuito»35. Lo Scarani , inoltre, si valeva degli exempla della tradizione antica, caratterizzata solo da testi teatrali in verso. Interessante è, per concludere, il riferimento all’effi cacia, appoggiato ad un chiaro riman-do al passo 1450b della Poetica: «vis enim et facultas, quam divnamin ap-pellant, utrumque respicit contrarium, quicunque enim potest scribere, potest et non scribere, Alexandri Aphrodisiensis haec est sententia in primo libro Topicorum»36.
Allo Scarani seguiva subito la risposta di Faustino Summo , che nel Discorso in difesa del metro37 ribadiva la necessità di mantenersi fedeli ai
34 Pauli Benii Eugubini In Aristotelis poeticam commentarii. In quibus ad obscura qua-equae decreta planius adhuc dilucidanda, centum poeticae controuersiae interponuntur & copiosissime explicantur. Quibus omnibus de poesis Aristoteleaeque Poeticae utilitate atque praestantia praeponitur oratio. Cum duplici indice, controversiarum uno, rerum memorabi-lium altero, [Patavii], in Beniana, per Franciscum Bolzettam, 1613, pp. 224-225.
35 Lucii Scarani philosophi medici Accademici Veneti. Scenophylax. Dialogus in quo Tragoedijs, et Comoedijs antiquus carminum usus restituitur, recentiorem quorundam iniuria interceptus, Venetiis, apud Ioan. Baptistam Ciottum Senensem, 1601, p. 12.
36 Ibi, p. 69.37 Discorso in difesa del metro nelle poesie, et nei poemi, et in particolare nelle tragedie
e comedie, contra il parere del M.R. sig. Paulo Beni di Faustino Summo padovano, in Pa-dova, appresso Francesco Bolletta, nella stamperia di Lorenzo Pasquati, 1601. Re-
La Merope in prosa 195
modelli greci e latini codifi cati, perseverando nell’uso del verso negli scritti teatrali. Antonio Scaino , nel medesimo giro d’anni, componeva – in polemica con il Beni – un Giudizio sul trattato del Benio in materia de’ versi, rimasto però inedito38.
L’età barocca, ormai compiutamente insediata39, non manca benin-teso di proporre, accanto ai sempre più numerosi trattati teorici, anche esempi frequenti di testi tragici in prosa, fra i quali fi gura, per citarne subito uno, la Guerra tra vivi, e morti di Giuseppe Artale , presentata come «tragedia di lieto fi ne» e composta con l’impiego minimo di par-ti in verso40. La curatrice dell’edizione moderna osserva, però, tra le numerose anomalie che caratterizzano il testo teatrale, che «la conclu-sione in versi della tragedia artaliana non fa che porre in risalto una complicità quasi ludica tra prosa e versi che corre costantemente in un testo pur dichiaratamente in prosa quale è quello dell’Artale »41. Del re-sto anche il poeta motivava la propria scelta in maniera piuttosto sbri-gativa: «Poteva anch’io componere quest’Opera in Verso; ma sapendo che può ben comparire coll’autorità degli antichi Maestri in Prosa una Tragedia di lieto fi ne, avendoti dato da bere bastantemente dell’acqua di Parnaso, t’offero queste poche stille dell’Aracinto, e godi»42. Trovo, però, interessante la giustifi cazione della prosa in virtù della scelta di un genere che sembra costituire un caso ‘a parte’ rispetto alla norma; del resto non serve ricordare che la stessa Merope, benefi ciaria di ben due riscritture in prosa, è pure tragedia di lieto fi ne, o quasi.
Tra gli scrittori secentisti di tragedie in prosa, si può annoverare an-che un concittadino del Maffei, il medico e letterato Francesco Pona 43,
lativamente a Faustino Summo si veda almeno il contributo di Elisabetta Selmi , I «Discorsi poetici» di Faustino Summo: teorie letterarie e ‘ordine del sapere’ nell’opera di un Accademico Ricovrato, in Atti del Convegno Storico per il IV centenario della fondazione dell’Accademia Galileiana (1599-1999), Padova, La Garangola, 2001, pp. 505-534.
38 Il manoscritto è conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, R 102 sup. misc. xvi. Cfr. Paul Oskar Kristeller , Iter Italicum, London, The Warburg Institute, 1965, vol. i, p. 310.
39 Il Quadrio , Della storia e ragione..., p. 113, ricorda fra le tragedie in prosa anche l’Arcinda. Tragedia del clarissimo signor Filippo Cappello , in Venezia, appresso Do-menico Amadio Vicenza, 1614; e Vincenzo Jacobilli , L’Ippollito, Roma, Guglielmo Facciotto, 1601; mi risulta, però, che entrambe siano scritte in verso.
40 Giuseppe Artale , Guerra tra vivi, e morti. Tragedia di lieto fi ne, a cura di Anna Ma-ria Razzoli Roio , Parma, Università degli studi di Parma (Archivio Barocco), 1990.
41 Ibi, pp. 7-9.42 Ibi, p. 48.43 È recente e molto dettagliato il contributo di Stefania Buccini su Francesco
Cristina Cappelletti196
che stranamente il marchese non cita nei suoi Teatri antichi e moderni, e che ricorda nella sezione della Verona illustrata dedicata ai letterati della città solo per la sua Lucerna e per la Cleopatra44. Si possono citare nume-rosi esempi, a partire da Lo Angelico, che inizia, secondo norma conso-lidata, con un prologo per musica in versi, cui però fa seguire un testo in prosa. L’autore, a dire il vero, ci aveva posti sull’avviso: nella lettera dedicatoria All’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Giovanni Grimani Capitanio di Verona, il Pona defi nisce la presente opera un «dramma», e quindi non propriamente tragedia, precisando poi al destinatario che: «anco al soggetto per se sacro, non mancano Episodij gustosi, che pos-sono dilettare con la varietà de gli oggetti ogni riguardante». La trage-dia è accompagnata inoltre da un’appendice di Intermedi di Gioseffo per lo Angelico, stesi in versi e quindi – secondo quanto detto nel prologo ai Lettori – facilmente adattabili all’accompagnamento musicale45. È poi in prosa (ma in questo ambito la tradizione era già codifi cata) anche il Parthenio commedia morale46; mentre viene versifi cata, presentando ele-menti di originalità da diversi punti di vista, un’altra tragedia del Pona , La Virgiliana, la quale viene defi nita «dramma libero» perché «l’Auttore non hà voluto obbligarsi a Unità di Favola, ò à cert’altre regole più rigo-rose, che congrue»47. Il testo in prosa più fortunato del veronese è sicu-ramente la tragedia sacra Cristo Passo, una riscrittura della passione di Cristo in forma scenica, che ricorda la sacra rappresentazione piuttosto che la tragedia d’impianto classico48. Nell’esemplare conservato presso la Biblioteca Civica di Verona (Coll. 134.2/169) insieme al testo teatra-le è stata rilegata una Apologia per lo Christo passo. Dialogo d’incerto. Gli
Pona autore di teatro, in La scena del mondo. Studi sul teatro per Franco Fido, a cura di Anthony Oldcorn - Lino Pertile - Rena A. Syska-Lamparska , Ravenna, Longo, 2006, pp. 159-169.
44 Scipione Maffei, Verona illustrata. Parte seconda. L’istoria letteraria o sia la no-tizia de’ scrittori veronesi, Verona, Vallarsi, 1732, ed. anastatica, Verona, Cassa di Ri-sparmio di Verona Vicenza Belluno, 1975, col. 238.
45 Lo Angelico del Cavalier Pona Historiografo Cesareo, Verona, fratelli Merli, 1650.46 Parthenio commedia morale di Francesco Pona , Venetia, Angelo Salvadori, 1638.47 La Virgiliana. Drama libero di Francesco Pona , Verona, Bartolomeo Merlo,
1635, p. 5.48 Il Cristo Passo. Tragedia sacra di Francesco Pona , Verona, Bartolomeo Merlo,
1629. Pietro Rossi , Francesco Pona nella vita e nelle opere, Verona, Franchini, 1897, par-lando di questa tragedia (si veda in particolare il capitolo iii della ii parte, Francesco Pona e i suoi drammi, pp. 77-106) osserva che il Cristo Passo «è un dramma sacro con gli intermedii in musica; fatto notevole per il secolo xvii, è scritto in prosa» (p. 101).
La Merope in prosa 197
interlocutori, Filandro e Aretèo, si preoccupano di individuare pregi e difetti (quest’ultimi puntualmente smentiti) della tragedia del Pona . Per quanto concerne l’aspetto singolare della sua stesura in prosa si legge:
Aret. Come potrete voi, ò come potrà egli salvare, l’aver composto Trage-
dia in Prosa? Quandoche vediamo i più eccellenti Scrittori, e Greci, e Latini,
e Toscani, averle sempre distese in Versi?
Fil. Non vi fate regola sì assoluta: perché il Cianippo, Tragedia del Sig.
Agostino Michele , è in prosa: et è Tragedia perfettissima.
Aret. Non mi sovveniva; perché una Rondine non fà Primavera. E tanto
meno voglio io, che il Cianippo habbia presso di me Auttorità, quandoche
si dicchiarò apertamente Aristotele , che la elocutione della Tragedia, è il
Verso. Dictionem appello illam quidam metrorum compositionem. E non solo
Horatio , che disse: Versibus exponi Tragicis, res Comica non vult...49
Fil. Veramente à prima vista, questa pare la più fondata opposizione, che
si possa fare alla Tragedia del Christo Passo. Ma chi và à poco à poco sgom-
brando le caligini dell’errore, egli si viene apertamente à manifestare il bel
Lume della Verità. Chiara cosa è, ò Areteo, che il Poeta è così detto, non per
lo stile, ò per lo metro, mà per l’imitatione: la quale può sì bene spiegarsi con
la Prosa, che col Verso. Testimonio ne siano le più belle Commedie scritte
nella lingua Toscana, che scritte in prosa molto meglio riescono, che quelle
spiegate in verso, à parere universale. Perché la prosa non manca lei ancora
del numero suo sostentato, e sonoro; che forma impensatamente Giambi, di
quando in quando; versi familiarissimi al favellare domestico, delle per-
sone ben create. Che appunto per colpire in questa naturalezza, e per non
scortarsi poco, ò nulla dalla Prosa, il Sig. Melchiore Zoppio , eminentissimo
letterato de’ tempi nostri, compose in sì fatti carmi Italiani, il suo Diogene accusato50: in modo che il Lettore solo s’accorgesse della dettatura in Verso,
perché lo vede nel Libro misurato, e distino; che per altro all’Uditore è così
bene celato il Verso, che non crede udir altro che Prosa. […] Adunque non
il Verso, ò la Prosa, mà l’imitatione forma il Poema. Anzi, che se vero è, il
49 Dubbia la prima citazione, mentre la seconda è tratta dall’Ars poetica di Ora-zio , v. 89.
50 Melchiorre Zoppio (Bologna 1544 - 1634), professore di logica a Macerata e Bologna e poi di fi losofi a morale. Nel 1588 fondò l’Accademia dei Gelati dove era detto Caliginoso. Fu autore, oltre alla citata commedia Diogene accusato (Venezia, Bindoni, 1598), anche delle tragedie L’Admeto, Medea esule, Creusa, Meandro (Bolo-gna, Rossi, 1629). Cfr. Rosamaria Faccioli , s.v. Zoppio, Melchiorre, in Letteratura italiana. Gli autori…, vol. ii, p. 1861.
Cristina Cappelletti198
Poeta altro non essere, che un accurato, e perfetto imitatore del Verisimile.
[…] Mancando adunque di Verisimilitudine il Poeta, verrebbe à mancar di
Fede: e mostrerebbe, non fatto allora emergente, ma azione palesemente
fi nta, studiata, & affettatamente mandata alla memoria. Che se i Dialogi,
per riuscir verisimili, è necessario che siano in Prosa, che altro son eglino, ò
Areteo, le Commedie, e le Tragedie, che Dialogi, fatti secondo la propria, e
natural forma del favellare, e non supposto lungo, e premeditato artifi cio?
[…] Dovendo adunque lo imitatore, quanto maggiormente sia possibile,
conformarsi alla Verità del fatto, che s’intraprende di spiegare; né essendo
verisimile, che alcuno Principe, ò Rè, ò altro Personaggio habbia d’impro-
viso tratto i suoi più gravi, e travagliati accidenti in Verso: quandoche più
tosto il dolore tronca, & impedisce le voci co’ gemiti, e co’ sospiri; egli è
una pazzia formale farlo sputar Versi, e tanto maggiore, quanto più limati,
gonfi , & più artifi ciosi51.
Oltre ad appellarsi all’auctoritas del Michele , l’anonimo difensore del Pona (ma non è da escludere che l’autore dell’opuscoletto sia il tra-gediografo stesso, dialetticamente sdoppiato) si richiama ai principi di verosimiglianza già ampiamente illustrati dal Beni .
Nel Seicento la prassi della tragedia in prosa sembra essere molto diffusa presso autori come Giovanni Francesco Savaro , che compose così L’amore non ha legge (Roma, Giacomo Fei, 1667), La Maria Stuarda (Milano, Gioseffo Mirelli, 1669) e L’Anna Bolena (Roma, Fei, 1667): testi tutti defi niti però «drammi», nonostante l’esito tragico dell’azione sce-nica52. Anche Giacinto Andrea Cicognini compose in prosa il Tradimento per l’onore, che presenta «momenti d’autentica tragicità»53. Va aggiunto
51 Apologia per lo Christo passo. Dialogo d’incerto, s.n.t., pp. 35-37.52 Giovanni Francesco Savaro (Pizzo 1610 - Mileto 1682), arcidiacono della Cu-
ria di Mileto, letterato, oratore, docente di retorica alla università di Bologna, ac-colto nell’Accademia romana degli Umoristi. Si veda almeno Pierantonio Frare , Le donne perseguitate nel teatro italiano, in Romanzesche avventure di donne perseguitate nei drammi fra '4 e '500. xxviii Convegno Internazionale, Roma, 7-10 ottobre 2004, Roma, Torre d’Orfeo, 2005, pp. 371-378.
53 Cfr. Federico Doglio , Il teatro tragico italiano, Parma, Guanda, 1972, pp. cvi-cvii. Notizie relative all’attività teatrale del Cicognini si desumono anche dal con-tributo di Diego Sìmini , Alcune opere ‘spagnole’ di Giacinto Andrea Cicognini fra tra-duzione, adattamento e creazione, in Teatro, scena e rappresentazione dal Quattrocento al Cinquecento, Atti del Convegno internazionale di Studi (Lecce, 15-17 maggio 1997), a cura di Paola Andrioli - Giuseppe A. Camerino - Gino Rizzo - Paolo Vitti , Galati-na, Congedo, 2000, pp. 305-313.
La Merope in prosa 199
inoltre il Costantino di Giambattista Filippo Ghirardelli54 , cui fa cenno anche Pietro Calepio 55.
Quest’ultimo lavoro, che può bene essere sorella di tante altre «tra-gediesse» composte nello stesso giro di anni, suscita accese polemiche, anche a causa della sua peculiare stesura, come si deduce dalla Difesa che l’autore aggiunse al testo già dalla princeps. Immediatamente dopo il primo allestimento, infatti, iniziarono a circolare manoscritte l’Op-posizione di un non meglio identifi cato Schiribandolo (che viene pub-blicata sempre e solo insieme al testo del Ghirardelli ) e un dialogo, Il Partenio, edito nel 1665, ad opera di Giovan Francesco Savaro , un altro che – secondo abbiamo appena accennato – si sarebbe fatto tentare da esperimenti di drammi tragici in prosa.
La Difesa, esempio abbastanza tipico della cavillosa retorica secen-tesca, ribadisce ai detrattori che Aristotele defi niva la tragedia greca e non universalmente il genere tragico; inoltre accenna al fatto che nell’antichità fosse uso cantare e accompagnarsi con musica durante le rappresentazioni drammatiche. Stringenti, ma scevre di originalità, le sue difese, che – come al solito – trovano giustifi cazione nell’ormai consolidato canone di esempi cinquecenteschi: il Cianippo del Michele , la Tamarre [sic] del De Velo , la Quintilia di Guazzoni .
Nel medesimo giro di anni anche l’autore dell’Aristodemo, Carlo de’ Dottori , indulge alla stesura in prosa di una tragedia, Bianca56, e di un dramma – parimenti redatto senza avvalersi di versi – a lieto epilogo,
54 Costantino tragedia di Giovanni Battista Filippo Ghirardelli con la Difesa della medesima, in Roma, appresso Antonio Maria Gioiosi, 1653. Giovan Battista Fi-lippo Ghirardelli (Roma 1623 - ivi 1653) fu letterato, fi losofo, teologo, nonché audi-tore del cardinal Egidio Carillo Albornoz e ambasciatore di Spagna presso il papa Innocenzo x. Composta nell’estate del 1632, la tragedia venne rappresentata nel «Palazzo de’ Signori Pichini» il febbraio del 1653. Cfr. Fabio Tarzia , s.v., Ghirardelli, Giovanni Battista Filippo, in DBI..., vol. liii, 1999, pp. 794-795; Uberto Limentani , La satira dell’«Invidia» di Salvator Rosa e una polemica letteraria del Seicento, «Giornale storico della letteratura italiana», cxxxiv, fasc. 408, 1957, pp. 570-585.
55 Pietro Calepio , Descrizione de’ costumi italiani, a cura di Sergio Romagnoli , Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1962, p. 45. Qui vengono menzionate – a titolo d’esempio – alcune tragedie in prosa: la Tamar del De Velo e il Cianippo di Michele ; nella prima stesura dell’operetta, però, veniva menzionato anche il Co-stantino del Ghirardelli , come si ricava facilmente dall’autografo zurighese del 1727 (di cui Romagnoli dà notizia in nota).
56 Bianca drama tragico d’Eleuterio Dularete [pseud. di Carlo de’ Dottori ]. De-dicato all’eccellenza del signor Girolamo Gradenigo capitano di Padova, Padova, Pietro Maria Frambotto, 1671.
Cristina Cappelletti200
Zanobia di Radamisto, edito postumo, quest’ultimo, e non facilmente da-tabile (Venezia, Valvasense, 1686)57.
La disputa intorno all’utilizzo del verso o della prosa nei testi tragici lascia traccia anche nei trattati di recitazione, come dimostra Andrea Perrucci nella suo Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso (1699). Dove scrive58:
se poi l’opera deggia scegliersi in verso, o in prosa: Hoc opus, hic labor est. Così potenti ragioni, e dell’una, e dell’altra parte militano, ch’io per me
confuso non saprei a quale appigliarmi; so che questa è questione da termi-
narsi più da chi compone, che da chi deve rappresentare; ma perché anche
a chi rappresenta sta qual deggia scegliere, per poterle più comodamente
riuscire; è di bene che si epiloghino le ragioni, e degli uni, e degli altri59.
Dopo una breve disamina sull’opportunità di usare la prosa nelle commedie, il Perrucci passa poi alla possibilità di utilizzarla anche nei testi tragici, a partire dalla tesi che essa sarebbe «disconvenevole parti-colarmente alla Tragedia»60. Riesce a dimostrare, però, in maniera che appare convincente, la validità del dettato tragico prosastico:
il verso più si convenga alla Tragedia per aver più gravità di sentenza, si
risponde, che anche, come si disse ha la sua gravità la prosa appunto come
l’hanno l’Orazioni, altrimente l’Orazioni tutte per esser gravi, sarebbe me-
glio farle in versi, che in prosa61.
Messe da parte le numerose polemiche del secolo xvii, il Settecento
57 Cfr. Antonio Daniele , Carlo de’ Dottori. Lingua, cultura e aneddoti, Padova, Antenore, 1996, pp. 6-7.
58 Andrea Perrucci (Palermo 1651 - Napoli 1704) si dedicò, oltre che alla stesura di un trattato sulla recitazione, Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso (Napoli, Michele Luigi Mutio, 1699), anche alla composizione di commedie, melo-drammi e opere «tragi-sacre». Cfr. Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1961, vol. viii, pp. 18-19.
59 Andrea Perrucci , Dell’arte rappresentativa premeditata ed all’improvviso, a cura di Anton Giulio Bragaglia , Firenze, Sansoni, 1961, p. 95. Sull’opera si veda il con-tributo di Pietro Spezzani , L’Arte Rappresentativa di Andrea Perrucci e la lingua della commedia dell’Arte, in Lingua e strutture del teatro italiano del Rinascimento, Padova, Liviana, 1970, pp. 357-438.
60 Ibi, p. 96. 61 Ibi, p. 99.
La Merope in prosa 201
si apre con un tentativo di riformare la tragedia e restituirle l’antica vi-talità, come dimostrano le numerose poetiche e i trattati sull’argomento. È lo stesso Maffei a farsi promotore del riadattamento alle scene di un numero cospicuo di tragedie antiche, con lo scopo di dimostrare quanto il genere antichissimo fosse ancora in grado di suscitare l’interesse del pubblico, pur conservando il proprio statuto diffi cile e alto-mimetico62.
Attestata ormai in larga parte la prassi vincente di stendere in verso il testo tragico, oggetto principale delle dispute del xvii secolo diventa il metro da impiegare in tal genere letterario. Normativo risultò essere il trattato di Pier Jacopo Martello , Del verso tragico (1709), in cui l’au-tore avanza la proposta di sostituire gli alessandrini francesi con due settenari, che danno origine a un verso di quattordici sillabe con forte cesura, a rima baciata. Questa forma metrica trova anche largo impiego in testi comici, come mostra un discreto numero di commedie goldonia-ne. Nonostante la felice trouvaille, però, il Martello non dimentica come «prese alcune delle nostre tragedie italiane, avvelenate, per così dire, dallo stile e da’ versi, e riducendole in prosa, spogliate de’ vani loro or-namenti non sono men forti e meno vive delle franzesi», tesi confortata, ad esempio, dall’Arsinda del Testi 63. L’affermazione, secondo il suo auto-re, si adattava in maniera ancora più calzante al Torrismondo di Torquato Tasso , riscritto in prosa dallo stesso Martello , al fi ne di rendere evidente la poca compatibilità dello stile poematico con i testi tragici64.
La riscrittura prosastica della tragedia cinquecentesca vuole, infatti, attestare in modo provocatorio la maggiore incisività che il testo avreb-be potuto avere, se il poeta non avesse adoperato uno stile troppo ma-gniloquente e un verso inadatto al teatro (non è un elogio della prosa, si badi bene, ma un rifi uto dell’endecasillabo). Così, con nitida consape-volezza, si giustifi ca il Martello: «Lo ridurrò in prosa, acciocché si resti d’accordo del pregiudizio che apporta il verso e lo stile a sentimenti per sé grandi e decenti al costume di chi favella»65.
62 L’ovvio riferimento è ai tre volumi del Teatro italiano o sia scelta di tragedie per uso della scena, Verona, Vallarsi, 1723-1725.
63 Pier Jacopo Martello , Del verso tragico, in Id., Scritti critici e satirici, a cura di Hannibal S. Noce , Bari, Laterza, 1963, p. 164.
64 Ibi, pp. 151-186; alle pp. 166-171 si può leggere la riscrittura in prosa della scena terza dell’Atto i del Torrismondo.
65 Cfr. anche il contributo monografi co di Grazia Distaso , Una riscrittura sette-centesca del “Torrismondo” e il trattato “Del verso tragico” di Pier Jacopo Martello, «La nuova ricerca», 11, 2002, pp. 315-323.
Cristina Cappelletti202
Di poco successivo (siamo nel 1715) è il trattato di Gian Vincenzo Gravina , Della tragedia, in cui il problema dell’oscillazione tra poesia e prosa non viene preso in considerazione, poiché l’autore è piuttosto interessato a stabilire quale sia il verso più opportuno per la tragedia volgare, e se sia consono ad essa l’uso delle rime.
Anche Scipione Maffei si occupa, a più riprese, di individuare un metro che possa essere atto al dettato tragico, capace cioè di conferire dignità letteraria al testo, evitando, però, eccessivi lirismi, e il conse-guente rischio di compromettere la messa in scena del dramma stesso. Il marchese, in questo caso, accorda la propria preferenza all’endecasil-labo sciolto, perché gli pare «non [si] avesse un verso il più comodo, il più libero, il più opportuno, per imitar chi ragiona»66. La sua posizione non è solo di compromesso tra la resa poetica e le esigenze rappresen-tative, ma tocca anche il punctum dolens della pratica scenica, e cioè la decadenza dell’arte dell’attore. Proprio per l’inadeguatezza delle com-pagnie, infatti, alcuni tragediografi hanno preferito ricorrere alla prosa, perché la recitazione di testi in verso rischiava di assumere, con quasi certezza, cadenza di una noiosa cantilena. La possibilità di abbando-nare la stesura in versi a favore di quella in prosa, però, è fermamente rifi utata: l’Attore è tenuto a saper fare il proprio mestiere, e a porgere con grazia i versi, che anzi – se ben congegnati – possono sostenere e valorizzare la sua arte. Scrive infatti l’erudito veronese:
Ora l’unica ragione per esiliar dal Teatro il verso, è presso cotesti valentuo-
mini, non potersi il verso recitar bene: la qual ragione è ancora più mirabile
dell’opinione istessa, poiché ragion primaria del far le Tragedie in verso pres-
so tutte le nazioni fu appunto, ed è, perché solamente in versi si può recitar
bene. Imprimer con forza, porger con grazia; e ciò che ne’ Teatri è sopra tutto
necessario, sostener la voce, non si può mai fare se non col verso, che con la
gravità sua, con gli spessi posamenti, e con l’armonia tutto ciò per se conse-
guisce: dove all’incontro in Teatro grande languisce sempre nelle serie recite,
e fi accamente arriva la prosaica voce, a riserva ch’altri non gridi67.
Naturalmente tutto ciò implica una perfetta preparazione, senza la quale l’attore che passa dalla più consueta commedia alla tragedia rischia di apparentare il recitato a una declamazione: «L’ignoranza de’ Comici
66 [Maffei], Teatro italiano..., pp. xxxviii-xxxix.67 Ibi, p. xxxix.
La Merope in prosa 203
– seguita Maffei – fu la principal ragione di bandir la Poesia dal Teatro: come potrebbe chi non gusta la nobiltà del verso, pronunziarlo bene, re-golare a tempo le infl essioni della voce, e far le posate a suo luogo?»68.
Anche in seguito alla pubblicazione della sua Merope, il marchese torna sull’argomento, negando la possibilità di adottare la polimetria propria della tragedia antica; come fra i metri moderni gli pare poco consono il settenario – naturalmente anche quello doppio del martel-liano –, così ribadisce la superiorità dell’endecasillabo, specie del suo, affermando:
In nostra lingua può farsi ottimamente di ciò giudizio nell’udir recitar
Tragedie; perché i versi settisillabi frammischiati ci fanno subito sentire
un non so che di Canzone, e son contrari a quell’incatenamento, e a quel
rompimento de’ versi, in cui dee consistere la grand’arte di rappresentare
un ragionar naturale. All’incontro il verso lungo [endecasillabo], che in se
comprende anche il corto, serve sempre l’istessa maestà, e decoro, e presta
facilità di fuggire il suono studiato, e la cadenza uniforme: ma non è per
verità di tutti il farlo come conviene69.
La scelta metrica del Maffei, nonostante le convincenti premesse, fi ni-sce però con il suscitare la perplessità (ma non sarà piuttosto l’invidia?) di molti contemporanei. Tra i primi, e forse più insospettabili, si può anno-verare anche il commediografo, e romanziere, Pietro Chiari , fervido so-stenitore dei versi martelliani, brutti e tediosi, almeno nelle sue comme-die in dialetto veneziano. L’autore, che durante la sua carriera non mancò di tentare anche la prova tragica, così oppone all’autore della Merope:
Lo stesso Maffei, tuttoché sì benemerito della Letteraria Repubblica, non
avrebbe sicuramente di costoro parlato con tanta imprudenza. Avrebbe egli
considerato, che la Poesia drammatica fu riputata mai sempre lo sforzo
maggiore dello spirito umano, che Commedie, e Tragedie senza difetti, co-
minciando dalla sua Merope, non ce ne furon giammai; che moderni Poeti
comici fanno tutto ciò, che ponno, per riformare il teatro, e fanno sempre
assaissimo, se nissun altro prima di loro fece mai altrettanto, e che fi nal-
68 Ibi, p. xxxv.69 Id., Paragone della poesia tragica d’Italia con quella di Francia, opera d’Autore ver-
satissimo nelle Italiane Tragedie e nelle francesi, «Osservazioni letterarie», Verona, Val-larsi, 1737, t. i, pp. 265-308 (la citazione è a p. 292).
Cristina Cappelletti204
mente godendo l’approvazione d’un popolo fatto ommai di cose teatrali
conoscitore acutissimo, anche da un tragico principiante, e fanciullo si me-
ritavano qualche onesto riguardo. […] Io non intendo per questo d’esclu-
dere da’ teatri d’Italia ogni altra sorte di verso; e l’endecasillabo particolar-
mente, che sin ora prevalse. Il moderno Euripide Veronese l’esalti pure a
suo senno: ma non mi dia per primo modello dell’endecasillabo sciolto il
solo Maffei; perché, grazie al Cielo, l’Italia n’ha qualche altro più poeta di
lui; e molto più non mi adduca per esemplare le di lui traduzioni d’Omero:
perocchè ogni critico disappassionato dirà; [sic] che il tradurre i Greci in
quella maniera, non è già un vestire Omero all’italiana; ma egli è piuttosto
un vestire la lingua italiana alla greca; e farla diventar barbara a segno di
non esser intesa70.
L’Euripide Veronese, mai direttamente nominato, ma indicato come autore della tragedia Teonoe, è Filippo Rosa Morando 71, che l’anno pre-
70 Pietro Chiari , Dissertazione storica, e critica sopra il teatro antico, e moderno, in Id., Commedie in versi, Venezia, Bettinelli, vol. I, 1756, pp. 32-35. Per notizie relative al Chiari , si rimanda almeno alla voce redatta da Nicola Mangini per il DBI..., vol. xxiv, 1980, pp. 556-562, da integrarsi – limitatamente alla biografi a – con la nota 3 del mio saggio Il commediografo in commedia. Appunti su Pietro Chiari personaggio letterario, «Quaderni di Lingue e Letterature» (Università di Verona), xxxii, 2007, pp. 29-42. Val forse la pena di ricordare che l’attacco del Chiari alla Teonoe era a tratti condiviso – se pur con altri toni – dal suo rivale Goldoni , che nell’introduzione alla Sposa persiana ne tesse sì un elogio, ma ne mette poi in luce le pecche: «Non può negarsi, che la Teonoe non sia verseggiata con una dolcezza di metro, e con una forza di sentimenti ammirabile. L’Autore suo degnissimo è Scolaro del celeberrimo Signor Marchese Maffei di gloriosissima ricordanza. Si conosce, ch’egli ha procurato imitarlo, copiando i pensieri della sua Merope, e i versi medesimi trascrivendo; ma in alcuni tratti, mi si conceda il dirlo, ha supera-to il Maestro. Io gli auguro di buon cuore lunga vita, e miglior salute, acciò possa egli arricchire i Teatri nostri di belle erudite Tragedie. Il talento suo felicissimo arriverà ben presto a conoscere i difetti di questa sua prima imperfetta opera, e si asterrà principalmente per l’avvenire di terminare una Tragedia in tal modo, che sarebbe riprensibile in Commedia ancora. […] Vedrà col tempo quanto sia meglio scemar il numero degl’inutili versi, delle repetizioni, e specialmente degli Argomenti; ed io son certo, che arriverà egli ad essere un giorno il decoro della Tragedia Italiana». Cfr. Carlo Goldoni , La sposa persiana. Ircana in Julfa. Ircana in Ispaan, a cura di Marzia Pieri , Venezia, Marsilio, 1996, p. 146.
71 Come ricorda Gian Paolo Marchi nel suo saggio Storia e tecnica della tra-duzione in Scipione Maffei, in Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto: dal Neo-classicismo al primo Romanticismo, Atti del Convegno Internazionale. Lecce-Castro, 15-18 giugno 2005, a cura di Giuseppe Coluccia e Beatrice Stasi , presentazione di Giuseppe A. Camerino , ii, Galatina, Congedo, 2006, pp. 149-165, a p. 153.
La Merope in prosa 205
cedente aveva scritto nell’introduzione di questa sua opera un conti-nuo elogio del Maffei e del suo verso tragico:
Altro verso non ho voluto in esso usare che l’Endecasillabo nostro affatto
libero dalle Rime. Verso per la propria sua gravità alla tragedia adattissimo,
e per la libertà, che ha di trascorrere ora in conciso e vibrato, ora in veloce e
continuato discorso, a meraviglia esprimente il vario impero degli affetti e
la facilità del natural ragionare72.
[…]Serbavasi questa gloria [del perfezionamente dell’endecasillabo] al
marchese Maffei, nome ch’io avrò sempre in onore per la candidezza del
suo costume e per l’eccellenza del suo sapere. Il suo ingegno nato a trovare
ciò che a tutti gli altri fu vanamente tentato, dando opera al verso sciolto
così felicemente vi riuscì, che nulla di più perfetto si può bramare. Egli ci
mostrò come del verso sciolto si debbe usare nell’epopea con la versione
de’ primi canti d’Omero , e come nella dramatica, con quella sua tragedia
che ha riportato sì grande applauso in Europa73.
Fra i detrattori dell’endecasillabo maffeiano ci sarà, e come poteva mancare?, il collerico e geloso Vittorio Alfi eri , il quale accuserà il mar-chese di aver «sbiadata […] nel dialogo tragico […] questa nostra di-vina lingua, sì maschia ancor ed energica e feroce in bocca di Dante».74 La questione del metro tragico, però, è più complessa: Maffei, infatti, non trova, nella tradizione precedente, un verso adatto alla sua idea di teatro. Gli alessandrini rimati delle tragedie francesi sono, a suo parere, stucchevoli e monotoni; gli endecasillabi alternati ai settenari producono un che di cantilena, di nenia per nulla adatta allo stile ‘alto’ della tragedia. Il verso deve essere usato semplicemente per conferire maggior decoro al testo, eliminando la sciatteria del sermo cotidianus, pur conservando schiettezza e immediatezza. La scelta dell’endecasil-labo sciolto, per Maffei, si inserisce proprio in questa direzione: spez-zando opportunamente i versi, ed evitando la coincidenza tra la fi ne della frase e quella del verso, egli ritiene possibile conferire maggio-re naturalezza e realismo alla rappresentazione75. Alle accuse mosse
72 Filippo Rosa Morando , Teonoe. Tragedia, Verona, Andreoni, 1755, p. [10].73 Ibi, pp. [17-18].74 Vittorio Alfieri , Vita, a cura di Giampaolo Dossena , Torino, Einaudi, 1967,
p. 157 (parte i, epoca iv, cap. i, 1775).75 Vincenzo Placella , La polemica settecentesca della «Merope», «Filologia e Let-
teratura», iii-iv, 1967, pp. 309-447 (il riferimento esatto è alla p. 316).
Cristina Cappelletti206
dall’Alfi eri , si potrebbe ben rispondere con alcune osservazioni dello stesso Maffei:
Diffi coltà immaginava ancora nel verso, perché non altramente che in en-
decasillabi sciolti ma ben girati credeva egli poter riuscire con gravità e
decoro una Tragica recita: ma dove questi facilissimi si credono, e pronti ad
ognuno, nel modo con che pareva a lui dovessero depurarsi, e condursi, ei
gli tenea per più diffi cili de’ rimati, facendo la rima soffrir parole soverchie,
e riempiture76.
Questi i termini della polemica sulla tragedia in prosa, almeno sino agli anni in cui venne redatta la seconda Merope ‘sine verso’. Veniamo ora ad analizzare in maniera più dettagliata le peculiarità delle due riscritture del testo maffeiano. Secondando le accuse alfi eriane nei con-fronti del dettato tragico della Merope, possiamo osservare come le ver-sioni in prosa non vadano troppo a snaturare la sintassi del testo che, per volere dello stesso Maffei, non eccedeva in lirismo. Da un’analisi comparata dei tre testi, l’originale maffeiano (da qui in poi maf)77 e le due rielaborazioni prosastiche (lon per la stampa Longhi e sar per quella di Michele Sarcone ), si può notare quanto molte parti si ridu-cono, soprattutto per quel che riguarda l’edizione napoletana, ad una mera parafrasi del testo, senza introdurre varianti lessicali di un qual-che rilievo. Fra i molti esempi possibili, vorrei segnalare i versi della scena sesta dell’Atto secondo, alla lettura dei quali, come ricordava Pindemonte nel suo elogio del Maffei, Alfi eri disse: «Convien confessa-re […] che tragici veramente son questi versi»78:
Mer. […] Or Polifonte
regnerà sempre e regnerà tranquillo.
O ingiusti numi! Il perfi do, l’iniquo,
il traditor, l’usurpator, colui
76 La Merope Tragedia con annotazioni dell’Autore, e con la sua risposta alla lettera del sig. di Voltaire . Aggiungesi per altra mano la version francese del sig. Freret, e la inglese del sig. Ayre, con una confutazione della critica ultimamente stampata, Verona, Ramanzini, 1745, pp. 22-23.
77 In mancanza di una edizione critica della Merope maffeiana, cito dall’ultima edizione edita per cura dell’autore (Verona, Ramanzini, 1745).
78 Ippolito Pindemonte , Elogio del Marchese Scipione Maffei, in Id., Opere in prosa ed in versi. Elogi, Milano, Silvestri, 1829, vol. i, pp. 3-271, a p. 56.
La Merope in prosa 207
che in crudeltà, che in empietà, che in frode
qual si fu mai più scelerato avanza,
questo voi proteggete, in questo il vostro
favor tutto versate e contra il sangue
del buon Cresfonte, contra gl’infelici
germi innocenti di scoccar v’è a grado
gli strali, e duolvi forse ora che, omai
estinti tutti, ove scoccar non resta. [maf ii, 6; p. 56]
Mer. […] Ora Polifonte regnerà sempre, e regnerà sempre tranquillo.
Oh Ingiustissimi Numi! Così proteggete il traditore, il perfi do,
l’iniquo usurpator dell’altrui? Colui, che nell’empjetà, nelle frodi
avanza ogni maggiore scellerato, quegli è da Voi colmato di gra-
zie, e di favori! E poi contro il sangue del buon Cresfonte, contro
gl’infelici innocenti della sua Stirpe tanto vi piace d’incrudelire?
Fors’anche vi duole, o disumani, che siete, ch’estinti oramai quan-
ti sono, non avrete più campo da fulminarli. [lon ii, 7; p. 40]
Mer. […] Or Polifonte regnerà sempre, e tranquillo regnerà…! Ingiu-
stissimi Numi, il perfi do, l’iniquo, un empio usurpatore, un tra-
ditore, colui, che in sceleraggine avanza qualunque uomo più
scelerato, che fu mai sulla terra, questo dunque voi proteggete!
In questo versate il vostro favore, ed è vostro diletto l’infi erire
contro il sangue del buon Cresfonte, e contra i suoi innocenti ger-
mi infelici!… [sar i, 10; p. 47]79
79 Gli esempi potrebbero essere infi niti; ne propongo uno ulteriore, particolar-mente signifi cativo:
Adr. Veggo più tosto che mentir non sai: non mi dicesti tu che il padre tuo in fortuna servil si giace?Egi. Il dissi e ’l dico. [maf. i, 4; pp. 40]
Adr. M’accorgo più tosto, che non sai l’arte di mentir bene. Non mi dicesti, che il vecchio tuo Padre vive poveramente in fortuna servile?
Egi. Il dissi, né il niego. [lon i, 4; p. 19]
Adr. Io veggo piuttosto, che tu mentir non sai. Non mi dicesti che il padre tuo si giace in fortuna servile?
Egi. Il dissi, e il dico. [sar i, 4; p. 25]
Cristina Cappelletti208
Risulta abbastanza evidente che le due versioni in prosa, specie quella napoletana, non si inoltrano nel terreno della riscrittura testuale. Ci sono, però, due scene un po’ particolari su cui mi vorrei soffermare. La prima è la quarta dell’Atto terzo, durante la quale Egisto, credu-to da Merope l’assassino dell’amato fi glio, è legato a una colonna e sta per essere ucciso dalla regina. Nella prima stesura della tragedia il Maffei faceva pronunciare ad Egisto il nome del presunto padre, cioè Polidoro, suscitando così in Merope un forte sospetto sull’identità del giovane stesso. Mentre la regina cercava di approfondire la questione, l’arrivo di Polifonte interrompeva l’indagine.
Il marchese Giovan Gioseffo Orsi , in seguito alla prima lettura della Merope, fece notare al Maffei come fosse troppo esplicito il riferimento al nome del padre per lasciare a Merope dubbi sull’identità di Egisto, con il risultato di anticipare così, senza volerlo, l’agnizione e portando l’actio tragica ad una fase di stallo. Inoltre, sempre l’Orsi , sottolineava come fosse incoerente che un fi glio invocasse non genericamente il pa-dre (come del resto aveva fatto nella battuta precedente con la madre), ma lo chiamasse per nome.80 Il Maffei, che andava particolarmente fi ero delle due agnizioni nella sua tragedia, cioè quella di Egisto da parte di Merope, e quella del medesimo Egisto, non esitò a mutare la battuta, sostituendo padre a Polidoro, con l’effetto di rendere così più vaghi i sospetti di Merope. Le moderne edizioni riportano in linea di massima questa seconda versione, apparsa anche in edizioni settecen-tesche riconosciute o direttamente invigilate dall’autore. Entrambe le versioni in prosa, invece, preferiscono la prima stesura, quella cioè con la lezione Polidoro, che anticipa, in certo senso, l’agnizione di Egisto. Riproduco i tre testi:
Egi. Ah padre mio,
tu mel dicesti un dì ch’io mi guardassi
dal por già mai nella Messenia il piede.
Mer. Nella Messenia? E perché mai?
Egi. Bisogna
credere ai vecchi.
Mer. Un vecchio è il padre tuo?
dal capo ai pie m’è corso un gelo, Euriso,
che instupidita m’ha. Dimmi, garzone:
80 Cfr. Placella , La polemica settecentesca..., pp. 323-324.
La Merope in prosa 209
[le cade l’asta di mano]
che nome ha...
Ism. Ecco servi, ecco il tiranno. [maf iii, 4; p. 68]
Egi. Polidoro tu mel dicevi ch’io mi guardassi dal por mai piede nella
Messenia.
Mer. Polidoro! E chi sei tu?
Egi. Insomma bisogna prestar fede a i vecchi.
Mer. Ma chi è questo Polidoro? Ahimè un freddo gelo corsomi giù per
le vene mi ha renduta stupida in un momento. Dimmi: che hai tu
a fare con la Messenia?
Egi. Nulla ch’io sappia: pure il Vecchio presago, così era solito d’avvi-
sarmi.
Mer. Dove nascesti? Chi fu tuo Padre? Qual è il tuo nome?
Ism. Ecco le Guardie col Tiranno. [lon iii, 4; p. 55]
Egi. Ah Polidoro! tu me’l dicesti un giorno, che io mi guardassi di
porre giammai il piede nella Messenia.
Mer. Polidoro!… E tu chi sei?
Egi. Creder bisogna a’ vecchi.
Mer. Ma rispondi… Dì, qual Polidoro è questi? … Euriso, dal capo al
piè m’è corso un gelo, che mi ha tutta istupidita… Dimmi garzo-
ne, che ha tu a fare colla Messenia?
Egi. Nulla; ma pure così egli dicea.
Mer. La Patria… il padre… il nome…
Ism. Ecco, oimè, le guardie, ecco il tiranno… [sar ii, 4; p. 63]
Nell’edizione napoletana, che riporta a fronte il testo originale del-la tragedia maffeiana, viene ovviamente ripresa la prima stesura di questa scena. È diffi cile stabilire il motivo di tale scelta; l’edizione bolognese, purtroppo, non ha neppure un’introduzione, a differenza di quella napoletana, in cui Michele Sarcone cerca di dar ragione di alcune delle proprie scelte. In quest’ultimo caso, però, tace, soffer-mandosi invece su un’altra scena, la quarta dell’Atto quarto (dodice-sima dell’Atto secondo, nella numerazione napoletana). Vediamone il breve intreccio: giunto a palazzo a notte ormai inoltrata, Polidoro ripara nell’atrio per trascorrervi la notte; lì scorge un giovane che non riconosce, ma che gli sembra una fi gura familiare. Sarcone , nell’in-troduzione, poneva in dubbio la credibilità della scena nella versione maffeiana:
Cristina Cappelletti210
Lo Spettatore non sa capire come Polidoro, che non ha svelato ancora
d’avere scoperto nel Servo, che dorme, il suo Cresfonte, possa aver ragione
di trattenere il colpo micidiale, che la Madre già vibra sul proprio fi glio. È
vero che il dotto Maffei ha cercato di render ragione di quest’Atto di Poli-
doro; ma la situazione della scena medesima, e la decente posizione degli
Attori o non rende accettabile questo rigiro, o spande un’ombra d’inverisi-
militudine nell’episodio più interessante di questa Tragedia. Con pochissi-
me parole si è tutto emendato; e togliendo ogni equivoco, si è dato un poco
più d’interesse, e di moto agli Attori senza alterare l’episodio principale.
Di fatto la precedente ricognizione, che Polidoro fa di Cresfonte, che dor-
me, produce un effetto sorprendente, e sparge una graziosissima vivacità
sull’azione susseguente81.
Non trovando credibile che Polidoro potesse fermare Merope sul punto di uccidere il non ancora riconosciuto Cresfonte, Sarcone mette in scena addirittura tre agnizioni, ma – come aveva fatto notare già l’Orsi al Maffei per la scena precedente – l’anticipato riconoscimento rischia di compromettere lo svolgimento dell’intera tragedia, offrendo allo spettatore/lettore un numero eccessivo di informazioni, che po-trebbero impedire il naturale corso dell’azione drammatica. Del resto è notte, l’atrio del palazzo è illuminato, ma non è diffi cile immaginare come Polifonte, che non riusciva a vedere in viso il giovane, non rico-noscesse immediatamente nella fi gura coricata Egisto.
Oltre a queste due varianti di certo rilievo, sussistono alcune pecu-liarità che rendono interessanti, ciascuna a suo modo, le due versioni in prosa della Merope.
Per quanto riguarda l’edizione Longhi, è da notare che essa non rap-presenta un caso isolato, quanto piuttosto una prassi abbastanza comu-ne per l’editore. Sono, infatti, numerose le tragedie in prosa stampate dal Longhi, anche se si tratta – per lo più – di traduzioni dal francese, mentre sono più rari gli originali.82 Dal breve elenco di testi riportati
81 sar, pp. [2]-[3].82 Fornisco solo un elenco sommario, a puro titolo di esempio, in primis delle
traduzioni: L’Agrippa opera nobilissima tradotta dall’idioma francese et accomodata per le scene all’uso d’Italia (s.d.); Il Britannico tragedia di Pietro Cornelio tradotta dal francese (s.d.); Edippo tragedia di Pietro Cornelio tradotta dal francese, ed accomodata alle scene d’Italia (s.d.); Stilicone tragedia di Tomaso Cornelio trasportata dall’idioma francese, e recitata da’ signori cavalieri del Clementino nelle vacanze del carnovale in Roma
La Merope in prosa 211
in nota appare un dato abbastanza signifi cativo: molte delle versio-ni in prosa vennero pubblicate per essere rappresentate nel Collegio Clementino di Roma, gestito dai padri Somaschi83. Questo potrebbe in parte spiegare le scelte ‘editoriali’ del Longhi. Dal momento che la stampa doveva essere propedeutica ad una rappresentazione ‘amato-riale’, è abbastanza comprensibile che l’uso della prosa fosse dettato dal desiderio di facilitare la messa in scena da parte dei giovani attori. Nonostante non si dichiari nel colophon, il saggio di Marco Andreetti dimostra che anche la riscrittura della tragedia maffeiana venne rap-presentata dai convittori del collegio romano84.
Relativamente all’edizione bolognese della Merope, quel che appare con maggiore evidenza è come – durante il passaggio dal verso alla prosa – si assista a un immotivato cambio di deittici allocutori: mentre i personaggi della tragedia maffeiana, secondo la consuetudine propria anche della tradizione greca, si rivolgevano gli uni agli altri declinan-
(1698); Berenice tragedia di m. Rasino tradotta, e rappresentata da’ sig. Cavalieri del Collegio Clementino in Roma nel carnevale dell’anno 1699 (1699, traduzione di Filippo Merelli ); Il Timocrate opera tragicomica di Tomaso Cornelio . Tradotta dal francese, e rappresentata da signori Accademici Ardenti di Bologna, e dedicata a’ signori Accademi-ci Stravaganti del Collegio Clementino di Roma (1699); Il Pirro tragedia di Tommaso Cornelio tradotta dal francese, e recitata da’ signori cavalieri del Collegio Clementino nelle vacanze del carnevale (intorno al 1700); Tamerlano, tragedia di monsù Pradon trasportata dall’idioma francese, recitata da’ signori Cavalieri del Clementino di Roma, nelle vacanze del carnovale (intorno al 1700); Eraclio. Tragedia di M. Pietro Cornelio , tradotta e rappresentata da’ sig. Cavalieri del Collegio Clementino in Roma nel Carnevale dell’anno 1699 (1701); Poliuto. Tragedia cristiana di M. Pietro Cornelio trasportata dall’idioma francese, e recitata da Sig. Cavalieri del Clementino nelle vacanze del Carne-vale (1701, traduzione italiana di d. Filippo Merelli ); Rodoguna tragedia di Pietro Cornelio tradotta dal francese (1702); Tito e Berenice. Opera heroicomica di Pietro Cornelio (1705); L’Arminio. Tragedia di Pietro Cornelio (1710); Il Balduino opera di M. Pietro Cornelio tradotta in italiano dall’abbate Gigli di Siena (1716); Attila re degli Unni tragedia di Pietro Cornelio (1718). Tra le opere originali si possono almeno ricordare: L’innocenza calunniata, ouero La regina di Portogallo Elisabetta la santa. Rap-presentatione del signore Giacinto Andrea Cicognini fi orentino (s.d.); La conversione di S. Agostino opera scenica del signor Giuseppe Berneri romano (1687); Pompeo Ca-donici , Dell’innocenza, e protezione del Cielo. Opera tragica (1691); Alfonso Cavazzi , Pertinace. Tragedia (1729).
83 Sull’attività teatrale del collegio romano, si veda il saggio di Marco Andre-etti , Eroi tragici fra balli galanti. Teatro e spettacolo nel Nobile Pontifi cio Collegio Clemen-tino di Roma: analisi degli anni del protettorato del Cardinale Benedetto Pamphilj (1689-1730), «Biblioteca teatrale», 3, 2001, pp. 165-191.
84 Ibi, p. 189: la Merope venne messa in scena il 23 settembre 1723.
Cristina Cappelletti212
do i verbi alla seconda persona singolare, nell’edizione bolognese tut-ti passano al voi. Si riscontra una sola eccezione: Merope si rivolge a Polifonte, l’usurpatore, l’assassino, il tiranno, usando il voi, un voi che però mette in rilievo lo sdegno e il disappunto della regina verso l’anta-gonista. Avviene, però, come nella scena sesta dell’Atto terzo (lon, pp. 57-59), che la regina, per blandire Polifonte e convincerlo a condannare Egisto, gli si rivolga familiarmente con una più amichevole seconda persona singolare, quasi come se solo in quel momento, per captatio benevolentiae, riconoscesse Polifonte quale signore e legittimo sovrano della Messenia, e quindi suo pari.
Nonostante Maffei, anche attraverso la prassi tragica, abbia sempre sostenuto la superiorità degli italiani nei confronti dei francesi, l’edi-zione bolognese della Merope pare invece volta – secondo diffusa gallo-mania – all’“infranciosamento”, come si sarebbe detto nel xviii secolo, della tragedia. Oltre al passaggio da una seconda persona singolare, conformemente ai dettami della tradizione classica, ad una più formale seconda plurale, evidenti in questo senso mi sembrano gli epiteti no-minali con i quali i vari personaggi si rivolgono a Merope: «Regina», «Signora» e, spesso, «Madama». Quest’ultima forma di cortesia richia-ma da vicino – a mio parere – un vezzo tipicamente francese, Racine docet, che – grazie anche all’inserzione nella quasi totalità delle battute delle forme di cortesia «madame» e «monsieur» – riesce a trasformare i palazzi greci in salotti parigini alla moda. Non è forse un caso che nei primi anni del ’700 lo stampatore Longhi di Bologna potesse vantare tra le sue impressioni un elevato numero di traduzioni tragiche dal francese, soprattutto da Racine e da Corneille . Si potrebbe addirittura ipotizzare che l’anonimo redattore di questa versione in prosa della Merope fosse anche traduttore di qualche tragedia d’Oltralpe, la qual cosa avrebbe potuto spingerlo a una rilettura in chiave francesizzante del testo maffeiano.
La Merope aveva riscontrato il plauso dei contemporanei anche per aver bandito dalle scene gli intrecci amorosi; l’autore evidenziava in-fatti la necessità di
rendere anche a’ nostri giorni accetta, e gradita una Tragedia senza amoreg-
giamenti; mentre l’uso già da gran tempo introdotto di non rappresentar
quasi altro, come si era veduto pochi anni innanzi nell’Artaserse di Giulio
La Merope in prosa 213
Agosti 85, benché senza inganno lavorato, disperdere avea quasi fatto la ve-
ra Tragedia, e svanire86.
L’edizione del Longhi pare volta ad accentuare questa caratteristica, epurando il testo delle parti che potevano far pensare alla persistenza di retaggi dell’intreccio amoroso nel dramma. Come noto, la Merope maffeiana si apre con la profferta nuziale di Polifonte alla regina, du-rante la quale il tiranno cerca di nascondere il fi ne politico del matri-monio con dichiarazioni d’amore. È per lo meno singolare il fatto che nell’edizione Longhi la parola amore sia sistematicamente sostituita da «stima», quasi a voler sottolineare la totale assenza di tematiche senti-mentali nel testo drammatico87.
A differenza della prosa di Sarcone , improntata – come vedremo – ad una riduzione anche materiale del testo (ripensato in tre atti invece che in cinque), la versione bolognese tende ad inserire frasi, a volte intere battute, del tutto superfl ue. Vari gli esempi che si possono addurre:
Mer. Adrasto, usa pietade
con quel meschin; benché povero e servo […]
dissomiglianti. Piaccia almeno al cielo
ch’anch’ei sì ben complesso e di sue membra
sì ben disposto divenuto sia. [maf i, 3; p. 38]
85 Per le poche notizie biografi che relative all’Agosti , è necessario ricorrere an-cora agli Scrittori d’Italia di Gianmaria Mazzuchelli (Brescia, Bossini, 1753-1763, vol. i, t. i, p. 207). Di lui si dice solo che fu originario di «Reggio in Lombardia», e che pubblicò nel 1700 la tragedia Artaserse, dedicata al Duca di Modena; riproposta poi nel 1709 e nel 1714, quest’ultima versione indirizzata al duca Francesco Maria Pico della Mirandola da Luigi Riccoboni . Il Quadrio (Della storia e ragione…, vol. iii, p. 97) sostiene che l’Agosti fu anche autore di un altro testo tragico, Cianippe, di cui già il Mazzuchelli non travava alcun riscontro. Relativamente all’Artaserse, invece, si veda il contributo di Giuseppe Leonelli , Uno “spettacolo” fra vecchio e nuovo secolo: l’Artaserse, tragedia di Giulio Agosti, «Atti e memorie dell’Arcadia», vii, 2, 1978, pp. 199-225.
86 La Merope Tragedia con annotazioni dell’Autore..., p. 21.87 maf. i, 1; p. 32: «Pol. […] Or che a la fi ne in calma / questo regno vegg’io,
destarsi io sento / tutti i dolci pensier; la mia futura / vecchiezza io vo’ munir co’ fi gli, e voglio / far pago il mio, fi n qui soppresso, amore. / Mer. Amore, eh?». Nella versione lon (i, 1; p. 11), invece, si legge: «Or fi nalmente che veggio in calma lo stato, cedo a’ miei pensieri più dolci, e cercando appoggio all’età mia ventura, fo ragione alla stima, ch’ebbi per voi. Mer. Stima per me eh?».
Cristina Cappelletti214
Mer. Usate pietà a quel Meschino, o Adrasto. Disperi la fuga. […] Piac-
cia almeno una metà, che come gli sarà simile nella comparsa,
così sia ancor ben disposto della persona, e corrisponda al valore
degli anni quello del corpo.
Adr. Non dubitate, Signora.Ism. I Dii che l’han sottratto al Tiranno, l’avranno renduto ancor forte con-
tro i disaggi. [Lon i, 3; pp. 17-18]
Oppure si potrebbe vedere l’amplifi catio di alcune battute:
Egi. […] lungo tormento
agl’innocenti genitori affl itti,
i quai la sola assenza mia son certo
ch’or fa struggere in pianto. (maf i, 4; pp. 39)
Egi. […] Pur troppo piangono di certo gli affl itti genitori miei la lun-
ga, e sola mia lontananza dal loro seno. Che non gli abbia a far morir di dolore la mia oppressa innocenza riconosciuta nella mia morte.
(lon i, 4; pp. 18-19)
Le inserzioni, si badi, non sono casuali: al personaggio di Merope, a titolo di esempio, vengono spesso aggiunte frasi nuove, con l’intento preciso di rendere ancora più patetico il personaggio, sottolineando la sofferenza e lo strazio a cui gli dèi l’avevano sottoposta. Per contro, Polifonte viene sempre identifi cato come il tiranno crudele (termine che nell’originale maffeiano compariva in una sola occorrenza dopo l’agnizione del legittimo erede, Cresfonte, mentre qui il termine viene utilizzato in maniera quasi sistematica).
Inoltre la tragedia maffeiana, propriamente tragedia degli affetti, o dell’affetto materno, diventa, nella versione bolognese, tragedia della vendetta. Spesso nelle battute di Merope vengono aggiunti inserti in questa direzione: l’anonimo riscrittore bolognese attribuisce sovente alla regina parole di vendetta, non solo nei confronti di Egisto creduto l’assassino di Cresfonte, ma – soprattutto – contro il traditore e usur-patore Polifonte.
pol. Ma in van, per non aver chi parli incontra,
il tutto a suo favor dipinge e adorna,
ch’io qual custode delle leggi offese
l’avversario sarò. (maf i, 3; p. 38)
La Merope in prosa 215
pol. Egli s’adula di comparir’innocente, perché niuno mostra in con-
trario, ch’egli è colpevole. Ma invano dipinge come difesa della
sua vita l’ardimento felice della sua colpa. Io quel Custode, che
sono delle leggi violate, parlerò in contrario, per convincerlo e
per vendicarle. (lon i, 3; p. 16)
pol. Pur non sarà così. Invano, per non esservi chi parli incontra egli
saprà adattare, e dipingere il tutto a suo favore. Qual custode
delle leggi io sarò l’avversario. (sar i, 3; p. 23)
Della versione Longhi fu certamente a conoscenza anche lo stesso Maffei, che però dimostrò di non gradire molto lo svolgimento in prosa del suo testo:
È allignata in alcune Città un’eresia Teatrale, fomentata da certuni studiosa-
mente, e promossa, che non si debba recitare in versi, ma in prosa. Fra genti
non idiote, e rozze, ma colte, e gentili non s’intese mai la più strana opinione:
tuttavia tanto vien sostenuta, ch’essendo stata in alcune private scene richie-
sta la moderna Merope, la misera non altrimenti ci comparve, che disfatta in
prosa: non è stata creduta in altre parti sì stravagante immaginazione, ma la
faccenda andò pur così; e per certo scempio assai minore può dirsi, che ne
facessero que’ miseri Comici, o ciarlatani, che vogliamo dire, i quali per farla
più rumorosa, ci appiccicarono al fi n d’ogni scena una rima88.
Del secondo esperimento conosciamo – come anticipato più volte – il curatore. Si tratta, appunto, del medico napoletano Michele Sarcone 89,
88 [Maffei], Teatro italiano..., pp. xxxvii-xxxviii.89 Michele Sarcone (Terlizzi [Bari] 1731- Sessa Aurunca [Caserta] 1797) studiò a
Napoli medicina, laureandosi brillantemente; nel 1777, venne nominato Segretario per le scienze fi siche della neo costituita Accademia delle scienze, per conto della quale si recò in Calabria a studiare le cause del terremoto del 1783. In ambiente letterario ebbe rilievo una sua polemica con il Galiani , che nutriva un certo ran-core nei confronti di tutti gli accademici napoletani, a seguito della sua esclusione dall’Accademia delle scienze. Egli attaccò nel suo trattato Del dialetto napoletano il contegno tenuto dal Sarcone durante l’epidemia del 1764, alludendo – nemme-no troppo velatamente – alla negligenza che il medico avrebbe mostrato in quel tragico episodio. Quest’ultimo però si vendicò attraverso la composizione della Lettera terza. Ammonizione caritativa all’autore del libro intitolato «Del dialetto napole-tano» (Napoli, s.t., s.d.), in cui metteva in rilievo le pecche dell’opera del Galiani . Non risultano invece ascritte al Sarcone , nei contributi biografi ci più attendibili,
Cristina Cappelletti216
il quale l’anno successivo avrebbe replicato l’esperimento con la stesura in prosa di un proprio Teodosio il Grande, tragedia rappresentata sempre al Real Teatro di Caserta, a dimostrazione di un apparente interesse del pubblico partenopeo per le novità in ambito teatrale. Anche Benedetto Croce ricorda questi due testi drammatici:
Vi si tentò [scil. a Napoli] anche la tragedia in prosa nel ’72 con la Merope
del Maffei, ridotta a quel modo da Michele Sarcone , e nel ’73 col Teodosio,
originale del Sarcone . Ma né l’una né l’altra piacquero; tanto che il Tanucci
ordinò che si smettessero, perché (egli sentenziava) “il gusto italiano non
è stato mai per le tragedie fi n da secoli remoti, onde è stato introdotto un
terzo spettacolo, che è l’opera”, e, per quel che poi concerne la tragedia in
prosa, essa “non è stata bene accolta dalle nazioni estere”90.
La riduzione in prosa napoletana è riduzione in senso stretto, ven-gono cioè spesso tagliate battute anche necessarie, soprattutto a partire da metà del secondo Atto, quasi che l’autore si fosse accorto – in ritardo – di dover ridurre a tre gli originali cinque atti. In alcuni luoghi, però, il testo maffeiano viene invece minimamente ampliato, con l’inserzione di battute volte ad accentuare il patetismo tragico, come accade nella prima scena del primo Atto:
Mer. O ciel, qual nuova spezie di tormento
le due tragedie in prosa e alcune altre opere poetiche a lui attribuite da Gaetano Melzi , Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all’Italia, Milano, Pirola, 1848-1859 (anche se il nome oscilla tra Sarcone e Sarconi): Cerere placata. Festa teatrale data in occasione di celebrarsi la solenne funzione in cui in nome di Carlo terzo si tiene al sagro fonte la real principessa Maria Teresa Carolina (Napoli, Stamperia Simoniana, 1772; Melzi , vol. ii, p. 110); Aureo regno di Ferdi-nando IV, re delle due Sicilie (Napoli, 1780; Melzi , vol. i, p. 101); Il conto del Borsotto mal pieno (Napoli, s.t., dopo il 1781; Melzi , vol. i, p. 251. Il Melzi data l’opuscolo intorno al fi nire del xvii secolo, data che sembrerebbe incompatibile con l’autore in questione; però poi accenna alla professione medica dell’autore); Il caffè. Opuscolo (s.l., s.d.; Melzi , vol. i, p. 160). Una cantata della Cerere placata, Bella Fiamma ad-dio, venne musicata anche da Wolfgang Amadeus Mozart (K. 528). Cfr. Benedetto Vulpes , s.v. Sarcone, Michele, in Biografi a degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, a cura di Emilio De Tipaldo , Venezia, Alvisopoli, vol. i, 1834, pp. 263-266; Nino Giangregorio , Michele Sarcone. L’uomo, il medico, lo scienziato, il meridionalista del Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1986.
90 Benedetto Croce , I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fi ne del secolo decimot-tavo, Bari, Laterza, 1916, pp. 221-222.
La Merope in prosa 217
apprestar mi vegg’io! Deh, Polifonte,
lasciami in pace, in quella pace amara
che ritrovan nel pianto gl’infelici;
lasciami in preda al mio dolor trilustre. (maf i, 1, p. 28)
Mer. Misera me! Qual nuova specie di tormento ora mi si appresta!
Deh, Polifonte, lasciami in pace, per pietà, in quella pace amara,
che trovano gli infelici nel pianto: lasciami in preda a quel dolore,
che da tre lustri mi divora e mi consuma. (sar i, 1; p. 9)91
La tendenza di Sarcone all’amplifi catio delle battute superstiti si nota anche dalle voces mediae maffeiane, che vengono spesso connotate dall’autore napoletano in senso positivo o negativo; in particolare l’ef-fetto viene ricercato attraverso l’inserzione di aggettivi volti a marcare maggiormente le dichiarazioni degli attori. Per esempio, i versi maffe-iani: «Un regno / non varrebbe il dolor d’esser tua moglie» (maf i, 1; p. 28) diventano: «Ogni più vasto regno non varrebbe il dolore d’esser tua moglie» (sar i, 1; p. 9).
È peraltro da osservare come il testo in prosa di Sarcone tenda, para-frasando, a una semplifi cazione di tipo retorico-formale, senza che ciò vada, però, a scalfi re l’incisività delle battute. Nella riscrittura dei versi con cui il marchese introduce il personaggio di Egisto-Cresfonte, carat-terizzati nella versione originale da un bel chiasmo, il medico napoleta-no elimina una forma retoricamente più ricercata, ma riesce comunque a mantenere l’incisività del detto, a rimarcare il divario tra l’aspetto nobile del giovane e il suo essere messo male in arnese:
Adr. […] giovane d’alti sensi in basso stato ed in vesti plebee di nobil volto. (maf i, 2; p. 35)
Adr. […] tutto che ei sia in basso stato, e in vesti plebee, in lui traluce un
giovane d’alti sensi, e di nobile aspetto. (sar i, 2; p. 17)
Come i due esperimenti analizzati, anche gli altri – pur esigui – ten-tativi di adattare la prosa al genere tragico non ebbero seguito. Abbiamo già ricordato che anche dal punto di vista meramente lessicografi co,
91 I corsivi sono miei.
Cristina Cappelletti218
sino a tutto l’Ottocento, nella defi nizione stessa di tragedia è sempre insita l’idea del verso. «Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza»; e una posterità abbastanza vicina all’autore della Merope e ai suoi emuli espresse un netto giudizio su questi esperimenti teatrali. Mi riferisco a Ippolito Pindemonte , che a lungo penò nel tentativo di comporre una tragedia degna di tenere il raffronto con quella del concittadino Maffei. Dopo il successo del suo Arminio, il nobile veronese decise di proporne una ristampa corredata da tre discorsi attinenti il genere tragico; nel se-condo (il terzo riguarda la querelle Maffei-Voltaire proprio intorno alla Merope) Riguardante l’Arminio e la poesia tragica, dedica un capitolo (il quinto) allo stile e al verso. Dove si legge:
L’Italia, che antivenne tutti i popoli nel risuscitare le arti, gli antivenne in
quei capricci ancora, che soglion guastarle; tra i quali la tragedia in pro-
sa non è meno ridevole. Promossela in Francia Lamotte , e fu rassomiglia-
to, meschino versifi catore com’era, alla volpe d’Esopo , che consigliava di
mozzarsi la coda, perché sventuratamente si trovava scodata. Ma molto
prima di lui Agostino Micheli scrisse in prosa il suo Cianippo; e l’imitarono
molti, e il Ghirardelli tra gli altri nel Costantino. Sì comoda usanza dovrebbe
piacere oggidì, che non si voglion catene di sorta alcuna. […] Altri per lo
contrario s’invaghirono della tragedia rimata, come il Martelli , che usò i
versi Alessandrini, e il Pallavicini , di cui abbiamo un Ermenegildo in ottava
rima92. […] Di questi due mali, cioè della prosa, o delle rime nella tragedia,
qual sia maggiore, non so. So, che all’uno e all’altro soggiacque indegna-
mente la nostra bellissima Merope, che un Vandalo in prosa disfece, e che le
rime in fi n d’ogni scena appiccò un Ostrogotto. Quella Merope, da cui prese
occasione Voltaire d’invidiare al Maffei il nostro verso sciolto; verso che
ancor più egli avrebbe invidiato, se le tante intrinseche, e drammatiche doti
potuto avesse l’uom forestiero conoscerne93.
Netto il giudizio relativo alla prosa tragica, ed evidente l’affetto del Pindemonte per il Maffei; meno immediata è l’identifi cazione del
92 Si tratta del gesuita Sforza Pallavicino , la cui fama è legata alla Storia del Conci-lio di Trento (1656). Nel 1644 pubblicò a Roma la tragedia Il martire Ermenegildo, for-temente infl uenzato dal teatro spegnolo. Cfr. Doglio , Il teatro tragico italiano…, p. xcviii. Si veda inoltre l’introduzione di Daniela Quarta all’edizione critica dell’Er-menegildo martire (Roma, Pagine, 1996).
93 Ippolito Pindemonte , Discorso secondo, Dello stile e del Verso, in Id., Arminio. Tragedia, Verona, Mainardi, 1812, pp. 217-218 (cap. v, Dello stile e del verso).
La Merope in prosa 219
Vandalo e dell’Ostrogotto, che osarono profanare il testo impeccabile della Merope. Giulio Cesare Becelli , nell’introduzione Al lettore, premes-sa al volume del Teatro maffeiano, ricorda – tra le numerose traduzioni – due francesi, l’una in verso e l’altra in prosa, così precisando:
ed è stata tradotta in Francese, in Inglese, e in Tedesco: e si stamperà forse
con quelle traduzioni appresso, acciò a forastieri anche per la lingua servir
possa. In Francese, oltre la traduzione stampata dal Frere in prosa, un’altra
ve n’è di bravo Poeta tragico in versi94.
Credo, però, sia inutile affannarsi nel tentare un’identifi cazione dei due barbari profanatori della Merope. Ciò che in realtà appare evidente è che le riscritture in prosa non suscitarono l’entusiasmo del Pindemonte , né di molti contemporanei, che proseguirono – Manzoni in primis – ad associare alla tragedia la prassi della versifi cazione95.
94 Teatro del Sig. Marchese Scipione Maffei. Cioè la tragedia, la commedia e il dram-ma. Aggiunta la spiegazione d’alcune Antichità pertinenti al teatro, Verona, Tumermani, 1730, pp. xi-xii.
95 La poca fortuna della tragedia in prosa, anche nell’Ottocento, è resa eviden-te dalle numerose versioni metriche di testi drammatici inglesi e francesi. Non si discostano da questo gusto letterario le traduzioni di opere teatrali, pubblicate da Nicolò Bettoni , la cui importanza in campo editoriale è indubbia: sono infatti scritte rigorosamente in verso Venezia salvata ossia una congiura scoperta, tragedia di Tom-maso Otway tradotta da Michele Leoni (Milano, 1828); Radamisti e Zenobia, tragedia di Crebillon (Milano, 1829); Atreo e Tieste tragedia di Crebillon tradotta dal conte Giuseppe Urbano Pagani-Cesa (Milano, 1831).