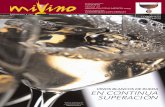A proposito di alcuni frontespizi di tesi del Collegio dei Nobili di Parma
Fonti per la storia del Paesaggio del Vino in Alta Maremma. Dal Medioevo alle "Vigne di Elisa", una...
Transcript of Fonti per la storia del Paesaggio del Vino in Alta Maremma. Dal Medioevo alle "Vigne di Elisa", una...
Collana Confronti, vol. 6A cura del Centro Studi Città e Territorio – Follonica (GR)Direzione: Giulia Galeotti – Marco Paperini
Il Centro Studi si avvale della consulenza di un comitato scientifico composto da:Giovanna Bianchi, docente di Archeologia Medievale, Università di Siena; Maurizio De Vita, docente di Restauro, Università di Firenze; Emma Mandelli, docente di Rilievo dell’Architettura, Università di Firenze; Rossano Pazzagli, docente di Storia Mo-derna, Università del Molise; Giuliano Pinto, docente di Storia Medievale, Università di Firenze; Carlo Tosco, docente di Storia dell’Architettura, Politecnico di Torino
In copertina: Veduta dai vigneti dell’azienda Agricola Le Corne, sullo sfondo Grumello del Monte (BG)©Archivio Azienda Le Corne
Concessioni per l’uso delle immagini:pp. 6/ 8/ 32/ 34 (montaggio Città e Territorio da Archivio Corne)/ 35, ©Archivio Azienda Le Corne – autore Clive Nicholspp. 3/ 14/ 39/ 127/ 129 (elaborazione grafica): ©Archivio Centro Studi Città e Territoriopp. 15/ 18/20/40/45/46/128/286 ©Giulia Galeotti p. 10 montaggio Città e Territorio da ©Archivio Marcello Giuntinip. 16 ©Mauro Davolip. 19-251 ©Paolo Da Rèp. 25/ 48/49 ©Archivio Arcipelago Muratori:p. 88 su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Torino con divieto di riproduzione (aut. 1190/28.28.00 del 16.03.15)pp. 87-91 su concessione della ©Bibliotèque Nationale de Francep. 90 su concessione della ©Bibliotèque Royale de Belgiquepp. 96-99 su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Bergamo con divieto di riprodu-zione (aut. 1259/28.13.11 del 16.03.15)p. 124 ©Michelangelo Pasquinelli – Amici di Suvereto p. 135 ©Roberto Pierallip. 139 su concessione Archivio Centrale dello Stato (autorizzazione nota 19.10.2011 n. prot. 4654)pp. 154/156/157/159/161 ©Vincenzo Cottinellip. 176 © Silvia Muratore - SiTIpp. 180/181/182/183/184 ©Archivio SiTIpp. 220/222/223/224/225 ©Fabrizio F.V. Arrigonip. 236 Disegno di ©Antonio D’Amico p. 244 ©Corrado Bonomop. 246 ©Pier Mario Turinap. 247.2 ©Jacopo Pennap. 247.3 ©Estudio Martín Azúa pp. 264/266/267/268/269/271, ©Associazione Orme su la Court e di Omar Pistamiglio Fotografopp. 23, 27, 29, 36, 52, 147, 151, 152, 272, 278, 283, 285 sono della redazioneLe altre immagini sono state fornite, sotto la propria responsabilità, direttamente dagli autori dei singoli contributi con conte-stuale autorizzazione alla pubblicazione. Per le immagini munite di © vale il divieto di riproduzione con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione del titolare del copyright. Il convegno I Paesaggi del Vino si è svolto dal 20 al 23 novembre 2014 presso l’Azienda Vitivinicola Le Corne di Grumello del Mon-te (BG) con il patrocinio di: Comune di Grumello del Monte; Provincia di Bergamo; Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo; Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – Università di Firenze; Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – Politecnico di Torino; Scuola Permanente dell’Abitare.
Comitato scientifico del convegno: Alessandro Camiz (Univ. La Sapienza – Roma); Maurizio De Vita (Univ. di Firenze); Edoardo Milesi (dir. Scuola Permanente dell’Abitare); Rita Occhiuto (Univ. de Liege); Rossano Pazzagli (Univ. del Molise); Hoissen Sandri (Girne American University - Cyprus); Akiko Sugesawa (Univ. di Tokio); Carlo Tosco (Politecnico di Torino).Discussant: Fabio Saggioro (Univ. di Verona); Giampiero Mele (Univ. eCampus); Maurizio De Vita (Univ. di Firenze); Carlo Tosco (Politecnico di Torino); Rossano Pazzagli (Univ. del Molise).
Confronti 6. I Paesaggi del Vino.A cura di Giulia Galeotti - Marco PaperiniEditing: Marco PaperiniImpaginazione e grafica: Giulia GaleottiCentro Studi Città e Territorio - www.cittaeterritorio.org
Debatte EditoreVia delle Cateratte, 84 int. 8 - 57122 [email protected]
ISBN: 978-88-6297-195-9
Stampato su Cyclus Print certificata FSC
123
Fonti per la storia del paesaggio del vino in Alta Maremma Dal Medioevo alle ‘Vigne di Elisa’, una proposta di ricerca
Marco Paperini
Introduzione
Nell’Alta Maremma il vino oggi è un elemento di cen-tralità paesaggistica ed in larga parte anche di centralità economica, a seguito della crisi che ha caratterizzato le industrie della vicina Piombino. Sono particolarmente interessate alcune aree: Bolgheri - Castagneto Carducci, dove si concentrano le grandi proprietà antiche e nobi-liari ma che ha saputo attrarre anche grandi produttori da altre parti di Italia, dal Piemonte soprattutto; Suve-reto, che da pochi anni ha ottenuto la DOCG per i suoi vigneti di rosso e dove si sono insediate alcune delle grandi cantine progettate da Archistar e meta di impor-tanti flussi turistici particolari, come la cantina Petra o la Tenuta Rubbia al Colle dell’Arcipelago Muratori; ed in-fine, Massa Marittima, con la DOC Monteregio in fase di ascesa. Quella del vino, naturalmente, non è l’unica produzione di qualità di questi territori dove si concen-trano, infatti, le maggiori coltivazioni olearie della costa e dove si trovano anche presidi DOP come il carciofo violetto della Val di Cornia. La mia indagine, con i limiti che illustrerò in seguito, si concentrerà sulla Val di Cornia e sull’area di Massa Ma-rittima, luoghi in cui le stesse comunità vanno sempre più identificandosi con la coltivazione della vite. Basti pensare al caso di Suvereto, dove il palio medievale di Santa Croce, anticamente corso a cavallo, ha nuovamen-te suscitato l’entusiasmo dei suveretani (e non solo) con la trasformazione, dal 1994, in una “Corsa delle botti”,
durante la quale i rappresentanti dei terzieri del paese si sfidano a una corsa facendo rotolare botti da cinque quintali per le vie del centro storico medievale. Questa gara ha poi dato vita, su sollecitazione degli spingitori suveretani, al Palio nazionale delle Città del Vino, pro-mosso dall’omonima associazione nazionale1.Per lo studioso è necessario, tuttavia, andare oltre la retorica commerciale che vorrebbe una produzione vitivinicola di qualità, ininterrotta fin dagli Etruschi. Nel ricostruire in maniera attendibile il paesaggio del-la Maremma prima del Novecento, ci siamo interro-gati se nell’epoca medievale (che ha anch’essa segnato particolarmente l’identità di questi luoghi) la vite fosse realmente predominante e, in caso affermativo, in che modo il vino caratterizzasse questi luoghi.La seguente è dunque una proposta di ricerca, non cer-to esaustiva, bensì limitata all’analisi di alcune tipologie di fonti per capirne le potenzialità.
L’età classica
La tradizione ci ricorda come nello stesso nome di Po-pulonia, il centro più importante della costa tirrenica, fosse leggibile la vocazione di questo territorio. La città deriva, infatti, il suo nome etrusco Fufluna da quello del dio Fufluns, noto nella mitologia greca e poi romana ri-spettivamente come Dionisio e Bacco, e quindi allusivo al germoglio e alla fertilità della vite. Plinio ci descrive a questo riguardo il simulacro di Giove custodito nel tem-
L’Alta Maremma è oggi nota per le produzioni vinicole di qualità. A Massa Marittima e Suvereto il paesaggio è a tal punto caratterizzato dai vigneti che il vino può essere considerato l’elemento identitario predominante delle co-munità locali. La ricerca è orientata a indagare gli elementi di continuità o trasformazione del paesaggio storico. A questo scopo, si presentano alcuni campioni di fonti - archeologiche e documentarie - per comprenderne le poten-zialità e gli usi ai fini della conoscenza storica del paesaggio maremmano, in un lungo cammino che dagli Etruschi, attraverso il Medioevo, giunge alle vigne di Elisa Bonaparte.
Alta Maremma is well known today for its production of high quality wine. In Massa Marittima and Suvereto the landscape is so characterized by the vineyards that wine can be considered the dominant element of identity of the local communities. The research is aimed at investigating the elements of continuity or transformation of the historic landscape. To do this, samples of sources - archae-ological and documentary – are presented in order to understand their potential and uses for the historic knowledge of the Maremma landscape, in a long journey that from the Etruscans, through the Middle Ages, comes to the vineyards of Elisa Bonaparte.
I Paesaggi del Vino
124
pio della città, scolpito a quanto pare in un unico tronco di vite. Populonia era già in rovina nel V secolo quan-do fu visitata da Rutilio Namanziano nel suo viaggio di ritorno verso le Gallie, e rappresentata con la celebre similitudine tra la mortalità del corpo e quella delle città:
«Sola manent interceptis vestigia muris,/ruderibus latis tec-ta sepulta iacent./ Non indignemur mortalia corpora solvi:/Cernimus exemplis oppida posse mori»2.
Questo quanto ci racconta la storia. Recentemente l’ar-cheologia ha iniziato a interessarsi delle produzioni agri-cole e vinicole in particolare dando vita a una serie di progetti, che si avvalgono di numerose altre discipline quali la botanica, la geoarchelogia, la biologia, l’infor-matica ecc. Ad esempio, numerosi casi studio sono stati messi a frutto, nel caso specifico della Toscana, con-fluendo nel volume miscellaneo Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell’indagine archeo-logica alle prospettive della biologia molecolare3 che già nel tito-lo ci illustra l’alto grado di specializzazione raggiunto da questa tipologia di studi. Come si evince dalla disamina dell’indice, tuttavia, accanto a progetti che hanno rag-giunto un buon livello di analisi come Archeovino per il territorio di Scansano (Grosseto) dove si è piantumato un vigneto sperimentale utilizzando i vitigni storici4, ve ne sono altri, come il progetto VINUM, che riguarda anche l’area populoniense, limitatosi purtroppo ad una prima indagine conoscitiva sui siti archeologici già esi-
stenti5. Nell’area sono state individuate undici piante di vite silvestre, altre sono state avvistate ma non cam-pionate per la difficoltà di accesso. Il contesto ambien-tale sembra particolarmente idoneo per lo sviluppo di queste piante che sono state individuate, per la maggior parte entro il circuito murario basso. Secondo gli stu-diosi, «le attività portuali legate al commercio del pro-dotto enologico potrebbero aver favorito fenomeni di introgressione genetica tra piante autoctone e materiale vegetativo proveniente dall’esterno, [presumendo] av-venisse anche lo scambio e la veicolazione di talee e di sementi di provenienza orientale»6.
Il Medioevo nel cartulario del Monastero di san Quirico
Rimanendo nell’area dell’antica città di Populonia viene in aiuto alla nostra ricerca un’importante serie docu-mentaria prodotta dal monastero di San Quirico.Il cenobio sorgeva a mezza costa, alle pendici del Mon-te Tondo nella zona, ormai in parte abbandonata, della città etrusco-romana di Populonia7.Incerta la fondazione, da attribuirsi con molta proba-blità alle politiche di controllo territoriale, in un sito di notevole interesse strategico, da parte di chi deteneva i maggiori poteri sul territorio, gli Aldobrandeschi in pri-mis , che contribuirono a dotarlo ampiamente nel corso dell’XI-XII secolo. Non distante dal sito del monastero,
Il Palio delle Botti di Suvereto.
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni
125
nei pressi dell’antico porto di Populonia, sorgeva il ca-stello di Porto Barattoli, inserito nella signoria del vescovo di Massa la cui sede primitiva era proprio Populonia8. Le prime attestazioni della chiesa di San Quirico risal-gono agli anni Trenta dell’XI secolo, mentre il monaste-ro, osservante la regola Benedettina e retto da un abate, è menzionato per la prima volta nel 1048. Nel 1147 esso fu posto sotto la protezione apostolica9. I suoi beni, ri-cavabili dal cartulario, si concentrarono nella bassa Val di Cornia. Nel 1259, stante un periodo di crisi, fu affida-to dal vescovo di Massa ai Guglielmiti di S. Guglielmo di Malavalle nel territorio di Castiglione della Pescaia. Abbandonato dai frati nel corso del XIV secolo, rimar-rà in funzione la chiesa dove, ancora a metà XVI se-colo, venivano rogati alcuni atti notarili. Recentemente il complesso è stato oggetto di un lavoro di indagine archeologica (a cura delle università di Siena e Venezia-Ca’ Foscari) e di rilettura delle fonti documentarie che ci permetteranno di conoscere meglio le vicende di que-sto importante ente religioso maremmano10.Nell’Archivio di Stato di Firenze si conserva il cartu-lario del monastero, pubblicato per la prima volta da Alceste Giorgetti tra il 1873 e 187411, costituito da sette pergamene incollate l’una di seguito all’altra fino a co-stituire un unico rotolo di 4260x300 in buono stato di conservazione. Si tratta della trascrizione di cinquanta atti riguardanti i beni del monastero secondo la dispo-sizione topografica delle proprietà, raggruppati per località, e non cronologicamente come invece risulta
dall’edizione Giorgetti.Importantissimo per la storia del cenobio, il cartulario lo è anche per la nostra ricerca, considerato che del to-tale degli atti trascritti ben ventisei riguardano donazio-ni, acquisti e concessioni a livello di terreni vitati. An-cor più ragguardevole considerando che si riferiscono a una parte ben circoscritta della Val di Cornia: la mag-gior parte dei terreni si trovavano nella zona compresa tra Suvereto, Campiglia Marittima e Vignale Riotorto, l’antico distretto di Cornino. Più precisamente gli atti riguardano il territorio di pertinenza della curtis di Casa-lappi tra il Cornia e le pendici delle colline del Parco di Montioni, salvo un atto relativo alla zona al confine tra Suvereto e Sassetta ma che, già in età altomedievale, era pertinenza della suddetta curtis12.
Veniamo al dettaglio. Il 17 aprile del 1035 Ildizio di Tre-mizio offre con alcune condizioni alla chiesa di S. Qui-rico la terza parte di due pezzi di terra di cui una «est in Loco Lungo cum vinea super se habente» in un’area da identificare con Calzalunga o Casal lungo, ai confini tra il comune di Suvereto e quello di Monterotondo Marit-timo, una zona agricola pianeggiante di grande impor-tanza nel Medioevo13. Non a caso l’atto è redatto nel vicino Castello di Campetroso. Nel 1045 è Turrismon-do del fu Alberto ad offrire al monastero una terra con vigna posta in luogo detto Castagneto «ubi dicitur Rivo Merdaccio, prope ecclesia S.Pauli»14; non conosciamo l’ubicazione esatta di detto luogo ma il Riomerdancio
I resti del monastero di S. Quirico a Populonia.
I Paesaggi del Vino
126
è un torrente che, nascendo sul Monte Calvi affluisce al fiume Cornia poco oltre Cafaggio, nel comune di Campiglia Marittima, per cui è possibile ipotizzare che, anche in questo caso, la vigna si trovasse nell’ampia pia-nura verso Casalappi.Sempre nel distretto di Cornino, in un non meglio iden-tificato luogo detto Burdi, si trova «medietatem de una petia de terra … quod est vinea» che Ava di Berizio vedova di Fulcaldo offre alla chiesa di San Quirico, imi-tata successivamente dal figlio, titolare dell’altra metà15. Una terra con vigna «quam detinet Magitia mulier Pe-tri» posta a San Frediano, circa due chilometri a SSE di Casalappi fu invece donata da Domenico di Albizia16 che l’ aveva ricevuta in dono cinque anni prima da Ro-dolfo del fu Gerardo, fattosi monaco17. Sempre nella zona di Casalappi si trovava uno dei due appezzamenti di terra con vigna «et campo cum olivis et aliis arbori-bus» che Tegrimo detto Saracino del fu Giovanni offre «pro remedio animarum quondam infrascriptis genitori meo et quondam Anselmi, qui fuit germano meo» al monastero18. Quasi due anni dopo Tegrimo donerà al monastero un altro pezzo di terra a Casalappi un cam-po «in quo fuit cassina et res massaricias, ubi residebat quondam Baroccio»19 e che si trova vicino alla chiesa di San Cristoforo, alla quale apparteneva una vigna20. In quest’area, conosciuta anche come Livellaria, nella qua-le si concentravano i maggiori possedimenti del mona-stero, si trovano altri cinque appezzamenti di terra con vigna21. Con uno strumento rogato nel castello di Sasso il 13 marzo del 1058 Enrico del fu Rozzo vendette al prete Luido due pezzi di terra, uno dei quali«cum vinea» posto a Valli presso la chiesa di San Donato e confinan-te con la vigna Ubertinga e l’altro a Monticelli (nei pressi del già citato Rivo Merdaccio di Suvereto) per 100 lire22. Non sappiamo come questi beni pervennero nelle mani del monastero che nell’agosto del 1080 le concesse a livello a Verruccio del fu Giovanni e Tuccio del fu Moro dietro la corresponsione del canone di «argentum de-narios bonis expendibiles de moneta de Lucca fummo XII» da versarsi il primo di settembre di ogni anno23. Purtroppo nessuno dei documenti fin qua analizzati fornisce indicazioni sulle dimensioni di questi vigneti, che dovevano comunque essere abbastanza ampi. L’u-nica misura di vigneto si ha nell’atto di donazione di un resede posto nei pressi del castello di Casalappi che Ildebrando e Alberto del fu Ildebrando e Ermingarda loro madre fanno al monastero il 7 gennaio del 109324: il resede aveva sulla sua superficie «duobus tramiti de vinea, quam ipse Martinus detenuit».Un’altra area di proprietà del monastero è rintracciabile nei pressi del Castello di Biserno (al confine tra gli at-tuali comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo)25 in particolare: nel 1079 Rodolfo del fu Gumpizo dona alla chiesa di San Quirico due appezzamenti di cui uno «cum vinea super se abentem», posto nei pressi della
chiesa di San Colombano e confinante con i terreni del conte Tedice [Gheradesca], con i vigneti di Pellegrino di Ilditio e con quelli di Pagano e Raniero, fratelli di Ro-dolfo26. Sempre al distretto del castello si riferisce una donazione di Tedice del fu Tedice, che dona ad Ami-co del fu Anatello una «petia de terra cum vinea infra se abentes, qual iter ab omni parte circumdata est per designatas locas, quod ipsa petia de terra per mensura a sistariorum XXX sistario de XII pani de grano te-nentes»27 posta a Dolgia, nei pressi del Rio Querceto. Oltre vent’anni dopo Amico d’Anatello insieme al figlio Raniero offrono all’abate Canizzone «omnibus casi set casisinis, seu casalinis atque terris, vineis, ortalia, oli-vetis, castagnetis, quercetis, silvis, virgaretis, pratis, pa-scuis, cultis rebus vel incultis sive mobile vel immobile quantum modo habere e possidere» con la condizione che «Eo modo ut si ipsi legitimi filii abuerint, et post ipso rum obitum vixerint, donec tamen vixerint ipsius vel eorum legittimi filiis, habeant infrascriptis rebus et a modo in antea per singulum anno abeat infrascripto monasterio, pro infrascriptis rebus obedientia omnem decimam de vino sive de fruges de una masia que esse videtur in loco ubi dicitur Carpineto»28. Tre anni dopo, alla morte del suddetto Amico, è la vedova Berta del fu Geto assieme al figlio Raniero a donare al monastero un pezzo di terra con vigneto posto a Dolgia29.Estraneo al contesto territoriale appare il manso di terra che il monastero riceve in dono dal conte Ildebrando del fu Ranieri con Massimilia del fu conte Ruggeri sua moglie e Lupa sua cognata30. Il manso si trovava sul Monte Maccajo ed aveva un vigneto ed un oliveto; la località è da intendersi al confine tra i comuni di Suve-reto e Sassetta, luogo ove sussistevano pertinenze della curtis di Casalappi che, come abbiamo visto, costituiva il fulcro dei possedimenti monastici.L’impressione che ne ricaviamo è di un’ampia diffusio-ne del coltura della vite, concentrata in aree forse più vocate alla produzione, centri curtensi di remota me-moria che quindi avevano con molta probabilità un or-ganizzazione tale da garantire oltre al fabbisogno dei proprietari anche una discreta quota per la commercia-lizzazione su medio – lunghe distanze del vino e sulla quale le fonti maremmane per il Medioevo non ci il-luminano. È interessante notare, da questo campione ben rappresentativo dei sistemi produttivi della zona, la scarsa presenza di colture ad olivo risultanti comunque marginali anche all’interno dei singoli fondi.Per quanto riguarda il commercio su larga scala man-cano in generale attestazioni per il periodo medievale. L’unico riferimento è relativo a Suvereto: alla fine del Trecento (1392) un mercante suveretano, tale Morovel-lo, fu assalito da un battello pirata al largo di Monte Cristo e gli furono rubate quaranta botti (non sappia-mo se piene). I pirati sulla rotta di ritorno verso il nord dell’Africa furono intercettati dai Messinesi e catturati.
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni
127
Morovello si rivolse allora agli Anziani di Pisa affinché intercedessero presso le autorità di Messina per ottene-re il recupero della merce31.Per l’area di Casalappi appena esaminata esiste una de-scrizione di molto successiva che ci fornisce una visione radicalmente diversa:
«A scirocco poi di Suvereto vi è la tenuta di Casalappi, una volta riunita al Principato, ed ora al medesimo separata e in-corporata alla Toscana. Il territorio di Suvereto è fertile d’o-lio, grano e pasture. L’olivo si fa all’uso di Pisa, e riesce ottimo […] questa pianta prospera molto anco nella pianura…».
Siamo alla fine del XVIII secolo, quando un anonimo ci lascia le sue Riflessioni sopra lo stato fisico, morale e politico del Principato di Piombino32, e nella piana suveretana dove nel Medioevo prosperava la vite si trovano pascoli e olivete.
Fonti per lo studio del contado di Massa di Ma-remma nel Medioevo
Il territorio di Massa Marittima si presta ad una ricerca di lungo periodo per vari motivi, e prima di tutto perchéconserva numerose testimonianze documentarie, dalla fondazione della città (XI secolo) fino all’epoca moder-na, permettendo così un’analisi di tipo seriale, applicata a un territorio ampio (circa 250 kmq) ma comunque circoscritto ed omogeneo33. Questo ha permesso la realizzazione di un progetto di ricerca articolato dove mediante l’incrocio dei dati, non solo di carattere docu-mentario ma anche archeologico, possiamo procedere all’analisi del rapporto città-contado, dell’uso del suolo a fini agricoli, produttivi ed estrattivi.
Va inoltre sottolineata l’importanza della fonte topono-mastica, testimonianza viva (archeologia della parola) sull’uso del territorio nel corso dei secoli che, a Massa, si caratterizza per una lunga tradizione di oralità che un’attenta schedatura dei dati potrà fissare nella memo-ria storica collettiva. Tutti questi dati confluiscono in un sistema digitale di database, GIS e elaborazione di cartografia tematica34.Per questo possiamo analizzare alcune tipologie di fon-ti, per evidenziarne le peculiarità e la tipologia di infor-mazioni che possiamo ricavarne.Solitamente per la tipologia di ricerca in oggetto ci av-valiamo di una fonte abbastanza ovvia, quella notarile che nel caso massetano non potrà però fornirci molte informazioni in generale in quanto scarsi sono i proto-colli di notai attivi a Massa e nel contado. Nell’archivio senese si segnalano solo quattro notai attivi nel Quat-trocento per un totale di tredici protocolli (1426-1472) oltre a un protocollo senza data, ma attribuito agli ini-zi del Quattrocento, della cancelleria della comunità di Massa35. A proposito del territorio oggetto della mia ricerca si possono segnalare anche due notai attivi a Travale: Geri di ser Nello da Siena, con un protocollo per il periodo 1364-1373 e Filippo Brunamonti di ser Lorenzo da Ra-dicondoli di cui si conservano dodici protocolli per il periodo 1434-147136. Non risultano protocolli di notai attivi a Massa nel Trecento neppure nel Notarile ante-cosimiano dell’Archivio di Stato di Firenze37. Si conserva invece, nel fondo Principato di Piombino presso l’Archivio di Stato di Firenze, un protocollo notarile trecentesco: ser Neri di Nuccio da Casole, relativo al 135638. Di particolare interesse sono le fonti normative. Massa è celebre per il suo statuto minerario39, il primo d’Eu-
Il Piano di Casalappi. Nella collina a sinistra, la cantina Petra.
I Paesaggi del Vino
128
ropa, mentre scarso interesse sembra aver destato fino ad oggi il Constitutum Comuni et Populi civitatis Massae (del quale il codice minerario costituiva in origine la quarta distinzione). Il codice, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, è databile tra il 1299 e il 1328 e solo la prima distinzione, oltre che la quarta, è stata finora studiata40. Presso l’Archivio di Stato di Siena esistono poi nel fondo Comunità soggette, altre redazioni statutarie la più antica delle quali datata al 1419. Questa redazione si inserisce nel progetto attuato dal Comune di Siena di rendere il più uniformi possibile, pur salvaguardan-done le specificità locali, gli strumenti normativi delle comunità soggette. Il codice è stato recentemente edito e commentato41. Copie di statuti dei secoli XV e XVI esistono anche presso l’Archivio Storico Comunale42. Per questa mia ricerca mi limiterò a prendere in esame la redazione del 1419 in quanto reca le norme per la compilazione dei registi della Lira che, redatti nel 1420, come vedremo, sono ancora conservati in toto e che quindi è possibile analizzarli in maniera comparata43.Negli statuti quattrocenteschi vi sono norme per un’at-tenta regolamentazione della raccolta, frangitura e ven-dita dell’olio, considerato più pregiato anche in ragione dell’importanza del prodotto; per il vino, invece, l’atten-zione del legislatore si è soffermata principalmente sulla vendita al minuto44. Nel mese di gennaio venivano eletti due ufficiali allo scopo di valutare le capacità produttive dei vigneti ed evitare così frodi e adulterazioni da parte dei produttori e venditori45. Il vino veniva posto in ven-dita in contenitori sigillati dal comune con l’indicazio-
ne del nome del venditore e del luogo di produzione. Sembra però emergere una produzione dedita princi-palmente alla sussistenza o comunque a un commercio limitato alle aree circostanti: non esistono, ad esempio, norme annonarie che interessino il vino in periodi di carestia mentre ve ne sono riguardanti i danni causati ai vigneti, analogamente alle altre tipologie arboree46. Esistevano inoltre norme, di carattere ‘protezionistico’ relative all’importazione di vini forestieri: essa era vie-tata dalle calende di settembre alle calende di giugno in città e nelle due miglia circostanti, fatta eccezione per il vino greco (da intendersi come il vino bianco prodotto nel Sud Italia, in genere ad alta gradazione e quindi re-sistente ai trasporti su lunga distanza), quello corso, la malvasia e la vernaccia (tra i vini più diffusi nel Medio-evo), il vino afro e quello montanino.
Di primaria importanza, anche perché prevalentemente inedite, sono le fonti fiscali. Al momento conosciamo poco del sistema fiscale in uso a Massa almeno fino ai primi decenni del Trecento: in quel periodo, analoga-mente a Siena (e forse su impulso della stessa), il comu-ne promosse la redazione di una Lira che doveva censi-re i beni dei cittadini massetani nel contado della città47. Un riferimento all’esistenza di un sistema di allibra-mento lo troviamo già nell’atto di cittadinatico dei Pan-nocchieschi di Pietra; i nobili, Signori di Pietra, erano obbligati a far fazione con gli altri e a sottoporsi all’al-libramento del comune48. I libri più antichi della Lira, purtroppo non si sono conservati.
Massa Marittima e il suo territorio in una vista dal Monteregio.
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni
129
Presso l’Archivio di Stato di Grosseto, è stato recente-mente identificato, da Michele Pellegrini, un consistente frammento della Lira trecentesca relativa al terziere di Borgo49. Dall’analisi della schedatura è stato possibile, tramite raffronti onomastici e topografici, datare la re-dazione agli anni intorno al 1320. Esiste poi una raccolta, attribuita nel proto-inventario del fondo al 148550, ma in realtà composta di sei libri della Lira che si riferiscono alle annate 142051, 1440 e 1485. I cittadini erano ivi censiti in base alla residenza; i volumi, infatti, sono divisi tra abitanti di Cittanuova e di Cittavecchia. Le partite sono organizzate per capifa-miglia e indicano le proprietà immobiliari e fondiarie in
città e nel contado.Dallo statuto del 1419 rileviamo che erano allibrati quanti da oltre dieci anni abitavano in città e ottenuta la cittadinanza svolgevano servizi “realia e personalia”. Non erano allibrati gli habitatores, i forestieri, il clero ed i miserabili; ovviamente, mancano purtroppo anche le proprietà degli enti religiosi assai numerose nel territorio.Ai fini della nostra ricerca ci avvarremo della redazione relativa appunto all’anno 1420. Il codice si compone di due fascicoli completi: uno con le partite fiscali degli abitanti di Cittavecchia, che ammontano a 190; l’altro, relativo agli abitanti di Cittanuova, censisce 174 capifa-miglia per un totale di 364 partite52.
Carta dell’uso del suolo del contado massetano elaborata sulla base degli Estimi del 1420:1 - Costie olivate e orti alberati 2 - Colture specializzate e vigne 3 - Boschi 4 - Sodi e pasture 5 - Aree non caratterizzate
I Paesaggi del Vino
130
Il primo dato che salta all’occhio è la grande diffusione dei vigneti, spesso di minima entità; sul totale delle par-tite oltre il 90% presenta uno o più appezzamenti vita-ti53. Non è possibile evincere però quanto di questo vino fosse destinato al consumo locale e quanto destinato al commercio estero, se esistente. La distribuzione delle terre vitate è abbastanza omogenea e segue una precisa gerarchizzazione degli usi del suolo: le proprietà si con-centrano a Gattorano, Rigalloro, Scabiano e Pozzaione, nel piano sottostante la città, verso il corso del fiume Pecora, dove si trovava anche il Mulino della Comunità (il Mulinpresso) e dove scorrono la Sata e l’Arialla. Al-cune coltivazioni si spingevano fino alle pendici e lun-go il crinale del Montarsenti intorno a un non meglio identificato Palazzetto dei Rossetti (posseduto in quote dalle maggiori famiglie della città e consistente, forse, in una fattoria fortificata). A sud-est della città, in altura, si concentravano nel Piano di Sopra, l’ampio pianoro al di fuori della Porta san Pietro oggi occupato dalle zone di espansione urbana del XX secolo54. È interessante notare che da questo punto di vista le aree di produ-zione del vino sono le stesse delle Lire trecentesche e che si sono mantenute ancor’oggi zone di produzione quantitativamente importanti55. Non mancano vigneti all’interno della cinta muraria, specialmente nelle aree del Pianale, del Moro e ai margini delle case di Cittanuo-va, spesso associati a orti o piccoli campetti promiscui. La presenza di vigneti urbani si riscontra anche nella cartografia storica, anche se di qualche secolo più tarda: nella carta del capitano Serafino Burali (1664, vedi co-pertina), nell’area sottostante il Monteregio e la fortezza senese, sono ben distinguibili alcuni pergolati.Nel centro urbano di Massa si contano solo sei cantine, più tre ricavabili dalle confinazioni di proprietà di enti religiosi. Quattro di esse sono nella Cittavecchia e due nella nuova; in quattro casi i proprietari possiedono vi-gneti: Lunardo da Castro abita in borgo, ma ha un celliere nel Terzo del Mezzo e un vigna alla Satella; Niccolaio di Marchione di ser Francesco possiede una casa nel Mez-zo con cantina e due vigne di cui una al palazzo; Bugho-lino di Cerbone ha un celliere sotto la casa di Giovanni di Cerbone del Troglio in Cittanuova e due appezzamenti vitati in San Giusto e in Gattorano; infine, Antonio di Cerbone del Troglio, che ha una casa anch’egli in Cit-tanuova con cantina, possiede una vigna alla Piana, una alla Sata e una al Guadaluccio56.
Le trasformazioni del paesaggio alla fine del Medioevo
In generale penso di poter confermare quanto già di-mostrato in alcuni lavori precedenti: la Maremma, di cui Massa è l’espressione principale, in pieno Medioevo aveva una connotazione diversa da quella che poi la ca-ratterizzerà nel corso dell’Età Moderna e che si è fissata in maniera indelebile nella nostra memoria collettiva57.
La Maremma due-trecentesca era, infatti, un’area dina-mica e ricca, con un potenziale strategico notevole. Il cambiamento politico ed economico si riflesse anche sul paesaggio: da un tessuto di produzione specializza-te ad alto reddito, come poteva essere la vite, si passò alla produzione diffusa di grano e a un sistema agricolo basato sull’incolto e sul sodo da destinare al pascolo; le colture specializzate, vite e in misura minore olivo, destinate al fabbisogno locale, vennero limitate alle aree immediatamente circostanti la città (se non addirittura all’ambito urbano), creando di conseguenza una gerar-chia degli spazi e dell’uso del suolo. Il caso precedente-mente esaminato del Piano di Casalappi è esemplare: lo spopolamento e l’abbandono delle coltivazioni specia-lizzate trasformarono quest’area, vocata a vigneti, in un immenso pascolo con molte aree di incolto, spostando la produzione vitivinicola nelle più immediate vicinanze di Suvereto, dove ancora oggi si concentra la quasi tota-lità della produzione.La Maremma successiva al XIV secolo corrisponde effettivamente al ritratto che ne fa Giuliano Pinto nel tracciare le vicende economiche della Toscana tardo-medievale58. Lo storico divide la Toscana in tre ma-cro-regioni che presentano caratteristiche abbastanza diverse dal punto di vista degli insediamenti, del popo-lamento e delle strutture socio-economiche59. Nel XV secolo il territorio maremmano si caratterizzava per una maglia insediativa larga, priva di insediamenti diffusi, con una modesta popolazione accentrata in castelli di altura spesso distanti tra loro e una struttura economica basata sullo sfruttamento dell’agricoltura e sull’alleva-mento. In quel periodo la Maremma era l’area della re-gione a minor densità (4-6 abitanti per km2).
Gli estimi di Massa del 1420 riportano una popolazione di circa 2500 abitanti, considerando anche la forte im-migrazione con habitatores che difficilmente soggiorna-vano nella città per i dieci anni previsti dagli statuti per ottenere la cittadinanza ed essere allibrati60.La scarsa popolazione determinava anche una prepon-deranza dell’incolto e del bosco rispetto alle coltivazioni intensive, relegate ai margini della città o addirittura al proprio interno61. La situazione era aggravata da una strutturale carenza di vie di comunicazione e lontananza dai luoghi di mercato. La pur presente cerealicoltura era destinata quasi in via esclusiva a rifornire Siena, città nel cui contado la Maremma si trovava ormai stabilmente. Le poche coltivazioni remunerative, così come l’alleva-mento e le nuove estrazioni minerarie (allume in spe-cial modo), erano gestite e finanziate da capitali citta-dini (senesi e fiorentini prevalentemente) con scarsa o nessuna ricaduta sull’economia del territorio. Nel suo incisivo saggio sul vicino centro di Suvereto, Isabelle Chabot ha ben connotato questa terra come in costante carenza di uomini62.
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni
131
È sempre Pinto, l’unico studioso che abbia dedicato a questo territorio un’accurata disamina per il periodo tardo-medievale, ad assimilare la Maremma al Meridio-ne d’Italia per la prevalenza di strutture arcaiche, facen-do risalire tale degrado al crollo dell’impero romano, dopo il quale la situazione si sarebbe cristallizzata per giungere poi fino a giorni a noi vicini63.In sintesi, la Maremma era una terra ricca di risorse ma con difficili condizioni ambientali, aggravate dalla mancanza di uomini e di capitali che ne impediva uno sfruttamento adeguato. L’immigrazione, spesso tempo-ranea, era anche foriera di forti conflitti sociali con le popolazioni indigene64.
Le vigne di Elisa
Facciamo un notevole balzo in avanti, per arrivare alla soglia della modernità, quando anche in Alta Maremma ebbe inizio la produzione vitivinicola di qualità.Nel 1805 Napoleone affidò il governo del principato di Piombino alla sorella Elisa, sposa di Felice Bacioc-chi, che lo resse fino al 1814. L’azione di governo di
Elisa fu improntata al rinnovamento e alla moderniz-zazione dello stato mediante lo sviluppo delle attività imprenditoriali, la cura delle infrastrutture e del territo-rio, le bonifiche e le innovazioni sanitarie, giuridiche ed economiche tra cui il forte impulso allo sfruttamento minerario dell’allume a Montioni sotto la direzione del francese Louis Porte (Marsiglia 1799-Firenze 1841)65.Quest’ultimo intendeva associare all’azienda mine-raria e al villaggio dei lavoranti (oltre 400, per lo più stagionali provenienti dagli Appennini tosco-emiliani) anche un’azienda agricola, con lo scopo di rendere più confortevole la permanenza a Montioni e garantire la creazione di una colonia – stabilizzando gli immigrati stagionali - oltre che integrare l’attività dei lavoranti alla miniera con quella degli agricoltori. Porte voleva inoltre che l’azienda agricola fosse in grado di produrre vino, olio, castagne, frutta, gelsi e di allevare cavalli, bovini e suini.Nel 1808 la principessa decise di dare nuovo impulso alla produzione vitivinicola cercando di impiantare nel principato nuove qualità e nuovi metodi di coltivazio-ne. Nel territorio furono inviati vitigni francesi, quelli
Carta d’insieme su base Catasto Leopoldino. Sono tratteggiate le aree occupate dai vigneti.A - Piazza monumentale del villaggio minerario V - Palazzo della Vigna sede della Fattoria
I Paesaggi del Vino
132
che entravano nella composizione dei crus più rinomati: lo champagne (direttamente dall’azienda di Jean-Rèmy Moët), i vini di bordeaux e quelli di Borgogna, prove-nienti dall’orto botanico di Marsiglia. I tentativi di im-pianto interessarono la capitale dello stato, Piombino, e in misura più ampia Montioni, dove fu impiantato un moderno vigneto all’uso di bordeaux che si estendeva per una superficie di circa 5 ettari66. Nello stesso anno Elisa poteva annunciare al fratello Napoleone, tra i po-sitivi esiti ottenuti dal suo governo per lo sviluppo del territorio, il successo dei nuovi vigneti67. Nel 1821, data delle prime rilevazioni catastali, i vigneti risultavano ancora in produzione e in parte in proprietà di importanti esponenti del ex-governo francese quali Luois Porte e Giacomo Leblanc (a suo tempo gover-natore dello stato di Piombino)68. Conoscendo il luogo dell’impianto sarebbe interessante una ricerca sul cam-po per capire se siano rintracciabili cloni dei vitigni del tempo: si tratterebbe di una buona opportunità per lo sviluppo della biostoria del territorio, nonché di uno strumento di promozione delle attuali produzioni vi-tivinicole.
Note
1 [01.04.15] http://www.paliodisuvereto.it/le_origini_storiche.html 2 Claudio Rutilio NamaNziaNo, De redito suo, su Populonia vedi vv. 401-414. Per l’edizione italiana cfr. Il ritorno a cura di A. Fo, Einaudi, Torino, 1992.3 A cura di A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero, All’insegna del Giglio Firenze, Firenze, 2012; Sulle problematiche metodo-logiche si rimanda al saggio di E. GiaNNiChEdda, Tempi lunghi per l’archeologia del vino, nel suddetto volume alle pp. 33-39.4 Ibidem, pp. 635-705.5 m. GiaNNaCE, I comprensori indagati nel 2005: l’alta valle dell’Om-brone (Siena), l’Alta Val d’Elsa (Siena), la Val d’Orcia (Siena), la bassa Val di Cornia (Livorno), l’alta valle dell’Albegna (Grosseto), in Archeologia della Vite e del Vino, pp. 493-516:504-507; per la valle dell’Albegna vedi anche m. FiRmati. P. RENdiNi, a. ziF-FERERo, La valle del vino etrusco. Archeologia della valle dell’Albegna in età arcaica, Effigi, Arcidosso, 2011.6 GiaNNaCE, I comprensori, p. 507. 7 «in loco monte non multo longe ad civitate que vocitatur Populonia».8 m. PaPERiNi, La signoria del vescovo di Massa in Maremma. In-sediamenti e risorse in Studi di storia degli insediamenti in onore di Gabriella Garzella, a cura di E. Salvatori, Pacini, Pisa, 2014, pp. 199-215.9 m. l. CECCaRElli lEmut, Castelli, monasteri e chiese del territorio di Populonia e Piombino nel Medioevo, in Populonia e Piombino in età medievale e moderna, a cura di M.L.Ceccarelli Lemut – G. Garzella, Pacini, Pisa, 1996, pp.17-36:19-20.10 I risultati dello scavo non sono ancora stati pubblicati. Al momento si rimanda al sito del Laboratorio di Archeologia di Grosseto: http://www.archeogr.unisi.it/CCGBA/labora-tori/laaum/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=103.11 Archivio di Stato di Firenze [d’ora in avanti ASFi], Diplo-matico Riformagioni Atti pubblici, 1029 gennaio 3. Il cartulario è stato edito la prima volta da a. GioRGEtti, Il cartulario del monastero di S. Quirico a Populonia, «Archivio Storico Italiano», s. III, XVII (1873), pp. 397-415; XVIII, pp. 209-224, pp. 354-370 e, «Archivio Storico Italiano», s. III, XX (1874), pp. 3-18; 212-227. Recentemente l’opera del Giorgetti è stata riedita, con introduzione critica e indici a cura di R. Belcari: a. GioR-GEtti, Il cartulario del monastero di San Quirico a Populonia, Archi-vinform, Venturina, 2010.12 Sul sistema curtese in Val di Cornia e su Casalappi in par-ticolare vedi m.l. CECCaRElli lEmut, Scarlino: le vicende me-dioevali fino al 1399 in Scarlino. Storia e territorio, a cura di R. Francovich, All’insegna del Giglio, Firenze, 1985, pp. 26-42; Per l’area tra Suvereto e Sassetta vedi m. PaPERiNi, Suvereto. Contributo alla storia di un comune rurale maremmano (XII-XIV secolo), Debatte, Livorno, 2012, pp. 132-134.13 GioRGEtti, doc. 2 Cartula da Loco Lungo et da Sambucheto (1035, 17 aprile); Per Calzalunga vedi Paperini, pp. 135-138 A quest’area possiamo attribuire anche l’atto 33, Cartula de Morcolatico prope Murum Longum (1117, 14 marzo).14 Ibidem, doc. 3 Da Castagneto (1045, 26 febbraio).15 Ibidem, doc. 4 Cartula da Burdi in Cornino (1049, 2 gennaio) e doc. 5 Cartula da Burdi in Cornino (1049, 3 gennaio). La località Burdi risulta confinante con Quercia Grossa, a occidente del fiume Cornia e con Pietrafitta (vedi doc. 25 cartula da Petra-ficta et da Quercia Grossa et da Corbellaio, possedimento degli
Portrait en buste di Elisa Bonaparte, Pietro Benvenuti (1769-1844).
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni
133
Aldobrandeschi dove nel XIV secolo si trovavano i pascoli comunicativi di Suvereto oggetto di un intervento del signore di Piombino Ritengo sia possibile localizzare anch’essi nei pressi di Casalappi, al tempo nel territorio di Suvereto. cfr. PaPERiNi, Suvereto, pp. 97-100.16 GioRGEtti, doc. 8 Cartula da s. Fridiano (1055, 26 agosto).17 Ibidem, doc. 7 Cartula da s. Fridiano (1050, 5 marzo).18 Ibidem, doc. 12 Cartula de Casalappi et da Curte Albertinga (1073, 7 gennaio).19 Ibidem, doc. 13 Cartula de Livellaria (1074, 10 dicembre).20 Ibidem, doc. 21 Cartula de Livellaria (1084, 30 maggio).21 Ibidem, doc. 18 Cartula de Parentorum prope Livellaria et de Ca-fagio (1079, 4 novembre) con questa carta è Gisla vedova del già citato Saracino a donare, con il consenso dei suoi monualdi, i terreni al monastero; doc. 19 Cartula de Livellaria de ecclesia et una petia de vinea ubi dicitur fossa Paterni (1079, 6 novembre); doc. 22 Cartula de Casalappi, da Livellaria et da S. Maria in Campo prope ipsa ecclesia (1084, 2 giugno): la vigna posta a Livellaria confina con un altro vigneto dei figli del fu Sturmulo; il doc. 35 libello dei Bai da Livellaria (1121, 15 gennaio) concerne la cessione di «una petia de terra super se vineam habentem» in enfiteusi a Martino, Villano, Calendo e Giovanni figli del fu Bai dietro il pagamento di una pensione, da versarsi ogni anno nel mese di luglio presso il monastero, pari a 12 denari lucchesi; doc. 46 De Livellaria de tres petti de terris et Vineis. Una est in Ribocco (1128, 20 febbraio) in questo atto sono due appezzamenti su tre ad essere coltivati a vitigni, uno a Livellaria, confinante con la vigna di Goffredo e l’altro a Ribocco, località sul fiu-me Cornia nei pressi dell’attuale borgo di S. Lorenzo (com. Suvereto). Ancora a Livellaria si riferisce la vendita fatta al monastero da Lamberto del fu Guido e Ugo del fu Uberto di tutte le terre lì poste insieme alla chiesa di S. Cristoforo ove si trovavano «omibus terris et vineis donicatis et massariciis nostris», cfr. doc. 30 Cartula de Livellaria de Ecclesia s. Christofori (1106, agosto).Alle pertinenze di Casalappi si riferisce anche una «terra vinea» che Ugo del fu Coruccio vende a Benigno monaco di San Quirico e posta «in loco qui Rachinaldi nominatur», confinante con la Cornia morta: cfr. doc. 38 Cartula da Rachi-naldi (1121, 10 febbraio).22 Ibidem, doc. 9 Da Suvereto da Monticelli prope ecclesia S. Do-nati (1058, 13 marzo); il documento successivo è la promissa del venditore di non disturbare l’acquirente nel possesso del terreno.23 Su Valli, castello che nel XII secolo entrerà a far parte della signoria del vescovo di Massa vedi PaPERiNi, La signoria del vescovo di Massa, pp. 205-208.24 GioRGEtti, doc. 26 Cartula da Casalappi de Sedio Martini de le donne.25 Sul castello di Biserno cfr. m.l. CECCaRElli lEmut, Ricerca storica in Campiglia. Un castello e il suo territorio, a cura di G. Bian-chi, All’insegna del Giglio, Firenze, 2003, pp. 59-73.26 GioRGEtti, doc. 17, Da Castagneto (1079, 28 aprile). 27 Ibidem, doc. 11 Da Biserno (1063, 8 giugno).28 Ibidem, doc. 23 Da Biserno. Repromissio Amiculi (1085, 2 giugno).29 Ibidem, doc. 24 Cartula da Biserno (1088, 25 gennaio).30 Ibidem, doc. 39 Da Monte Maccajo a Suvereto (1121, marzo), il documento succede alla donazione che gli stessi conti aveva-no fatto al monastero della corte di Franciana (non distante da Casalappi, lungo la costa).31 Archivio Storico Città di Piombino, Fondo Cardarelli, bu-sta 10, fasc. 1; Romualdo Carderelli nella sua schedatura di
documenti per la storia della Maremma cita in questo caso da A.Malard (p.229). Sulle attività portuali di Piombino, sca-lo di riferimento per l’Alta Maremma vedi m.l. CECCaRElli lEmut, Tre porti un promontorio in Il porto di Piombino tra storia e sviluppo futuro, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut et alii, Pacini, Pisa, 2014, pp. 30-49 e nello stesso volume il saggio di G. GaRzElla - o. VaCCaRi, Piombino tra Pisa e gli Appiani: un porto strategico nella Toscana medievale e rinascimentale, pp. 53-71, dove però non si fa cenno al vino tra i prodotti che transitavano per lo scalo piombinese.32 Edita in appendice a I segni di Elisa. Scienza e governo del terri-torio nel Principato napoleonico di Piombino, catalogo della mostra Piombino-Suvereto 2006, a cura di T. Arrigoni, Felici, Pisa, 2006, pp. 147-160: 149. La produzione vitivinicola è riferita, per quanto riguarda il Principato, solo all’Isola d’Elba «fe-conda di vino, che dagli isolani si smercia in Terraferma, e in Genova, e in Francia», Ivi, p. 153.33 Per la situazione delle fonti storiche cfr. m. PaPERiNi, Massa di Maremma. Dalla signoria vescovile all’affermazione del comune (XI-XIII secolo), Tesi di dottorato in Storia Medievale, Università di Firenze, XXV ciclo, tutor: S. Carocci, in part. pp. 10-37.34 Il progetto è in corso, a cura del sottoscritto e della collega Giulia Galeotti. Per i dettagli cfr. G. GalEotti – m. PaPERiNi, Un progetto per la storia del paesaggio nell’antico contado di Massa di Maremma in Città e territorio. Conoscenza, tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali, a cura di G. Galeotti – M. Paperini, Debatte/Centro Studi Città e Territorio, Livorno, 2013, pp. 12-15. I beneficiari primi di questo lavoro saranno, oltre a gli stu-diosi e gli addetti ai lavori, gli enti locali che avranno a dispo-sizione uno strumento di conoscenza del proprio territorio utile alla pianificazione e alla promozione delle tipicità e del turismo culturale ed ecosostenibile. Anche per i cittadini e per gli operatori che quotidianamente vivono e fruiscono il territorio sarà un valido strumento per rafforzare la propria identità in rapporto (e non contrapposizione) con le reti di conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio storico che interessano tutta la regione. Per le nuove generazioni questo centro di documentazione virtuale sarà poi il serbatoio di memoria collettiva dove ritrovare il senso delle proprie origini, la co-noscenza del divenire storico che caratterizza ogni paesaggio e quindi la consapevolezza della grande risorsa culturale (ed economica) di cui disponiamo.35 Archivio di Stato di Siena [d’ora in avanti ASSi], Notarile ante-cosimiano, n° 323; 343-6; 406; 469-74;486.36 ASSi, Notarile ante-cosimiano, n° 173; 393-404.37 M. ButElli, Documenti notarili della Maremma medievale e mo-derna, in La costa maremmana: uomo e ambiente tra medioevo ed età moderna Atti dei convegni dell’Archivio di Stato di Grosseto, a cura di m. Paperini, Debatte, Livorno, 2009, pp. 27-34.38 ASFi, Principato di Piombino, Amministrazione centrale, appendice II, n° 11. Il volume riporta anche un protocollo del periodo 1429-1430; Al n° 10 dello stesso fondo è segnalato il proto-collo di Antonio di Piero, attivo a Massa per il periodo 1438-1461. Cfr. B. CasiNi, Guida inventario degli Archivi del Principato di Piombino, Piombino s.e., 1971, p.46.39 Europaisches bergrecht in der Toscana: die Ordinamenta von Massa Marittima im 13. und 14. Jahrhundert / hrsg. und mit einer Einlei-tung versehen von Dieter Hagermann und Karl-Heinz Ludwig, Koln, 1991. Per l’edizione con apparato fotografico del codice cfr. Ordi-namenta super arte fossarum ramerie et argenterie civitatis Massae, a cura della Deputazione di Storia Patria della Toscana, Firen-
I Paesaggi del Vino
134
re 140 capi vaccini bradi, 140 porci, 800 fra pecore e capre, 12 cavalli, 5 buoi domati, 6 bufali e 1 somaro), possedeva due vigneti (uno nei pressi della Sata e uno in Tebaldadico) più metà di una vigna al Palazzo dei Rossetti per un totale di poco meno 20 ha contro venti appezzamenti di terra, pre-valentemente a sodo e bosco, per 100 ha, e numerose case e botteghe in città ripartite su tutti e tre i Terzieri.54 La presenza nell’area del Piano di Sopra subito fuori da Porta S. Pietro di numerosi casalini addossati alle mura e lunga la via comunale fanno pensare ad un progetto di espansione edilizia, forse collegato alla realizzazione della Cittanuova e mai completato.55 staRaCE, Nuovi dati su Massa Marittima, pp. 22-31. Le aree di maggior concentrazione di vigneti sono: Fonte Giallinga, Palazzetto, Pozzarone (Pozzaione), Rialla, Sata, Scabiano, Te-baldatico e Termignone.56 Giovanni di Cerbone del Troglio possedeva anche un ver-rocchio in Cittanuova.57 PaPERiNi, Suvereto; id., Per una ‘nuova’ storia di Massa di Ma-remma e del suo contado nel Medioevo, in Città e Territorio, pp. 40-49; id., Suvereto dal dominio Pisano allo stato di Piombino, in Il museo d’arte sacra di Suvereto, a cura di M.T. Lazzarini, c.s.58 G. PiNto, La Toscana nel tardo Medio evo. Ambiente, economia rurale e società, Firenze, 1982.59 Ibidem, pp. 41-66, a cui mi riferirò più volte nella trattazione descrivendo la Maremma tardo-medievale.60 Ci riferiamo agli statuti del 1419: cfr. Statuta. Sulla base degli estimi, Pinto calcola una popolazione di 1600 individui, ma il riferimento a 700 fuochi nel 1565 citati nella documentazione fiorentina, corrispondenti a una popolazione di circa 2000 individui in un periodo di ulteriore calo demografico, ci porta a considerare più corretto questo dato che inoltre è in linea con quello dei 10.000 abitanti da me prospettato in PaPERi-Ni, Massa di Maremma, pp. 1-9. Il riferimento fiorentino è in ASFi, Otto di Balia, response 83 c. 376 citato da Cardarelli fasc. CXCIV c. 71 (in Archivio Storico della Città di Piombino).61 I già citati estimi ci informano sull’esistenza in ambito urbano, oltre che di orti, anche di olivete e vigneti, nonché fienili e granai.62 i. ChaBot, Una terra senza uomini. Suvereto in Maremma dal XVI al XIX secolo, Marsilio, Venezia, 1997.63 PiNto, La Toscana, p. 67. L’autore è ritornato su queste sue convinzioni anche nel recente saggio Qualche considerazioni sul-la storia della Maremma dal Medioevo all’età delle bonifiche, in Città e Territorio, pp. 25-29.64 Vedi, ad esempio, il caso del vicino castello di Scarlino, luo-go prediletto dagli immigrati nel principato di Piombino: si trattava prevalentemente di ebrei, còrsi, tedeschi e altri immi-grati provenienti dallo Stato della Chiesa, che ebbero scontri, anche cruenti, con la popolazione locale. Cfr M. PaPERiNi, Fonti per la storia degli ebrei nel Principato di Piombino (1399-1634), in «Registro delle lezioni» I 2010, pp. 123-129.65 Su Montioni nel Medioevo vedi PaPERiNi, La signoria del ve-scovo di Massa, pp. 208-209. Sul villaggio minerario vedi Leggere il territorio. Montioni, storia e beni culturali in Alta Maremma, a cura di M. Paperini, Felici, Pisa, 2009.66 G. BiaGioli, Le vigne di Elisa, in I segni di Elisa, pp. 77-81.67 Ivi, p. 81.68 Sulla probabile collocazione dei vigneti vedi m. PaPERiNi, Prime indagini di archeologia industriale a Montioni: il villaggio indu-striale, in Leggere il territorio, pp. 49-62:60-62.
ze, 1938 rist. a cura della provincia di Grosseto s.d.. L’intro-duzione è di N. Rodolico, pp. 7-25.40 P. BiNi, L’ordinamento costituzionale del comune di Massa Marit-tima nel “Constitutum Comuni et Populi civitatis Massae”, Tesi di Laurea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze A.A. 1981-82; E. BaRtoliNi, Il codice degli statuti di Massa marittima esistente nell’Archivio di Stato di Firenze, Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Pisa A.A. 1960-61, rel. E. Cristiani. Lo statuto è collocato in ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 434. Attualmente è in corso l’edizione dello statuto a cura del sottoscritto e di I. Del Punta.41 Statuta Communis et Populi civitatis Masse a. D. 1419, a cura di B. Cillerai-M. Sozzi, Laurum, Pitigliano, 2009.42 Archivio Comunale Massa Marittima, Statuti, I, Statuti e ordini del comune e popolo della città di Massa (XV sec.); II, Statuti del danno dato (1590); III, Statutorum magnificae civitatis Massae (1746).43 Statuta, pp. 99-10. 44 Ad esempio, il divieto di vendita di due qualità diverse di vino e il divieto di mescita nel giorno del Venerdì Santo. Cfr. Statuta, pp. 454-5, Quod nemo vendant duo vina rubea vel duo alba eodem tempore, capitulo CVI e p. 561-2, De tabernariis, hospitibus et vinaiuolis, capitulo CLXI. 45 Cfr. Statuta, pp. 441-2, De electione duorum civium ad mensuran-dum vegetes, capitulo LXXXXIII.46 De pena incidentis vineam vel arbores alicuis, capitulo CXIII, cfr. Statuta, p. 537; De pena dantis aliquod damnum vel guastum. Capi-tulo CXV, cfr. Statuta, pp. 537-8.47 Dagli atti riguardanti la lunga questione che vide opposti il comune di Massa e i Signori di Piombino circa il possesso dei castelli di Valli e Montioni, apprendiamo che nel 1319 una commissione di ufficiali deputati dal comune aveva sti-mato i beni dei cittadini massetani. Cfr. a. CEsaREtti, Istoria del principato di Piombino e osservazioni sopra i diritti della corona di Toscana sopra i castelli di Montioni e Valle, Firenze, 1788, rist. anast. Bologna, Forni, 1974, t. II, p. 159. Nel caso specifico, gli estimi della famiglia Todini non poterono essere utilizzati in quando non redatti dal cancelliere della comunità e relativi a beni sottoposti ad altra giurisdizione. Cfr. R. dEl GRatta, Giovan Battista de Luca e gli Statuti di Piombino, Napoli, ESI, 1985, pp. 85-93: p. 88. Per i Todini vedi PaPERiNi, Massa di Maremma, pp.141-145.48 ASSi, Riformagioni Massa, 1328 nov. 8.49 Si tratta di un frammento composto da quattro fascicoli relativi alle lettere A-L (esclusa la E), contenente 289 unità fiscali riguardanti il terziere di Borgo. Cfr. M. staRaCE, Nuovi dati su Massa Marittima nel Trecento. Analisi del frammento di un estimo massetano nell’Archivio di Stato di Grosseto. Tesi di laurea in Conservazione, Gestione e Comunicazione dei Beni Archeo-logici. a.a. 2010-2011, rel. M. Pellegrini.50 ASGr, Estimi, Massa Marittima, n° 285.51 La schedatura del volume e la creazione di un data base ono-mastico, toponomastico e topografico, realizzato insieme alla dott.ssa Giulia Galeotti, ci permettono di confermare la reda-zione del volume all’anno 1420, così come vuole la tradizione erudita locale.52 Da segnalare il confronto con il frammento di cui alla nota 49. Il totale di tutti gli allibrati della città nel 1420 è di poco superiore a quelli presenti nel fascicolo del terziere di Borgo, redatto appena un secolo prima.53 Ad esempio, il più grande proprietario fondiario della città, Giovanni di Geri di Dozzo, allevatore (dichiarava di possede-
305
Indice
Presentazioni .....................................................................................................................................................................
Cinzia Cortinovis ................................................................................................................................................................ Nicoletta Noris ...................................................................................................................................................................
Introduzioni .......................................................................................................................................................................
I Paesaggi del Vino, paesaggi multidisciplinariGiulia Galeotti - Marco Paperini ......................................................................................................................................
Agricoltura, architettura, territorio, paesaggio, sostenibilitàEdoardo Milesi ...................................................................................................................................................................
PrefazionePaesaggi del vino, territorio e sviluppo ruraleRossano Pazzagli ..................................................................................................................................................................
Parte I: Agricoltura biologica e prospettive future, tecniche, imprese e comunicazione ...........................
Etica e Bussines nella comunicazione del territorioSilvia Bernardini ...................................................................................................................................................................
Verso la collina verde: le esperienze dell’azienda “Le Corne” di Grumello del Monte Paolo Bonardi .......................................................................................................................................................................
Il contributo della formazione scolasticaNadia Baldini ........................................................................................................................................................................
Paesaggi vitivinicoli e la viva testimonianza del sapereFrancesco Iacono - Luigi De Micheli ...............................................................................................................................
Parte II: Fonti e storia del Paesaggio del Vino nel Medioevo .............................................................................
Il paeaggio della vite nella Liguria medievale. Secoli X-XIIICarlo Moggia ........................................................................................................................................................................
Fonti per la storia del commercio dei vini nel tardo MedioevoIgnazio Del Punta ................................................................................................................................................................
“Tracanno la bevanda salutare in terra straniera”. La cultura del vino nel paesaggio islamico medievaleAlessandro Angelucci ...........................................................................................................................................................
5
79
11
12
16
20
31
32
36
40
46
51
52
64
74
306306
Indice
306306
Uva miniata. Rappresentazioni vitivinicole nei manoscritti medievaliChiara Meistro ......................................................................................................................................................................
Produzione e consumo di vino nelle comunità medievali della bergamasca: appunti dagli statutiGian Paolo Giuseppe Scharf..............................................................................................................................................
Parte III - Paesaggi del Vino: storia e trasformazioni ..........................................................................................
Riuso di-vino. Il ‘Palmento’ rinvenuto nelle cisterne romane di FermoAlessia Maiolatesi ...............................................................................................................................................................
Vineas foram porta Sancti Sebastiani. L’uso del suolo nel suburbio sud-est di Roma attraverso la cartografia storicaAngela Paolini ......................................................................................................................................................................
Fonti per la storia del paesaggio del vino in Alta Maremma. Dal Medioevo alle ‘Vigne di Elisa’, una proposta di ricercaMarco Paperini ....................................................................................................................................................................
I paesaggi del vino nella Sibaritide tra antichità ed età contemporaneaRossella Schiavonea Scavello ..............................................................................................................................................
Il paesaggio vitivinicolo della Toscana attraverso gli archivi aziendali: nuovi percorsi di ricercaArianna Brazzale .................................................................................................................................................................
Personaggi e paesaggi del vino: il ritratto di Nino di Andrea ZanzottoMaria Pia Arpioni ...............................................................................................................................................................
Parte IV - Conoscenza, tutela e valorizzazione .......................................................................................................
Quale identità per i paesaggi storici del vino? Una riflessione sulle ‘terre del Prosecco’Angelica Dal Pozzo .............................................................................................................................................................
Il sito Unesco ‘I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato’Marco Valle - Martina Ramella Gal ..................................................................................................................................
Terroirs e paesaggi del vino nelle Alpi LiguriAlessandro Carassale............................................................................................................................................................
PPP - Parco Pubblico Produttivo. Proposta di una nuova tipologia di verde pubblico urbanoSara Lanzini ..........................................................................................................................................................................
Il Territorio di Locossano con le bici lungo i sentieri del vino e dell’olio. Realizzazione di percorsi tematici tra tradizione e tecnologiaMichele Di Stasio – Daniela Stroffolino ..........................................................................................................................
Parte V - Architettura e progetti nei Paesaggi del Vino .......................................................................................
La cantina ‘visibile’: la scelta progettualeMarco Marchetti ..................................................................................................................................................................
Nòah. Progetto per una cantina ad Altavilla IrpiniaFabrizio F. V. Arrigoni ........................................................................................................................................................
82
96
105
106
114
122
136
144
154
165
166
176
186
194
204
213
214
220
307
Indice
L’architettura del vino in IrpiniaDaniela Stroffolino – Michele Di Stasio .........................................................................................................................
Agricoltura eroica: il caso della Costa Viola. La forma dei terrazzi, lettura territoriale e percezioneSara Maria Serafini ..............................................................................................................................................................
Alla ricerca di una nuova architettura rurale Edoardo Milesi - Giulia Anna Milesi ...............................................................................................................................
Parte VI - Governare i Paesaggi del Vino..................................................................................................................
Un territorio patrimonio dell’umanità: Nizza Monferrato e i paesaggi vitivinicoli del BarberaMichela Scaglione ...............................................................................................................................................................
Le esperienze del parco artistico “Orme su la Court”Laura Botto Chiarlo - Michela Scaglione ........................................................................................................................
Progettare il paesaggio, governare il territorio. Il piano regolatore delle Città del VinoGianpaolo Pioli ...................................................................................................................................................................
Prodotto e comunicazione turistica nei Paesaggi del Vino Ario Locci ............................................................................................................................................................................
Bibliografia ........................................................................................................................................................................
Profilo dei curatori e degli autori ................................................................................................................................
228
238
244
253
254
264
272
278
287
299
309
Per conoscere le attività e le pubblicazioni del Centro Studi Città e Territorio:www.cittaeterritorio.org
La collana ‘Confronti’
Prossime uscite
7 - I Paesaggi del sottosuolo. Paesaggi geologici, archeologici, minerari e delle acque8 - Medioevo in Formazione. Studi storici e multidisciplinarità 9 - Romanico Piemontese - Europa Romanica. Architetture, circolazione di idee e uomini, paesaggi10 - I Paesaggi minerari. La bonifica e messa in sicurezza dei siti minerari
Città_Territorio CentroStudi
La collana ‘Confronti’ si propone di raccogliere esperienze e progetti sviluppati in Italia e all’estero al fine di promuovere studi riguardanti paesaggio e società con un particolare taglio multidisciplinare e transdisciplinare, e quindi favorire il confronto tra le discipline e le metodologie.La collana è curata dal Centro Studi Città e Territorio e pubblica al proprio interno raccolte di saggi su tematiche che riguardano la storia, l’archeologia, l’architettura e il paesaggio. La scelta dei contributi avviene sotto la supervi-sione del comitato scientifico del Centro Studi e di appositi gruppi di referee esterni selezionati in base alle tematiche e discipline presenti in ogni singolo volume.
Volumi editi