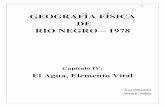L'acqua, elemento di costruzione del paesaggio di Bottinaccio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'acqua, elemento di costruzione del paesaggio di Bottinaccio
L’ACQUA, ELEMENTO DI COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO DI BOTTINACCIO1. Il villaggio di Bottinaccio è ubicato sulla collina di Montecastello (quota 263 m.s.l.m.) sul confine NordOvest del territorio comunale di Montespertoli. Il rilievo fa parte del sistema collinare delineato a SudOvest dal torrente Orme tributario dell’Arno e a NordEst dal torrente Turbone affluente della Pesa; la collina è nettamente divisa dal resto del territorio anche sul versante Sud dal borro del Vallone. In direzione Nord il colle degrada sul pianoro di San Piero (l’antica S. Pietro a Nebiaula) nel territorio del comune di Montelupo.Tutta l’area è caratterizzata da una struttura geologica di formazione alluvionale risalente al Pliocene medio (da 5 a 2,5 milioni di anni fa) ed è costituita da banchi di conglomerato di ciottoli (‘grotte’), strati di sabbia talvolta mista a ciottoli di minuta granulometria (‘tufi’ e ‘spugne’) ed estese lenti di argilla. Dal versante Ovest di Montecastello originano il rio Val di Botte e il rio Tomba di Berto che sfociano in Arno dopo aver attraversato la piana empolese con il nome di rio della Piovola e rio Grande di Sammontana; sul versante Est del colle confluiscono nel Turbone il rio del Borro dei frati, il rio del Lastrino e il rio del Bucignone. Il borgo di Bottinaccio, insieme a Case San Matteo sul versante Sud, è l’unico agglomerato presente sulla collina al cui apice si trova la villa-fattoria di Montecastello. L’altra emergenza architettonica significativa del luogo, il secentesco Santuario di Santa Maria della Pace con annesso l’ex Convento francescano, è situato sul pianoro Sud.2 Tutti i versanti della collina sono punteggiati dalle case coloniche che facevano capo ai diversi poderi della Tenuta Frescobaldi e del Patrimonio della chiesa di S. Andrea. La ricerca, condotta alcuni anni or sono da chi scrive, sulle fonti di approvvigionamento idrico del borgo rurale di Bottinaccio, ha evidenziato l’importanza assunta nel corso degli ultimi due secoli dalla gestione accurata e sapiente dell’acqua.3 La collina di Bottinaccio all’inizio dell’Ottocento era marcatamente segnata dal tipico paesaggio della coltura promiscua, qui caratterizzato anche dalla consistente presenza di boschi, arbusteti e terreni ‘sodi’. Lo scarso controllo delle acque meteoriche aveva provocato nel corso del tempo fenomeni di dilavamento dei suoli, smottamenti e frane. Dalla terza decade dell’Ottocento, in seguito a consistenti lavori di miglioramento fondiario nei due patrimoni che egemonizzavano l’area, si perfezionò a Bottinaccio un sistema di approvvigionamento e drenaggio delle acque che soddisfaceva il fabbisogno della comunità rurale e contribuiva alla tutela e al governo del territorio, trasformando l’acqua in un importante agente di domesticazione e costruzione del paesaggio. Per funzionare in modo efficace il sistema aveva bisogno di supervisione attenta e assidua manutenzione, prestazioni di manodopera onerose in termini di ore di lavoro che potevano essere assicurate solo dal modello economico mezzadrile e più in generale dal sistema di fattoria. Il paesaggio ottocentesco subì una forte modifica dagli anni Sessanta dello scorso secolo con l’introduzione in agricoltura della meccanizzazione diffusa che provocò la scomparsa dei reticoli della coltura promiscua. La mezzadria a Bottinaccio ebbe vita particolarmente lunga e tramontò definitivamente all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso quando la ‘Fattoria’ e la ‘Chiesa’ dismisero la gestione dell’attività agricola ed affittarono ad imprese esterne una parte ridotta dei fondi lasciando incolto il restante territorio.4 La manutenzione dei sistemi di captazione e drenaggio delle acque cessò provocando la fine del sistema idrico. Diminuirono fin quasi a sparire anche tutti quegli ‘accolli’, come la manutenzione delle strade vicinali, che la ‘Fattoria’ tradizionalmente si assumeva. La concomitanza di una forte pressione antropica che ha costantemente utilizzato l’area a scopi ricreativi e l’insorgenza di fitopatologie che hanno afflitto alcune essenze arboree caratteristiche (cipressi, olmi e pinastri), hanno influito sull’assetto del territorio e sul paesaggio rendendo evidente il cambiamento in atto nel breve volgere di un paio di decenni.
Bottinaccio nel XIX secolo. Cenni sull’economia e sul popolamento.
Ad oggi sono note solo tre immagini ‘storiche’ dell’area in esame, tre dipinti di pittori anonimi, databili tra la seconda metà del XVII e gli inizi del XVIII secolo, che raffigurano la villa di Montecastello e le sue adiacenze5. La tavola n. 1 illustra un particolare dell’albero genealogico della famiglia Frescobaldi (olio su tela, 1660 circa). Si tratta di una raffigurazione celebrativa del ‘fortilizio’ di Montecastello ritenuto, insieme al castello di Malmantile, il luogo di origine della famiglia; la raffigurazione dell’edificio nelle forme precedenti la ristrutturazione secentesca, è verosimile come hanno dimostrato le evidenze di alcuni muri di fondazione affiorati durante i lavori di ristrutturazione effettuati alcuni anni fa.6 Il castello era stato costruito nella seconda metà del Trecento da Castellano di Bardo de’ Frescobaldi intorno alla casa-torre del padre.7 L’edificio sorge sulla parte apicale della collina con l’ingresso orientato a Sud ed ha intorno un’ampia area di rispetto lasciata a prato e delimitata da un ciglione parzialmente piantumato a siepe; subito al di sotto si notano coltivazioni arboree (olivi o frutti?); sul lato NordEst si intravede il bosco di pini.8 La scarpata che divide la parte sommitale della collina è lasciata a prato, mentre si nota la mancanza del pozzo-cisterna.
tav. 1
La vocazione vitivinicola del territorio affonda le sue radici in epoche remote. Il Velluti nella sua Cronica attesta che Castellano Frescobaldi “fece porre molte vigne” traendone grandi guadagni. E’ noto che gli investimenti del capitale mercantile e finanziario cittadino indussero dalla fine del XIII secolo sulle colline della val di Pesa lo sviluppo del sistema mezzadrile.9 La proprietà fondiaria nell’area di Bottinaccio era divisa tra famiglie della nobiltà di denaro fiorentina, la chiesa di S. Andrea e istituzioni religiose secolari (Capitolo di S. Lorenzo) e regolari (Monache di Chiarito). Le prime notizie attualmente repertate sull’esistenza della parrocchia risalgono alla fine del 1200 quando la chiesa viene menzionata nelle Rationes Decimarum Italiae (Tuscia) con l’appellativo di S. Andrea de Vivario (1296).10 E’ significativo che il toponimo fosse identificato da un manufatto pertinente all’acqua, la vasca per la conservazione del pesce vivo.11 Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo i Frescobaldi acquisirono i beni immobili dell’area appartenuti ad altre famiglie fiorentine consolidando la proprietà fondiaria di Montecastello e del borgo che rimase sostanzialmente invariata fino agli anni Settanta del Novecento. Nel 1837 i fondi della tenuta Frescobaldi e quelli della Chiesa di S. Andrea confinavano, sul versante Ovest della collina con i beni di Giovanni Campacci, di Cortenuova, proprietario della Leccia e con quelli del Capitolo di S. Lorenzo di Firenze che possedeva estese proprietà dalla Val di Botte fino a Sammontana. A Nord il Balì Niccolò Martelli di Firenze era proprietario della Fattoria del Colle ed il senatore Giuliano Leonetti di Prato possedeva la tenuta degli Scopeti e di S. Pierino. La fattoria della Marta a NordEst, era di proprietà del marchese Gino Capponi ed in prossimità di Quarantola, sul versante Est, aveva acquistato beni il geologo e naturalista inglese Francis Joseph Sloane. Sul pianoro a Sud, presso Poggio Aglioni, insistevano le proprietà di Egidio Bargioni di Signa e, oltre il Vallone, si estendevano i possedimenti di Pietro Toccafondi di Coeli Aula.12 Il secondo dipinto (tavola n.2), olio su tela ascrivibile al 1660, rappresenta la villa durante la ristrutturazione secentesca; l’edificio ha già assunto l’attuale forma quadrangolare ma non è stato ancora completato il tetto a quattro falde; il parco intorno all’edificio è costituito da cipressi sul lato Sud e dalla pineta sul lato Nord. Il dipinto raffigura una animata e realistica scena di caccia in località ‘Stoppaccie’(podere Lastrino): i battitori hanno stanato un capriolo nel folto bosco del Bucignone e lo hanno portato a tiro del signore armato di fucile a pietra focaia. Il cacciatore è colto nell’atto di sparare mentre accanto a lui un servo regge una picca e conduce al guinzaglio un segugio tenuto a terra da un bambino nudo. Sulla strada un altro battitore tiene fermo un terzo cane. 13 La caccia era appannaggio dei proprietari terrieri e di coloro che da essi ne ricevevano licenza, come sanciva la legge del 27 aprile 1782.14 Montecastello era circondato da boschi e mortellai (arbusteti) e la selvaggina era numerosa. Il paesaggio dell’epoca era ancora caratterizzato dal bosco che gli conferiva un aspetto remoto e selvaggio specialmente nelle forre più profonde del Bucignone, della Tomba di Berto, del Vallone e della Buca del Falco (l’odierna Buca di Sarre). La superficie boscata appariva comunque frammentata non solo dai coltivi
ma anche da aree lasciate a pascolo, dove nei punti più scoscesi, a causa della particolare litologia dei suoli costituiti da conglomerati di ciottoli degradati (‘macie’), si innescavano gravi fenomeni di erosione (Buca di
tav. 2
Sarre, Lastrino, Borratino, Spugne, Fangacci, Bucacce). Al centro del quadro, infatti, si nota tra alcuni scoscendimenti il rio Lastrino presso la ‘Pozzaccia’ o ‘Pozzaccio’. La piaggia è raffigurata con la vegetazione rasata dal pascolo e con i radi alberi sgamollati. Dai primi decenni dell’Ottocento lo sfruttamento forestale della Tenuta Frescobaldi fu regolato in modo da garantire una rendita costante e si cercò di rimediare i danni causati dai tagli indiscriminati effettuati negli anni precedenti adottando regole minuziose. I boschi, identificati con precisione con i ‘confini di pietra’ e suddivisi tra i diversi poderi, erano allevati a ceduo con turni di taglio decennali inframmezzati ogni cinque anni dallo ‘sterzo’ (diradamento dei polloni più rigogliosi). Dal ceduo si ricavavano ‘fastelloni’ di legna da ardere e cataste di legname pregiato; dal mortellajo si traevano fastella di arbusti minuti (‘fascine’ e ‘stipa’). Il taglio riguardava i polloni del ceduo (lecci, cerri, querci, ornielli, olmi, ecc.); si proibiva lo svellimento delle ceppaie e si salvaguardavano i cipressi, i pini e le ‘porrine’ (matricine originate da seme) di quercia e di leccio che sviluppavano gli esemplari di alto fusto. Il legname veniva ‘strascicato’ in luoghi predeterminati dove, a seconda delle essenze tagliate e degli impieghi previsti veniva sottoposto allo spurgo in acqua. A questo scopo, per esempio, era usata la ‘Pozzaccia’ del Lastrino. Queste regole avevano lo scopo di garantire la rigenerazione del bosco ed il mantenimento di un livello minimo di produzione di ‘frasche’, utilizzate per integrare il foraggio, e di ghiande usate per il pascolo dei maiali. 15 Il taglio era venduto a boscaioli di fuori con la redazione di una scrittura privata che regolava il prezzo, i confini, i tempi di pagamento e di trasporto del legname oltre alle modalità del taglio e perfino le dimensioni delle cataste. 16 Quando il taglio era programmato ad uso della Fattoria, il fattore lo affidava a braccianti pagati a ‘opra’, scelti tra i coloni o i pigionali del Palazzaccio e del
Convento.17 I coloni potevano recuperare liberamente per proprio uso soltanto la legna secca e quanto necessario alla costruzione di attrezzi. Le condizioni litologiche del luogo e la morfologia di questo sistema collinare, più aspra che nel resto del territorio di Montespertoli, determinarono non solo la storia insediativa e la scelta dei luoghi da dissodare rispetto alle aree boscate ed ai ‘sodi’ lasciati a pascolo, ma anche le attività collaterali all’agricoltura. I depositi di argilla affioranti sul sistema collinare furono infatti utilizzati come cave.18 Nel dipinto riprodotto nella tavola n. 2, è raffigurato un edificio sul limitare del bosco presso il quale sul volgere del XVIII secolo si trovava la fornace e la ‘stalla delle pecore’.19 Le fornaci di fattoria erano costruite in prossimità dei luoghi dove c’era ampia disponibilità delle materie prime indispensabili alla produzione: acqua, legname e argilla; anche la Fattoria di Montecastello, come altre fattorie della zona (Cortina, Monti, Sammontana, ecc.), impiantò nel XVIII secolo una fornace di calcina e di ‘lavoro quadro’ (mattoni, tegole, pianelle, ecc.) che si approvvigionava di argilla in loco.20 Il terzo dipinto (tavola n.3) è una rappresentazione animata della villa di Montecastello databile ai primi anni del XVIII secolo. La villa, circondata da cipressi, ha assunto l’aspetto che conserva ancora oggi con il doppio scalone che conduce alla terrazza e la torre di Bardo che sporge dal tetto in posizione asimmetrica. Al centro della facciata sopra al portone di ingresso è raffigurata l’epigrafe che ricorda i lavori di restauro del 1703. Il dipinto è animato da numerose figure tra cui due cavalli ed un cavaliere; al centro del prato un garzone dorme accanto al gregge; un villano con la vanga in spalla discorre con una pastorella; due serve conversano tra loro mentre una governa le galline e l'altra porta una mezzina per attingere l’acqua al pozzo.
tav. 3
La scena pastorale non è solo un omaggio alla moda bucolica del tempo ma è anche epitome significativa della vita che si svolgeva realmente intorno alla villa-fattoria sul volgere del XVIII secolo; il villano è rappresentato munito della sua vanga, strumento principe del dissodamento e dello scavo delle fosse per le barbatelle delle viti; la pastora col suo lungo bastone tiene a bada il gregge che bruca l’erba del prato mantenendola rasata; l’allevamento delle pecore, infatti, era praticato sia sui terreni della Fattoria che su quelli della Chiesa anche se non risultano, a tutt’oggi, evidenze di commercializzazione dei prodotti caseari. Il cavaliere, i cavalli ed i cani, come nella scena di caccia del secondo dipinto, celebrano l’attività venatoria esercitata per diporto dai signori e dai loro amici. Nel quadro sono quindi presenti tutti i principali attori (manca solo il priore) che popolavano il mondo rurale di Bottinaccio nel XVIII secolo e che caratterizzarono il luogo anche nel secolo successivo. Fin dalla metà del Settecento, con il declassamento del
Palazzaccio da villa-fattoria padronale a ‘casamento’ per pigionali, si era stratificata nel villaggio una struttura sociale abbastanza complessa che regolava, in edifici contigui, la convivenza di famiglie di contadini, camporajoli e pigionali che esercitavano vari mestieri, tutti legati all’economia rurale e silvo-pastorale (braccianti, barrocciai, carbonai e boscaioli). Gli unici possidenti erano i Frescobaldi ed il priore della chiesa di S.Andrea. La mezzadria era il modello economico diffuso che governava la comunità e che determinò anche il modello sociale e culturale dominante condiviso dalla popolazione rurale. Nel 1832 gli abitanti residenti erano 191. Oltre al priore della chiesa di S. Andrea, al fattore e sua moglie, si contavano 124 individui appartenenti a famiglie coloniche (64,92%), 58 a famiglie di pigionali (30,36%) e 6 servi o garzoni.21 Le famiglie dei pigionali erano composte in media da circa quattro persone. Il numero dei componenti delle famiglie coloniche solo in due casi arrivava a 10 e 11 persone (famiglia Borri divisa nei due rami del podere Torricella e del podere Val di Botte); la media era di circa sette individui a famiglia pur essendo presenti spesso relazioni parentali di terzo grado (fratelli sposati con presenza di cognate/i e nipoti). Questo dato conferma la nota tendenza all’orizzontalità delle famiglie rurali.22 Il patto colonico regolava con la forza giuridica del contratto ogni aspetto di rilevanza economica della vita della famiglia contadina e di fatto vincolava anche la sfera della vita affettiva e sociale delle persone. La pianificazione familiare, elemento imprescindibile del sistema mezzadrile ottocentesco, aveva proprio nel matrimonio lo strumento di riequilibrio della forza lavoro del podere. 23 Le ragazze in età da marito dovevano essere ‘dotate’ almeno del ‘corredo’ e della relativa cassa per contenerlo, onere talvolta assai gravoso. Per questo era assai comune l’istituto della ‘dote’ per le fanciulle indigenti. A Bottinaccio, come altrove, venivano amministrati dal parroco dei sussidi, costituiti da appositi lasciti di benefattori o dello stesso proprietario terriero, destinati a costituire la dote per un certo numero di fanciulle per ogni anno. I maschi celibi che si volevano sposare potevano restare nella casa colonica dei genitori se nel podere sussisteva la necessità di manodopera, altrimenti dovevano cercarsi una sistemazione come pigionali; talvolta potevano aspirare all’assegnazione di un podere in proprio, specialmente quando se ne liberava uno nei possedimenti dello stesso proprietario. I coloni, a causa degli scarsi margini gestionali, dell’incertezza dei raccolti, e dell’endemica penuria di liquidità derivante dall’economia mezzadrile improntata all’autoconsumo, diventavano facilmente preda dei debiti che li asservivano al ‘possidente’. Questa dipendenza era molto più evidente nel caso dei pigionali che vivevano prestando ‘opra’ occasionale a seconda delle opportunità stagionali offerte dall’economia locale. “I suddetti coloni e barrocciaj possono dirsi indigenti casuali, i primi perché non ritraggono dai poderi che lavorano il vitto per tutto l’anno, atteso la sterilità dei poderi stessi, i secondi perché ritraggono piccolo guadagno dal loro mestiere.”24 Le parole del priore Carlo Pierotti, ripetute in calce ad ogni pagina dello Stato d’anime del 1841, esprimono bene lo stato di precarietà della classe subalterna rurale a metà dell’Ottocento. Occorre tuttavia tener presente che lo stato d’anime del 1841 fu redatto per essere trasmesso in copia alle Magistrature Comunitative a fini statistici per il censimento nominativo della Toscana e anche a fini informativi relativi all’arruolamento e al riparto della Tassa di Famiglia.25 La portata dell’assunto del priore Pierotti deve essere presa nel suo valore relativo di asserzione generalizzata, valida soprattutto per quei pigionali che non esercitavano mestieri artigianali ma semplici mansioni di manovalanza. La condizione reale dei singoli coloni probabilmente era più diversificata rispetto a quanto dichiarato e, con buona probabilità, alcuni di essi arrivavano a vantare crediti nei saldi annuali grazie anche alle attività integrative, quali l’esecuzione delle fosse per i nuovi impianti, il lavoro alla fornace, il taglio e lo ‘strascico’ del legname, la coltivazione del grano marzuolo. L’esame della composizione sociale dei nuclei familiari residenti nel popolo di Bottinaccio intorno alla metà dell’Ottocento non ha tuttavia evidenziato quei casi di mobilità sociale riscontrati invece in altre aree del Comune di Montespertoli, dove, grazie alla maggiore produttività dei terreni ed ai proventi di attività collaterali alla conduzione del podere, alcune famiglie riuscirono ad accumulare sufficienti risparmi per acquistare appezzamenti di terra, case o perfino interi poderi ed elevarsi al rango di piccoli possidenti ed imprenditori.26 Questa realtà locale può essere solo parzialmente spiegata con la “sterilità dei poderi”. La granitica egemonia economica ed il saldo controllo sociale che i Frescobaldi e la Chiesa esercitavano sulla popolazione rurale ebbero probabilmente ruoli altrettanto importanti. La casa colonica era organizzata come unità produttiva funzionale al podere; tutte le coloniche esistenti nel XIX secolo nell’area in esame erano organizzate con i locali di produzione al piano terreno (loggiato, stalle, porcilaie, ecc.) e con l’abitazione dei contadini (cucina, granaio, camere e gabinetto) al primo piano. Solo Torricella aveva uno sviluppo abitativo anche al piano terreno. I quartieri dei pigionali del Refettorio, del Palazzaccio e del Convento erano molto più modesti e consistevano in poche stanze per nucleo familiare (spesso solo cucina e camera). L’arredo consisteva in pochi mobili (madia, tavolo, panche, letti o semplici tavolacci su cavalletti di ferro, casse per la biancheria) generalmente di gattice (‘gattero’ o ‘arbero’), più raramente di cipresso.27 La cucina (la ‘casa’) con il suo focolare costituiva il nucleo centrale della vita domestica; la legna ed il carbone
vegetale erano le uniche fonti energetiche per cucinare e per scaldarsi. L’austera economia autarchica del sistema mezzadrile, spingeva alla conservazione e al riciclo delle scarse suppellettili disponibili. Molti strumenti di lavoro e per la casa erano fabbricati dagli stessi coloni in legno, salci o rametti di olivo. Il vasellame da fuoco (pentole, tegami e relativi testi) era quasi interamente di ‘coccio’ (terracotta invetriata all’interno con modesti decori a filetti o girali gialle). Il vasellame da mensa (piatti, ciotole e boccali) era in maiolica grossolana o in terra rossa con decoro a girali, a foglia di vite o a rametto fiorito. L’acqua potabile e ad uso domestico era attinta alla fonte o al pozzo e conservata in casa nelle mezzine di terracotta invetriata all’interno che venivano riposte sull’acquaio accanto ai comunissimi catini di terracotta decorati a ramina.28 Per le abluzioni che si ritenevano necessarie all’epoca erano sufficienti la brocca e la catinella. La pulizia del corpo era per lo più limitata al lavaggio dei piedi, delle mani e della faccia perché, ancora all’inizio del XIX secolo, era opinione trasversalmente condivisa tra le diverse classi sociali che il contatto prolungato con l’acqua, specialmente in certe parti intime fosse dannoso per la salute e moralmente disdicevole; la detersione personale era ottenuta con pezzuole pulite, unguenti e decotti.29 Il ‘luogo comodo’ (gabinetto) consisteva in una semplice buca tappata da un chiusino di legno ed era ricavato in uno stanzino o su un ballatoio esterno; la buca era collegata tramite un condotto di ‘trombotti’ di terracotta direttamente al pozzo nero. I pigionali usufruivano di gabinetti in comune. Nelle camere si usavano i pitali e le ‘tube’. I depositi a tenuta presenti nel borgo anche in prossimità delle fonti erano svuotati frequentemente per ricavare concime dalla parte solida del loro contenuto (i ‘sughi’) e le loro ‘botole’ (dette anche ‘lapidi’) erano coperte e riparate per evitare le infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del deposito. I pozzi neri costituivano una possibile origine di inquinamento batteriologico delle acque che poteva avere conseguenze mortali sulla salute delle persone. La discreta disponibilità di acqua di buona qualità e la particolare attenzione nel governo delle acque sorgive e delle acque reflue contribuirono a risparmiare la popolazione di Bottinaccio dalla virulenta epidemia di colera del 1855 che fece numerose vittime anche nella vicina Coeli Aula. I panni di casa e quelli di Fattoria erano periodicamente lavati nelle ‘conche’ collocate sotto la loggia o nel cigliere;30 si utilizzava sapone fatto in casa e ranno di cenere. Una volta lavati, i panni erano attorcigliati su un lungo bastone e portati al ‘pillone’ per essere risciacquati. Il ‘pillone’ era un luogo di aggregazione delle donne e dei bambini. Chi scrive ha rinvenuto presso una di queste strutture i frammenti di due diversi ‘ciuchini con il fischio’, fischietti di terracotta modellati a forma di cavalluccio, di probabile manifattura montelupina, che costituivano ‘trastulli’ a buon mercato popolarissimi tra i bambini del tempo. Nel villaggio, intorno agli spazi a comune (forno e pilloni) si svilupparono consuetudini condivise da tutti allo scopo di ridurre le conflittualità tra i residenti. L’attività di panificazione era appannaggio delle donne; per quanto riguarda i ‘pilloni’, gli uomini pulivano a turno i drenaggi, riparavano le crettature delle vasche e preparavano gli zipoli di olmo che ne otturavano gli scarichi. Le donne provvedevano alla pulizia delle vasche e stabilivano i turni di risciacquo dei panni, lasciando il privilegio della prima acqua a chi aveva pulito la vasca. I litigi ed conflitti erano tuttavia frequenti specialmente quando non si rispettavano le convenzioni sociali tacitamente imposte e condivise spesso obtorto collo. Come abbiamo visto la dipendenza economica aveva conseguenze molto pesanti sulla vita delle famiglie anche a livello comportamentale e sociale. I diversi status personali implicavano il rispetto di una gerarchia che aveva al vertice il proprietario terriero e il prete, e poi, in ordine decrescente, il fattore, il guardia, il terz’omo, i coloni, fino ad arrivare alla base della piramide sociale rappresentata dai prestatori d’opra (i ‘pigionali’), dalle serve e dai garzoni. Si trattava di un modello socio-culturale imposto ed accettato per necessità e per mancanza di alternative che condizionò la mentalità della popolazione rurale ben oltre la durata giuridica dei ‘patti colonici’.
L’acqua di Bottinaccio. Bottinaccio sorge a quota 223 m.s.l.m. su una terrazza di conglomerato di ciottoli a forma di mezzaluna sotto al quale si trova un deposito di argilla che determina la copiosa presenza di acqua di falda. Tra le leggende che formano il patrimonio folklorico di Bottinaccio è particolarmente pertinente al nostro tema quella del lago sotterraneo: “sotto terra, tra la chiesa ed il Palazzaccio esisterebbe un lago ricco di acqua che alimenta le sorgenti presenti intorno al borgo; alcune di queste sarebbero alimentate da lunghi condotti di terracotta che prelevano l’acqua da questo grande bacino ipogeo”.31 Il tema del lago (o del fiume) sotterraneo dà conto in chiave favolistica della presenza delle numerose risorgive ed è comune a molti luoghi dove si verifica una consistente presenza di acqua in mancanza di torrenti o laghi in superficie. 32 Il 29 luglio 1904 il professor Carlo de Stefani docente di geologia e direttore del Museo di geologia di Firenze, incaricato dal Comune di Montespertoli dello studio della sorgente Maioli presso Lucardo, consegnava al Sindaco le sue “Considerazioni sul regime delle sorgenti nelle colline di Val di Pesa e di Val d’Elsa”. La rigorosa analisi di de Stefani individuava gli strati orizzontali delle nostre colline plioceniche come composti da un’alternanza di conglomerati di ciottoli, sabbie compatte e depositi di argilla; stabiliva
che la capacità di erogazione idrica delle sorgenti, ubicate tutte a livello di ogni strato di contatto tra rocce permeabili e argille, dipendeva dalla capacità cubica dello spessore di conglomerato e sabbie superiore che fungeva da ‘bacino rifornitore’. Il de Stefani notava altresì che le sorgenti potevano trovarsi a quote diverse su ogni collina e che “[…] si possono ripetere le sorgenti in colline diverse a livelli differenti”. Infine il geologo notava che “le sorgenti sono anche più abbondanti se il confine tra rocce permeabili e impermeabili trovasi presso il livello di base, cioè presso il fondo della vallata […]”; egli citava, come esempio la Chiarina di Montespertoli e le sorgenti di Sammontana. 33 L’analisi del professor de Stefani si attaglia perfettamente alla geologia di Bottinaccio ed aree limitrofe, dove il fenomeno è noto da sempre ed ha determinato gli insediamenti demici e le attività economiche locali. Le strutture idriche del villaggio, alimentate da un ‘bacino rifornitore’ dello spessore di 40 metri (dislivello intercorrente tra la quota di Montecastello e quella del borgo) sopperirono, insieme ai pilloni costruiti nei poderi della Fattoria, al fabbisogno di acqua fino agli anni Novanta del secolo scorso. Alla fine degli anni Sessanta si supplì alla sempre maggiore richiesta di acqua con la costruzione degli acquedotti di fattoria e della chiesa che si approvvigionavano alle sorgenti di Fontevanni (Frescobaldi) e delle Bucacce (Chiesa); l’acqua arrivò finalmente nelle case con l’ausilio di due pompe alimentate ad energia elettrica che sollevavano l’acqua dai punti di captazione ai due depositi situati rispettivamente presso la Fattoria e presso la casa del contadino della Chiesa. L’acquedotto di Publiacque arrivò solo nel 1995. La grande disponibilità di acqua e il suo razionale sfruttamento messo in atto nel XIX secolo dai due istituti detentori della grande proprietà fondiaria a Bottinaccio, danno ragione del silenzio assordante delle fonti archivistiche relative alle richieste di erogazione idrica, così numerose ed insistenti nel periodo 1860-1945 per le altre aree esaminate del territorio comunale di Montespertoli. La ‘Fattoria’ e la ‘Chiesa’ si ponevano ancora nel XIX secolo come gli interlocutori privilegiati che rispondevano alle necessità della popolazione rurale al posto dell’Amministrazione comunale diventandone di fatto intermediari esclusivi. Nella scarpata intorno al villaggio sono ubicate una serie di sorgenti captate da manufatti idrici diversi. Queste opere sono ripartite in modo quasi speculare tra la ex-proprietà Frescobaldi e la proprietà della chiesa: sul versante Nord un pozzo, un ‘pillone’ e due cisterne; su quello a Sud un pozzo, un bottino di captazione, un vivajo, un ‘pillone’ ed una cisterna. Ad oggi si è potuto individuare l’epoca di costruzione solo del ‘pillone’ della chiesa (1832) e di quello di Querce (Le Cetine) (1886), ma è probabile che le opere fuori terra pervenute ai nostri giorni siano attribuibili tutte allo stesso arco di tempo in quanto i manufatti presentano caratteristiche simili sia per i materiali da costruzione, sia per le forme che per le dimensioni.34 In prossimità della prioria si trova il vivaio alimentato da un bottino di captazione dell’acqua; i due manufatti furono restaurati nella prima metà dell’Ottocento. E’ in questo punto che con buona probabilità si trovavano il ‘vivario’ ed il ‘bottinaccio’ attestati alla fine del Duegento che dettero il nome al villaggio. L’acqua del vivajo fuoriusciva da un tubo di ‘troppopieno’ che la incanalava in un lavatoio distante alcune braccia. Da questo, tramite un piccolo acquidoccio murato, l’acqua scolmava in alcune grosse conche interrate che servivano per l’irrigazione dell’orto della chiesa; nel 1832 l’orto veniva coltivato da Giovanni Santini, ‘ortolano’, residente in un quartiere del Podere della Chiesa.35 In tutta l’area di Montecastello esistevano sei pozzi di cui uno nel giardino della villa, uno al convento, due nel borgo e due presso le case coloniche; il pozzo di Rose, inserito nello spessore della residua cortina muraria del borgo, è il manufatto più antico e meno rimaneggiato del sistema idrico di Bottinaccio. Anche il pozzo della canonica era inserito in un contesto analogo. Il pozzo del Lastrino, ubicato in prossimità della strada comunitativa che univa Bottinaccio a Pulica e San Donato, serviva la casa colonica del podere, la fornace di Fattoria e la casa del podere Torricella (edificio di origine medievale ridotto a casa colonica). Presso Maiano esisteva un altro pozzo che fu riempito negli anni Settanta durante l’impianto di un vigneto. Durante la ricerca condotta da chi scrive furono censite cinque cisterne di cui due alimentate esclusivamente da acqua piovana e tre provviste al loro interno di un punto di captazione dell’acqua che attinge direttamente dalla falda. Le cisterne rivestivano un’importanza fondamentale nel sistema di approvvigionamento idrico in quanto oltre a raccogliere e conservare una grande quantità di acqua nei periodi più piovosi, permettevano di ricostituire di notte la riserva idrica dopo che l’acqua era stata utilizzata durante la giornata; la possibilità di rigenerare una riserva minima di acqua aveva una notevole importanza perché le sorgenti del villaggio erogavano acqua in modo costante ma con una portata piuttosto modesta. Ferdinando Morozzi nel suo trattato sulle case dei contadini suggeriva numerosi accorgimenti per la costruzione delle cisterne che prima di tutto dovevano garantire la perfetta tenuta dell’acqua. Il Morozzi, che scriveva nella seconda metà del Settecento, reputava l’acqua piovana decantata nelle cisterne più salubre dell’acqua delle fonti che poteva essere più facilmente contaminata.36 Le opere più diffuse e in un certo senso più caratteristiche del luogo sono però i ‘pilloni’. Ne sono stati individuati undici, di cui due nel borgo e nove sparsi nel territorio circostante. Alcuni di questi rimasero in uso fino a pochi anni fa. I pilloni sono organizzati in base ad un semplice schema di sfruttamento idrico rimasto invariato dal medioevo: tre vasi con trabocco a caditoio: il bottino o ‘fontino’ (ricettacolo chiuso per
l’acqua potabile), l’ abbeveratoio (per attingere acqua per gli animali) ed il lavatoio. Il bottino di raccolta dell’acqua potabile era accessibile da un chiusino di legno e da un tubo sottostante chiuso da uno zipolo di salice. L’abbeveratoio era chiuso da un coperchio di assi di legno. Il lavatoio con i bordi inclinati verso l’interno, serviva soprattutto per sciacquare i panni. Nel 1992 sul pillone del Palazzaccio, regolarmente utilizzato per l’approvvigionamento di acqua potabile e per il risciacquo del bucato, era ancora leggibile la scritta “vietato lavare i cani”! La rigida gerarchia dei ricettacoli dell’acqua del pillone era ancora puntigliosamente rispettata dai residenti; l’acqua del ‘fontino’ veniva fatta analizzare due volte all’anno da un laboratorio di analisi; le vasche erano ripulite a turno ogni settimana. Le acque reflue erano incanalate nella fossa lungo la strada vicinale delle Rose e da lì l’acqua fluiva nelle fosse lungo i campi che degradavano fino in Val di Botte. In estate l’acqua risultante dalla pulizia delle vasche (circa tre metri cubi) era utilizzata per l’irrigazione degli orti sottostanti. La sola differenza rispetto al secolo precedente consisteva nel fatto che l’acqua della seconda vasca, una volta destinata alle ‘bestie’, veniva ancora mantenuta rigorosamente pulita, ma era ormai usata solo come riserva idrica per riempire il lavatoio durante la stagione estiva. Il ‘pillone’ si configurava ancora come unità di sfruttamento globale della risorsa idrica e come punto ordinante del sistema di imbrigliamento delle acque di risorgiva che erano convogliate, dopo il loro sistematico sfruttamento, nelle fosse o negli acquidocci di drenaggio che ne impedivano il ruscellamento incontrollato. Non a caso,infatti, in questi ultimi anni, i fenomeni erosivi sono ripresi nei punti finali del sistema di drenaggio delle acque reflue del borgo, cioè nei terreni dei ‘Fangacci’ e dell’ex podere della Chiesa, dove ormai da oltre un trentennio è venuta a mancare la manutenzione delle fosse delle vecchie unità poderali. Dalla seconda metà del Settecento si era iniziato a teorizzare, proprio nell’area della bassa Valdelsa, modalità di gestione delle acque di ruscellamento che imbrigliavano la forza erosiva dell’acqua e la utilizzavano per il consolidamento dei versanti collinari e l’aumento della superficie delle aree coltivabili. Cominciò lentamente a diffondersi l’uso di pratiche di coltivazione che invece di secondare la massima pendenza del versante collinare (rittochino) privilegiavano una sistemazione del terreno allineata alle curve di livello (giropoggio). Sia le esperienze dell’abate Landeschi a Sant’Angelo a Montorzo e del Dott. Chiarenti a Montajone, che le successive realizzazioni del marchese Cosimo Ridolfi e del suo fattore Agostino Testaferrata nella tenuta di Meleto, postulavano che l’acqua di ruscellamento superficiale fosse incanalata in un adeguato sistema di fossi e rallentata in punti strategici dove poteva depositare i sedimenti erosi a monte. Il Ridolfi propagandò queste pratiche a livello nazionale con il Giornale Agrario edito dall’Accademia dei Georgofili (1827–1865). L’idea che una diffusione delle conoscenze agronomiche tra i possidenti, i fattori e i coloni giovasse al miglioramento delle pratiche agrarie e all’aumento della produzione era alla base dell’istanza didattica che animò molti Georgofili tra cui l’abate Lambruschini e lo stesso Ridolfi. Questi favorì la fondazione di scuole di agraria per possidenti e fattori, le accademie e le società orticole (Scuola Agraria di Meleto, 1834, Società Empolese di Scienze Economiche Tecnico Pratiche, 1845, Società Orticola di Firenze, 1859).Un analogo spirito didattico animò anche la fondazione della Scuola Agraria di Castelletti di Signa fondata nel 1859 da Leopoldo Cattani Cavalcanti. Le tecniche diffuse dal Ridolfi furono fatte proprie a Bottinaccio dal canonico empolese Carlo Pierotti, priore di S. Andrea a Bottinaccio dal 1829 al 1869. Carlo Gaetano Giuseppe Maria Pierotti (Empoli 1800 – Bottinaccio 1869) proveniva da una benestante famiglia empolese; il padre, il notaio Lorenzo, aveva ricoperto numerosi incarichi pubblici ed era ben introdotto nella classe dirigente locale. Nel 1813 Carlo entrò nel Seminario Maggiore di Firenze; nel 1818 fu nominato canonico della collegiata da monsignor Michele del Bianco; nel 1823 fu ordinato sacerdote.37 Tre anni dopo ottenne la cura di S. Giusto a Petroio sulla via Salaiola, chiesa restaurata nel 1810 proprio per volontà del Capitolo empolese e del proposto Del Bianco. In questo periodo il Pierotti maturò la decisione di trovare una cura d’anime in aperta campagna. Fu così che nel luglio 1829, resasi vacante la cura di Bottinaccio per morte del rettore Pietro Guerrazzi, nonostante il parere contrario dei familiari e di alcuni canonici della Collegiata, il Pierotti chiese ed ottenne dal patrono, cav. Matteo Frescobaldi, la cura di S. Andrea a Bottinaccio. Le condizioni del patrimonio della chiesa erano miserevoli e il priore, dopo aver fatto redigere una prima perizia di parte, si risolse a chiedere l’intervento del patrono per risanare i beni della chiesa, come sarebbe stato d’obbligo in base al diritto canonico. In quegli anni l’istituto del giuspatronato laicale, appannaggio del proprietario terriero, era ancora ritenuto un segno distintivo di prestigio ed il parroco, investito del beneficio dal nobile patrono prima ancora che dal vescovo, era considerato un docile strumento di controllo sulla popolazione rurale. Tuttavia il diritto di patronato era ormai valutato pragmaticamente in base alla convenienza del suo esercizio ed il patrono valutava bene il rapporto tra i costi ed i benefici che se ne potevano trarre in termini di prestigio sociale e controllo sul territorio.38 Il Pierotti deciso a risanare i fabbricati e a rendere produttivi i terreni della chiesa, si trovò nella necessità di reperire liquidità per finanziare i lavori di risistemazione e gravò il beneficio di una serie di censi contro il parere del Frescobaldi che lo invitava alla prudenza.39 I rapporti tra i due si deteriorarono sempre più e sfociarono in una serie di cause dalle quali però il prete ne uscì sempre senza soverchie noie grazie anche ai ripetuti interventi in suo favore dell’amico Vincenzio Salvagnoli. Il Pierotti, infatti, pur risiedendo a Bottinaccio,
mantenne sempre le sue relazioni empolesi (oltre al patrimonio immobiliare e gli incarichi presso la Collegiata) e si giovò spesso delle sue influenti conoscenze, in particolare del Salvagnoli a cui chiese a più riprese di intervenire in suo favore presso gli uffici granducali e presso l’Arcivescovado.40 La lite con la famiglia Frescobaldi non si ricompose nemmeno con la morte del cav. Matteo (1841), anzi si riacutizzò con il figlio Gherardo, allargandosi anche a questioni di giurisdizione ecclesiastica relative all’oratorio privato della villa di Montecastello dove si custodiva la miracolosa Immagine di S. Maria della Pace.41 Ancora nel gennaio 1868 il priore si rivolgeva al Comune di Montespertoli chiedendo che si accertassero ufficialmente i danni recati ai fabbricati della chiesa e della canonica dal ruscellamento delle acque meteoriche provocato dai lavori di modifica ad un acquidoccio nella proprietà Frescobaldi e sovrastante la prioria, messi in atto per la costruzione di un viale che congiungeva la strada comunale alla villa.42 Nel ventennio tra il 1830 e il 1850 l’iniziativa del priore Pierotti portò alla sistemazione e messa a coltura di buona parte della pendice collinare di SudEst (Fangacci e Podere della Chiesa). L’area fu drenata con un sistema di fossi e fognette orientati in modo da ridurre la velocità dell'acqua di ruscellamento ed indurre il deposito dei sedimenti nei punti depressi. Furono costruiti degli sbarramenti (‘serre’) formati da fascine e zolle di terra (‘piote’) che nel tempo originavano le ‘colmate’. I terreni furono messi a coltura con la piantumazione di reticoli di essenze arboree (viti e frutti) che circoscrivevano le colture cerealicole. I campi furono dotati di resole di sbiado carrabili. Nel rio di Val di Botte furono costruite serre in laterizi che sbarravano trasversalmente il corso del rio riducendo la forza di erosione delle acque e provocando il deposito dei sedimenti. Queste opere annullavano il naturale sprofondamento del rio e favorivano l’addolcimento del declivio. Nel luglio 1853 Cosimo Ridolfi, dopo una visita ai poderi della prioria di Bottinaccio, testimoniò i buoni risultati della pratica della colmata di monte applicata con perseveranza e tenacia dal priore Pierotti nei Fangacci, a cui per l’occasione fu cambiato il nome in ‘Podere Giardino’: « Le numerose e floride coltivazioni di viti e di ulivi che ella ha eseguite, e che adesso custodisce con ogni diligenza e premura, attestano l’impiego di vistosi capitali; e mostrano che Ella non ha temuto di anticipare alla Terra, contando sulla sua gratitudine e nella convinzione che solo per questa via si possono fare veri e considerabili miglioramenti. La diligente direzione delle acque, ed i vantaggi ottenuti col frenarne il corso, prima disordinato e nocivo, attesta altresì come ella fosse convinto che questa sia la principal solerzia, che deve avere l’agricoltore, se non vuol vedere dissipato il tesoro di pensieri e di danaro che versa nel suo terreno».43 L’opera di risanamento messa in atto dal priore indusse Matteo Frescobaldi ad iniziare lavori di miglioramento fondiario che furono diretti dai fattori Carlo Masi e Salvadore Barbani. Nel Turbone furono costruite alcune serre in laterizio. Tutte questi interventi prevedevano l’impiego di manodopera pagata ‘ad opra’ e per la quale si ricorse talvolta a maestranze ‘forestiere’ e spesso al lavoro dei pigionali o, a seconda della stagione, agli stessi coloni. Le controversie legali tra il Frescobaldi ed il priore non impedirono alle due parti di trovare accordi per questioni specifiche come alcuni riconfinamenti e la costruzione in società di migliorie fondiarie sui confini a comune come l’acquidoccio costruito sui terreni di Casacce lungo la strada comunitativa per Montespertoli in un punto particolarmente fragile ed esposto all’erosione ed alle frane.
Il processo di consolidamento e messa a coltura dei fragili versanti dei poggi pliocenici di Bottinaccio, contribuì alla formazione di quello che è celebrato come il ‘tipico’ paesaggio collinare toscano; un paesaggio dominato dalla coltura promiscua dove le coltivazioni arboree di viti, olivi e frutti sparsi (fichi, mandorli, peri, meli, ecc.) insieme ai ciglioni piantumati con siepi di prugnoli e biancospini, costituivano la trama reticolare dei campi coltivati a cereali e colture erbacee.
Negli anni Cinquanta dell’Ottocento anche Bottinaccio fu colpita dalla devastante epidemia di oidio (la ‘Trittogama’) che falcidiò soprattutto le viti e gli olivi e ridusse drammaticamente la produzione di vino e olio. Da allora si diffuse l’uso della ramatura e solfatura delle piante. L’antica copertura boschiva, ancora abbastanza estesa nella prima metà dell’Ottocento, nel corso del secolo divenne sempre più residua nei versanti più scoscesi e meno fertili del territorio (Buca del Falco, Bucignone, Borratino, Tomba di Berto, val di Botte, rio delle Grotte, ecc.). La superficie coltivata si estese in quegli anni anche a numerose aree relativamente ripide dove, nel corso del tempo, si erano realizzate piazzole, più che terrazzamenti veri e propri, servite da strette resole, per la coltivazione dell’olivo (Le Bucacce, Val di Botte, ecc.). 44 La piantumazione dell’olivo sui versanti più sassosi aveva il vantaggio di lasciare spazio alle colture cerealicole. La riduzione del manto forestale fu determinata anche dalla diffusione fin dai primi anni del secolo della coltivazione del grano marzuolo (o ‘semone’) per la produzione della paglia da cappelli, richiesta, pur tra gli alti e bassi della domanda, da una vivace industria manifatturiera dell’area fiorentina.45 L’opera iniziata da Carlo Pierotti, da Matteo Frescobaldi e dai fattori Carlo Masi e Salvatore Barbani fu proseguita e mantenuta dai loro successori. Carlo Pierotti morì il 18 marzo 1869. I sacerdoti che si avvicendarono nella prioria di S.Andrea (Giuseppe Bonardi, Tito Vettori, Eugenio Marmugi e Bruno Tacci), continuarono l’attività intrapresa dal priore.
Il figlio di Matteo, Gherardo Frescobaldi, condusse la Tenuta di Montecastello per tutta la vita. Nel 1863 il fratello Angelo sposò Leonia degli Albizi, che portò in dote l’ingente patrimonio familiare tra cui le fattorie di Nipozzano, Pomino e Poggio a Remole in val di Sieve. Qui il fratello di lei, Vittorio, a partire dal 1860, aveva intrapreso nuove tecniche di viticoltura specializzata che in seguito furono applicate in tutte le proprietà dei Frescobaldi dove l’attività vitivinicola divenne sempre più preponderante. Il nipote di Angelo e Leonia, Lamberto (1892) ereditò insieme alla proprietà di Montecastello il titolo marchionale. Egli ed i suoi eredi continuarono l’attività a Bottinaccio fino al 1988.
Il XX secolo e la fine del ciclo plurisecolare della mezzadria. Nel 1886 il Comune di Empoli, che utilizzava le sorgenti di Sammontana dal 182446, chiese la concessione di due sorgenti ubicate in Tomba di Berto per implementare la portata di acqua della fontana del Pampaloni in piazza Farinata degli Uberti. I Frescobaldi ed il priore Giuseppe Bonardi concessero l’uso gratuito in cambio della costruzione di un fontanile pubblico per ogni punto di captazione, dell’erogazione gratuita di un metro cubo di acqua pro die all’ospedale San Giuseppe e all’Istituto Calasanzio in Najana e dell’apposizione di targhe commemorative nei punti di captazione e di arrivo dell’acqua. Sulla fontana di piazza dei Leoni ad Empoli è ancora visibile la targa commemorativa, mentre le targhe collocate in Tomba di Berto sono andate perdute. Nella prima metà del Novecento la comunità di Bottinaccio continuò ad essere governata dal sistema di fattoria e dal modello economico mezzadrile. Le idee socialiste di riscatto delle classi subalterne, che circolavano fin dai primi anni del secolo, superata la crisi della prima guerra mondiale, sembrarono per un momento realizzabili e a portata di mano. Ma le speranze e l’anelito di riscatto sociale degli anni venti furono annichiliti dall’avvento del fascismo che contribuì al rafforzamento del sistema di fattoria ritenuto capace di garantire con le sue gerarchie consolidate la stabilità sociale nelle campagne.47 Nell’ottobre 1922 il geometra Luigi Montagni, su incarico del priore Eugenio Marmugi redasse una perizia48 volta a dimostrare la convenienza dell’alienazione di alcuni terreni nudi dati in affitto ed ubicati in aree marginali (val di Piane, Rio de’ Corvi e Campo di Marliano). La vendita avrebbe dovuto finanziare i lavori di scasso e piantumazione di nuove barbatelle di vite americana, resisi necessari per rinnovare i vigneti decimati dall’epidemia di fillossera arrivata in quegli anni sulla collina di Bottinaccio. Il documento illustra la coltivazione promiscua di viti ed olivi in filari con campi avvicendati a grano, fieno e leguminose. La coltivazione della paglia, praticata fin dai primi anni dell’Ottocento era ancora praticata nelle aree marginali e affidata a opra ai coloni o a soggetti esterni. I lavori di piantumazione delle nuove barbatelle furono effettuati in tutti i poderi e furono dissodati anche nuovi appezzamenti in Pietra Cava dove si costruirono due vasche per contenere l’acqua per ramare ed un deposito di ‘pozzo nero’ per le concimazioni; i bacini erano riempiti con l’acqua di una sorgente poco distante che oggi è asciutta. Il ragionamento svolto dal perito riproponeva la vecchia questione ottocentesca della convenienza della conduzione a mezzadria rispetto all’affitto delle terre. A partire dagli anni Trenta si fece sentire la grande recessione che sfociò nella tragedia della seconda guerra mondiale. Nel 1944 la collina si popolò di sfollati che cercavano scampo dai bombardamenti. Negli anni successivi alla guerra furono varati interventi amministrativi locali e legislativi nazionali volti prima ad uscire dall’emergenza postbellica e poi a sviluppare l’agricoltura. Fin dal 1952 furono varate leggi che prevedevano contributi per la meccanizzazione delle aziende agricole. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso iniziò un grande cambiamento nella comunità. La richiesta di manodopera delle fabbriche della piana empolese fornì ai giovani opportunità di lavoro nelle ceramiche, nelle vetrerie e nei calzaturifici. In quegli anni molti si trasferirono in paese in case più piccole, munite di servizi igienici e vicine a tutti i servizi offerti dall’agglomerato urbano. Si scardinava così uno dei capisaldi che aveva sostenuto la mezzadria fino agli anni Cinquanta: i giovani avevano una concreta possibilità di lavoro alternativo all’attività agricola; gli anni del boom economico diedero una possibilità di scelta ad una intera generazione di giovani contadini. In questo periodo la vecchia comunità autoctona cominciò a sfilacciarsi. Nuove famiglie coloniche arrivarono da territori limitrofi, altre emigrarono dal Casentino e dal Senese ed occuparono i poderi lasciati vacanti. Da un punto di vista sociale si trattò di un parziale rinnovo della comunità che mantenne salda la propria identità; dal punto di vista della memoria storica quegli anni rappresentano un primo momento di relativa obliterazione. A partire dagli anni Settanta i contratti di mezzadria che giungevano a naturale scadenza per limiti di età dei coloni non furono più rinnovati. Da allora la Fattoria ‘segnò all’agricoltura’ i propri lavoratori. Le famiglie degli ex-mezzadri continuarono a vivere nelle case coloniche e nei quartieri del Convento e del Palazzaccio. I nuovi vetrai e ceramisti prestavano opra per la vendemmia e la raccolta delle olive; le donne, a casa, rifinivano le scarpe o rivestivano i ‘fiaschetti’ di vetro verde prodotti nelle vetrerie del piano49. Le condizioni di vita della popolazione rurale di Bottinaccio
migliorarono sensibilmente proprio grazie alla maggiore disponibilità finanziaria derivante dai salari di coloro che lavoravano nelle fabbriche e dagli introiti del lavoro a domicilio delle donne. La Fattoria continuava ad essere gestita come sempre dalle figure tradizionali del fattore, del ‘guardia’ e del ‘terz’omo’.Si affermò una nuova figura di operaio specializzato, il ‘trattorista’, che mandò definitivamente in pensione il vecchio ‘bifolco’. L’introduzione della meccanizzazione, attuata nella Tenuta Frescobaldi già dai primi anni Settanta rese possibile il grande rinnovamento della coltura della vite e provocò una consistente modifica del paesaggio della collina.50
L’impianto dei grandi vigneti moderni fu reso possibile dalla regolarizzazione dei terreni; questa pratica colturale rese necessario il livellamento dei ciglioni e l’eliminazione del reticolo arbustivo ed arboreo della poco produttiva coltura promiscua, sopravvissuto fino agli anni successivi alla seconda guerra mondiale; scomparve buona parte della partizione dei campi scandita dalle vecchie resole poderali rintracciabili ancor oggi sul catasto leopoldino. I movimenti di terra provocarono in qualche caso anche la scomparsa di interi edifici, testimoni della passata attività della fattoria come la fornace del Lastrino ed il pozzo di Majano. Si diffuse nuovamente la sistemazione del terreno a rittochino. Con i contributi erogati per le bonifiche fondiarie furono realizzati anche due laghetti per irrigazione, uno al Lastrino dove un tempo era stata la ‘Pozzaccia’ ed uno in Borratino (versante di Pietracava). I vecchi ciglioni divennero residuali delle aree dove non si era proceduto all’impianto di coltivazioni specializzate (vigneti o nuovi oliveti). Essi sono ancora presenti in quelle aree dove si è continuata la coltivazione degli oliveti impiantati in epoca antecedente alla meccanizzazione e dove si è garantita una minima manutenzione del terreno senza necessità di interventi più invasivi (Le Rose, ecc.). Fino agli anni Novanta il territorio rimase presidiato dalla stessa struttura organizzativa che, pur di fronte ai rapidi cambiamenti della produzione agricola e della gestione delle risorse, era rimasta sostanzialmente ancorata, dal punto di vista socio-culturale, alle vecchie categorie di gestione mezzadrile. Nel 1988 vennero a mancare i due riferimenti dell’identità socio culturale della comunità: l’ultimo priore residente di Bottinaccio (don Bruno Tacci) lasciò la chiesa. e la Fattoria di Montecastello fu venduta ad una società per azioni multinazionale che ridusse l’attività dell’azienda agricola in vista di una riconversione di tipo turistico. Il 1988 può essere quindi considerato il termine conclusivo del cambiamento sociale ed economico avviato fin dai primi anni Sessanta. In questo anno avvenne anche un altro evento significativo: il 15 giugno 1988 la Soprintendenza per i beni artistici e storici delle provincie di Firenze e Pistoia prelevò dalla prioria di Bottinaccio una “tempera su tavola cm. 89 x 64” raffigurante la ‘Madonna col Bambino’, opera di Filippo Lippi della metà del Quattrocento. Di fronte a questa Immagine sacra innumerevoli generazioni di giovani contadine si erano inginocchiate a pregare per i loro bambini lattanti. Il ‘prelievo’ di questo dipinto sigillò emblematicamente la fine della comunità mezzadrile di Bottinaccio.
L’incerto futuro di Bottinaccio tra tentazioni speculative e necessità di tutela. La Montecastello S.p.A. aveva l’obiettivo dichiarato dello sviluppo turistico della collina e progettava la riconversione della villa in un relais di lusso con dependences nelle case coloniche, il Palazzaccio si sarebbe trasformato in una spa alla moda e sulle piagge asciutte e sassose di Casaccia, Terralba e Torricella sarebbe sorto un bel campo da golf da 18 buche. Gli affittuari delle coloniche e dei quartieri del Convento e del Palazzaccio furono sfrattati, fu ridotto il numero degli operai agricoli. Il faraonico progetto (verosimilmente buono più come materiale mitografico per future leggende elaborate nel canto del fuoco, piuttosto che razionale progetto di sviluppo) ebbe nella realtà esiti ben diversi. La Villa, il Convento e Le Rose subirono una sbrigativa ristrutturazione che poi non ebbe alcun seguito. Il Convento fu venduto, il Palazzaccio e le coloniche furono vandalizzati e un po’ per volta crollarono. L’azienda agricola fu chiusa e gli ultimi operai furono licenziati. Cessò così la manutenzione delle resole, dei fossi e dei ciglioni e si innescarono fenomeni di erosione e di frana anche molto estesi che ricordano i guasti del territorio lamentati alla fine del Settecento. Nel breve volgere di pochi anni il territorio, non più presidiato dal personale della fattoria, fu depredato ed iniziò un processo di degrado che non si è ancora arrestato. Recentemente la Montecastello S.p.A. è stata posta in liquidazione coatta e si è aperta una fase in cui l’assenza di una proprietà definita e la conflittualità di competenze tra enti preposti alla vigilanza, lascia aperto un varco al vandalismo ed all’abuso da parte dei soggetti più vari. Attualmente l’attività agricola è limitata ad una parte della tenuta di Montecastello (vigneti, oliveti e seminativi) dati in affitto ad una azienda di Montespertoli che gestisce le terre con mezzi meccanici propri.
Come già avvenuto ciclicamente nel passato, il paesaggio della collina di Bottinaccio sta mutando per cause naturali. Alla fine degli anni Sessanta gli olmi campestri furono attaccati dalla grafiosi51 che, dopo un periodo di remissione di una ventina di anni (1990-2010), ha ripreso virulenza e sta falcidiando la totalità degli esemplari adulti. Le gelate intense dell’inverno 1985 provocarono la morte di moltissime piante di olivo; i ricacci spuntati al piede delle piante secche furono allevati a tre polloni per pianta modificando la
fisionomia degli oliveti che persero la classica forma ‘a vaso’. Il cosiddetto cancro dei cipressi52 mise a serio rischio le cipressete di Bottinaccio negli anni Ottanta e Novanta ed è ancora presente su numerosi esemplari, fortunatamente con una netta regressione della patologia. In questi ultimi anni la cocciniglia corticicola (Matsuccoccus), diffusasi dalle pendici del versante NordOvest (Sammontana) ha colpito i pinastri dell’intera collina e sta rapidamente eliminando la quasi totalità degli esemplari che cadono a centinaia rendendo spesso difficoltoso il cammino sui sentieri; la moria dei pinastri sta sconvolgendo le consociazioni del bosco e ne modifica macroscopicamente l’aspetto. Il paesaggio di Bottinaccio nella seconda metà dell’Ottocento si modellava su un territorio plasmato da secoli di lavoro agricolo; il suo ordito fu pensato e costruito a tavolino dai possidenti più intraprendenti (laici ed ecclesiastici), con investimenti di capitali a volte assai consistenti. La trama sottile del tessuto identificativo di questo paesaggio fu però prodotta e mantenuta dall’estenuante lavoro, dalla fatica e dalla capacità manuale dei contadini e dei loro familiari che nulla possedevano. I coloni, i camporajoli ed i pigionali erano depositari di competenze legate ai vari aspetti della pratica agricola e forestale.53 La relazione tra popolazione residente e territorio rimase sempre fortissima nel corso degli anni e passò indenne attraverso i grandi cambiamenti determinati dall’evoluzione storica, economica e sociale di oltre un secolo, perché rimase costante il presidio del territorio da parte di coloro che tale territorio utilizzavano per il proprio lavoro e per la propria vita. La secolare relazione tra paesaggio e microsocietà locale non esiste più nei termini di rapporto economico e sociale tra territorio e comunità locale. Questa relazione si è allargata al comprensorio intercomunale di Empoli, Montelupo e Montespertoli. Il paesaggio che si dispiega sotto i nostri occhi, nel suo continuo divenire, è oggi modificato dall’abbandono delle colture e dal forte impatto antropico derivante dalla massiccia urbanizzazione della piana empolese dove si sta ormai saldando la conurbazione Prato-Firenze-Pisa. I frutti ben visibili di questo connubio sono le vigne ridotte a forteto, i tagli abusivi del bosco, la scomparsa delle fungaie e delle tartufaie, l’abbandono diffuso di rifiuti, il degrado dell’arbusteto usato per le piste abusive di motocross e per le disfide domenicali di soft air durante le quali si disperdono nell’ambiente miriadi di pallini bianchi non biodegradabili. L’incuria e l’indifferenza con cui ci si avvicina alla risorsa naturale conducono al depauperamento di un grande patrimonio comune a tutti. Una miope, ignorante e malintesa idea di sviluppo ha portato alla distruzione completa di interi edifici storici; le ristrutturazioni selvagge e gli ampliamenti clandestini delle vecchie coloniche, l’allargamento di interi tratti delle vecchie strade vicinali, l’indiscriminata asportazione, distruzione o modifica di manufatti antichi come le targhe dei tabernacoli, i superstiti lacerti della cortina medievale del villaggio, i resti dei lavatoi e delle serre, stravolgono ed obliterano le testimonianze che hanno segnato la storia sociale delle nostre campagne e dei nostri antenati. Il cambiamento è la categoria principale dell’esistenza umana ed è quindi naturale che anche il territorio evolva in base alle nuove caratteristiche della comunità, allargata su scala comprensoriale, che lo frequenta e lo utilizza. Bottinaccio ha una plurisecolare tradizione di accoglienza che nel passato si esplicitava nelle feste e nei pellegrinaggi e può ben assorbire oggi la moderna pressione antropica purché l’approccio al territorio sia rispettoso delle sue peculiarità naturalistiche e storiche. Nonostante gli sfregi al patrimonio storico e ambientale arrecati negli ultimi anni dai fattori sopra accennati, l’area di Bottinaccio e più in generale il sistema collinare tra Turbone e Orme, sul confine dei Comuni di Montespertoli, Montelupo ed Empoli, conserva un grande valore paesaggistico e storico, meritevole proprio per la sua fragile bellezza, non solo di maggior tutela ed attenzione da parte delle competenti autorità ma anche di maggiore e più partecipe consapevolezza e sensibilità da parte di tutti noi.
1 sta in: AA.VV./Acqua e paesaggi della memoria a Montespertoli._ San Gimignano, Nidiaci, 2014 2 Recentemente sul rilievo degli Scopeti,in prossimità di S. Piero, nel comune di Montelupo, dove nell’Ottocento si trovava la villa-fattoria di proprietà del senatore Leonetti di Prato, è stato edificato un intero borgo costituito da appartamenti nuovi in stile ‘toscano’. L’antica villa-fattoria è stata rasa al suolo. 3 G. ROMAGNOLI, L’acqua di Bottinaccio, uso e gestione dell’acqua in un villaggio contadino, 2013 (pubblicato in proprio per la Parrocchia di S. Andrea in occasione della festa di S. Maria della Pace), p. 10. Il saggio, presentato nel maggio 2012 durante il convegno “Archeologia in Valdelsa” sarà prossimamente pubblicato per i tipi della Miscellanea Storica della Valdelsa. 4 La legge 203 del 1982 sanciva la fine del contratto mezzadrile con proroga di dieci anni (10 novembre 1993) per i contratti dove il colono prestava solo un terzo delle sue ore lavorative per la conduzione del podere. 5 I tre dipinti sono di proprietà della famiglia Frescobaldi. Le riproduzioni sono tratte da D. FRESCOBALDI, F. SOLINAS, I Frescobaldi, una famiglia fiorentina, Firenze, Le Lettere, 2004.
6 L. FALSETTI, Appunti inediti. L’architetto Luigi Falsetti partecipò al progetto di ristrutturazione della villa di Montecastello. 7 D. VELLUTI, La cronica domestica di Messer Donato Velluti, a cura di I. Del Lungo e G. Volpi, Firenze, Sansoni, 1914, pp.
102-103. 8 Il titolo marchionale concesso dai Medici nel 1680 sotto il predicato della ‘Capraja’ fu modificato nel 1888 sotto il titolo
di ‘Montecastello della Pineta’ (Inventario dell’archivio Frescobaldi, a cura di I. Marcelli, 2007). Attualmente il parco della Ragnaja è costituito da lecci. 9 G. PINTO, Ordinamento colturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana del tardo medioevo in Contadini e proprietari nella Toscana moderna: Atti del convegno di studi in onore di G. Giorgetti, Firenze, Olschky, 1979, pp. 221-225. 10 P. PIRILLO, Forme e Strutture del Popolamento nel Contado Fiorentino, Firenze, Olschky, 2005. 11 Il vivaio era presente nei conventi dove serviva per conservare il pesce che la comunità consumava durante i numerosi giorni di magro. Anche presso il Convento di S. Maria della Pace era stato costruito un vivaio sul lato S dell’edificio (1600 circa). Il sostantivo ‘vivario’ deriva dal latino vivarium, vivaio. Il toponimo ‘Bottinaccio’ si afferma dagli inizi del XIV secolo, deriva dal sostantivo tardo latino botte, attestato dal VI secolo, manufatto idoneo a contenere acqua. Il termine buctinus, attestato dal 1226, indica un tunnel di captazione dell’acqua scavato nel sottosuolo ed anche un «ricetto d' acqua, o pozzo murato, e chiuso» (Vocabolario dell’Accademia della Crusca); (G. ROMAGNOLI, L’acqua di Bottinaccio, cit. p. 7). 12 Altri confinanti erano: gli Allegranti, fornaciai di Samminiatello, a Quarantola; Giuseppe Rigoli, la famiglia Bicchierai, Maria Bitossi di Montelupo, Giuliano Ricci, Cosimo e Gaetano Romagnoli (ARCHIVIO STORICO FAMIGLIA FRESCOBALDI, da ora ASFF, 19). 13 E’ la via comunitativa del Lastrino (tuttora esistente) che portava da Montecastello a S. Maria a Pulica. 14 Richiamata dal Rescritto del 15 dicembre 1785 pubblicato con notificazione del 23 gennaio 1786. 15 Si utilizzavano in particolare le frasche di acero e di olmo campestre, di orniello e di numerose essenze arbustive. Nelle annate in cui la produzione di ghiande era particolarmente consistente (annate di ‘pasciona’) esse erano raccolte e conservate per essere usate come mangime del bestiame stabulato. Questo uso è continuato fino all’epoca contemporanea. 16 “[…]Queste cataste devano esser lunghe braccia sei, alte braccia due, larghe braccia uno e mezzo. Il padrone non gradisce vedere alzate nei boschi le cataste di un terzo, di un quarto, di mezza catasta, vuole ed ordina che sieno alzate a seconda della misura sopra indicata, senza tanti complimenti ragionamenti ed intendiamoci. Pure devonsi lasciare le porrine che merita il bosco acciò si formi delle querci per la pasciona tanto utili per l’interesse dei maiali e altre bestie, oltre il lavoro da costruzione che va a formarsi con il tempo, non volendo seguitare il sistema tenuto da pessimi amministratori di tutto depauperare come è seguito nei soli boschi dei Frescobaldi […] I coloni non devono tagliare genere alcuno nei boschi senza aver ricevuta licenza dal fattore il quale all’occasione del taglio del bosco può consegnare loro quello che gli occorre per gli strascichi […]” ASFF, 17,(Foglio sciolto privo di sottoscrizione). 17 Dopo la soppressione del 1808 i frati lasciarono il Convento nel 1810; dopo alterne vicende, l’edificio fu acquistato dal Frescobaldi e ridotto a quartieri per pigionali. 18 Oltre che dalle fattorie della zona, le cave furono probabilmente sfruttate anche da famiglie di fornaciai di Montelupo e Samminiatello (Bitossi, Corradini, Allegranti) che risultavano proprietarie di fondi nel territorio esaminato. Si veda la nota n. 11. 19 ASFF, 17. 20Dalle ricerche sin qui effettuate non è stata reperita in ASFF la data di costruzione della fornace del Lastrino. che risulta in attività nel 1810 (ASFF, 1895). 21 APSA, Stato d’anime 1832. 22 Nel 1832 nel popolo di Bottinaccio c’erano altre due famiglie coloniche con dieci componenti insediate in due poderi (Scopeti e San Pierino) di proprietà del Senatore Leonetti sovrastanti Sammontana, ubicati in posizione marginale rispetto all’area in esame. 23 Per questo motivo in caso di morte di uno dei coniugi, non erano infrequenti le seconde nozze. Il tragico incidente di Cherubina Tampucci, morta il 23 aprile 1832 sotto una frana all’età di 23 anni, evidenzia bene questa realtà. La giovane contadina rimase schiacciata sotto uno ‘stacco di terra’ mentre aiutava il marito nel recupero di un albero secco sotto la ‘grotta’ del Borratino nel borro del Bucignone. Cherubina lasciò un bambino, Ferdinando, di sette mesi che sopravvisse perché, evidentemente, fu trovata una balia che lo allattò. In quell’anno nel popolo di Bottinaccio c’erano cinque puerpere che erano quindi nella condizione fisiologica idonea ad assumersi l’onere del baliatico. Di queste ben due erano vedove rimaritate. Il marito di Cherubina, Amoddio Nigi di 23 anni, viveva nel podere Amore (proprietà Frescobaldi) insieme ai genitori, alla sorella Maria diciannovenne nubile e al fratello Pietro di 13 anni. Amoddio si risposò dopo pochi mesi ed ebbe altri cinque figli (APSA, Libro dei morti, Stato d’anime 1832 e 1841). 24 APSA, Stato d’anime 1841. 25 Il censimento del 1841 fu il primo ed unico rilevamento ufficiale del Granducato che descrisse la popolazione toscana nel suo complesso. Fu portato a termine dai parroci, riconosciuti come ufficiali di stato civile (motu proprio del 18 giugno 1817). 26 Si veda il caso della famiglia di Massimiliano Giuntini nel saggio di P. GENNAI, La comunità del Pino ed il suo pozzo, nota n. 29. 27 I mobili in legno di cipresso diventano comuni solo dalla fine dell’Ottocento. Agli inizi dell’Ottocento nelle case dei contadini l’armadio non era un mobile comune perché essi non avevano quasi niente da metterci dentro. Erano invece comunissime le ‘casse’ per la biancheria. Completavano il modesto arredo poche seggiole impagliate. La descrizione dell’arredo è desunta dall’inventario redatto nel luglio 1829 in morte del priore Pietro Guerrazzi (ASPB, Inventario
Guerrazzi). Ben poco era cambiato dal Quattrocento, come si evince dagli inventari dei beni di famiglie contadine dell’epoca analizzati da M. S. MAZZI e S. RAVEGGI in Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento, Firenze, Olschki, 1983, pp. 200-217. Si veda in particolare l’inventario di beni ereditali redatto in morte di Maso di Pitacco del popolo di S. Giusto a Montalbino (1458) in cui si descrivono mobili, masserizie, arnesi e scorte alimentari presenti nella casa al momento della morte di Maso (pp.351-353). 28 Nella tavola n. 3 una delle donne reca appunto una mezzina di ‘coccio’. I catini e le catinelle erano insieme alle mezzine i diffusissimi contenitori per l’acqua, utilizzati per innumerevoli usi. Per le tipologie ceramiche si veda F. BERTI, Storia della ceramica di Montelupo: uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo, Montelupo, Aedo, 1997-2003, vol. 2°, pp. 214-219, tavv. 362,366,371, 373,383; e vol. 3° pp.221-226, tavv.410-412. Si veda anche: M. VIGNOZZI
PASZKOWSKY, Montelupo e il suo mestiere venuto dal fango. Le fornaci e il resto nel tempo dell’industria. in Sette secoli di ceramica a Montelupo: cultura, design e industria in un territorio fiorentino, a cura di F. Berti e M. Paszkowsky, Montelupo, Aedo, 2004, pp. 95-96. 29 P. SORCINELLI, Storia sociale dell’acqua: riti e culture, Milano, B. Mondadori, 1998, p. 55 e segg. 30 La tradizionale e diffusissima ‘conca’, invetriata all’interno e provvista di un foro nel fondo, era un accessorio sempre presente nelle case e attestata nella nostra zona fin dal Quattrocento. Si veda per esempio, l’inventario per restituzione dei beni dotali redatto in morte di Michele di Giovanni di Tingo del popolo di S. Maria a Sammontana del 1410, in cui, tra le suppellettili e gli arnesi facenti parte della dote portata a suo tempo dalla moglie Margherita, si indica la “chonca pro buchato faciendo” (M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, Gli uomini e le cose cit. p. 369; si vedano anche le pp. 213-214; 348 e segg.). 31 La leggenda del lago di Bottinaccio fu raccolta nel 1992 da Antonio Landi, ’Tonino’, ultimo ‘guardia’ della Fattoria. Egli sosteneva che tutta la storia gli era stata raccontata dal priore Tacci e che lui stesso aveva visto i tubi di adduzione dell’acqua. Il Landi usava inconsapevolmente due classici espedienti della narrazione orale e cioè la testimonianza ritenuta autorevole anche se lontana nel tempo e la testimonianza personale diretta; questi elementi servono a dare verosimiglianza e autorevolezza a quanto affermato. A differenza di altri racconti come il ‘Ballo degli Ignudi’ o la ‘Tomba di Berto’, l’origine della leggenda del lago ipogeo non è facilmente collocabile in un periodo storico preciso a causa dell’esiguità delle testimonianze sin qui raccolte. (G. ROMAGNOLI, L’acqua di Bottinaccio, cit., pp. 4-5). 32 Si veda la leggenda della Diana di Siena, il torrente ipogeo che si diceva alimentasse le fonti della città e che si poteva sentire scorrere sottoterra nel silenzio della notte. 33 Archivio Storico del Comune di Montespertoli, (ASCM),Serie XX, cat.10, cl.4, fasc. 1. 34 Si veda A. CAGNANA, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova, SAP, 2000. 35 APSA, Stato d’anime 1832. 36 F. MOROZZI, Delle case de’ contadini. Trattato architettonico di Ferdinando Morozzi nobile colligiano, Firenze, Cambiagi, 1770; edizione consultata: Firenze, LEF, 2001. 37 Fonti per la biografia del Pierotti: ARCHIVIO STORICO DELLA COLLEGIATA DI EMPOLI (ASEE) Libro dei battesimi e Stato d’anime 1800. ARCHIVIO STORICO DEL SEMINARIO DI FIRENZE (ASSF),Ar 1359; ARCHIVIO STORICO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE (ASAF), Preti 1. ASFF, filza 19. 38 G. GRECO, I giuspatronati laicali nell’età moderna, in Storia d’Italia, (Annali), vol. 9, La Chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1986. pp. 534-566. 39 Probabilmente la prudenza del Frescobaldi era dettata anche dalla difficile situazione finanziaria della famiglia; le sorti della casata si risollevarono a partire dagli anni Quaranta in particolare grazie all’opera di Giuseppe, Angiolo e Luigi, figli di Matteo e della seconda moglie, Cinthia Rosselli del Turco, “intelligenti funzionari e dignitari della casa di Lorena” (FRESCOBALDI, SOLINAS, I Frescobaldi, cit. p. 263. 40 ARCHIVIO STORICO COMUNE DI EMPOLI, (ASCE), fondo Salvagnoli - Marchetti, carteggio Pierotti. 41 Sull’Immagine della Madonna delle Grazie si veda: G. ROMAGNOLI, Tabernacoli devozionali del Comune di Montespertoli in ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTESPERTOLI, Andar per tabernacoli, Montespertoli, 2000, pp. 34-36. 42 Il 15 maggio 1868 l’Ingegnere comunale, Giorgio Costa presentava al sindaco una perizia nella quale accertava i danni lamentati dal Pierotti e proponeva una serie di soluzioni tecniche per ovviare all’inconveniente (ASCM, Serie XX, cat.10, cl.4, fasc. 1, 1868). Non sappiamo se i lavori furono portati a termine. Carlo Pierotti morì il 18 marzo 1869; oggi il viale non esiste più ed al suo posto c’è solo una modesta resola poderale; le acque di ruscellamento continuano saltuariamente a riversarsi sulla strada della chiesa. 43 ‘Bullettino agrario’, n. 23 (1853). Firenze, Al Gabinetto scientifico e letterario di G.P. Vieusseux, 1853. 44 Queste aree furono coltivate fino agli anni Cinquanta del secolo scorso quando la progressiva meccanizzazione e la fine del sistema mezzadrile ne resero controproducente la coltivazione provocandone l’abbandono. L’arbusteto e poi il bosco riconquistarono allora ampie porzioni di territorio che sono ancor oggi riconoscibili per la presenza degli olivi ormai inselvatichiti che condividono lo spazio disponibile in un’inedita consociazione con i corbezzoli, i lecci e gli ornielli. 45 M. NARDI DEI, Monografia Storica e Statistica del Comune di Montespertoli, Firenze, Tip. Cooperativa, 1873; edizione anastatica Bologna: Atesa, 1981 pp. 152-154 e 163-164. L’industria ‘diffusa’ della paglia da cappelli fu soggetta a periodi di forte sviluppo (1815-1825; 1840-1854 e anni successivi.) e a periodi di crisi (1826-1840). (M. PACINI, Tra acque e strade, Lastra a Signa da Pietro Leopoldo al Regno d’Italia, Firenze, Olschky, 2001, pp. 61-79. C. BACCETTI, Le terre di Montelupo. Società ed economia in una comunità toscana dell’Ottocento, Firenze, Editoriale Tosca, 1991, pp. 103-112). 46 G. ROMAGNOLI, L’acqua di Bottinaccio, cit., p. 11, nota. 47 D. PRETI, L’economia toscana nel periodo fascista, in Storia d’Italia; Le regioni dall’Unità ad oggi, la Toscana, a cura di G. Mori, Torino, Einaudi, 1986, pp. 612-617. 48APSA, Perizia Luigi Montagni, 1922.
49 Indagine condotta da chi scrive dal 1992 al 2012 con interviste somministrate ai membri delle famiglie di residenti. 50 Il mestiere di trattorista non è privo di rischi e pericoli e purtroppo anche a Bottinaccio si registrò un incidente mortale. Il 13 maggio 1976 Mario Forconi, trattorista di 40 anni, sposato e padre di due bambini, morì sotto al proprio trattore in un vigneto tra Terralba e il Lastrino. 51 Malattia fungina diffusa da un coleottero e da contagio radicale tra piante infette. Le piante giovani sono immuni dalla malattia per cui le siepi di olmo non sono in genere attaccate. 52 Il cancro corticale del cipresso è provocato da un fungo, il Seridium cardinale che pare sia stato introdotto in Europa durante la seconda guerra mondiale con le cassette di munizioni delle artiglierie americane. I dati relativi alla fitopatologia delle essenze arboree derivano da: http://meta.arsia.toscana.it/meta/. 53 “[…] Fra noi è frequentissimo il caso che una stessa persona professi vari mestieri e si occupi in più maniere.” M. NARDI DEI, Monografia, cit. p. 165.