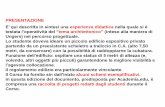elementi di ecclesiologia e di teologia del primato petrino
Transcript of elementi di ecclesiologia e di teologia del primato petrino
CHRISTUS TOTUSElementi di ecclesiologia cattolica
Vito Sibilio
“Il mondo è stato fatto in vista della Chiesa”(Erma)
“Come la volontà di Dio è un atto che si chiama mondo, così la sua intenzione è la salvezza dell’uomo,
e si chiama Chiesa”(Clemente di Alessandria)
Il Cristo totale è la Chiesa e la Chiesa è il Cristo totale.Questo perché la Chiesa è essenzialmente e pienamente ilCorpo Mistico di Cristo. Di tutte le immagini simboliche chela Sacra Scrittura ha adoperato per lumeggiare il misterodella Chiesa questa è senz’altro la più pregnante. Soloconsiderandola un organismo mistico, ossia una strutturastabile di strumenti realmente e misteriosamente uniti aColui Che li adopera, la Chiesa può essere rettamente intesa,sceverando in essa ciò che è essenziale da ciò che non lo è,per cui si configura come una completa realtà umana e divinaad un tempo, una realtà cioè teandrica1. Il grande mistero ecclesiologico promana dunque da quellocristologico, è il luogo del compimento della missionepneumatologica, il frutto di quello soteriologico e siriflette pienamente in quello mariologico e, in subordine adesso, in quello giosefologico. E’ quindi sulla scia di quantoabbiamo detto nei capitoli precedenti che continuiamo lanostra esposizione.
LA NATURA DELLA CHIESA
1 Nel corso dei secoli l’ecclesiologia ha privilegiato alcune definizionipiuttosto che altre. Il Concilio Vaticano II, nella monumentale costituzionedogmatica Lumen Gentium, ha abbracciato e ampiamente esposto il concettoteandrico di Chiesa.
1
Possiamo arrivare a capire la Chiesa come Corpo Mistico soloandando per gradi, solo esplorando dal basso verso l’alto leregioni nelle quali si estende il suo insondabile mistero. La Chiesa è, anzitutto, l’assemblea dei chiamati, di coloroche fanno parte della comunità –universale e locale – cheoffre a Dio il culto a Lui gradito: è questo il senso dellaparola Ekklèsia in greco, che a sua volta rende bene l’ebraicoQal. Essa è infatti la vera Assemblea di Dio, la Qal YHWH2. LaSacra Scrittura illustra bene, con le immagini suggeriteledallo Spirito Santo, la reale dimensione di questa Assemblea;in particolare nell’AT le immagini adoperate sono variantidel tema del Popolo di Dio, su cui ci soffermeremo piùavanti. Ma assai significative sono le figure del NT.Anzitutto quella dell’ovile, la cui porta è Cristo. Essaillustra la prima e unica condizione per essere nella Chiesa:passare attraverso il Redentore e rimanere in Lui. In questoovile tutti siamo dunque custoditi, mentre esso stesso è inGesù. Indi quella del gregge, di cui lo stesso Cristo Dio,adempiendo le profezie (Is 40, 11; Ez 34, 11 ss.), è ilPastore, Che lo guida tramite i capi stabiliti da Lui e Cheaddirittura dà la vita per le pecore, la cui docilità èdunque l’unica risposta possibile a tanta dedizione. Ancoraun’altra immagine è quella del podere o campo o vigna di Dio,coltivato da Lui stesso, datore di vita per le anime. Questoluogo si identifica con ciò che vi cresce: l’Antico Olivo la cuiradice sono i Patriarchi e in cui si rincontrano Giudei eGentili (Rm 11, 13-26); l’Albero di Senape che, nato dal piùmodesto dei semi, è cresciuto sino a coprire tutta la terra esi è trasformato nelle sue stesse strutture, esplicitando ciòche alle origini era nascosto3; la Mistica Vite, di cui il Padreè il vignaiolo e noi i tralci, mentre essa è Cristo stesso
2 Infatti nell’AT è annunciata l’epoca di un’assemblea di Dio degna e pura, chesi realizzerà nell’età messianica, ossia ai tempi della Chiesa.3 Questa è una immagine assai importante per la comprensione teologica dellastoria della Chiesa, come ben evidenziò il grande maestro della materia, ilcompianto Joseph Lortz. La Chiesa ha uno sviluppo storico, nelle strutture enella dottrina, che non è né casuale né infedele alle sue origini, ma legataall’esplicitazione e al compimento del suo mistero, il luogo in cui sicostituisce la Tradizione, che anzi si sostanzia proprio delle trasformazionistoriche della vita ecclesiale ed ecclesiastica, le cui strutture ne sonoun’espressione.
2
(qui siamo ad un passo dal Corpo Mistico), che ci innesta inLui per portare frutto4. Tutte queste immagini hanno in comunel’idea di Chiesa come una realtà organica, viva. Ma la Chiesaè anche l’edificio di Dio, di cui tutti siamo pietre vive e di cuiCristo è la pietra angolare, scartata dai costruttori macapace, per decreto divino, di stritolare chiunque abbia laventura di esserne schiacciato5. L’edificio è fondato sui XIIApostoli, ma è costruito solo da Dio. Il suo basamento visibile,Pietro e i suoi successori, sono cristomimetici, ossia ilRedentore opera per mezzo loro. E’ la Casa di Dio, perché viabita il Suo Spirito; a maggior ragione ne è il vero Tempio,appunto di pietre vive, per il culto perpetuo. Queste figuremettono in evidenza sempre l’idea di unità armonica e sacra.Tale realtà, come architettonicamente strutturata, ancormeglio si esprime nell’immagine della Città Santa, la NuovaGerusalemme, dove Dio vive con gli uomini, contemplatadall’apostolo Giovanni mentre scende dal Cielo, ossia quandodiviene così come l’Altissimo l’ha pensata, alla fine delmondo6. La città esprime ancor meglio la molteplice unitàdella Chiesa e la sua armonia. Questa città è appunto l’umanità nuova, riunita come in unsolo organismo per essere Sposa di Cristo, ossia tutta ecompletamente sua7, per generargli sempre nuovi figli
4 Gesù volle comunicare l’aspetto organico del rapporto tra Lui e noi, ma fuattraverso Paolo che enunciò quelle caratteristiche proprie del Pleroma, del Suovolontario completamento, nell’unità mistica chiamata Corpo.5 In effetti, nessun nemico della Chiesa le è sopravvissuto.6 Sant’Agostino nel De Civitate Dei illustra il mistero ecclesiale come quello dellacomunità che Dio costruisce poco a a poco e che è attualmente mescolata con lacomunità umana, per esserne separata solo alla fine del mondo. Per ora vi èquasi racchiusa. La cristianizzazione della città dell’uomo fece si che essafosse riassorbita nella Chiesa e questa fosse protetta dalla prima, mediante laprovvisoria e impropria concezione della Chiesa come racchiusa nell’ImperiumChristianorum, una ecclesiologia che ancora perdura in Oriente e che si esprimenella cosiddetta sinfonia tra i due poteri, tradizionalmente espressasiattraverso l’egemonia consuetudinaria dell’Imperatore sulla Chiesa. La ChiesaOccidentale si è liberata da questa soggezione incorporando in sé gli elementipositivi della città dell’uomo e realizzando l’indipendenza della religionedalla politica, attraverso l’affermazione della superiorità della prima sullaseconda, mediante il concetto di Cristianità di cui diremo.7 Fu per questo che Cristo non sposò nessuna donna. La Sua Sposa è tuttal’umanità redenta.
3
nell’economia sacramentale di cui è strumento8, e costituirsiquindi come Madre degli Uomini9. Tale Sposa e Madre, nata dalBattesimo e quindi Immacolata, fecondata dallo Spirito equindi Vergine10, è unita al Cristo come ogni donna al suouomo, in modo da fare una carne sola. Infatti la Genesi (2,24) dice: I due saranno una sola carne. E San Paolo annota cheCristo amò la Chiesa dando il modello sponsale per eccellenza(Ef 5, 25-26). Perciò, dopo lo Sposalizio mistico consumatosulla Croce, Cristo e la Chiesa sono un solo Corpo. Biblicamente, ilcorpo è la persona che lo possiede. Perciò la Chiesa si uniscea Cristo in una persona mistica. Questa persona mistica è unasussistenza di relazione, ossia La Chiesa esiste e dura solo perché è legata a Cristo.Senza di Lui è nulla, mentre Lui, senza la Chiesa, sussiste di per Sé, sia come Uomoche come Dio, nella Sua Persona Divina. Uscita dal Costato squarciatodel Redentore Nuovo Adamo, la Chiesa Nuova Eva è da subitounita a Lui in un vincolo eterno, che la costituisce suomezzo unico ed esclusivo di salvezza per tutti. In questoevento si capovolge la sorte dell’umanità traviata dallaColpa: da Adamo fu tratta Eva in modo incruento ed essidiedero la morte a chi nacque da loro, mentre da Cristo futratta la Chiesa in modo cruento, per dare la vita a chirinasce da questa nuova Coppia. Ma, mentre Eva fu unita adAdamo dopo essere stata tratta e separata da lui, La Chiesanasce già unita a Cristo, ne è il riflesso, la continuazione,l’integrazione, la pienezza. Esce da Lui senza diminuirlo osepararsi da Lui11. 8 I redenti non sono figli di Cristo, ma figli in Lui del Padre. Gesù è infattiil Figlio perfetto; la Sua unione sponsale non deve generare una umanitàparallela a quella adamitica, ma innestare quella su di Lui, uomo perfetto. Sulmodello della generazione trinitaria, in cui il Padre genera il Figlioconsostanziale e quindi a Lui unito, così il Cristo dalla Chiesa genera figliinnestati in Lui e non da Lui distinti. Viene così capovolto il paradigma dellagenerazione umana, che separa l’uno dall’altro e moltiplica la colpa attraversola sessualità, con uno schema che unisce e moltiplica la santità attraverso lospirito.9 Si adempie la profezia che fa della Nuova Gerusalemme, la Chiesa appunto, laMadre dei Popoli. 10 Per cui si compie in essa l’archetipo mariano. La pienezza delle prerogativedi Maria SS. trova compimento nella Chiesa, veramente Madre, veramenteImmacolata, veramente Vergine e veramente Santa.11 La nascita della Chiesa avviene per gradi. Anzitutto il Verbo s’incarna e, pervolontà divina, unisce alla Sua Umanità il peso delle colpe dell’uomo espiandolefino alla morte e dispensando, con la Sua presenza, le grazie che preparano la
4
Questo meraviglioso progetto fu voluto da Dio Padre stesso:Egli creò l’uomo perché, modellato su Cristo, gli fosse tantosimile da diventare parte di Lui; perché l’umanità tutta,creata nel tempo, fosse beata nell’eternità per suo gratuitodono. Tale piano, realizzato in Gesù Cristo, è compiutoincessantemente dallo Spirito, che non smette di unire allaChiesa, nonché di guidare e santificare in essa coloro chesono predestinati. Così l’umanità si eleva oltre la natura ediventa Famiglia stessa di Dio, in Cristo, per lo Spirito, colPadre stesso12. In ragione di ciò, la Chiesa nel suo compiersie nel suo destino ultraterreno sono i veri, unici scopi percui Dio Uno e Trino ha fatto il mondo, gli obiettivi in vistadi cui Egli guida con Provvidenza i fatti storici, non perchéessi debbano sboccare nell’eterno, ma perché, con immensaliberalità, Colui Che creò l’universo volle elevarlo fino aSe’, proprio tramite questo mistero13. Tale elevazione avvieneattraverso il suo componente più alto, l’uomo, che èintegrato in Cristo. Egli, tramite tale elevazione, sirealizza in tutte le cose, le riunisce a Sé, restaurando emigliorando l’armonia originaria tra Dio, uomo e naturaturbata da Adamo. Tale mistero fu prefigurato e preparatonell’Antica Alleanza, ma realizzato solo in Gesù. Egli, Uomoe Dio, è l’unico e vero Fondatore della Chiesa14: annuncia ilRegno che in essa si manifesta e compie; sceglie i XIIfase successiva. In essa il Redentore, che ha compiuto la Sua missioneaddormentandosi sulla Croce, ha forgiato l’Umanità nuova, la Chiesa,prototipicamente presente solo nella Sua Madre, che però già riceve in Sé tuttala grazia destinata agli altri eletti. Qui diciamo che la Chiesa è tratta dalCostato di Cristo e, nello stesso momento, gli è condotta in Sposa con unvincolo di stabile sussistenza che fa dei due un solo Corpo. Dalla Pentecoste inpoi la Chiesa è manifestata e costituita in pienezza e i doni della Graziascorrono tra gli uomini ad essa uniti. 12 Si compie così la natura prototipica della Sacra Famiglia di Nazareth, nucleodella Chiesa, i cui membri sono i soli, all’epoca, pienamente incorporati estabilmente sussistenti in Cristo, che li ha adornati di grazie specialissime invista del loro compito sussidiario alla Sua azione salvifica. 13 La Provvidenza con cui Dio regge il mondo naturale sfocia così in unaprogettualità soprannaturale e ha in essa la sua suprema ragione di essere.14 Non esiste soluzione di continuità tra l’opera di Cristo e quella degliApostoli, ma solo sviluppo. La fatidica affermazione dei modernisti: “Cristoannunciò il Regno ed è venuta la Chiesa” non solo è dogmaticamente eterodossa,ma storicamente inesatta. Cristo è il Regno, ma esso si realizza solo nellapienezza della Chiesa, perché tramite essa si innesta in ogni uomo, per cuipossiamo dire che il Regno è in noi.
5
Apostoli e Pietro loro Principe; istituisce i Sacramenti chela vivificano; si immola per essa, risorgendo vittorioso econtinuando a nutrirla di Sé nell’Eucarestia; manda il SuoSpirito perché scorra in essa come linfa. Perciò Cristo nonsolo fonda la Chiesa, ma ne è il Fondamento. Il Suo Spirito,Che vuole le medesime cose del Padre e del Figlio stesso,accetta di essere mandato nella Chiesa e vi compie tutte lefunzioni abbondantemente descritte nei capitoli precedenti,parlando di Lui e della Giustificazione15. In questa maniera iDivini Tre compiono, Ciascuno nel Suo modo proprio, nellaChiesa, il Loro piano di salvezza. Tale piano si compiràdefinitivamente quando, finito il mondo e separato il granodalla zizzania, la Chiesa tutta sarà nella gloria, formata datutti gli eletti, come Pleroma del Cristo, ad opera delloSpirito, per gloria del Padre. In attesa di quell’evento, la Chiesa rimane nella storia,anche se contemporaneamente la trascende, immersa in essasecondo la logica dell’Incarnazione, carica di tutta larealtà umana, per interagire con essa, fecondarla, animarla,salvarla. Tale dimensione è anche la matrice della suacontinua prova: immersa nel mondo, spesso in molti suoimembri e persino in molte sue strutture essa ne ècondizionata o appesantita16. Ma, in virtù della Grazia,questo appesantimento non rimane fine a se stesso, macontribuisce, a dispetto di satana, alla realizzazione deldisegno di Dio nel mondo. Per questo, come dicevo, la storiadella Chiesa è storia e teologia insieme, mentre la teologiadella Chiesa è teologia e storia insieme17. In ragione di ciò, la Chiesa è contemporaneamente più cose,ognuna delle quali si colloca nella profondità dellaseguente: comunità organizzata18, ceto dei fedeli, società sui15 Ispirazione e composizione della Scrittura e della Tradizione; illuminazionedel Magistero; dispensazione della Grazia.16 Questo perché non tutti i chiamati (battezzati) sono eletti, in quanto nonpredestinati. Sono in un certo senso membri provvisori della Chiesa, suecomponenti di certo infedeli.17 La storia della Chiesa può essere capita solo con una formazione teologica ela teologia deve per forza confrontarsi con la storia, perché in essa Dio sirivela e la Sua Rivelazione vi rimane.18 San Roberto Bellarmino diceva che la Chiesa è una comunità alla stessa streguadel Regno di Francia o della Repubblica di Venezia. Sant’Agostino nel De CivitateDei la chiamava anche Res Publica Fidelium.
6
generis eppure reale19, Corpo Mistico20; essa inoltre si dispiegain più livelli spazio-temporali: la terra, il purgatorio, ilcielo21. Per tale ragione, come dicevo, è una realtàteandrica. In essa si realizza il mistero dell’unione degliuomini con Dio, perché tramite lei tutte le cose sonoricapitolate in Cristo, in quanto innestate in Lui; ma ancheperché, in virtù dello sposalizio mistico tra la Chiesa eGesù Cristo, la prima partecipa della sua misteriosasussistenza in un modo particolarissimo, per cui esiste inLui, con Lui e per Lui, per mediazione della Sua Umanità.Questo significa non solo che Gesù, in quanto Dio, vuole cheessa esiste, ma che non vuole che esista fuori di Lui in sensoontologico, ossia che il modo di esistere della Chiesa, lasua stessa essenza, la sua natura, è di esistere in relazioneal Redentore, come ho già detto. Inoltre, ogni membro dellaChiesa è, in essa, anch’egli orientato ad essere stabilmenteunito a Cristo e, tramite Lui, al Padre nello Spirito: è atale scopo che, come vedremo, sono compiute, nella Chiesa,tutte le azioni sacramentali e spirituali.
19 Papa Leone XIII, nelle Encicliche Satis Cognitum e Divinum Illud, nel quadro dellacrescente separazione della Chiesa dalla società laica, evidenziò come la primasia essa stessa ceto dei fedeli e vera società, con i diritti delle societànaturali più quelli che Dio le ha concesso: mantenere e difendere la propriaidentità, diffondere la propria dottrina, governarsi liberamente, dotarsi diproprie strutture, educare i propri membri, professare il proprio culto,amministrare la propria giustizia, compiere opere di carità, animare la culturae le forme della vita sociale, politica ed economica, relazionarsi con gli Statie le altre confessioni religiose, finanziarsi, avere dei beni, essereindipendente dalle interferenze degli altri gruppi umani, difendersi dai proprinemici. La natura della Chiesa come società è tale da permettere che in essa nonci siano solo membri singoli, ma interi altri gruppi umani (Stati, popoli,nazioni, stirpi, famiglie, organizzazioni varie) formate da battezzati. La lorosomma è la Cristianità, la comunità politico-culturale dei cristiani che vivono neltempo secondo la propria fede. Essa è parte della Chiesa, che però la trascendee la supera, estendendosi anche laddove i cristiani sono minoranza. Questanozione è insegnata dal magistero papale da Giovanni VIII (872-882) in poi,particolarmente da Gregorio VII (1073-1085), Urbano II (1088-1099), InnocenzoIII (1198-1216), Gregorio IX (1227-1241), Innocenzo IV (1243-1254), BonifacioVIII (1294-1303), Clemente V (1303-1314), Giovanni XXII (1316-1334). Su questotema hanno insistito tutti i Papi almeno fino al Concilio Vaticano II.20 Pio XII (1939-1958) sviluppò il rapporto tra Corpo Mistico e Chiesa nell’enc.Mystici Corporis (1942), superando la dicotomia tra Chiesa visibile e invisibile,secondo la lezione patristica, per esempio di san Bernardo di Chiaravalle.21 E’ la nozione di Comunione dei Santi che approfondiremo dopo.
7
Tale scopo determina la funzione stessa della Chiesa, che èsacramento di salvezza universale, mysterion. Ossia è per suotramite che agisce e si manifesta l’opera salvificadell’Umanità Santa e Santificante di Gesù Cristo, per operadello Spirito. In poche parole, lo Spirito, mandato daCristo, unisce a Lui le membra mistiche e opera tramite loroe in loro. Questa opera si compie appunto coi sacramenti, cheformano e innestano le membra nel Cristo. Egli cioè genera il SuoCorpo per sussistenza, non per sostanza. Esse non sono Dio, ma sono in CristoUomo e Dio, e quindi sono rivestite della Sua Umanità e Divinità. La Chiesa,che appunto così ne risulta, quasi che il Capo replicasse Sestesso in ogni membro, contiene e comunica la Graziainvisibile, che è appunto la Vita di Cristo in noi. Perciòappunto è essa stessa sacramento (in senso analogico). Essaraduna tutti gli uomini nel Nuovo Adamo, Che se ne serve aSuo piacimento. La Chiesa, per volontà del Suo Mistico Capo,si accresce continuamente. In tale ottica si comprendono perciò meglio le tre figurechiave per interpretare tutta la natura della Chiesa: Popolo diDio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito. Il Popolo di Dio è tale perché non si identifica né con unarazza, né con una lingua, né con una nazione, né con unacultura, ma con Dio, Che l’ha fatto proprio, quale nazionesanta, stirpe eletta, sacerdozio regale. In esso si entra non pernascita, ma per rinascita, ossia per il Battesimo. Il suo Capo èil Cristo, e quindi il Popolo stesso è messianico, ossia untodi Spirito Santo, perché il vincolo che lo lega al suoSignore è più forte di ogni vincolo analogo terreno. Ha comecondizione la figliolanza divina, estesa a tutti i suoi membri. Lasua Legge è quella di Mosè, di per sé naturale anche serivelata, ma elevata e integrata con quella soprannaturaledella carità. Ha la missione di salvare il mondo,propagandosi in esso. Il suo fine è il Regno di Dio, ossiaesso – che è Cristo stesso - si realizza pienamente nellaChiesa, fino alla beatitudine di tutti gli eletti. TalePopolo è sacerdotale, perché i suoi membri sono consacrati a Dioe al Suo culto, santificando e santificandosi in tutte lecose; è profetico, perché annuncia la Fede professandola,approfondendola, diffondendola e vivendo in attesa del suo
8
compimento; è regale, perché domina su tutte le cose,schiacciando il peccato, diffondendo la verità, servendo isofferenti e soffrendo esso stesso per la salvezza del mondo;in tutti questi aspetti, il Popolo è uniformato a Cristo. In virtù di questa conformità e di questa unionestrettissima, il Popolo di Dio, il cui Capo appunto è Cristo,senza cessare di essere popolo, ma divenendo qualcosa di più,è -ancor meglio- Corpo del Capo Suo, ossia appunto CorpoMistico, organismo reale. Solo così diviene realmenteuniforme a Lui ed è gradito al Padre, al Quale è unitoproprio tramite Cristo, Che è Suo Figlio. Questa comunione tra noi e Lui è reale: noi siamo realmenteassociati alla Sua vita, depositari dei Suoi segreti,partecipi della Sua missione, della Sua gioia, delle Suesofferenze; siamo edificati in Lui perché ci nutriamo di Luinell’Eucarestia e quindi siamo trasformati per ciò chemangiamo e beviamo; in noi scorre la Sua Grazia come unsangue; abbiamo la Sua stessa Madre; siamo saldati a Luiperché abbiamo il Suo stesso Spirito, il Medesimo Che uniscePadre e Figlio e Che, nella Chiesa, ci fa Membra delRedentore in modo quindi più reale di quanto un membro delnostro corpo umano sia parte di noi stessi. Tale unione si èrealizzata proprio quando Gesù, salito al Cielo, ci ha potutomandare lo Spirito, unendoci a Lui. Questa unione ha trecaratteristiche ontologiche: tutte le membra sono unite anche tra loroin quanto unite al Capo – per cui il bene e il male che compiamogiovano o danneggiano invisibilmente tutti- il Capo è solo Cristo –per cui partecipiamo al Suo primato ma dobbiamo seguire laSua strada di morte e resurrezione, mentre Lui stessoprovvede alla nostra crescita così come ognuno di noi cura leproprie membra- la Chiesa è Sposa di Cristo – per cui, come dicevamo,l’unione tra noi e Lui è analoga a quella tra marito emoglie, che sussistono in un nuovo soggetto vivente pur nellaloro distinzione essenziale, mentre da tale connubiocontinuamente sono generati nuovi figli. Il suggello di talematrimonio tra l’Agnello e la Sposa è stato il Sangue versatoper gli uomini. Cristo e la Chiesa formano quindi quello cheall’inizio chiamavamo il Cristo Totale, la pienezza di Colui Cheha voluto che tutte le cose si realizzassero in Lui. Siamo
9
diventati Cristo (sant’Agostino), perché Egli presentò SeStesso quasi come unica Persona unita alla Chiesa assunta inLui (san Gregorio I Magno), ossia divenendo una sola Personamistica con lei (san Tommaso d’Aquino), in quella che hochiamato una sussistenza di relazione. Infatti non solo laChiesa esiste in Cristo e noi nella Chiesa, ma questatotalità tra Lui e la Chiesa si rapporta in modo univoco alleAltre Persone Divine e all’umanità. Cristo, per il Padre e loSpirito, è una cosa sola con la Chiesa. Costei, per il mondo,è una cosa sola con Cristo. Senza la Chiesa, Cristo non operané è conosciuto nel mondo. Questo Mistico Corpo perciò vuole,sente e comprende in Cristo come una sola cosa (Bernardo diChiaravalle)22. Opera cioè in Lui, con Lui e per Lui, sia chepreghi, sia che agisca, sia che patisca, sia che gioisca,venendo a completare ciò che manca alle azioni del Cristostorico e costituendone il completamento e il prolungamento,sia in questo mondo che nell’altro, così da collaborare allaRedenzione e alla Salvezza di tutti gli uomini, a cominciaredai suoi membri, che agiscono l’uno a vantaggio dell’altro.Quando poi il mondo terminerà, il Pleroma regnerà con Cristonei secoli dei secoli.Il segno maggiore di questa realtà ineffabile, che eleva ilgenere umano ad una dignità sublime, è il fatto che in noitutti e singoli abiti lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo.E non abita in noi come in una dimora occasionale, ma comenella dimora a Lui più consona, ossia, come abbiamo detto, inun Tempio, svolgendo nel Corpo Mistico la funzione di unaMistica Anima, principio di vita, in quanto risiede e operatotalmente e perfettamente sia nel Capo che nelle Membra esimultaneamente in loro. Egli inoltre risiede solo nellaChiesa e fuori di essa nel mondo non è presente da nessunaparte in tal maniera, per cui essa è la Sua sacra dimora:come si trovò bene in Cristo, così in noi, a Lui uniformati,si trova altrettanto bene. Svolgendo le funzioni Sue proprienella Chiesa, lo Spirito ne mostra la natura sacrale: Egliopera infatti solo in questo sacro recinto. Essa è il Tempiofuturo contemplato da Ezechiele. E’ Lui Che fa si che ogni22 In tal maniera furono superate le dispute trinitarie e cristologiche, sisvilupparono le strutture dell’unità ecclesiastica, si superarono scismi e siprofessa infallibilmente l’unica fede.
10
membro svolga la sua funzione specifica, diversa per grado eruolo. In ragione di ciò, la Chiesa si struttura, a secondadelle funzioni delle sue membra, quale Comunione Gerarchica,sottomessa ai Capi visibili scelti da Cristo nello Spirito,ai quali sono sottoposti sia gli uffici – ossia i compitiistituzionali – che i carismi – ossia i doni liberi emiracolosi che il Paraclito concede per adornare la Sposadell’Agnello. In questa sottomissione all’Invisibile tramiteil Visibile da Lui istituito c’è l’unico criterio perriconoscere se qualcosa o qualcuno sia realmente unito allaChiesa e al Suo Capo23.LE PROPRIETA’ DELLA CHIESA
La Chiesa, in virtù dell’unione con Cristo, ha quattroqualità sostanziali, inseparabili l’una dall’altra: è Una,Santa, Cattolica e Apostolica. La Chiesa è Una, perché il modello e il principio del suomistero è l’Unità nella Trinità delle Persone Divine. Lo èperché il suo Fondatore ha riunificato tutti in un soloPopolo e in un solo Corpo mediante il Suo Sangue versatosulla Croce, e lo è sul modello dell’Unione Ipostatica dellaPersona Divina del Verbo, suo Capo; in effetti, essa stessasussiste nel Verbo Incarnato. La Chiesa inoltre è Una perchéun solo Spirito la abita tutta, la regge in ogni cosa e lariempie ovunque, producendo la comunione delle membra traloro e col Capo, e divenendo Egli stesso principio attivodella Unità ecclesiale. Infine è Una perché tutti mangiano unsolo e medesimo Pane e bevono un solo e medesimo Vino,mostrando di essere un solo e medesimo Corpo. L’Unità dellaChiesa si manifesta nel tempo attraverso la Professione diuna sola Fede trasmessa e codificata dagli Apostoli, mediante23 La dicotomia tra Chiesa visibile e invisibile, portata oltre il punto dirottura dalle ecclesiologie protestanti, specie in quelle basate su unasoteriologia deterministica, è qui così superata. Lì l’appartenenza alla Chiesaè solo un fatto formale, in quanto nessuno sa se predestinato (Calvino) onessuno si salva se non per fede (Lutero). Qui l’universale chiamata allasalvezza esige un’ altrettanto universale sottomissione a dei pastori congiurisdizione di eguale estensione. Chi persevera in tale soggezione, si salva.Chi no, si danna. Tale sottomissione è, sia pure nelle cose dello spirito esecondo le regole sue proprie, col limite della responsabilità della coscienza edella Legge di Dio, è indispensabile alla salvezza (Innocenzo III, BonifacioVIII).
11
la Celebrazione comune del Culto Divino e dei Sacramenti,nella obbedienza ai legittimi Pastori stabiliti da Cristo inSua vece attraverso la successione apostolica nel sacramentodell’Ordine24. Sebbene sia Una, la Chiesa non è priva dimolteplicità intima, garantita dalla pluralità di liturgie,di teologie e di legislazioni canoniche. Laddove però talepluralità si afferma attraverso la negazione della fede(eresia) o dell’autorità legittima (scisma), inevitabilmentel’Unità della Chiesa si rompe e i responsabili, lacerando ilMistico Corpo del Cristo, si separano da Lui per discordia.Se coloro che causarono tali lacerazioni non furono esenti dacolpe – che però esigono sempre di essere contestualizzatenella storia e non escludono responsabilità anche di chirimase nella vera Chiesa – quelli che oggi sono ancora loroseguaci non sono colpevoli se ignorano la natura del loroerrore; anzi presso di essi, fratelli separati, sussistonoancora quei doni che il seme dell’eresia e dello scisma nonha soffocato, per cui essi contribuiscono alla salvezza deicristiani non cattolici e li preparano alla riunificazione.Il processo di unificazione, chiamato ecumenismo, è pertantodoveroso, non perché la Chiesa di Cristo non sia giàcompleta, ma perché coloro che ne sono distaccati possanoritornare alla sua pienezza e lo stesso Cristo abbia sollievonella Sua Passione25. Tale processo si ottiene pregando,soffrendo e operando. Le opere più qualificate in tal sensosono il rinnovamento e la conversione, che eliminano i motividi divisione; la preghiera comune con la sua forza
24 La successione apostolica è l’ordinazione ininterrotta di Vescovi in unacatena che risale agli Apostoli stessi, che per primi consacrarono i Successori.I Vescovi, muniti della pienezza del sacerdozio, ordinano a loro volta iPresbiteri e i Diaconi, garantendo la successione anche per loro, anche se in unpotere sacerdotale non pieno.25 Per secoli concepito come concorrenziale e reciprocamente esclusivo, ilrapporto delle Chiese cristiane solo di recente è stato improntato ad un sanodesiderio di riunificazione. E’ forse la maggiore acquisizione della teologiacontemporanea. Il Concilio Vaticano II, con la Unitatis Redintegratio, ha datoall’ecumenismo il più alto avallo possibile. In quanto alla divisione dellaChiesa e alla Passione di Cristo, questa fu particolarmente cruenta proprio invista di tali lacerazioni ed è misticamente replicata nel dispiegarsi storico ditali eventi. Cristo continua a soffrire misticamente nel Suo Corpo, sino alperpetuo coronamento degli eletti nell’Unità. Unire le Chiese è dunque come unacura delle Piaghe del Redentore.
12
d’intercessione e la conoscenza reciproca che la rendepossibile; la formazione ecumenica e il dialogo teologico26;la cooperazione negli ambiti caritativi. Lo scopodell’ecumenismo è la piena restaurazione in Cristo deicristiani divisi e non va confuso né con forme diimperialismo religioso né di confederazionismo né di irenismoteologico27.La Chiesa è Santa, in modo indefettibile, perché il Santo,Gesù Cristo, l’ha riscattata col Sangue, l’ha unita a Se’,fonte di santità, e l’ha riempita del Suo Spirito Santo. E’Santa, perché, in virtù dell’Unione con Cristo e dellapresenza dello Spirito, è santificante, perché santifica isuoi membri con mezzi santi per un fine santo, essere santicome Dio stesso. E’ Santa perché è perfetta nel Suo Capo enella Madre Sua, perché molti suoi membri sono santi in modoautentico e sono canonizzati, moltissimi altri lo sono inmodo perfetto e perché comprende anche la folla dei salvatinell’altro mondo. E’ Santa, perché la sua vita è la Carità,che sola sostiene tutte le sue azioni, specie le più sublimi,che senza di essa non sarebbero possibili. E’ Santa, purcomprendendo nel suo seno i peccatori; essi infatti sonochiamati alla salvezza, e solo con la loro morte potrannoessere realmente e definitivamente espulsi dal Mistico Corpo;fino ad allora, almeno potenzialmente, anch’essi possonocontenere e ricevere la Grazia. Questa convivenza di zizzaniae buon grano nella Chiesa terminerà solo alla fine dei tempi;in vista di essi, la Chiesa stessa ha l’obbligo di vigilaresu se stessa, tramite i suoi Pastori e mediante ogni suomembro, perché si perfezioni ed estirpi da sé ogni difettoche dispiaccia a Dio, causi la Passione e Morte di Cristo,26 Il grande teorico del dialogo fu Paolo VI (1963-1978) nell’Enc. Ecclesiam Suam,una pietra miliare dell’ecclesiologia contemporanea . 27 La Chiesa è disponibile a rivedere le forme concrete della sua giurisdizionein relazione alle Chiese separate eventualmente ritornate nel suo seno (Enc. UtUnum Sint di Giovanni Paolo II) come a rispiegare, all’occorrenza con formulenuove, le verità controverse in modo da renderle condivise, senza però mutilareo modificare il senso della Rivelazione. Tuttavia il World Council of the Churches,come confederazione delle Chiese Cristiane, non è il punto di apprododell’Unità, e perciò papa Pio XI (1922-1939), a scanso di equivoci, rifiutò dientrarvi, senza condannarlo. In quanto all’irenismo e al sincretismo sono essistessi dei gravissimi errori, perché pervertono e falsano la Verità Rivelatamescolandola con l’errore.
13
contristi lo Spirito e scandalizzi gli uomini. Ecclesia semperreformanda.La Chiesa è Cattolica, ossia è Universale, in due sensi. Anzituttoperché in essa sussiste la pienezza del Corpo di Cristo (ilPleroma appunto); tale sussistenza non è data dalla quantitàdei membri, ma dal fatto che essi siano uniti a Cristo –anche un solo uomo, se unito a Cristo, sarebbe “ChiesaCattolica”- e dal fatto che solo in essa vi sono tutti imezzi di salvezza: la vera fede, il pieno culto, il ministeroordinato. La Chiesa è poi Cattolica perché mandata inmissione a tutte le genti, in quanto tutti gli uomini e tuttii popoli sono chiamati da Dio ad entrarvi. Solo così l’interogenere umano sarà ricapitolato in Cristo, Nuovo Adamo. Inragione di queste due forme di Cattolicità, tale attributo èproprio di tutte le parti della Chiesa, a cominciare daquelle locali, ossia dalle comunità radunate attorno alproprio Vescovo, purchè sussistano in esse i mezzi disalvezza ed esse siano in comunione con Cristo tramite il SuoVicario in terra, il Papa. Tale Cattolicità mira, comedicevo, alla missione. Lo sforzo missionario è sorretto essostesso da una riflessione teologica, la missionologia. Essoverte sull’unico vero scopo della Chiesa: annunciare al mondoil Vangelo e battezzare tutte le nazioni per salvarle. Perrenderlo possibile, è legittimo avviare il dialogo culturalecon chi non professa la fede cattolica; esso è ecumenico invista della restaurazione dell’Unità che è essa stessa unobiettivo missionario; tuttavia mentre il dialogo è un mezzoe non il solo, la missione è il fine28. Naturalmente, finchèl’annuncio del Vangelo non li raggiunge, gli acattolici nonsono privi di ogni grazia per la loro salvezza, ma sono, inmodi differenti, uniti alla fonte della salute, in quantoCristo è morto anche per ognuno di loro e vuole salvi tutti.
28 La citata Ecclesiam Suam pone le basi teologiche di questa dia logicità,ancorandola alla prospettiva della conversione dei pagani e superando ilparadigma della conflittualità tra la Vera Fede e quelle false, nonché con leopinioni filosofiche erronee su Dio stesso, non per cedimento all’errore ma peramore dell’uomo, redento da Cristo. Il dialogo è una vocazione della Chiesa, mauna vocazione strumentale. Purtroppo oggi molti lo hanno dimenticato. E questodanneggia la missione. Il rapporto con le religioni non cristiane è statoteologicamente definito dal Concilio Ecumenico Vaticano II con la dichiarazioneNostra Aetate.
14
La Chiesa, con il suo culto e la sua santità, dispensa, inmodo misterioso ma reale, anche ai non cattolici la Grazia,attraverso le vie straordinarie o nascoste. Per esempio la Chiesaè strettamente unita a coloro che, battezzati, nonobbediscono al Romano Pontefice (scismatici) e non professanotutte le verità di fede (eretici); maggiore però è il numerodegli errori professati, minore è l’unione col Corpo Mistico.Al di fuori del novero dei battezzati, in attesa della lucedel Vangelo, sono provvisoriamente uniti in modo imperfettoal Mistico Corpo anzitutto coloro che conservano intatta laVecchia Alleanza (gli Ebrei), poi coloro che hanno mantenutointegra l’alleanza con Abramo nella fede nell’Unico Dio(Musulmani). In quanto a coloro che professano religioni nonmonoteiste, essi, in virtù delle verità naturali che Dio hadispensato loro e che impreziosiscono le loro religioni – lacui origine rimane del tutto umana – partecipano di una qualcerta vera unione nello Spirito Santo e ricevono le grazienecessarie per ottenere la salvezza nell’ascolto della vocedella coscienza e nella disponibilità potenziale a servire ilVero Dio, se e quando si manifestasse loro. Tale grazia èconcessa anche a chi, senza sua colpa, non professa alcunafede. Tutti costoro, quando e qualora conoscano la ChiesaCattolica quale strumento di salvezza e rifiutino diaderirvi, non possono più essere salvi; qualora l’abbraccinoricevono però un mezzo di salvezza più perfetto e unaprospettiva di gloria più alta. Perciò, sia se membriconsapevoli di essa, sia se tramite essa, anche seinconsapevolmente, santificati, tutti gli uomini si salvanosolo tramite la Chiesa. Extra Ecclesiam nulla Salus29. Le religioninon sono tutte uguali, solo la Cattolica è fondata da Dio esalva, e le altre fedi di per sé possono solo causare larovina eterna30. Ragion per cui, chi è nella Chiesa solo colcorpo ma non con l’anima – ossia chi vive in peccato – chi latrascura come mezzo di salvezza (i cosidetti credenti non29 Verità fondata sul Vangelo, dove Gesù impone la Fede e il Battesimo comecondizione di salvezza; sempre insegnata dalla Chiesa e ribadita dal ConcilioVaticano I. La mistica mappa della partecipazione dei non cattolici al Pleromain questo mondo si deve alla Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.30 Insegnamento ribadito di recente dal papa Giovanni Paolo II nell’IstruzioneDominus Jesus del 2000. L’Apostolo Paolo insegnache non vi è altro Nome nel Qualesi può essere salvati.
15
praticanti), chi addirittura la abbandona e la disprezza puressendo stato battezzato in essa (agnostici, atei, apostati,empi) non può giungere alla salvezza eterna. In quanto alleanime che sono nell’Oltretomba, se salve, sono pienamenteincorporate al Mistico Corpo, sia se in uno stato dipurificazione, sia se già nella Gloria. Coloro poi chevissero prima di Cristo in attesa della Sua venuta con unafede in Lui almeno implicita, furono uniti a Lui in modipreparatori ma reali, embrionali rispetto al pieno Corpo, contutti i mezzi allora necessari alla Salvezza, in forme semprepiù perfette succedutesi nei secoli con l’accrescersi dellaRivelazione: l’Alleanza con Noè, quella con Abramo, quellacon Mosè. La Chiesa è infine Apostolica, perché fondata sulla predicazionee la testimonianza degli Apostoli, scelti da Cristo percostituire il Nuovo Israele; perché custodisce e trasmette illoro insegnamento con l’aiuto infallibile dello SpiritoSanto, attraverso la Scrittura e la Tradizione,interpretandola col Magistero; perché è istruita, santificatae guidata dai loro Successori, il Papa e i Vescovi. GliApostoli infatti sono stati scelti da Cristo per continuarela Sua missione, appositamente formati a tale scopo e munitidei Suoi stessi poteri sacerdotali e regali; a loro promisedi rimanere accanto sino alla fine del mondo, impegnandosievidentemente a dare loro dei Successori e a sostenerli. Inparticolare a San Pietro, costituendolo Capo del CollegioApostolico e conferendo a lui solo tutti i poteri che glialtri hanno ricevuto solo insieme a lui e sotto la suaautorità, Gesù Cristo ha affidato la funzione di esserefondamento visibile della Chiesa e Suo Vicario in Terra.Ragion per cui, come dice Nostro Signore nel Vangelo, chiascolta voi ascolta Me, chi disprezza voi disprezza Me e Colui Che Mi ha mandato(Mt 10,40). La missione apostolica ricapitola in sé tutta lamissione della Chiesa. Agli Apostoli incombe l’onere diinsegnare, celebrare, governare, annunziare. I Nomi dei SS.XII Apostoli dell’Agnello sono scritti sui basamenti dellecolonne della Celeste Gerusalemme, ossia la Chiesa: Pietro,Paolo, Giovanni, Giacomo il Maggiore, Andrea, Giacomo ilMinore, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Simone e
16
Taddeo. Essi siederanno in trono a giudicare con Cristo ivivi e i morti, e con i SS. Patriarchi figli di Giacobbe –Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Dan, Neftali,Gad, Aser, Giuseppe e Beniamino- compongono la Corte deiVegliardi che siede innanzi al Signore Dio per tutti isecoli. I loro Successori, senza averne la dignità,partecipano ai loro poteri e vanno venerati per Colui Cherappresentano. Queste quattro proprietà, se sussistono almeno parzialmentein tutte le Chiese cristiane, si trovano pienamente solonella Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica, che è tale inTerra, in Cielo e in Purgatorio, in quanto tutte le animesante, ovunque si trovino, sono in piena comunione solo conlei. Chiamiamo questa Chiesa Cattolica Romana o Apostolica Romana perchè in essa la Sede di Pietro, Roma, esercita un primatouniversale, custodisce senza errori la dottrina del Principedegli Apostoli, ed è indispensabile per la salvezza rimanerein comunione con lei. In effetti, la Chiesa Romana, in quantoChiesa Universale oltre che particolare, ha solo in Dio ilSuo Fondatore, Che operò tramite san Pietro e san Paolo31.Tale Chiesa è essa stessa, anche e realmente ortodossa – perchéseguace della vera fede – ed evangelica – perché basata sulVangelo di Cristo.
I POTERI E LE GERARCHIE DELLA CHIESA
Come dicevamo, la Chiesa è una Comunione Gerarchica,conformemente alla sua natura di Popolo e di Corpo, nei qualii membri e le membra non sono tutti uguali. Ladiversificazione gerarchica è presente sia nell’Oltretombache in Terra. Qui esamineremo quella terrestre. La Sacra Gerarchia della Chiesa è triplice, perché tre sono iPoteri, cui corrispondono altrettanti Uffici, che Gesù Cristoha affidato alla Chiesa stessa, perché li eserciti in SuoNome o, più precisamente, perché Egli li eserciti tramitelei. Essi sono il Potere di Ordine, cui corrisponde l’Ufficio diSantificare, quello di Giurisdizione, cui spetta l’Ufficio di Governare, e
31 Così insegna il Dictatus Papae di san Gregorio VII (1075).17
quello di Magistero, a cui è spettanza l’Ufficio di Insegnare. Dio havoluto ripartire così competenze e incombenze, perché ognunoservisse l’altro nella carità e ciascuno onorasse i Pastorinell’umiltà. Tale struttura gerarchica è lo specchio terrenodella Gerarchia Celeste della quale Dio si serve pergovernare l’Universo; entrambe sono il riflesso dell’ordineintimo con cui le Tre Persone Divine operanoconseguenzialmente in seno all’Unità Divina.Il Potere di Ordine è quello che si esercita nel cultoliturgico e nell’economia sacramentale; l’Ufficio connesso èquello della Santificazione, che dispensa la Grazia aifedeli. La Gerarchia di Ordine è quella basilare, perché è laGerarchia dello stesso Sacerdozio32. A noi non interessano gliaspetti sacramentali e liturgici, ma solo la scansione deigradi. Coloro che sono chiamati da Dio al Sacerdoziocostituiscono il Clero, la parte scelta, della Chiesa, i cuimembri sono detti, dalla radice della stessa parola greca,chierici. Il massimo grado del sacerdozio è l’Episcopato; in essosono costituiti i Vescovi, cioè coloro che sorvegliano.Successori degli Apostoli nella catena ininterrotta delleOrdinazioni, essi dispensano la pienezza della Graziacompiendo tutti gli atti del culto stabiliti da Cristostesso. I loro collaboratori sono i Presbiteri o Preti,costituiti nel Presbiterato, collaboratori dei Vescovi e da loroordinati; in tale funzione sono i Successori dei LXXIIDiscepoli del Signore. Essi compiono le azioni liturgiche piùcomuni, per potere proprio o per delega del Vescovo. Il loronome etimologicamente vuol dire “anziani” e rimanda allafunzione dell’educazione, che spetta a chi ha lo Spirito diDio. Infatti nella Bibbia la saggezza senile non è legataall’età ma al dono di Grazia. Questi due Ordini sono statiistituiti da Gesù Cristo e sono descritti in modo esaurienteda San Paolo nelle Lettere Pastorali. Il terzo Ordine èquello del Diaconato, in cui sono innestati i Diaconi, checompiono etimologicamente un “ufficio di servizio”, ossiacollaborano con Vescovi e Presbiteri nella santificazione delpopolo mediante azioni sussidiarie. Essi sono i Successori32 Le parole sono parlanti: Ordine viene dal latino Ordo, che significa grado;Sacerdozio è lo stato del Sacerdote, cioè di colui che elargisce il sacro ed ècostituito in esso.
18
dei Sette Diaconi istituiti dagli Apostoli agli inizi dellaloro missione e devono essere anch’essi ordinati dai Vescovi.Accanto a questi tre Ordini Maggiori, si collocano gli OrdiniMinori, istituiti dalla Chiesa. Essi preparano i chierici aricevere il Sacerdozio, ma possono essere conferiti anchesolo ai laici per permettere la loro collaborazioneall’apostolato della Gerarchia; in tale prospettiva sonochiamati Ministeri. Essi sono, dall’alto verso il basso:l’Accolitato, proprio degli Accoliti, i principali collaboratoridei Diaconi33; il Lettorato, in cui si collocano i Lettori, chepossono proclamare la Parola di Dio nell’assemblea liturgica;l’Esorcistato, di cui sono insigniti gli Esorcisti, alla cuipreghiera di intercessione è affidato il compito di scacciarel’influsso demoniaco; l’Ostiariato, i cui membri sono gli Ostiari,che hanno il potere di custodire le porte delle Chiesa.Le altre due Gerarchie si innestano su queste, perchéarticolano al loro interno coloro che sono costituiti neivari Ordini, specie i maggiori. La Gerarchia di Giurisdizionesvolge l’Ufficio di Governare, ossia regge il popolo con ilconsiglio, la persuasione, l’autorità e la potestà, fondandoil Diritto Canonico che regola la vita della Chiesa in vistadella salvezza eterna dei suoi membri. Coloro che esercitanola Giurisdizione sono detti Prelati o Presuli, perché sollevatirispetto agli altri, chierici e laici. Al vertice di questacomplessa piramide c’è il Papa, il quale, in quanto Vescovo diRoma, è il Successore di San Pietro, Principe degli Apostoli, e l’erededella sua suprema potestà di “legare e sciogliere (Mt 16, 18-19)34”, ossia appunto di governare, conferitagli da GesùCristo, perché agisse in Sua vece. Il Papa dunque, in quantoPontefice Romano35, è Vicario di Nostro Signore Gesù Cristo in Terra, Sommo33 Un tempo esisteva il grado intermedio del Suddiaconato, proprio dei Suddiaconi, iprimi collaboratori dei Diaconi, il cui stadio introduceva al Sacerdozioordinato fondato da Cristo. Gli Accoliti erano i collaboratori dei Suddiaconi,ma il papa Paolo VI abolì l’Ordine, per marcare la differenza tra i Ministeri egli Ordini. Forse potrebbe essere restaurato.34 Legare, nel linguaggio rabbinico, è proprio l’esercizio di un governo;sciogliere è l’atto dell’insegnare. Per questo tali espressioni di Gesù nelVangelo fondano sia il primato di giurisdizione che l’infallibilità delmagistero papale.35 Il Pontefice era, nella religione romana, “colui che faceva il ponte tra terrae cielo”. Entrato nel linguaggio cristiano, il termine indica il Vescovo. IlPapa è il Pontefice per eccellenza, ma più propriamente è il Pontefice Romano o
19
Pontefice della Chiesa Universale, Capo Visibile della Chiesa Cattolica, PastoreSupremo e Universale. Il suo è l’Episcopato Universale, in quanto eglipuò comandare in Nome di Dio a tutti e a ciascuno, anche secon uno scopo paterno e di servizio alle anime, per cui lochiamiamo Santo Padre e Servo dei Servi di Dio. Infatti ciò che Egliscioglie in Terra è sciolto in Cielo, e ciò che lega in Terraè legato in Cielo36. Perciò lo chiamiamo anche Vescovo dei Vescovi.Rappresentante in Terra di Colui Che è la Santità stessa, cirivolgiamo a lui col titolo di Sua Santità, e di Santo SignoreNostro. Siccome poi il Primato di Pietro, ossia la sua preminenza,è legato alla sua Sede, quella Romana appunto, dettaantonomasticamente Santa Sede o Sede Apostolica, la sua Chiesa èessa stessa associata a tale funzione. Perciò il Papa siserve, per consuetudine, di una serie di collaboratori, aiquali, per diritto divino, può delegare l’azione in sua vece.Essi sono i membri del Sacro Collegio dei Cardinali37 e della CuriaRomana38. Il primo è costituito dai Vescovi delle Diocesivicine a Roma, dai Parroci della Città e dai Diaconidell’Urbe39; essi formano una sorta di Senato ecclesiastico,
il Sommo Pontefice, cioè il capo di tutti i Pontefici, che nell’antica Roma erachiamato anche Pontefice Massimo, un titolo anche usato per il Papa.36 Cfr. Mt 16, 18-19. L’Episcopato Universale è dogma di fede definito dalConcilio Vaticano I (1870). Esso è la Plenitudo Potestatis Ecclesiasticae o Auctoritas SacrataPontificum insegnata dalla Chiesa in relazione al Papato dai Padri, dai Dottori edagli stessi Pontefici, sin dai tempi di san Clemente I (91-101), la cui Letteraai Corinzi – in cui è enunciata per la prima volta tale dottrina ed esercitatala potestà connessa - potrebbe tuttavia essere ancora più antica. Il processo dicentralizzazione amministrativa, non avvenuto nei primi secc. Per vua dellepersecuzioni dell’Impero Romano, iniziato e interrotto per due volte a causadelle invasioni barbariche (IV-V secc.; IX-X secc.), fu riavviato da sanGregorio VII (1074-1085) e mai più interrotto fino appunto al Concilio VaticanoI.37 Sono chiamati così perché sono i chierici su cui si appoggia, come cardini, laChiesa Romana e quella Universale. Le loro riunioni sono dette, come quelledegli antichi dignitari imperiali, Concistori; essi possono essere pubblici,semipubblici e privati; in alcuni casi possono avere poteri deliberanti, masempre sotto l’autorità del Papa. 38 Curia significa “insieme di uomini”; era l’amministrazione della RepubblicaRomana. Ora il termine indica l’amministrazione ecclesiastica papale, con ilsignificativo aggettivo “romana”. Ha una storia millenaria, ed è stataristrutturata da Giovanni Paolo II per l’ultima volta.39 Si articola perciò in tre Ordini, presieduti da altrettanti Decani; il Decanodel primo Ordine è il Capo di tutto il Collegio. I suoi membri sono Principi dellaChiesa, per analogia ai Principi del Sacro Romano Impero, e vestono di rossoporpora per indicare la fedeltà al Papa sino all’effusione del sangue. Spetta
20
nel quale da secoli siedono, in segno di comunione con laChiesa Romana, i maggiori prelati del mondo, e nel quale ilPapa sceglie i suoi collaboratori più stretti; ad essispetta, per legge canonica, l’esclusiva elezione del Papa,per ispirazione dello Spirito Santo40. La seconda è l’insiemedei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il Papanell’esercizio della sua missione; tali uffici sono spessopresieduti e formati dai Cardinali. Dalla Curia Romanadipendono i prelati che agiscono in nome e mandato del Papa:i Nunzi e i Delegati Apostolici, che rappresentano la Santa Sedepresso le potenze secolari e le Chiese locali; i LegatiApostolici, che svolgono funzioni specifiche e spesso rispondonoal solo Pontefice direttamente (Legati a latere); i VisitatoriApostolici, che svolgono funzioni ispettive.In quanto Successori degli Apostoli, i Vescovi sono essi stessi soggettidi giurisdizione. Anche a loro Gesù Cristo diede il potere dilegare e sciogliere, insieme a san Pietro (Mt 18, 18). Perciòessi costituiscono il Sacro Collegio Episcopale, il cui Capo è il Papa;esso, sempre con Pietro e sotto di lui, ha la suprema potestàsu tutta la Chiesa, quella potestà che il Pontefice Romano hatutta quanta anche da solo41. Tale collegialità subentra aquella analoga che contraddistinse il potere degli Apostoli:è perciò di diritto divino. Le modalità di esercizio di talecollegialità spesso esigono una riunione formale, il Concilio oSinodo. Sull’esempio del Concilio di Gerusalemme (At 15, 4-35),tenuto dagli Apostoli sotto la presidenza di San Pietro, laChiesa ha strutturato tutte le sue assemblee episcopali. Lapiù importante è il Concilio Ecumenico o Universale, al qualepartecipano tutti i prelati del mondo; esso è la più altaassise della Chiesa, ed è legittimo solo se convocato o
loro il titolo di Eminenza Reverendissima.40 La riunione elettorale avviene in clausura ed è perciò detta Conclave, ossia“sotto chiave”.41 Il primato dei Vescovi tutti insieme sulla Chiesa è da sempre professato dallaChiesa e si fonda sulla Scrittura, nella quale gli Apostoli tutti insiemedecidono in modo solenne ciò che riguarda la Chiesa. La dottrina del Collegio èstata formulata dal Concilio Vaticano II in modo certo nella Lumen Gentium, anchese non dogmatico. In ragione di essa, ogni forma di Collegialità nella Chiesa,anche parziale, esiste solo in subordine al Papa, ma è realmente efficace e diorigine apostolica.
21
almeno ratificato dal Sommo Pontefice42. Quando questiriunisce tutti i presuli delle Chiese direttamente a luisottoposte si ha invece un Concilio Generale43. Di recente è statoistituito il Sinodo dei Vescovi allo scopo di aiutare il Papa nelgoverno della Chiesa con il suo referenziato consiglio44. Nefanno parte membri eletti e qualificati dell’Episcopatomondiale. Le sue Sessioni si tengono, ogni quattro anni, informa generale ordinaria e, ogni qualvolta il Papa voglia, informa generale straordinaria; inoltre spesso se ne sono convocateassemblee speciali per singole aree geografiche – come quellecontinentali, già ripetute più volte. I Vescovi sono i Pastori delle Chiese locali o Diocesi45; della lorosuccessione apostolica si è detto. Essi esercitano lagiurisdizione ordinaria sui fedeli incardinati nella lorocircoscrizione. Perciò sono chiamati anche Ordinari. Rimangononell’Episcopato anche quando abdicano per ragioni di età esono perciò Emeriti. Sono tutti uguali tra loro; generalmenteeletti e investiti dal Papa e consacrati su suo mandato, inOriente sono chiamati Eparchi e le loro circoscrizioni Eparchie.Tali partizioni amministrative possono essere istituite,divise, modificate, accorpate o soppresse solo dal Papa. Adessi sono equiparati alcuni gerarchi particolari: i Vicari e iPrefetti Apostolici, che sono gli Ordinari delle Diocesimissionari, anche se spesso non sono consacrati Vescovi; gliEsarchi Apostolici, eletti dal Papa per fedeli spesso di ritoorientale, sprovvisti di loro presuli; gli AmministratoriApostolici, nominati dal Pontefice, o Diocesani, eletti dal clerolocale, per reggere le Diocesi in attesa di un nuovo Vescovo;i Prelati Personali, che governano i fedeli appartenenti ad unacircoscrizione non territoriale, la Prelatura; infine alcunihanno il titolo onorifico di Arcivescovo. Accanto all’Ordinario,nelle Diocesi più grandi vi sono gli Ausiliari, spesso condiritto di successione, che lo aiutano nel governo, e iCoadiutori, che collaborano solo per la vita liturgica. I
42 L’Ecumene è tutta la terra abitata. I Concili Ecumenici del primo millenniofurono sempre convocati dall’Imperatore Romano e ratificati dal Papa. Quelli delsecondo millennio sono stati sempre convocati dal Papa e da lui applicati. 43 Per esempio tutti i Vescovi dell’Occidente Latino.44 Fu Paolo VI a volerlo dal 1967. Da allora si riunisce periodicamente.45 Il nome viene dalle antiche partizioni amministrative del Tardo Impero Romano.
22
Vescovi, secondo la Tradizione degli Apostoli, sicostituiscono in organismi collegiali locali, percollaborare. Più Diocesi si riuniscono in una ProvinciaEcclesiastica, retta da un Arcivescovo Metropolita, o semplicementeMetropolita nelle Chiese Orientali, che esercita tale autoritàdi raccordo in nome del Pontefice, dal quale ricevesimbolicamente la stola o pallio; i suoi Vescovi sono dettisuffraganei, perché danno il suffragio o voto nei Conciliprovinciali convocati dal Metropolita ai sensi del DirittoCanonico. Più Province formano una Regione ecclesiastica, i cuiVescovi sono stabilmente riuniti in una Conferenza EpiscopaleRegionale, presieduta in genere dal Metropolita più importante,e che li raccorda per la loro attività. Essa è una specie diSinodo con meno poteri e più stabilità. L’Arcivescovo piùimportante di una nazione è chiamato Primate, è spessoCardinale ed esercita una preminenza più o meno onorifica,sempre in nome del Papa, anche se per dirittoconsuetudinario, a meno che non gli vengano conferiti poteriparticolari. I Vescovi sono riuniti stabilmente nelleConferenze Episcopali Nazionali – a volte di più nazioni – percoordinarsi; esse hanno un Presidente, un Segretario Generale –nominati dal Papa – un Consiglio di Presidenza formato daiPresidenti delle Regioni Ecclesiastiche e si riuniscono nelleAssemblee periodiche dette plenarie. Tali Conferenze sonoraccordate in Unioni continentali molto blande. Senzaperiodicità si riuniscono Concili Regionali o Nazionali46. I Patriarchisono invece i Vescovi delle Diocesi fondate direttamentedagli Apostoli e che, in Oriente, esercitano un primatogiuridico sugli altri presuli della loro circoscrizione. Capidel Popolo di Dio sulla loro terra, i Patriarchi orientalipresiedono Chiese autonome, con un proprio Rito e una proprio46 L’auspicio è che i Concili si riuniscano periodicamente per condannare leeresie, promuovere la missione, disciplinare clero, religiosi e fedeli,reprimere gli abusi liturgici e canonici, progettare la pastorale, programmareopere di carità, evangelizzare la società. Si potrebbero convocare i Sinodiprovinciali annualmente, quelli Regionali ogni triennio, quelli Nazionali ogniquinquennio. Le Conferenze Episcopali raccorderebbero l’esecuzione dei canoni,debitamente approvati dal Papa, a livello regionale e nazionale, mentre ogniVescovo li applicherebbe per le sue Diocesi. Auspichiamo anche che i Primatipossano controllare la disciplina dei Metropoliti e costoro quella dei Vescovisuffraganei. Contemporaneamente, andrebbero snellite le strutture delleConferenze Episcopali.
23
Diritto Canonico, diverso da quelli della Chiesa Latina47.Eletti dai loro Vescovi, i Patriarchi entrano subito incarica, nonostante debbano entrare in comunione con Roma, asegno della loro apostolicità. Il mandato di governare ipropri Vescovi viene però dall’autorità di Pietro. AlcuneChiese Orientali sono rette da Arcivescovi Maggiori48, anch’essieletti dai propri Vescovi ma bisognosi della conferma papale.I Patriarchi orientali governano con l’ausilio di un SinodoPermanente, hanno la loro Curia, nominano all’occorrenza i loroVicari ed Esarchi. Essi convocano i Concili Generali delle loroChiese. Anche gli Arcivescovi Maggiori hanno strutturesimili. Presso le Chiese Patriarcali non vi sono peròMetropoliti. Quelli di diritto orientale sono infattiautonomi: eletti dai loro Concili, sono confermati dal Papa49.Se solo i Vescovi esercitano una piena giurisdizione perchépossono legiferare e istruire processi canonici, esistetuttavia anche una Gerarchia sub episcopale di giurisdizione.47 Quando parlavamo della ricca molteplicità della Chiesa, ci riferivamo proprioa questo. Accanto alla Chiesa Latina, che custodisce la tradizione liturgico-canonica dell’Apostolo Pietro nella Sede di Roma, si collocano la Chiesa Coptacon la Sede di Alessandria d’Egitto, fondata da san Marco Evangelista; la ChiesaGreca Melchita con le Sedi di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, appartenentealla tradizione di Costantinopoli inaugurata dall’Apostolo Andrea; la ChiesaSiriaca, con la Sede di Antiochia, fondata da San Pietro prima di arrivare aRoma; la Chiesa Maronita, rientrante nella stessa tradizione antiochiena; laChiesa Caldea, con la Sede di Babilonia, della tradizione caldea degli ApostoliTaddeo e Simone. 48 Sono l’Ucraina e la Rumena, di tradizione costantinopolitana, e la Malabarese,di tradizione caldea, ma legata alla memoria dell’Apostolo Tommaso in India.49Sono quelli delle Chiese Etiope, di tradizione alessandrina, Rutena, ditradizione costantinopolitana, nonché Malankarese, di tradizione antiochiena. Siauspica che aumentino i poteri dei Patriarchi, replicando in piccolo quelli delPapa, e promuovendo gli Arcivescovi Maggiori al rango patriarcale; i Concilipresieduti da entrambi potrebbero ricevere maggior prestigio. Sarebbe proficuo,a mio avviso, istituire una riunione periodica del Papa coi Patriarchi e gliArcivescovi Maggiori d’Oriente. Per rafforzare le gerarchie orientali, sipotrebbero restaurare le metropolie nei Patriarcati. Il Papa ha rinunciato altitolo di Patriarca d’Occidente – per la Chiesa di Roma – pur esercitando ipoteri patriarcali nel suo ambito di giurisdizione, essendo la Sede di Pietrol’unica Apostolica d’Occidente per tradizione. Il Papa infatti esercita il suoprimato pieno e diretto anche su Chiese Occidentali con rito proprio ma con ilDiritto Latino. In Spagna abbiamo la tradizione liturgica mozarabica, a Milanoquella ambrosiana (esclusiva) e nel Terzo Mondo molti riti ausiliari legati allacultura locale. Con la costituzione Anglicanorum coetibus del 2008 Benedetto XVI haconcesso a molti Anglicani di unirsi a Roma conservando le proprie particolaritàliturgiche e canoniche, creando una sorta di Chiesa autonoma occidentale.
24
Anzitutto ogni Vescovo emana dalla sua autorità apostolicaalcuni organismi che lo aiutano nel governo: la Curia diocesana,il Collegio dei Consultori – al cui qualificato parere si rivolgeper vari responsi – il Capitolo Cattedrale – che riunisce come inun Senato diocesano i sacerdoti che officiano nella ChiesaCattedrale della Diocesi, i quali sono detti Canonici, perchévivono secondo dei canoni o leggi comuni50- il ConsiglioPresbiteriale – in cui siedono i rappresentanti eletti dei suoiPreti. Il primo collaboratore del Vescovo è il Vicario Generale,ossia il coordinatore del governo diocesano. Inoltre, ogniDiocesi è divisa in Parrocchie, caratterizzate da Chiese in cuisi amministrano tutti i sacramenti, retti da PresbiteriParroci, che applicano la giurisdizione episcopale ai fedelilaici di cui si occupano51. Il Parroco agisce su mandato delVescovo, che gli affida una porzione della Diocesi, e puòaffiancargli un Vicario Parrocchiale; quando il clero di unaParrocchia, specie se assai antica, è numeroso, vienecostituito in un Capitolo Collegiale, retto da un Arciprete. Questipuò svolgere anche funzioni ispettive su più Parrocchie oChiese rurali. Le Chiese in cui non si può battezzare sonosussidiarie delle Parrocchie e sono guidate da Rettori o Vicari.Tutto il clero di una Diocesi si riunisce, senzacalendarizzazioni, in Sinodi diocesani, così come i Presbiteri diGerusalemme si riunirono con gli Apostoli nel Concilio52. Il Potere di Magistero insegna la verità e condanna l’errore;perciò è connesso all’Ufficio di insegnare. Esso custodisceil Deposito della Fede. Già quando parlammo della teologiafondamentale, distinguemmo tra magistero ordinario estraordinario, per cui qui non c’è bisogno di ripetere taliclassificazioni. Mi limito a rammentare che il Magisterostraordinario dichiara, pronunzia e definisce i Dogmi di Fede,50 Dotato di grande prestigio, il Capitolo ha quattro dignità, l’Arcidiacono, l’Arciprete,il Penitenziere, il Primicerio, con varie funzioni, amministrative, giudiziarie,liturgiche e sacramentali, oggi in parte decadute. Il Capitolo è retto da unPresidente. I Canonici sono nominati dal Papa per indicazione del Vescovo.51 Parrocchia e Parroco sono parole greche che indicano la vicinanza alla casadei fedeli. 52 La disciplina del clero e l’incremento della vita religiosa esigerebbero unaconvocazione del Sinodo più frequente, almeno due volte l’anno. Analogamente, ipoteri degli Arcipreti sui propri canonici o sulla propria giurisdizione, comequelli dei Parroci sui loro chierici, potrebbero essere rafforzati per la tuteladella disciplina canonica.
25
ossia le verità rivelate e quindi indiscutibili, ed èinfallibile e indefettibile. Il Papa, in quanto munito delpotere di “legare e sciogliere” in Terra e Cielo, quandodefinisce un dogma riguardante la Fede o la morale, èinfallibile e indefettibile, per l’azione dello SpiritoSanto, per cui le sue decisioni sono irreformabili,indipendentemente dal consenso della Chiesa53. Talidefinizioni sono dette ex Cathedra Petri. Il Pontefice esercitainoltre il magistero ordinario, sia supremo e definitivo, siatransitorio. Il Collegio Episcopale è anch’esso infallibilenell’esercizio del Magistero, sia nel Concilio Ecumenico che inquello Generale, purchè i suoi Dogmi siano ratificati dalPapa54. Anche il Concilio Ecumenico ovviamente ha un magisteroordinario. Fino ad ora, il Sinodo dei Vescovi, in tutte le sueforme, ha sempre svolto un magistero ordinario, conformementealla sua natura consultiva, e i suoi insegnamenti sonoesposti in documenti pontifici. In genere, tutti i Concili –generali, nazionali, regionali, provinciali, patriarcali – sono soggetti dimagistero ordinario, e sulla loro falsariga lo sono anche leConferenze Episcopali, nazionali e regionali. Infine, ogni Vescovo è ilmaestro ordinario della sua Diocesi; egli associa a questosuo insegnamento il suo Sinodo diocesano. La parola di ognipresule, quanto più illuminata, edifica ben oltre i confinidella sua giurisdizione. Questa triplice Gerarchia esercita il suo triplice Potere conl’assistenza dello Spirito Santo in Nome di Cristo. Siccomepoi non solo gli uomini singoli, ma anche le loro societànaturali – come la famiglia e lo Stato – sono incorporati conloro al Corpo Mistico, nella Chiesa terrestre anche esse sonotenute a seguire il Magistero e la Giurisdizioneecclesiastica nelle questioni morali e religiose. Siconfigura perciò una potestà ecclesiastica nelle cose temporali, di naturagiuridica e non sacramentale, che può essere di due tipi:
53 Questo potere, usato solo due volte nella storia della Chiesa, è esso stessooggetto di dogma, definito dal Concilio Vaticano I nel 1870.54 L’infallibilità del Concilio Ecumenico di per sé, con il Papa, non è mai statooggetto di dogma ma è verità attestata dalla Scrittura e dalla Tradizione. IlConcilio Generale solo una volta ha definito un Dogma (649) e i critici lo fannoderivare dal magistero papale più che conciliare.
26
diretta e indiretta55. La prima si ha quando l’Autoritàecclesiastica interviene sanzionando direttamente gliinadempienti, generalmente per promuovere il bene delle animeo per arginare un peccato; la seconda invece si ravvisanell’indirizzo dato ai Battezzati perché operinoconformemente alla loro Fede nell’ambito secolare. Nellamoderna società, in cui molte nazioni hanno assunto lostatuto di laiche (spesso necessariamente in quanto formateda membri di più religioni), vi è spazio per ilriconoscimento solo della seconda potestà, esercitata propriosui fedeli laici e tramite essi. La Chiesa gerarchica loadopera anche per difendere la semplice legge moralenaturale, il cui artefice è Dio stesso, e che quindi èaffidato alla tutela dell’autorità ecclesiastica. In ragionedi tale potere in temporalibus nel NT leggiamo che Pietro, innome della Chiesa, confessa di avere due spade56, che ilSignore giudica sufficienti per compiere la missioneapostolica. Ravvisiamo in ciò inoltre la ragione dellasuperiorità della Chiesa sullo Stato, sebbene si tratti didue entità ontologicamente distinte e svolgenti funzioniseparate. Infatti la Chiesa ha una natura superiore e finispirituali; può inoltre, consacrando il potere laico,elevarlo alla sfera sovrannaturale e inserirlo nell’economiasalvifica e sacramentale; infine può appunto correggerlo,anche se non è detto che sia ascoltata, purché lo faccia perle ragioni citate. Essa è l’Uomo Spirituale, il Cristo Totaleappunto, di cui parla San Paolo, che giudica quello carnale, manon ne è giudicato. Infine, proprio da questa funzione dellaChiesa gerarchica nei confronti dello Stato, deduciamo cheessa può, anche se non necessariamente deve, esercitare unpotere politico, come più volte ha fatto nella Storia. Ilpotere ecclesiastico non è incompatibile con quello civile,anche se il secondo non deve appesantire il primo, perchémezzo e non fine. Nel caso specifico del Papato, tale potere,
55 Sull’argomento l’insegnamento patristico e magisteriale è costante dal V sec.Nelle varie epoche si è insistito ora su una forma ora su di un’altradell’esercizio di tale potere, così come non sono mancati abusi.56 Lc 23, 38. Le due spade sussistono nella Chiesa anche quando i laiciesercitano il potere con la consapevolezza di esservi chiamati da Dio in quantobattezzati.
27
sebbene storicamente condizionato nelle sue forme, èopportuno perché garantisce l’indipendenza del governospirituale, se non addirittura necessario.
RELIGIOSI E LAICI NEL MISTERO DELLA CHIESA
I Religiosi sono membra importanti e significative del MisticoCorpo. Sebbene tutti i fedeli siano chiamati alla perfezionenel proprio stato, soltanto professando i Consigli Evangelici dellaPovertà, della Castità e dell’Obbedienza il cristianobattezzato può raggiungere l’apice della santità. TaliConsigli, che non obbligano nessuno, se seguiti alla letterarendono simili a Cristo Che, da ricco e libero Signoredell’Universo, si fece povero e umile Servo di tutti, vivendonella più completa castità per unirsi solo alla Chiesa,compiendo in obbedienza la piena Volontà del Padre Suo mediantela Morte in Croce. Se ognuno dei battezzati deve esseredistaccato dai beni di questo mondo- non ricercando laricchezza o almeno non compiacendosi in essa- deve sforzarsidi seguire la Volontà di Dio come si manifesta nella propriavita- anche attraverso la voce dei legittimi superiori- devepraticare la castità nel proprio stato nella fedeltàconiugale o nella continenza prematrimoniale, è anche veroche alcuni, per libera chiamata divina – a cui rispondonoaltrettanto liberamente – professano i Consigli in modopubblico, impegnando tutta la loro vita nella ricerca dellaperfezione tramite essi. In ragione di cio’, chi li professaè “legato” in modo particolare a Dio, come appunto indica iltermine “religioso”, in senso etimologico. Le forme dellavita consacrata sono molteplici e suscettibili di modifiche,integrazioni, trasformazioni, ma essa è parte della naturadella Chiesa e perciò indispensabile e immutabile: tramite iltipo di esistenza dei suoi membri, tutto il Corpo Misticovive la pienezza della Santità del Suo Capo in modo stabile.La professione dei Consigli può essere privata o pubblica; sepubblica, solenne o semplice. In entrambi i casi implica il voto,ossia la promessa a Dio, sotto vincolo di peccato grave per
28
l’inadempienza, di osservarli per tutta la vita57. Laprofessione privata può anche essere svincolata da ognilegame giuridico e accontentarsi di una semplice promessa oaddirittura di un proposito. E’una forma di vita in cuil’unione mistica, nascosta ma reale, viene valorizzata almassimo: chi l’abbraccia compie il proprio bene per la Chiesasoprattutto in modo invisibile, ma più reale di qualsiasiforma visibile, perché si fonda sulla potenza dell’offerta disé nell’abnegazione, nel sacrificio, nella preghiera enell’innocenza58. I Religiosi sono, già in questo mondo, inuna forma di vita che anticipa il Cielo, sono su una sorta disoglia, di limen, tra questa vita e l’altra. La forma più antica di tale professione è la vita eremitica.Gli Eremiti vivono separati dal mondo, nel silenzio, nellasolitudine, nella preghiera e nella penitenza, che offronocon Cristo per la salvezza propria e di tutto il mondo. Sonocome Gesù nel Deserto. Ne conosciamo già dal III sec.59
Accanto a loro, sin dalle origini della Chiesa (cfr. 1 Cor 7,34-36), ci sono le Vergini consacrate, che sposano misticamenteCristo nell’assoluta continenza, benedette dal Vescovo con un57 Generalmente preceduto da un voto temporaneo, al termine di un periodopreparatorio detto noviziato, perché l’aspirante religioso sia ben consapevole deltipo di vita da abbracciare.58 Per questo i Religiosi sono spesso aspramente perseguitati e quasi maiincompresi: il mondo e il diavolo rifiuta in loro ciò che diametralmente sioppone al proprio modo di essere. Ma è anche fondamentale che la loro vita siacostantemente monitorata e gli abusi che eventualmente vi allignino venganoestirpati, in quanto essa non ha senso se viene meno alla sua vocazioneascetica, mistica e spirituale.59 Il nome più antico giuntoci è quello di san Paolo Protoeremita, del III sec.La forma eremitica è legata ai deserti, alle foreste, alle isole selvagge e allelande inaccessibili, nonché ai monti e a luoghi impervi. Singolare l’usodell’eremitaggio sulle sommità di alcune colonne, i cui praticanti sono dettiStiliti. I grandi Santi del monachesimo, sull’esempio di Cristo, di Paolo, diElia, di Giovanni il Battista, hanno tutti vissuto periodi di eremitaggio. Aiconfini dell’ecumene cristiano, nei deserti africani o asiatici, in isolesperdute degli Oceani o tra le fitte ombre delle foreste, ancora esistono uominiche cercano Dio per parlagli da solo a Solo. E’ una vocazione altissima, la piùalta. Non può che essere incoraggiata, insegnando che essa è un anticipo diCielo in terra, a vantaggio di tutti, in modo sì invisibile, ma più reale diqualunque altro. Ognuno può, nel suo piccolo, farsi eremita nel silenzio e nelnascondimento della propria casa, nella notte, con la preghiera e il digiuno eil sacrificio, com’è concesso ad anime elette che vegliano ai confini internidella Cristianità, ai bordi di un mondo già reso puteolente dallasecolarizzazione.
29
apposito pubblico rito e dedite alle opere di carità. Per laloro maggior sicurezza, possono vivere associate. Anticamenteanche le Vedove spesso si consacravano al Signore vivendo iltempo che rimaneva loro nella dedizione a Lui. Si parlaperciò di un Ordo Virginum e di un Ordo Viduarum60. Più specificamente, la Vita Religiosa – nata in Oriente nei primisecoli del Cristianesimo61 e poi diffusasi ovunque – sidistingue, tra le forme consacrate, per la professionepubblica dei Consigli con voti solenni o semplici, per lavita comune o cenobitica, per la testimonianza evangelica, peril culto liturgico suo proprio. Coloro che la professano,maschi o femmine, sono i Religiosi propriamente detti e le loroistituzioni sono chiamate Religioni, ed indicano i modispecifici con cui essi si legano a Dio. Tutti i Religiosisono collaboratori del Vescovo diocesano nell’apostolato;spesso i Religiosi sono anche ordinati sacerdoti, per cuidistinguiamo i Religiosi Laici da quelli Chierici; nelleChiese Orientali solo tra i Religiosi sono scelti i Vescovi.Storicamente la prima forma di Vita Religiosa è ilMonachesimo, il cui fine è la fuga dal mondo e ilperfezionamento fuori di esso, non senza che i laici possanoabbeverarsi alle fonti di questa santità mediante il contattocol Monaco, “colui che è solo” con Dio, specie quando èsacerdote62. Egli segue sempre una Regola. In Oriente60 Qui il termine Ordo non indica una organizzazione strutturata, ma unacategoria di persone, che realizza una forma di vita più perfetta, quellacastità virtuosa che già l’Apostolo Paolo considerava la più elevata di tutte,anche se non obbligatoria per tutti, perché orientata alla sola gloria di Dio.Anche oggi bisognerebbe almeno proporre a tutte le vergini e alle vedovecristiane questa vita di virtù. Esso sarebbe anche il giusto approdo da additarea chi, dopo una vita di dissolutezze, anche forzate, chiede di tornare alla casadel Padre. Non a caso infatti prostitute convertite spesso abbracciano la gioiadella continenza.61 Compare già dai tempi della Grande Persecuzione di Diocleziano; esprime lavolontà di ampi gruppi di fedeli di vivere una religiosità più autentica adispetto della minor qualità della sempre maggiore massa dei fedeli.62 L’importanza per la Storia religiosa, ascetica, liturgica, teologica,pastorale, missionaria, ecclesiastica del Cristianesimo, avuta dal Monachesimo,non può essere calcolata. Ad essa va aggiunta una eccezionale valenza politica,culturale, economica e sociale per la Storia umana. La vita monastica, chenecessita di un ciclico ritorno alla purezza delle singole Regole e di unasempre più vivo e frequente ricorso alle riunioni capitolari, dev’essere il piùpossibile diffusa tra i cristiani delle giovani Chiese. La sua testimonianzapotrà vivificare e convertire in modo massiccio.
30
ricordiamo le Regole di sant’Antonio Abate (250-365), che fudapprima eremita, di san Pacomio (290-346), di san BasilioMagno (330-379); in Occidente quella di san Benedetto daNorcia (480-547), applicata poi da tutte le varie famigliemonastiche e più volte riformata. Oggi esistono circacinquanta gruppi monastici orientali e occidentali. In generei Monasteri sono retti da un Abate, un “Padre”, chiamatoArchimandrita in Oriente, eletto a vita, che esercita unapotestà di giurisdizione sui Monaci, con l’aiuto del loroCapitolo, ed è equiparato ai Vescovi; spesso ha anche laconsacrazione episcopale; sempre sono sottoposti solo alPapa63. Quando i Monasteri o Abbazie sono uniti tra loro davincoli confederali si costituiscono le Congregazionimonastiche, accomunate dalla stessa Regola e dotate dispecifiche Costituzioni, spesso su base regionale o nazionale64. Acapo di esse ci sono gli Abati primati. Tale struttura vale ancheper le fondazioni femminili, rette dalle Badesse. I Capitoligenerali delle Congregazioni svolgono funzioni di governo sututti i membri delle stesse. Nel Monachesimo dell’XI-XII sec.i vincoli tra le Abbazie si fecero più forti e, pur nellamedesima tradizione benedettina, nacquero alcuni Ordini, cheunivano i monaci che seguivano certe Regole in tutto il mondocristiano65. Tali istituzioni sono equiparate a pieno titoloalle strutture della Gerarchia di Giurisdizione del Clero e,quando emanino indicazioni dottrinali per i propri membri, aquella di Magistero. Accanto al Monachesimo, a partire dall’XI sec., abbiamo inmodo sistematico i Canonici Regolari, ossia Canonici che seguonouna Regola e vivono in comunità. Essi sono tutti sacerdoti.Dediti all’apostolato nella Chiesa locale, i Canonici sonodediti alla vita contemplativa. Ci sono una decina di lorogruppi66. La Regola più seguita è quella di sant’Agostino (354-
63 Per ragioni storiche di affrancamento dall’alto clero corrotto. Poi come segnodi comunione e servizio alla sola Chiesa Universale. Prima del X sec. imonasteri erano tutti sottoposti agli Ordinari.64 Come quella di Montecassino o di Cava dei Tirreni o di Pulsano, o anche iVallombrosiani e i Camaldolesi.65 Come i Cluniacensi, i Cistercensi, i Certosini, gli Ordini di Grandmont eFontevrault.66 Ricordiamo i Canonici Lateranensi e i Premostratensi. Una particolare formamonastica nata in quel periodo è quella degli Ordini Monastico-Cavallereschi, o
31
430), che la elaborò per sacerdoti che volessero vivereinsieme. Essi hanno le medesime Gerarchie del Monachesimo.Dal XIII sec. esistono gli Ordini Mendicanti, che oggi sonosedici. Essi hanno una struttura ancor più accentrata; leloro fondazioni non sono isolate ma sorgono nelle città(Conventi) e la loro vita è comunitaria, anche se più vicina alpopolo (Frati); anch’essi hanno membri chierici e laici. Ilvalore della povertà è sottolineato, in quanto neanchel’Ordine mendicante in quanto tale può possedere alcunché,spettandogli solo l’usufrutto di beni appartenenti invece alPapato, alla cui giurisdizione sono immediatamentesottoposti67. Le loro Regole più famose sono quelle disant’Agostino – adattata a questo scopo – di san Francescod’Assisi (1181-1226), di san Domenico di Guzman (1170-1221),di sant’Alberto di Gerusalemme (1206-1214). Ve ne sono dimaschili e femminili. Dalla Controriforma nacquero e sidiffusero le Istituzioni Apostoliche – che svolgono un ministero dievangelizzazione, come quelle missionarie o educative- eDiaconali – che hanno compiti caritativi. Ce ne sonocentocinquanta maschili e milleduecentosettanta femminili.Ogni Regola è quasi sempre originale. Nelle IstituzioniApostoliche maschili parliamo di Chierici Regolari, ossia di Cleroche vive secondo una Regola – per esempio i Gesuiti disant’Ignazio di Loyola. La struttura dei Mendicanti e degliIstituti è simile: i Conventi, tramite il proprio Capitolo, sidanno un Superiore; un certo numero di Conventi forma laProvincia, il cui Capitolo elegge il Provinciale, che governa conla propria Curia; il Capitolo Generale di tutta la Religioneelegge il Generale, che governa anch’egli con la propria Curia.I Capitoli Generali approvano, tra le altre cose, leistituzioni di nuove Province, mentre quelli Provincialiratificano la fondazione di nuovi Conventi. Tali istituzioni
Milizia Monastica. Oggi sopravvive solo l’Ordine di Malta, peraltro dedito ad operedi carità e riconosciuto come Sovrano. Diffondere i Canonici Regolari – ossia lavita associata del clero – sarebbe assai opportuno: i sacerdoti si sosterrebberol’uno con l’altro e la loro missione ne sarebbe potenziata. Ovunque è possibiletale vita andrebbe incoraggiata.67 Anche questi Ordini, già molto diffusi, vanno sempre sostenuti, nonmitigandone le forme di vita, ma anzi profeticamente mantenendole intatte, comesegno nel mondo; così attireranno molti membri. Bisogna favorire l’unione dellefamiglie religiose simili – come le francescane – e diffonderli ovunque.
32
sono parte della Gerarchia di Giurisdizione e Magistero,esattamente come quelle monastiche equivalenti; ma i mandatisono quasi sempre a tempo determinato68. Di più recente fondazione sono gli Istituti Secolari, i cui membrivivono nel mondo professando i Consigli Evangelici, assunticon vincoli sacri, mentre mantengono tra loro comunione efraternità. Svolgono una funzione evangelizzatriceall’interno del mondo. Tale forma di vita, legata ai ricordidegli Atti degli Apostoli, si diffuse dal XIX sec. e fuapprovata da Pio XII; conta oggi centotrenta fondazioni69.Infine abbiamo le Società di Vita Apostolica, i cui membri, senzavoti religiosi, si perfezionano secondo un modo proprio, invita comunitaria, seguendo le proprie Costituzioni. In alcunicasi assumono i Consigli Evangelici70. I Fondatori di tutte leReligioni e le Società, una volta che lo Spirito Santo liillumina in tal senso, devono sottoporre il loro progetto divita all’Autorità Ecclesiastica competente, perché essa nonpuò aver senso fuori della Chiesa; le Regole e leCostituzioni, che sono il basamento della vita consacrata ereligiosa, devono essere approvate dal Papa, sia in formasperimentale che definitiva, mentre le Società di VitaApostolica hanno bisogno solo del consenso dell’Ordinario71.Il Romano Pontefice può, naturalmente, sopprimere omodificare l’assetto degli Istituti Religiosi, e deveratificarne gli atti interni, perché essi abbiano vigore, acominciare dall’elezione degli Abati e dei Superiori Generalie Provinciali. 68 La frequenza delle riunioni collegiali è importante e va sempre incrementata.L’osservanza delle Regole e degli Statuti sempre riproposta e mai mitigata. E’bene che la Chiesa approvi sempre tutte le nuove forme di vita religiosaapostolica e diaconale che lo Spirito Santo suscita. 69 Mai si incoraggeranno abbastanza tali forme consacrate di incalcolabile valorein un mondo avvelenato dal secolarismo. Tali Istituti vanno ancor piùseveramente controllati e selezionati, perché più esposti al contatto col mondo.Ma anche in tal caso, con la debita prudenza, vanno approvati tutti quelli chelo Spirito suscita, in quanto la creatività divina è inesauribile.70 Questa forma di vita dovrebbe essere presente in ogni Diocesi. Ogni Vescovodovrebbe fondare una Società. Sebbene poco strutturate, esse pure devonofrequentemente riunirsi perché i membri si sorveglino esortandosi gli uni glialtri.71 Male non sarebbe che esistessero Società di Vita Apostolica ramificate anchein province e regioni ecclesiastiche, se non addirittura su scala nazionale einternazionale, sottoposte a questo punto a istanze superiori agli Ordinari.
33
I Fedeli Cristiani Laici (Christifideles Layci) sono tutti i battezzatinella Chiesa Cattolica che non appartengono né al Clero né aiReligiosi. Il loro nome vuol dire infatti “comuni”, incontrapposizione agli “scelti” del Clero. Tuttavia la lorovocazione non è infima, ma basilare. La Chiesa infatti sirealizza nel Clero, nei Religiosi e nei Laici. Incorporati aCristo nel Battesimo, nutriti dell’Eucarestia, inabitatidallo Spirito, i Laici sono costituiti Popolo di Dio,partecipano della funzione sacerdotale, profetica e regale di Gesù Cristo ecompiono, nella Chiesa stessa e nel mondo, la missione loropropria. In quanto Sacerdoti, essi consacrano a Dio tutto ciòche fanno e vivono, offrendo sacrifici spirituali (si trattaquindi si un Sacerdozio completamente diverso da quello delClero, perché incapace di produrre la Grazia). In quanto Redominano il peccato in sé e nel mondo e fanno fiorire lavirtù. In quanto Profeti, annunziano con parola e opere ilVangelo. Essi operano nelle realtà temporali animandolesecondo Cristo: esse infatti (politica72, economia, società,cultura, comunicazioni), pur essendo illuminate etrasfigurate dal Vangelo, e sebbene siano innalzatenell’economia salvifica se rettamente compiute e vissute, nonsono campo specifico del Clero e dei Religiosi, anzi sonospesso loro esplicitamente vietate. In esse dunque i Laicidevono operare, concretizzando le indicazioni del Magisteroed esercitando la loro libera responsabilità negli ambiti incui esso non può entrare. In modo specifico spetta poi a lorocreare le Famiglie Cristiane attraverso il Sacramento delMatrimonio, modellato sull’unione di Cristo con la Chiesa, incui i coniugi si completano e, accanto alla procreazionenaturale, compiono l’educazione cristiana dei figli, per cuirealmente esse sono delle Chiese Domestiche. In virtù delBattesimo e della Cresima, i Laici sono annunziatori delVangelo e cooperatori dell’Apostolato Gerarchico, a cui sono72 Un tempo la Regalità e l’Impero, consacrati nel rito liturgico apposito,svolgeva una importante funzione a vantaggio della Chiesa. Sebbene laici, iSovrani erano introdotti nell’esercizio sacrale del potere e muniti di unagrazia particolare. L’incoronazione è infatti un Sacramentale, produce la Graziaper le preghiere della Chiesa. Le ultime monarchie cristiane esistenti hannoinvece vergognosamente abdicato ai loro doveri, approvando spesso leggi incontrasto con la Volontà Divina nei loro paesi.
34
sottoposti, nella partecipazione all’amministrazionetemporale dei beni e alla gestione delle attivitàecclesiastiche, nella consulenza per le iniziativepastorali73, nella formazione spirituale e catechetica,nell’animazione liturgica, nella devozione privata epubblica, nelle opere di carità. Queste sono le forme delcosiddetto Apostolato dei Laici. Esso si concretizza spesso ebene nelle forme associate: le Confraternite; le Arciconfraternite74;i Terzi Ordini; le Pie Unioni, Opere e Associazioni; le Associazioni di AzioneCattolica – nelle quali rientrano tutte le organizzazionistrutturate a livello nazionale e internazionale, sia conquesto nome che con qualsiasi altro – gli antichi OrdiniEquestri. Tali Associazioni, fondate anch’esse su mozione delloSpirito Santo, devono essere confermate dall’AutoritàCompetente, che esercita la sua giurisdizione nel raggiod’azione dell’Associazione stessa; i loro Statuti devonoessere debitamente approvati; hanno il dirittoall’autogoverno con organi elettivi o designati, in ogni casosottoposti alla Gerarchia Ecclesiastica. Essa può riformare,modificare, sopprimere ogni tipo di Associazione75. Una menzione particolare meritano i Movimenti Ecclesiali: spessonati – nella seconda metà del XX sec.- solo per i Laici, sisono poi strutturati comprendendo gruppi che professano iConsigli Evangelici e fraternità sacerdotali. Sono un pontetra i diversi stadi di vita della Chiesa76.
73 In Oriente spesso sono inseriti nei Sinodi. In Occidente hanno compiti nelleCurie. La presenza dei Consigli Pastorali, spesso solo parrocchiali, andrebbepotenziata. Sarebbe auspicabile un Consiglio per ogni grado di giurisdizioneecclesiastica, sino al Papato.74 Le seconde sono più illustri per dignità. E’ bene che i loro membri sianooggetto di formazione costante, perché tali appartenenze non siano soloespressione di folklore. I doveri comunitari devono essere rispettati, e ilClero dovrebbe controllare tale adempimento. 75 L’Apostolato dei Laici è sempre esistito. Ma un suo allestimento moderno ecomplessivo, un rilancio, si deve al Papato da Pio IX a Giovanni Paolo II (es.ap. Christifideles Layci) e al Concilio Vaticano II con la cost. Apostolicam Actuositatem.Anche le Associazioni, con una costante verifica interna, una formazioneperpetua, una disciplina morale, una frequente riunione degli organi collegiali,una buona turnazione dei responsabili, una prassi quotidiana di preghieraliturgica e privata, devono costantemente crescere nella vita dello spirito,altrimenti diventano dei circoli ornati di Croci alle pareti, magariattivissimi, ma non graditi a Dio.
35
LA CHIESA COME COMUNIONE DEI SANTI
La Chiesa di cui abbiamo parlato fino ad ora è essenzialmentela Chiesa terrestre, alla quale solo in senso pregnante siaddice tale nome. Infatti, come dicevamo all’inizio, ilPleroma del Corpo Mistico, che è appunto la Chiesa Una SantaCattolica e Apostolica, si estende anche oltre il tempo e lospazio. Nonostante ciò, essa è sempre unita. ChiamiamoComunione dei Santi questa partecipazione indivisa dei suoimembri ai beni della sua unità. I Santi, ossia i battezzati –che, giunti all’altro mondo, hanno la certezza di essereormai eletti perché predestinati – hanno comunione dipreghiera e meriti, a seconda degli stati in cui si trovano.Essi sono tre, corrispondenti ad altrettante Chiese, distintenon per sussistenza, ma per il modo di essere in Grazia deisuoi membri: la Militante, la Espiante e la Trionfante. La Militante è la Chiesa terrestre: essa è in lotta, perché lavita dell’uomo sulla terra è una battaglia, come dice Giobbe.I suoi membri sono quelli che abbiamo descritto; tutti gliuomini, nei modi indicati, vi sono almeno parzialmentecongiunti, se non si oppone la Giustizia Divina; tra i suoiBattezzati non tutti sono Eletti, ma tutti sono Chiamati. Adessa spetta di onorare i membri delle altre due Chiese e dichiederne la protezione.La Chiesa Espiante è la Chiesa delle Anime del Purgatorio. Senzaentrare in merito alla natura di tale espiazione, su cuitorneremo in un altro capitolo, e che è necessaria perrimettere le pene meritate per i peccati mortali perdonati eper i veniali, anche di cui non ci si è pentiti, diremo che76 Ricordo l’Opus Dei di san Josè Maria Escrivà de Balaguer (1902-1985), eretto aPrelatura Personale; il Movimento dei Focolari; Comunione e Liberazione. Anchetali Movimenti hanno bisogno di una intensissima vita spirituale e di unafrequente riunione di organismi collegiali, oltre che di stretti controllidisciplinari. Per molti la Prelatura Personale sarebbe un buon sistema diautogoverno. Si auspica in genere l’istituzione di un organismo di raccordopermanente di tutto il movimentismo e l’associazionismo laicale ed ecclesiale,un’Opera Internazionale dei Congressi del Laicato Cattolico, dipendente dalPontefice, diviso in Sezioni (religiosa, politico-culturale, economico-sociale),con filiazioni nazionali, regionali, provinciali e diocesane, per renderecompatto e poderoso il lavoro dei laici in tutti i settori, sotto l’egida dellaGerarchia.
36
in essa transitano tutte le Anime degli Eletti, ossia dicoloro che, anche fuori della Chiesa visibile, sono vissutiin Terra secondo il volere di Dio e ora si perfezionano,temporaneamente, per un periodo la cui massima durata puògiungere sino al Giudizio Universale. In questo luogo diinvisibile e inimmaginabile tormento le Anime, più saldamenteunite al Pleroma perché non possono più esservi distaccatedal peccato, soddisfano la Giustizia di Dio e perciò sono daLui infinitamente amate. Sono quindi infinitamente più felicidi chiunque in Terra, pur soffrendo più di ogni altro nelMistico Corpo. Essendo Comunione Gerarchica, anche qui laChiesa ha membri diseguali al suo interno: sono riconoscibili coloroche in Terra ebbero un carattere indelebile, in seguito al Battesimo, alla Cresima, alSacerdozio; coloro che formularono voti nei Consigli Evangelici; sono poidiversificati in ragione dell’intensità e della durata delle pene, oltre che per il gradodi gloria a cui sono destinate. A noi terrestri è più evidente laprima differenziazione, per cui parliamo, con compassione etimore, delle Anime più lontane dalla fine dellapurificazione, di quelle più a lungo soggiornanti in essa, diquelle più prossime all’uscita, di quelle più devote e quindipiù meritevoli di compiacenza divina. Spesso tra esse, anchese per breve tempo, soggiornano le Anime dei Santi chesaranno anche canonizzate. Queste Anime possono moltissimo presso Dioper noi e intercedono costantemente, memori anche dei legami terreni; sono in unostato ontologico superiore, libero dal corpo e dal peccato, immuni dall’influssosatanico, partecipi di vaste conoscenze, di ampi poteri, di ardenti sentimenti diperfezione, spesso investite di missioni particolari e capaci anche di manifestarsi edi soccorrere i mortali, ma nulla possono per se stesse. Noi Terrestriinvece possiamo abbreviare la loro purificazione offrendo perloro i nostri Suffragi, con la preghiera, con il sacrificio, con l’elemosina, con lacelebrazione della Santa Messa, con le Indulgenze77. Infatti è
77 L’Indulgenza è la manifestazione più qualificata della Comunione dei Santi. IMeriti di Cristo e quelli da Lui suscitati nella Vergine, nei Santi e negliAngeli costituiscono un Tesoro inesauribile, che può virtualmente coprire nonsolo tutte le colpe, ma anche espiare tutte le pene. Per Divina Ispirazione, laChiesa Terrestre apre tale forziere mistico e concede alle Anime devote diattingervi: compiendo una o più opere buone indulgenziate dall’AutoritàEcclesiastica, e quindi infinitamente più meritevole, il fedele può applicarneil frutto a un Defunto o anche a se stesso. Le condizioni sono quattro: ilcompimento di tale opera (una preghiera, un pellegrinaggio, un’offerta o
37
scritto: Fece offrire il Sacrificio Espiatorio per i morti perché fossero assolti dalpeccato (2 Mac 12, 46). Questa è una carità soprannaturale di grandissimovalore e purtroppo spesso dimenticata. Ma anche noi, se avremo laGrazia di passare per il fuoco del Purgatorio piuttosto chedi finire in quello eterno, quando ci saremo, avremo bisognodi aiuto, e non ne avremo, se non lo avremo per primielargiti. Dio infatti è il dispensatore e l’autore di taliaiuti, ispirandoli e rendendoli efficaci, e non mancherà disoccorrere i generosi e di punire i duri di cuore. EgliStesso poi, liberamente, può concentrare le pene dei Defuntiin tempi più brevi o ridurle per alcune circostanze meritoriedella loro vita - come la devozione mariana o eucaristica oagli stessi Defunti – o per intercessione delle Anime delParadiso. Alle Anime del Purgatorio tutte insieme la Chiesa eleva preghiere,costruisce templi e altari, celebra la liturgia ricordandoli anche in una memoriacollettiva (la Commemorazione dei Fedeli defunti) e garantisce la conservazionedecorosa dei loro resti mortali in attesa della Resurrezione dei Corpi. Tributaloro un culto detto di venerazione. Infatti le Anime Purgantisono degne di onore perché si sono santificate in Terra,perché soffrono per amore di Dio, perché in loro noiveneriamo l’opera del Redentore. In tali onori mai manca tuttavial’azione di suffragio o commemorazione. Ognuno di noi ha il dovere diun culto e di un suffragio privato dei propri defunti, ed èesortato a pregare per tutti i morti, secondo quanto Dio gliispira78.
un’azione caritatevole, ripetute o una volta sola, in certi luoghi o indeterminati momenti o per alcuni periodi, come l’Anno Santo); la Confessionesacramentale con il sincero dolore e il proposito di evitare anche il peccatoveniale (di solito basta solo quello di evitare il mortale o grave); laComunione eucaristica; la Preghiera per le intenzioni del Santo Padre, che apree chiude il Tesoro delle Indulgenze. Esse dunque non sono automatiche, ma legateal fervore del fedele che solo Dio può valutare. Esse possono essere parziali ototali, per disposizione ecclesiastica, se coprono in tutto o in parte il debitocon Dio. I fedeli hanno il diritto di attingervi e il Clero il dovere dipredicarle. Vi sono infatti innumerevoli Indulgenze lucrabili: tutte lepreghiere più antiche sono indulgenziate, almeno con le parziali. Il Rosario, laVia Crucis, la Preghiera al Crocifisso dopo la Comunione hanno tuttil’Indulgenza plenaria; la lettura della Bibbia concede la parziale se duraalmeno un quarto d’ora e la plenaria per più di mezz’ora.78 Il suffragio dovrebbe essere parte della vita quotidiana e costantementeinsegnato. L’antica prassi di celebrare e pregare per i Morti il Lunedì oltreche nel Mese votivo di Novembre andrebbe energicamente ripresa. Lodevole è laconservazione dell’Ottavario per i primi giorni dello stesso mese. Da
38
La terza Chiesa è la Trionfante. E’ la Chiesa dei Santi inParadiso. E’ l’approdo ultimo delle Anime Purganti, la metadegli Eletti della Terra, la massima perfezione per oraesistente del Pleroma, in attesa della Fine del Mondo, quandoi Predestinati, con anima e corpo, saranno tutti con Cristo,realizzando pienamente il mistero della Chiesa in eterno.Allora nella Chiesa Celeste avverrà l’apocatastasi delle altredue, riassorbite in essa definitivamente. Allora la Chiesasarà solo degli Eletti e non più anche dei Chiamati. Fino aquel momento, in questa Chiesa Celeste ci sono solo le Animedei Santi. La natura della Beatitudine del Paradiso – su cuitorneremo in un prossimo capitolo – ci sfugge nella sua piùintima essenza. Sappiamo tuttavia che i Santi non sono tuttiuguali: quelli che vissero con maggior perfezione hanno unagloria più alta. Ma tutti vedono e godono Dio in modo pieno eappagante, senza traccia di infelicità. Alcuni arrivano inCielo senza passare per il Purgatorio. Ma chi sono i membridella Chiesa Celeste?Sotto Nostro Signore Gesù Cristo, il Capo del Corpo che è la Chiesa,la Pienezza di Colui Che si realizza in tutte le cose (Ef 1, 22-23), alla MadreSua Maria SS., Madre della Chiesa stessa, già glorificata inCielo in Anima e Corpo, nonché al Patriarca San Giuseppe, sidispongono i Cori Angelici e le Schiere dei Santi. Dei CoriAngelici diremo la prossima volta: basti dire che l’ArcangeloSan Michele è il più vicino al Trono di Dio, il Santo piùnobile dopo lo stesso Padre Putativo del Verbo Incarnato79.Ora descriviamo il modo in cui le Schiere si mostrano, nelleloro differenti perfezioni, alla contemplazione e allavenerazione dei fedeli della Chiesa Militante e di quellaEspiante, secondo le vocazioni alle quali Dio chiamò in terrai vari loro componenti, mostrando ancora una volta la naturadella Chiesa come Comunione Gerarchica. Noi non possiamo
incoraggiare il Novenario per la Commemorazione dei Fedeli defunti. Ogni Messa eogni Ora canonica dovrebbe avere la sua preghiera per i defunti. Alcunepreghiere sono indulgenziate solo per i Defunti (come l’Adoro Te Croce Santa),mentre nell’Ottavario si può lucrare la plenaria solo per essi. Molte Animeelette fanno l’Atto Eroico di Carità, che offre come suffragio tutti i meritiavuti in vita; costoro hanno per sé la plenaria in punto di morte e alta gloriain Cielo.79 Tra gli Spiriti Celesti, accanto a lui dobbiamo ricordare i Santi ArcangeliGabriele e Raffaele.
39
quantificare la gloria e la perfezione di ciascun Santo, mapossiamo tuttavia indicare l’ordine delle loro categorie. Percui la descrizione della Chiesa Trionfante si può risolverein una agiologia, ossia in una teologia della santità.Anzitutto abbiamo i già menzionati XII Apostoli, che vissero conGesù e sulla cui testimonianza si regge la Chiesa, da essidiffusa nel mondo, i cui membri entrano poi nella vitaeterna. Gli Apostoli alla fine dei tempi giudicheranno i vivie i morti col Figlio dell’Uomo. Nessuno è più Santo degliApostoli; tutti loro resero gloriosa testimonianza colmartirio. Sei di loro scrissero il Nuovo Testamento perDivina Ispirazione. Due di loro – san Matteo e san Giovanni –furono anche Evangelisti, che scrissero due dei QuattroVangeli. Accanto agli Apostoli ci sono coloro che furono soloEvangelisti, ossia san Luca e san Marco, che scrissero appuntogli altri due Vangeli che portano il loro Nome e diedero lavita per la Fede, instancabilmente testimoniata anche da lorofino alla fine. Indi abbiamo i Santi che furono Discepoli delSignore, ossia che gli stettero accanto per tutta la vita, eche pure spesso testimoniarono col martirio la loro fede80. Al di sotto di questa ineguagliabile aristocrazia spirituale,si colloca il Popolo dei Salvati, che forma la cosiddettaMistica Rosa, offerta alla Santissima Trinità e divisa in duesezioni simboliche: quelli che credettero in Cristo venturo equelli che credettero in Cristo venuto. I Santi dell’AT sonocoloro che credettero in Cristo venturo. Essi sono antichissimi e leloro figure spesso misteriose. Li distinguiamo in Patriarchi eProfeti. I Patriarchi da Adamo – e sua moglie Eva – fino a Noèfurono Capi del Genere Umano in una età mitica, durata sinoal Diluvio81; quelli post-diluviani sono della stirpe di Sem,primogenito di Noè82; poi abbiamo i Grandi Patriarchi, i
80 Per esempio Santa Maria di Magdala, Santa Maria di Cleofa, Santa Maria madredi Giacomo, San Cleofa, Sant’Alfeo e molti altri parenti di Gesù. Tra iDiscepoli ricordiamo san Mattia, associato ai XII Apostoli, e san Barnaba. 81 Sono i Dieci Patriarchi dell’Antichità. Di essi conosciamo solo i nomi. A lorova aggiunto il giusto Abele. Tra essi spicca Enoc, che scomparve misteriosamentedal mondo, senza morire in questo mondo.82 Accanto ai tre figli di Noè, Sem Cam Iafet, capostipiti della nuova umanità,si affiancano i discendenti in linea retta dello stesso Sem, da cui discendeAbramo. Anche di loro conosciamo solo i nomi.
40
capostipiti di Israele: Abramo (con Sara sua sposa)83, Isacco(assieme a Rebecca sua moglie), Giacobbe (con Lia e Rachele84)e i suoi Dodici figli, eponimi delle altrettante Tribù diIsraele, a cui vanno aggiunti i Due figli di Giuseppe,Manasse ed Efraim. Questi colossi ebbero spesso l’onore diparlare direttamente con Dio. I Profeti invece sono tutticoloro che Dio mandò al Popolo d’Israele per istruirlo. Laloro schiera si apre con Mosè, affiancato dal fratelloAronne85: egli diede la Legge del Sinai e alla sua parolarisale il Pentateuco; prosegue con Giosuè, che portò Israelein Terra Santa e la conquistò, tramandandone il racconto nelLibro che porta il suo nome; indi abbiamo i Giudici, conSamuele, alla cui testimonianza risale la loro storia equella dei tempi suoi, descritta nei Libri omonimi. Poi c’èla nobile serie dei Re, a partire da David, dalla cuifamiglia nacque il Cristo, e che consta dei suoi eredi giustima anche dei monarchi saggi del Regno del Nord, che sorseroquando questi si divise da Giuda. Dopo costoro abbiamo i veriProfeti: Elia e Eliseo furono i maggiori tra coloro che nonscrissero nulla; poi annoveriamo coloro che redassero LibriSacri, come Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, dettiMaggiori per la mole dei loro scritti, nonchè i XII Profetiminori, tali per le dimensioni dei loro Oracoli86. Allaschiera profetica si aggiungono anche Esdra e Neemia, Tobia esuo padre, i Maccabei sacerdoti e sovrani, le sante donne delVT: Rut, Noemi, Ester, Giuditta coi loro amici: ad ognuno dicostoro risale la narrazione che è contenuta nei Libri a lorodedicati. Dietro questi Santi antichissimi si assiepano tutticoloro che si salvarono nella Vecchia Alleanza, anzi sindalle Origini del mondo sino alla Nascita di Cristo, anchefuori del Popolo d’Israele. La schiera dei Santi Profeti sichiude con san Giovanni Battista, il Precursore, e i suoigenitori, sant’Elisabetta e san Zaccaria. Come un mistico83 Accanto a lui, che strinse con Dio il Patto della Circoncisione, si collocanoil nipote Lot, il figlio Ismaele, sua madre Agar, il re e sacerdote Melchisedec.All’età dei Patriarchi risale anche Giobbe.84 E dalle concubine Bala e Zilpa, oltre che la figlia Dina e la nuora Tamar,nonchè i nipoti Fares e Zamar, figli di Giuda.85 E dalla sorella Maria col nipote Eleazaro.86 Osea, Naum, Abdia, Giona, Zaccaria, Malachia, Abacuc, Gioele, Amos, Michea,Sofonia, Aggeo, nonché il segretario di Geremia Baruc.
41
festone, si dispongono in Cielo gli Avi paterni delRedentore, nonché i genitori di Maria SS., i santi Anna eGioacchino.Inizia poi il novero di coloro che credettero in Cristo venuto. Tracostoro, il posto più alto è occupato dai Martiri, i testimoni,che versarono il loro sangue per la Fede e per la Carità, lecui vesti sono candide perché le hanno lavate nel Sanguedell’Agnello, e che hanno la palma tra le mani. Essa è unaschiera immensa87, aperta da santo Stefano; essi, in virtùdella loro fine, andarono direttamente in Cielo. La loromoltitudine è appunto descritta nell’Apocalisse. Molti deiDiscepoli e tutti gli Apostoli furono anch’essi martiri. E’una schiera in continuo aumento88.Sotto di loro i Confessori, coloro che soffrirono ma nonmorirono per la Fede. Anch’essi sono in continuo aumento89.Tra i Martiri e i Confessori molti furono insigniti delladignità episcopale, ossia furono Pontefici, anche se in ognicaso fanno Schiera a sé. Tra loro i Papi hanno sicuramenteuna dignità particolare. Tra i Pontefici moltissimi furonoDottori della Chiesa, ossia illustrarono la Religione con la lorosantità e la loro dottrina; i più antichi di tali Dottorisono i Padri della Chiesa90. Una ulteriore Schiera è quella dei87 Solo nel disgraziato secolo XX ben quarantacinque milioni di battezzati sonomorti per la Fede.88 Tra i più importanti ricordiamo, attingendo alle Litanie usate nel cultoliturgico e al Canone della Prima Preghiera Eucaristica, gli Innocenti, Lino,Anacleto, Clemente I, Alessandro I e Sisto I papi, Ignazio di Antiochia,Policarpo di Smirne, Giustino, Lorenzo, Crisogono, Vincenzo, Fabiano papa eSebastiano, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, Gervasio e Protasio, Corneliopapa e Cipriano di Cartagine, Marcellino papa e Pietro, Bonifacio, Stanisalo diCracovia, Tommaso Becket, Giovanni Fisher, Tommaso Moro, Paolo Miki, Giovanni diBrebeuf e Isacco Jogues, Pietro Chanel, Carlo Lwanga; tra le donne Perpetua eFelicita, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Maria Goretti. Le Litaniedei Santi fissano i nomi più illustri per il culto ufficiale solenne, mentre ilCanone elenca Santi molto antichi invocati per la celebrazione dell’Eucarestia.Aggiungo per devozione, Gaspare, Melchiorre e Baldassare, Pio I papa, Tarcisio,Vito, Modesto e Crescenzio, Cristoforo, Filomena, Vitale, Adeodato vescovo,Giovanna d’Arco, Massimiliano Maria Kolbe (il primo martire della Carità, perchédiede la vita per un compagno di prigionia condannato a morte), Pio daPietrelcina (il cui martirio mistico di Carità è durato tutta la vita). 89 Nel XX sec. popoli e nazioni intere soffrirono per la Fede, e ancoramoltissime patiscono tale tormento, in Africa e in Asia. 90 Tra costoro ricordiamo coloro che sono invocati nelle Litanie dei Santi:Silvestro I (papa e confessore), Leone I Magno (papa, dottore e padre), Gregorio
42
Sacerdoti, insigniti del Presbiterato, e dei Leviti (Diaconi oChierici), quando i loro membri non facciano parte delleSchiere precedenti91. Accanto a loro, risplendono i Monaci egli Eremiti, tra cui possiamo annoverare tutti coloro chefecero vita religiosa, con particolare riguardo per iFondatori92. Seguono poi le Schiere delle Vergini e delleVedove93. Infine, contempliamo la Schiera dei Santi Laici, checomprende genericamente tutti gli altri94. A questi Santi,detti canonizzati perché inseriti nell’elenco ufficiale oCanone, la Chiesa Militante tributa diversi onori divenerazione, per quello che Dio ha fatto in loro e per ilgrado della perfezione da essi raggiunto: ne rammenta i Nomi
I Magno (papa, dottore e padre), Ambrogio di Milano (vescovo, dottore e padre,confessore), Agostino (vescovo, dottore e padre, nonché monaco), Gerolamo(dottore e padre, ma anche monaco), Atanasio (vescovo, dottore e padre,confessore), Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo (vescovi,dottori e padri), Giovanni Crisostomo (vescovo, dottore e padre, confessore),Martino I (papa e martire, anche tradizionalmente annoverato tra i confessori),Nicola di Mira (vescovo, dottore e padre), Patrizio (vescovo e dottore), Cirilloe Metodio (vescovi e dottori), Carlo Borromeo (vescovo), Francesco di Sales(vescovo e dottore), Pio X (papa). Aggiungo per devozione personale Severo(vescovo), Remigio (vescovo), Massimo il Confessore, Gregorio II, Gregorio III,Leone III (confessore), Niccolo’ I, Gregorio VII (confessore), Pio V, AdrianoIII, Leone IX, Pietro Celestino (vescovo e confessore, nonché monaco), GregorioBarbarigo (vescovo).91 Generalmente un Santo appartiene a una Schiera. Quando può essere annoveratotra più di esse il culto lo ascrive in primo luogo a quella in cui è morto,aggiungendovi poi le altre, nelle quali è stato annoverato in seguito. Costorosono dunque commemorati nella prima Schiera in cui sono inseriti. Per questecategorie Citiamo Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Vincenzo de’ Paoli,Giovanni Maria Vianney, Giovanni Bosco, invocati sempre in quelle Litanie.Ricordiamo pure devotamente Gaspare del Bufalo (sacerdote e confessore), LuigiGonzaga, Leopoldo Mandic, Josè Maria Escrivà de Balaguer.92 I maggiori sono Antonio Abate, Benedetto da Norcia, Bernardo di Chiaravalle(dottore e padre), Domenico di Guzman, Francesco di Assisi, Tommaso di Aquino(dottore). Costoro sono debitamente pregati nelle Litanie dalle qualiattingiamo. Vi aggiungo Antonio da Padova (dottore), Severino Abate, LeonardoAbate, Giovanni Gualberto, Francesco di Paola, Giuseppe da Copertino, FrancescoAntonio Fasani, Luigi Orione.93 Tra costoro si annoverano le Religiose, visto che la verginità è un meritoanche maschile. Nelle Litanie sono invocate Caterina di Alessandria, Caterina daSiena (dottore), Teresa d’Avila (dottore), Rosa da Lima. Ricordiamo perdevozione anche Severina, Matilde di Sassonia, Brigida di Svezia, Chiarad’Assisi, Rita da Cascia, Margherita Maria Alacoque, Veronica Giuliani, CaterinaZoe Labourè, Bernadette Soubirous, Maria Faustina Kowalska.94 Ricordiamo Luigi IX di Francia, Monica di Tagaste, Elisabetta di Ungheria,sempre scelti nelle Litanie. Ricordiamo pure Domenico Savio e Giuseppe Moscati.
43
nelle invocazioni litaniche; innalza loro preghiere; erigeloro chiese e altari; celebra la loro memoria liturgica;venera le loro reliquie – perché lo Spirito di Dio ha operatoin esse e, se corporali, le unirà alle loro Anime nellaGloria – ne raffigura le immagini, munite di aureola. LaGloria dei Santi è infallibilmente proclamata in Terra dalPapa, che ha le chiavi del Regno dei Cieli. Ma non tutti iSanti sono canonizzati ufficialmente: di moltissimi la Chiesanon ha cognizione, ma essi sono egualmente – e ovviamente –gloriosi in Cielo. Al di sotto dei Santi, nel culto della Chiesa Terrestre visono i Beati. Sebbene in Cielo non vi sia necessariamentedifferenza tra loro e sebbene spesso i Beati divengano Santicanonizzati, essi costituiscono una categoria minore dellamanifestazione della Gloria celeste ai nostri occhi. Per essiè autorizzato un culto minore, sempre dal Papa95. Virtualmenteanche tra i Beati si possono distinguere le categorie deiSanti canonizzati96. Sotto costoro la Chiesa Terrestre veneracoloro che praticarono eroicamente le virtù sotto gli occhidel Popolo Cristiano, detti appunto Venerabili. Tra costoro cisono coloro che saranno glorificati come Beati e Santi97.Santi canonizzati, Beati e Venerabili sono coloro dei qualisi può affermare con certezza che sono in Cielo. Di tutto il95 Per la Beatificazione è necessario che il candidato interceda presso Dio perottenere un miracolo a chi lo ha invocato. Un successivo miracolo comporta laCanonizzazione. Il candidato deve essere stato riconosciuto preventivamente comemodello eroico di virtù, ossia Venerabile, come diremo. La Causa di Canonizzazioneinizia, su richiesta del Vescovo, presso il Pontefice, per persone morte in famadi santità, i cosiddetti Servi di Dio (p. es. Felice Canelli, Giovanni Paolo I,Giovanni Battista Tornatore, Paolo VI, Giuseppe e Raffaella Cimatti, MarieMarthe Chambon, Santina Scribano, Matteo da Agnone). Anticamente laCanonizzazione scaturiva dal culto popolare, sancito generalmente dalla morteper martirio, poi dallo stato di Confessore, indi dalla vita verginale emonastica. Poi toccò ai Vescovi decretarla. Furono perciò istituite le Cause.Alla fine tale prassi fu riservata al Papato, per evitare abusi. In essa ilcompimento di miracoli è sempre stato fondamentale.96 Devotamente ricordo tra i Beati i papi Vittore III, Urbano II, Gelasio II,Eugenio III, Gregorio X, Innocenzo V, Benedetto XI, Urbano V, Innocenzo XI, PioIX, Giovanni XXIII; il vescovo confessore Aloijsius Stepinac; il sacerdotemartire Jertzy Popieluszko; il sacerdote Edoardo Poppe; le religiose Maria deMatthias, Rosa Gattorno e Teresa di Calcutta; i laici Bartolo Longo, NunzioSulprizio, Piergiorgio Frassati, Giacinta e Francesco Marto di Fatima. 97 Tra essi menzioniamo i papi Pio XII e Giovanni Paolo II; il sacerdote LeoneDehon; i religiosi Cirillo da Praga e Bartolomeo da Saluzzo.
44
resto della folla dei Salvati, la Chiesa Terrestre fa memorianella Solennità di Tutti i Santi, il Primo Novembre, con iloro più illustri compagni98. I membri della Chiesa Celeste sono quelli di più altolignaggio nel Pleroma. Essi possono intercedere, a richiestao spontaneamente, per i membri delle altre due Chiese.Infinitamente amati da Dio, Lo riamano perfettamente e siamano tra loro; svolgono missioni nei confronti dei fedeliterrestri e purganti, spesso perché scelti dalla ChiesaTerrestre (patroni e protettori); infine mettono i loromeriti a disposizione di tutti gli altri nel Tesoro dellaComunione dei Santi. Spesso si manifestano ai fedeliterrestri in svariati modi – come del resto le Anime delPurgatorio – come visioni, sogni, apparizioni o interventiprodigiosi. Questi interventi, debitamente riconosciuti dallaChiesa terrestre, sono il segno della costante unione deivari membri della Comunione dei Santi. Su di essi svettano isegni che Gesù Cristo stesso e la Madre Sua, assai spesso, sidegnano di concedere a noi, mostrando anche le Loroineffabili fattezze, in attesa di mostrarcele definitivamentenella Gloria eterna.
98 Il numero ufficiale dei Santi e dei Beati sembra superi le ventiduemila unità.Quelli commemorati nel Calendario Universale della Chiesa, ossia festeggiati intutto il mondo, era di centocinquantuno, quando fu modificato da Paolo VI.
45
ADNEXUM II
TU ES PETRUSAppunti per una teologia del Primato di Pietro
“Dice il Signore Dio degli Eserciti:Porrò sul suo omero le Chiavi della Casa di Davide:
se egli chiude, nessuno aprirà;se egli apre, nessuno chiuderà.”
(Isaia 22, 22)
“ Per me, dopo Gesù, non c’è che il Papa.”(San Pio da Pietrelcina)
“Per la sua salvezza, ogni creatura dev’essere sottomessa al Pontefice di Roma.”
(Bonifacio VIII)
LINEE PER UNA TEOLOGIA DELLA STORIA DEL PRIMATO
Tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli Inferi nonprevarranno contro di essa. A te Io darò le Chiavi del Regno dei Cieli, e tutto ciò chelegherai sulla Terra sarà legato nei Cieli e tutto ciò che scioglierai sulla Terra saràsciolto nei Cieli (Mt 16, 18-19). Con queste parole Nostro SignoreGesù Cristo conferì all’Apostolo San Pietro il Primato sututta la Chiesa, dopo che questi, primo tra tutti i fedelinella Storia, ebbe confessato che lo stesso Gesù era appuntoil Messia, il Figlio del Dio Vivente99. Questo primo, puro,incondizionato atto di fede, ispirato non dalla carne né dalsangue – ossia non da realtà terrene – ma dal Padre Celeste,ha procacciato a Pietro l’altissima missione in vista dellaquale il Signore, chiamandolo alla Sua sequela dallacondizione di pescatore, gli aveva cambiato il nome: Tu sei
99 Siamo nel luglio del 29, presso Cesarea di Filippo, a NE del Lago diGenesareth.
46
Simone, figlio di Giona. Da oggi ti chiamerai Cefa, ossia Pietra (Gv 1, 42)100.Questa missione – di Pescatore di Uomini, come disse lostesso Gesù - è quella appunto di edificare la Chiesa, laComunità degli Eletti. Non si tratta solo di costruirla dalnulla, ma di mantenerla come realtà edificata. La frase diNostro Signore infatti allude a un potere eterno, come sonoeterni tutti i poteri conferiti alla Chiesa, che è essastessa eterna e come è eterno il suo confronto con gliInferi, le cui potenze, simboleggiate nelle porte, maiavranno il sopravvento, proprio perché contenute dai poteridivini della Chiesa stessa. Anzi Cristo pone in Pietro enella potestas ligandi et solvendi l’antemurale di difesa dellaChiesa che mai sarà abbattuto. I poteri della missionepetrina sono chiari: legare e sciogliere sono termini rabbinici cheindicano anzitutto il potere di assolvere o condannare concensure i membri della Comunità, e poi quello di proibire opermettere qualcosa, sia in campo giuridico che in campodottrinale, per tutti i fedeli. Ci troviamo appunto dinanzi aquello che abbiamo chiamato il potere di giurisdizioneuniversale e al magistero infallibile e indefettibile diPietro, oggetto essi stessi di dogma di fede. E’ la plenitudopotestatis o auctoritas sacrata pontificum. Le decisioni prese daPietro in virtù di tale potere sono valide in Cielo e quindisono divinamente ispirate: Cristo non volle lasciare solocolui che avrebbe agito in Suo Nome e lo corroborò con unaassistenza particolarissima dello Spirito Santo, il SuoSpirito. E’ da notare che tale potere di legare e sciogliereè conferito anche agli Apostoli tutti insieme, con Pietropresente, per cui essi senza lui nulla possono, ma lui solovale per sé e per loro stessi. Non a caso negli elenchi deiXII nei Vangeli Pietro non solo è sempre il primo, ma èintrodotto esplicitamente con questo numerale in Matteo.L’Apostolo diviene dunque Pietra vivente della Chiesa, basamento cristomimetico: ilCristo infatti è la vera Roccia della Chiesa, ma opera ed è presente in Pietro e quindinei suoi Successori, visto che la durata della vita dell’Apostolonon coincide con quella della storia della Chiesa, sebbene i100 Pietro era sposato e aveva almeno una figlia. Nativo di Bethsaida, discepolodi Giovanni Battista, seguì Gesù che lo chiamò lungo le rive del Lago diGenesareth, dopo il fratello Andrea. La famiglia lo seguì nella missione, anchedopo la Morte e Resurrezione di Cristo.
47
poteri petrini siano a maggior ragione necessari in unacomunità cristiana ben più estesa e strutturata di quella deitempi del Pescatore di Galilea. Ancora nel Vangelo di Luca(22, 32) Gesù Risorto, dopo aver profetizzato a Pietro il suotradimento imminente, gli ordina, una volta ravveduto, diconfermare i suoi fratelli, ossia di esercitare una funzione di guidanei confronti della loro fede, conformemente al linguaggiorabbinico, insegnando loro cosa credere e cosa no. Come giàdicemmo a proposito della teologia fondamentale, non tutto ilmagistero papale è infallibile, ma tutto è autentico e vero,sia nelle parti integrabili dell’insegnamento ordinario, siain quelle solenni dell’ordinario supremo, fino alle formerealmente scevre da ogni errore e difetto dellostraordinario, che può definire o ratificare la definizionedei Dogmi della Fede, parlando a Nome stesso di Dio Uno eTrino. Infine, in Gv 21, il Signore ha con l’Apostolo questotoccante dialogo: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Equegli : Certo Signore, Tu lo sai che Ti amo. E Gesù di rincalzo: Pasci imiei agnelli. E ancora: Simone d Giovanni, mi ami? E Pietro: CertoSignore, Tu lo sai che Ti voglio bene. Al che Gesù replicò: Pasci le miepecorelle. E infine: Simone di Giovanni, mi ami? E Pietro, addoloratoper questa triplice richiesta, che pure voleva compensare iltriplice rinnegamento, disse: Signore, Tu sai tutto. Tu sai che io Ti vogliobene. E Gesù ancora: Pasci le mie pecorelle. A questa reiteratadichiarazione d’affetto seguì dunque la triplice conferma delpotere pastorale, lo stesso potere di Cristo, da esercitarsievidentemente in funzione vicaria, verso le Sue pecorelle e iSuoi agnelli, ossia i servi – essendo il termine greco latraduzione di uno ebraico che ha entrambi i sensi- daidentificarsi con gli altri Apostoli o pastori delegatiminori – visto che i servi sono, biblicamente, proprio coloroche si prendono cura della Casa del Padrone e del Gregge.Dopo, il Signore profetizzò il martirio all’Apostolo, perrenderlo anche in questo simile a Lui. Da quel momento,Pietro fu il Capo indiscusso della Chiesa. Già quando era inTerra Gesù Pietro svolse funzioni importanti (sebbene a voltenon capisse il Messianismo sofferente del Maestro101, i suoi
101 Mc 8, 31-33.48
colloqui con Cristo sono pieni di ardore e zelo102; agì quasisempre da portavoce e capo del gruppo apostolico; fu sempretra i tre intimi di Cristo con Giovanni e Giacomo ilMaggiore; fu mandato a preparare l’Ultima Cena assieme aGiovanni103; fu testimone della Resurrezione della Figlia diGiairo104, della Trasfigurazione105, dell’Agonia delGethsemani106), ma dalla Resurrezione del Maestro, il Principedegli Apostoli godette di una autorità incontrastata.Nonostante il triplice rinnegamento in casa di Caifa –seguito alle tracotanti attestazioni di fedeltà di qualcheora prima – Pietro, che si pentì amaramente subito dopo unfulminante sguardo del Redentore tradotto in lacci innanzi alSommo Sacerdote107, fu il primo a recarsi al Sepolcro vuotoassieme a Giovanni, perché con lui parlò Maria di Magdala108.Fu a lui che il Risorto concesse la prima apparizionepersonale ad un Apostolo, quella che Paolo enumera al primoposto tra quelle che fondano la Fede109. Fu a lui, gettatosi anuoto senza neanche spogliarsi per incontrarlo sulla rivadove era apparso, che Gesù parlò lungamente sul Lago diGenesareth, chiedendogli la triplice dichiarazione d’amore dicui sopra e predicendogli la morte in Croce110. Egli assistetteall’Ascensione di Gesù e presiedette la riunione in cui fuscelto san Mattia come sostituto di Giuda111. Egli prese laparola iniziando la predicazione agli Ebrei dopo il donodello Spirito Santo a Pentecoste112, pronunziando il primo diuna serie di bellissimi discorsi tramandati dagli Atti degliApostoli, ricchi di dottrina e calore umano. Egli continuò102 A lui per esempio Gesù spiega che non era tenuto a pagare il tributo alTempio in quanto Figlio di Dio, ma lo manda a pescare il pesce nella cui boccatroverà la moneta da versare nel tesoro per tutti e due. A Pietro Gesù dàdelucidazioni sulla fine del Mondo nel Discorso Escatologico del Martedì Santo. 103 Lo attestano i Tre Sinottici.104 Mt 9, 18-26.105 Mt 17, 1-8.106 Questo è narrato in tutti e tre i Sinottici.107 La cronaca è in tutti i Vangeli. Marco ci dice che Pietro rinnegò due volteGesù. Luca ci dice dello scambio di sguardi. Giovanni ci spiega come entrò nellacasa di Caifa, prima ancora che Gesù arrivasse.108 Gv 20; Lc 24, 12.109 Lc 24, 34; 1 Cor 15, 5.110 Gv 21. 111 At 1, 1-26.112 At 2, 1-40.
49
per primo la missione taumaturgica del Salvatore, guarendo loStorpio alla Porta Bella del Tempio salomonico113 e iniziandouna serie di prodigiose guarigioni dovute spesso alla suasola ombra sui malati o al solo contatto con il loro corposofferente di oggetti da lui toccati. Fu lui a scomunicareAnania e Saffira, poi fulminati dall’Ira Divina a complementoe suggello della sua sentenza114. Fu ancora lui a condannare lacondotta di Simon Mago, capofila degli Gnostici115. Infine, fuancora lui ad annunziare per primo il Vangelo ai pagani delcenturione Cornelio e a farli battezzare dopo che lo Spiritoscese su di loro116. Da quel momento si riservò il primatonella missione ai pagani, sciogliendoli dall’obbligo dellaLegge Mosaica, senza rinunciare all’egemonia anche nellaevangelizzazione degli Ebrei117. Fu per videre Petrum che ilneoconvertito Paolo di Tarso, sebbene Gesù stesso lo avesseaggregato al Collegio Apostolico, salì a Gerusalemme,affinchè ciò che egli aveva imparato sul Cristianesimo glifosse confermato e per concertare col Pescatore le lineedella sua missione118. Arrestato con i Dodici nei primissimitempi della missione119, perseguitato con i suoi fedeli inGerusalemme, fu poi arrestato da solo da Erode Agrippa I, maun Angelo lo liberò dal carcere miracolosamente prima chefosse martirizzato120. In queste circostanze lasciò Gerusalemmeper Roma – indicata negli Atti con una locuzione cifrata121 –dove risiedette per un certo tempo122, dando una fisionomiadefinita alla Chiesa della Capitale e diventandone così il
113 At 3, 1-10.114 At 5, 1-11.115 At 8, 9-25.116 At 10, 9-48.117 Gal 2, 7.118 Gal 1, 18. Il dissidio tra i due testimoniato nella Lettera e accaduto adAntiochia fu solo pastorale ed è narrato con gran rispetto per Pietro; né si puòdedurre dal contesto che Paolo avesse per forza ragione.119 At 4, 1-22.120 At 12, 1-17.121 In altro luogo. E’ la locuzione che Ezechiele adopera per parlare di Babilonia,che è a sua volta il crittogramma di Roma. Gli At citano così Ezechiele. Laprudenza di Luca nell’omettere il nome della Città è dettata dal timoredell’autorità imperiale. 122 1 Pt 5,13.
50
primo Vescovo123. Lasciò l’Urbe124 per presiedere il Concilio diGerusalemme125 a cui partecipavano tutti gli Apostoli e checonfermò l’abolizione della Legge Mosaica per i pagani,introducendo norme transitorie126. Poi si trasferì ad Antiochiadi Siria127, la cui Chiesa resse per sette anni. Da lì passò apredicare in Asia Minore e Grecia128, per poi tornare inItalia129, dove pure svolse una intensa opera dievangelizzazione avendo Roma come base, che si esteseprobabilmente anche oltre le Alpi. In Roma il suo interpretee segretario san Marco scrisse il Secondo Vangeloraccogliendo le sue memorie quando il Principe degli Apostoliera ancora in vita130. Sempre da Roma san Pietro scrisse le suedue Lettere contenute nel NT131. In suo nome san Marco andò adevangelizzare l’Egitto e a reggere la Chiesa di Alessandria.Perciò, tutte le Sedi patriarcali dell’Antichità siriconnettono alla predicazione di Pietro. Fu in Roma chePietro collaborò strettamente anche con Paolo, aggiuntosi alui nella predicazione in Città e nella guida della suaChiesa. E fu nell’Urbe che il Principe degli Apostoli el’Apostolo delle Genti, traditi dai giudaizzanti, furonoconsegnati a Nerone che scaricò su di loro la colpadell’incendio della capitale condannandoli a morte132. Pietro123 Siamo nel 42 o anche prima. La notizia è di Papia e di Girolamo. 124 Nel 44, alla morte di Agrippa. 125 Non più tardi del 48. 126 At 15, 7-11.127 Gal 2, 11-14.128 1 Cor 1, 12. 1Pt 1,1.129 Nel 57. Di quest’ultima fase storica della vita di Pietro attesta laTradizione.130 1 Pt 5, 13.131 Se la Prima Lettera è universalmente attribuita a Pietro, alcune perplessitàsuscita la Seconda che però con la sua struttura richiama la Prima. Peraltro unsuo frammento, anteriore al 67, si sarebbe conservato nella Grotta 7 di Qumran eperciò proverebbe anche paleograficamente ciò che tutti gli scrittoriecclesiastici antichi avevano insegnato, e cioè che la Lettera è autentica. Ledifferenze di stile tra le due missive si devono ai segretari di cui Pietro siserviva in tempi differenti.132 La notizia è adombrata nell’Apocalisse (11, 1-13) in modo prudente. Giovanniinfatti biasima il potere imperiale in modo assai forte e non può menzionarloesplicitamente, né nominarne le vittime, chiamate i Due Testimoni. ClementeRomano, Ignazio di Antiochia e Ireneo di Lione attestano che Pietro visse e morìmartire a Roma. Lo stesso fanno Eusebio di Cesarea e Tertulliano. La data è trail 67 e il 68. L’episcopato di Pietro a Roma sarebbe dunque durato 25-26 anni, e
51
fu crocifisso come il suo Signore, a testa in giù, mentrePaolo fu decapitato133. La morte di Pietro a Roma dopo un lungoepiscopato fece sì che la sua eredità primaziale passasse alla Chiesa Romana e achi la presiedeva, i suoi Vescovi o Papi134, visto che nessuna Chiesasussiste senza il suo presule. Ragion per cui tutta laschiera dei Pontefici Romani è la linea dei Successori diPietro, partecipi del suo stesso supremo potere apostolico,in cui sono costituiti grazie alla sola legittimità dellaloro elezione135. Dalla vita di Pietro essi traggono esempi e
il suo Papato 37-38.133 Lattanzio, Origene, Eusebio danno questa notizia.134 La parola “Papa”, che significa padre, è usata dai cattolici solo per ilVescovo di Roma. Ma nelle Chiese d’Oriente è titolo spettante anche aiPatriarchi più antichi (come quello di Alessandria d’Egitto).135 Pietro scelse il suo successore in san Lino di Volterra (68-78), martiresotto Tito. I primi Papi si scelsero i successori. Sant’Alessandro I, martiresotto Traiano, fu il primo papa eletto (109-116). La prassi dell’elezione, fattadal popolo e dal clero, durò fino al 1058. Gli Imperatori, quando divennerocristiani, spesso confermarono l’elezione per evitare abusi. In alcuni casidesignarono i candidati. Il Concilio Lateranense di papa Niccolò II (1058-1061)stabilì che i Papi dovessero essere eletti dai Cardinali Vescovi col concorsodei Cardinali Presbiteri e Diaconi. La norma non fu bene applicata anche per inumerosi scismi che travagliarono la Chiesa Romana fino al 1179, quando il IIIConcilio Ecumenico Lateranense escluse definitivamente gli Imperatori dallascelta del Papa riservandola ai Cardinali, che dovevano eleggerlo con i dueterzi dei loro voti. Nel 1271 il beato Gregorio X (1271-1278) introdusse laclausura degli elettori o Conclave. L’elezione del Papa è una scelta che avvieneper opera dello Spirito Santo, per cui un buon eletto è un dono di Dio, e unocattivo un suo castigo. L’elezione papale è valida se avviene quando il tronopapale è libero e quando gli elettori sono privi di costrizione. Anche sesimoniaca, l’elezione, senz’altro immorale, rimane valida. Chiunque può essereteoricamente eletto, purchè battezzato, cattolico, maschio e con uso di ragione.Infatti, diversi Papi non furono Cardinali, e alcuni addirittura laici. In casigravi, valutati dalla sua coscienza, un Papa può abdicare, e cinque l’hannofatto. In altri, a causa di una degenerazione barbarica del Diritto Canonico, enon sempre con procedure legittime, alcuni Papi sono stati deposti. Talesituazione è stata riconosciuta quando il Papa ha accettato la sentenza. Oggi lalegge canonica non prevede la deposizione di un Papa, in quanto Prima Sedes anemine iudicatur. In circostanze particolarmente gravi (come per gravissimemalattie mentali) può essere interdetto dai Cardinali. Un caso limite sarebbe unPapa formalmente eretico nel suo magistero: la Professione di Fede di Pietrorende impossibile questa situazione, che infatti non si è mai verificata, ma ilDiritto Canonico mantiene l’ipotesi di una interdizione per una similecircostanza da parte dei Cardinali. L’odierno Pontefice, Sua Santità BenedettoXVI, è il duecentosessantatreesimo Vescovo di Roma, Successore di Pietro eVicario di Nostro Signore Gesù Cristo in Terra. Invece coloro che sono eletti ocontro un Papa legittimamente in carica o in concomitanza con uno legalmenteeletto o in modo irregolare durante una vacanza della Sede sono detti Antipapi e
52
modi di esercizio dell’autorità. La loro Sede è la Santa Sedeper eccellenza, la Sede Apostolica per antonomasia. Chi siede sudi essa è certo di avere il potere di sciogliere e legare, diconfermare nella Fede, di pascere gli agnelli e le pecore.Egli è l’Apostolico, che ha la Cattedra presso le Spoglie diPietro, tumulato laddove oggi sorge, superba e maestosa, laBasilica a lui dedicata sul Colle Vaticano, dove egli fumartirizzato, presso l’ormai scomparsa dimora dell’imperatorepersecutore136.
sono usurpatori. Coloro i quali rigettano il magistero dei Pontefici Romani dopoil Concilio Vaticano II e considerano vacante la Santa Sede per eresia (iSedevacantisti) e hanno addirittura eletto essi un proprio Papa (Conclavisti)sono scismatici ed eretici.136 La sepoltura di Pietro a Roma è assolutamente certa. L’altare centrale dellaBasilica fu costruito da Clemente VIII (1592-1605) sopra la Memoriadell’Apostolo. Il Venerabile Giovanni Paolo II (1978-2005) ha rimesso incomunicazione la Confessione con la Tomba di Pietro. Sotto l’altare clementinovi è quello di Callisto II (1119-1124), che a sua volta sormonta quello diGregorio Magno (590-604). Proseguendo, s’incontra il monumento quadrangolare dimarmo bianco e porfido rosso voluto da Costantino nel 312, al livello di 0,20m., quello della Basilica da lui voluta. Tra i suoi muri racchiude unacostruzione ancora più remota: un’edicola su base rettangolare di otto metri perquattro, il “Campo P”, circondato da stanze funerarie del 130-150, nel sito diuna vasta necropoli del II – III sec., che ingloba una serie di luoghi funerariancora più antichi. Sul lato ovest sorge il “Muro Rosso”, del 146-161. Duenicchie sovrapposte sono scavate nel Muro, in cui sporge una lastra ditravertino con due colonnine di marmo bianco; nel selciato un’apertura chiusa dauna lastra, con un nascondiglio rivestito di marmo, che aveva contenuto lespoglie di Pietro. E’ questo il Trofeo descritto da Gaio nel 160, il monumentoche descrive il trionfo del martirio. Edificato con difficoltà in quel puntopreciso, aveva ragion d’essere perché lì era tumulato Pietro. Il “Muro G”,posteriore al Rosso, ma anteriore al Monumento costantiniano, contenente unloculo di 77 cm per 29 per 31 rivestito di marmo greco, aveva poi ospitato iresti dell’Apostolo per evitare profanazioni. Il complesso corrisponde a unatomba povera, detta “Theta”, assieme ad altre tre posizionate nei pressi delsepolcro petrino, e risalente agli anni 69-79, quelli di Vespasiano, che salì altrono un anno dopo la morte di Pietro. A partire dalla prima metà del III sec.,una elegante tomba cristiana della Gens Iulia fu costruita per onorare la vicinasepoltura del Pescatore. Gli scavi sono stati condotti tra il 1939 e il 1949 epoi tra il 1953 e il 1958. Nel 1963 le ossa rinvenute dal loculo del Muro Gfurono riconosciute, in seguito ad accertamenti scientifici, come quelle di unuomo di sessanta-settanta anni, robusto, frammiste a stoffa tinta di porpora e aoro, nonché a terra del luogo. Con esse c’era un frammento con l’iscrizionegreca: Pietro è qui dentro. Oggi la tomba è visibile ai pellegrini per i lavoriordinati da Papa Woityla. In quanto alle ossa di Paolo, sono state identificatecon quelle rinvenute sotto l’Altare della Confessione della Basilica di SanPaolo Fuori le Mura, nel 2008. Sebbene Paolo non abbia avuto il Primato, neiprimi secoli fu considerato anche lui vescovo di Roma, per cui i Papi furono
53
Dalla morte di Pietro, i Papi suoi Successori divengono iSommi Pontefici della Chiesa Universale, i suoi Capi Visibiliin luogo di Cristo137. L’autorità disciplinare viene esercitataimmediatamente sulle altre Chiese138, anche se la persecuzionepressoché endemica dell’Impero Romano sconsigliò unacentralizzazione di governo, onde evitare che l’uccisione diun Papa decapitasse il mondo cristiano. Le maggiori sentenzedottrinali dei primi tre secoli furono inferte dai Papi139. Apartire dal 180-190 la Chiesa Romana si latinizzòdecisamente, abbandonando la lingua greca140. Cessata lapersecuzione imperiale con l’Editto di Milano di Costantinodel 313, il Papato potè avviare un processo dicentralizzazione amministrativa e vide la sua autoritàdottrinale rafforzata141. La posizione giuridica del Papa fureputati anche suoi successori, con un titolo che andrebbe riproposto perchégiuridicamente valido e unico nel mondo.137 I titoli completi di un Papa – la maggior parte dei quali già sono staticitati – sono i seguenti: Vescovo di Roma [o Pontefice Romano], Successore diSan Pietro, Successore del Principe degli Apostoli, Vicario di Nostro SignoreGesù Cristo in Terra, Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, Primated’Italia, Patriarca dell’Occidente [oggi abbandonato da S.S.Benedetto XVI], Capodel Sacro Collegio Episcopale, Vescovo dei Vescovi, Vescovo Universale, PastoreSupremo della Santa Chiesa Universale, Pastore Universale della Santa ChiesaCattolica, Sovrano e Sommo Pontefice [o Pontefice Massimo] della Santa ChiesaUniversale, Capo Visibile della Santa Chiesa Cattolica, Rettore del Mondo, Servodei Servi di Dio. Egli porta inoltre il titolo di Sovrano, oggi dello Statodella Città del Vaticano.138 Papa san Clemente I (91-101), padre della Chiesa e martire sotto Traiano,redasse una Lettera ai Corinzi che ammoniva quei cristiani a comporre le lorodispute, dando istruzioni in merito. Probabilmente la Lettera, datata al 96, èpiù antica (69-70), per cui sarebbe stata composta da Clemente, allorapresbitero, su mandato di papa Lino.139 Tutti i Papi dei primi tre secoli furono martiri, con qualche eccezione. SanTelesforo (125-136) condannò gli Gnostici, san Pio I (142-155) i Marcioniti, sanSotero (166-174) i Montanisti, san Vittore I (189-198) i Quartodecimani, gliGnostici e gli Adozionisti, san Zefirino (198-217) i Modalisti, come sanCallisto I (217-222), che riprovò anche i Rigoristi, san Cornelio (251-253) iNovazianisti, santo Stefano I (254-257) sostenne la validità del Battesimo degliEretici e la necessità di perdonare i lapsi in persecuzione, san Dionigi (260-268)risolse la disputa trinitaria in Egitto.140 Col summenzionato papa Vittore I, martire sotto Settimio Severo. I Papimartiri Stefano I e Fabiano furono i più grandi Papi di quei secoli.141 I Concili Ecumenici (di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia,rispettivamente nel 325, 381, 431, 451) furono convocati dagli Imperatori eratificati dai papi san Silvestro I (314-335), san Damaso I (366-384), sanCelestino I (422-432) e san Leone Magno (440-461). Questi ultimi prepararono ideliberati, e il decreto di Calcedonia riprende il Tomo a Flaviano di Leone
54
riconosciuta anche dallo Stato ormai cristiano142. Lacentralizzazione ebbe tuttavia una battuta d’arresto sia perl’opposizione della Chiesa Imperiale di Costantinopoli siaper le Invasioni Barbariche in Occidente143. Terminò con laRiconquista Giustinianea dell’Italia (554), sebbene ilPrimato petrino non fosse messo in discussione dai Romanid’Oriente ma anzi esplicitamente confessato144. Nel periododella Dominazione Bizantina (554-752) il Papato fu ilcostante punto di riferimento dell’Ortodossia e spessocrudelmente vessato per piegarsi alla volontà degliImperatori in campo dottrinale, ma senza successo145. Una voltache il dominio orientale fu agli sgoccioli, per garantire lapropria indipendenza dai Barbari e la sopravvivenzadell’ideale imperiale, il Papato fondò il Potere Temporale(752-1870) e, alleandosi coi Franchi, ricreò l’Impero inOccidente (800-888)146. Nel quadro della riunificazionepolitica, potè così riprendere la centralizzazione
Magno. I maggiori Pontefici, protagonisti dell’accentramento e delle disputegiuridico-teologiche, furono i SS. Giulio I (337-352), Siricio (384-399),Anastasio I (399-401), Innocenzo I (401-417), Felice III (483-492), Gelasio I(492-496), Ormisda (514-523), Agapito I (535-536), nonché Giovanni II (533-534).142 Gli Imperatori Costantino I, Teodosio I, Giustiniano I, Foca,Costantino IVconfermarono anche ai sensi della legge civile il Primato di Pietro.143 La concezione per cui il rango di una Chiesa dipendesse da quello civiledella città dove aveva sede fece si che la Chiesa di Costantinopoli, capitaledell’Impero, facesse resistenza ad una completa soggezione a Roma. Le Chiesebarbariche, considerate associate all’ecumene romano, svilupparono unacostituzione autonoma, sinodale, ai margini del Patriarcato Romano, cui purespettava il dominio pieno su di esse. Ma la cristianizzazione dei Barbari dipesequasi sempre da una iniziativa papale.144 Giustiniano costrinse papa Vigilio (537-555) a ratificare la condanna dei TreCapitoli fulminata dal II Concilio di Costantinopoli da lui convocato (535). Lacondanna, mai sconfessata dal Papa, fu recepita come valida dai suoi Successorie attesta quanta importanza avesse per l’Imperatore il consenso del Vescovo diRoma. 145 San Martino I (649-653) diede la vita per non aderire al monoteletismo,condannato dai Predecessori e poi, definitivamente, dal III Concilio diCostantinopoli, approvato dai SS. Agatone (678-681) e Leone II (681-683); sanSergio I (687-701) si oppose alle determinazioni antilatine del II ConcilioTrullano a rischio della vita; Costantino I (707-708) convinse Giustiniano II adaccettare solo i canoni trullani che non contrastavano la tradizione romana; sanGregorio II (715-731) e san Gregorio III (731-741) combatterono risolutamentel’iconoclastia, il primo anche in spregio della vita. 146 Stefano II (752-756) fondò lo Stato Pontificio. San Leone III (795-816)incoronò Carlo Magno.
55
amministrativa in Europa147, cercando di estenderla ancheall’Oriente, dove però la tendenza autocefalica ecclesiasticalo rese impossibile148. Il crollo dell’Impero Carolingio bloccòla programmazione ecclesiastica universale e fece precipitarela Santa Sede nell’anarchia, tamponata dall’influenza edall’ingerenza dell’aristocrazia capitolina (882-962; 963-1045)149. La restaurazione dell’Impero Romano-Germanico (962-1806)150 creò i presupposti per la liberazione del Papato dallefamiglie romane per cui esso, sotto il controllo tedesco(963-1003, ma soprattutto 1046-1057), avviò un programmavastissimo di riforma religiosa che si tramutò in unrinnovamento istituzionale, volto a riprendere il piano diaccentramento amministrativo e poi a liberare il Sacerdoziodall’influenza del potere civile attraverso la Lotta per leInvestiture (1074-1122). Fu la Riforma – pregregoriana egregoriana151 (1049-1154)– che tolse alla Chiesa Romana quellaOrientale, non disponibile alla sottomissione nelle nuoveforme giuridiche152, ma le consegnò tutte le altre Comunitàd’Occidente, le attribuì la guida della vita religiosa, lemise in mano il suo rinnovamento, le conferì il potere di147 Grandi protagonisti di questa impresa furono san Leone IV (847-855), sanNiccolò I il Grande (858-867), Giovanni VIII (872-882).148 Il consenso papale rimase fondamentale in campo di dottrina. I Concili IINiceno e IV Costantinopolitano (787; 869-870) furono approvati da Adriano I eAdriano II (867-872). Le fazioni ecclesiastiche in lotta a Bisanzio chieserosempre l’appoggio papale, ma non permisero mai che la giurisdizione ordinariapassasse a Roma, né questo era possibile. Ma la fede nel Primato giurisdizionalefu incrinata dai contrasti politici fomentati dai Patriarchi come Fozio eCerulario, e solo nei secoli, per reciproche colpe, andò perduta.149 E’ il Secolo Oscuro. Ma ancora il Papato è interpellato da Oriente eOccidente per varie questioni. 150 Giovanni XII (955-963) incoronò Ottone il Grande.151 L’iniziatore della prima fu il santo papa lorenese Leone IX (1049-1054).Altri illustri esponenti furono Niccolò II e Alessandro II (1061-1073). Laseconda prende il nome dal suo capofila, il grande san Gregorio VII (1074-1085).Illustri continuatori furono il Beato Urbano II (1088-1099), Callisto II (1119-1124), Innocenzo II (1130-1143), il Beato Eugenio III (1143-1154). I ConciliLateranensi I e II (1123 e 1138) furono le due più grandi assisi riformatricidell’epoca. Primi Ecumenici convocati dal Papa, i due Sinodi rispettivamentechiusero la Lotta per le Investiture e lo Scisma del 1130, rinsaldando laconsapevolezza della Chiesa di essere un Corpo Mistico che spontaneamente avevascelto il suo vero Papa.152 La rottura data al 1054. Ma più volte furono chiuse delle Riunificazioni(1095; 1147; 1187; 1204; 1275 al II Concilio di Lione, 1439 al Concilio diFirenze) che naufragarono per reciproche colpe.
56
rinnovare e unificare la legislazione e la liturgia, laliberò dall’influenza imperiale. Esaurita la spintariformatrice, una serie di Papi giuristi (1155-1268) definìla posizione della Santa Sede nei confronti dell’Impero,conducendo una vittoriosa lotta contro la Casa Sveva ecodificando il Diritto Canonico153. Questo battagliero Papatosi accollò l’onere di riformare nuovamente la vita religiosa,di reprimere l’eresia e di dare un nuovo volto alle struttureunitarie della Chiesa154. Essendosi impelagato in lottepolitiche (1271-1304), fu umiliato e tradotto ad Avignone(1305-1378). Ma pure qui potè continuare l’opera diaccentramento amministrativo, anche se trascurò la rinnovataesigenza della riforma religiosa155. Tornato a Roma eprecipitato nel Grande Scisma che diede prima due e poi trePontefici alla Chiesa (1378-1417), il Papato potè essererestaurato solo da una temporanea preminenza su di esso delConcilio156. La restaurazione della Monarchia Pontificia volutada Dio (1417-1447)157 avvenne non senza che l’istanza di
153 I grandi canonisti furono senz’altro Alessandro III (1159-1181), che trionfòsu Federico Barbarossa e tenne il III Concilio Lateranense nel 1179; InnocenzoIII (1198-1216), che dominò il mondo cristiano, riformò i costumi e combattèl’eresia, sconfisse Ottone IV e tenne il IV Concilio Lateranense (1215);Gregorio IX (1227-1241), che combattè valorosamente Federico II e gli Eretici,mentre sostenne la Riforma e promulgò il Corpus Iuris Canonici; Innocenzo IV (1243-1254), che sconfisse Federico II e tenne il II Concilio di Lione (1245);Bonifacio VIII (1294-1303).154 Nei secoli XII-XIII praticamente tutti i Papi diedero un contributo allacentralizzazione monarchica o se ne servirono per compiere grandi imprese. Oltreai summenzionati, cito anche Adriano IV (1154-1159), Onorio III (1216-1227)Clemente IV (1265-1268), Niccolò III (1277-1280). Il concetto evangelico delgranellino di senape che diventa un albero enorme trova qui la sua pienaattuazione. 155 I Papi avignonesi furono tutti benemeriti dell’accentramento monarchico.Clemente V (1305-1314), che pure subì tante umiliazioni da Filippo il Bello, fuun grande canonista e tenne il Concilio di Vienne (1311); Giovanni XXII (1316-1334) fu anch’egli un papa legislatore. L’unico riformatore religioso fu ilbeato Benedetto XII (1334-1342).156 Fu il Concilio di Costanza (1414-1417), che si eresse a suprema istanza inquanto non si poteva trovare un Papa accettato da tutti. Ma esso non definì lasupremazia assoluta del Sinodo sul Papa. Il nuovo pontefice, Martino V (1417-1431), non volle convocare facilmente nuovi Sinodi per timore di unaradicalizzazione delle posizioni dette concili ariste. Tralasciò, come del restoi Successori, la Riforma che solo un Concilio poteva fare.157 Trionfo del Concilio di Firenze e di papa Eugenio IV (1431-1447) sul Concilioribelle di Basilea.
57
rinnovamento religioso, ormai gravissima, fosse trascurata,fino a divenire cancrenosa nell’Età rinascimentale (1447-1527)158. Qui il Papato subisce la grave offensiva dellaRiforma protestante (1517)159, che lo spinge alla RiformaCattolica e alla Controriforma (1534-1644), correggendo anchese stesso e impegnandosi nell’evangelizzazione del NuovoMondo160. Decaduta la sua potenza politica in seguito alla finedella Controriforma, il Papato mantenne la sua autoritàspirituale nel corso dei secoli seguenti (1644-1789)161, mentreil suo primato giuridico fu battuto in breccia dalle formegiurisdizionalistiche settecentesche della Chiesa di Statodelle nazioni cattoliche162. La Rivoluzione Francese (1789-1815), che pure portò la Santa Sede sul punto del crollo163 eperseguitò la Fede, servì a rafforzare l’autorità pontificiasulla Chiesa, per cui nel XIX sec. il processo diunificazione ecclesiastica si compì con la definizione delDogma dell’Infallibilità Papale e del suo EpiscopatoUniversale nel Concilio Ecumenico Vaticano I (1870)164. In
158 Il periodo tra il XV e il XVI sec. è forse il peggiore della storiaecclesiastica e, accanto al Secolo Oscuro, il più corrotto e violento di quelladel Papato. Il Concilio Lateranense V (1511-1516) voluto da Giulio II (1503-1513) non servì a nulla. Nel Rinascimento, solo Adriano IV (1522-1523) compresela gravità della situazione della Chiesa, ma potè fare poco.159 Papa Leone X (1513-1521) condannò, ma non potè arginare, Lutero.160 L’acme della Riforma e della Controriforma fu il Concilio Ecumenico di Trento(1545-1562), tenuto sotto Paolo III (1534-1549), Giulio III (1550-1555), Pio IV(1560-1565). I Papi più impegnati nella Controriforma furono Pio IV, san Pio V(1565-1572), che promulgò il Messale emendato, Gregorio XIII (1572-1585), SistoV (1585-1590), Clemente VIII (1592-1605).161 I Papi Innocenzo X (1644-1655), Clemente IX (1667-1669), Clemente XI (1700-1721) condannarono il Giansenismo; il beato Innocenzo XI (1676-1689) condannò ilQuietismo e il Gallicanesimo, oltre che il lassismo morale; contro di questo sieresse pure Alessandro VIII (1689-1691). Altre sentenze furono emesse daInnocenzo XII (1689-1700). Clemente XI (1730-1740) condannò per primo laMassoneria; Clemente XIII (1758-1769) gli errori dei Lumi.162 Lo Staatkirchentuum non fu mai imposto completamente, e conseguenzialmente lecondanne del febronianesimo di Clemente XIII, del Gallicanesimo di Innocenzo XIe del Giuseppinismo di Pio VI (1775-1799) furono in parte bypassate daglioppositori.163 Pio VI, che condannò i suoi errori, fu deportato e morì in esilio. Dopo untemporaneo accordo, anche Pio VII (1800-1823) fu arrestato da Napoleone e poiliberato nel 1814.164 Fu il trionfo dell’Ultramontanismo, erede del Curialismo medievale. Il Papatotra l’altro esercitò un energico magistero di condanna contro gli errorifilosofici, politici, religiosi e sociali del secolo (liberalismo, socialismo,
58
conseguenza di ciò anche la perdita del Potere Temporale fuun danno ammortizzato e i Papi dell’Età moderna (1846-1958),sebbene a lungo prigionieri in Vaticano (1870-1929),poterono guidare egregiamente la Chiesa in un mondo ostile elaicizzato, avviandone una eccezionale espansione165. Nelletempeste del XX sec. – le Guerre Mondiali e le Persecuzionidei Totalitarismi, specie quello comunista166 (1915-1989) – ilPapato ritrovò provvidenzialmente un piccolo Potere Temporale(1929)167 e mantenne compatta la Chiesa sotto il suo dominio.Il processo di rinnovamento del Concilio Vaticano II ebbe nelPapato contemporaneo, a forte contenuto carismatico, il suomotore e il suo centro applicativo168 (1963 a tutt’oggi);
comunismo, idealismo, irrazionalismo, positivismo, società bibliche, massoneriae sette segrete, ecc.) con lo stesso Pio VI, con Leone XII (1823-1829), GregorioXVI (1831-1846), il beato Pio IX (1846-1878). Questi fu il primo Papa a definireun dogma, l’Immacolata Concezione, senza Concilio Ecumenico.165 Si può parlare senza timori apologetici di una età aurea del Papato neldifficile secolo XX. Leone XIII (1878-1903), pur ribadendo le condanne deiPredecessori, creò le basi per la riconciliazione della Chiesa col mondo modernoe contemporaneo, diede impulso alle missioni e alla vita spirituale in tutte lesue forme. San Pio X (1903-1914) schiacciò il Modernismo e avviò una completariforma religiosa. Benedetto XV (1914-1922) promosse l’impegno umanitario dellaChiesa nella Prima Guerra Mondiale e nel I Dopoguerra, agendo in tutti i campicon moderazione e zelo. Promulgò il Codice di Diritto Canonico che sostituì ilCorpus di Gregorio IX, sviluppando l’iniziativa di Pio X. Pio XI (1922-1939)condannò energicamente Comunismo, Fascismo e Nazismo, continuò la lineaspirituale dei Predecessori, cercò di garantire la sicurezza della Chiesa intutte le nazioni con la politica dei Concordati. Il ven. Pio XII (1939-1958)resse la Chiesa con prudenza e fermezza durante la II Guerra Mondiale e laGuerra Fredda. Condannò Nazismo e Comunismo coi suoi orrori, protesse la civiltàcristiana, tenne un magistero di altissimo livello intellettuale. Fu il secondoPapa a definire un dogma, l’Assunzione della Vergine, senza il ConcilioEcumenico.166 La violenza lambì il Papato, con minacce anche fisiche e progetti diassassinio o deportazione nazifascista di Pio XII e con l’attentato del 1981 alven. Giovanni Paolo II (1978-2005).167 E’ lo Stato della Città del Vaticano, nato col Trattato contenuto nei PattiLateranensi di Pio XI con l’Italia.168 Tenuto dal 1962 al 1965, il Concilio fu voluto dal beato Giovanni XXIII(1958-1963) e concluso da Paolo VI (1963-1978) che lo applicò, realizzando lepiù ampie riforme della storia della Chiesa. L’opera fu continuata da GiovanniPaolo II, col nuovo Codice di Diritto Canonico e il Catechismo Universale.Condannò gli errori politici del secolo e sistemi etici erronei. Sua SantitàBenedetto XVI (eletto il 19 aprile 2005) si sta concentrando sullamoralizzazione del clero, assai colpito da piaghe sessuali in passato non bencombattute, e sulla disciplina liturgica e canonica. Ha condannato più volte ilRelativismo.
59
nonostante la grave crisi interna ecclesiastica (1965-1980) ela marea secolarizzatrice, i Papi non conobbero contraccolpinella loro autorevolezza169. La crisi è in parte rientrata, ilprocesso di rinnovamento morale – assai doloroso in questiultimissimi periodi – è in pieno svolgimento per l’iniziativadella Santa Sede, il movimento ecumenico dà i suoi frutti,l’evangelizzazione dei pagani continua e il grande nemico, ildrago rosso del marxismo, è stato abbattuto col concorsodecisivo del Papato (1989)170. La grande sfida del futuro è ladilagante secolarizzazione nel mondo cristiano tradizionale171.
LA NATURA DEL PRIMATO DI PIETRO
Sui poteri giurisdizionali e magisteriali del Papa ci siamodiffusi già in precedenza172. Qui puntualizziamo alcuni aspettidella natura del suo Primato. Esso può anzitutto esserecompreso in ragione del suo rapporto con Cristo. Questi haconcesso al Papa tutti i poteri necessari per reggere laChiesa Terrestre nel suo complesso, anche in rapporto allealtre due Chiese della Comunione dei Santi. Ragion per cui ilPapa è lo strumento consapevole di cui il Signore si serve
169 Il simbolo di ciò è il prestigio universale di papa Giovanni Paolo II, chetenne un altissimo magistero, viaggiò in tutto il mondo laddove mai alcunPontefice era stato, promosse il rinnovamento di ogni forma di vita religiosa,aumentò lo sforzo missionario, seppe adattare benissimo la monarchia papale allamoderna globalizzazione dei media, promosse il movimento ecumenico dichiarandodi essere disposto a riconoscere le autonomie delle altre Chiese cristiane incaso di riunione, favorì il dialogo interreligioso. Egli sviluppò le linee digoverno di Paolo VI e le ha tramandate a S.S.Benedetto XVI.170 Ossia di papa Giovanni Paolo II.171 Reiteratamente stigmatizzato nel suo laicismo edonista e relativista, nochènel suo indifferentismo, da S.S. Benedetto XVI.172 Essi sono esercitati o a voce o per iscritto. Le tipologie dei documentipapali sono le seguenti: Bolle [tra le più antiche, per prescrizioni disvariatissima natura, anche per la definizione dei dogmi], Motu Propri [emanatisenza consultarsi con nessuno], Brevi [per affari minori], Chirografi, Rescritti[concepiti come risposte a quesiti], Lettere Decretali [aventi forza di legge],Encicliche [Lettere, se trattanti argomenti, Epistole, se concernenti persone],Lettere e Epistole Apostoliche [rispettivamente su argomenti o persone ma menosolenni delle Encicliche], Esortazioni Apostoliche, Costituzioni Apostoliche[normative nel proprio ambito], Lettere ed Epistole. Oralmente il Papa pronunziaAllocuzioni – alla Curia e ai Cardinali – Discorsi, Radio e Video Messaggi[diffusi anche a mezzo internet], Omelie e Sermoni. Spesso di recente scriveanche libri, a titolo personale.
60
per governare la Chiesa. Qualunque scelta un Papa faccia, purrimanendo piena la sua responsabilità, o è voluta – se buona– o è permessa – se cattiva - da Dio, proprio in vista dellasua ricaduta sulla Chiesa. Il Papa esiste dunque in relazionea Cristo, in rapporto al Suo stesso Potere. Esso, senza maiessere separato da Colui Che lo possiede e realmente loesercita, sussiste tutto nel Papa. Perciò, come tutta laChiesa sussiste in relazione al Cristo come Persona Misticadi cui Lui è Capo, così il Papa sussiste in relazione alCristo come riproduzione mimetica, visibile e mistica dellasua funzione di Capo di questa Persona sulla Terra. Il Papa èlo stesso Potere di Cristo. Egli è perciò strettamentecongiunto all’Unione Ipostatica del Verbo, in quanto laPersona Divina del Figlio opera congiuntamente come Dio eUomo, e tramite la Sua Umanità, che in relazione alla ChiesaTerrestre globalmente intesa agisce tramite il Pontefice173.Investito di questa santa missione, di origine divina, ogniPapa è santo nel suo ruolo, degno di venerazione da parte deifedeli, anche se personalmente mantiene i suoi difetti. Egliè santificato per i meriti dell’Apostolo (san Gregorio VII)che a sua volta scaturiscono da quelli di Cristo. Ladistinzione tra la Persona del Papa e la Persona di chi èPapa, pur essendo logica e reale, non impedisce che laseconda sia inglobata nella prima. Anzi il Papa è il Papatovivente, in quanto l’istituzione non esiste al di fuori dichi la ricopre e tutto il Potere dei Pontefici, da Pietro inpoi, sussiste nel Vescovo di Roma regnante174. Per questo persecoli il Papa è stato detto Vicario di Pietro, per poi piùopportunamente essere definito Vicario di Cristo. Il Paparappresenta realmente in Terra Gesù Cristo, ne è l’iconamistica. Egli era chiamato da Caterina da Siena il Dolce Cristo in173 In Terra non vi è nessuno più unito al mistero dell’Ipostasi di Cristo delPapa regnante. Dopo di lui il Collegio Episcopale, ma preso nel suo complesso esempre cum Petro e sub Petro. Il Papato cesserà quando Cristo stesso guideràvisibilmente la Chiesa, riunita in Cielo. Ma il Potere delle Chiavi non svanirà,tornerà alla sua fonte.174 Infatti durante la Sede Vacante il potere è retto simbolicamente daiCardinali, che non possono fare niente, esattamente come i sacerdoti diqualunque diocesi senza il suo Vescovo. Il reggente dell’interregno è ilCardinal Camerlengo, che sovrintende alle riunioni preparatorie del Conclaveassieme al Decano del Sacro Collegio. Anche i vari funzionari della Curiadecadono, con pochissime eccezioni, dettate dalla necessità pastorale.
61
Terra. Perciò egli è l’unico che a giusto titolo si puòdefinire universale nell’autorità. Un secondo rapporto da lumeggiare è quello con la Chiesa. Se fa leveci di Cristo Capo, allora il Papa farà anche quelle diCristo sposo. La Chiesa è sposa di Cristo nel Papa in sensomimetico, ossia le loro Nozze sono replicate, quasi inmemoriale, nell’atto con cui ogni Vescovo di Roma è posto acapo della Chiesa stessa. Infatti il Papa ha un anello, cheindica tale connubio, così come ogni anello episcopale indicale nozze del presule con la sua Chiesa locale. In ragione diciò il Papa è, realmente, un Padre in Cristo per ognuno deifedeli i quali, nel Battesimo, così come sono uniti a Cristo,allo stesso modo sono consegnati al Pontefice Romano, gliappartengono, e lui ne porta la responsabilità. Questaperfetta unione del Papa con Cristo e con la Chiesa èsimboleggiata dalla Tiara, il copricapo oggi in disuso il cuisignificato simbolico e dottrinale rimane però valido. Essa èsul capo del Papa e simboleggia la Chiesa, perciò indical’unione del Corpo col Capo che è Cristo. Essa è una, ma hatre corone, che rappresentano le Tre Chiese. Nei confronti ditutte e tre, anche se in modi diversi, il Papa esercita isuoi tre poteri: Magistero infallibile, GiurisdizioneUniversale, Pienezza di Potere di Ministero. In ragione diciò, il Papa è superiore a qualsiasi potere terreno, ha lapienezza di quello spirituale e ha anche quello temporale.Perciò, come Vicario di Colui Che è Capo dell’Umanità, ilPapa è chiamato Rettore del Mondo – anche se oggi tale dizione èin disuso. Come si vede, c’è una triplice interpretazionedella natura trinitaria del Triregno175. In virtù della suafunzione mediana tra Cristo e la Chiesa, intesa come comunitàdei Battezzati, il Papa è chiamato Fonte di ogni potere legittimo.Egli infatti non solo elegge o conferma i Vescovi e iPrelati, ma li investe e li consacra. Stabilisce poi su diloro tutti coloro che, in sua vece, coordinano la lorocollegialità (metropoliti, primati, patriarchi), in quantosolo lui è Capo di tutti i Vescovi. A costoro, in segno dipotere delegato, invia il pallio, una stola di lana ornata di175 Si diceva al Papa quando cingeva la Tiara: Ricevi la Tiara ornata di treCorone e ricorda che tu sei Padre, Principe e Re, il Rettore del Mondo e ilVicario di Gesù Cristo.
62
sei croci che il Papa per primo indossa sempre. Inoltre,elevando all’ordine sovrannaturale il potere civile, locostituisce legittimamente tra i battezzati176. Possiamo perciòcapire il senso del titolo di Sovrano Pontefice, coniato da LeoneMagno, e di due affermazioni di Innocenzo III: “Il Papa èqualcosa di intermedio tra Dio e l’uomo”; “Egli è posto al disopra dei popoli e dei regni: nulla di ciò che accadenell’Universo deve sfuggire all’attenzione del SovranoPontefice”. In tale concezione, per cui l’Umanità èriassorbita nella Chiesa in quanto tutta incorporata nelMistico Corpo, si trova anche la cifra per la decodificazionedel rapporto tra il Papa e il mondo, del quale non a caso,nei tempi nostri, con le moderne comunicazioni, egli è potutodivenire la coscienza universale e la più alta istanzamorale, facendosi carico delle questioni umane dei singoli edei popoli anche se non cristiani. Tale impostazione moraledel Primato sul mondo fa sì che esso possa esplicarsi anchein una società laica o addirittura secolarizzata. Il terzo rapporto da enunciare è quello tra il Papa e i fedeli.L’immenso potere ricevuto non deve servire per innalzarsi, maper servire. Il Papa infatti è il responsabile della sorteeterna di tutti gli uomini, per quanto dipende da lui. Egli èpredestinato a tale compito. Egli è dunque sovrano, ma perservire. Il suo servizio è il più grande e quindi il piùuniversale, il più pesante: egli è il Servo dei Servi di Dio, comediceva Gregorio Magno. Il Pastore dei Pastori è colui cheporta il loro peso e quello dei loro fedeli, e se ogniPastore è Servo, allora il Papa è il Servo di tutti i Servi.Egli è il Servo fedele al quale il Padrone ha affidato la Suacasa, in attesa del Suo ritorno. Guai se, rientratoall’improvviso, lo troverà intento ad abusare della suaautorità! Quanto salda la fede, quanto profonda la speranza,quanto ardente la carità deve essere in un Papa. Che umiltàegli deve indossare per rivestire il suo ruolo. Quale zelo,quale prudenza, quale fortezza devono muoverlo. Con ardore
176 Questo era assai evidente con le Monarchie in età di ierocrazia. Oggi talefunzione si concepisce con difficoltà perché sono i popoli e non i singoli adessere sovrani. Rimane tuttavia saldo il principio della Potestas Directa vel Indirectain temporalibus, di cui ho già parlato, e che dev’essere esercitata soprattutto dalPontefice Romano.
63
egli deve orientarsi verso l’imitazione del Cristo gioioso esofferente, perché nelle sue parole, nei suoi gesti, nei suoisguardi il popolo dei fedeli veda il Redentore e non si sentaorfano, ma ricordi la promessa: Io non vi lascerò orfani (Gv 15, 14).Perciò, quel cristiano predestinato al Papato che nonraggiunge la santità è senz’altro autenticamente Pontefice eVicario di Cristo, ma ha sprecato la sua vita, perché non èdivenuto simile, anche di per sé, a Colui Che rappresenta.Questo nobile ufficio è oggi contraddistinto dall’eserciziodi svariate competenze, che andiamo a sintetizzare. Il RomanoPontefice tutela il Deposito della Fede, lo interpreta e nepromuove la retta comprensione, anche cercando e punendo levolpi piccoline che devastano la vigna, ossia gli eretici177;coordina e guida l’attività di evangelizzazione in tutto ilmondo, perché il Vangelo sia annunziato a tutti i popoli;stabilisce le norme del culto divino e dell’amministrazionedei Sacramenti, vigilando che siano applicate e anche punendoi contravventori, che gettano le perle ai porci, ossiaprofanano le cose sante; legifera per tutta la Chiesa einterpreta autenticamente le leggi vigenti; elegge e investei prelati, dando mandato per la loro consacrazione, edetermina i confini delle loro giurisdizioni, istituendo iloro organismi collegiali e approvandone i deliberati;convoca le sessioni del Sinodo dei Vescovi e i ConciliEcumenici e Generali, approvandone, promulgandone eapplicandone i deliberati; approva gli atti dei Concililocali; tratta gli affari delle Chiese Orientali che nonpossono essere regolati dai Patriarchi; regola la vita delclero e dei religiosi, punendo gli abusi riservati alla suagiurisdizione, e approvandone le forme di vita associata,confermandone i capi e ratificando gli atti dei loroorganismi collegiali; approva le forme dell’apostolato deilaici e le indirizza nelle loro attività, regolandole eapprovandone le norme, oltre che i massimi dirigenti e gliatti dei loro organismi di governo; beatifica e canonizza i
177 Per questi e altri ribelli valgono le sanzioni canoniche, di cui le piùimportanti sono la scomunica – che espelle dalla Chiesa privando della Grazia diDio – e l’interdetto – che vieta le celebrazioni liturgiche per un luogo o unapersona. Le sanzioni temporali, un tempo inferte in virtù della potestà coattivamateriale, non sono più inflitte perché la Chiesa non la esercita più.
64
Servi di Dio, regolandone il culto; regola la disciplina e ilcursus studiorum dei seminari e di tutti gli Istituti di Studio,inoltre erige le Università e gli altri Istituti maggiori,sorvegliando l’ortodossia dell’insegnamento ivi impartito;promuove il processo di unificazione tra le Chiese cristiane;compie le opere di carità, giustizia e pace che interessanotutta la Chiesa a vantaggio di chiunque abbia bisogno; tutelala famiglia cristiana; regola e promuove l’uso dei mezzi dicomunicazione cristiani e i rapporti tra fede e cultura;coordina la conservazione e la tutela del patrimonioartistico e storico della Chiesa; concede le Indulgenze eassolve i peccati riservati alla sua autorità; pronunzia lesentenze civili e penali di sua competenza o in appello;sorveglia l’amministrazione della giustizia in tutta laChiesa; riscuote le tasse canonicamente spettanti alla SedeRomana; amministra i beni della Santa Sede e sorveglia che iVescovi gestiscano quelli delle loro diocesi con rettitudine;cura le relazioni della Chiesa con le potenze secolari etutela la vita e i diritti dei cristiani in tutto il mondo.Come si vede, una somma di competenze notevoli, che superanoquelle di qualunque monarca assoluto, e che sono esplicate daquel complesso di organismi che chiamiamo Curia Romana178 – di178 La Curia, nata come struttura sganciata dall’amministrazione locale di Romanell’XI sec., è stata riformata più volte. Ai sensi della CostituzioneApostolica Pastor Bonus del ven. Giovanni Paolo II (1988), essa è cosìstrutturata: comprende la Segreteria di Stato, le Sacre Congregazioni, i Pontifici Consigli, i Tribunali,gli Uffici, gli Organismi e, come enti collegati, gli Istituti. La Segreteria di Stato è retta dalCardinale Segretario di Stato e collabora più da vicino col Papa; è divisa inuna Sezione Ordinaria – che tratta tutti gli affari non riservati ad uno specificodicastero ed è retta dal Sostituto; da essa dipendono il Bollettino Ufficialedella Santa Sede (gli Acta Apostolicae Sedis), e l’ufficio per le Pubbliche Relazioni,detto Sala Stampa, nonché l’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa – e in una Straordinaria –che cura le relazioni con gli Stati, che è retta da un Segretario e presso cui ècostituito il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, il cui Prefetto è il Segretariodi Stato; da essa dipendono i Nunzi, i Delegati e gli Internunzi Apostolici,nonché gli Osservatori e i Legati Apostolici con funzioni diplomatiche. Questipresiede anche il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi economici e organizzativi dellaSanta Sede. Le Sacre Congregazioni, formate da Cardinali Padri e Vescovi membri, retteda un Cardinal Prefetto e da un Segretario, hanno competenze indicate dai loronomi: Per la dottrina della Fede [presso cui sono costituite la Pontificia Commissione Biblicae la Commissione Teologica Internazionale], Per l’Evangelizzazione dei Popoli, Per le Chiese Orientali,Per i Vescovi [presso cui è costituita la Pontificia Commissione per l’America Latina], Per ilClero [presso cui è costituita la Pontificia Commissione per la conservazione e la tutela delPatrimonio artistico e storico], Per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per i
65
cui si è detto – presieduti e formati soprattutto dai membridel Sacro Collegio degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, Vescovi,Presbiteri e Diaconi, della Santa Chiesa Romana – sui cui poteri pure cisi è soffermati in precedenza. Costoro rappresentano il Papa,ne sono in un certo senso una emanazione179, oppure uncomplemento180. E’ proprio infatti del Primato suscitarefunzioni subordinate e associate. Non va inoltre dimenticatoche al Pontefice spetta l’incombenza di governare la sua
Seminari e gli Istituti di Studi, Per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Per le Cause dei Santi. IPontifici Consigli, retti da un Presidente Cardinale o Arcivescovo, aiutato da unSegretario, formati da un certo numero di membri Cardinali o Vescovi, hannoanch’essi nomi parlanti per le loro competenze: Per la Giustizia e la Pace, Cor Unum [chesvolge funzioni socio-caritative concrete in tandem con il primo avendo incomune il Presidente], Per i Laici, Per l’Unità dei Cristiani [presso cui è costituita laCommissione per gli Ebrei], Per il Dialogo interreligioso [presso cui è costituita laCommissione per i Musulmani], Per i Non Credenti, Per l’interpretazione dei Testi Legislativi, Per laPastorale degli Operatori Sanitari, Per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, Per la Famiglia, Per leComunicazioni Sociali, Per la Cultura. I Tribunali sono tre: il Supremo Tribunale della SantaSegnatura Apostolica [retto da un Prefetto, che funge da Corte Suprema], la Sacra RotaRomana [che funge da tribunale d’appello ed è retta dal Decano del Collegio deisuoi giudici, gli Uditori], la Santa Penitenzieria Apostolica [per il foro interno,retto dal Penitenziere Maggiore]. Gli Uffici sono: della Camera Apostolica [retta dalCamerlengo di S.R.C. e un tempo funzionante come ministero delle Finanze e oggiattivo soprattutto durante la Sede Vacante], dell’Amministrazione del Patrimonio dellaSede Apostolica, della Prefettura degli Affari Economici [il primo è una specie di ministerodel Tesoro, la seconda una sorta di Corte dei Conti e di ministero del Bilancio;entrambi hanno un Presidente Cardinale]. Gli Organismi sono la Prefettura della CasaPontificia [che è governata dal Prefetto e che regge quella che era un tempo laCorte papale, oggi Famiglia Pontificia, divisa in Ecclesiastica e Laica, in cui la vecchiaAristocrazia dei Patrizi Romani ha ormai un ruolo ridotto], l’Ufficio delle CelebrazioniLiturgiche del Sommo Pontefice [che è retta dal Maestro delle Cerimonie e organizza lefunzioni celebrate dal Papa, comprese le solenni Cappelle Papali], l’ElemosineriaApostolica [che è governata dal Grande Elemosiniere Apostolico e che compie lacarità materiale e spirituale a nome personale del Papa]. Gli Istituti sono l’ArchivioSegreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana [retti da un Cardinale che è ad untempo Bibliotecario e Archivista di S.R.C.], la Reverenda Fabbrica di San Pietro [cheamministra la Basilica del Principe degli Apostoli], le Accademie Pontificie, l’IstitutoOpere di Religione [la fiduciaria che amministra i beni mobili affidatele]. Inposizione subordinata ad altri dicasteri vi sono le amministrazioni palatinedella Tipografia Poliglotta Vaticana, della Libreria Editrice Vaticana, la Radio Vaticana,l’Osservatore Romano, il Centro Televisivo Vaticano. Esistono inoltre le Pontificie Commissioni,prive di una giurisdizione e provvisorie: la Disciplinare per la Curia Romana, Centrale perl’Arte Sacra, Per l’Archeologia Sacra, Per gli Archivi Ecclesiastici in Italia, Ecclesia Dei [per il rientronella Chiesa della Fraternità San Pio X], nonché quella Per lo Stato della Città delVaticano [che governa il dominio temporale del Papa]; i Pontifici Comitati: di ScienzeStoriche, Per i Congressi Eucaristici Internazionali; la Commissione Cardinalizia per i Pontifici Santuari diPompei, Loreto e Bari. Ognuna di esse ha il suo Presidente, un Segretario e un certo
66
Diocesi181. Egli è peraltro tenuto a presiedere le funzioniliturgiche per la sua Chiesa e per quella Universale. Inoltreegli riceve i fedeli che vogliono incontrarlo, in formapubblica o privata182; i Vescovi sono tenuti a visitarlo perrelazionare sullo stato delle loro Diocesi ogni quattro anni(visite ad limina Apostolorum) nel quadro di un pellegrinaggiosulla Tomba di Pietro. Da mezzo secolo, i Papi hannointrapreso regolarmente a viaggiare in Italia e all’estero183.Infine, vi è il fattivo esercizio della sovranità sul piccoloDominio Temporale ancora esistente184. Il tutto finalizzato albene supremo, condurre le Anime alla salvezza eterna.
numero di membri. La prestazione del lavoro nella Curia è gestita dall’UfficioCentrale del Lavoro della Sede Apostolica. Presso la Curia e i suoi Tribunali sonoaccreditati gli Avvocati, ascritti all’apposito Albo.179 E’ il concetto proprio dei rappresentanti pontifici, i Legati Apostolici, untempo detti a latere, ossia usciti dal fianco del Pontefice. 180 Ciò vale soprattutto per i Cardinali, ossia per il clero della Chiesaprimaziale di Roma, che esistono solo in ragione del Papato e che infatti nonsono una istituzione di diritto divino. Essi mantengono fino ad ottanta anni ildiritto di eleggere il Papa. Il numero degli elettori è fissato a centoventi.Coloro che hanno più di questa età non hanno limiti di numero. Le citateriunioni dei Cardinali, i Concistori, possono essere pubblici, semipubblici eprivati; in alcuni casi deliberanti. I Cardinali possono presiedere solennifunzioni liturgiche dette Cappelle Cardinalizie.181 Ciò avviene essenzialmente attraverso il Cardinale Vicario Generale di SuaSantità per la Diocesi di Roma, coadiuvato dal Vice Gerente, dagli uffici delVicariato e da un congruo numero di Vescovi Ausiliari. Per lo Stato della Cittàdel Vaticano c’è un Vicario Generale separato.182 Da cinquant’anni l’Udienza Generale, aperta a tutti, si tiene il mercoledì.183 In questa maniera, ai pellegrinaggi dei fedeli presso Pietro e il Papa, siaffiancano quelli del Papa alle Chiese locali.184 Tramite le istituzioni proprie dello Stato della Città del Vaticano: ilGovernatorato e la Consulta di Stato, sotto l’egida della citata PontificiaCommissione per lo S.C.V.
67