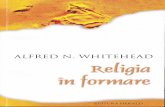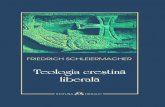elementi di teologia battesimale e crismale
Transcript of elementi di teologia battesimale e crismale
CAPITOLO IIISACRUM BAPTISMA
Elementi di teologia battesimale“Andate dunque e ammaestrate tutte le genti,
battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Chi crederà e sarà battezzato,
sarà salvo; chi non crederà,
sarà condannato” Nostro Signore Gesù Cristo agli Apostoli
Il Sacro Battesimo è il primo dei tre Sacramentidell’Iniziazione cristiana. Se essi pongono le basidell’edificio della vita cristiana, il Battesimo ne è ilfondamento primario e assoluto, il vestibolo d’ingresso cheva attraversato per forza se si vuole entrare nella Vitanello Spirito Santo, la porta che apre l’accesso agli altriSacramenti. Esso è lo strumento mediante cui Cristo,attraverso il Suo Spirito, ci libera dal Peccato originale eci rigenera – realmente e non simbolicamente – quali figli diDio, incorporati in Lui come membra del Suo Corpo Mistico eresi partecipi della Sua missione di Sacerdote, Re e Profeta.Esso è, come insegnava il Catechismo Romano – e come ancorainsegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, che lo cita- ilSacramento della Rigenerazione mediante l’acqua e la Parola.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TEOLOGIA BATTESIMALE
Il nome Battesimo, Baptisma, Baptismum, che deriva dal verbobattezzare, baptizare, baptizein, significa immersione, e quindil’atto o l’azione di immergere e tuffare. Tale immersione èsegno del seppellimento dell’aspirante cristiano – ilcatecumeno - nella Morte di Cristo – per cui in essa eglimuore al peccato che ha marchiato la natura umana - mentre la
riemersione significa la partecipazione alla Sua Resurrezione(Rm 6, 3-4; Col 2,12), nella quale il neofita rinasce qualenuova creatura (2 Cor 5, 17; Gal 6, 15). In poche parole, nelBattesimo l’uomo diventa cristiano, perché da semplice figliodi Adamo diventa figlio di Dio, perché, estratto da Adamostesso nella nascita naturale, in tale rinascita è innestatoin Cristo; per cui non è più meritevole di ira da parte diDio, in quanto macchiato dalla Colpa del Primo Uomo (figliodell’ira), ma, rivestito dei meriti di Gesù Nuovo Adamo, èdegno di amore (figlio della Grazia). Il battezzato è quindifiglio di Dio perché membro dell’Unico Figlio naturale diDio. Il Battesimo è dunque la tomba dell’uomo vecchio ocarnale e l’incubatrice dell’uomo nuovo o spirituale. Non acaso il Sacramento è chiamato anche nella Lettera a Tito,lavacro di rigenerazione e rinnovamento nello Spirito Santo(3,5). L’una e l’altro sono reali e avvengono per unmutamento ontologico della condizione naturale esoprannaturale dell’uomo: infatti Gesù, parlando a Nicodemo,pose come condizione per l’ingresso nel Regno di Dio – ossiaper l’instaurazione nell’anima della presenza sovrana delSignore e quindi per l’accesso alla vita eterna in Paradisooltre la morte– la nascita dall’acqua e dallo Spirito (Gv3,5). Non solo dall’una, né solo dall’Altro, ma per mezzodell’una e attraverso l’Altro. Non il ritorno nel grembomaterno, ma la gestazione nel seno della Trinità. Il Padreinfatti innesta nel Suo Figlio mediante lo Spirito diEntrambi; il Figlio comunica i meriti della Sua Redenzionemediante lo Spirito e incorpora in Sé il cristiano,conducendolo al Padre; lo Spirito Santo giustifica attraversol’acqua rendendo il battezzato Suo Tempio e modellandolosull’Uomo perfetto, Cristo, perché tramite Lui giunga alPadre. Il circuito trinitario si apre e chiude sul battezzatoall’interno dell’amministrazione del Battesimo stesso.Il Sacramento è chiamato anche Illuminazione, perchél’insegnamento dei segni battesimali illuminano realmente lementi, sia consapevoli che inconsapevoli, quando li ricevono.Perciò il battezzato è Figlio della Luce e Luce del mondoegli stesso (1 Ts 5,5; Ef 5,8), avendo ricevuto il Verbo, laLuce vera, che appunto illumina ogni uomo (Gv 1,9), propriotramite questo Sacramento. In genere, il Battesimo è, come
insegna San Gregorio di Nazianzo, Dono, perché è dato a chinulla porta in cambio; Grazia, perché è concesso aicolpevoli; Unzione, perché è sacro e regale e rende talicoloro che lo ricevono; Veste, perché copre la nuditàdell’anima nata spoglia nel Peccato d’Origine; Sigillo,perché ci custodisce ed è segno della Signoria divina su dinoi.Come sempre è solito fare, il Signore Dio ha preparato lafunzione battesimale disseminando nella Storia Sacra figure esimboli legati all’acqua. Tali immagini non hanno cessato diavere una validità, ma sono ricapitolate nel misterobattesimale, che le trasfigura e assegna loro il proprioautentico significato, svelandone il senso profetico. E’ perquesto che la Benedizione dell’Acqua battesimale - chegeneralmente si impartisce nella Veglia Pasquale e che èl’atto liturgico costitutivo dell’efficacia della materia diquesto Sacramento - commemora tutti questi segniveterotestamentari: l’acqua originaria, su cui aleggiava loSpirito di Dio, che in essa poneva così non solo i germidell’ordine naturale e della vita fisica, ma anche quellidell’ordine soprannaturale e della vita spirituale; l’acquadel Diluvio, sulla quale galleggiò l’Arca, a sua voltasimbolo della Chiesa, i cui occupanti scamparono alla morte,mentre il peccato finiva travolto e iniziava la vita nuova;l’acqua del Mar Rosso, aperta da Mosè per mandato divino enella quale passarono gli Ebrei uscendo così dalla schiavitùd’Egitto, simbolo del peccato; l’acqua del Giordano, apertada Giosuè per ordine celeste, attraverso cui Israele entrònella Terra Santa, simbolo del Paradiso.In genere, le acque bibliche sono sia quelle di fonte chequelle di mare: le une significano la vita, le altre lamorte; profeticamente, questa è in ogni caso sempre e solo laMorte del Cristo, immerso nel mare dei patimenti, che a Suavolta nel Battesimo ci immerge proprio in questo Suo oceanodi dolore rigeneratore, senza che noi abbiamo a patirlo, nonpotendo meritare la nostra salvezza e venendo così ad essereesentati dalla pienezza della sofferenza rigeneratrice, percui, come il Peccato venne da uno solo, Adamo, senza nostra
colpa, così la Grazia venne sempre da Uno solo, Cristo, senzanostro merito.Nel Nuovo Testamento poi viene compiuto il Battesimo di Gesùstesso: esso da un lato è il compimento di tutti i riti dipurificazione antichi , che trovano nell’assoggettamento alpiù recente di essi, da parte dello stesso Cristo, la ragionedella loro efficacia retroattiva; dall’altro è l’attofondativo, la ragione eziologica del Battesimo cristiano.Gesù infatti si appropria di questo rito e lo fa Suo : la Suadiscesa nelle acque le santifica; la Sua Morte e Resurrezionefa sì che chi entra nelle acque possa, su Suo mandato,ricevere tramite esse ciò che Lui ha guadagnato per tutti.Infatti proprio nel Battesimo Gesù si manifesta quale Uomo eDio, inserito nel vincolo trinitario, con lo Spirito chescende su di Lui e con il Padre che lo presenta quale Figlioprediletto da ascoltare. E Giovanni, il Precursore, attestache Colui su Cui scese lo Spirito era stato a lui presentatoquale Agnello di Dio che toglie il peccato: vi è dunque unnesso ermeneutico tra il Battesimo e il Sacrificio di Cristo;Egli, come nell’Eucarestia, istituisce prima il segnosacramentale e poi compie l’unico atto che gli dà efficacia.In ciò si realizza la parola del Signore Che, al Battistacontrario al Suo Battesimo perché non ne aveva bisogno,rispose: “Conviene che così adempiamo ad ogni giustizia ” (Mt3,15). Infatti Gesù parlò poi della Sua Morte come di unBattesimo (Mc 10, 38) in cui doveva essere battezzato e chelo angosciava, fino a quando non l’avesse ricevuto. Eral’immersione appunto nel dolore purificatorio per l’umanità.Così dopo la Morte, trafitto al Costato, versò dal CuoreSangue e Acqua, segni sostanziali dell’Eucarestia e delBattesimo, resi possibili dalla Sua Immolazione. In un certosenso, l’acqua del Sacramento è l’acqua del Costato di Gesù.Al termine poi della Sua Vita sulla Terra, già risorto,apparendo sul Tabor in Galilea ai Suoi Apostoli, Gesù stessoconferì loro il mandato missionario e disse: “Andate dunque eammaestrate tutte le genti, battezzandole nel Nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro adosservare tutto ciò che vi ho comandato. Chi crederà e saràbattezzato, sarà salvo; chi non crederà sarà condannato” (Mt
28, 19-21). E già durante la Sua attività di ministero, primadella Sua Passione, Gesù aveva detto: “Chi non rinascedall’acqua e dallo Spirito non può entrare nel Regno deiCieli” (Gv 3,5). E’ la frase che disse a Nicodemo, come horammentato prima. Dicevamo che tale rinascita non avvienesolo dallo Spirito ma anche dall’acqua; non solo dall’acqua,ma da essa e dallo Spirito, che la fecondava dall’inizio deltempo. La Nuova Creazione, di cui Cristo è artefice cosìcome, in quanto Verbo, realizzò la Vecchia, si compie in ogniBattesimo, perché ogni uomo, vertice della Creazione antica,è ricreato in esso, e in ciascun uomo tutti gli elementi sonoredenti.E’ dunque da dopo la Morte e Resurrezione di Gesù che si devebattezzare nel senso cristiano –essendo stato quello diGiovanni un lavacro penitenziale e non sacramentale – ed èper il Suo ordine di farlo che esso diventa strumentoordinario indispensabile per accedere alle sorgenti dellaSalvezza , per entrare in quella Chiesa fuori della quale nonvi è salvezza, per comunicare ai meriti di quel Cristo Che èil solo Salvatore. Dal giorno di Pentecoste gli Apostolibattezzano (At 3, 28); essi offrono il Sacramento a tutti,pagani ed ebrei, uomini e donne, adulti e bambini, legandolosempre alla professione della Fede. Essa è intesa non solocome atto e quindi confessione di determinati dogmi, ma comeabito, ossia come affidamento di sé alla potenza salvificadel Cristo, Unico Redentore, che ci ha salvati e alla qualesiamo quindi predisposti: “Credi in Gesù e sarai salvato tu ela tua famiglia” disse san Paolo al suo carceriere, che poiricevette il Sacramento coi suoi parenti (At 16, 31). Perquesto, come diremo meglio, il Battesimo è Sacramento dellaFede, più di tutti gli altri Sacramenti, perché la genera equindi la esige.Ed è proprio san Paolo a rivelare per conto dello SpiritoSanto la mistagogia – ossia il percorso misterico – delBattesimo, che come ho detto ci immerge nella Morte diCristo, facendo morire l’uomo vecchio nato nel Peccatooriginale e segnato da esso e dai peccati attuali, e che cirisolleva nella Resurrezione, facendoci rinascere come uomininuovi. In poche parole, tramite il Battesimo ogni uomo
ottiene quella Salvezza che a coloro che erano nati prima delRedentore era data solo per la fede, implicita o esplicita,nel Redentore venturo. E la comunica con una pienezzasconosciuta all’Antica Alleanza. Infatti esso non solopurifica in questa Alleanza, ma santifica e giustifica inmodo da rivestirci di Cristo. L’uomo diviene pienamentemembro del Corpo Mistico e può osservare pienamente la Leggedella Carità .
LA LITURGIA BATTESIMALE
Questo Sacramento viene celebrato dalla Chiesa in un modoparticolare. Nel caso del Battesimo degli adulti,innanzitutto colui che aspira al Sacramento, appunto ilcatecumeno, deve essere iniziato attraverso delle tappe:ascoltare la Parola, accogliere il Vangelo, convertirsi,professare la Fede, ricevere il Battesimo propriamente detto,per poi avere l’effusione dello Spirito e la ComunioneEucaristica. Nei primi secoli il catecumenato, riservatoordinariamente agli adulti proprio per tale percorso, eracomplesso e articolato. Invalso l’uso del Battesimo deibambini, la celebrazione stessa è diventata un condensato diquesti momenti. Per cui l’istruzione vera e propria èriservata ad un catecumenato post- battesimale eall’insegnamento del Catechismo.Questo, sebbene esista ancora oggi il catecumenato per gliadulti, diviso in più gradi dal Concilio Vaticano II e con unRito proprio promulgato da Paolo VI (1972); anzi nelle Chiesemissionarie vengono accolti, nel rituale cristiano, queglielementi di iniziazione legati alle culture locali che nonsono in contrasto con la nostra Tradizione. In attesa di averricevuto il Battesimo, il catecumeno è già parte della Chiesaanche se in modo imperfetto; qualora muoia senza averricevuto il Battesimo, il desiderio che egli ne ebbe fa siche gliene siano anticipati gli effetti in punto di morte(Battesimo di desiderio). In genere, in tutti i riticattolici, l’iniziazione comincia col catecumenato e arrivaal suo vertice con la celebrazione unitaria del Battesimo,
della Cresima e dell’Eucarestia. Questa trinità sacramentaleè amministrata anche ai bambini nei riti orientali, mentre inquello romano al Battesimo segue, dopo alcuni anni e conadeguata catechesi, sia l’Eucarestia che la Cresima; la primaè peraltro preceduta dalla prima Confessione.I bambini, che sono stati battezzati sin dall’origine dellaChiesa, quando intere famiglie entravano in essa, sonodiventati i soggetti principali del Sacramento per svariateragioni: anzitutto essi nascono col Peccato originale equindi hanno altrettanto bisogno di rinascere, al più presto,alla vita di Grazia, alla quale tutti sono chiamati, per nonvivere inultilmente molti anni fuori della Salvezza; poiessi, con la loro completa inconsapevolezza, ben si addiconoa ricevere il puro dono gratuito del Sacramento, che nullasuppone in colui al quale è amministrato; inoltre, inrelazione ai propri genitori, danno occasione per ilcompimento di un grave dovere di salvezza e vita immortale –ben maggiore di quella terrena – nei loro confronti. Ingenere, con il consolidarsi delle generazioni cristiane, giàdal II sec. iniziò la prassi del Battesimo dei bambini .In ordine alla celebrazione del Sacramento, va innanzituttodetto che ne è ministro ordinario il Vescovo o il Presbiteroe, nella Chiesa latina, per delega, il Diacono . In quanto aimomenti centrali della mistagogia liturgica battesimale, essisono i seguenti:
1. il Segno della Croce, all’inizio, perché ilbattezzando riceverà la Grazia conquistata sulla Croce daCristo e ne porta il sigillo in quanto gli apparterrà;
2. l’Annunzio della Parola, che illumina i presenti esuscita, in loro o nel battezzando o in chi per lui, larisposta della Fede di cui il Battesimo è appunto ilSacramento per eccellenza;
3. l’Esorcismo, che scaccia satana dal battezzando,unto appositamente con l’Olio dei catecumeni, benedettodal Vescovo nella Messa Crismale del Giovedì Santo; inragione di ciò il battezzando o chi per lui rinunzia aldiavolo, alle sue opere e seduzioni e può fare subitodopo
4. la Professione di fede negli articoli essenzialidella dottrina cristiana ;
5. la Benedizione dell’acqua battesimale, secondo lapreghiera di epiclesi citata, sia la Notte di Pasqua che,nelle chiese senza fonte battesimale, sul momento;
6. il Rito essenziale, o Battesimo vero e proprio; lasua materia è l’acqua, nella quale il battezzando èimmerso tre volte – nei riti orientali – o da cui èasperso o su cui è infusa altrettante volte – nel ritoromano – accompagnata dalla forma che recita: “N., io tibattezzo nel Nome del Padre e del Figlio e dello SpiritoSanto” (in Occidente) o “il servo di Dio N. è battezzatonel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”;essa è pronunziata in modo tale che ad ogni immersione,aspersione o infusione è scandita l’invocazione di unadelle Persone Divine ; tale rito essenziale può essereimpartito da solo in caso di necessità, come il pericolodi vita, addirittura da qualunque fedele laicobattezzato, se non persino da un non cattolico e un noncristiano, maschio o femmina, adulto o ragazzo, purchèadempia alla formula prescritta e abbia l’intenzione difare ciò che fa la Chiesa, in quanto Dio vuole tutti gliuomini salvi (1 Tm 2,4) e il Battesimo stesso èindispensabile alla salvezza (Mc 16, 16) ;
7. l’Unzione col Sacro Crisma, l’olio profumatoconsacrato dal Vescovo nella Messa crismale – da cuiprende il nome- che significa il dono dello Spirito Santodato al battezzato; esso indica la nuova dignità delcristiano, sacerdote re e profeta come Cristo, del CuiCorpo è ora membro; nella Chiesa Orientale tale unzione èSacramento perché è Confermazione; in quella Occidentaleè Sacramentale perché rimanda al dono dello Spirito Santofatto col solo Battesimo in attesa della Cresima diqualche anno dopo;
8. l’imposizione della Veste Bianca indica che ilbattezzato è ormai rivestito di Cristo, con la Graziasantificante, privo di ogni macchia;
9. la Candela accesa dal Cero pasquale significa che ilbattezzato è ormai partecipe della Luce di Cristo, con
cui deve illuminare il mondo; essa gli viene consegnata oè data a chi per lui;
10. la recita del Padre Nostro da parte del battezzato,ormai figlio di Dio, o da parte di chi lo rappresenta;
11. la Prima Comunione eucaristica, data ai bambininelle Chiese Orientali e solo agli adulti nella ChiesaOccidentale; sono due prassi sacramentalisufficientemente motivabili: la prima, in quanto Gesù haordinato che i piccoli vengano a Lui (Mc 10, 14), laseconda perché è bene tuttavia aver uso di ragione perriceverlo sacramentalmente;
12. la Benedizione solenne, che nel caso del Battesimodei bambini riguarda la madre in modo particolare.
Al battezzando, nel momento centrale del rito sacramentale,si chiede la Fede. Come insegna Gesù stesso, chi crede e sifa battezzare si salva. La Fede richiesta è quella in CristoSalvatore. Tale Fede permette di ricevere con profitto ilBattesimo, che dà la Grazia che ci rende capaci del bene.Infatti san Paolo insegna che è giustificato chi crede inCristo. La Fede tuttavia non viene fuori dalla volontà edall’intelligenza del battezzando, ma dalla Chiesa stessa,alla quale egli – o chi per lui – la chiede. Ossia vienecomunicata al catecumeno in virtù dell’efficacia della Chiesaquale sacramento di salvezza e quindi per effetto anticipatodel Battesimo stesso, senza cui nessuna Grazia può essereconferita al neofita. Ossia, quel Dio che chiama al Battesimosuscitando la fede in esso, tramite esso conferisce lapienezza della Grazia che la fede stessa reclama. Perciòdiciamo che il Battesimo è Sacramento della Fede. Tale Fede èdunque embrionale all’atto del Battesimo, appunto più unabito che un atto. Dovrà crescere. Diciamo quindi che si ègiustificati per le opere in modo altrettanto esatto. Inentrambe le formule soteriologiche la scaturigine strumentaledella Grazia è il Battesimo. In ragione di tutto ciò, da unlato il Battesimo può essere ricevuto anche dai bambini,perché essi sono capaci di ricevere la Fede come Grazia,anche se non possono ancora fare atti della Fede stessa;dall’altro proprio per conto dei bambini i loro genitori e icosiddetti padrini possono chiedere alla Chiesa il dono dellaFede nel Battesimo stesso in vista della Salvezza, facendo
essi in prima persona un atto di questa virtù teologale eimpegnandosi ad educare i figli nella religione cristiana .In poche parole, battezzare un bambino anche se questi non hala consapevolezza di ciò che gli accade non è pedagogicamentediverso dal fatto che egli sia educato dai genitori in valoriche non ancora conosce e capisce, ma ai quali è sottintesoche debba e voglia dopo dare il suo assenso, proprio perchéeducato in essi. Ragion per cui le obiezioni dellaplurisecolare disputa sul Battesimo dei bambini non hanno unaragion d’essere, ancor meno se si considera che il Sacramentonon è solo un atto pedagogico, ma produce una mutazioneontologica nel soggetto che lo riceve, di cui andiamo adire .
EFFICACIA SOTERIOLOGICA DEL BATTESIMO
Nostro Signore in Persona ha insegnato che il Battesimo ènecessario per la salvezza: da esso si rinasce e dalloSpirito, come dal grembo materno (Gv 3, 5), come si è dettoall’inizio. Perciò tutte le genti debbono essere battezzate,o altrimenti saranno perdute (Mt 28, 19 ss.): Morte oBattesimo è l’alternativa che San Bernardo mostrava ai pagani. Coloro che dunque sanno che Dio ha istituito taleSacramento e lo rifiutano o lo disprezzano o lo trascurano,pur potendolo richiedere, sono fuori della Chiesa e quindiprivi della Salvezza (Mc 16, 16). Non esiste infatti alcunaltro mezzo per cui la Chiesa stessa possa comunicare laGrazia santificante. Dio ha legato la salvezza a questoSacramento.Tuttavia Egli non è vincolato ai Suoi Sacramenti. Perciò visono altre due forme battesimali mediante cui vienecomunicata la Grazia ai non battezzati nell’acqua. La prima èil Battesimo di Sangue, ossia la testimonianza del martirio:chiunque muoia per la Fede senza aver ancor ricevuto illavacro, è asperso dal Sangue di Cristo nell’uniformazionealla Sua Morte . Il già citato Battesimo di desiderio valesia per coloro che sono morti prima di ricevere il Sacramentoa cui si preparavano (ossia i citati catecumeni) sia per
coloro che, pur non conoscendo il precetto di Cristo sulBattesimo, sarebbero desiderosi di riceverlo se loconoscessero, come anche coloro che, non conoscendo Cristostesso o finanche Dio, sarebbero disposti a servirLi sefossero loro noti, con zelo e amore. Costoro desiderano,senza saperlo, un Battesimo che non conoscono. Almeno unavolta nella vita, tutti i non cristiani sono messi incondizione di desiderare il Battesimo e di entrare cosìinvisibilmente nella Chiesa, anche se magari mai laconosceranno in terra. Tale Battesimo trae la sua efficaciadalla mediazione universale e strumentale della Chiesa,Sacramento di Salvezza. In quanto ai bambini morti senzaBattesimo, è certo che senza la sua Grazia essi sono perdutialla Salvezza e destinati ad una mera felicità naturale oLimbo dei Fanciulli; ma non è detto che essi non possanoessere raggiunti, per vie a noi ignote, dalla Grazia stessa equindi entrare anch’essi nel Regno di Dio. In ogni caso èbene battezzare i bambini entro otto giorni .Tale universalità del Battesimo si deve al fatto che tramiteesso si compiono azioni insostituibili:
1. innanzitutto esso cancella il Peccato originale;restituisce quindi l’innocenza in cui Adamo fu creato econferisce la Grazia santificante, ossia la vita divina,mediante cui lo Spirito Santo opera e risiede in noi;diventiamo perciò membra del Cristo, figli del Padre,tempio dello Spirito;
2. inoltre cancella i peccati personali in chi loriceve da adulto, sia in ordine alle colpe (ossial’imputabilità) sia alle pene, di qualunque genere:mortali e veniali; chi muore dopo il Battesimo, anche seadulto, se dopo non ha commesso alcun nuovo peccato, vadiritto in cielo perché innocente;
3. cancella altresì le conseguenze personali delpeccato, sia originale che individuale; dunque restaurala libertà perduta col Peccato d’origine, per cui l’uomopuò non solo scegliere il bene con il libero arbitrio, maperseverare in esso; altresì annulla le conseguenze sullalibertà umana causate dai peccati individuali, specie semortali; non fa scomparire invece le conseguenze del
peccato sulla natura: la sofferenza e la morte,l’ignoranza, la concupiscenza, nonché le lorodeclinazioni individuali, come difetti e limiti dellamente e del corpo, della volontà e del sentire ;
4. conferisce la Grazia sacramentale, ossia quellaspecifica per vivere per sempre come fedele cristiano, adispetto e in contrasto con le stesse conseguenzenaturali del peccato, mantenendo almeno l’opzionefondamentale per Dio nell’anima;
5. in virtù della Grazia santificante, infonde le trevirtù teologali, chiamate così perché riguardano Dio, chepossono essere praticate di conseguenza. Esse sono: 1) laFede, che ci fa credere fermamente in Lui, in quantoverità infallibile, e in ciò che ci ha rivelato e ci èproposto dalla Chiesa, vivendo di conseguenza, a partiredalla Due Verità principali del Cristianesimo: A) Unità eTrinità di Dio; B) Incarnazione, Passione, Morte eResurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, Vero Uomo eVero Dio, Giudice dei Vivi e dei Morti; la Speranza, checi fa attendere dalla Sua bontà, per le Sue promesse e imeriti di Cristo Salvatore, la vita eterna e le grazienecessarie per meritarla con le buone opere che sivogliono e devono fare; la Carità, che ci fa amare Diosopra ogni cosa, sopra la nostra stessa vita e sopra noistessi, perché Bene infinito e nostra felicità che ciamati per primo e infinitamente, nonché il prossimo, peramor suo, come noi stessi, come amiamo Lui e come Lui loama, perdonando le offese;
6. sempre per la Grazia santificante, rende capaci divivere e agire sotto l’azione dello Spirito Santo, che èla Grazia increata, riempiendoci dei Suoi doni: laSapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la Scienza, laPietà, la Fortezza, il Consiglio e il Timor di Dio;
7. infine, in relazione alla Grazia santificante e allasacramentale, permette di praticare il bene naturale,elevato al rango sovrannaturale, tramite le virtùmorali ;
8. esplicando quanto detto, esso ci incorpora allaChiesa, rendendoci membra gli uni degli altri (Ef 4, 25),facendoci partecipi del sacerdozio reale dei fedeli,
dandoci in proprietà a Cristo e sottomettendoci a Lui eai Suoi rappresentanti in Terra, nonché conferendoci idiritti ai beni soprannaturali custoditi nella Chiesastessa e legandoci ai doveri della professione pubblica edell’apostolato della Fede, nonché del culto edell’osservanza dei Comandamenti;
9. imprime quindi il carattere o sigillo indelebile checi fa cristiani, ossia ci scorpora da Adamo e innesta inCristo stesso; tale sigillo non è cancellato da nessunpeccato, anche se i peccati successivi impediscono,specie se mortali, al Battesimo di portare frutti; talesigillo, custodito con zelo, sarà motivo di gloria pergli eletti; negletto, sarà ragione di vergogna per idannati .
NOTE AL CAPITOLO III1. La Legge mosaica imponeva abluzioni rituali in caso di impurità in Nm19, 1-22. I Profeti indicarono la pratica dell’abluzione come segno dipurificazione interiore, associata al dono dello Spirito (Ez 36, 25-28).I riti di abluzione si moltiplicarono presso gli Ebrei durante ladominazione persiana e il termine “battesimo” si diffuse negli ambientifarisaici. Nel I sec. i proseliti erano battezzati dopo la circoncisioneper avere accesso ai sacrifici templari. L’ultimo di questi attisimbolici fu proprio il Battesimo di Giovanni. Esso era una prassipenitenziale in vista dell’avvento prossimo del Messia. Probabilmente,sulla scia di Qumran, surrogava o integrava i sacrifici del Tempio. Innessuna di queste forme l’abluzione cancellava il Peccato da se stessa,né tantomeno rendeva partecipi di una Nuova Alleanza e di un Sacrificiodefinitivo. Questi caratteri vengono attribuiti al Battesimo da Gesù, Chequindi lo rivoluziona completamente, per cui il Suo Battesimo ècompletamente diverso da quelli precedenti. Esso prende il posto anchedella Circoncisione, quale segno di appartenenza al nuovo Popolo Eletto.Vi è dunque, nel significato del Battesimo cristiano, un complessosinecismo concettuale desunto sia dalle abluzioni mosaiche che da altririti iniziatici del mosaismo, ma dotato di una forza e di una peculiaritàsoteriologiche inedite.2. Tutti i Sacramenti sono stati istituiti da Gesù Cristo. Anche iRiformatori protestanti ammettevano che il Battesimo è stato voluto daGesù. Tuttavia Lutero sostiene che esso sia solo un’esortazione alla fedeche giustifica e il simbolo della purificazione per fede; Zuingli loconsidera un rito di ammissione alla Chiesa ma non un mezzo per laremissione del Peccato d’origine, in cui egli non crede; Calvino inveceidentifica l’efficacia del Battesimo di Cristo con quella del Battesimodi Giovanni: questo era simbolo della remissione delle colpe per la fedein Cristo venturo, quello segno della remissione delle colpe per la fedein Lui venuto. Invece i Protestanti liberali affermarono che il Battesimosia nato negli ambienti cristiani entro il II sec. Lo stesso insegnaronoi Modernisti e i Neomodernisti. Che Cristo abbia istituito il Battesimo,lo attestano Mt 28, 18; Mc 16, 15; lo attesta la pratica degli Apostoliattestata dagli Atti, che si rifanno alle parole di Gesù, evidentementemolto prima del II sec. e già nella prima generazione cristiana –peraltro gli Apostoli marcano la differenza tra il Battesimo di Gesù equello di Giovanni, ribattezzando i seguaci di questo- lo attesta sanPaolo, battezzato lui stesso, che oppone tale Battesimo alla
circoncisione e che battezza a volte personalmente, su mandato di Cristo;lo attesta infine tutta la Tradizione patristica, che chiama ilSacramento Battesimo di Cristo. D’altro canto, se il Battesimo fossestato istituito da altri, perché la Sacra Scrittura avrebbe dovutotacerlo? E’ ovvio che un tale rito, così importante, venisse attribuito aqualcuno. Ma ciò non avviene, perché lo istituì Cristo, appositamentemenzionato a tale proposito dalla Bibbia.3.Che il Battesimo sia indispensabile per la salvezza è stato ribaditodal Concilio di Firenze (1437-1445), da quello di Trento (1545-1564) e dapapa san Pio X (1903-1914), nonché dal Concilio Vaticano II (1962-1965) edal ven. Giovanni Paolo II (1978-2005), che al Battesimo ha dedicato lelettere apostoliche Magnum Baptismi Donum ed Euntes in Mundum. Il Battesimo èmezzo necessario, per ordine di Dio, il Quale supplisce da Sé, nei modiche vedremo, laddove tale Sacramento non può essere amministrato. ICainiti e i Quintiliani, che dicevano che solo la Fede basta per lagiustificazione, furono contrastati da Tertulliano. I Pelagiani, chenegarono il Peccato originale, considerarono il Battesimo necessario soloper acquistare il Regno di Dio e non la vita eterna, separando l’unodall’altra surretiziamente. Catari e Albigesi sostituirono il Battesimocon il Consolamento, credendo che il primo fosse stato istituito dalprincipio negativo del cosmo, in quanto amministrato con un elementomateriale. Lutero considerò invece il Battesimo indispensabile, comeCalvino, non perchè mezzo necessario, ma solo per l’ordine di Gesù. ISociniani invece ne rigettarono la necessità, in quanto per essi era soloun rito di adesione alla Chiesa, di cui non c’è bisogno se si nasce dagenitori già cristiani. Mt 28, 19; Mc 16, 16; Gv 3, 5; At 2, 41; 10, 48;Gal 3, 27 sono luoghi biblici in cui si mostra chiaramente il contrariodi quanto insegnato da costoro. La Tradizione puntella questa dottrinabiblica, con i Padri Apostolici, con Erma, Tertulliano, Origene, sanCipriano, san Cirillo di Gerusalemme, sant’Ambrogio, sant’Agostino.4. Nella Nuova Alleanza, Maria SS., essendo Immacolata e Tutta Santa, èpreservata da ogni macchia, così come fu creato Adamo, nonostante siaanche Lei sua figlia, perché Ella è più unita al Figlio Suo che al padrecomune. La Sua partecipazione ai riti d’iniziazione della Legge mosaicadà a quei riti il loro compimento, a vantaggio degli altri ebrei, invirtù dei Suoi meriti, che sono parte integrante, anche se nonnecessaria, del mistero della Redenzione. In un certo modo quindi,battezzati in Cristo, Che contiene in Sé l’efficacia dei meriti Suoi e insubordine di Maria, noi siamo messi in contatto anche con i meriti diCostei, che in quanto Corredentrice e Mediatrice, è chiamata ed èrealmente Madre della Grazia Divina e Madre di ognuno di noi e dellaChiesa nel suo complesso. Gli Apostoli a loro volta, con tutti idiscepoli di Gesù, e la stessa Madre di Dio, furono battezzati di SpiritoSanto e fuoco a Pentecoste, come profetizzò Giovanni Battista: Eglibattezzerà in Spirito Santo e fuoco.Ma questo, solo per coloro che loascoltavano: infatti molti discepoli di Giovanni divennero discepoli di
Gesù e addirittura Apostoli. Per noi il fuoco è ormai solo il simbolodella carità che il Sacramento ci comunica.5. Luoghi biblici del Battesimo dei bambini sono l’uso estensivo di Gv3,5 e 1 Tim 2, 4; sono altresì Mt 19, 14; Mc 10, 13; Lc 18, 15; Rm 5,17;Col 2, 11; At 10, 48; 16, 33; 18, 8. Autori della Tradizione che sipronunciano in merito sono Tertulliano, san Cipriano, sant’Ireneo,Origene. L’obiezione fatta spesso al Battesimo dei bimbi, per cui essisono forzati in quanto inconsapevoli, è inconsistente. Il bambino ètenuto ad obbedire alle leggi naturali in virtù della sua stessa nascita;a maggior ragione, siccome senza Battesimo non può adire all’eternità, ètenuto a riceverlo, come legge soprannaturale che perfeziona le naturali.Perciò, come non si chiede ma si suppone il suo consenso all’ingressonella società e all’ossequio alle sue leggi, così non si immagina cheegli possa rifiutarsi di entrare nella Chiesa e di seguirne le leggi,date da Dio stesso. Infatti, l’uomo è libero di professare una qualsiasifede innanzi ai propri simili, ma non innanzi alla propria coscienza e aDio. In virtù di ciò, i genitori hanno l’obbligo grave di battezzare ifigli. Anche contro la volontà dei genitori cristiani, in casi estremi, ibambini devono essere battezzati, da chi ne ha il diritto o la tutela ola responsabilità, legali o morali, temporanee o perpetue, o forse anchesolo la possibilità. Per esempio quando un bambino, nato da genitoriapostati, è in punto di morte, o quando per odio alla Chiesa e alla fedeil bambino non è battezzato, per volere anche di un solo genitoreapostata, magari a dispetto della volontà dell’altro genitore.Analogamente i bambini figli di non battezzati possono essere battezzatida chi ne ha la tutela legale o morale – come in caso di affido o in ognisituazione in cui un cristiano educhi quei bambini senza inframmettenzesignificative dei genitori non cristiani- ma è bene che tale Battesimonon si amministri se i genitori non cristiani possano poi opporre alSacramento la loro opera educativa contraria al Vangelo, rendendo quindiinerte la Grazia ricevuta. Infatti è diritto naturale di ogni famigliaordinare liberamente la propria vita religiosa sotto la guida deigenitori (Dichiarazione del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae n. 15).Perciò, siccome è bene che nessuno sia forzato ad agire contro la propriacoscienza (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.155,promulgato dal ven. Giovanni Paolo II nel 2004), ivi compresi i genitorinon cristiani, quando essi hanno voce in capitolo, per evitare di agirein modo controproducente, non si deve battezzare i loro figli a dispettodel loro volere. Sebbene “infatti la Rivelazione non affermiesplicitamente il diritto all’immunità della coercizione esterna inmateria religiosa.. un elemento fondamentale della dottrina cattolica…èche gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendovolontariamente; nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare laFede contro la sua volontà (DH nn. 9-10)” ed evidentemente contro quelladi chi legittimamente esercita la sua potestà su di lui. La coercizioneda cui l’uomo dev’essere libero è quella del potere civile. Nel corso deisecoli, quando la potestà coattiva materiale spettava anche alla Chiesa,
essa, in alcuni casi, specie quando la dilatazione della Fedecorrispondeva a quella della Cristianità intesa come comunità politico-sociale, ha formato al Battesimo e lo ha amministrato senza che essoavesse una reale alternativa per chi lo riceveva. Bisogna tuttaviadistinguere i casi limite di Battesimi forzati fisicamente, semprerigettati dalla Chiesa anche se riconosciuti validi, dai Battesimiamministrati a gruppi inseriti in società cristianizzate anche con laviolenza (dottrina del Coge intrare): quest’ultimo caso, sebbene moltolontano dalla sensibilità moderna, rientra in una tipologia missionariaperfettamente legittima e conforme a quelle epoche, in cui non erateorizzata la libertà individuale nei modi contemporanei. Oggi taleteologia è stata modificata per le ragioni di cui sopra, sia perché laChiesa non ha più la potestà coattiva (decaduta col Codice di DirittoCanonico pio-benedettino), sia perché essa stessa rifiuterebbe di usarlain tale senso. Infatti, sebbene tutti gli uomini debbano esserebattezzati, perché ne hanno bisogno, la natura della Fede che scaturiscedal Battesimo, ossia libera e volontaria, si addice meglio ad unasituazione a sua volta scevra da ogni coazione.6. Nel Battesimo pubblico e solenne, con tutti i riti che seguono, iministri ordinari sono appunto il Vescovo e il Presbitero che esercitiuna giurisdizione, ossia titolare di una chiesa con il fonte battesimaleo parrocchiale; il ministro straordinario è il Diacono, perché delegato,in quanto privo di giurisdizione propria. Il fatto che gli Apostoliabbiano subito abbandonato quasi completamente l’uso di battezzare facapire che i Presbiteri li surrogarono (1 Cor 1, 14-17). In quanto aldiritto del Diacono cfr. At 9, 18. La Tradizione conferma quanto dettocon sant’Ignazio di Antiochia, san Vittore I (181-191), Tertulliano,santo Stefano I (254-257), san Cirillo di Gerusalemme, l’Ambrosiaster.7. Chiamiamo Promesse battesimali le Rinunzie e gli Atti di Fede.8. La materia è in tal caso di due tipi: remota e prossima. Remota èl’acqua in quanto tale; l’immersione o infusione o aspersione è materiaprossima. Per quanto concerne la materia remota, il Concilio di Trentoinsegna che l’acqua dev’essere vera e naturale, e non può esseresostituita da altri liquidi; insegna altresì che il battezzato rinascerealmente e non solo simbolicamente dall’acqua e dallo Spirito. Gnostici,Manichei, Albigesi e Catari consideravano l’acqua un elemento malvagio,in quanto materiale, e la ripudiarono; Lutero riteneva che potesse essereall’occorrenza sostituita da altri liquidi e non necessariamente dovesseessere di fonte; Calvino invece aveva le stesse idee della ChiesaCattolica. Che l’acqua battesimale faccia rinascere, lo attesta laScrittura, in numerosi luoghi del Vangelo e degli Atti: Gesù a Nicodemo,Pietro a Cornelio, Filippo all’Eunuco di Candace; anche Paolo lo attestaa Tito. Analogamente lo testifica la Tradizione, con la Didakè,sant’Ireneo, Tertulliano, sant’Agostino. Ovviamente l’acqua dev’essere,come dicevamo, appositamente benedetta. In relazione alla materiaprossima, diciamo che può appunto essere di tre tipi, ed è bene che ogni
fedele si adegui all’usanza del proprio rito. Siccome il Signore,stabilendo l’abluzione come materia prossima, non ha specificato il modo,nella Scrittura troviamo i tre modi: immersione, aspersione, infusione.Perciò errano Protestanti e Ortodossi che accettano solo l’immersione.L’immersione è attestata in Col 10 e Rm 6; Ef 5, 26; Mt 3, 16; Atti 8,36. In principio fu totale, poi parziale. Questa è la maniera piùlodevole e sicura, perché più comune (Alberto Magno e Tommaso d’Aquino).L’aspersione e l’infusione sono attestati in At 2, 41; 9, 18; 16, 33; 22,16; la seconda è anche testimoniata nella Didakè. Tre infusioni,aspersioni e immersioni sono necessarie solo nel Battesimo solenne, ma inquello d’emergenza ne basta una. Deve esserci contatto diretto tral’acqua infusa, aspersa o in cui si è immersi e il corpo del battezzando;tale contatto esige che l’acqua sia fluente (la Congregazione delSant’Uffizio ordinò, nel 1898, sotto Leone XIII, che il Battesimoimpartito come unzione d’acqua fosse, sia pure sotto condizione,rinnovato); se non vi è completa immersione del battezzato, alloral’acqua va versata sul capo (uso invalso nella Chiesa latina nel XIIIsec.); bisogna che colui che immerge o asperge o infonde di acqua sulbattezzando pronunzi lui stesso la forma battesimale.9. Il I Concilio di Nicea (325) ha ordinato di ribattezzare coloro chenon sono stati battezzati in Nome della SS. Trinità, perché il loroBattesimo è invalido. Ciò riguardava Paulinisti, Fotiniani, Montanisti eAriani, mentre oggi verte su tutti coloro che fanno parte di gruppiantitrinitari, come i Testimoni di Geova. I Riformatori protestantinegarono l’importanza della formula trinitaria e addirittura quelli piùrecenti negarono che si potesse risalire alla formula dettata da Cristo.In realtà Mt 28, 19 in modo diretto e At 19,1 in modo indiretto attestanol’uso della formula trinitaria sin dalle origini. In quanto poi allaforma del Battesimo in Nome di Gesù, qua e là attestata nel NT, essa nonrimanda ad un uso liturgico ma ad un senso teologico, marcando ladifferenza col Battesimo di Giovanni e mostrando la centralità dellaMediazione di Cristo nella Salvezza. La Tradizione conferma la formulatrinitaria, con la Didakè, con san Giustino, sant’Ireneo, san Cipriano,sant’Ambrogio, san Beda, san Bernardo, il beato Ugo di San Vittore,Pietro Lombardo, Alessandro di Hales e san Tommaso. Il magistero, amargine del I Niceno, conferma tale insegnamento, con sant’Innocenzo I(401-417), san Niccolò I (858-867) e con il Concilio di Arles del 314nonché altri sinodi. Va peraltro aggiunto che la forma deve citareseparatamente ed espressamente le Tre Persone Divine, pena la nullità, edeve essere premessa da “N., Io ti battezzo” oppure “il Servo di Dio N. èbattezzato”.10. Si tratta del Battesimo privato e amministrato in caso di necessità.Questa dottrina sul ministro universale è stata insegnata da santoStefano I (254-257), san Niccolò I, dal Concilio Laterano IV (1215), dalConcilio di Firenze. I Marcioniti insegnavano erroneamente che le donnepotessero amministrare anche il Battesimo solenne; altri eretici che
insegnavano lo stesso furono contestati da Tertulliano. Calvino invecenegava il diritto dei laici a battezzare. Tale diritto invece è sancitodalla Scrittura (At 9, 18). La Tradizione lo conferma con san Vittore I,Tertulliano – che impone il dovere di battezzare, a chi può farlo, nellecircostanze estreme – san Cirillo di Gerusalemme, l’Ambrosiaster,sant’Agostino, san Bonaventura. San Cipriano di Cartagine negò il dirittodegli eretici di battezzare, ma fu contraddetto da papa santo Stefano I eda sant’Agostino, che su questo polemizzò anche con i Donasti. Ciprianoriteneva, nella fattispecie, che l’eretico non volesse dare il Battesimosecondo l’intenzione della Chiesa, non ritenendone tutta la dottrina, mapapa Stefano, secondo l’uso romano, rammentò che bastava che essi loamministrassero per quello che esso doveva sortire, ossia la liberazionedal peccato e l’iniziazione cristiana. Fu la più grande Controversiabattesimale della storia, riguardante non tanto i ministri, quantol’effetto e la reiterabilità del Battesimo stesso. A poco a poco laChiesa africana si adeguò all’uso romano, che custodiva la dottrina delPrincipe degli Apostoli.11. I padrini –ossia il padrino e la madrina – rappresentano ladimensione ecclesiale del Battesimo: essi si impegnano a coadiuvare igenitori nell’educazione cristiana del bambino. Male non sarebbe segenitori e padrini, in vista del loro compito, fossero sensibilizzatiogni volta che si accingono a tenere a Battesimo qualcuno. Anche se peressi varrebbe la formazione cristiana già ricevuta e l’iniziazionesacramentale, purchè completa, già fatta.12. La disputa sul Pedobattesimo o Battesimo dei Bambini fu aperta daiPelagiani, i quali, negando il Peccato originale, asserivano che ibambini non avessero bisogno di essere battezzati. Catari, Valdesi eAlbigesi pure rigettarono il Battesimo dei bimbi, mentre Pietro di Brugesostenne che era necessario un atto, e non solo un abito, della Fede, perla giustificazione, per cui il rito in questione era nullo. Storck eMüntzer lo dichiararono illecito e invalido, perché i bambini non hannouso di ragione, non possono essere aggregati alla Chiesa, non hannoancora fede, non hanno Peccato originale e non se ne parla – a loro dire– nella Bibbia. Perciò essi ribattezzarono i loro seguaci da adulti efurono detti Anabattisti. Lutero stesso li condannò. Calvino e Zuinglioaccettano anch’essi il Battesimo dei Bambini. Erasmo ammetteva ilPedobattesimo ma chiedeva che il battezzato, appena avesse uso diragione, esprimesse il suo consenso alle promesse battesimali, cosa chesi presta a fraintendimenti sull’efficacia del Sacramento. I Battisti,considerando il Battesimo un mero simbolo di rigenerazione, rifiutano ilSacramento ai bimbi, che non possono formulare l’atto di fede necessario.In genere le famiglie protestanti giustificano per Fede – quando lo fanno– e non per il Sacramento, confondendo la scaturigine della Grazia con laGrazia operante e l’abito con l’atto di Fede. I Modernisti consideraronoil Battesimo dei bambini il frutto della separazione del Battesimo stessodalla Confessione. I Razionalisti lo considerarono una prassi invalsa dai
tempi di Tertulliano. E tuttavia, che i bambini vadano battezzati losappiamo dal magistero dei papi san Siricio (334-338), Innocenzo III(1198-1216), san Pio X, dei Concili Lateranense IV, di Vienne, Fiorentinoe di Trento.13. La prassi antica faceva sì che interi popoli si battezzassero, per ilconsenso del Re alla Fede in nome di tutta la sua nazione. La volontàsovrana sussumeva quella dei sudditi, che ad essa si adeguavano nontrovando ostacoli nella propria coscienza a questa funzione del monarca.Sarebbe bello se anche oggi interi Stati aderissero alla Religione.Nazioni come la Francia, l’Ungheria, la Polonia, la Lituania, la Russia,la Norvegia, la Danimarca, la Svezia, l’Armenia, l’Etiopia hanno la datadel loro battesimo.14. Esempio principe quello della Strage degli Innocenti. I bambinimassacrati in odio alla Fede nel Messia sono i primi martiri,inconsapevoli, per Cristo. La validità è attestata da Mt 5, 39; Lc 9, 24;nella Tradizione da Tertulliano e sant’Agostino. Papa Innocenzo III lo hasostenuto nel suo magistero.15. I bambini morti senza che i genitori abbiano avuto, incolpevolmente,il tempo di farli battezzare, possono a mio avviso godere del Battesimodi desiderio attraverso il desiderio dei genitori stessi, ossia hanno ilprivilegio della prolessi battesimale dei catecumeni in terza persona. Ibambini morti nel grembo materno i cui genitori li avrebbero battezzatipossono, sempre a mio parere, usufruire del medesimo privilegio. Ibambini uccisi nel seno materno dall’aborto volontario o fuori di essocon la distruzione degli embrioni potrebbero, sempre a mio parere, essereconsiderati martiri perché generati e poi uccisi in disprezzo alla Leggedi Dio – come gli Innocenti – per cui avrebbero un Battesimo di sangueindiretto, condannati dai propri stessi genitori. Infatti chi non sa cheDio e la Sua Chiesa condannano l’infanticidio? Chiunque lo compie, locompie in disprezzo di ciò, e quindi compie un atto in odio alla Fede suterzi. Il Battesimo di desiderio vale, a mio avviso, anche per i figlinon nati, senza colpa alcuna, di genitori non cristiani che avrebberodesiderato per i loro figli la piena adesione alla volontà di Dio,qualunque essa fosse. In tale prospettiva, il Limbo potrebbe esserevuoto. In genere, per quanto riguarda il Battesimo di desiderio, dettoanche di fiamma, i luoghi biblici di riferimento sono Gv 14, 21.23; At10, 44-48; gli autori della Tradizione sono l’Anonimo del Ribattesimo,sant’Ambrogio, sant’Agostino. Il magistero è implicato con sant’InnocenzoI, san Pio V (1565-1572), i Concili di Trento e Vaticano II, che lo hamesso alla base della sua ecclesiologia allargata all’umanità intera.16. Ciò che ho elencato, lo insegnano i Concili di Trento e di Firenze.La trasformazione del battezzato non è solo nominale, per cui egli èsimul iustus ac peccator, secondo la formula luterana, ma è reale, percui egli è iustus, realmente. Il Sacramento muta lo stato ontologicodella natura umana rovinata dal peccato, per cui l’uomo può esseregiustificato dalle opere che è efficacemente in grado di compiere. Esse
non sono solo una conseguenza della Grazia conferita, ma sonoattribuibili a chi, con la stessa Grazia, ha potuto compierle; esse sonoveramente gradite a Dio, perché non solo formalmente ma realmentesoprannaturali. Il Battesimo ha dunque una efficacia intrinseca. Che ilBattesimo cancelli i peccati originale e personali, lo attestano laScrittura (Gv 3,5; At 2, 38; 22, 16; Tit 3, 5; Mc 16, 16; 1 Pt 3, 21; Rm6, 22; 8, 1; 1 Cor 6, 11; Ef 5, 25-26; Gal 3, 27) e la Tradizione (Erma,san Barnaba, sant’Ireneo, Tertulliano, san Cipriano, sant’Agostino,Pietro Lombardo, san Tommaso; la tradizione iconografica). Analogamente,che il Battesimo rimetta le pene personali dovute al peccato, loattestano, in ordine sparso, san Bonaventura, il Concilio di Trento,quello di Firenze, Rm 8,1 e la prassi consolidata della Chiesa.17. Che il Battesimo conferisca la Grazia santificante e quella suapropria, assieme alle Virtù teologali, ai Sette Doni dello Spirito Santoe alle Virtù Morali, per infusione, lo attesta il magistero. Per esempioi Concili di Vienne (1311) e di Trento, che lo insegnano come dottrina difede. Luoghi biblici in materia sono Gv 3, 6; At 2, 38; Rm 6; Tit 3,5.Autori patristici che prendono posizione sull’argomento sono Erma,sant’Ireneo, Tertulliano, san Cirillo di Gerusalemme, san GiovanniCrisostomo e moltissimi altri.18. Il carattere indelebile è stato insegnato solennemente da papaInnocenzo III, nonché dai Concili di Firenze e Trento. Sebbene taleverità non sia insegnata esplicitamente dalla Bibbia – per cui iProtestanti la rigettano – e nemmeno dalla Tradizione, il linguaggio deiPadri giustifica la terminologia usata da papa Innocenzo ed entrata nellaterminologia teologica comune, come sostengono il beato Duns Scoto eSuarez. I Padri greci parlano di sigillo (Erma, Atti di Tommaso, sanClemente Romano, Abercio, san Cirillo di Gerusalemme). In ogni caso nonva confusa la Grazia santificante conferita dal Battesimo e che puòessere persa e riacquistata con la Penitenza, con il carattere, impressodal solo Battesimo. Esso è evidentemente qualcosa di più profondo dellastessa restaurazione della libertà: è un marchio impresso nell’anima, untitolo di appartenenza concreto e reale a Cristo: lo stato di cristiano,che non esisteva neanche ai tempi dell’Adamo innocente. Esso è segno chedistingue dagli angeli e mette in fuga i demoni. Che il carattere siaindelebile si arguisce dal fatto che il Battesimo non debba essereripetuto. Stefano I vietò ai vescovi d’Africa di ripetere il Battesimoimpartito dagli eretici, purchè fosse validamente amministrato, inquanto, sebbene se amministrato da essi forse non era né utile néfruttuoso, a causa degli errori in cui era irretito, di certo era realenell’effetto. Ossia era valido ex opere operato Christi, secondo laformula usata da sant’Agostino contro i Donatisti. In genere, che ilBattesimo non vada ripetuto lo attesta la prassi scritturistica (Gv 13,10; Ef 4, 5; Ebr 6, 4-6), nonché l’insegnamento patristico diTertulliano, san Dionigi Alessandrino, sant’Ireneo, sant’Epifanio,sant’Ottato di Milevi, sant’Agostino. L’eccezione di San Cipriano fu
rintuzzata da papa Stefano, perché il vescovo di Cartagine negava lavalidità del Battesimo degli eretici. La prassi, blasfema e ridicola,oggi diffusa di chiedere la cancellazione dai registri battesimali daparte degli apostati, definita spregiativamente sbattezzamento, èereticale e più che ereticale, in quanto il Sacramento non può essereannullato. Appare peraltro ridicolo che chi non creda senta il bisogno dicancellare un rito privo di qualunque efficacia. La nota di apostasia,registrata a margine dei documenti ecclesiastici, attesta proprio questarecessione dalla comunione ecclesiale, ma no di certo il riconoscimento,da parte della Chiesa, di un annullamento della validità sacramentale.
CAPITOLO IVSACRAMENTUM CHRISMATIS
Elementi di teologia crismale“E Io pregherò il Padre,
ed Egli vi manderà un altro Consolatore, perché rimanga con voi in eterno,
lo Spirito di Verità Che il mondo non può ricevere”
Nostro Signore Gesù Cristo agli Apostoli
Il Sacramento della Cresima o Confermazione è il secondodell’Iniziazione cristiana, la seconda tappa per essereimmessi negli Arcana Mysterii. Come insegna la Lumen Gentium del
Concilio Vaticano II, esso lega più perfettamente allaChiesa, arricchisce specificamente di Spirito Santo e rendeperciò abili alla professione, alla divulgazione, allatestimonianza e alla difesa della Fede. Questo Sacramento èperciò necessario, anche se non è da riceversiobbligatoriamente. Purtroppo molti fedeli lo trascurano,sebbene la Chiesa voglia che sia ricevuto – con una maggiorforza negli ultimi decenni – e sebbene essa arrivi aconferirlo persino sul letto di morte sin dal VI sec. Vediamodunque le caratteristiche di questo Sacramento.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TEOLOGIA CRISMALE
Se il fedele rinasce alla vita di fede mediante il Battesimo,esso cresce e si irrobustisce in modo definitivo – alla paridella vita naturale - mediante la Cresima. Se nel Battesimoil cristiano nasce in Cristo al Padre - ossia se esso cirende Figli - la Cresima, sempre in Cristo, ci riempie delloSpirito Santo, per il medesimo Padre. La Cresima è ilSacramento della Terza Persona Divina, il vero dono dell’Eramessianica; è quello che ci uniforma pienamente a Cristo, nelQuale lo Spirito scorre potente; è quello mediante cui loSpirito passa da Cristo alla Sua Chiesa, che ne è il Corporeale e mistico insieme. Nella Cresima dunque si compie lavera promessa messianica: il Padre effonde il Suo Spirito suogni persona, come vaticinato da Gioele e rammentato da sanPietro a Pentecoste. Ognuno di noi e tutti noi insiemediventiamo nuovo Tempio, secondo la profezia di Ezechiele,per la parola di Cristo che ci rende adoratori in Spirito everità. Andando a Cristo e bevendo di Lui, in virtù dellaFede comunicata dal Sacramento, da ognuno di noi fiumi diacqua viva zampillano per la vita eterna, come Egli stesso ciha annunziato.Il nome Cresima, Chrisma, Chrysma o Myron, vuol dire Unzione,perché l’unzione implica una copertura totale e una pienacompenetrazione tra chi è unto e ciò che lo unge. Essa è unaunzione spirituale per il segno di quella materiale, che diper sè ne è solo un pallido riflesso. Il vero e pieno Unto è
il Messia, il Cristo, che appunto significa questo termine, eche per Gesù è diventato Nome Proprio. Come siamo battezzatinella Sua Morte e Resurrezione, così siamo cresimati in Lui,Che fu sempre ripieno di Spirito Santo come Uomo e che da Sé,in quanto Dio, Lo fa sempre procedere come avviene dal PadreSuo. Cristo, immolato per noi, ci unge nel Suo Sangue, che èla Sua Vita. Ma la Vita di Cristo, Uomo e Dio, è il SuoSoffio Vitale, e il Soffio di Dio è il Suo Spirito, Che havivificato anche l’Umanità del Verbo. Perciò la Morte e laResurrezione di Cristo ci comunicano, per l’unzione - cosìcome il Sangue unse il Corpo del Redentore colando su di esso- il Suo Santo Spirito Paraclito. Egli infatti venne effusodopo la Resurrezione di Cristo, in quanto prima non erapossibile perché il Redentore non lo aveva meritato per noi.Con il dono dello Spirito la nostra intimità con Cristo e,tramite Lui, con il Padre, è ancora più forte: siamo inseritinel circuito trinitario. Infatti non siamo solo più Corpo delVerbo Incarnato, ma diventiamo partecipi, siamo rivestitidello Spirito del Padre e del Figlio. Ecco perché,nell’Iniziazione, la Cresima implica una tappa ben piùsignificativa del Battesimo: essa ci introduce pienamentenell’economia salvifica la cui scaturigine e la cui meta è lastessa SS. Trinità.Quando Cristo fu battezzato, Egli, per contatto, santificò leacque, profanate dalla caduta di Adamo, che dannò tutto ilcosmo, di cui era capo e vertice. Gesù rese così possibile ilBattesimo. Ma nel momento stesso in cui fu battezzato, su diLui si posò visibilmente e pubblicamente lo Spirito (1).Perciò Egli fu unto innanzi al Popolo, cresimato dal Padrestesso in quanto Uomo (2), con le parole: Questi è il FiglioMio Prediletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo(Mt 3, 17). Il Cristo era ricolmo di Spirito sin dalla SuaConcezione in modo perfettissimo, ma tale effusione pubblicaservì per avviare il Suo ministero. Iniziò così la Suamissione e in Lui si conservò quello Spirito Che, nel momentoin cui veniamo incorporati al Suo Corpo, comincia a scorrerepure in noi. Questo perché Cristo è l’Unico Mediatore, e amaggior ragione lo Spirito ci viene dalla Sua Umanità.
Questo rito, celebrato dal Padre stesso perché solo Luipoteva ungere l’Umanità del Suo Figlio, così come l’avevagenerato, sempre di Spirito, nel grembo di Maria, diede sensoe compimento alle unzioni veterotestamentarie. I Sacerdoti,da Aronne in poi, erano unti di un profumo unico, la cuimistura era stata stabilita da Dio stesso, il Crisma: ciò erafigura del Sacerdozio supremo del Messia. Anzi di quelprofumo oleoso erano unti anche l’Arca- simbolo del Cristo-la Dimora- segno della Chiesa Suo Corpo- le tavole e glialtari – figura delle funzioni messianiche. I Re eranoanch’essi unti, perché il Messia sarebbe stato Egli stessoSovrano e della Casa di David. Infine i Profeti, unti spessodirettamente di Spirito (3), avevano atteso che il maggioretra loro, ossia il Cristo, sorgesse ricoperto di quelloSpirito Che essi stessi avevano ricevuto e del Quale, perbocca di Isaia, avevano elencato i Sette Doni: Sapienza,Intelletto, Consiglio, Scienza, Pietà, Fortezza e Timor diDio (4). Questi Doni, presenti già nell’Antica Alleanza invirtù dei meriti futuri di Cristo, così come lo era lo stessoSpirito, anche se non nella forma solenne che Lo mostravaPersona Divina separata e nella funzione di Paraclito (At 2,16; 5, 32; 15, 8), furono presenti in Cristo sin dallaConcezione pneumatica, e già ci sono elargiti nel Battesimo.Ma solo nell’età adulta dello spirito, inaugurata dallaCresima, ognuno li riceve, crescendo così, come Cristostesso, in sapienza e grazia innanzi a Dio e agli uomini.Perciò chiamiamo questo Sacramento con un altro nome:Confermazione, Confirmatio, nella tradizione latina, perchéappunto essa suggella l’azione iniziata nel Battesimo,facendo agire direttamente la Terza Persona Divina, inviatacida Cristo mediante il Suo Corpo glorioso. Egli infattiistituì questo Sacramento e nessun altro (5). Promise piùvolte, specie nell’Ultima Cena, l’effusione dello Spirito,come compensazione della Sua scomparsa visibile (Gv 14, 16;25, 26) (6), anzi, mancando nel Vangelo una prescrizioneaccurata come per il Battesimo da parte del Signore, possiamodire che Egli istituì il Sacramento non mostrandolo mapromettendolo, come dice San Tommaso d’Aquino. Nostro Signoreeffuse poi lo Spirito Santo emanandolo da Sé a Pasqua sugliApostoli (7); avendo infine rinnovato la Promessa
all’Ascensione (Lc 24, 49) ed essendosi assiso alla Destradel Padre quale Mediatore, dal Suo Corpo glorioso comunicòdefinitivamente il Paraclito il giorno di Pentecoste - dandocompimento all’azione da Lui compiuta cinquanta giorniprima (8)- quando gli Apostoli e la Beata VergineMaria (9). Lo ricevettero con fragore e potenza, per la loromissione pubblica(10). In quel giorno l’Umanità fu nuovamenteriunificata in Cristo, contrapponendosi alla babele deglispiriti e delle lingue generata dal Peccato e consolidatasidopo il Diluvio (11). Pieni di Spirito Santo, gli Apostoliiniziano ad annunziare le opere di Dio (At 2, 11). Pietro,Capo della Chiesa, afferma che l’effusione dello Spirito è ilsegno dell’Era messianica. Infatti coloro che credono primasono battezzati e poi ricevono lo Spirito Santo (At 2, 38),distintamente anche se in modo concomitante. Questa ricezioneavviene mediante l’imposizione delle mani da parte degliApostoli stessi (At 8, 15-17; 19, 5-6) ed è parte integrantedell’Iniziazione cristiana secondo la testimonianza dellaLettera agli Ebrei (Eb 6,9) (12). Tale imposizione delle manicostituisce la materia del Sacramento della Cresima. Essaavviene, conformemente alla tradizione biblica, inconcomitanza con l’unzione fatta con il Sacro Crisma, che laChiesa eredita dalla tradizione mosaica e che, come dicevo,fu voluto da Dio stesso sul Sinai. Ciò ci rende visibilmentecristiani, ossia di Cristo, etimologicamente “untinell’Unto”(13).In ragione di ciò, nei primi secoli della Chiesa la Cresima eil Battesimo furono dati insieme in una sorta di “doppioSacramento” (San Cipriano) (14). Tuttavia, se il Battesimo fuda subito delegato ai Presbiteri e ai Diaconi, come pure èpossibile fare secondo la Scrittura, la Chiesa occidentale,volendo conservare ai Successori degli Apostoli la direttaamministrazione di questo Sacramento, che perfeziona ilBattesimo, separò le due liturgie, limitandosi a dare albattezzando – una volta che il numero dei fedeli crebbe einvalse il pedobattesimo – una unzione crismale cheprefigurasse quella sacramentale. La Chiesa orientale invecedelegò volentieri ai Presbiteri anche l’amministrazione dellaCresima, in concomitanza anche del pedobattesimo, per cuicolà si è battezzati e confermati insieme, risolvendo il
problema della latitanza dei fedeli al momento dellarecezione del Sacramento e sganciando la maturazione dellavita spirituale da quella, simile solo in modo estrinsecoanche se reale, della vita corporea. Perciò ministro delSacramento è propriamente il Vescovo, ma anche qualunquePresbitero debitamente autorizzato da lui direttamente o daicanoni. Infatti in ogni caso per confermare il Presbiterodeve usare il Crisma consacrato dal Vescovo. Inoltre nellaChiesa Latina il Vescovo può delegare solo per motivi seri –per esempio il Presbitero può cresimare qualunque fedele inpunto di morte. Naturalmente un adulto che riceva ilBattesimo riceverà anche la Cresima, sia nella Chiesad’Occidente che d’Oriente.Proprio in relazione al cresimando, va detto che devericevere questo Sacramento chiunque non l’abbia ancoraricevuto e, come dicevamo, anche tempestivamente, perché illebbroso che è in ognuno di noi sia purificato al più prestocome avveniva profeticamente nel rito del Levitico, conunzioni di sangue e di olio, ossia per la Redenzione el’effusione dello Spirito. L’età più indicata è quella delladiscrezione, perché il Sacramento della maturità, quale è laCresima, sia efficace – questo ovviamente nella Chiesalatina. In vista di tale Confermazione è bene che ilcandidato sia opportunamente preparato e catechizzato, nellasensibilizzazione all’appartenenza alla Chiesa. Colui che ècandidato al Sacramento, procurerà di mantenersi in Grazia,se virtuoso, o di riacquistarla con la Confessione, sepeccatore, al momento della Crismazione. Infatti non potrebbelo Spirito di Colui Che è tre volte santo scendere inun’anima impura, non essendo la Cresima deputata allaremissione di colpa alcuna. Tradizionalmente, il cresimando èaccompagnato da un padrino o da una madrina che si fa garantedella sua formazione spirituale, con un gesto che oggi haperduto parte del suo significato effettivo e che andrebberiscoperto, magari scegliendo a tale scopo lo stesso mentoredel Battesimo.LA LITURGIA CRISMALE
La consacrazione del Sacro Crisma è un momento importante diogni rito crismale anche se avviene il Giovedì Santo nellaMessa degli Oli per mano del Vescovo. In ogni crismazionedella Chiesa d’Occidente, il candidato rinnova le promessebattesimali e professa la sua fede, riallacciandosi alBattesimo. Nella liturgia romana il Vescovo stende le manisul cresimando e, come gli Apostoli, invoca lo Spirito Santo.Il rito essenziale segue subito dopo: il Vescovo conferiscela Confermazione imponendo la mano e ungendo la fronte delcresimando, mentre pronunzia la forma: “Ricevi il sigillodello Spirito Santo”; nelle Chiese Orientali l’unzione colCrisma è fatta, dopo una preghiera di epiclesi, sulla fronte,sugli occhi, sul naso, sulle orecchie, sulle labbra, sulpetto, sul dorso, sulle mani e sui piedi, accompagnandolaogni volta con la frase: “Sigillo del dono che è lo SpiritoSanto” (15). Il bacio di pace chiude la celebrazioneesprimendo la comunione tra i cresimati, il Vescovo e tutti ifedeli.
EFFICACIA SOTERIOLOGICA DELLA CRESIMA
Molteplici e meravigliosi sono gli effetti del Sacramento cheporta lo Spirito di Dio nella nostra anima:
1. Innanzitutto lo Spirito Santo stesso prende unapiena e definitiva dimora nell’anima nostra; in ragionedi ciò
2. la nostra filiazione divina si perfeziona, in quantoil Paraclito è Colui Che grida in noi “Abbà, Padre” (Rm8, 15); e in quanto lo stesso Spirito Che è in noi èemanato ad un tempo dal Padre e dal Figlio, per cui laPrima Persona Divina vede in noi quella Terza Persona chescaturisce da Sé e dal Figlio Suo, nello stesso movimentoeterno della Spirazione in seno alla Trinità;
3. la nostra unione al Corpo di Cristo è rafforzata,perché lo Spirito scorre in esso e lo tiene unito, percui riceverLo ci incorpora maggiormente al MisticoOrganismo del Redentore; in ragione di ciò siamopienamente e perfettamente inseriti nella Chiesa;
4. i Doni dello Spirito, comunicati nel Battesimo, sonoeffusi in noi con maggior forza, essendo inabitati daColui Che li fa scaturire da Sé; con essi si rafforzanole Virtù Teologali e sono appunto confermate le morali;
5. inaugura in noi la militia Christi, ossia lacapacità di combattere la Buona Battaglia, difendendo ediffondendo, con la parola e le opere, la Fede, senza maivergognarsi della Croce del Redentore (16);
6. confermando l’azione battesimale, la Cresima lacompleta in modo analogo, imprimendo anch’esso il marchioindelebile del carattere o sigillo, che rende ilcristiano Soldato di Cristo o, più biblicamente, che loriveste di potenza dall’alto (Lc 24, 48-49) (17), per cuiil cresimato riceve il potere e quindi l’obbligo diprofessare pubblicamente la fede quasi per mistero.
NOTE AL CAPITOLO IV
1. Possiamo dire che sul Cristo Uomo si posò la Mano invisibile delPadre, perché lo Spirito è simboleggiato anche dalla mano nella Bibbia.Ravvisiamo quindi in modo invisibile una imposizione delle mani anchenella Crismazione di Cristo, come nel rito sacramentale, del qualediremo.2. Qui l’unzione, come l’imposizione delle mani, è invisibile perchéscende lo Spirito stesso direttamente, che è simboleggiato dall’unzione,come abbiamo visto, nel VT; ma è reale così come lo è nel Sacramento, incui è visibile. Nella Crismazione di Cristo il ministro è il Padre, Chequindi manda direttamente lo Spirito senza la mediazione del segnosensibile, ma con un atto divino che lo sussume spiritualmente, dandosenso analogico da quanto istituito poi dal Figlio per i cristiani.3. Come sarebbe accaduto a Cristo.4. Dei loro effetti si è detto: la Sapienza ci fa conoscere e gustare lecose divine; l’Intelletto ci fa comprendere per quanto possibile leverità rivelate; il Consiglio ci permette di fare delle scelte conformialla volontà di Dio; la Scienza ci fa vedere le cose create in rapportoal piano divino; la Pietà ci eleva alla vita di devozione; la Fortezza cidifende dalle tentazioni; il Timor di Dio ci fa fuggire il male e fare ilbene per rispetto di Lui. Essi ci cautelano anche dai Peccati contro loSpirito: Disperazione della Salvezza, Presunzione di Salvarsi senza
merito, Invidia della Grazia altrui, Ostinazione dei Peccati, Impugnarela verità conosciuta, Impenitenza finale.5. Prima del XVI sec. nessuno negò l’istituzione divina dellaConfermazione. Il primo fu Lutero che considerò la Cresima un semplicesacramentale, come la benedizione dell’acqua. Calvino invece sostenne chela cerimonia crismale era, per gli antichi, l’esplicitazione dellepromesse battesimali da parte di chi era stato battezzato da bambinodinanzi al Vescovo che lo benediceva. In ogni caso questa cerimoniasussiste ancora in molte Chiese riformate con questo senso. Per gliAnglicani la Cresima è un segno esterno di una Grazia speciale ma non èSacramento. Queste dottrine sono tuttavia contraddette dalla Scrittura,come la tesi modernista per cui la distinzione tra Cresima e Battesimosia delle prime generazioni cristiane o quella razionalista che essa siail frutto della cristianizzazione di alcuni riti pagani. Dalla Bibbiainfatti si evince che nella Chiesa, subito dopo la sua nascita, esistevaun rito di crismazione separato dal Battesimo. Per esempio in At 8, 4-17leggiamo che i Samaritani furono battezzati da san Filippo il Diacono manon ricevettero lo Spirito Santo, che fu effuso da san Pietro e sanGiovanni apostoli appositamente recatisi in loco, perché solo essiavevano tale potere. Ancora in At 19, 1-6 san Paolo fa ribattezzarecoloro che avevano ricevuto solo il battesimo di Giovanni e impone luistesso le mani ai neofiti per conferire lo Spirito. Da questi e altripassi (p. es. Eb 6, 2; 2 Cor 1, 21-22; 1 Cor 12, 13) dunque si evince chel’imposizione delle mani era un vero segno sacramentale, distinto dalBattesimo – per ministro, rito ed effetto - e che conferiva realmente loSpirito e che era di istituzione divina, non potendo certo gli Apostoliarrogarsi tale potere. Non a caso il Sacramento si è conservato nelleChiese Latina, Greca e precalcedonesi. L’istituzione divina della Cresimaè stata insegnata dal magistero del Concilio di Firenze nel Decreto pergli Armeni; definita esplicitamente dal Concilio di Trento nel canone IDe Sacramento Confirmationis; ribadita da san Pio X nel Decreto Lamentabilicontro i Modernisti; nuovamente espressa dal Vaticano II con la LumenGentium nel quadro di una esauriente teologia di questo Sacramento,nonché da Paolo VI che all’argomento dedicò la Cost. Ap. Divinae ConsortiumNaturae.6. Il valore di questa promessa nell’istituzione del Sacramento fusottolineato anticamente da papa san Fabiano e poi dal Catechismo Romano.7. Il Concilio di Trento ha lasciato liberi i teologi di determinare ilmomento dell’istituzione della Cresima, in quanto ai suoi tempi sidistingueva tra la determinazione generica del segno sacramentale – cheCristo fece ogniqualvolta impose le mani a qualcuno, specie ai bambini,anche se a scopo curativo e non confermativo – e la determinazionespecifica – che il Redentore fece il giorno di Pasqua. Oggi si evidenziacome Egli progressivamente abbia preparato i discepoli al Sacramentocrismale, attraverso la Rivelazione progressiva dello Spirito Santo, comehanno recepito i documenti del magistero recente, dal Vaticano II a Paolo
VI. I momenti di tale percorso istitutivo sono appunto quelli cheelenchiamo. Va precisato che, effondendo lo Spirito Santo a Pasqua, Gesùnon istuisce solo la Confermazione, ma anche la Penitenza, come spiega lostesso brano (Gv 20, 23) e l’Ordine episcopale. Questo è perfettamenteconforme alla pluralità di effetti propria delle azioni divine.8. Sebbene a Pentecoste non vi sia imposizione di mano visibile sugliApostoli, la discesa dello Spirito è essa stessa imposizione di mano(come per la Crismazione del Cristo), perché nella simbologia biblica lamano rappresenta lo Spirito, e Dio non ha mano corporea, mentre Cristoera già in Cielo. Lo stesso dicasi dell’unzione, visibilmente assente maopearata dallo stesso Spirito, Che biblicamente unge coloro che possiede.9. Costei era già ripiena di Spirito Santo per la missione Sua propria:Immacolata, Tutta Santa, Sempre Vergine, Madre per opera del Paraclito epoi Corredentrice, lo ricevette pubblicamente per poterlo altrettantopubblicamente riversarlo sugli altri. Infatti la fiamma viva delloSpirito si posò dapprima su di Lei e poi sugli altri, secondo laTradizione. Si intravede qui la Mediazione strumentale di Maria mediantecui il Dono per eccellenza, attraversandola come una porta cheamorosamente e volontariamente si apre, viene a comunicarsi alla Chiesa.Infatti i XII Apostoli sono coloro mediante cui, nella catenasacramentale, tutti noi riceviamo il Dono dello Spirito.10.In ragione di ciò l’effusione dello Spirito su di noi non è névisibile né carismatica, ma perfettamente uguale a quella di Pentecoste,essendo le parole di Cristo che ne spiegano l’effetto rivolte a tutti gliuomini (At 1,8).11.L’Umanità peccatrice che vuole elevarsi da sé al Cielo è confusa nellelingue e quindi negli spiriti. Ma quando il Logos, Verbo del Padre, parlaall’Uomo e lo eleva attraendolo a Sé nella Croce, allora la divisione inlingue e pensieri concomitanti scompare e gli spiriti si riunificano. Ciòavviene perché lo spirito umano si esprime nel pensiero e si comunicanella parola, mentre lo Spirito di Dio procede dal Padre pensante e dalFiglio pensato come Verbo, ossia come Parola e Concetto insieme.12.L’imposizione delle mani non è fatta da Gesù nel giorno di Pasqua. Mail contesto lascia supporre un simile gesto, a mio avviso. Inoltre èimpossibile che gli Apostoli iniziassero ad imporre le mani come segnosacramentale senza che Gesù lo avesse approvato, Egli che aveva compiutotale gesto in diverse circostanze. Perciò l’approvazione del gesto se nonil suo comando potè accadere nei Quaranta Giorni tra Pasqua e Ascensione,fermo restando che esso è presente da subito negli Atti degli Apostoli,che è Scrittura ispirata.13.La materia remota è il Crisma consacrato nella Messa crismale; quellaprossima è l’imposizione delle mani con l’unzione. Il Crisma in quantotale non può essere separato dall’imposizione delle mani, quasi avesse unpotere magico di per sé.
14.Testimonianze della distinzione concettuale dei due Sacramenticoncomitanti si hanno nella Tradizione patristica (nonostante siano avolte chiamati entrambi “Battesimo”): san Clemente Romano, Erma, sanGiustino, sant’Ireneo, Tertulliano e lo stesso san Cipriano, nonchénell’Epistola di Firmiliano al Presule cartaginese, e Origene. Molto piùricche le testimonianze a partire dal IV sec.: sant’Ottato di Milevi,sant’Ambrogio, sant’Agostino in Occidente; san Cirillo di Gerusalemme,sant’Atanasio e altri in Oriente. Questa composita Tradizione chiama ilSacramento con molti nomi: Imposizione delle Mani, Sigillo del Signore,Sigillo Spirituale, Sacramento della Crismazione o dell’Unzione o dellaConsegnazione – oltre ovviamente ai nomi adoperati di solito anche oggi.Anche i testi liturgici mostrano la distinzione sacramentale traBattesimo e Confermazione.15.La materia duplice e la forma del Sacramento sono state ribaditenuovamente da Paolo VI nella Divinae Consortium Naturae. Egli ha cosìrisolto una controversia molto antica, se cioè fosse più importantel’imposizione delle mani o l’unzione, confermando la tradizionale unionedell’una all’altra. In ordine alla materia, nella Tradizione della Chiesasi rileva quanto segue. Un luogo teologico dell’uso del Crisma è 1 Gv2,27, ma non riconosciuto da tutti i teologi. Tertulliano e san Ciprianorilevano la impressione del segno di Croce sulla fronte all’attodell’imposizione delle mani; il gran Presule cartaginese parla di unzionenella controversia con santo Stefano I. Questi chiedeva che agli ereticinon fosse riconferito il Battesimo, ma solo imposte le mani, perl’effusione dello Spirito, Che non può essere donato fuori della veraChiesa. Da qui una confusione per i posteri delle funzioni dei Sacramentidella Cresima e della Penitenza, in quanto l’unzione crismale fu a volteil segno della riconciliazione degli eretici con la Chiesa (Conc. diEpaon, 517, can. XVI). In Egitto le Costituzioni della Chiesa Egiziana(425) che si rifanno alla Traditio Apostolica (III sec.) citanol’unzione; a Roma essa è citata esplicitamente dal V sec. Qui papa sanSiricio legò l’imposizione delle mani all’effusione dello Spirito; pocodopo sant’Innocenzo I nel 416 distinse tra unzione battesimale ecrismale. In Oriente invece l’unzione è citata da san Teofilo diAntiochia sin dal II sec. e poi prende il sopravvento, nelle fonti,sull’imposizione delle mani, così come a Roma dal V sec., in quanto l’unapresuppone l’altra. Sant’Isidoro di Siviglia dà in merito unainformazione assai importante: dice che l’unzione assimila al Cristo, mache solo l’imposizione delle mani del Vescovo conferisce ai battezzati eunti lo Spirito Santo (VII sec.). Inoltre ai tempi suoi esistevano inOccidente due imposizioni delle mani, delle quali solo una era quellacrismale e l’altra un sacramentale amministrato in diverso momento. PapaVigilio (537-555) insegnò l’autentica divisione tra Cresima e Penitenza,distinguendo tra imposizione delle mani dell’uno e dell’altro Sacramento.In relazione alla forma, si nota altresì quanto segue. Gli Apostoliimponevano le mani pregando, ma non conosciamo la formula. Testimonianzesulla forma del Sacramento, nella sua oscillazione in una banda lessicale
e fraseologica che però esprime sempre un medesimo concetto, si hanno inTertulliano, sant’Ippolito, le Costituzioni Egiziane, sant’Ilario, sanGerolamo, sant’Ambrogio, il Sacramentario Gelasiano e quello Gregoriano,l’Ambrosiaster, il Messale Gotico, i Sacramentari ambrosiani, san Tommasod’Aquino, san Cirillo di Gerusalemme. Tale oscillazione è coerente con ledefinizioni magisteriali fino al Tridentino, le quali, pur insegnando conforza che Cristo ha istituito questo Sacramento, hanno evidenziato che lemodalità concrete non sono state da Lui puntualizzate attraverso laScrittura ma nella Tradizione, permettendo così una possibilità più ampiadi fissazione degli aspetti contingenti delle stesse da parte dellaChiesa.16.Infatti la vita dell’uomo sulla terra è una milizia, come dice ilLibro di Giobbe.17.Che la Cresima imprima il carattere è stato definitivamente insegnato dal Concilio di Trento