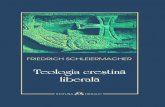UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA
elementi di teologia penitenziale, delle indulgenze e dell'unzione degli infermi
Transcript of elementi di teologia penitenziale, delle indulgenze e dell'unzione degli infermi
CAPITOLO VIREMISSIO PECCATORUM
Elementi di teologia penitenziale“Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati
saranno rimessi, a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi.”
Nostro Signore Gesù Cristo agli Apostoli“Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno”.
Nostro Signore Gesù Cristo per i suoi carnefici
La Remissione dei Peccati è un articolo di fede, che noiconfessiamo nel Credo. Nel Simbolo degli Apostoli è citatasoltanto con questa espressione; nel Credo Niceno-Costantinopolitano invece si recita: Professo un soloBattesimo per la Remissione dei Peccati. Cosa sia laRemissione dei Peccati è presto detto: è il processo mediantecui avviene la Giustificazione, ossia l’atto della nostraRedenzione – su cui ci soffermammo in un capitolo de Il DogmaCattolico (1)- e i modi con cui ci viene applicato attraversol’economia sacramentale. Di questa economia stiamo appuntoparlando, per cui in effetti attraverso il Sacramento delBattesimo noi riceviamo la Remissione dei Peccati, sia perchéchi lo riceve in età adulta è completamente purificato inordine alla colpa e alla pena dei delitti commessi, siaperché, ancora più radicalmente, egli è purificatodefinitivamente dal Peccato originale, che è il fomite dellapossibilità stessa di peccare. Tuttavia non basta il soloBattesimo per rimettere definitivamente i peccati, chepossono essere compiuti in ogni momento della vita, perché lacancellazione del Peccato d’origine non implica la sanazionedel difetto di natura da esso causato nell’Uomo. Se illavacro battesimale ci imprime il carattere di cristiani, cheè confermato da quello crismale e che è indelebile, per cuiva a cancellare dall’anima il Peccato originale- che quindi
non può più tornare- è anche vero che la scelta volontariadel male ci fa ricadere nella colpa, che a sua volta,staccandoci dal Corpo Mistico di Cristo, ci priva dellaGrazia per cui noi facciamo il bene; ragion per cui, unavolta che abbiamo peccato nuovamente dopo il Battesimo, nonpossiamo più convertirci da soli e compiere nuove azionibuone valide per la Vita Eterna con le nostre forze. Proprioper ovviare a tale condizione di indigente impotenza, ilSignore nella Sua Misericordia ha istituito i Sacramenti diguarigione, ossia la Confessione e l’Unzione degli Infermi.In questo capitolo parleremo della Confessione, il granSacramento mediante cui costantemente siamo perdonati,rigenerati, rinnovati e salvati, come nel Battesimo, inordine alle colpe che abbiamo la sfrontatezza di commetteredopo la nostra Redenzione. Esso è un Sacramentoimportantissimo per la nostra vita spirituale. Grazie allasua amministrazione, ognuno di noi continua a ricevere, apropria salvezza, i meriti della Passione di Cristo, dellaSua dolorosa Morte, della Sua gloriosa Resurrezione. Sebbenedi quella Passione e Morte la causa siano gli stessi peccatiche per essa vengono perdonati. Vediamo più da vicino questoeccezionale capolavoro della Misericordia di Dio, in cui ilCristo assume le nostre colpe mortifere e ci comunica i Suoimeriti vivificanti, in cui il Buon Pastore, dopo avercicercati, ci carica sulle spalle e ci riporta all’ovile.
CONFESSIONE, PENITENZA, RICONCILIAZIONE.
L’Apostolo Paolo, parlando del Battesimo, scriveva che inesso noi moriamo con Cristo al Peccato, siamo con Lui sepoltie, sempre con Lui, risorgiamo a vita nuova. PraticamenteCristo ha preso su di Sé la morte dovuta a noi per le nostrecolpe, l’ha subita in modo atto ad espiarle e, tramite ilBattesimo, ci ha comunicato la Sua Resurrezione comeprincipio di vita eterna. Egli ha preso il male e ha dato ilbene. Questo vale, nel Battesimo, sia in relazione al Peccatod’origine sia in relazione ai peccati attuali commessi primadella recezione del Sacramento. Infatti, ai tempidell’Apostolo, si era battezzati soprattutto da adulti, per
cui la sua disamina degli effetti del Sacramento riguardatale situazione in particolare.Tuttavia anche coloro che, dopo il Battesimo, cadono inpeccato, hanno bisogno del lavacro rigeneratore nell’Acqua enel Sangue scaturiti dal Costato trafitto del Redentore. Seinfatti il Battesimo cancella una volta per tutte il Peccatooriginale e se attraverso la Grazia santificante restaura lalibertà umana permettendole di scegliere e compiere il benemeritevole per la vita eterna, nonché di fuggire il male cheporta alla dannazione - anzi suscitando nell’animo umano taliatti, sostenendoli mentre si compiono e coronandoli nellarealizzazione - è pur vero che l’uomo, mediante la stessalibertà, può scegliere di disobbedire a Dio, di non seguirel’ispirazione della Grazia e di fare il male che non deve edi non fare il bene che deve. Il Battesimo non può cancellarequeste colpe che avvengono dopo la sua recezione; se esse noncancellano il carattere impresso dal Sacramento, tuttaviarompono l’amicizia dell’Uomo con Dio e hanno bisogno diessere rimesse innanzi alla Sua Giustizia. Cristo è morto inCroce per tutti i peccati di ognuno, quindi tutti noi siamoredenti, ma bisogna entrare in contatto con la Sua potenzasalvifica per avere la Remissione delle colpe. Il mezzo dicontatto in questione è il Sacramento della Confessione oPenitenza o Riconciliazione, ordinato appunto alla Remissionedei peccati commessi dopo il Battesimo. I tre nomi sonoparlanti: il primo indica l’atto dell’accusa delle colpe, ilsecondo l’atteggiamento che lo deve sottendere, il terzo loscopo e il risultato dell’uno e dell’altro (2). Esso fuistituito da Gesù Cristo quando disse ai Suoi Apostoli, nelgiorno stesso di Pasqua: “Ricevete lo Spirito Santo. A chirimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non lirimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20, 22b-23). Ilpotere dunque di perdonare le colpe è un potereesclusivamente sacerdotale, precisamente episcopale, essendoi Vescovi i Successori degli Apostoli. A questi già Cristoaveva conferito questo potere, senza ancora conferire ilmandato, quando aveva detto: “Tutto ciò che legherete sullaterra sarà legato in Cielo, e tutto ciò che scioglierete interra sarà sciolto in Cielo” (Mt 18, 18). Questa espressione,che significa propriamente il potere conferito di insegnare
ed esercitare la giurisdizione, implica anche l’autorità digiudicare, assolvendo o condannando. Lo stesso Signore, Chenon ha mai amministrato alcun Sacramento ad altri al di fuoridella Sua intima cerchia, e mai più di una volta, ha invecepiù volte personalmente assolto i peccatori, presentatisi aiSuoi piedi con le dovute disposizioni. Anzi, tutti, in quantosuoi carnefici, ci ha potenzialmente assolti quando, almomento della Crocifissione, ha detto: “Padre, perdona loroperché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34). E ancorasulla Croce assolse il Ladrone pentito, ultimo atto di bontàverso un peccatore prima della Morte. Cristo naturalmentesapeva tutto e non aveva bisogno che alcuno Gli aprisse ilcuore, addirittura vedeva in esso lo spirito penitenziale,per cui non vi era bisogno che la gente si confessasse a Lui,anche se i rei si presentavano al Suo cospetto spessoriconoscendo la loro condizione di peccatori. Perciò, suquesto esempio anche gli Apostoli hanno amministrato questoSacramento, ma esigendo la confessione delle colpe stesse perpoterle giudicare (3). In alcuni casi assai emblematiciaddirittura essi hanno negato il perdono per peccati palesi orivelati loro da Dio, mostrando quindi di avere il potere dirimettere le colpe – come nel caso di Pietro con Anania eSaffira o con Simon Mago. Da allora fino ad oggi, la Chiesaascolta la confessione dei penitenti e accorda loro ilperdono di Dio (4).Ma quali sono i peccati che devono essere rimessi e perchédevono essere confessati e con quali disposizioni? Anzituttova evidenziato che l’uomo può commettere due tipi di peccati,i mortali e i veniali. I peccati mortali sono costituiti datre elementi: materia grave, piena avvertenza e deliberatoconsenso. Ossia si compiono quando c’è una disobbedienzaconsapevole e volontaria ad una prescrizione importante dellaLegge di Dio. Tali mancanze hanno la drammatica conseguenzadi causare la Morte di Cristo. Egli infatti muore proprio perespiarli, in quanto ognuno di essi strappa la Graziasantificante all’anima dell’uomo e lo uccide alla vitaeterna, per cui solo l’offerta della Vita del Cristo puòrestituirgliela, mediante l’espiazione vicaria, ossia fattavolontariamente dall’Innocente in vece dei colpevoli. Ragionper cui mediante il peccato mortale ogni uomo è realmente
carnefice di Cristo; mentre Questi, proprio in vista dellaremissione del peccato mortale di ciascuno, accetta di morireper ogni uomo (5). Ciò è bastevole per mostrare la maliziadel peccato mortale in tutto il suo orrore. Esso, inconseguenza, annulla la filiazione adottiva di Dio Padre;espelle lo Spirito Santo lasciando posto al demonio; distaccadal Corpo Mistico di Cristo in modo violento il membro chel’ha commesso, danneggiando tutti gli altri suoi membri eimplicando per loro conseguenze negative; causa le sofferenzecorredentrici della Madre di Dio ai piedi della Croce;contrista i Santi e gli Angeli; rompe la comunione coidefunti; perde il Paradiso; merita l’Inferno nella vitafutura e castighi in quella attuale; rompe l’armonia delcosmo ed è foriero della dissoluzione delle cose terrene;rende l’anima schiava di satana; fa perdere la libertàrestaurata tramite il Battesimo. All’anima in peccato mortalerimane solo l’effetto della Grazia che permette di compiereun bene naturale, estrinseco, ma non meritevole del Cielo.Proprio per rimettere queste colpe mortifere, Nostro Signoreha istituito la Confessione. In questo Sacramento tali colpesono rimesse da quella Morte che hanno causato. In ragione diciò, i fedeli che siano in età di ragione devono confessarealmeno una volta l’anno le loro colpe gravi, per precettopositivo della Chiesa (6), ma è assolutamente necessario, perla loro sicurezza spirituale, che lo facciano non appena liabbiano compiuti (7). Infatti nel tempo trascorso in peccatomortale non si può compiere nulla di valido per il Cielo, siaccumulano altre colpe per l’Inferno e, se disgraziatamentesi muore – e nessuno sa quando Dio lo chiamerà, né Lui ètenuto a chiamarci a Sé solo quando siamo in Grazia – si èdannati per l’eternità.In quanto ai peccati veniali, essi sono degni di venia, ossiadi perdono, perché manchevoli di uno o più requisitirichiesti perché siano mortali. Anch’essi offendono Dio, inquanto nessun peccato può mai essere indifferente alla SuaGiustizia (8), ma nell’economia salvifica fondata sulla Croceessi non sono causa di morte dell’anima, anche se causanodolori proporzionali alla loro malizia a Cristo nella SuaPassione e, conseguenzialmente, offendono la bontà del Padre,
contristano lo Spirito, feriscono il Corpo Mistico, fannosoffrire la Madre Addolorata, rattristano i Santi e gliAngeli, indeboliscono la Grazia, preparano al peccatomortale, accrescono le pene meritate in questo mondo e inPurgatorio, perturbano l’ordine cosmico. Essi nonnecessariamente devono essere portati nel Sacramento dellaConfessione, ma è bene che ciò avvenga, perché esso, cherimette i mortali, a maggior ragione annienta quelli minori,rigenerando e accrescendo la vita della Grazia nell’attingerealla fonte inesauribile dei meriti del Redentore. In effettiè salutare e moralmente necessario che la Confessione siafrequente, regolare e conseguenzialmente estesa ai peccativeniali (9).Questi peccati devono essere confessati, ossia esplicitamenteaccusati e riconosciuti innanzi a Dio, mediante il Suoministro, compensando la superbia di averli commessi conl’umiltà dell’ammissione. In questo modo il peccatore imital’umiltà del Redentore innocente, Che si è umiliato fino allaMorte di Croce, nella quale così il reo viene ad innestarsiprogressivamente. Questa confessione, praticata per esempioda Zaccheo con Gesù stesso e sempre dall’età apostolica –l’Apostolo Giacomo prescrive di confessare i peccati gli uniagli altri, riferendosi sia al fatto che i laici siconfessano al clero sia alla pubblicità dell’accusa – untempo era fatta innanzi a tutti, mentre oggi può esserecollettiva in caso di grave necessità (ossia ognuno la fanella sua mente dinanzi al sacro ministro) (10) ma, nella suaforma ordinaria e secondo il volere divino, dev’essereindividuale ed auricolare con il sacerdote (11), il quale ètenuto peraltro al segreto della confessione, ossia non puòrivelare nessun peccato conosciuto nel foro sacramentale, pernessuna ragione, né tantomeno fatti e circostanze apprese inesso, pena la scomunica (12). La confessione dei peccati daparte del penitente costituisce la materia del Sacramento, dafarsi al ministro – ossia il Vescovo o il Presbiteroautorizzato (13)- che così può pronunziare la formasacramentale, la formula assolutoria, che rimette appunto ipeccati (14).
Tale remissione avviene in ordine alla colpa e alla pena, inrelazione al dolore che accompagna la confessione. Va infattipuntualizzato che ogni peccato è imputabile come colpa, chemuta lo stato ontologico del cristiano, rendendolo da giustopeccatore, e come pena, che è conseguenzialmente meritata o atitolo sanzionatorio – per la colpa non riconosciuta – o atitolo purificatorio ed espiativo – per quella ammessa. IlSacramento della Confessione può rimettere l’una e l’altra,alle debite disposizioni. Certamente rimette la colpa,all’occorrenza la pena. Tutto dipende dal tipo di dolore cheil penitente prova al momento della confessione o anchesubito dopo. Tale dolore è esso stesso una grazia, chescaturisce dall’efficacia del Battesimo e in subordine dellaCresima (se ricevuta), per via dei caratteri che imprimono eche sono un titolo esigitivo dell’azione salvifica di Cristo,quando il fedele non sia refrattario ad essa o addiritturaindurito nel male. Infatti il penitente, soffrendo per ilmale commesso, partecipa del dolore che Cristo stesso ebbe ditutto il male che ha commesso l’umanità e ogni suo membrodurante la Sua Agonia e, in genere, durante la Sua Passione.Il dolore è dunque parte integrante del Sacramento,condizione previa per ricevere il perdono di Dio (15).Abbiamo due tipi di dolore. Chiamiamo il dolore perfetto colnome di contrizione. Etimologicamente indica lo spezzarsi delcuore. E’ il dolore della prostituta che lava i piedi diCristo con le lacrime, li bacia, li asciuga con i capelli. E’il dolore del Buon Ladrone. E’ il dolore di Zaccheo. E’quello di Pietro. Esso avviene per motivi eminentementeteologali, legati alla carità verso Dio: il dolore di avercausato la Morte di Cristo tra i tormenti, di aver versato ilSuo Sangue, di aver lacerato le Sue Piaghe, di aver mutilatoil Suo Corpo Mistico. E’ il dolore di aver contristato lamaestà e la bontà di Dio Padre, Che ci ha creati e redentinel Suo Figlio per poi adottarci e mandarci il Suo Spirito.E’ il dolore di aver scacciato questo Spirito Che ci inabitacome in un tempio amandoci com Sua dimora. E’ il dolore diaver offeso, deluso, abbandonato Dio Uno e Trino. Insubordine e in conseguenza, di aver causato il dolore diMaria SS. nella Corredenzione, di aver contristato gli Angelie i Santi. La contrizione rimette subito la colpa e la pena,
se implica il proposito della Confessione, perché è ilmassimo che l’uomo può fare dopo aver sbagliato: viene dallapura carità e quindi brucia ogni imperfezione, in quanto Gesùdice che a chi molto ama sono perdonati i suoi molti peccati.In virtù di ciò, sebbene rimanga l’obbligo di ricevere ilsuggello sacramentale, chi eventualmente morisse dopo essersicontrito e senza essersi potuto confessare, sarebbe salvo.Inoltre la perfetta contrizione, rimettendo colpa e pena,conduce direttamente in Paradiso, abbonando i castighiterreni e quelli in Purgatorio. Tale dolore, sebbene siaappunto una grazia, va opportunamente stimolato conriflessioni, meditazioni e preghiere (16).Il dolore imperfetto è detto invece attrizione. E’ quellocausato dal timore dell’Inferno, dal rimpianto del Paradiso,dal compatimento della propria rovina spirituale e dallabruttezza dell’azione compiuta. L’attrizione rimette la colpanella Confessione, ma non la pena, perché è dolore servile,non filiale. E’ il dolore del Figliol Prodigo. Ma è essostesso una grazia, anche se minore, che il fedele devepropiziare con riflessioni, meditazioni e preghiere,accettando con umiltà il fatto di non essere stato degno didolore più vero e con la gratitudine di aver pur ricevuto ildono delle lacrime (17).Il peccatore pentito deve quindi confessare in modo integrole sue colpe al confessore. L’integrità della Confessionedipende dall’accusa, sincera, completa, senza né diminuzioneo alterazione o anche accrescimento dei peccati, tacendoperaltro ogni colpa o nome altrui. I peccati mortali vannoconfessati nella specie, nel numero e nelle circostanze. Laspecie è il tipo del peccato, per cui non basta dire di averpeccato contro il Settimo comandamento, ma bisognaspecificare se si è rubato o frodato o evaso le giuste tasse.Il numero indica le varie volte in cui si è ripetuto undeterminato peccato, perché ogni volta che lo si commette èuna colpa differente, ed è fondamentale per le colpe mortali.Le circostanze sono quelle per cui un’azione malvagiacontiene la malizia di uno o più peccati mortali, come adesempio uno stupro che è ad un tempo peccato impuro eviolenza. All’occorrenza le circostanze sono un’aggravante –
per esempio rubare a un povero è più grave che rubare ad unricco – o anche una scusante – come agire sotto l’occasionaleimpulso dell’ira o per altro disturbo emotivo. Chiunque,volontariamente, nasconde, per qualunque motivo, un peccatomortale, commette un sacrilegio e la sua Confessione non èvalida. Egli deve riconfessarsi, accusandosi di tutte lecolpe commesse dall’ultima Confessione ben fatta. Inoltre, ilpenitente deve riparare i danni causati dai suoi peccaticontro la giustizia (come ad esempio restituire oggettirubati o ritrattare calunnie fatte). In ragione di ciò, èopportuno, specie per chi si confessa di rado, prepararsi alSacramento con un Esame di coscienza approfondito,richiamando alla memoria tutti i peccati mortali commessi oanche i veniali (18). Ad esso segue appunto lo sforzo dieccitare il dolore, che è sempre dei peccati propri, non delpeccato in genere (19).Nel momento in cui il penitente ha confessato le sue colpe,può ricevere l’assoluzione sacramentale, con il vincolo dicompiere la penitenza assegnata dal confessore, che è parteintegrante del Sacramento stesso. Essa è da collocarsi nellapiù ampia visione della penitenza cristiana, che è tuttavalorizzata dal Sacramento della Riconciliazione. Anzituttova detto che essa è indispensabile per avere il perdonodivino, sebbene esso sia irrogato prima con atto giudiziario,perché è soddisfattoria, ossia espia almeno una parte dellepene meritate per le colpe commesse. Poi va ricordato che lapenitenza è di tre tipi: canonica, divina e volontaria, aseconda di chi la commina. La canonica può essere pubblica eprivata. Anticamente, l’una e l’altra erano immediatamenteconnesse al Sacramento, oggi lo è solo la seconda. Questaconsiste nella buona azione imposta dal confessore odall’Autorità ecclesiastica come riparazione, in forme comela preghiera, l’elemosina e la mortificazione; bisognacompierla quanto prima e richiederla se è dimenticata dalsacerdote. In quanto alla pubblica, nelle persone debitamenteconfessate le sue forme imposte dalla Chiesa sono atte adespiare i peccati perdonati, oltre che quelli altrui ecollettivi. Esse sono connesse ai tempi liturgicipenitenziali e sono essenzialmente il digiuno del Mercoledìdelle Ceneri e del Venerdì Santo, l’astinenza obbligatoria
dalle carni i Venerdì di Quaresima, quella facoltativa neglialtri Venerdì, sostituibile con altre opere buone a scelta.Queste forme devono essere adempiute, pena colpa grave, inquanto tutti sono tenuti a partecipare a forme di penitenzacollettiva . Non mancano forme di penitenza pubblica chiesteda Dio stesso in rivelazioni private e autenticate dallaChiesa ma non imposte con vincolo di coscienza, che è benefare (20). In quanto alla penitenza divina, essa è quellainflitta da Dio stesso, mediante le pene della vita terrena(malattie, dolori, sventure ecc.) – inferte ai singoli e aigruppi – e quelle del Purgatorio. Ad esse nessuno puòsottrarsi, a meno che non abbia avuto la contrizioneperfetta, ed è perciò bene che siano accolte con umiltà erassegnazione, sia a vantaggio proprio che degli altri.Infine, la penitenza volontaria è quella che ognunoliberamente si assume, per prevenire i castighi divini esovvenire ad essi. Le forme tipiche sono la preghiera,l’elemosina e il digiuno. Nella prima la forma sovrana è lapartecipazione alla Messa con la Comunione (21). Nellaseconda annoveriamo anche ogni forma di carità cristiana esolidarietà umana fatta in isconto delle proprie colpe. Nellaterza includiamo anche tutte le rinunce volontarie a cose diper sé neutre moralmente o meno buone della rinuncia stessa,per temprare la volontà e mortificarsi(22). E’ bene che ilcristiano abbia sempre un sincero spirito di compunzione, nonconfondendo la vita gaudente con la gioia della Fede, chescaturisce dalla consapevolezza di essere redenti. Nellapenitenza infatti il fedele è simile al suo Signore, Chevolle soffrire per salvarlo.Il coronamento della Riconciliazione sacramentale sta nelproposito di non più peccare. Sarebbe infatti un controsensoconfessare colpe che si intendono ripetere; nessun peccatopuò essere perdonato se non vi è un sincero proposito di nonpiù commetterlo; tale proposito è indispensabile per laremissione dei peccati mortali, che vanno confessati perforza. L’assenza del proponimento, come quella del dolore,costituisce un elemento di inefficacia nella recezione delSacramento e, se è consapevole e volontaria, rende colpevolidi sacrilegio. Il proposito è la maniera con cui il penitentesi uniforma alla volontà salvifica di Cristo; lo sforzo di
esservi fedele è simile a quello fatto dal Redentore nelsaper soffrire per noi; esso è legato già alle Promessebattesimali, di cui è un sostanziale rinnovamento, ed èorientato sia ad evitare di commettere di nuovo le stesseazioni sia ad evitare le occasioni che comportino il rischioimmediato di compierle nuovamente. Proprio nella sinceritàdel proposito si misura la verità della conversione: secondoil Salmo, l’empio passa dalla confessione al peccato e dalpeccato alla confessione; egli inoltre si illude con sestesso esaminando la propria coscienza, perché la sua anima èsempre dominata dalle cattive intenzioni. Nessuno puòproporre da solo di fuggire il male; la fortezza delproposito del penitente, che nei casi estremi arriva anche asaper morire per Dio come Lui è morto per noi (come fecePietro), è una grazia. Perciò il proponimento va posto convigore ma nel contempo implorato con la preghiera e motivatocon la meditazione. In effetti, sebbene ognuno sappia chenella Confessione i propri peccati sono rimessi, altrettantobene conosce di non poter essere sicuro della bontà delleproprie disposizioni nel ricevere il perdono, per cui, comedice l’Apostolo, non sa se è degno di misericordia o di irainnanzi a Dio e, come insegna il Concilio di Trento, non puòavere fede nella propria personale giustificazione così comela ha nei dogmi rivelati. Può tuttavia compiere un’altraazione teologale: può sperare nella Misericordia di Dio equindi avere la certezza morale del perdono e delle grazieconcomitanti, laddove non abbia la certezza umana di nonessere nelle disposizioni giuste. E in questo stato puòcontinuare a vivere, cristianamente, lavorando, pregando esoffrendo. Perciò la Confessione, sacramento del Perdono, èanche quello della Speranza. Esso è la causa efficiente delgrande movimento spirituale che accompagna costantemente lavita cristiana: la conversione. Essa, che etimologicamenteindica il cambiamento di strada, dev’essere incessante, perdare compimento a quella prima fondamentale svolta dellanostra vita che è stata la recezione del Battesimo. Perciòl’ultimo nome che si può dare a questo Sacramento di cuiparliamo è quello di Sacramento della Conversione. Un nomeche sintetizza tutti gli altri.
LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
La celebrazione individuale del Sacramento della Penitenzaavviene ordinariamente secondo questo schema: il saluto e labenedizione del sacerdote; la lettura della Parola di Dio perilluminare la coscienza e suscitare la contrizione;l’esortazione al pentimento; il rito essenziale ossia laconfessione dei peccati da parte del penitente, l’imposizionedella penitenza da parte del sacerdote, l’assoluzioneimpartita da lui, dopo l’atto di contrizione recitato dalpenitente; indi, la lode con rendimento di grazie e ilcongedo con la benedizione da parte del sacerdote. La formulaassolutoria in Oriente spesso è deprecatoria. In Occidenteoggi suona così: Dio Padre di misericordia, Che hariconciliato a Sé il mondo nella Morte e nella Resurrezionedel Suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la Remissionedei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nelNome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.L’ultima frase è quella centrale e va pronunziata per forzadal confessore, pena la nullità del Sacramento. Spesso laConfessione è celebrata col semplice Segno di Croce, conl’accusa, l’imposizione della penitenza e con l’assoluzione.Altrettanto spesso, per ragioni pastorali, il penitente èconfessato contemporaneamente alla celebrazione della Messa,sebbene due Sacramenti non possano essere amministratiinsieme. E’ bene, nel quadro della pietà personale, che ilpenitente ringrazi Dio per il beneficio dellaConfessione (24). Essa è ordinariamente amministrata inchiesa, con il sacerdote che indossa la cotta e la stola,possibilmente nel confessionale, la cabina dove trovano postosia il penitente che il confessore (25). Il tempo piùindicato per accostarsi alla Confessione è, in considerazionedel fatto che essa precede la Comunione eucaristica, allaquale è la migliore preparazione, quello delle vigilie dellefeste in cui ci si comunicherà, come per esempio il sabato,nelle ore pomeridiane o serali (26).Nel quadro di una celebrazione comunitaria, i ritiintroduttivi e di conclusione sono fatti in una liturgia
collettiva e debitamente arricchita, di letture bibliche,omelia, esame collettivo di coscienza, richiesta di perdono,recita del Pater, ringraziamento comune, rimanendoindividuale la Confessione dei peccati e l’assoluzione. Inquanto alla menzionata Confessione con assoluzionecollettiva, essa può essere impartita solo col consenso delVescovo, il quale valuta il rischio di morte di molte personeinsieme o la mancanza di un numero congruo di sacerdotiperché i singoli fedeli non stiano troppo a lungo senzaconfessarsi. Va da sé che coloro che non sono in rischio divita sono tenuti, appena possono, a confessarsiindividualmente, qualora abbiano beneficiato dellacelebrazione comunitaria del Sacramento. Infatti laConfessione individuale, come si è detto, rimane il solomezzo ordinario per la riconciliazione con Dio, salvoimpedimento fisico e morale, che dispensa da essa (27).In genere, per rendere sempre vivo il fervore del pentimentoe del proposito, nonché fervente la richiesta del perdono, èbene che i fedeli, sia prima della Comunione sacramentale,sia alla fine della giornata – dopo un apposito esame dicoscienza, come si fa per esempio a Compieta – sia parecchievolte nell’arco del giorno, facciano atti di dolore perfetto,anche in forme brevi o brevissime. Altrettanto opportuna è larecita di un atto di riparazione, sia prima della Comunioneche alla fine del giorno, per supplire a tutte le propriemancanze in ordine all’espiazione delle pene.E’ bene ricordare sempre che la Confessione, sebbeneindividuale, rimane un atto liturgico inserito nel misterodella Chiesa. Il sacerdote agisce in persona Christi, lui eil penitente sono membra della Chiesa, sia le preghiere comele azioni penitenziali di tutta la Chiesa sono sempre avantaggio dei penitenti e degli stessi peccatori bisognosi diconversione. E’ infatti dalla mediazione della Chiesa, chesempre offre la Vittima Immacolata per il mondo, chescaturisce la grazia continuamente rinnovata del perdono deipeccatori, sia attraverso la loro chiamata alla Confessionesia, per chi è fuori, attraverso le vie straordinarie dellaGrazia che Dio solo conosce.
GLI EFFETTI DELLA CONFESSIONE
Mirabili sono gli effetti di questo Sacramento nell’anima delpenitente. Egli, attraverso il bagno purificatore nel Sanguee nell’Acqua contenute nel Cuore di Cristo, viene risuscitatoalla Grazia. Perciò gli viene restituita la GraziaSantificante, viene nuovamente inabitato dallo Spirito Santo,viene reinnestato nel Mistico Corpo di Cristo, torna adessere figlio del Padre. Rientrato nel circuito dellasalvezza, è nuovamente figlio di Maria SS. e la suaconversione rallegra gli Angeli e i Santi più della santitàdei giusti; ritorna in comunione con i Defunti; non corre piùil rischio di precipitare nell’Inferno; riacquista il dirittoad andare in Paradiso; se contrito, ha anche la remissionedelle pene terrene e del Purgatorio.Riacquistata la Grazia, può nuovamente compiere operemeritorie per la salvezza, tornando ad essere giustificato.Viene comunicata la Grazia sacramentale, che rende capaci diresistere alle tentazioni e di compiere il bene, in ragionealla Grazia di stato e mediante le grazie attuali. La libertàumana, che è restaurata nel Battesimo sacramentale o didesiderio, e che il peccato ad esso successivo rende capacesolo di compiere azioni estrinsecamente buone, torna,coonestata dalla Grazia, a poter volere le azioni buone ditipo teologale. Non si esagera dicendo che ogni volta che unpeccatore si confessa vi è un’autentica rinascita spirituale.Rivivono nell’anima anche i meriti anteriori alla caduta;quelli invece, puramente umani, acquisiti in mancanza diGrazia, servono solo a stimolare alla conversione e a nonaccrescere la dannazione, ma non hanno valore per la VitaEterna. L’anima che si purifica nella Confessione dai solipeccati veniali trova una rigenerazione ancor più efficace,in quanto il torrente della Grazia sanatrice si riversa su unorganismo spirituale sano che se ne imbeve con maggiorepienezza. E’ per questo che il progresso spirituale non puòavvenire se non in anime che usano la Confessione per laremissione delle colpe veniali, avendo costante lo sforzo dievitare quelle mortali, nelle quali o mai o raramente cadono.
LA PENITENZA NELLA TRADIZIONE
Ricco e complesso fu lo sviluppo del Sacramento dellaConfessione nella Tradizione della Chiesa. Esso mette a fuocol’apostolicità della prassi penitenziale della ChiesaCattolica. Anzitutto va evidenziato che ai tempi degliApostoli, come dicevamo, la Confessione era praticata con lastessa facilità con cui è amministrata oggi. Infatti sisapeva che ogni peccatore poteva essere perdonato per laPenitenza (Gc 1, 21; 5, 19 ss.; 2 Pt 3, 9; 1 Gv 2,1 ss.),nella mediazione sacramentale della Chiesa (1 Gv 5, 14; Gc 5,14 ss.). La prassi era quella della Confessione pubblica (1Gv 1, 9), ma l’assoluzione era riservata agli Apostoli e aiVescovi. Questa universale destinazione del Sacramentopenitenziale riposava sulla convinzione che non vi è alcunpeccatore che Dio, all’occorrenza, non possa e non vogliaconvertire (Ap 2, 2; 2, 14 ss.; 2, 20-23). Va anche detto chel’alto livello morale della prima generazione cristiana fecesì che la Penitenza fosse sempre irrogata senza creare motividi particolare scandalo.Questa impostazione teologica rimase intatta nei PadriApostolici: la Didakè (90 ca.) e la Lettera di Barnaba (98ca.) esortano alla Penitenza e alla conversione senzarestrizioni, mentre il diritto del Vescovo di giudicare ilpenitente è ribadito da Sant’Ignazio di Antiochia nelle sueLettere (107). Tuttavia la diffusione del Cristianesimo el’ingresso nella Chiesa di gente non sufficientementemotivata nello sforzo ascetico fece sì che i peccati simoltiplicassero – come descrive, tra l’altro, lo stessoIgnazio – e pose la prima grande questione dottrinale legataal Sacramento: quante volte può essere ricevuto da chi peccamortalmente? Sebbene nel NT nulla impedisse che il Sacramentofosse reiterato fino a settanta volte sette, cioè sempre, iltimore che s’introducesse il lassismo nella prassipenitenziale della Chiesa spinse ad una reazione, visibile inErma e nella sua opera Il Pastore (150 ca), legata agliambienti romani. Come accennato, nelle visioni descritte nellibro Erma riceve alcune indicazioni significative: anzituttola Confessione e la penitenza concomitante sono un dono della
Misericordia Divina; inoltre essa deve essere ricevuta unavolta e non di più, in quanto appare difficile credere nelpentimento di chi, confessate colpe gravi, poi vi ricada confacilità. E’una svolta significativa, volta a porre un argineagli abusi ma con una ricaduta disciplinare che rende piùrara l’amministrazione del Sacramento, avviandola ad unaciclicità liturgica annuale. E’ la prima modifica canonica,non dogmatica, subita dal Sacramento nella sua storia.In concomitanza di questa svolta a Roma, nel 150 sant’Ireneodi Lione (140†195) attesta che la Penitenza salva i peccatorie nel 170 ca. Dionigi di Corinto ricorda che tutti possonoadire al Sacramento della Confessione per qualunque peccato,in polemica con i Montanisti, che sostenevano invece che laChiesa, pur potendo assolvere ogni peccato, non dovesse farloper non dare esempio di cedevolezza. Questa dottrina eraaccompagnata dalla pretesa che l’assoluzione dovesse esseredata non dal Vescovo, ma dai profeti del loro movimento. Inquesta che è la prima grande controversia penitenziale dellaStoria della Chiesa e che mostrò come essa sia ordinata allasalvezza dei peccatori, entrò in campo Tertulliano (160†220ca.) il quale, nel suo fondamentale trattato De Poenitentia,enunciò principi ancora oggi professati dalla Chiesa: che laConfessione può e deve assolvere tutti i peccati gravi; cheessa restituisce la Grazia Santificante; che l’assoluzionespetta al Vescovo. L’Africano descrive bene anche lastruttura del rito, invalsa dopo la svolta di Erma: ilpenitente, che è tenuto alla confessione privata col Vescovoe poi innanzi alla comunità, per adempiere al precetto dellapenitenza pubblica, deve trascorrere un congruo periodoliturgico fuori della chiesa mentre si tengono in essa lefunzioni; nel contempo deve compiere atti privati dipenitenza; indi deve farne di pubbliche, in corrispondenza adun periodo in cui può trattenersi sulla soglia della chiesamentre in essa si celebra, nonché ad una terza fase in cui èammesso nello stesso tempio durante il culto; trascorsoquindi il periodo penitenziale, il Vescovo concedel’assoluzione e il cristiano è riammesso ai Sacramenti.L’anteposizione della penitenza canonica all’assoluzioneserviva a rendere più impegnativo il percorso penitenziale.In questa linea, Sant’Ippolito di Roma (170†235) ribadiva
nelle sue Tradizioni Apostoliche che il Vescovo può assolvereda ogni peccato – polemizzando con i Montanisti e con lostesso Tertulliano passato nelle loro fila e poi divenutoancor più rigorista di loro – ma che le penitenze inflittedebbono essere serie e all’occorrenza severe. Il papa SanCallisto I (217-222), invece, fece invalere il principio percui la penitenza dovesse essere al servizio dellariconciliazione e non causa di allontanamento, nonostante lecritiche di Tertulliano e Ippolito, la cui opposizione generòuna seconda controversia penitenziale in seno alla ChiesaRomana con uno scisma. Ippolito infatti, divenuto antipapa,sostenne che il ministero sacerdotale dipendeva dalla santitàdegli ordinati, con una ricaduta anche sulla possibilitàpratica di impartire l’assoluzione, anche se non tematizzata.Lo scisma cessò con la persecuzione di Massimino il Trace.Toccò a San Cipriano di Cartagine (200 ca.†258) gestire lacrisi penitenziale connessa alla persecuzione di Decio e allaconseguente pretesa dei cristiani che avevano apostatato perpaura (i lapsi), terminata la violenza, di ritornare nellaChiesa. Il Cartaginese fece invalere i principi tradizionali,contro i lassisti e i rigoristi: anche i lapsi potevanoessere assolti, ma dopo una lunga e congrua penitenza,destinata in alcune forme a prolungarsi tutta la vita data lagravità del peccato di apostasia; la raccomandazione deiconfessori ottenuta dai lapsi pentiti costituiva una potenteintercessione innanzi alla Chiesa, ma non surrogaval’assoluzione sacramentale, che poteva essere concessa senzapenitenza solo in punto di morte a chi aveva queste specialicredenziali; tale assoluzione spettava al Vescovo; lastruttura del Sacramento descritta dal Santo prevede laconfessione, le opere di penitenza, l’exomologesi (o fase incui si è fuori dalla chiesa come edificio), l’assoluzione.Sono peraltro le medesime fasi descritte qualche anno primain Oriente da Origene (†254). L’insegnamento di Cipriano furibadito da papa San Cornelio (251†253), contro il rigorismodi Novaziano (200 ca.†258), antipapa autore di uno scisma dacui nacque una Chiesa la cui caratteristica fu proprio quelladi negare l’assoluzione per i peccati più gravi, che duròfino al V sec. e che venne condannata nel Concilio romano del251 e altre volte fino al I Concilio di Nicea (325). Una
nuova crisi penitenziale fu attraversata dalla Chiesa Romanadopo la persecuzione di Diocleziano: ancora ci fu chi negòche la Penitenza potesse assolvere i lapsi, ma papaSant’Eusebio (310) ribadì la dottrina tradizionale.In Oriente, Clemente Alessandrino (145 ca.†217 ca.) avevainsegnato che la Confessione era la seconda occasioneconcessa all’uomo per salvarsi dopo il Battesimo, attestandoche l’esigenza di rigore introdotta da Erma era ai suoi tempidiffusa ormai in tutto il mondo cristiano, greco e latino.Del resto, la tendenza diffusa a farsi battezzare in punto dimorte, che toccò l’apice nel IV sec., faceva sì che icatecumeni ricevessero, con il Battesimo, l’unica remissionedelle colpe della loro vita mettendo in ombra, per unperiodo, il Sacramento della Penitenza. Origene tuttavia haben chiara la funzione di questa: serve per i peccati mortalie non per i veniali; la confessione dev’essere piena esincera, resa al Vescovo e poi alla comunità; è inoltredovere del Pastore cercare i peccatori e spingerli aconfessarsi. E’ tuttavia assai significativo che nella ChiesaSiriaca del III sec., dove si erano conservate intatte letradizioni apostoliche della prima generazione, grazie alcomune ambiente aramaico, la Penitenza non è affattocomminata una volta sola, ma tutte le volte che è necessario(Didascalia; Costituzioni Apostoliche). La riformadisciplinare di Erma non ha potuto scalfire il prestigiodelle abitudini della prima generazione cristiana, arrivateintatte sino a quei tempi.Nel IV-V sec. la disciplina penitenziale diventa ancora piùrigida, in relazione alla diffusione di massa delCristianesimo, e si aggancia alla Quaresima. Essa terminavail Giovedì Santo con l’assoluzione del Vescovo, la cuiimportanza è ricordata con forza da Sant’Innocenzo I(401†417), da San Leone Magno (440†461) e da San Girolamo(347†420 ca.). La penitenza si può prolungare per anni, senon a vita, come ammonisce lo stesso Sant’Ambrogio (374†397).Non si può più bypassarla con il Battesimo in punto di morteperché ormai è caduto in disuso, sotto il peso delladeprecazione della Chiesa. Solo Sant’Agostino (354†430), allaluce delle sue dotte riflessioni sulla Grazia e delle
polemiche con Pelagio e i Donatisti, evidenzia che ognisituazione è diversa dalle altre e imposta la questionepenitenziale con maggiore mitezza, intravvedendo i rischiconcretizzatisi nell’età seguente.In essa, il sec. VI-VII, sia in Spagna che in Gallia lepenitenze sono ormai al limite del sostenibile, come dovràammettere lo stesso XIV Concilio di Toledo (684), e spessoconducono i penitenti, col loro protrarsi a vita, sullasoglia della disperazione. Tuttavia nessuno osa modificarel’impianto della penitenza pubblica. Molti rinviano in puntodi morte la Penitenza, per non doversi sobbarcare l’oneredelle azioni espiative e con grave rischio per la loro saluteeterna. La Chiesa gallo-visigota stessa incoraggia questaprassi. Ciò peraltro mette in ombra il Sacramento degliInfermi. Timidi tentativi di accorciamento delle penitenzevengono da San Cesario di Arles (470†543). Solo San Fulgenziodi Ruspe (468†533), fedele discepolo di Agostino, riesce amitigarne i rigori e a rimettere il Sacramento al serviziodella salvezza. Una significativa innovazione liturgica si haa Roma, dove il Sacramentario Gelasiano attesta la facoltàdelegata di assoluzione per i Presbiteri.La strada per la liberazione del Sacramento dalle formepietrificate della penitenza pubblica fu la rinascita dellapenitenza privata, promossa proprio per evitare di cadere neirigori della prima, che veniva ormai da molti abbandonata.Così attestano San Cesario, Desiderio di Vienne, San GregorioMagno (590†604), secondo una linea di tendenza embrionalmentepresente già in Leone Magno. Ma gli artefici del rinnovamentofurono i Penitenziali irlandesi e le loro Redenzioni.Nell’Irlanda evangelizzata nel V sec. si era sviluppato unCristianesimo di matrice celtica incentrato sul monachesimo.L’adattamento alla mentalità della popolazione dell’isolaaveva fatto sì che spontaneamente si sviluppasse un sistemapenitenziale basato su schemi fissi, in cui ad ogni peccatocorrispondeva una penitenza, seria ma snella rispetto aquelle del Continente, perché praticabile in privato (VIsec). Le varie forme di penitenza o Redenzioni erano poiall’occorrenza legate da sistemi di commutazione edequivalenze. Per esempio più giorni di digiuno erano
commutabili nella recita del Salterio completo; tale recita,impossibile per gli analfabeti, poteva essere surrogato daquella di centocinquanta Pater accompagnati da altrettantegenuflessioni; successivamente poterono essere rimpiazzati daaltrettante Ave Maria con le medesime genuflessioni.Analogamente, erano previste anche pene pecuniarie,conformemente alla tradizione del Libro del Levitico. QuesteRedenzioni erano anche dette Tariffari e si diffusero sulContinente quando proprio dall’Irlanda partirono missionariper evangelizzare i rozzi barbari che avevano distrutto buonaparte dell’antica Cristianità paleoromana (VI-VIII sec.).Esse divennero il mezzo più diffuso per la prassi dellapenitenza privata. Grazie ad esse la sclerotizzata penitenzapubblica fu accantonata.Già dall’Età carolingia la penitenza pubblica fu riservata aisoli peccati pubblici, notori, da compiersi entro laQuaresima. L’assoluzione avveniva il Giovedì Santo. Lepenitenze divennero meno onerose grazie alla prassi deipellegrinaggi penitenziali e delle offerte (Sinodo di Tribur,895). Gli uni facevano confidare nell’intercessione dei Santie sono la preistoria delle Indulgenze; le altre avevanofondamento nei Tariffari a loro volta fondati sul Levitico.Per i peccati veniali, l’assoluzione avveniva già prima dellaQuaresima (come attesta San Teodulfo d’Orléans, 750†821), nelquadro della Confessione annuale, in cui ognuno, in privato,accusava le colpe commesse per i Sette Vizi Capitali. Se traessi ve ne erano di più gravi, rientranti tra le colpe gravima non notorie, l’assoluzione era impartita dopo laQuaresima. In conseguenza di questa separazione tra penitenzaper i peccati gravi pubblici e quella per i peccati graviprivati, la prassi dell’imposizione delle Ceneri nelMercoledì apposito fu estesa a tutti i battezzati e non piùriservata ai soli penitenti.Nel cuore del Medioevo feudale, dal IX alla fine del X sec.,si cercano e si trovano motivi per assolvere prima dellapenitenza canonica. La prassi invale e soppianta quellaprecedente, favorita dal nuovo sistema penitenziale dimatrice tariffaria e dalla distinzione tra peccati pubblici eprivati. Anzi ben presto acquista valore una distinzione tra
peccati gravi assolvibili da chiunque e peccati graviriservati direttamente al Vescovo se non addirittura al Papa,specie all’indomani della Riforma gregoriana (XI-XII secc.).Questi ultimi, che ottengono l’assoluzione dopo un interoviaggio, sono ormai al posto dei vecchi peccati notoriespiati nella penitenza pubblica. Analogamente sono legatialla penitenza pubblica, ma in forme di volta in voltadiverse, coloro che incorrono nella scomunica onell’interdetto fulminato dai canoni o ferendae sententiae. Nelsec. XI tuttavia rimane l’uso di confessare i peccatipubblicamente, ma solo in assenza di sacerdoti e in caso dinecessità, come su di un campo di battaglia. La tendenzaconsolidata è quella ormai di rendere più frequente laConfessione, a dispetto della Comunione che è invece piùrara. Nel XIII sec. ormai la Penitenza è annuale ma privata,condotta peraltro sulla base di precisi manuali per l’esamedi coscienza.Il punto culminante è il IV Concilio Lateranense (1215). Inesso papa Innocenzo III (1198-1216) fa definitivamentericonoscere che la Confessione è individuale ed auricolare,in quanto il giudice del penitente è il sacerdote; obbliga iconfessori al segreto sacramentale; mantiene l’obbligo dellaConfessione annuale ma non tanto in senso minimale, quantopiuttosto massimale, per far capire ai fedeli che ilSacramento non va ricevuto irresponsabilmente commettendofacilmente peccati gravi. Ma putroppo la prassi che invaslefece sì che si ritardasse fino ad oggi la Confessione anchein casi di peccati gravi. E nella pietà comune del BassoMedioevo e del Rinascimento Confessione e Comunione dei laicierano rare.In ogni caso la Confessione faceva parte integrante delDeposito della Fede su cui la Chiesa Greca e Latinaconversero nei Concili Lionese II (1274) e Fiorentino (1438-1445). Il Concilio di Costanza (1415-1417) condannò JohnWycliff (1324†1384) e Jan Hus (1371 ca.†1415) che negavanol’origine apostolica di questo Sacramento. Quando poi Lutero(1483†1546), per la giustificazione per fede, Zuingli(1484†1531) e Calvino (1509†1564), per la doppiapredestinazione, rigettarono la necessità della Confessione,
il Concilio di Trento (1545-1563) potè nuovamente edefinitivamente insegnare che il Sacramento della Confessioneconsta di tre parti: pentimento, confessione, soddisfazione.Nell’Età della Controriforma furono i Gesuiti a promuovereuna teologia sacramentale che, nella distinzione tracontrizione e attrizione, permettesse a tutti di poterconfidare nel perdono divino ricorrendo più spesso allaConfessione. Ciò fece da contravveleno alla teologiagiansenista che, nel XVII sec., sostenendo l’infallibilitàdella Grazia, riteneva impossibile che si potesse esserecristiani e avere un livello di vita morale mediocre,tagliando così alle radici la ragion efficiente dellaConfessione stessa, il ricorso frequente alla quale avrebbeattestato al penitente che egli non era tra gli eletti. Lacondanna del Giansenismo fulminata da Urbano VIII(1622†1644), Innocenzo X (1644†1655), Alessandro VII(16551†667) e Clemente XI (1700†1721) servì anche a mantenereintatta la dottrina penitenziale della Chiesa, anche sebisognò intervenire più volte da parte dei Papi contro ledegenerazioni lassiste della morale gesuitica. Sempre nelXVII sec. le Rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a SantaMargherita Maria Alacocque (1647†1690) diedero una spintaalla prassi della Confessione e della Comunione mensili conspirito di riparazione, destinata a decollare in modo decisonella seconda metà del XIX sec., con il beato Pio IX(1846†1878). Tuttavia ancora dopo il Vaticano I (1868-1870) iVecchi Cattolici misero in discussione l’apostolicità dellaPenitenza. Su questa scia li seguirono i Razionalisti e iModernisti condannati da Pio X (1903†1914). Questi,promuovendo la Comunione frequente, sviluppò ulteriormente laConfessione ripetuta. Il movimento eucaristico e la devozioneal Sacro Cuore, inculcata da tutti i Papi del XX sec. fino aGiovanni XXIII (1958†1963), nonché quella al Cuore Immacolatodi Maria con la pia pratica dei Primi Cinque Sabati del Mese– anch’essa con Confessione, Comunione e Rosario a scoporiparativo, rivelata a Suor Lucia Dos Santos (1907†2005) –fece sì che la Penitenza divenisse finalmente un Sacramentofrequentemente ricevuto.
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) parlò della Penitenzanella costituzione sulla liturgia Sacrosanctum Concilium,prescrivendone la riforma rituale; ma ne accennò anche nellaPresbiterorum Ordinis e nella Christus Dominus, in relazione aiministeri sacerdotale ed episcopale. Paolo VI (1963†1978)realizzò il mandato conciliare, pubblicando il nuovo Rito dellaPenitenza (19.9.1973), con una introduzione teologico-pastoraledi grande rilevanza.Per bilanciare lo scivolamento della Confessione verso lasola pietà privata si ripristinarono forme collettive dicelebrazione, nel quadro di una mitigazione delle penitenzepubbliche. Purtroppo la secolarizzazione e una teologianeomodernista minò le basi della prassi penitenziale diffusache subì una flessione. Sui complessi temi teologicipenitenziali il b. papa Giovanni Paolo II (1978†2005) convocòla VI sessione ordinaria del Sinodo dei Vescovi, i cui lavorifurono pubblicati nella monumentale esortazione apostolicapost-sinodale Reconciliatio et Poenitentia (1983). Ancora nelCatechismo della Chiesa Cattolica (1993) il Papa fece unasussunta della dottrina cattolica sull’argomento. L’odiernopontefice Benedetto XVI esorta continuamente i fedeli ad unapenitenza sacramentale frequente e sincera, nelle formecustodite dalla Chiesa Cattolica, le uniche che, a frontedelle oscillazioni delle Chiese ortodosse e dell’apostasia diquelle Protestanti, hanno mantenuto intatta la dottrinaapostolica sull’argomento.
ADNEXUM CAPITULO VIREMISSIO POENARUM
Elementi di teologia delle Indulgenze“In verità ti dico, non uscirai di lì
prima di aver pagato l’ultimo spicciolo!”
Nostro Signore Gesù Cristo
La Remissione delle Pene si ottiene, nell’economiasacramentale, con il Battesimo degli adulti, con lacontrizione unita alla Confessione e, per i soli peccativeniali, all’Eucarestia.Esiste tuttavia un mezzo predisposto dalla Divina Bontà perottenere la Remissione delle Pene dei peccati confessati, siamortali che veniali, l’Indulgenza. Essa non è un Sacramento,perché non produce la Grazia per efficacia propria, ma unSacramentale, ossia è efficiente per le preghiere dellaChiesa. In un certo senso è il Sacramentale per eccellenza.Ma, siccome essa può essere lucrata, ossia guadagnata, solo
dopo aver ricevuto i Sacramenti, è bene parlarne adesso,completando il discorso sulla Remissione dei Peccati.
TEORIA E PRASSI DELLE INDULGENZE
L’Indulgenza è la remissione delle pene temporali meritatedal peccato, sia in Terra che in Purgatorio. Tale remissionesi può ottenere solo per i peccati confessati o, se veniali,di cui si sia ricevuta l’assoluzione anche solo mediantel’atto penitenziale o l’Eucarestia o avendo almeno l’animocontrito, anche se non in modo perfetto, almeno in quellosufficiente per la loro remissione in quanto alla colpa.Questa remissione avviene perché la Chiesa ha un Tesoro diMeriti, costituito dalla sovrabbondanza di quelli di Cristo edegli altri da Lui suscitati, nella Vergine, negli Angeli enei Santi. Tali meriti sono di gran lunga superiori a quellinecessari alla semplice salvezza di chi li ha accumulati;quelli di Cristo poi sono atti a rimettere non solo tutti ipeccati in quanto alla colpa ma anche alla pena, in quantoEgli compì il Sacrificio perfetto, ad un tempo olocausto,sacrificio di espiazione, di riparazione, di comunione,oblazione e libagione. Completamente annientato a compensarela completa insubordinazione della razza umana, capace diespiare tutte le colpe cancellandole, di restaurare lacomunione tra Dio e l’uomo, di offrire l’offertapropiziatrice universalmente gradita, di spandere lalibagione perfetta nel Suo Sangue, l’Agnello di Dio riparatutte le conseguenze causate dal peccato andando a compensareogni disordine e quindi sanando tutti i debiti di pena dovutialla Giustizia di Dio. Tuttavia attraverso i Sacramentil’uomo ottiene necessariamente ed esclusivamente laremissione della colpa, ossia ritorna giusto, cosa che dasolo mai potrebbe fare. La remissione della pena, che èvirtualmente possibile, dipende dal tipo di dolore suscitatodalla Grazia nell’animo del penitente. Questo perché l’uomoaccede allo stato di giusto anche quando non ancora haespiato le sue colpe, anzi l’espiazione accettata conferma erafforza la giustizia di chi la compie. Tuttavia all’uomo è
concesso, anche quando non l’ha avuto ottenuto inConfessione, di cancellare le pene delle colpe di cui èpentito, mediante un atto particolare della DivinaMisericordia, che non a caso è detto Indulgenza, ossiaperdono particolare, sia nei modi che nei tempi. Proprioattingendo dal Tesoro dei Meriti, la Chiesa, cui compete dilegare e sciogliere, aprire e chiudere le porte dellaGiustizia, concede l’Indulgenza, che dà la sicurezza dellaremissione delle pene a determinate condizioni, variabili aseconda del condono offerto (31). Tale remissione vale siaper chi la lucra sia per i defunti ai quali il penitentevoglia applicarle a modo di suffragio, sia plenaria cheparziale.Le condizioni variano in base ai due tipi fondamentali diIndulgenza, la plenaria e la parziale (32). La plenaria è laremissione totale di tutte le pene meritate per i peccati,debitamente confessati. Essa si ottiene a quattro condizioni:la Confessione sacramentale, cui segua il fermo proposito dievitare per il futuro ogni peccato, anche veniale; laComunione eucaristica; la recita almeno di un Pater e Avesecondo le intenzioni del Papa, che concede l’Indulgenza; ilcompimento dell’azione indulgenziata, il cui potere espiativoè, per l’occasione, amplificato dall’autorità ecclesiastica.Confessione e Comunione si possono fare anche diversi giorniprima (o anche dopo la seconda) dall’atto indulgenziato; lapreghiera per il Papa va fatta lo stesso giorno. Si puòlucrare una sola plenaria al giorno. Possono lucrarsi piùplenarie anche con la medesima Confessione, mentre laComunione e la preghiera per il Pontefice vanno ripetute perognuna. L’Indulgenza parziale invece è la remissione di unaparte della pena meritata per i peccati, da compiersi conanimo almeno contrito, anche se non in modo perfetto, e checancella la pena meritata raddoppiando quanto espiato dalfedele col semplice compimento dell’atto indulgenziato (33).Si possono lucrare più parziali al giorno.Quali sono le opere che sono indulgenziate dalla Chiesa perla plenaria e la parziale? Il loro elenco è contenutonell’Enchiridion Indulgentiarum (34); trattasi generalmente dipreghiere, ma anche di azioni virtuose compiute con le debite
disposizioni o il pellegrinaggio ad un Santuarioindulgenziato (35). Un tipo particolare di Indulgenza èquella legata ad un periodo di tempo, che può essere di ungiorno o più lungo, ed è allora detto Giubileo, dal suono dicorno che lo bandiva.Esso è l’Anno Santo, ossia l’anno in cui Dio concede laremissione delle colpe e delle pene. Fondato nel Leviticocome periodo di remissione dei debiti e interpretatospiritualmente dalla Chiesa e da lei autoritativamentecollegato a determinati tempi, anche sulla base dellaTradizione espressa nella pietà popolare, esso può esserelocale o universale; l’uno e l’altro sono concessi dal Papa.Il Giubileo locale è concesso in luoghi specifici per ragioniparticolari, generalmente connesse a determinate ricorrenzein cui Dio è più propizio, come i centenari della morte deiSanti, Suoi amici. Il Giubileo universale è invece per tuttala Chiesa e si celebra ogni venticinque anni nella sua formaordinaria, fermo restando che il Papa può celebrarne distraordinari quando lo reputa opportuno (36). Nel corso deiGiubilei chi adempie alle condizioni richieste può lucrarel’Indulgenza in qualunque momento, può essere assolto daqualunque censura e da qualunque chierico. Le condizioni sonogeneralmente le medesime nei vari Giubilei (37).Ovviamente, nessuno può impedire a Dio, Che conosce i cuori,di dispensare Lui stesso l’Indulgenza a chi creda meritevole,magari sulla scorta di pratiche pie o azioni sante della fedecattolica. Infatti Egli, autore delle Indulgenze, non ne èvincolato in alcun modo (38).L’INDULGENZA NELLA TRADIZIONE DELLA CHIESA
Come ogni aspetto della dottrina della Fede, anchel’Indulgenza è stata sottoposta ad uno sviluppo progressivo,analogamente al granello di senape che dapprima è il piùpiccolo dei semi e poi diviene un albero sui cui rami siposano gli uccelli del cielo e alla cui ombra dormono lefiere. Molti, specie in campo protestante, hanno consideratol’Indulgenza come la sintesi degli abusi del Papato. Inrealtà questa affermazione, se ha un fondamento storico in
relazione agli aspetti pastorali e canonici del problema inalcune epoche, non ha nessun fondamento invece in campodogmatico e liturgico.Le prime Indulgenze furono concesse direttamentedall’Autorità ecclesiastica solo nel X sec., cominciando conl’abbonamento totale o parziale delle sfibranti penitenzecanoniche. Ma dalla notte dei tempi i fedeli compivano attidi pietà che implicitamente ottenevano l’Indulgenza (39). Unaprima tappa è costituita dal valore attribuito ai meriti deiConfessori fin da quando essi erano in vita (40). Già daitempi di San Cipriano di Cartagine (200 ca.-258) coloro iquali erano caduti nel peccato di apostasia e chiedevano lariconciliazione con la Chiesa si procuravano dei libelli incui i superstiti delle persecuzioni intercedevano per loro. Aquesti lapsi libellatici veniva concessa l’assoluzione inpunto di morte senza penitenza canonica, a dimostrazione chel’intercessione del Confessore era considerata vicaria dellapenitenza stessa, non potendo i moribondi più adempirla. Ciòdipendeva dai loro meriti.Una seconda tappa è costituita dalla prassi delpellegrinaggio o viaggio sacro. Intrapreso per culto deiSanti e delle loro Reliquie, stimolato dal compimento dimiracoli, motivato dal bisogno di soccorso nella malattia enelle difficoltà della vita, impreziosito dal desiderio diuniformarsi almeno per una parte della vita alla povertà,alla castità e all’obbedienza di Cristo, il pellegrinaggio hada sempre una valenza espiativa molto forte e degli archetipibiblici assai marcati (41), ed è ancora oggi una praticadevota raccomandata dalla Chiesa. Da quando essa nacque, ifedeli cominciarono a recarsi nei luoghi più santi dellaFede, quelli di Palestina, convinti che lo sforzo compiutoper raggiungerli sarebbe stato massimamente meritorio per lacongiunzione di tale merito con quelli sovrabbondanti diCristo medesimo, della Vergine, degli Apostoli e dei Santiche colà erano vissuti, e avrebbe ottenuto loro l’agognataremissione delle pene meritate dai peccati. Il viaggio era adun tempo presso il Luogo Santo e la Chiesa ivi radunata,presso la memoria e il memoriale della Presenza Divina (42).L’emancipazione del Cristianesimo e la fioritura di Santuari
attorno ai venerati corpi dei Santi, oltre che in luoghiimpreziositi da ierofanie miracolose (43), fecero sì che icentri di pellegrinaggio si moltiplicassero all’infinito eattirassero i penitenti alla ricerca di un’espiazione cheandasse a supportare l’assoluzione sacramentale (44). Già dal490 l’Arcangelo San Michele, apparendo a San Lorenzo Maioranoin quel di Monte Sant’Angelo, potè promettere: Ubi saxa pandunturibi peccata hominum remittuntur. I Santuari in cui la fede popolaree l’insegnamento ecclesiastico ravvisavano le condizionidella remissione della pena sono al centro di complessi cicliagiografici che, parte integrante della Tradizione, attestanola fede embrionale in un’Indulgenza legata ad un luogo e aduna santità ivi testimoniata, con cui si entrava in contattomediante il viaggio sacro. Così per esempio San GregorioMagno (590-604) poteva già attestare che la Tomba del BeatoApostolo Pietro era il luogo della universale remissione deipeccati, a causa dell’immenso afflusso di pellegrini in cercadi espiazione.Questo sistema espiativo ebbe ancor più successo da quando sidiffuse il sistema delle Redenzioni e dei Tariffari, cheprescriveva esso stesso il pellegrinaggio per determinatidelitti. Numerosi Santuari avevano collezioni votive dicatene, portate dai penitenti in segno di espiazione emiracolosamente scioltesi all’atto del loro arrivo in quellemete; anche le liste dei peccati che essi si portavano dietrospesso bruciavano spontaneamente al momento della visita.Cuore dei Santuari erano e sono le Sante Reliquie. Oggetto diculto perché ricordo fisico dei Santi, perché dotate dellasantità che appartenne loro per inabitazione dello SpiritoSanto e perché glorificate da Dio mediante i miracolicompiuti presso di esse (45), esse sono venerate dasempre (46)e si dividono in tre grandi tipi: quelle reali,quelle per contatto e i brandea. Questi erano i pezzettini,anche minuti, dei sepolcri dei Santi, sbrecciati dai fedeli eusati almeno fino a quando rimase in vigore il divieto romanodi smembrare i corpi dei Santi stessi o di traslarli, ossiafino al VIII sec. Questa legge, ora ripristinata, preservò ilmondo cristiano da una proliferazione a volte ambigua (47).Le Reliquie reali sono i corpi stessi dei Santi o gli oggettiusati da essi in vita; invalsa la prassi dello smembramento
dei corpi e degli oggetti, esse poterono essere conservate inpiù luoghi. Le Reliquie per contatto erano quelle generatedai fedeli toccando, con un oggetto, il corpo o il sepolcro ogli oggetti stessi del Santo; a volte era la stessa Chiesa aprodurre così le Reliquie – come ancora si fa – per ladevozione dei fedeli(48). Accanto alle Reliquie, che aigiorni nostri sono diventate più articolate nella tipologia,grazie ai filmati, alle registrazioni e alle fotografie deiSanti stessi, anche se non sono ancora oggetto di un cultoindiscriminato che pure avrebbe ragion d’essere, si collocanole Icone, considerate le immagini autentiche di Cristo, diMaria e dei Santi, degne per questo di venerazione e veicolidella loro presenza operativa efficace. Spesso accantoall’Icona dipinta si collocano le Statue. Le ferocipersecuzioni iconoclaste in Oriente alzarono il prestigiodelle Icone e la fede nella loro efficacia salvifica, ivicompresa la loro potenzialità espiativa. Il tipo iconico,rigorosamente stabilito e rispettato, garantisce laraffigurazione formalmente corretta di Cristo, della Madre,degli Angeli e dei Santi, in ossequio al principiodell’Incarnazione, che ha dato un Immagine visibile al Dioinvisibile, senza che però, mancando la consustanzialità trail raffigurato e il raffigurante, si corra il rischiodell’idolatria (49). L’Icona e la raffigurazione in quantotale, avendo come oggetto la persona e non la natura edessendo quella realmente ancora esistente ed operante, sonoun mezzo mediante cui i raffigurati possono agire. Ad uncerto punto della storia, perciò, la mappa del mondocristiano assunse la caratteristica che ancora oggi ha: unafitta trama di Santuari e Chiese, spesso assiepate in cittàdivenute sante per la loro ricca presenza e quindi metacostante di postulanti di grazie e perdono (50).Una terza tappa per la diffusione dell’Indulgenza fu il suolegame con la guerra. In un mondo sconvolto dalla violenza,prendere le armi fu ben presto concepito come atto diespiazione (51). Pipino il Breve scese in Italia nel 752 enel 756 per liberare Roma dai Longobardi e donarla al papaStefano II (752-757) pro venia delictorum suorum, ossia inpenitenza delle sue colpe, evidentemente già perdonatesacramentalmente, non avendo lui subito nessuna imposizione
penitenziale. Papa San Leone IV (847-855) promiseall’esercito dei Carolingi che quanti fossero caduti al suointerno per la difesa del mondo cristiano dai barbari paganisarebbero andati in Cielo direttamente, ossia diede allaguerra giusta con conseguente morte un valore soddisfattoriopieno. Non solo la sentenza fu reiterata da papa GiovanniVIII (872-882), ma ebbe un corrispettivo nella convinzionedell’imperatore Niceforo II Foca (963-969), che a Bisanzioconsiderava martiri della Fede i suoi soldati caduti inbattaglia contro i Saraceni, anche se il patriarca Polieucto(956-970) non volle attribuire loro nessun culto, sebbeneconvinto che fossero saliti in Cielo. Questa equiparazionetra martirio e piena purificazione penitenziale legata allaguerra contro gli infedeli fu ripresa anche da San Leone IX(1049-1054). Alessandro II (1061-1073) accordò l’Indulgenza achi combatteva per liberare la Spagna dall’oppressionemoresca. San Gregorio VII (1073-1085) bandì numeroseindulgenze per coloro che combattevano le sante battaglie delPapato e della Chiesa, decidendo già da questo mondo la lottatra bene e male.Il geniale coniugatore della guerra giusta col pellegrinaggiofu il Beato Urbano II (1088-1099) che, sulla base delparadigma biblico dell’Esodo, pellegrinaggio in armi verso laTerra Santa, allo scopo di soccorrere i Cristiani d’Oriente edi liberare i Luoghi Santi, bandì la Crociata nei Concili diPiacenza e Clermont Ferrand (1095) concedendo l’Indulgenzaplenaria a chiunque vi avesse partecipato, anche senzaperdervi la vita. Da questo momento la plenaria è collegataalla Crociata, pur non mancando Indulgenze generose legate aipellegrinaggi inermi e ad altre opere buone, ormaisignificativamente richieste nelle penitenze per i peccatipiù gravi e pubblici, capaci di abbonare sia le penecanoniche che quelle in Purgatorio o entrambe. Il Concilio diBari (1098) confermò le concessioni. Urbano II le estese allaReconquista spagnola, pellegrinaggio in armi a Santiago. Allaplenaria corrispondeva il voto del crociato, l’impegnosolenne preso di andare a combattere sotto vincolo di peccatograve: da esso decorreva l’applicazione dell’Indulgenza. Il IConcilio Lateranense (1123) confermò l’Indulgenza plenaria inSpagna e Terra Santa; il Beato Eugenio III (1047-1054) la
concesse alla Crociata contro gli Slavi pagani che impedivanola diffusione della Fede sul Baltico, come pellegrinaggioarmato presso le Chiese perseguitate e presso la Terra dellaBeata Vergine Maria (essendo state donate quelle lande allaMadre del Verbo); il III Concilio Lateranense (1179) laestese alla lotta contro gli eretici, come pellegrinaggioarmato presso le Chiese funestate dalla loro presenza, cheminacciavano il Corpo Mistico di Cristo. Introducendo ilsistema di commutazione dei voti su base tariffaria presenteanche nel Libro del Levitico, papa Innocenzo III (1198-1216)confermò la prassi diffusa di concedere l’Indulgenza anche achi armava un crociato a proprie spese e concesse questogenere di commutazione a chi lo chiedeva per validi motivi.Così, mentre fioriva la grande età dei pellegrinaggi inermi,quelli armati anche raggiungevano l’apice e la legislazionecanonica del IV Concilio Lateranense (1216) radunava leazioni meritevoli di perdono se compiute in armi: contro gliinfedeli, i pagani, gli scismatici, gli eretici e gliscomunicati.Una mutazione di tendenza cominciò a configurarsi con OnorioIII (1216-1227) che riconobbe l’Indulgenza della Porziuncola,plenaria, da lucrarsi il 2 agosto e ottenuta da NostroSignore stesso per richiesta di San Francesco d’Assisi (1181-1226), legata solo alla preghiera, ai Sacramenti e allavisita alla Chiesa assisiate e ai vari templi che poi ebberoquesto privilegio, oggi esteso a tutte le parrocchie e allechiese francescane del mondo. Lo sviluppo del culto deiDefunti fece sì, già dall’XI-XII sec., che l’Indulgenza fosseapplicata, come suffragio, ai Purganti, sia plenaria cheparziale. In ragione di ciò il 2 novembre, legato allaCommemorazione dei trapassati, fu impreziosito dalla plenariae il suo Ottavario da altre forme di perdono (52). QuesteIndulgenze erano ovviamente slegate sia dal pellegrinaggioinerme che armato. Invece la politicizzazione dell’uso dellaCrociata (contro gli Svevi, contro gli Aragonesi, contro iColonna, contro i Ghibellini) e la caduta di San Giovannid’Acri (1291) contribuirono all’eclisse della plenaria legataal pellegrinaggio in armi, anche se le spedizioni sacrecontinuarono ad essere organizzate fino al XVIII sec.,tornando a parziale fulgore nelle guerre contro i Protestanti
(secc. XVI-XVII) e contro i Turchi nei Balcani (secc. XIV-XVIII). Una nuova plenaria inerme fu concessa da SanCelestino V (1294) in Santa Maria di Collemaggio, lacosiddetta Perdonanza, ancora in uso. Nel frattempol’Indulgenza si legò sempre più anche alla semplice recita dipreghiere o al compimento di opere buone (53).Ma l’apice dell’Indulgenza plenaria si ebbe con l’istituzionedel Giubileo nel 1300 per volontà di Bonifacio VIII (1294-1303). Alla cadenza prima centenaria, poi cinquantennale indiventicinquennale dell’Anno Santo fece seguito la possibilitàdi lucrare l’Indulgenza anche fuori Roma. Clemente VI (1342-1352) fu il primo a concedere ai Maiorchini di lucrarla convisite alla Cattedrale e con l’offerta di una somma pari aquella che avrebbero speso per andare a Roma. Questaconcessione alla mentalità materialistica del Medioevo ebbepurtroppo tristi sviluppi: l’Indulgenza tariffata in basealla possibile spesa del viaggio a Roma divenne la prassi diBonifacio IX (1389-1404), che quindi fece entrare la simonianel sistema penitenziale. Egli usò anche largamente la prassidell’Indulgenza giubilare bandita al di fuori del Giubileostesso, lucrata in genere con un’offerta. La predicazionedell’Indulgenza divenne spesso grossolana e il richiamo allaConfessione e alla Comunione più flebile, specie nelRinascimento. Le numerose Indulgenze giubilari lucrate conofferte spesso si basarono su tariffe predeterminate,assecondando la parte più bassa della pietà popolare, quelladesiderosa di poter quantificare il merito. La pretesa, maiesplicitata, che l’Indulgenza concessa da Leone X per lacostruzione della Basilica di San Pietro rimettesse anche lacolpa e che non avesse bisogno della Confessione, oltre chedi una sua efficacia automatica, fece inorridire Lutero(1483-1546) il quale tuttavia negò il diritto stesso dellaChiesa di concederle, per cui Leone X (1513-1521), se da unlato precisò i punti controversi sollevati dal ribelleriaffermando la prassi tradizionale, dall’altro condannò glierrori in merito con la Exurge Domine (1520) e la Decet RomanumPontificem (1521). Il Concilio di Trento (1545-1563) potè cosìribadire la dottrina delle Indulgenze, così come l’abbiamoesposta, reprimendo gli abusi simoniaci. Nell’età modernaesse furono legate soprattutto a pii esercizi di ampia
popolarità, come la Via Crucis, le Litanie autorizzate, laPreghiera al Crocifisso, il suffragio (54). Pur rimanendo igrandi pellegrinaggi e i grandi Santuari (55), l’Indulgenzasi legò sempre più alla pietà privata, alla preghiera, mentrela prassi dell’offerta andò declinando. Il Concilio VaticanoII (1962-1965) prescrisse i necessari ammodernamenti poirealizzati da Paolo VI (1963-1978). Rimane ad oggi viva laprassi del pellegrinaggio, grazie alle continuemanifestazioni del soprannaturale nelle visioni, apparizionie nella vita di alcuni grandi Santi, per cui i fedeliistintivamente ancora accorrono alle fonti dell’espiazioneche Dio stesso apre loro (56). In effetti, l’ultima grandeIndulgenza concessa, quella della Divina Misericordia nellaII Domenica di Pasqua, da Giovanni Paolo II, corrisponde allavolontà espressa da Gesù in Persona a Santa Maria FaustinaKowalska (1905-1938), alla quale il Signore promise unarigenerazione talmente forte ai penitenti da restaurare lapura Grazia battesimale.
NOTE AL CAPITOLO VI E AL SUO ADNEXUM
1. Libro edito digitalmente su Amazon.com che raduna le catechesicomparse sul sito www.theorein.it .2. Altre denominazioni sono: Sacramento del perdono o della pace, perchédona l’uno e l’altra.3. Già nell’AT il peccatore confessava le sue colpe a Dio. Qui laconfessione è ricevuta da coloro che lo rappresentano.4. Sebbene la Confessione si sia sviluppata pienamente, come Sacramentoindividuale, nella Chiesa Cattolica e nella teologia sacramentarialatina, essa esistette sempre e si mantiene, a volte in forme differentima analoghe, nelle Chiese Orientali separate. La pretesa di Lutero – chepure accettò quel Sacramento per i primi tempi della sua riforma – e diCalvino nonché di Zuingli di abolirla come non evangelica non ha, in
effetti, alcun fondamento. Né ha alcun senso il suo svilimento, fatto daalcune correnti eterodosse postconciliari, in nome di un presunto ritornoall’antichità apostolica – in cui la Confessione era regolarmente efrequentemente amministrata – in quanto tale tentativo serve solo aprotestantizzare la pietà cattolica.5. La Morte di Cristo svolge diverse funzioni giustificatrici per ognuno.Anzitutto rimette la Colpa originale, che però può essere imputata soload Adamo. In conseguenza di ciò mette ogni uomo in condizioni di fare ilbene, restaurando la sua libertà, ispirandogli, sostenendogli ecoronandogli le buone opere, compreso lo sforzo di evitare le azionicattive. Per cui è dalla Morte di Cristo che ognuno è preservato daipeccati che avrebbe potuto commettere e che mai ha fatto, ed è per essache compie tutto il bene che può essergli attribuito. In relazione aipeccati commessi la Morte di Cristo è strettamente espiativa, per cuiogni colpa veniale è causa di una parte delle sofferenze di Gesù e ognicolpa grave da sola è bastevole a causarla, perché ogni colpa graveoffende infinitamente Dio, e quindi può essere compensata solo dalSacrificio dell’Uomo Dio, il Quale, Incarnandosi, scelse di redimeremediante un sacrificio perfettamente proporzionato, anzi eccedente,rispetto al male commesso dagli uomini. Infatti Gesù avrebbe potutoredimerci versando anche una sola goccia di Sangue, perché Dio. Se nonaddirittura con il semplice fatto di perdonarci, anche senzaIncarnazione. La Sua scelta di immolazione serve a mostrare da un latol’abissale grandezza della mostruosità del peccato, dall’altro la ancorpiù profonda bontà divina.6. E’ uno dei Cinque Precetti Generali della Chiesa. Esso vincola dopo laPrima Confessione che si fa a otto anni. Gli stessi bambini che devonoricevere la Prima Comunione prima debbono fare la Prima Confessione.7. L’uso della Confessione più frequente negli ultimi tempi è statopromosso, in relazione alla Comunione frequente, da S. Pio X (1903-1914)e dai suoi successori. In particolare Pio XII (1939-1958) si è moltoraccomandato per la Confessione mensile. Una buona frequenza è quellasettimanale.8. Papa Alessandro VIII (1688-1691) condannò la proposizione lassista del“peccato filosofico”, ossia della colpa che non offende Dio perché fattain ignoranza della Sua Legge o addirittura senza l’esplicita convinzionedi offenderLo, quasi che l’ingiuria a Dio sia un’elemento estrinseco alpeccato stesso, che l’individuo possa aggiungere o togliere a piacimento.9. Sebbene essi siano rimessi anche dalla Comunione o anche dall’attopenitenziale e dal Confiteor durante la Messa con le sue formuleassolutorie seguenti.10. Come la mancanza di un buon numero di sacerdoti in imminente pericolodi morte per più persone; rimane fermo il principio che appena si può cisi deve accostare al Sacramento individualmente.
11. Ciò fu definitivamente sanzionato dal Concilio Lateranense IV (1216).12. Molti sacerdoti sono morti per mantenere fede al segreto (come SanGiovanni Nepomuceno), perché Dio dà una grazia particolare per osservaretale comando.13. Il Vescovo è il vero ministro del Sacramento. Tuttavia almeno iParroci e in genere i Sacerdoti in cura d’anime sono delegati aconfessare. Per i peccati cosiddetti riservati, i Vescovi nominano uno opiù Penitenzieri che assolvono in suo nome. I peccati spettantiall’assoluzione del Papa sono rimessi o da lui direttamente o dalla suaSanta Penitenzieria Apostolica. Tra i peccati riservati, sanzionati dallascomunica, ricordiamo l’aborto – assolvibile dal Vescovo – laconsacrazione di Vescovi senza il consenso del Papa (ossia lo scisma),l’attentato alla sacra persona del Pontefice Romano, il furto delle OstieConsacrate, la negazione esplicita di un dogma di fede (cioè l’eresia),tutti assolvibili solo dal Pontefice. La scomunica è la privazione dellaGrazia di Dio da parte del potere apostolico (1 Cor 5, 1-13). Sebbeneogni peccato mortale sia di per sé causa di privazione totale dellaGrazia, in casi gravi o dubbi la sentenza canonica serve a rafforzare laconsapevolezza dell’indegnità dell’azione commessa; in tal casol’assoluzione non è solo dal peccato commesso, ma anche dalla scomunicastessa come pena comminata e sempre efficace. I crimini citati hanno lascomunica latae sententiae, ossia inferta automaticamente, anche se ildelitto non viene conosciuto dall’autorità ecclesiastica. Ne consegue checoloro i quali si confessano di quelle colpe sanzionate dalla scomunica aun ministro giuridicamente incompetente non sono validamente assolti.Altri delitti, a seconda delle circostanze, sono sanzionati dallascomunica ferendae sententiae, ossia valida solo se inflitta esplicitamentedal Papa o dal Vescovo. La scomunica maggiore, ormai in disuso, tagliafuori dai rapporti con tutti gli altri cristiani. Fu comminata peresempio dal beato Pio IX ai negatori del dogma dell’Infallibilità papalee in genere spetta agli eretici convinti. Durante il giubileo in linea diprincipio ogni confessore può assolvere da ogni scomunica. La scomunicariservata è quella che può essere assolta solo dal Papa. Quella inarticulo mortis può essere assolta solo in punto di morte. Oggi, appuntoin caso di pericolo di morte, qualunque sacerdote può assolvere daqualunque peccato e da qualunque scomunica, anche se lui stesso non ha ilmandato di confessare ordinariamente. L’altra grande pena canonica dellaChiesa è l’interdetto, che esclude il condannato da alcune o tutte lefunzioni liturgiche, e che può essere locale, personale o misto; illocale e il misto possono essere particolari o generali. All’occorrenzaintere nazioni possono essere sottoposte all’interdetto.14. La Confessione è un diritto del cristiano. I sacerdoti sono tenuti aconfessare ogniqualvolta ne sia fatta ragionevole richiesta. E semprequando ci sia pericolo di morte. Inoltre spetta al clero raccomandare laConfessione ed esortare ad essa. In quanto poi al ministro confessore,deve essere debitamente preparato e dotato di conoscenza della Legge di
Dio, di esperienza delle cose umane, di rispetto, tatto e delicatezza, diamore per il Signore e per la Chiesa, di pazienza e fermezza, diprudenza, di zelo per le anime e di volontà di contribuire alla loroconversione con la preghiera e la penitenza in prima persona.15. Così definì il Concilio di Trento.16. Il contrito non può tuttavia accostarsi alla Comunione se non dopol’assoluzione, a meno che non abbia un motivo grave per farlo e non possaaccedere ad un confessore (ad esempio un sacerdote che celebra e non puòconfessarsi prima della Messa).17. Chi, fuori della Chiesa, è contrito può evidentemente avere laRemissione dei peccati. Tale contrizione è ovviamente modulata sullaconoscenza reale che ognuno ha di Dio e dell’offesa arrecatagli. Ingenere, come si parla di Battesimo di desiderio e di sangue, secondo mesi può avere una Confessione di desiderio, perché il singolo che ama Diosi confesserebbe di certo se sapesse che Lui lo esige. In tal maniera,anche l’attrizione di chi è fuori della Chiesa, per quanto è possibileaverla, viene suggellata da una Confessione di desiderio, purchè ilpenitente ignori la possibilità di riceverla nella Chiesa Cattolica.18. E’ altrettanto opportuno concludere le confessioni accusandosi anchedi ciò che non si ricorda. Ciò sottopone al foro sacramentale anche ciòche non si dice senza colpa. Ovviamente, un peccato mortale ricordato oconosciuto successivamente può essere confessato nella prima occasioneutile. Nell’esame di coscienza bisogna peraltro evitare i rischi dellassismo e del rigorismo, avendo una coscienza ben formata. Per questo èbene avere un confessore ordinario e un padre spirituale, possibilmentenella stessa persona, che insegnino al penitente come ben confessarsi ecome vivere cristianamente per progredire nella vita spirituale eascetica. Il padre o direttore spirituale è una guida indispensabile, acui si chiede lume in ogni circostanza di vita, non solo morale, allaluce della Fede, considerandolo uno strumento nelle mani di Dio. Vascelto con saggezza tra i sacerdoti santi, anche se può essereteoricamente persino un laico. Senza direzione spirituale non vi è pianodi vita né progresso dell’anima. Direzione spirituale e confessionepossono avvenire anche nella medesima circostanza, se possibile. La rettaformazione della coscienza nell’esame fa si che il penitente possaessere, nel foro della Confessione, teste a carico e contrario per sestesso, come insegna il Concilio Vaticano II.19. Il dolore può essere anche susseguente alla Confessione,perfezionandosi. Dolersi in modo sempre più consono per colpe confessateanche in passato implica una migliore remissione delle stesse perché giàassolte nel foro sacramentale. Solo in un caso si può assolvere senza cheil penitente non accusi i peccati, quando questi sia moribondo e incapacedi parlare, ossia sub conditione.
20. Il digiuno consiste nel saltare un pasto o almeno in una sua notevolerestrizione, dal ventunesimo al sessantesimo anno. L’astinenza dalle
carni inizia dal quattordicesimo anno e dura tutta la vita. Lacommutazione, decretata da Paolo VI, può avvenire con preghiere,elemosine o altre mortificazioni volontarie. Purtroppo oggi i fedelihanno abbandonato quasi del tutto la prassi della penitenza pubblica.21. Per esempio la pratica riparatrice dei Primi Venerdì del Mese o deiPrimi Sabati, in onore rispettivamente del Sacro Cuore di Gesù e delCuore Immacolato di Maria, da compiersi mediante la confessione e lacomunione in quei giorni con l’intenzione soddisfattoria richiesta.22. Con essa, tutte le forme di culto liturgico. A cascata, tutte leforme di devozione, a partire dal Rosario e dalla Via Crucis, passandoper la meditazione, la contemplazione e la lettura della Sacra Scrittura.23. Sono pertanto sia fisiche che spirituali.24. Magari con la recita del Magnificat. Il ringraziamento privato puòprecedere la penitenza, se questa non è fattibile al momento.25. Istituito dal Concilio di Trento e modificato dal Vaticano II, essotutela l’anonimato o almeno la riservatezza del penitente. Peraltro, ifedeli devono accuratamente evitare di ascoltare la confessione altrui,sotto vincolo di peccato mortale.26. Come suggerito dal Concilio Vaticano II.27. Così il Rituale della Penitenza di Paolo VI.28. La dottrina del Tesoro dei Meriti è stata enunciata in modosistematico, dopo una gestazione millenaria, dalla bolla Unigenitus di papaClemente VI (1342-1352) e poi ribadita dal magistero successivo, sinoalla cost. ap. Indulgentiarum Doctrina di Paolo VI (1963-1978) del 1967. Ilb. papa Giovanni Paolo II (1978-2005) l’ha riespressa nella bollaIncarnationis Mysterium del 1998; il tema era sotteso alle lettereapostoliche dello stesso Papa, Tertio Millennio Adveniente (1994) e Novo MillennioIneunte (2001), rispettivamente di preparazione e conclusione agli eventigiubilari millenari.29. L’antica distinzione tra Indulgenze reali, locali e personali non èpiù contemplata nella disciplina canonica.30. Paolo VI abolì l’uso di quantificare l’abbono delle pene delladisciplina precedente, introducendo questa formula che àncoral’espiazione alle disposizioni del penitente in modo drastico.31. Sempre Paolo VI abolì tutte le vecchie Indulgenze che non fosseroesplicitamente indicate nell’Enchiridion o per cui non vi fosse una leggespeciale. L’attuale Enchiridion è stato pubblicato in una quarta nuovaedizione del testo base di Paolo VI nel 1999, per ordine del b. papaGiovanni Paolo II.32. Tra gli atti indulgenziati per la plenaria ricordiamo: accostarsi perprimi alla Comunione o tra i primi con un pio ringraziamento seguente;recitare il Rosario o l’inno Akhatistos in famiglia o in chiesa o in
gruppo; fare la Via Crucis; elevare la Preghiera a Gesù Crocifisso dopo laComunione nel sabato di Quaresima [Pio IX l’aveva concessa ogni giorno],leggere o ascoltare la lettura della Bibbia per più di mezz’ora,praticare le varie forme dell’Adorazione Eucaristica per un medesimolasso di tempo, partecipare alla processione del Corpus Domini, usareoggetti sacri come il Crocifisso, fare gli esercizi spirituali per tregiorni di seguito, visitare una chiesa e pregare in una chiesa in cui sitengano solenni funzioni in onore di un Santo o di un Beato proclamatonel corso dell’anno, recitare comunitariamente novene approvate o ancheprivatamente litanie o Piccoli Uffici riconosciuti, cantare in comunitàil Veni Creator Spiritus a Pentecoste o a Capodanno, e il Te Deum il 31dicembre , celebrare (se sacerdoti) la prima messa o i propri giubilei,parteciparvi (se fedeli, recitare il Credo alla Veglia di Pasqua onell’anniversario del proprio Battesimo, recitare Pater e Credo nellachiesa in cui si tiene un Sinodo, partecipare alle funzioni di una Visitapastorale . Chi ha recitato nella vita quotidianamente qualche preghierapuò, in punto di morte, con le debite disposizioni, anche se nonconfessato, ottenere la plenaria, opportunamente tenendo il Crocifisso.La plenaria in punto di morte è concessa anche con la Benedizioneapostolica impartita dal Sacerdote, al quale è vivamente raccomandato diconcederla. Una forma particolare di Indulgenza è considerata quella dicui godono gli ascritti alla Confraternita di Maria SS. del Carmelo dellaQuale portano lo Scapolare: essi escono dal Purgatorio il primo sabatodopo la morte, avendolo devotamente portato in vita, avendo osservato lacastità nel proprio stato e avendo adempiuto ad altre condizioni. LaPromessa risale alla SS. Vergine e fu avvalorata implicitamente dalmagistero ecclesiastico. Per la parziale esiste una serie di azioniindulgenziate, tra cui la sopportazione delle vicissitudini della vita oil compimento dei propri doveri di stato, elevando preci a Dio, o ilpregare mentalmente più volte nella giornata, anche brevemente [magaricon le giaculatorie debitamente approvate], potendone applicare il fruttoanche ai defunti; il lavorare a vantaggio del prossimo con animomisericordioso; il privarsi di qualcosa di lecito spontaneamente; ilprofessare la propria fede apertamente nei propri ambienti di vita elavoro. Queste sono le quattro concessioni generali legate alla parziale.Essa è inoltre concessa a chi prega in forme non liturgiche per leintenzioni delle Giornate Mondiali della Chiesa, come la Missionaria oper le Vocazioni o per la Pastorale sanitaria, o nella Settimanadell’Unità dei Cristiani; a chi insegna o impara la sacra dottrina; a chipratica le forme del culto eucaristico nelle forme non annesse allaplenaria; a chi recita l’Anima Christi o la Preghiera al Crocifisso dopo laComunione o fa la Comunione spirituale; a chi fa l’esame di coscienza esi eccita al dolore prima della Confessione o dopo di essa recitapreghiere penitenziali stabilite; a chi fa gli esercizi spirituali informe specifiche; a chi ascolta i sermoni delle Missioni al popolo; a chirecita il Rosario da solo, l’Angelus o altre preghiere marianespecifiche; a chi prega l’Angelo Custode, San Giuseppe, i SS. Pietro e
Paolo in forme indulgenziate, nonché ogni altro Santo e Beato nella suamemoria con preghiere autorizzate, o un Santo o un Beato recentementeproclamato in una chiesa in cui è stato solennemente venerato; a chirecita determinate preghiere delle tradizioni orientali; a chi prega peri benefattori, per il Papa, per il Vescovo al suo ingresso in diocesi onell’anniversario dello stesso, nelle forme approvate; a chi pregamattina e sera, prima e dopo i propri affari, prima dei pasti conorazioni indulgenziate; a chi recita il Credo, fa il Segno della Crocecon la formula di rito, recita gli Atti di Fede, Speranza e Carità,rinnova i voti battesimali, visita il Cimitero e prega almeno mentalmenteper i defunti, recita il Requiem Aeternam o le Lodi o i Vespridell’Ufficio dei Defunti; a chi legge o ascolta leggere la Bibbia per untempo inferiore alla mezz’ora.33. I luoghi da visitare sono: le Quattro Basiliche Patriarcali [SanGiovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo Fuori le Mura,Santa Maria Maggiore] a Roma sempre; le Basiliche minori, le ChieseCattedrali, i Santuari internazionali, nazionali e diocesani debitamenteeretti (a cominciare da quelli del Santo Sepolcro di Gerusalemmne, di SanPietro e San Paolo a Roma, di San Giacomo a Compostela, di San Michele aMonte Sant’Angelo), le chiese degli ordini e delle congregazionireligiosi, quelle parrocchiali e non parrocchiali e gli altari indeterminati giorni dell’anno, nonché nelle chiese in cui si tenga unaliturgia stazionale, il giorno stesso, per avere la plenaria; lecatacombe, per la parziale. Sarebbe auspicabile che la plenaria fossesempre possibile nei Santuari della Terra Santa.34. Abbiamo nel calendario della Chiesa Universale, lucrabili in chiesa,le Indulgenze del Due Agosto detta della Porziuncola, quella del DueNovembre solo per i Defunti [e nei giorni dell’Ottavario visitando ilCimitero], quella della Domenica della Divina Misericordia, la prima dopoPasqua, alle debite condizioni. Si ottengono Indulgenze plenarie anchenei giorni in cui le famiglie si consacrano al Sacro Cuore o alla SacraFamiglia alla presenza di un sacerdote, o nella solennità di Cristo Re odel Sacro Cuore quando si recita pubblicamente la Consacrazione a Lui; silucrano inoltre nel giorno in cui si riceve la Benedizione Apostolica oquando ci si unisce alla Via Crucis papale il Venerdì Santo o al Rosariorecitato dal Pontefice anche tramite i mezzi di comunicazione di massa;in quelli in cui si prega liturgicamente per scopi specifici, come leMissioni o le Vocazioni, o nella Settimana per l’Unità dei Cristiani;quando si partecipa all’Adorazione della Croce il Venerdì Santo; nellafesta dei SS. Pietro e Paolo per chi usa oggetti sacri quotidianamente efa in quell’occasione la professione di fede; quando si ascoltano isermoni delle missioni al popolo e si partecipa alla loro funzioneconclusiva; infine, coloro che sono ascritti alle Pie Unioni – comequella del Transito di San Giuseppe o del Santo Bambino di Praga- possonolucrare la plenaria in occasione di festività liturgiche e ricorrenzelegate allo spirito delle Unioni medesime.
35. Esistevano sia l’Anno Sabbatico che quello Giubilare, descritti nelcap. XXV.36. Giubilei romani occasionali, basati sulla credenza che nell’annocentenario della Nascita di Cristo si potessero avere particolari formedi perdono, furono forse tenuti dai papi Silvestro II (999-1003),Pasquale II (1100-1118) e Innocenzo III (1198-1216) negli anni secolaridel loro regno. Bonifacio VIII (1294-1303), su richiesta dei pellegriniaccorsi a Roma per il 1300, accolse la pia credenza e indisse il Giubileoper quell’anno, stabilendo di tenerlo ogni secolo (bolla Antiquorum habetFidem). In ragione della brevità della vita umana, Clemente VI stabilì dicelebrarlo ogni cinquanta, nella Unigenitus. Urbano VI (1378-1389) decisedi tenerlo ogni trentatrè anni in memoria della durata della vita diCristo, con la Salvator Noster; Paolo II (1464-1471) ne volle quattro ognisecolo, ogni venticinque anni, tanti quante sono le stagioni (IneffabilisProvidentia). Alessandro VI (1492-1503) ne riformò i riti liturgici con laPastoris Aeterni (1499), introducendo l’uso di aprire le porte sante dopoaverle picchiate con un martelletto d’argento pronunciando la formulaApritemi le porte della Giustizia, alla vigilia di Natale. Importanti bolled’indizione furono la Annus Domini di Clemente VIII (1592-1605), la Quodhoc di Leone XII (1823-1829), la Properante di Leone XIII (1878-1903), laInfinita Dei Misericordia di Pio XI (1922-1939), la Iubilaeum Maximum del ven.Pio XII (1939-1958). Paolo VI determinò condizioni nuove in cui potesseroessere lucrate le Indulgenze anche nelle Chiese locali (Apostolorum Limina),essendo fino ad allora di solito esse riservate ai pellegrini a Roma.Giovanni Paolo II riprese la legislazione sull’argomento indicendo ilGiubileo straordinario del 1983 (Aperite portas Redemptori) e quello ordinariodel 2000, modificando in occasione di questo i riti liturgici connessi(Incarnationis Mysterium), mediante l’abolizione dell’uso del martelletto econ la semplice spinta dei battenti delle porte sante delle Basiliche.Alcuni giubilei furono celebrati senza bolla d’indizione, ex lege, neitempi più remoti (1400; 1423-1425). Uno (1875) in forma privata. Numerosisono i Giubilei straordinari, di cui l’ultimo è quello citato del 1983.Vanno ricordati gli Anni devozionali mondiali, legati anch’essi adIndulgenze, come gli Anni mariani aperti da Pio XII e Giovanni Paolo II,gli Anni paolino 2008-09 e sacerdotale 2009-10, voluti da papa BenedettoXVI.37. L’Incarnationis Mysterium prevedeva, per i pellegrini a Roma, un piopellegrinaggio a una delle Basiliche patriarcali [o a San Lorenzo alVerano o a Santa Croce in Gerusalemme o al Santuario del Divino Amore oalle Catacombe], la partecipazione alla Messa o alle Lodi o ai Vespri oaltre funzioni liturgiche, o in alternativa alla Via Crucis o al Rosarioo al canto dell’Akhatistos, nonché la visita devota, anche privata, conl’adorazione eucaristica e pie meditazioni per un certo tempoconcludendole con il Pater, la professione di fede e l’invocazione dellaVergine; per i pellegrini in Terra Santa, un pio pellegrinaggio nelleBasiliche del Santo Sepolcro a Gerusalemme, della Natività a Betlemme,
dell’Annunciazione a Nazareth alle medesime condizioni; nelle altrecircoscrizioni ecclesiastiche, per i pellegrini nelle Cattedrali e inaltre chiese indicate dall’Ordinario, alle stesse condizioni, nonché lavisita anche individuale alla Cattedrale o ad altro Santuario designato,la pia meditazione in essi per un certo periodo e la recita finale delPater, della professione di fede e l’invocazione della Vergine; percoloro che in ogni luogo si recano a rendere visita per congruo tempo aifratelli in necessità o in difficoltà (infermi, carcerati, anziani soli,handicappati ecc.), visitando in essi Cristo sofferente, alle stessecondizioni generali delle plenarie, con l’invito a rinnovarle nell’annosanto più volte lucrando in ognuna la plenaria; per coloro che, almenouna volta nell’anno, si astengano da consumi superflui (fumo, alcool),pratichino l’astinenza o il digiuno e facciano offerte a vantaggio deipoveri; sostengano opere di carattere religioso o sociale (specie perl’infanzia abbandonata, la gioventù in difficoltà, gli anziani bisognosi,gli stranieri in cerca di migliori condizioni di vita); dedichino unacongrua parte del tempo libero ad attività che hanno interesse per lacomunità o altre forme personali di sacrificio.38. Possiamo far afferire a questa libertà di azione di Dio tutte quellepromesse di remissione legate a pratiche rivelate ed autenticate, anchese le Indulgenze rispettive non hanno avuto un riconoscimento esplicito,come ad esempio quelle di Nostro Signore a Santa Brigida di Svezia per leQuindici Orazioni alle Sante Piaghe. Oppure poniamo mente a tutti quegliatti, ignoti agli uomini, mediante cui il Signore rimette le pene aipeccatori pentiti che abbiano le condizioni da Lui richieste e che noiconosciamo tramite la Chiesa.39. Su di esse vi è, contrariamente a quanto si crede, una riccaletteratura patristica.40. Lo attesta ad esempio Tertulliano.41. Abramo, Isacco e Giacobbe vissero una vita di pellegrinaggioperpetuo, di nomadismo sacro. L’Esodo è un pellegrinaggio. La Leggeprescrive pellegrinaggi votivi e cultuali. Il rientro dall’Esiliobabilonese è un pellegrinaggio. Nostro Signore Gesù Cristo stesso visseuna vita di pellegrinaggio predicatorio e salì più volte devotamente aGerusalemme. Lo stesso fecero gli Apostoli. Tutta la vita cristiana è unpellegrinaggio da questo mondo al Padre, così come l’Incarnazione è unviaggio del Figlio dal Padre al mondo, per poi tornare a Lui.42. Migliaia di persone, nel corso dei secoli, anelarono di morire edessere sepolti in Terra Santa se non addirittura a Gerusalemme perpotersi coprire, nel Giorno del Giudizio, dei meriti stessi di Cristo.43. L’apparizione, sebbene debba essere oggetto di esame accurato daparte dell’Autorità ecclesiastica, sia in ordine all’attendibilità delveggente che alla ortodossia del messaggio, è un evento possibile e anziabbastanza frequente. Le apparizioni – ossia le circostanze in cui unSanto, un Angelo, la Vergine o Cristo stesso si rendono visibili in
questa dimensione – e anche le visioni sensibili – in cui invece è ilveggente che osserva qualcosa che è al di fuori della realtà che cicirconda- sono, quando debitamente riconosciute, parte integrante dellaTradizione e luogo teologico da tenere presente. Norme sul lorodiscernimento sono state dettate dal V Concilio Lateranense (1512-1516).44. Il Santuario è un luogo in cui il sacro ha una manifestazione eun’allocazione privilegiata, esattamente come nell’AT, in luoghi comeEbron, Betel, Sichem, Bersabea, il Sinai, Galgala, Silo, ecc., fino algran Tempio di Gerusalemme, edificato tre volte e oggi distrutto.45. Sono i motivi della venerazione addotti da Tommaso d’Aquino.46. Testimonianze per esempio nel Martirio di San Policarpo di Smirne, inSan Girolamo, in San Cipriano, in Sant’Agostino, in San Cirillo diGerusalemme, in San Gregorio di Tours ecc.47. Ai tempi di papa San Paolo I (757-767) furono traslate le primespoglie di martiri verso Chiese germaniche. Da allora il flusso deglispostamenti non ebbe più termine e alcuni importantissimi Santuari, comeSan Marco a Venezia, San Nicola a Bari ecc. devono la loro fortunaaddirittura ai sacri furti delle Reliquie che custodiscono. Infatti siriteneva che i Santi non avrebbero mai permesso che i loro corpi fosserorubati se non fossero stati contenti di essere spostati. Molti Santuaridi Apostoli e Santi molto antichi si fondano proprio sullo smembramentodei corpi di coloro ai quali sono dedicati. Bonifacio VIII (1294-1303)proibì lo smembramento dei corpi e la conseguente traslazione, ma ildivieto ebbe poco esito e non ebbe peso per il culto agiologico.48. Caso tipico quello delle Reliquie della Passione, con i frammentiinnumerevoli della Vera Croce. In ogni caso l’autenticità della Reliquia,quando è possibile constatarla, dev’essere acclarata dall’Autoritàecclesiastica. Essa non implica necessariamente una autenticità storica,ma una correttezza nel processo di sacralizzazione anche per contatto.49. Come dimostrarono San Giovanni Damasceno, San Teofane, San Niceforo,Sant’Adriano I, il II Concilio di Nicea (787) e San Teodoro Studita. Lateologia aniconica ancora oggi seguita dai seguaci di Calvino e Zuingli èquindi priva di un autentico fondamento biblico e patristico.50. I Santuari maggiori erano: Gerusalemme (Deus), Monte Sant’Angelo(Angelus), Roma e Santiago de Compostela (Homo). In Oriente fondamentaleera Costantinopoli con il suo tesoro di reliquie di inestimabile valore.Montserrat, Il Pilar, Rocamadour, Coutances, Le Puy, Clermont, Lione,Chartres, Reims, Boulogne, Charroux, Saint-Denis, Limoges, Vezélay,Tarascona, Tours, Saint-Gilles, Walsingham, Lough Dergh, Aquisgrana,Colonia, Mariazell, Einsiedeln, Chzestochowa, Venezia, Padova, Assisi,Salerno, Benevento, Bari, Varallo, Milano, Genova, Bologna, Tessalonica,Pec, Ochrid, Kiev, Antiochia, Alessandria d’Egitto, Efeso, Cartaginefurono, nell’area euromediterraneo, dal Tardo Antico al Basso Medioevo,solo alcuni dei nomi più prestigiosi.
51. Bisogna spogliare la mente dall’idea dell’uso delle armi comeselvaggio e anticristiano di per sé. Se il magistero di Paolo VI eGiovanni Paolo II ha mostrato che ovviamente la pace e il dialogo sonopiù conformi al Vangelo, sin dalla notte dei tempi la teologia ha fissatole condizioni della guerra giusta, che non è un bene ma un male minore eche, in ragione dei fini, diventa un atto di carità. La tradizionepatristica, canonistica e dei Dottori è unanime in tal senso. LaPurificazione della Memoria del 2000 fatta da Giovanni Paolo II e le suebasi teologiche messe dall’Istruzione della Commissione TeologicaInternazionale in vista di quell’evento non inficiano la possibilità diuna retta comprensione dell’etica e della teologia sottese alla prassimillenaria della guerra giusta nell’interesse e con la benedizione dellaChiesa. Il nocciolo morale non è mai cambiato, sono mutate le condizionistoriche, di costume, in cui calarlo e viverlo.52. Conformemente alla prassi biblica, attestata nei Libri dei Maccabei ein quelli di Samuele, della preghiera per i morti.53. Innocenzo III concesse l’Indulgenza a chi, sposandola, redimeva unaprostituta. I grandi mistici e visionari del Basso Medioevo ebberorivelazioni private su pratiche di pietà che accorciavano il Purgatorio,per sé e per altri. Per esempio le Orazioni per un anno e per dodici annirivelate a Santa Brigida di Svezia (1303-1373) da Gesù stesso. O lafamosa preghiera Ti Adoro Croce Santa, che libera le Anime del Purgatorio,poi confermata dai Papi.54. San Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751) fu il grande apostolodella Via Crucis. Pio VII (1800-1823) concesse la plenaria alle Litanie delSanto Bambino recitate pubblicamente il 25 di ogni mese. Il Beato Pio IX(1846-1878) la concesse a chi avesse recitato la Preghiera al Crocifissodopo la Comunione. Pio XI (1922-1939) la concesse ai fedeli che facciano,in suffragio dei Defunti, l’Atto eroico di Carità, ogni volta che sicomunicano.55. Loreto, Pompei e Guadalupe sono i nomi più noti dei Santuari fioritiin età moderna. Lourdes, Banneux, Rue du Bac sono invece nomi legati allagrande pietà del XIX sec.56. I luoghi sono Fatima, San Giovanni Rotondo, Siracusa ecc.
CAPITOLO VII
HASTHENOUNTAS THERAPEUETE
Elementi di teologia dell’Unzione degli Infermi
“Guarite gli infermi!”
Nostro Signore Gesù Cristo agli Apostoli
“I Dodici.. partiti… ungevano di olio
molti infermi e li guarivano”
Mc VI, 12“Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa
e preghino su di lui dopo averlo unto con olio, nel Nome del Signore. E la preghiera fatta con fede
salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati
gli saranno perdonati”
San Giacomo il Minore
“Guarite i malati!”, ordinò Nostro Signore ai Dodici,inviandoli a due a due nei luoghi dove stava per recarsi.Conferì loro a tale scopo molti poteri, sia taumaturgici chesacramentali, dando loro autorità sulla salute e sulla vitastessa dell’anima e del corpo, nonché sui demoni (1).In questa frase e nella prassi che ne seguì, nel corso dellastessa missione apostolica – nella quale i Dodici ungevano diolio gli infermi guarendoli – noi riscontriamo l’istituzionedel Sacramento dell’Unzione degli Infermi, detta anche OlioSanto o Estrema Unzione. Esso è quindi istituito, come tuttigli altri segni salvifici, dal Signore. La pienapromulgazione della Volontà Divina su questo Sacramento ètuttavia avvenuta nella Lettera di San Giacomo (5,14-15),dove l’Apostolo prescrive quanto aveva ricevuto dal Signore,ossia che i malati chiamino al proprio capezzale i presbiteriper esserne unti con olio per ricevere la salvezza in quelmomento estremo, di sicuro nell’anima – mediante il perdono –e poi all’occorrenza nel corpo, se l’Unzione è ricevuta conla dovuta fede e se ciò è conforme al Volere di Dio.Questo Sacramento è dunque mirabile negli effetti, manegletto, sia nella vita del singolo cristiano – persoverchie superstizioni che lo associano all’idea dellamorte, in conseguenza della quale è scaramanticamente evitato– sia nella storia della Chiesa – in cui appare come laCenerentola dei segni salvifici. In ragione di ciò, andiamoad esporre i cardini della Fede su questo argomento, sperandodi favorire una retta comprensione di esso e una sua piùfervente pratica sacramentale.
ELEMENTI DI TEOLOGIA DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Come la Confessione, questo Sacramento è di guarigione. Maesso è legato alla condizione della malattia. Perciò s’imponeuna serie di considerazioni. Anzitutto, va ricordato che ilSignore ha una cura particolare per i malati. Essi vivono unacondizione dalla quale nessuno può esimersi e che prima o poitocca a tutti. E’ la conseguenza del Peccato d’Origine, cheha creato distonia tra l’Uomo, fatto per la vita, e la suastessa natura, vulnerata dalla colpa; è la conseguenza deipeccati attuali, meritevoli di sanzione anche nel corsodell’esistenza terrena (2) e di correzione (3); è infine ilpassaggio obbligato dei viventi corporei, soggetti allacorruttibilità e alla fragilità dell’elemento materiale, cheprima o poi deve cessare di esistere, ossia deve morire.I malati sono spesso messi alla prova nella loro vitainteriore, abbandonati a se stessi, di fronte ad un destinoduro e ineluttabile, a volte tentati e allontanati da Dio inseguito alla sofferenza. Gesù, Che Si è caricato di tutti inostri peccati e quindi anche delle loro conseguenze, nonvuole che il malato e il sofferente si sentano soli: la SuaPassione e Morte, rimuovendo la causa prima del dolore edella morte, ossia il peccato, hanno la potenza terapeuticaanche di rimuoverne gli effetti, anche se la pienaemancipazione dell’Uomo dalla caducità avverrà nell’altravita e alla Resurrezione dei Corpi. Il Signore, se da un latovuole associare i Suoi fedeli alla Sua sofferenza salvifica -dando così al dolore umano una valenza nuova, per la qualecolui che soffre è un prescelto da Dio, quanto maggiori sonole sue sofferenze e la sua innocenza, nonché la sua capacitàdi offrire in conformità al Volere Divino, per la salvezzadel mondo - dall’altra non vuole infliggere loro doloriinutili, soverchi o troppo pesanti - amando esercitare la SuaMisericordia, che guarisce anima e corpo - né desidera cheessi siano soli nel portare la croce (4). La guarigionefisica, da Lui spesso concessa nel Vangelo e anche oggi in
circostanze specifiche, è sempre legata a quellaspirituale (5). Anzi, Egli mostra la Sua autorità di legare esciogliere dal vincolo del peccato proprio sanando malatiumanamente incurabili: ciechi, sordi, muti, paralitici,zoppi, lebbrosi e ogni altra sorta di infermi. Ad essi chiedesolo come condizione la Fede (6). In virtù di essa, risana ilcorpo e l’anima.Questo legame tra sofferenza fisica e spirituale rimane vivoanche nel mandato di guarigione da Cristo concesso agliApostoli e ai Discepoli, capostipiti della Successionesacerdotale sia dei Vescovi che dei Presbiteri. Ai Suoi piùintimi seguaci infatti il Signore conferisce il potere diguarire i malati. I malati a cui fa riferimento il Signore sono coloro che sonoduramente colpiti, che sono sulla soglia dell’eternità, che sono in uno stato dipermanente dolore: quelli cioè che a causa della loro infermità sono in pericolo divita, sia fisica che, conseguenzialmente, morale (7). Il termine grecohasthenountes indica proprio coloro che sono indeboliti,abbattuti, prostrati. E il comando therapeuete indica lacapacità di guarire non solo il corpo ma anche l’anima, che èlenita e sanata dalle Piaghe del Redentore. Perciò noi senzaombra di dubbio troviamo in Mt 10,8 e in Mc 6,11-13 ilracconto dell’istituzione di questo Sacramento da parte diCristo. Esso, come insegna il Concilio di Trento, è qui ineffetti accennato, ma realmente istituito, con una modalitàperfezionata, promulgata e raccomandata dall’ApostoloGiacomo, il fratello del Signore (Gc 5, 14-15) (8).Il Signore ha voluto questo Sacramento perché non solo lamalattia è conseguenza del peccato, ma soprattutto perché alsuo insorgere, facendo capolino la morte, il cristiano possapiù intimamente essere uniformato, unito e conformato a Luisofferente e morto; in ragione di ciò, nello stretto guadodel soffrire, l’Uomo non è lasciato solo, ma è sorretto nellabattaglia decisiva. La sua malattia diventa occasione disalute; il suo morire sfocia nella Vita Eterna. Non è unSacramento iatrico, che supplisce alla medicina, ma è unSacramento salvifico, che nel momento cruciale dell’esistenzasopperisce all’umana debolezza e conferisce una graziaspeciale di guarigione, all’occorrenza anche esteriore,specie se ricevuto con Fede (9). Per questo la Chiesa
raccomanda di riceverlo a chiunque, anche solo per ragionianagrafiche, sia già in predicato di morte. Esso non èindispensabile per la salvezza, ma fortemente consigliato eopportuno. Infatti completa l’equiparazione tra momentinaturali e soprannaturali della vita cristiana. Come laConfessione, anche l’Unzione degli Infermi rappresenta unbagno purificatore nel Sangue di Cristo. In ragione di ciò,il nome Unzione degli Infermi è sicuramente quello più adattoa definirne la natura. La vecchia dizione, Estrema Unzione,rimane tuttavia valida in considerazione del fatto che essa èl’ultima da conferire, non solo e tanto cronologicamente, maquanto e soprattutto soteriologicamente, perché fruttoestremo dell’azione salvifica applicata del Cristo, ultimascaturigine della Sua Misericordia redentrice, Sacramentospeculare ed esplicativo nei confronti del Battesimo, essendoquesti di entrata nella Grazia in questo mondo e quello diuscita dalla vita terrena, quello di entrata nella vitaceleste e questo di uscita dalla morte del peccato, entrambiin modo definitivo, sebbene l’uno imprima il sigillo el’altro operi solo in chi l’ha ricevuto. In un modo quinditutto speciale questo Sacramento unisce alla Morte di Cristo,consegnando corpo e anima del fedele alla Sua Sepoltura econformandolo alla Sua Resurrezione direttamente nell’altravita, con un effetto che qui, negli ultimi momentidell’esistenza, ha solo il suo pallido ma efficace inizio. E’perciò chiamato Sacramento degli Uscenti.Questo Sacramento ha il suo ministro o nel Vescovo o nelPresbitero, secondo quanto abbiamo detto, leggendo Matteo,Marco e Giacomo. La materia è appunto l’unzione con l’olio,d’oliva o vegetale, mediante imposizione delle mani (10).Essa avviene, conformemente alla credenza biblica nel poterecurativo naturale dell’olio stesso, sulla fronte e sullemani, secondo quanto recentemente precisato dal Magisterodella Chiesa (11), una volta sola. Naturalmente la Graziaonnipotente di Cristo conferisce a questo rimedio medico unpotere che non potrebbe mai avere da solo. Esso è sancitodalla forma, anch’essa ricondotta alla sua espressionetradizionale centrale: “Per questa Santa Unzione e per la Sua piissimamisericordia ti aiuti il Signore con la Grazia dello Spirito Santo e, liberandoti daipeccati, ti salvi e nella Sua bontà ti sollevi.” (12) In ragione di ciò, tale
formula è oggi scandita una volta sola. Questo Sacramento,proprio perché di guarigione, può essere ovviamente ricevutopiù volte. Inoltre, dal modo in cui viene impartito, sicomprende la ragione per cui è chiamato anche OlioSanto (13). Come tutti i Sacramenti, va ricevuto con ledebite disposizioni: pentimento, proposito, pietà, devozione,fede.
LA CELEBRAZIONE LITURGICA DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Come tutti i Sacramenti, l’Unzione degli Infermi è un attocomunitario, anche se celebrato fuori dalla chiesa e solo peril malato. E’ opportuno che sia celebrato nella Messa, oalmeno preceduto dalla Confessione e seguito dall’Eucarestia.Infatti, dopo l’Olio Santo, se il fedele può riceverla, èbene amministrare la Comunione, in quanto Viatico oSacramento dell’ultima strada, quella che ogni uomo devepercorrere; questa Comunione è, in verità, la più solennedella vita cristiana, quella che realmente unisce in modototale alla Morte e alla Resurrezione di Cristo. Tornando alSacramento dell’Unzione, dopo il Saluto del Celebrante, vi èl’Atto penitenziale e la Liturgia della Parola; segue il Ritosacramentale essenziale, con l’Imposizione delle Mani insilenzio, la Preghiera sul malato o Epiclesi, l’Unzione conl’Olio. Penitenza, Unzione ed Eucarestia sono il trittico deiSacramenti che preparano alla Patria Eterna.
EFFETTI SOTERIOLOGICI DELL’OLIO SANTO
Meravigliosi sono gli effetti di questo ultimo Sacramento:1. Viene conferita la Grazia sacramentale del conforto,della pace e del coraggio nella malattia e nellavecchiaia, nonchè di difesa dalla tentazione estrema;
2. Vengono rimessi i peccati, qualora non siano statiperdonati in Confessione, alle medesime condizionirichieste da quel Sacramento, se l’infermo non puòadirvi;
3. Viene conformato al Cristo sofferente e morto ilfedele così unto, tanto da essere consacrato all’azionedi partecipazione alla Redenzione;
4. Viene messo in circolo, nel Mistico Corpo, tutto ilmerito acquisito dal morente così conformato a Cristo; ilmalato riceve poi il vantaggio dell’intercessione dellaChiesa a suo vantaggio;
5. Viene preparato l’ultimo passaggio per il malato, daquesto mondo al Padre;
6. Viene concessa guarigione, salute e vita, se èconforme al Divino Volere e se c’è fede a sufficienza.
L’UNZIONE DEGLI INFERMI NELLA TRADIZIONE
Proprio per confutare l’erronea concezione di una nascitatardiva e non chiara di questo Sacramento, è bene indicarecome esso sia stato sempre presente nella Tradizione. Sindalla Lettera di Giacomo, abbiamo la prova dell’esistenza edella prassi dell’Unzione degli Infermi, sia nella ChiesaGiudaico-Cristiana, cui è indirizzata, sia ovviamente inquella ex gentibus, che pure ricevette la missiva comescrittura ispirata. Molte sono le attestazioni nelle Liturgiedell’Occidente e dell’Oriente. Tuttavia il Sacramento rimasein ombra per diverse ragioni: la prassi diffusanell’Occidente a praticare la Penitenza sacramentale unavolta sola, con suo differimento al punto di morte (V sec.) ela prassi di rimandare lo stesso Battesimo al momento finale(IV sec.). Avendo l’uno e l’altro Sacramento il potere dirimettere le colpe, addirittura in radice il secondo,l’Unzione degli Infermi fu trascurata, ma non dimenticata. Fupapa sant’Innocenzo I (402-417), scrivendo a Decenzio vescovodi Gubbio, a ricordare che i Sacramenti sono Sette e che traessi si annovera anche l’Unzione degli Infermi (Si institutaecclesiastica, 416). Il Sacramento è attestato nel VI sec. sia inGallia che Spagna. San Cesario di Arles (470-543) esorta i
malati ad andare in chiesa, comunicarsi, farsi ungere.All’Olio Santo è attribuito anche il potere di guarire edesorcizzare (14), ed era a tale scopo consegnato ai fedeli.L’antica preghiera per la consacrazione dell’Olio apposito,la “Effondi Signore il Tuo Santo Spirito Paraclito”, fuinserita nella Preghiera Eucaristica ed è attestata sia nelSacramentario Gregoriano (VII sec.) che nella TraditioApostolica di sant’Ippolito (III sec.), ed è ancora in uso.Essa attesta ovviamente l’esistenza del Sacramento per cuil’Olio è consacrato.Tra l’VIII e l’XI sec., l’Unzione fu dapprima inserita tral’imposizione della penitenza e l’assoluzione pubblica delSacramento della Confessione, per evitare che essa, inun’epoca in cui ancora non era invalsa quella auricolare,fosse trascurata dai fedeli; serviva altresì a garantire ilperdono a chi fosse morto improvvisamente. Nel X sec. fuamministrata addirittura dopo l’assoluzione, divenendoEstrema Unzione. Solo la nascita e il diffondersi dellaPenitenza privata e la preposizione dell’assoluzione allepratiche espiative tolse l’Olio Santo dall’angolo in cui erastato confinato.Col passare dei secoli, nella Tradizione liturgica furonoprecisate, in vario modo, le parti del corpo dell'infermo chedovevano essere unte con l'Olio santo, e furono aggiunte piùformule per accompagnare le unzioni, appunto contenute neilibri rituali delle varie Chiese. Durante il Medioevo, nellaChiesa Romana invalse la consuetudine di ungere gli inferminelle sedi degli organi di senso, con l'uso di questaformula: «Per questa santa Unzione e per la sua misericordiapietosa, il Signore ti perdoni tutto ciò che hai commesso dimale», formula che veniva adattata a ciascuno dei sensi.La dottrina sull’Unzione fu esposta nel Concilio Fiorentino –a fronte dell’Unione con i Greci- e Tridentino, per arginarela contestazione protestante.Il Concilio Fiorentino descrisse gli elementi essenzialidell'Unzione degli Infermi, nel Decretum pro Armeniis; ilConcilio di Trento ne proclamò la divina istituzione,indicando tutto ciò che intorno alla Sacra Unzione ètramandato dall'Epistola di san Giacomo, per quanto riguarda
soprattutto la realtà e l'effetto del Sacramento. Merita unacitazione testuale, che possa ravvivare la Fede in questosegno salvifico: «Questa realtà è, infatti, la grazia delloSpirito Santo, la Cui unzione lava i delitti, che sianoancora da espiare, toglie i residui del peccato e recasollievo e conforto all'anima del malato, suscitando in luiuna grande fiducia nella misericordia del Signore, per cuil'infermo, così risollevato, sopporta meglio i fastidi e itravagli della malattia e più facilmente resiste alletentazioni del demonio che gli insidia il calcagno (Gn 3, 15)e riacquista talvolta la stessa salute del corpo, quando ciòconvenga alla salute dell'anima (15)» Il medesimo Concilioproclamò che questa Unzione deve esser fatta agli infermi, esoprattutto a coloro che sembrano essere in fin di vita. Daqui l’uso della denominazione Estrema Unzione. Da ultimo, perquanto riguarda il ministro competente, dichiarò che ne èministro il presbitero.Il Concilio Vaticano II integrò la dizione "Estrema Unzione"con quella di "Unzione degli infermi", perché ciò a cui siriferisce non è il Sacramento solo di coloro che si trovanoin estremo pericolo di vita (16). «Con la sacra unzione degliinfermi e con la preghiera dei presbiteri tutta la Chiesaraccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato,perché rechi loro sollievo e li salvi (cf Gc 5, 14-16), anzili esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla mortedi Cristo (cf Rm 8, 17; Col 7, 24; 2 Tm 2, 11-12; 1 Pt 4,13), per contribuire così al bene del Popolo di Dio (17).” Inragione di ciò, avvenne la revisione del rito della SacraUnzione, al fine di adattar meglio alle odierne circostanzequegli aspetti che erano stati soggetti a mutamento, perchénon essenziali. Fu la cost. ap. Sacram Unctionem Infirmorum diPaolo VI (1972) a realizzarla e l’Ordo concernente l’Unzionedegli Infermi e la loro cura pastorale (1974) la mise inpratica.
NOTE AL CAPITOLO VII
1. Conformemente alla concezione di 1 Sam 16,14; Gb 18, 13; Sal 91, 6,per cui la malattia è causata anche dalle potenze infernali, i due poteripossono essere collegati.2. Es 11,4; Nm 12, 9-13; Sal 38, 3-9; Lc 13, 16; Gv 5, 14; 9, 2; 1 Cor11, 30; Rm 8, 20.
3. Gv 11, 4; 2 Cor 12, 7.4. La sofferenza ha un posto unico nella teologia cristiana. Unita aquella di Cristo sullo sfondo epistemologico della soteriologia, è unelemento dell’ascetica, della mistica e anche dell’etica. Oggetto dicostante riflessione magisteriale, è al centro di una pastoraleparticolare, detta appunto degli Infermi, che oggi si è sviluppata inmodo autonomo e completo grazie allo sviluppo della medicina. Di recenteun’ampia sintesi sul valore salvifico della sofferenza cristiana e tuttoil suo significato si è avuta nella Salvifici Doloris del beato Giovanni PaoloII (1984). Essa descrive il vasto mondo della sofferenza umana; ne cercail significato; lo rintraccia nell’Amore di Cristo, che la vince e latrasforma in azione salvifica. Per cui la sofferenza diventa Vangelo e ilBuon Samaritano il tipo del cristiano che aiuta chi soffre. In essa sitrova un chiaro riferimento alla Mediazione Materna che Maria, Salute deiMalati, svolge verso i suoi figli. Tale dottrina è antica quanto laChiesa. La Vergine, come del resto in tutti i Sacramenti, intercede,media e coopera al compimento della Grazia del segno salvifico.5. Nell’AT Dio è ad un tempo Colui Che infligge la malattia –direttamente o indirettamente- e Che guarisce. Lv 26, 26; Dt 28, 22; 2Sam 24, 16; 2 Re 19, 35; Gb 2, 7. Nel NT invece la Sua azione èessenzialmente guaritrice, essendo il Figlio venuto a redimere l’uomo equindi a farsi carico delle conseguenze del Peccato. Mt 1, 21; 17,11; 20,28; Mc 10, 45; Lc 2, 11.21.30; 15, 1; 19, 10; 21, 28; Gv 1, 17; 3, 17; 4,12.42; 6, 38; 12, 32.47; 18, 9 ecc.6. La Fede - espressa dalla preghiera - è condizione di guarigionenell’AT, assieme al digiuno e ai sacrifici: 2 Re 20, 3 ss.; Sal 38, 41; 2Sam 12, 16 ss.; Nm 25, 8. Anche nel NT è espressa in 2 Cor 12, 8. Lapreghiera per il malato diviene poi la forma stessa del Sacramento, comevedremo.7. Sebbene la prassi della Chiesa sia infatti quella di conferire ilSacramento a chi, avendo una grave malattia, è in pericolo di mortefisica, male non sarebbe, a mio avviso, di conferirlo anche a chi, avendouna malattia grave ma non immediatamente mortale, è tuttavia in pericolodi morte spirituale, perché provato e tentato a causa della durezza delsuo destino.8. Non vi è in effetti alcun fondamento nella tesi delle Chieseevangeliche, come dei Vecchi Cattolici e dei Razionalisti moderni, chel’Unzione degli Infermi non sia stato istituito da Cristo o addiritturanon sia Sacramento.9. In ciò trovano compimento le concezioni veterotestamentarie per lequali Dio è il vero e solo guaritore, ma del corpo in vista dell’anima,in uno spirito tipico della Nuova Alleanza. Cfr. Es 15, 26; Os 11, 3; Sal6, 3; Gb 5, 18.
10.L’olio in quanto tale è materia remota; l’unzione mediante imposizionedelle mani è prossima. Di recente, non essendo specificato nella Bibbiache olio adoperare, in ragione del fatto che in alcune regioni dellaterra l’olio d’oliva è difficile da reperire, è stato concesso di usarealtri oli, purchè vegetali. Il Signore preparò all’uso della materiasacramentale guarendo più volte per mezzi materiali simbolici: Lc 10, 34;Gv 5, 3 ecc.11.Paolo VI (1963-1978) ha riformato l’amministrazione del Sacramento conla Cost. Ap. Sacram Unctionem Infirmorum (1972). Prima si ungevano più partidel corpo, in corrispondenza con le aree motorie e sensitive. Sfrondandoil rito delle sue duplicazioni invalse nel Medioevo, il Papa haprescritto, secondo la Tradizione, la sola unzione della fronte e dellemani. In caso di necessità, sulla sola fronte o in altra parte del corpoche possa essere unta.12.La formula precedente faceva riferimento ai vari luoghi del corpo cheerano via via unti ed era ripetuta.13.L’Olio adoperato è quello degli Infermi, benedetto dal Vescovo nellaMessa Crismale del Giovedì Santo, insieme a quello Crismale e a quellodei Catecumeni.14.Per il nesso tra presenza infernale e malattia di cui dicevamo.15.Conc. Tridentino, Sess. XIV, De extr. unct., cap. II:16.Conc. Vaticano II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n.73.17.Cost. dogm. Lumen Gentium.