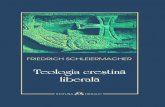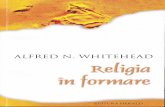La teologia politica vichiana. La figura della divinazione nella teologia civile della Scienza Nuova
Transcript of La teologia politica vichiana. La figura della divinazione nella teologia civile della Scienza Nuova
La teologia politica vichiana. La figura della divinazione nella teologia civile
della Scienza Nuova
Una figura della Scienza Nuova
Questo saggio si propone di indagare l’idea di «teologia politica» in Vico a partire da
una duplice ipotesi. La prima è che attraverso la sua teologia politica Vico presenta
una soluzione al problema filosofico politico della fondazione dell’ordine diversa da
quella moderna-giusnaturalistica e contrattualistica1. La seconda ipotesi è che la
figura della divinazione rappresenta l’elemento che meglio permette di esprimere il
crinale di tale diversità.
La riflessione sulla teologia politica, indicata da Vico con l’espressione latina di
teologia civile, è considerata esplicitamente da Vico come elemento costitutivo della
propria scienza: «La qual condotta della provvedenza divina è una delle cose che
principalmente s’occupa questa Scienza di ragionare; ond’ella, per tal aspetto, vien ad
essere una teologia civile ragionata della provvedenza divina»2.
La divinazione è invece un elemento che compare in maniera meno
programmatica, ma non per questo meno pregnante. Sono due gli elementi che ne
1Il dibattito sui rapporti fra forma politica moderna e teologia è al centro della riflessione politica almeno dal saggio diCarl Schmitt «teologia politica» che si apre con la celebre e icastica affermazione che «tutti i concetti più pregnantidella moderna dottrina dello stato sono concetti teologici secolarizzati». C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitelzur Lehre von der Souveränität, München - Leipzig, 1922. tr. it. di P. Schiera Teologia politica in Le categorie delpolitico, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 61. Inoltre dello stesso C. Schmitt, Politische Theologie 2: die Legende von derErledigung jeder Politischen Theologie Berlin, Duncker & Humblot, 1970. In polemica con Schmitt è interessante H.Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt am Mein, Suhrkamp, 1966, tr. it. Di C. Marelli, Genova, Marietti,1992. Una mappa del dibattito, incluse le riflessioni degli ultimi decenni, è M. Scattola, Teologia politica, Bologna, ilMulino, 2007.2 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744), in Id., Opere, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, par. 2. La forma «teologia civile» è una espressione latina theologia civilis equivalente al greco theologia politikè M. Scattola, Teologia politica, Bologna, il Mulino, 2007, p. 13.
3
indicano esplicitamente l’importanza: il primo è la separazione fra ebrei e gentili: «La
religion ebraica fu fondata dal vero Dio sul divieto della divinazione, sulla quale
sursero tutte le nazioni gentili»3; la seconda è la divinazione come scienza del bene e
del male, «‘scienza del bene e del male’, la qual poi fu detta ‘divinazione’»4.
Cercheremo di dimostrare che l’importanza della divinazione che traspare da questi
due passaggi non è occasionale, ma è invece essenziale per mostrare la peculiarità
della soluzione vichiana al problema della fondazione dell’ordine politico.
Cominciamo cercando, analizzando attentamente il testo vichiano, di comprendere
cosa intende Vico per divinazione e quale sia la sua rilevanza. La divinazione è posta
da Vico al fondamento delle prime comunità umane. È il primo atto sociale umano,
l’atto attraverso cui l’uomo dà significato al mondo, attribuendo la qualifica di
divinità al cielo, sancendo la nascita della religione, che presso i gentili è
indistinguibile dalla divinazione: «La divinazione, dalla qual appo i gentili tutti
incominciarono le prime divine cose»5. La religione ha una funzione centrale nel
pensiero di Vico. Essa permette, grazie al timore che l’idea di divinità incute, di
reprimere gli istinti antisociali dei primi uomini. L’atto iniziale dell’uomo come
essere sociale è la sottomissione ad una percepita forza superiore. È questa
percezione a spingere gli uomini a cercare rifugio nella grotta e a proteggere,
all’interno delle grotte stesse, la discrezione dei rapporti sessuali6.
La religione è anche una «legittimazione» del comando. Il comando dei padri delle
3 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 167.4 Ivi, par. 3655 Ivi, par. 96 Il cuore dell’argomentazione vichiana è esposta nelle degnità XXX e XXXI. (Ivi, parr. 175-179).
4
prime famiglie, il primo nucleo della socialità, è il comandare «ciò che credevan
volesser gli dèi con gli auspìci»7. La religione dunque è un meccanismo ermeneutico
di interpretazione dei segni, un’attività sacra, da cui discendono i principi di autorità e
la decisione sulla giustizia all’interno dei gruppi sociali8. È qui che nasce la
fondamentale figura del «poeta-teologo» ossia colui il quale è capace di comprendere
il linguaggio degli dei, avendo quindi la facoltà di divinare ossia di «indovinare» o
«predire»9. La qualifica di «poeta» è estremamente importante perché mette in
rilievo l’importanza che per Vico riveste l’atto del creare, che in riferimento ai poeti
teologi significa fondare le nazioni e la socialità10. La divinazione si presenta anche
come «scienza» che nasce nel momento del gesto seminale dei poeti teologi di
«interpretare» il volere divino e creare forme di legame sociale.
Possedere la scienza della divinazione consente ai padri di essere veri e propri
«fondatori di nazioni», considerati giusti per «la creduta pietà di osservare gli
auspici»11. I padri-poeti-teologi erano dunque anche i depositari della giustizia, intesa
come conformità ad un ordine immaginato divino. In questo modo la divinazione
diventa regolazione dell’agire pratico nel futuro, impregnando l’intero ethos dei primi
gruppi e ponendosi come sistema di regolamentazione etico-politico. La divinazione
è il primo atto sociale perché è la prima forma di regolamentazione e disciplina della
società stessa.
7 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 258 Vedi anche G. Carillo, Vico: origine e genealogia dell’ordine, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, p. 247.9 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 381.10 L’etimo greco della parola «poeti» è ricordato da Vico stesso: «onde furon detti ‘poeti’, che lo stesso in greco suona che ‘criatori’» (Ivi, par. 376). Che gli uomini siano creatori delle «nazioni» lo ricorda il passo forse più citato dell’intera opera vichiana: «Questo mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini» (Ivi, par. 331).11 Ivi, par. 14
5
Il rapporto fra teologia politica e divinazione è ancora più stretto in riferimento
all’età eroica, che ha origine con l ‘incontro fra le famiglie, appena descritte, e i
famoli, discendenti degli uomini non riuniti in famiglie e rimasti nelle selve, incontro
che dà origine alle città. La divinazione è anche qui fondamento dell’ordine sociale.
Lo scarto è che essa si presenta anche come fondazione di un ordinamento
propriamente giuridico, ossia esterno ai legami familiari, che non è puro dominio ma
creazione di un ordine rituale-politico12.
Gli eroi, discendenti dei primi poeti teologi, mantenevano un rapporto privilegiato
con la divinità basato su una supposta derivazione genetica, che segnava non solo una
diversità di status, ma una vera e propria diversità di natura fra eroi e famoli13. Il
rapporto privilegiato degli eroi con la divinità diventava rapporto giuridico reale,
proprio in virtù del monopolio che essi avevano della scienza e dell’amministrazione
delle cose divine.
Il fondamento dell’ordine sta nella decisione politica espressa attraverso l’atto di
interpretare il volere degli dei. Non sono né la morale né la metafisica a fondare le
nazioni, ma la politica14. Ciò si vede chiaramente anche dalla dicotomia che Vico
immagina alla base della fondazione delle nazioni: da una parte i pii-forti, dall’altro
gli empi-vagabondi-deboli15. La divinazione è ciò che permette il passaggio dalla
forza alla morale e quindi la fondazione delle nazioni. La divinazione è dunque la
figura fondamentale della sapienza poetica, perché per suo tramite viene creata una
12 Ivi, par. 646ss.13 Ivi, par. 15.14 Ivi, par. 721.15 Ivi, par. 18.
6
modalità di convivenza, un ordine, con un apparato di norme, regole, punizioni delle
trasgressioni. Qui è evidente l’indistinzione quasi perfetta fra teologia e politica16.
Non si tratta però solo di mostrare l’indistinguibilità fra il legislatore e il teologo, ma
anche l’impossibilità di disgiungere la capacità umana di creare un ordine politico e
morale dalla capacità mitologico-immaginativa che nella prima fase vengono da Vico
ricondotte alla religione17. La divinazione è comando basato su una volontà divina ma
è anche, e direi soprattutto, scienza del bene e del male. La possibilità di dire il giusto
è indistinguibile da una superiore forza materiale, ma non è ad esso riconducibile.
Qui sta anche la peculiarità della maniera vichiana di affrontare la ritualità delle
prime nazioni ma anche la ritualità della politica nella sua dimensione di lotta. Per
Vico, nonostante l’enorme rilevanza del conflitto nella politica, non è possibile
immaginare la lotta politica come pura e semplice «presa del potere» ma è sempre
lotta per i significati etici e simbolici. Tutta la lotta politica a cui Vico si riferisce
ruota intorno alla gestione rituale dei diritti, proprietà della terra, possibilità di
trasmissione della proprietà attraverso matrimoni solenni. Vico non dà una lettura di
questi conflitti in termini esclusivamente materiali o in termini di ampliamento dei
diritti, ma vi conferisce un carattere molto più profondo perché si propongono di
sanare l’ingiusta situazione subita da una parte, i famoli, ritenuta erroneamente di
inferiore natura. La lotta dei famoli ha un carattere certamente politico nel suo
svolgimento ma etico nella sua fondazione. Il problema essenziale della lotta è
16 Vedi F. Botturi, La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica, Milano, Vita e pensiero, 1990, p.178. 17 Sul legame politica, poesia, religione, diritto alcune considerazioni, che forse enfatizzano eccessivamente l’elementotrascendente della provvidenza, vedi M. Olender, Ce que le politique doit au poétique in Y. Bonnefoy (éd.), Laconscience de soi de la poésie, Paris, Seuil, 2008, pp. 135-153.
7
l’affermazione dell’uguaglianza naturale che passa per l’abbattimento della struttura
rituale eroica sottesa all’ordinamento politico.
La lotta dei famoli e il divinari
A questo punto si pone un problema cruciale ossia come avviene l’abbattimento della
struttura rituale eroica e se ad esso corrisponda l’abbandono della divinazione e delle
facoltà politiche e poetiche che rappresenta.
Mettere in discussione l’ordine basato sulla divinazione significa contestare la
giustezza dell’ordine politico, ed è questo il presupposto della lotta dei famoli e dello
stesso cambiamento storico. In un primo momento è considerato giusto il regime di
dominio basato sulla capacità dei poeti teologi di «interpretare» la volontà della
divinità, poi è considerato giusto l’ordine basato su una supposta diversità di natura
fra eroi, di stirpe divina, e famoli, infine, quello basato sul riconoscimento
dell’uguale natura degli uomini18. Cosa accade quando le lotte per l’uguaglianza
fanno cadere l’illusione di una natura superiore? Qui sta il problema essenziale,
perché è il problema che la modernità risolve su basi razionali e utilitaristiche,
affermando l’uguaglianza formale dell’umanità. Come vedremo meglio in seguito,
Vico scrive la propria scienza in larga misura contro questo esito «empio». Come
dicevo, la mia tesi è che la figura della divinazione sia la chiave per comprendere la
18 È importante sottolineare che non è questa la descrizione di una progressione teleologica o assiologica, masemplicemente l’enunciazione di differenti possibilità la cui attuazione dipende dalle concrete relazioni simboliche e dipotere all’interno dei gruppi sociali. In altre parole il “prima” e il “poi” sono da considerare esiti sempre possibili.
8
soluzione vichiana, anche se Vico non usa il termine in riferimento alla fase umana19.
Essa è, tuttavia, essenziale perché rappresenta ciò che si potrebbe chiamare
«eccedenza etico-creativa-futurologica» che mantiene intatta la sua natura
«divinatoria». La sua funzione politico-etica non si esaurisce completamente con la
crisi e la fine dell’ordine eroico. La lotta politica conserva l’impronta del momento
divinatorio iniziale della socialità, che rappresenta un’eccedenza rispetto allo
sviluppo della ragione. In fondo, tutta la scienza di Vico è un tentativo di rendere
conto di quella eccedenza, e della sua forte matrice arazionale, sia nel momento della
nascita sia nel momento della conservazione della nazione20. Non viene meno la
necessità di proporre una diversa articolazione sociale, né ciò avviene attraverso un
processo di autochiarificazione razionale. È essenziale capire il punto. Attraverso il
nesso divinazione-teologia politica Vico non individua il fondamento della politica
nella religione positiva, né implica la necessità di una religione civile alla Machiavelli
o alla Rousseau, né potrebbe mai seguire Hobbes nell’elaborazione di un minimo
«teologico» di fede, «Jesus is the Christ», oltre il quale la religione diventa
irrilevante, né condividere l’idea dell’elaborazione di un qualche tipo di religione
universale. L’appello vichiano ad una dimensione religiosa indica la necessità della
presenza di un tipo di sapienza che sappia porsi i problemi politici ed etici, primo fra
tutti quello della giustezza dell’ordine politico. Tale necessità è implicata nell’idea
19 Che Vico non possa usare il termine divinazione nella fase umana è, d’altronde, comprensibile, dato che avrebbe significato affermare l’equivalenza funzionale fra la religione cristiana e tutte le altre.20 È il caso di sottolineare che sostenere la presenza di elementi «arazionali» nel pensiero di Vico non significa fare diVico un irrazionalista né si tratta di sostenere la superiorità del momento non-razionale. Si tratta di sottolineare lapresenza di ambiti in cui la razionalità non entra. SI può sostenere che in Vico ci sia una forte coscienza dei limiti dellaragione, accompagnata però, dall’idea che su questi limiti si possa ragionare, attraverso un diverso tipo di logica e,naturalmente, una nuova scienza.
9
che non sia possibile, come vedremo meglio nelle prossime pagine, una fondazione
puramente razionale della politica21.
Dobbiamo però prima cercare di capire, da un punto di vista filologico e letterale,
se è possibile individuare lo spazio per la divinazione nell’azione dei famoli e nella
fase umana. Il primo elemento da notare è che Vico rileva come i famoli non avessero
accesso alla divinazione ma solo «auspici minori» o «privati»22. Devono quindi, da
un lato, rovesciare la religione degli eroi, dall’altro creare un altro tipo pensiero che
possa mettere in discussione l’ordine stabilito dagli auspici eroici. L’esito di questo
processo è lo sviluppo di un pensiero politico «fantastico», che si esprime attraverso
una serie di figure mitologiche. Vico pensa ad un vero e proprio conflitto fra la
sapienza dei primi teologi e le mitologie dei famoli, individuando alcuni caratteri che
lottano contro Apollo, «dio della divinità o sia della scienza della divinazione, ossia
scienza d ‘auspici’», a simboleggiare la volontà dei plebei di essere messi a parte
degli auspici23. Da notare che le sfide ad Apollo avvengono nel canto, ossia sostiene
Vico, «di quel ‘canere’ o ‘cantare’ che significa ‘predire’»24. Un’altra figura
centrale è quella di Anteo, simbolo dei famoli, che viene sconfitto da Ercole, che
simboleggia gli eroi fondatori di nazioni25. Un altro elemento fondamentale da tener
presente è il canone mitologico del «carattere doppio»26. Alcune divinità, Vico si21 Alcuni elementi interessanti sulla «religiosità» di Vico sono, nonostante sia un testo datato, in A. Corsano,Umanesimo e Religione in G. B. Vico, Bari, Laterza, 1935, p. 172. Degna di nota è l’idea che siano tre gli elementi chedistinguono il pensiero religioso di Vico da quello dei suoi contemporanei: l’accettazione franca del dogma della caduta,la fondazione religiosa della politica, l’idea di una religione volgare e popolare. Tale elementi sono contigui a treelementi individuati anche in questo testo: l’idea di un uomo da solo di fronte alla necessità della creazione di un ordine,una fondazione non razionalistica della politica, una religiosità spiccatamente antropologica. 22 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 568.23 Ivi, par. 647.24 Ivi, par. 646.25 Ivi, par. 618.26 Ivi, parr. 579-581.
10
riferisce in particolare a Vulcano, Marte e Venere hanno la singolare proprietà di
significare tanto gli eroi quanto i famoli: «Le quali favole, ovvero caratteri doppi,
devon essere stati necessari nello stato eroico, ch’i plebei non avevano nomi e
portavano i nomi de’ loro eroi»27.
L’elaborazione di figure «contro-eroiche», quali quella di Anteo, ha nel contesto
della lotta dei famoli la funzione di permettere la comprensione poetica della propria
condizione, creando nel contempo la possibilità di una universalizzazione di tale
comprensione che è legata alla rifigurazione del passato, anche e soprattutto mitico, e
alla prospettiva di azione nel futuro. È vero che tutte le figure che abbiamo citato
sono figure di una sconfitta dai famoli. Tuttavia esse mostrano che il carattere di
sottomissione è dovuto alla sconfitta nella lotta e non ad una reale diversità di natura.
Per questo la narrazione eroica si presta ad essere utilizzata dagli stessi famoli per la
creazione di una identità di gruppo e come apertura di una possibilità di azione.
La figura cruciale è quella di Solone28. La lotta della plebe ateniese avviene in
primo luogo contro la sapienza degli auspici degli eroi, che rende i plebei di origine
bestiale, e conseguentemente priva dei diritti di cittadini. Solone è quindi un uomo di
sapienza volgare (termine che a maggior ragione qui è da considerare nel suo
significato etimologico) ma anche un capoparte di plebe che «avesse ammonito i
plebei ch’essi riflettessero a se medesimi e riconoscessero essere d ‘ugual natura
umana co’ nobili, e ‘n conseguenza che dovevan esser con quelli uguagliati in civil
27 Ivi, par. 581.28 Ivi, parr. 414-416.
11
diritto»29. Questo «riflettere a se medesimi» esprime l’esigenza di «prendere
coscienza» della propria condizione, e di agire per migliorare le condizioni di vita.
Nello stesso paragrafo c’è un’altra considerazione decisiva: «Se non, pure, tal Solone
furono essi plebei ateniesi, per questo aspetto considerati»30. Non ci interessa qui
sapere se, e in che misura, Vico ritenesse Solone personaggio storico realmente
esistito o no. Ci interessa mostrare che a livello politico la sua importanza è di essere
un universale fantastico equivalente agli auspici ma invertito di segno.
Le narrazioni mitopoietiche, allora, rispondono perfettamente a due funzioni
essenziali della divinazione, cioè la «gestione» della coscienza e la prefigurazione
dell’azione nel futuro. Vico stesso effettua il collegamento fra queste dimensioni e la
divinazione: «La provvedenza fu appellata ‘divinità’ da ‘divinari’, ‘indovinare’
ovvero intendere o ‘l nascosto agli uomini ch’è l’avvenire, o ‘l nascosto degli uomini
ch’è la coscienza»31. Ciò chiarisce il senso dell’insistenza di Vico sulla necessità
della vitalità dell’immaginazione e della fantasia. Il futuro non è a disposizione della
razionalità politica, non si può razionalisticamente prevedere il futuro, si può solo
«indovinare»32. Si può, in altre parole, prefigurare un atto, con l’uso della fantasia, se
noi stessi siamo gli autori del futuro, e ne decidiamo la forma. «La narrazione, in
quanto radicata nell’esperienza trascorsa dei padri, ri-figura il passato degli
accadimenti e, in quanto ordina la prospettiva dell’agire, ne pre-figura il futuro»33. È
29 Ivi, par. 414.30 Ibidem.31 Ivi, par. 342.32 Vedi ivi, parr. 62, 342. È presente anche l’espressione «avvisar l’avvenire»: ivi, parr. 9, 475, 477, con il francesismoavvisar per «indovinare».33 F. Botturi, Tempo, linguaggio e azione. Le strutture vichiane della storia ideale eterna, Napoli, Guida, 2001, pp. 25-26.
12
cruciale anche verificare come la divinazione in quanto prima scienza, cioè scienza
che fonda la socialità, sia qualcosa che fa appello alla coscienza. La divinazione si
mostra quindi come modalità con cui può essere pensata la politica da un punto di
vista etico34.
È chiaro che, allora, la lotta mitopoietica dei famoli ha tutti i caratteri della
divinazione in quanto atto politico e poetico che riguarda il futuro. È politico perché,
in Vico, la forma dell’ingiustizia è essenzialmente il mancato riconoscimento
dell’uguaglianza naturale, che significa la non partecipazione alla creazione di un
ordine giusto, sia per quanto riguarda i diritti di proprietà, al centro dell’interesse
vichiano, sia per quanto riguarda la partecipazione alla gestione dello Stato35. È
poetico, mitopoietico, perché si esprime attraverso una logica poetica. È una forma di
creazione di mitologie che passa dall’elaborazione della teoria del carattere doppio e
culmina nella figura di Solone, che esorta la moltitudine ateniese a riconoscersi di
uguale natura con i nobili. La narrazione mitica come i rituali che ad esso sono legati,
prima fra tutte la divinazione, articolano quindi la dimensione temporale tanto nel
34 Il termine «etica» non compare nella Scienza Nuova. Vico parla esclusivamente di «morale». Tuttavia, da Hegel inpoi, il termine morale assume un carattere astratto e soggettivistico estraneo a Vico, per cui la «morale» non è maiqualcosa che prescinde dal «senso comune» determinato storicamente. Vedi, su tutte, le degnità XI «L’umano arbitrio,di sua natura incertissimo, egli si accerta e determina col senso comune degli uomini d’intorno alle umane necessità outilità, che son i due fonti del diritto naturale delle genti» e XII: «Il senso comune è un giudizio senz’alcuna riflessione,comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il gener umano» G.B. Vico,Scienza Nuova (1744) cit., par. 142. La scelta di usare, in questo intervento, il termine etica non intende prendersi caricodella riflessione hegeliana, ma ha certamente l’intenzione di evidenziare il carattere non astrattamente individualisticodella «morale» di Vico. Il riferimento hegeliano è alla filosofia del diritto, parte seconda «la moralità» e terza«l’eticità». 35 Com’è noto sono due le forme politiche in grado di prendersi carico della uguaglianza naturale dell’uomo lamonarchia e la repubblica popolare: «I terzi sono governi umani, ne’ quali, per l'ugualità di essa intelligente natura, laqual è la propia natura dell'uomo, tutti si uguagliano con le leggi, perocché tutti sien nati liberi nelle loro città, cosìlibere popolari, ove tutti o la maggior parte sono esse forze giuste della città, per le quali forze giuste son essi i signoridella libertà popolare; o nelle monarchie, nelle qual’i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi, e, avendo essisoli in lor mano tutta la forza dell’armi, essi vi sono solamente distinti in civil natura». Sull’interesse vichiano i diritti diproprietà e la loro funzione strutturante dei rapporti sociali vedi M. Montanari, Vico e la politica dei moderni, Bari,Palomar, 1995, p. 193.
13
passato quanto nel futuro. Riflettere sul processo narrativo interno alla logica poetica
attraverso cui agiscono i famoli, è di enorme importanza perché permette di
comprendere come essa costituisca un principio unificatore del binomio
teologia-politica36. Vico spiazza la dicotomia teologia/politica sottolineando l’origine
comune fra politica e religione, collegando quest’ultima ad una facoltà, quella di
immaginare, che è centrale nell’antropologia vichiana37. La teologia civile vichiana è
dunque lo studio degli elementi che costituiscono la fondazione dello stare insieme. È
importantissimo notare che l’intuizione di Vico è di staccare tale studio da qualsiasi
religione positiva particolare. Ciò che Vico immagina è un ambito antropologico che
riguarda il nesso trascendenza-futurologia-immaginazione-comportamento
etico-azione politica che non viene mai meno. Tale nesso è testimoniato dalle
numerose volte che Vico avanza considerazioni etimologiche, dando sovente
sfumature leggermente, ma significativamente, differenti che mettono in evidenza
diversi aspetti del divinari.
Il primo aspetto messo in evidenza è la contiguità di futurologia e trascendenza:
«La divinazione, dalla qual appo i gentili tutti incominciarono le prime divine
cose (…) fu universalmente da tutto il gener umano dato alla natura di Dio il nome di
‘divinità’ da un’idea medesima, la quale i latini dissero ‘divinari’, ‘avvisar l
36 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 2. Su questo alcune considerazioni interessanti si trovano in B. De Giovanni, La «Teologia civile » di G. B. Vico, in «Il Centauro» 2, 1981, pp. 12-22. In particolare è da tenere sempre presente la considerazione dell’infondatezza della teologia come ambito a sé stante cfr pp. 14-15. Vedi anche M. Vanzulli, La Scienza Nuova e lo spirito dell’Idealismo, Milano, Guerini, 2003, pp. 34-44.37 Vedi il testo, ormai un classico della letteratura secondaria vichiana, D. P. Verene, Vico’s Science of Imagination, Ithaca, Cornell University Press, 1981, tr. it. di F. Voltaggio, Roma, Armando, 1984. Un altro testo rilevante è G. Cacciatore, - V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo, M. Sanna, (a cura di), Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico nella riflessione filosofica contemporanea, Napoli, Guida, 2004.
14
‘avvenire’»38. Già qui Vico individua la comune radice etimologica fra idea di
dio-divinità e la divinazione. Più avanti l’identificazione, è condotta in maniera
ancora più esplicita. Gli antichi credevano «che la natura fusse la lingua di Giove; la
scienza della qual lingua credettero universalmente le genti essere la divinazione, la
qual da ‘ greci ne fu detta ‘teologia’, che vuol dire ‘scienza del parlar degli dèi’»39.
Il secondo aspetto è quello etico-morale che emerge ben presto sotto forma di
interrogazione sulla coscienza: «La Provvedenza fu appellata ‘divinità’ da ‘divinari’,
‘indovinare’, ovvero intendere o ‘l nascosto agli uomini, ch’è l’avvenire, o ‘l
nascosto degli uomini, ch’è la coscienza»40. In maniera ancora più esplicita Vico
identifica, nel mondo gentile, «la scienza del bene e del male» con la divinazione41.
Nel cruciale paragrafo 365, in particolare Vico ricostruisce il processo dalla scienza
omerica delle muse, appunto scienza del bene e del male, alla scienza dei cristiani del
«vero bene e del vero male». Al di là delle possibili riflessioni che implicherebbe
questo riferimento alla verità, è importante notare che la sapienza conserva, per Vico
il carattere etico, perché deve riferirsi al bene dei popoli e deve essere «volgare»
ossia politica42.
L’elemento politico emerge, con ancor maggior forza, nel momento in cui Vico
illustra la «sapienza volgare», ossia la sapienza dei fondatori di nazioni. La «scienza
in divinità d’auspìci» infatti, «fu la sapienza volgare di tutte le nazioni di
38 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 9.39 Ivi, par. 379.40 Ivi, pag. 342.41 Ivi, parr. 365-381.42 L’equivalenza più chiara fra sapienza volgare e politica è quando Vico ricorda che la sapienza degli antichi fusapienza volgare di legislatori che fondarono il gener umano, non già sapienza riposta di sommi e rari filosofi. Ivi , par.384.
15
contemplare Dio per l’attributo della sua provvedenza, per la quale, da ‘divinari’, la
di lui essenza appellossi divinità. E di tal sapienza vedremo appresso essere stati
sappienti i poeti teologi, i quali certamente fondarono l’umanità della Grecia»43.
Ragione e divinazione
Rimane ancora una questione, forse la più importante, da affrontare. Cosa accade
quando la ragione, nel corso delle nazioni, tende a prendere il posto di tali capacità
divinatorie? Che cosa succede quando, ed è un esito storico che cominciava a
delinearsi chiaramente all’epoca di Vico, religione e politica tendono a separarsi
ovvero quando la direzione del pensiero europeo era chiaramente indirizzato a
elaborare una fondazione della politica privata di ogni riflessione religiosa e
teologica? È possibile considerare chiuso il problema etico e morale dello stare
insieme? Il tentativo di rispondere a queste domande, che mi sembrano delle
importanti sorgenti carsiche che scorrono all’interno della Scienza Nuova, è uno dei
drammi della filosofia vichiana.
La risposta è, mi pare, decisamente negativa. Persino l’uguaglianza non è affatto il
grimaldello che serra la porta della politica, mettendola al riparo dalla necessità di
pensare continuamente il giusto perché anch’essa, se non accompagnato dal divinari,
può essere anche ciò che conduce all’atomizzazione, e perciò alla barbarie e al
ricorso. L’importanza delle facoltà divinatorie è quella di costituire una sorta di
43 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 365.
16
antidoto contro il formalismo delle soluzioni utilitaristiche, contrattualistiche,
giusnaturalistiche, che spoliticizzano proprio queste domande etiche.
È chiaro che, nell’età della ragione, un’arte divinatoria fondata sugli auspici, ossia
sulla lettura dei «segni sensibili» dati da dio, non avrebbe senso. Ma la facoltà di
divinare ossia di agire eticamente secondo un’immagine del futuro è, deve essere,
sempre presente. Rimane sempre la necessità di svolgere le funzioni divinatorie:
l’interrogazione sul futuro e sulla coscienza, la necessità, in altre parole, di una
«scienza del bene e del male.
Per argomentare questa posizione è necessario abbandonare la prospettiva
filologica-letterale per comprendere il funzionamento teorico degli elementi posti
finora. Metteremo in evidenza alcune categorie del pensiero di Vico, cercando di
identificare in esse la natura prettamente divinatoria.
Per dimostrare la permanenza della divinazione è necessario in primis riferirsi alla
degnità XXIV, in cui si afferma che, mentre la religione ebraica fu fondata dal vero
Dio sul divieto della divinazione, le nazioni gentili si fondarono proprio sulla
divinazione44. Già qui possiamo rintracciare la radice della nostra argomentazione. Se
la divinazione è la scienza del bene e del male, ovvio che non possa trovare spazio
presso il popolo cui Dio aveva rivelato la vera, quindi giusta, legge. Ma nelle nazioni
non ebraiche la riflessione sul bene e sul male non poteva essere evitata. Quando dio
tace, è l’uomo (ma di certo non l’uomo astratto liberale, ma sempre l’uomo poeta
concreto e immancabilmente politico di Vico) che deve farsi carico di questa
44 Ivi, par. 167.
17
riflessione. Il problema della fondazione della forma politica emerge allora in tutta la
sua rilevanza. Come sappiamo il problema si pone in Vico al di là di due soluzioni
fondamentali quella di un ordine naturale delle cose, e quello di un costruttivismo
razionalistico.
Con la caduta dal paradiso il vero, la vera giustizia, non è più raggiungibile
dall’uomo, se non con i mezzi, pur sempre provvisori e terreni della fantasia e della
filosofia. Se il popolo ebraico, in virtù del privilegio mosaico, può avere a
disposizioni un insieme di norme divine, quindi perfette, immutabili, e non a
disposizione dell’uomo, le nazioni gentili non solo possono, ma devono fare ricorso
alla divinazione per fondare e conservare una società. Di fatto, la specificità della
Rivelazione come orizzonte della legittimità politica scompare. Diventa superfluo, se
non addirittura impossibile, pensare con questo riferimento la giustizia e la verità
della forma politica. Dobbiamo precisare che non è questo un esito che Vico
sottoscriverebbe. Tuttavia emerge chiaramente che non c’è né una struttura
teleologica che pone come esito necessario dell’umanità la conversione al
cristianesimo, né una prospettiva assiologica che pone in posizione di evidente
superiorità la religione cristiana. La rivelazione non è essenziale: la fase umana si
espande anche a paesi non cristiano senza, apparentemente, risentirne. Certamente
Vico non può dirlo in maniera esplicita ma, di fatto, solo la storia sacra (ebrea) può
essere divinamente fondata. Da qui lo scarsissimo rilievo dato a Gesù Cristo45. Solo
da un punto di vista etnocentrico, che certamente non è quello di Vico che cerca
45 Lo segnalano opportunamente L. Amoroso, Lettura della Scienza Nuova di Vico, Torino, UTET, 1998, p. 45 e A. Battistini, Vico tra antichi e moderni, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 258.
18
invece la comune natura delle nazioni, la fase umana dipende dalla Rivelazione. Non
c’è un superamento delle «false religioni» in direzione, univocamente, della «vera
religione» cristiana. La fase umana, come mostra chiaramente la parte comparativa, a
dire il vero scarna, della Scienza Nuova non è in alcun modo relata al cristianesimo46.
Questa è la cornice entro cui va studiato il problema del divinari nella fase umana,
il cui studio è certamente ostacolato dalla propensione di Vico ad occuparsi
maggiormente delle altre due fasi. Stabilita questa cornice, possiamo enucleare alcuni
elementi che ci sembrano centrali per comprendere la natura del divinari nella fase
umana.
L’elemento centrale deve essere rintracciato nella funzione creatrice della
«parola»47. Come Dio crea attraverso la parola, anche l’uomo crea attraverso la
parola, in particolare la parola «immaginata divina» dei poeti teologi48. La
divinazione, come è emerso nelle pagine sopra, è una delle forme precipue del fare
umano precisamente la modalità che permette di fondare le nazioni. La continua
46 La parte comparativa in senso stretto si riduce al capitolo terzo del libro quinto DESCRIZIONE DEL MONDO ANTICO E MODERNO DELLE NAZIONI OSSERVATA CONFORME AL DISEGNO DE’ PRINCIPI DI QUESTA SCIENZA. G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 366., par. 1088-1096. Ciò vale, però, se ci limitiamo al comparativismo sincronico. Al contrario tutta la Scienza Nuova potrebbe essere considerata un esercizio di comparativismo diacronico. 47 È qui assolutamente da tenere conto della peculiarità delle teorie vichiane sul «linguaggio». Di fatto Vico, più che unafilosofia del linguaggio in senso stretto elabora una teoria dei segni, attraverso cui viene svolta non solo la funzione dicomunicare, ma anche di stabilire norme etiche e politiche. Ricordiamo, ad esempio l’ampiamento semantico deltermine nell'espressione «parole reali» che indica come nella prima umanità le cose erano usate, simbolicamente, comeparole. Celebre, a questo proposito l’aneddoto di Idantura re di Scizia: «Idantura, re degli sciti, ne’ tempi assai tardi(posta la loro sformata antichità, nella quale avevano vinto essi egizi, che si vantavano essere gli antichissimi di tutte lenazioni), con cinque parole reali risponde a Dario il maggiore che gli aveva intimato la guerra; che furono unaranocchia, un topo, un uccello, un dente d'aratro ed un arco da saettare. La ranocchia significava ch’esso era nato dallaterra della Scizia, come dalla terra nascono, piovendo l’està, le ranocchie, e sì esser figliuolo di quella terra. Il toposignificava esso, come topo, dov’era nato aversi fatto la casa, cioè aversi fondato la gente. L’uccello significava aver iviesso gli auspìci, cioè, come vedremo appresso, che non era ad altri soggetto ch’a Dio. L'aratro significava aver essoridutte quelle terre a coltura, e sì averle dome e fatte sue con la forza. E finalmente l’arco da saettare significava ch’essoaveva nella Scizia il sommo imperio dell’armi, da doverla e poterla difendere». G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit.,par. 435).48 Su questo parallelismo torneremo più avanti.
19
produttività della parola è alla base dell’esistenza del mondo delle nazioni. È di
cruciale importanza il motto homo non intelligendo fit omnia49. La prima parola non
serve a comprendere il mondo ma a crearlo a partire da se stessi, in quella mancanza
di punti di riferimenti tipica della prima umanità. E questa è a maggior ragione la
situazione a proposito di ciò che l’uomo non può mai pienamente intendere ossia il
nascosto degli uomini, la coscienza, e il nascosto agli uomini, il futuro. Queste
considerazioni sono essenziali in tutto e per tutto anche nella fase umana. La
divinazione, parte essenziale della logica poetica, riempie di senso le parole, non
senza una dose di arbitrio tutto politico. Privare la parola di questa facoltà significa
abbandonarsi ad un razionalismo sterile o all’ironia che, all’opposto della metafora,
svuota di senso le parole, facendone strumento della manipolazione e dell’inganno50.
Questo ci conduce ad un altro elemento essenziale, il ruolo della sapienza. La
funzione della sapienza, come abbiamo già visto, è strettamente legato a quella della
divinazioni proprio in relazione alla politica. I primi sapienti, si diceva, sono i poeti
teologi. La sapienza in cui eccellono è appunto quella della divinazione, scienza
«volgare» del bene e del male. Tale carattere della sapienza non va mai perduto,
come emerge in primis dalla frase che Vico inserisce proprio a chiusura della Scienza
Nuova: «Da tutto ciò che si è in quest’opera ragionato, è da finalmente conchiudersi
che questa Scienza porta indivisibilmente seco lo studio della pietà, e che, se non
siesi pio, non si può daddovero esser saggio»51. È importante ricordare cosa implica
49 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 40550 Ivi, par. 410.51 Ivi, par. 1112.
20
per Vico il riferimento alla pietà: «La morale poetica incominciò dalla pietà,
perch’era dalla provvedenza ordinata a fondare le nazioni, appo le quali tutte la pietà
volgarmente è la madre di tutte le morali, iconomiche e civili virtù; e la religione
unicamente è efficace a farci virtuosamente operare, perché la filosofia è più tosto
buona per ragionarne. E la pietà incominciò dalla religione, che propiamente è timore
della divinità»52. La sapienza viene di nuovo connessa alla pietà, alla dimensione
etica dello stare insieme, esattamente come avveniva con i poeti teologi. Con un gesto
che mi pare di poter considerare tipicamente vichiano la «fine» mostra la sua
prossimità con l’inizio, lo studio dell’arcaico rimanda ad una più profonda
consapevolezza del contemporaneo.
Credo che sia proprio questa la sapienza che interessa a Vico. Non è assolutamente
un caso che Vico, senta il bisogno di una nuova scienza che riprenda lo studio della
pietà, non astrattamente o per puro spirito di carità, ma in virtù della fondamentale
importanza politica che riveste. Anche questa esigenza, mi pare, trae la sua origine
teologico-politica nella separazione fra ebrei e gentili, che assume qui una
dimensione che potremmo definire performativa. È la radicale assunzione di
un’assenza dell’ordine divino, almeno in un senso che sia direttamente utile per
l’uomo, e la necessità della riflessione sulla pietà ossia sui valori etici della comunità.
La divinazione è la socializzazione, meglio ancora bisognerebbe dire politicizzazione,
della pietà e della giustizia. Ciò è particolarmente evidente nella prima umanità
quando il giusto «ministrato» attraverso la legge agraria è frutto del consiglio degli
52 Ivi, par. 503.
21
eroi con gli dei tramite gli auspici53. Come già abbiamo accennato in precedenza,
nella fase umana tutto questo diventa narrazione mitologica che mette in forma non
solo le rivendicazione della plebe ma anche, direi, la loro stessa capacità di agire54.
La domanda centrale è «da dove viene il giusto nell’età umana»? Vico a questa
domanda, che pure si pone al centro del pensiero vichiano, non risponde chiaramente,
ma possiamo cercare di capire il punto pensando «in negativo», ossia a quando si
verifica l’assenza della giustizia e della pietà. Questo ci porta all’ultimo elemento,
ossia il ricorso della barbarie. La natura della barbarie della riflessione mostra, infatti,
in negativo, l’importanza del divinari.
Il citato richiamo finale alla pietà, che segue di pochi paragrafi l’icastica
descrizione dell’ «ultimo civil malore», è inequivocabilmente un invito a conservare
un atteggiamento pio. Ciò che Vico più teme, come sappiamo, è la ragione staccata
dalla pietà: sono «audacia ed empietà» che portano alla rovina le nazioni55. Anche
l’utile, pur forza fondamentale per comprendere lo stare insieme degli uomini, non
può essere inteso come calcolo individuale che prescinde da motivazioni di carattere
etico. Il meccanismo provvidenziale (e che l’uomo può far inceppare, seppur
provvisoriamente) e che permette che l’utile possa effettivamente funzionare come
collante della società è proprio questa utilità eticamente ed intersoggettivamente
intesa. L’utilità «buona» cui Vico fa riferimento non è mai quella del singolo
53 Ivi, par. 51654 Su questo punto sono da tenere presenti le riflessioni della scuola di Francoforte su Vico. In particolare Horkheimer.M. Horkheimer, Anfange der burgerlichen Geschichtsphilosophie, Stuttgart: Verlag von W. Kohlhammer, 1930; tr. it diG. Backhaus , Torino, Einaudi, 1970 Un saggio molto interessante sul tema è J. Mali, Retrospective Prophets. Vico,Benjamin and Other German Mythologists. «Clio» 26 (1996), 4, pp. 427- 448.55 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 504.
22
direttamente, ma è sempre «filtrata» da una fedeltà nei confronti di un gruppo,
famiglia, ordine, nazioni, umanità stessa56. È importante notare che questa fedeltà è
prettamente politica e indica la percezione di un interesse comune. Questo è un
elemento da tenere sempre presente e che Vico fa risaltare ulteriormente quando,
riferendosi al sistema politico greco, osserva che «‘n tali ragunanze pubbliche le
menti degli uomini particolari, che son appassionate ciascuna del propio utile, si
conformavano in un ‘idea spassionata di comune utilità»57. L’etica dell’utile pubblico
viene così ricondotta ad una dimensione politica, che sembra perdersi già sotto le
monarchie, quando «son i sudditi comandati d’attender a’ loro privati interessi e
lasciare la cura del pubblico al sovrano principe»58). I problemi per il mantenimento
dell’utilità cominciano quando i cittadini cominciano a guardare ai loro privati
interessi, e per privato si intende essenzialmente «individuale», non curandosi più
dell’utile pubblico59.
È questa la barriera insormontabile che separa Vico dal razionalismo di gran parte
della modernità ed è qui che la politica stessa si separa dalla possibilità di una
chiusura razionale completa. La razionalità serve, Vico è ben lungi dal negarlo, ma
non può tutto. È quando la natura fantastica della divinazione, e quindi dell’etica,
viene svelata dalla riflessione che si rischia la barbarie della riflessione, di cui è di
capitale importanza spiegare la natura appunto riflessiva. Essa si oppone direttamente
alla divinazione, a quella facoltà mitopoietica che esalta il conosci te stesso come
56 Ivi, par. 341.57 Ivi, par. 1041.58 Ivi, par. 951.59 Ivi, par. 1008.
23
essere parte di un gruppo di cui si condivide il «destino» cioè il divenire.
Posti tutti gli elementi, è chiaro che l’importanza del divinari sta nel suo essere
capacità di porre il problema etico-politico della convivenza attraverso un atto
fondato nella dimensione del potere, ma che mantiene una ineliminabile dimensione
linguistica. Solo il linguaggio, in particolare il linguaggio poetico, si può porre il
problema della coscienza e del futuro, come si nota anche dal fatto che l’«avvenire»
è sempre legato al verbo «indovinare». È per questo che Vico pone questa
importanza nel linguaggio e condanna fermamente l’ironia, la svalutazione del punto
di vista della «verità» e che «salva sempre la propietà delle parole e l’indifferenza
delle azioni» e facendo nascere una «falsa eloquenza, apparecchiata egualmente a
sostenere nelle cause entrambe le parti»60.
In ultima analisi, è questa la sapienza poetica della divinazione che Vico vuole
salvare: l’uso della facoltà pratica etica e politica di dare senso alle parole, in vista
della perpetuazione del gruppo sociale.
Una teologia politica moderna?
L’indagine che abbiamo effettuato sulla presenza della divinazione e del divinari
nella Scienza Nuova porta ad un ‘interpretazione dell’idea di teologia civile, che trae
la sua ragion d’essere dalla separazione fra storia sacra e storia gentile. Come la
teologia politica della modernità, anche quella di Vico è un tentativo, in questo
60 Ivi, parr, 823 e 1102
24
assolutamente moderno, di de-naturalizzare l’ordine politico, reso non più dipendente
da un ordine divino. Tuttavia la strada percorsa da Vico si differenzia in maniera
radicale da quella cartesiano-hobbesiana-giusnaturalistica perché ciò che Vico
recupera è proprio ciò che la modernità, almeno quella parte, vuole eliminare in
quanto pericoloso, dal dibattito politico e che, certamente non a caso, sono gli
elementi chiave della divinazione: la coscienza, con la separazione di foro interno e
foro esterno, e il futuro. Non è certamente un caso che la genesi dello stato sia
accompagnata dalla lotta della ragione contro la profezia61. Ciò non significa,
naturalmente, auspicare un ritorno dei profeti, e non stiamo sostenendo una lettura
irrazionalista di Vico. Il pensiero presentato da Vico nella Scienza Nuova richiede uno
studio ragionato degli elementi che la invece la modernità esclude dall’ambito della
riflessione razionale politica: la coscienza, la riflessione sul bene e sul male e il
futuro62. Vico, quindi, pur rifiutando l’esito razionalistico del giusnaturalismo, prende
completamente carico del problema moderno della perdita dell’ordine. Vico è
assolutamente disposto a porsi su un piano umano, un piano in cui l’ordine divino
della Res publica christiana è finito per sempre. La separazione fra ebrei e gentili
pone, in maniera irreversibile, la necessità di fondare umanamente l’ordine.61 R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979, tr. it. di A. Marietti Solmi, Genova, Marietti, 1986, pp. 18-19. Il più radicale critico della profezia è probabilmente Thomas Hobbesche dedica il trentaseiesimo capitolo del Leviatano a depotenziare l’impatto politico del profetare, sostenendo che, in ultima istanza, è il sovrano che decide dell’autenticità della profezia. Segnaliamo solo un passaggio in particolare che misura la distanza fra Hobbes e Vico: «Profeti furono non solo coloro che erano portavoce di Dio (…) ma anche tutti quegli impostori che pretendono – o con l’ausilio di spiriti familiari o con la divinazione [consistente nella] superstiziosa [considerazione] di eventi passati di predire, a partire da cause false, eventi analoghi nel tempo a venire».
T. Hobbes, Leviathan or the matter, forme and power of a common wealth ecclesiasticall and civil, London, 1651, tr. it., di A. Pacchi, Roma-Bari, Laterza, 199611, p. 345.
62 Chi ha avanzato questa critica in maniera radicale alla modernità è Leo Strauss. La scienza politica moderna esclude apriori la possibilità di quella che Strauss considera «la questione fondamentale», ossia la riflessione sul bene e sulla giustizia. Un testo chiaro ed esauriente è L. Strauss, Natural rights and history Chicago, Chicago University Press, 1953. Sul tema vedi le riflessioni di M. Farnesi Camellone Giustizia e storia. Saggio su Leo Strauss, Milano, Franco Angeli, 2007.
25
Il tentativo di Vico è di pensare la necessità di una riflessione morale ed etica e la
natura artificiale della politica, escludendo, di fatto, ogni fondazione metafisica
dell’ordine (al modo medievale) ma anche una fondazione razionale e formale del
politico (al modo moderno). La riflessione vichiana si interseca, quindi, in maniera
potente con la teologia politica moderna e in particolare con il tema della
secolarizzazione63. Apparentemente, nessun autore potrebbe essere più lontano
dall’intenzione di «secolarizzare» la politica. Tuttavia l’approccio vichiano al
problema dei rapporti fra politica e religione sposta il piano del discorso, rendendolo
irriducibile ad un discorso “classico” sulla secolarizzazione. Sarebbe fuori luogo
occuparsi dell’infinito dibattito sul tema e su quello della teologia politica della
modernità e ci limitiamo qui a segnalare solo un punto, che ci è utile per concludere
l’argomentazione.
Accennavamo prima all’importanza della parola come creazione. Questa è una idea
di chiara ascendenza ebraica, ed è Vico stesso a segnalarlo: «lógos o ‘verbum’
significò anche ‘fatto’ agli ebrei»64. L’equivalenza fra «parola» e «fatto» è di
cruciale importanza per Vico. In apertura del capitolo sulla logica poetica Vico
presenta, in una vertiginosa esposizione, la sequenza logos-favella-favola
(mito)-verbum-fatto. Vico crea così un ambito semantico in cui creazione, narrazione
e fatto, si intrecciano grazie all’ingegno, reso aguzzo dalla topica, in particolare
63 La letteratura sul dibattito sulla secolarizzazione è infinito. Fra le pietre angolari del dibattito l’approccio più utile dalpunto di vista di questo saggio sono i testi di , H. Lubbe, Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs,Freiburg-München, 1965 tr. it. di P. Pioppo, Bologna: Il Mulino, 1970, K. Löwith, Meaning in History, Chicago, TheUniversity of Chicago, 1949; tr. it. di F, Tedeschi Negri, Milano, Il Saggiatore, Milano 2004, oltra a quelli citati aproposito della teologia politica nella nota 1 di questo testo. Un interessante lettura in lingua italiana è senz’altro G.Marramao, Potere e secolarizzazione, Roma, Editori Riuniti, 1983.64 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 401.
26
grazie dalla topica sensibile che permise ai primi uomini di unire «le propietà o
qualità o rapporti, per così dire, concreti degl’individui o delle spezie, e ne formavano
i generi loro poetici» permettendogli così di «ritruovare tutte le cose necessarie
alla vita umana»65. È esattamente la facoltà del divinari che si situa a questo
incrocio, ed è una facoltà analoga alla facoltà con cui Dio crea il mondo. A questo
proposito è interessante l’interpretazione che di Vico propone Sandra Rudnick Luft
nel suo Vico’s Uncanny Humanism. Il cuore della tesi che l’autrice sostiene è che
mentre, nel complesso, la modernità secolarizza la creatività di un dio ordinatore, un
Dio come intelletto originario, Vico pensa la creatività dei suoi primi uomini come
secolarizzazione, o sostituzione, della creatività linguistica del dio poeta66. Nella fase
umana è questa caratteristica che l’uomo deve mantenere, perché la sua caduta, e il
suo «erramento ferino» posteriore al diluvio, costituiscono una perdita radicale
dell’ordine e delle leggi divine, tale da richiedere, come osserva Luft, una ontologia,
perché l’ordine deve essere creato e non semplicemente rispettato67.
C’è certamente una simmetria fra la creazione divina, che dà legge e ordine al
mondo umano attraverso la rivelazione divina e la creazione umana che avviene
attraverso l’insieme di processi divinatori. Più in profondità si tratta della simmetria
fra Dio che attraverso la parola crea l’ordine naturale, e gli uomini che costruiscono,
inventano, un ordine umano. Il nesso pietà-giustizia-ordine, non può essere rimosso,
65 Ivi, parr. 495 e 498.66 S. Rudnick Luft, Vico s Uncanny Humanism.Reading the New Science between Modern and Postmodernʼ , Ithaca,
Cornell university press, 2003, pp. 8-9.67 Ivi, pp. 116-118. Un tesi in parte analoga, che però riconnette la capacità creativa, anche in relazione all’etica e all’origine della socialità, ad una tradizione umanista si trova in F. Botturi, L’etica narrativa di Giambattista Vico, in A. Lamacchia (a cura di) Metafisica e teologia civile in Giambattista Vico, Bari, Levante, 1992, vedi in particolare pp. 113-115.
27
secondo Vico, e in assenza di una diretta rivelazione divina, come per gli ebrei, è
affidato alla divinazione e le sue religioni. Nella fase umana essa deve essere oggetto,
secondo Vico, di una «teologia civile ragionata». In questo senso si può parlare di
secolarizzazione in Vico. Ad essere «secolarizzata» è la facoltà di creare un ordine,
che assume la forma divinatoria del «dire» un ordine morale ed etico.
L’impatto di Vico sull’idea di secolarizzazione è notevole. Da un lato egli fa della
secolarizzazione, intesa come passaggio di facoltà divine all’uomo, una condizione
esistenziale dell’intera umanità, fatta eccezione per gli ebrei. Dall’altro, non ponendo
queste facoltà pienamente nell’ambito del razionale, mortifica ogni pretesa della
razionalità di esaurire le potenzialità politiche dell’uomo.
Da tutto ciò emerge che interrogarsi sulla teologia civile di Vico, a partire dalla
figura della divinazione, può contribuire a comprendere la natura dell’eccedenza del
pensiero di Vico, che di fatto costituisce l’oggetto della sua teologia civile. Parlare di
una eccedenza arazionale non significa, è importante ribadirlo, dare una lettura
irrazionalistica di Vico. Con il termine arazionale dobbiamo indicare un ambito da cui
la ragione deve saggiamente ritrarsi, pena peccare di «audacia ed empietà». Nel
rapporto fra pietà e sapienza, perentoriamente affermato da Vico nell’ultima frase
della Scienza Nuova la necessità di una riflessione intorno all’eccedenza a-razionale
dell’ordine politico viene svelato definitivamente, dando una fondamentale chiave di
lettura retrospettiva. È la figura della divinazione che indica tale eccedenza che non
può (ed è una considerazione che appare in Vico anche, e forse soprattutto,
performativa) essere messa in discussione. A me sembra che siano questi gli elementi
28
cruciali della teologia politica vichiana, teologia che non sembra affatto
semplicemente, come invece sostiene Vico stesso, identificabile con la «nostra
teologia cristiana, mescolata di civile e di naturale e di altissima teologia rivelata»68.
È la sua stessa «teologia civile», che viene posta come «antidoto» alle teorie
giusnaturaliste e, più in generale, al rischio del ricorso69. Quando Vico rimprovera ai
pensatori giusnaturalisti di aver considerato la materia del diritto naturale
«incominciandola da metà in su» non sta rimproverando semplicemente di aver
mancato di considerare l’aspetto storico del diritto, e di aver fatto una semplice
astrazione, ma sta anche rimproverando ai giusnaturalisti di aver colto solo la metà
delle facoltà dell’uomo70. A Grozio rimprovera di aver concepito un sistema
professandone l ‘efficacia anche in assenza di ogni cognizione di Dio, ossia senza
alcuna cognizione della divinità provvedente71; a Selden contesta la supposizione che
tutte le norme morali siano state trasmessi dai gentili72; a Pufendorf contesta l’assenza
del principio di provvedenza73. Si badi: Vico non sta rimproverando l’assenza di un
riferimento alla religione rivelata ma all’assenza del riferimento alle facoltà
divinatorie, come si comprende anche dal rimprovero a Selden, sarebbe incapace di
capire la nascita del diritto a prescindere dalla legge mosaica. D’altronde è Vico
stesso che lo afferma chiaramente: «Laonde incominciamo a ragionare del diritto, che
prima nacque divino, con la propietà con cui ne parlò la divinazione o sia scienza
68 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 366. Vico riprende, pur modificandola, una tripartizione classica. M. Scattola, Teologia politica, cit. p. 18.69 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 385.70 Ivi, par. 394.71 Ivi, par. 395.72 Ivi, par. 396.73 Ivi, par. 397.
29
degli auspìci di Giove, che furono le cose divine con le quali le genti regolavano tutte
le cose umane, ch’entrambe compiono alla giurisprudenza il di lei adeguato
subbietto»74.
Non bisogna affatto confondere la teologia civile, questa teologia civile, con la
rimessa in circolo dell’idea di un ordine fondato sulla legge divina75. Questa mossa
infrangerebbe, di fatto, l’idea di una separazione fra ebrei e gentili, e quindi fra una
storia «sagra» e una «profana», per dirla in termini vichiani. In fin dei conti, la
presenza effettiva di una rivelazione immediatamente politica annullerebbe la
necessità e il senso stesso della Scienza Nuova76.
La «teologia civile ragionata» vichiana, in definitiva, è il corrispettivo simmetrico
della «divinazione» in quanto prima scienza. Come quest’ultima ha l’obbiettivo di
permettere l’uscita dalla barbarie, la teologia civile ragionata vichiana si prefigge lo
scopo di non far precipitare le nazioni nella barbarie della riflessione. Inoltre, cosa
più importante, sono i medesimi l’oggetto, la coscienza e il futuro, e lo scopo, dare
conto della dimensione etica e politica arazionale dello stare insieme. D’altro canto
ciò è coerente con una delle più celebri affermazioni di Vico: «Natura di cose altro
non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise»77. Infatti la natura della
74 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744) cit., par. 398. 75 Questa è la tesi, ad esempio, di Mark Lilla. M. Lilla, G. B. Vico: the Making of an antimodern. Cambridge – Mass –London, Harvard university press, 1993. Sull’interpretazione di Lilla vedi Interculturalità: religione e teologia politica,G. Cacciatore – R. Diana (a cura di), Napoli, Guida, 2010. Nel saggio che apre il volume Lilla presenta la suainterpretazione della teologia politica vichiana, flettendola fin quasi a sovrapporla ad una idea di teocrazia. SecondoLilla la teologia politica deriva i suoi principi dal nesso divinamente rivelato fra Dio, l’uomo e il mondo. Vedi M. Lilla,Il «ricorso» della teologia civile, in ivi p. 44. 76 Il problema che si pone è che non è chiaro se la cultura cristiana sia l’erede di quella ebraica, o di quella «gentile». Lalettera del testo va certamente nella prima direzione, ma il fatto che la civiltà europea, anche dopo la nascita di Cristo,sia soggetta ai processi di sviluppo storico come tutte le culture gentili ed extraeuropee fa propendere per la secondainterpretazione. Soprattutto, da una prospettiva di storia sacra sarebbe impensabile la figura del ricorso che Vicoconsidera non solo nella sua dimensione teorica ed eventuale, ma anche storicamente accaduta durante il medioevo.77 Come molte delle Degnità, anche su questa potrebbero essere scritti interi volumi. Qui ci limitiamo a considerare una
30
nazioni gentili è segnata indelebilmente, pur con le (quasi) infinite combinazioni
pratiche, dalla assenza di leggi divine e dalla presenza della divinazione.
nota di Battistini: «L’universalità della natura non riposa sul suo essere assoluta e immutabile, bensì sull’essere identica in tempi e circostanze ipoteticamente uguali, e di fatto diversa in tempi e circostanze effettivamente differenti». Nota 3 di pag. 500
31