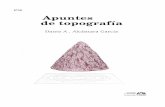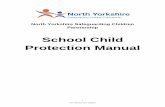Elementi di Topografia cristiana delle contee del Northumberland, del Durham e dello Yorkshire...
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Elementi di Topografia cristiana delle contee del Northumberland, del Durham e dello Yorkshire...
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Scienze dell’Archeologia e Metodologia della ricerca
Storico – Archeologica
Tesi in Archeologia Cristiana
Elementi di Topografia cristiana delle contee del Northumberland, del
Durham e dello Yorkshire
Relatore: Candidato:
Prof. Danilo Mazzoleni Canali Luca
Correlatore: Matricola: 267639
Prof.essa Myla Perraymond
Anno Accademico 2011-2012
2
PREMESSA
Questo lavoro vuole essere uno spunto per approfondire gli studi su una
regione dell’orbis christianus antiquus poco conosciuta, ma che potrebbe
offrire diversi spunti di riflessione: l’antico regno di Northumbria, del quale si
prendono in esame le attuali contee del Northumberland, del Durham e dello
Yorkshire.
La ricerca si spinge fino al primo decennio dell’VIII secolo, un periodo
del tutto anomalo per quanto riguarda l’archeologia cristiana ma, come si
vedrà, tale scelta è stata determinata da diversi fattori tra cui, il principale, è lo
sviluppo tardo della religione cristiana in questi luoghi e il lungo processo che
ha l’ha portata ad essere accettata dalle popolazioni che si insediarono in
Britannia, occupando il vuoto di potere lasciato dall’abbandono della provincia
da parte dei Romani.
La ricostruzione storica e topografica è stata possibile grazie allo studio
dell’opera del Venerabile Beda Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, la
quale, spesso con dovizia di particolari, ricostruisce la nascita e il
consolidamento del Cristianesimo in Britannia, ma soprattutto della
Northumbria, sua patria d’origine.
Per quanto riguarda gli edifici, le fonti abbondano di riferimenti chiese
lignee, una modalità costruttiva portata dagli invasori sassoni, tutte innalzate
nei primi decenni del VI secolo ma di cui non sono mai state rinvenute tracce.
Intorno alla metà del VI secolo, gli edifici ecclesiastici vengono convertiti in
pietra, ma anche in questo caso, sono molto poche le chiese originali ancora in
3
piedi: la maggior parte, nel corso dei secoli, hanno ricevuto rimaneggiamenti
ed aggiunte che ne hanno nascosto l’aspetto più antico. Nonostante questo, il
numero di edifici cristiani è molto alto, segno che la cristianizzazione ebbe uno
sviluppo capillare ed impulso straordinario proveniente sia dai sovrani
convertiti, sia dai monaci e missionari provenienti dal continente e dalla vicina
Irlanda.
Il lavoro presenterà, nei primi due capitoli, una panoramica storica della
provincia romana della Britannia e della formazione e sviluppo del regno di
Northumbria fino ai primi decenni dell’VIII secolo e dell’avvento del
Cristianesimo sull’isola e delle vicende riguardanti la Chiesa northumbriana.
Nel terzo e nel quarto capitolo si passerà in rassegna delle evidenze
archeologiche sia per quanto riguarda l’epoca romana che l’aspetto principale
di questo elaborato, ovvero gli edifici cristiani.
Nell’ultimo capitolo verrà proposta una lettura e interpretazione di un
oggetto che rappresenta l’apice della produzione artistica e del sincretismo
culturale e cultuale presente nella regione.
4
I.STORIA DELLA PROVINCIA
I.1 PRIMA DI ROMA
Abitata fin dal Paleolitico inferiore (giacimenti di Clacton-on-Sea,
Hoxne, Swanscombe), la Gran Bretagna si stacca dal continente nel 6000-5500
a.C., con il passaggio dalla fase climatica boreale a quella atlantica.
Nel corso del IV millennio a.C. i primi agricoltori neolitici elaborarono
la cultura di Windmill Hill, caratterizzata dalla presenza dei monumenti
megalitici.
Mentre nel III millennio fiorisce la “cultura del bicchiere
campaniforme”, nel millennio successivo viene sostituita dalla “cultura
dell’Essex” (1800-1400 a.C). E’ questa la fase in cui si completa il più
impressionante monumento della preistoria britannica: Stonehenge1.
Dopo una fase di stasi culturale, nel IX-VIII secolo a.C. si avvia
l’immigrazione dei popoli celtici dal continente, che si fa più massiccia nel V
secolo a.C., e che attorno al 250 a.C., con l’arrivo dei Belgi, dà l’avvio alla
cultura di La Tène insulare2.
1 Mallory 1997 Beaker Culture (s.v.), in Mallory-Adams 1997.
2 Simon-Rig 1997, pp.35-40.
5
Diodoro Siculo, nel I secolo a.C., introdusse la forma Πρεττανια3,
mentre Strabone4 utilizza la forma Βρεττανία. I Romani usarono poi il nome
"Britannia" per tutta l'isola, compreso il territorio a nord del Vallo di Adriano.
Brittannia, o Brittānia, era il nome con il quale i Romani indicavano tale
territorio fin dal I secolo a.C. Dopo la conquista romana, avvenuta nel 43, il
nome fu utilizzato per indicare la provincia romana, che venne così ristretto
all'isola di Gran Bretagna (la porzione a sud del Vallo di Adriano).
I.2 La conquista romana (Fig.1)
Nel corso della guerra gallica, Cesare aveva compiuto incursioni in
Britannia, seppur non seguite da alcuna conquista: lo scopo era di acquisire
informazioni. La prima spedizione si ebbe nel 55 a.C.: le navi di Cesare
approdarono sulla costa del Kent ma, a causa di una tempesta che danneggiò la
flotta e della scarsità di cavalleria a sua disposizione, il generale tornò nelle sue
basi in Gallia.
L’esercito romano affrontò la seconda spedizione l’anno seguente con
forze militari più ampie, tentando di sottomettere le tribù britanne, o
invitandole a pagare tributi e a dare ostaggi per avere la pace5. Cesare non fece
dunque conquiste territoriali, ma stabilì un sistema di clientele e portò almeno
parte della Britannia nella sfera d'influenza di Roma.
Ottaviano Augusto pianificò diverse invasioni nel 34, nel 27 e nel 25
a.C., senza però riuscire a portarle a termine per una serie di circostanze
3 Diodoro Siculo, Bibliotheca historica V 1-3.
4 Strabone, Γεωγραφικά, I 4.2.
5 Giulio Cesare, De bello Gallico, V 8-23.
6
sfavorevoli e così le relazioni tra la Britannia e Roma restarono di tipo
diplomatico (con ambasciatori inviati dai sovrani dei Britanni ad Augusto) e
commerciale (com'è dimostrato dall'attestazione di un aumento delle
importazioni di beni di lusso dall'Impero romano alla Britannia sud-orientale)6.
L'effettiva invasione romana della Britannia si ebbe solamente al tempo
dell'imperatore Claudio: nel 43 d.C. le forze romane, sbarcate nel Kent al
comando del generale Aulo Plauzio, sconfissero i Catuvellauni e i loro alleati
nelle due battaglie del Medway e del Tamigi. Uno dei loro capi, Togodumno,
fu ucciso, mentre il fratello Carataco sopravvisse, continuando a guidare la
resistenza. Raggiunto dall’imperatore in persona con dei rinforzi, Plauzio
marciò sulla capitale catuvellauna, Camulodunum (odierna Colchester),
conquistandola7. Su questo territorio venne creata una provincia, mentre
alleanze vennero strette con i popoli vicini, e Plauzio ne divenne il primo
governatore, carica che mantenne fino al 47, quando fu sostituito da Publio
Ostorio Scapula. Intanto il futuro imperatore Vespasiano sottometteva il sud-
ovest dell’isola8.
Conquistata la parte meridionale della Britannia, i Romani rivolsero la
loro attenzione al Galles, ostacolati dai Siluri, dagli Ordovici e dai Deceangli
che si opposero però strenuamente agli invasori, catalizzandone gli sforzi
militari. A capo dei Siluri si pose Carataco, che condusse una vera e propria
guerriglia contro le truppe del governatore Publio Ostorio Scapula, il quale,
però, sconfisse il leader britanno nel 51 e lo costrinse a rifugiarsi allora presso
Cartimandua, regina dei Briganti, la quale provò la sua fedeltà ai Romani
consegnandolo.
Nonostante la cattura del loro capo, i Siluri, ora guidati dall'ex marito di
Cartimandua, Venuzio, continuarono ad opporsi9.
6 Ottaviano Augusto, Res Gestae, 32; Strabone, Γεωγραφικά, IV, 5; Cassio Dione, Historia romana, LI, 38,
LIII 22, 25. 7 Cassio Dione, Historia romana LX, 19-22.
8 Svetonio, De vita Caesarum, Vespasianus, IV.
9 Tacito, Annales XII, 31-38.
7
Il comportamento vessatorio dei magistrati romani, il tentativo di
impadronirsi dell’isola di Mona, sacra al culto druidico, le eccessive pretese
dei sacerdoti del tempio di Claudio a Camulodonum, determinarono la rivolta,
a capo della quale fu Boudicca, regina degli Iceni (nel 60) 10
. I Trinovanti e i
Catuvellauni si unirono agli Iceni, assalendo e distruggendo la colonia romana
di Camulodunum. Il governatore Svetonio Paolino, ancora occupato contro i
Siluri, raggiunse Londinium, su cui stavano marciando i rivoltosi. Constatando
però che la città era indifendibile con le truppe a sua disposizione, Paolino
l'abbandonò al suo destino, spostandosi a Verulamium (odierna St Albans).
Londinium fu distrutta e la popolazione massacrata. Con alcune legioni
Svetonio alla fine si scontrò coi nemici, sconfiggendoli nella battaglia di
Watling Street. Boudica morì non molto tempo dopo, o avvelenandosi o di
malattia11
.
Le città distrutte furono ricostruite e la capitale della provincia fu
spostata a Londinium. I problemi causati dalla rivolta risultarono di tale gravità
che Nerone pensò di ritirarsi dalla Britannia12
.
Successive turbolenze nell'isola ci furono nel 69, cioè nell'"anno dei
quattro imperatori". Davanti al disordine che si diffuse nell'Impero romano,
Venuzio dei Briganti scacciò l'ex moglie e assunse il controllo del nord del
paese. Dopo la salita al potere dell'imperatore Vespasiano, Quinto Petillio
Ceriale pose fine alla rivolta13
.
Negli anni successivi i Romani conquistarono buona parte dell'isola. Il
governatore Gneo Giulio Agricola, suocero dello storico Tacito, sottomise gli
Ordovici nel 77 e i Caledoni nell'83 nella battaglia del Monte Graupio
(nell'odierna Scozia del nord)14
. Poco dopo la vittoria, Agricola fu richiamato
10
Tacito, Annales, XIV, 29,30. 11
Tacito, Agricola, XIV-XVII; Tacito, Annales, XIV 29-39; Cassio Dione, Historia romana, LXII 1-12. 12
Svetonio, De vita Caesarum, Nero 18. 13
Tacito, Agricola, XVI-XVII; Tacito, Historiae I, 60 e III 45. 14
Tacito, Agricola, XVIII-XXXVIII.
8
in patria e i romani si ritirarono sulla linea del più difendibile istmo del Forth-
Clyde.
Quando Adriano raggiunse la Britannia durante il suo famoso viaggio
attraverso le province attorno al 122, dispose la costruzione di un vallum,
costruito fra la foce del Solway e quella del Tyne (Fig.2). L'imperatore dispose
che se ne occupasse il nuovo governatore Aulo Platorio Nepote, a cui fu
affidata una nuova legione proveniente dalla Germania inferiore: la VI Victrix,
che doveva sostituire la IX Hispana, della cui scomparsa si è molto discusso
tra gli storici moderni. I rilievi archeologici hanno poi dimostrato che, durante
questa prima metà del secolo, vi fu una notevole instabilità politica in Scozia.
Lo spostamento della frontiera più a sud dovrebbe essere considerata in questo
contesto.
Questa frontiera venne spinta verso l'istmo di Forth-Clyde a partire dal
regno di Antonino Pio, quando fu costruito un nuovo vallum più a nord di
quello di Adriano (142 circa). Ma una quindicina di anni più tardi, si ebbe una
nuova crisi (nel 155-157) quando i Briganti si rivoltarono e costrinsero le
armate romane a ritirarsi all'antico vallum Hadriani, sebbene questa ribellione
fosse stata inizialmente repressa dall'allora governatore, Cneo Giulio Vero. E
sembra che il confine del vallo di Antonino fosse rioccupato un solo anno più
tardi, ma abbandonato definitivamente nel 163-164. Negli anni che seguirono,
durante l'ultimo periodo del regno di Marco Aurelio, alcuni forti a nord del
vallo di Adriano furono rioccupati, come quello di Newstead ed altri sette di
minori dimensioni15
.
Nel 193, nella crisi seguita alla morte di Pertinace, il governatore della
Britannia Clodio Albino fu acclamato imperatore dalle sue truppe; ma poi,
dopo essersi alleato contro un altro pretendente, Pescennio Nigro, con Settimio
Severo, finì per soccombere proprio a quest’ultimo (197). Severo rinforzò le
15
Cassio Dione, Historia romana, LXXI, 16.
9
difese del limes britannico, dividendo la provincia in due nuove unità,
Britannia Superior e Britannia Inferior.
Nel III secolo vi furono momenti di grave crisi: negli ultimi decenni
emersero figure di usurpatori come Carausio e Allecto, ma la provincia si
mantenne sostanzialmente prospera. Diocleziano, dopo la sconfitta di Carausio
da parte di Costanzo Cloro nel 296, frazionò ulteriormente la provincia: la
Britannia Superior venne suddivisa in Britannia I e Maxima Caesariensis,
mentre la Britannia Inferior in Britannia II e Flavia Caesariensis (con
l’aggiunta della Valentia nel 369) facenti parte della diocesi della Britannia.
Nel IV secolo, sotto gli intensificati attacchi di Franchi, Pitti, Sassoni e
Scoti, la crisi della provincia cominciò ad aggravarsi fino alla drammatica
decisione dell’imperatore Onorio nel 410: l’abbandono delle truppe romane
dell’isola.
I.3 La Britannia post-romana (Fig.3)
Nel 407 le truppe, ancora restanti della guarnigione britannica, elessero
al trono imperiale l'usurpatore Costantino III. Questi si spostò, con tutte le
forze ancora disponibili nell'isola, al di là della Manica per fronteggiare
l'esercito inviatogli contro dall’imperatore d’Occidente Onorio, dal quale
venne sconfitto e ucciso nel 411. Dopo la partenza delle ultime guarnigioni
sembra che fossero gli stessi abitanti ad assicurare la difesa del territorio dalle
10
incursioni sassoni e il rescritto di Onorio, citato da Zosimo, se si riferisce alla
Britannia, confermerebbe questo stato di fatto16
.
Progressivamente si sostituirono ai funzionari e alle istituzioni romane
dei potentati locali di tipo feudale. Combattimenti tra diversi gruppi sono stati
interpretati come contrasti tra favorevoli o contrari all'indipendenza dall'impero
romano, ovvero tra seguaci della Chiesa romana e del pelagianesimo o, ancora,
come conflitti sociali tra contadini e proprietari terrieri legati all'élite urbana.
La vita quotidiana dovette comunque continuare pressoché invariata nelle
campagne e declinare nelle città, come sembra potersi constatare nel resoconto
della visita in Britannia di san Germano d'Auxerre17
.
Secondo Beda, che data l’avvenimento intorno al 446, il re Vortigen
avrebbe deciso di far arrivare dei mercenari sassoni a difesa dalle incursioni dei
barbari come foederati, secondo l'uso romano, stanziandoli "nella parte
orientale dell'isola"18
. In seguito, i Sassoni, accresciuti di numero da altri arrivi,
si sarebbero ribellati e si sarebbero dati al saccheggio. Sarebbero stati, quindi,
combattuti dal britanno-romano Ambrosio Aureliano, forse base storica per la
figura del re Artù e al quale è attribuita, da alcune, fonti la vittoria del monte
Badon19
, intorno all'anno 50020
.
L'avanzata sassone venne arrestata e i Britanni restarono in possesso del
Galles e della parte dell'Inghilterra ad ovest della linea che congiunge York e
Bournemouth, mentre i Sassoni controllarono il Northumberland, l'Anglia
orientale e la parte sud-orientale dell'Inghilterra. Gildas cita altri governanti
16
Thompson 1984, pp.303-18. 17
Costanzo, Vita sancti Germani, III (ed. Borius p.112) 18
Beda, HEA, I, XIV, 28-34 (ed. Lapidge, I p.67). 19
Beda, HEA , XVI, 6-12 (ed. Lapidge, I p.73); l’episodio di Ambrogio Aureliano e dell’assedio del Mons
Badonicus è ripreso da Beda direttamente da Gildas, De excidio Britanniae, 24. Sono state avanzate molte
proposte di identificazione per questa località (cfr. Wood in Lapidge-Dumville 1984, p.23). 20
Gildas afferma che la battaglia si sarebbe svolta "44 anni e un mese fa, nell'anno della mia nascita", quando si
può pensare che egli stese la sua opera nel 547 o prima. E questo porterebbe a datare lo scontro al 503 o poco
prima. Beda, estrapolando dal contesto le affermazioni di Gildas, ritiene la battaglia si svolse 44 anni dopo
l'arrivo degli Anglosassoni in Britannia (circa 449) e ciò porterebbe a datare lo scontro al 493 (per altri al 491).
Tale datazione è totalmente priva di qualsiasi consistenza storica. (cfr. Miller in “BBCS” XXIV, 1974-1976,
pp.169-174) .
11
britanni: Costantino di Dumnonia, Aurelio Canino, Vortipor della Demetia,
Cuneglasso e Maglocuno.
L'endemica tensione e le lotte violente di questo periodo, a cui alludono
tutte le fonti scritte, e il declino della produzione, riscontrabile nei dati
archeologici, dovettero tuttavia comportare una diminuzione della popolazione.
I dati forniti dalla dendrocronologia sembrano inoltre attestare che si ebbe un
periodo di clima più freddo e umido intorno al 54021
, che dovette contribuire al
calo della produzione agricola. Ad aggravare la situazione si aggiunse l'arrivo
nelle isole britanniche della “peste di Giustiniano” alla fine del VI secolo: non
è chiaro se questa epidemia fosse di peste bubbonica, la stessa che colpì
l'Europa nel XIV secolo, ma gli effetti sociali e culturali furono simili. Tale
morbo potrebbe aver avuto origine dall'Etiopia o dall'Egitto e essersi diffusa
verso nord fino a Costantinopoli, considerati anche i notevoli flussi di generi
alimentari, soprattutto grano, che provenivano dal nord-Africa. L’arrivo ai
porti britannici deve essere dovuta alle navi dei mercanti bizantini22
. La peste
influenzò anche la Guerra gotica (535-553), dando agli Ostrogoti la possibilità
di rafforzarsi durante la crisi degli avversari.
La battaglia di Dyrham, combattuta nel 577 tra il re sassone Ceawlin del
Wessex e i Britanni, avrebbe portato all'occupazione sassone di Cirencester
(Corinium), di Gloucester (Glevum) e di Bath (Aquae Sulis) e viene
considerata, non senza discussioni, l'episodio che portò alla separazione dei
Britanni del Galles da quelli del Devon e della Cornovaglia.
La data convenzionalmente, scelta dagli studiosi per la fine di questo
periodo, è il 597, anno in cui arriva sull’isola il monaco Agostino, primo
arcivescovo di Canterbury. Tale datazione, utilizzata per la parte finale del
periodo è arbitraria, perché la cultura postromana continuò nell'Inghilterra
occidentale e nel Galles.
21
Davey 2004, p.50. 22
Maddicott 1997, p.2.
12
I.4 Il regno di Northumbria (Fig.4)
La Northumbria fu in origine composta dai regni indipendenti della
Bernicia e della Deira, unificati da Aethelfrith, un sovrano della Bernicia, che
conquistò la Deira intorno al 60423
. Egli fu sconfitto e ucciso intorno al 616 in
una battaglia presso il fiume Idle da re Raedwald dell'Anglia orientale, che
mise sul trono Edwin, figlio del precedente re della Deira, Aella24
.
Edwin, convertitosi al Cristianesimo nel 627, divenne presto il più
potente re d'Inghilterra: venne riconosciuto come bretwalda25
e conquistò il
Rheged, l'Isola di Man e il regno di Gwynedd, nel Galles settentrionale. Sotto
tale sovrano il regno raggiunse la sua massima potenza ed estensione
(dall’Humber al Firth of Forth, includendo anche Edimburgo). Edwin fu
sconfitto da un'alleanza tra il re in esilio di Gwynedd, Cadwallon ap Cadfan, e
Penda, re della Mercia, nella battaglia di Hatfield Chase nel 63326
.
Dopo la morte di Edwin, il regno di Northumbria si divise nella Bernicia,
dove prese il potere Eanfrith27
, uno dei figli di Aethelfrith, e nella Deira, dove
divenne re un cugino di Edwin, Osric28
. Entrambi furono uccisi l'anno
seguente, nel corso della devastante invasione della Northumbria, condotta da
Cadwallon, re di Gwynedd. Dopo l'assassinio di Eanfrith, suo fratello Oswald,
23
Beda, HEA, I, XXIV, 15-21 (ed. Lapidge, I, pp.95-97). 24
Beda, HEA, II, XII, 95-103 (ed. Lapidge, I, p.241). 25
Il termine deriva dall'anglosassone bretanwealda, "signore di Britannia", riferendosi alle pretese di signoria
dei re sassoni sui Britanni. 26
Beda, HEA, II, XX, 9 (ed. Lapidge, I, p.269). 27
Beda, HEA, III, I, 5-8 (ed. Lapidge, II p.13). 28
Beda, HEA, III, I, 1-5 (ed. Lapidge, II p.13).
13
sostenuto da un contingente di Scoti inviato da re Domnal di Dal Riada,
sconfisse e uccise Cadwallon nella battaglia di Heavenfield del 63429
.
Re Oswald reintrodusse il Cristianesimo nel regno, affidando l'incarico
di convertire il suo popolo ad Aidan, un monaco irlandese originario dell'isola
scozzese di Iona. Ciò portò all'introduzione del cristianesimo celtico, in
contrapposizione al cristianesimo romano. A Lindisfarne fu fondato un
monastero, probabilmente sul modello di quello dell'isola di Iona.
La guerra contro la Mercia continuò: nel 642, Oswald fu ucciso dai
Merciani guidati da Penda nella battaglia di Maserfield. Nel 655 Penda lanciò
una massiccia invasione della Northumbria, aiutato dal sovrano vassallo della
Deira, Aethelwald, ma subì una pesante sconfitta per mano di un esercito meno
numeroso, guidato dal successore di Oswald, Oswiu, sul fiume Winwaed30
.
Questa battaglia segnò una svolta nelle sorti della Northumbria: Penda morì in
battaglia e Oswiu ottenne il controllo della Mercia, divenendo così il re più
potente d'Inghilterra.
Nell'anno 664 si tenne un grande sinodo a Whitby per discutere il
calendario delle celebrazioni pasquali. Erano infatti sorte parecchie divergenze
tra le pratiche della Chiesa celtica di Northumbria e i precetti della Chiesa di
Roma. Alla fine, la Northumbria fu persuasa a passare al Cattolicesimo, e il
vescovo Colman di Lindisfarne fece ritorno a Iona31
.
La Northumbria perse il controllo della Mercia verso la fine degli anni
'50 del VII secolo, a seguito di una rivolta guidata dal figlio di Penda, Wulfhere
re di Mercia. Ciononostante, la Northumbria riuscì a mantenere la sua
posizione di dominio fino a quando non subì una disastrosa sconfitta per mano
dei Pitti nella Battaglia di Nechtansmere del 685; il re di Northumbria,
Ecgfrith, figlio di Oswiu, fu ucciso, e il potere che il regno esercitava a nord fu
gravemente indebolito32
. Durante il periodo di pace che caratterizzò il suo
29
Beda, HEA, III, I, 36-37 ed. Lapidge, II p.15). 30
Beda, HEA III, XXIV, 17-35 (ed. Lapidge, II p.113). 31
Beda, HEA , III, XXV (ed. Lapidge, II pp.119-121). 32
Beda, HEA, IV, XXIV, 10-23 (ed. Lapidge, II p.293).
14
regno, Aldfrith33
, fratellastro e successore di Ecgfrith, riuscì a limitare i danni
subiti, ma è da questo momento in poi che il potere della Northumbria
cominciò a declinare, e un periodo di cronica instabilità seguì la morte di
Aldfrith, avvenuta nel 70434
.
Le invasioni vichinghe e scozzesi ridussero ulteriormente la
Northumbria a una contea, stretta tra i fiumi Tees e Tweed, ed essa rimase per
lungo tempo in una zona contesa tra i nascenti stati nazionali di Inghilterra e
Scozia. I conti di Northumbria mantennero un certo grado di indipendenza, ma
ci furono lunghi periodi di lotta per il controllo della contea.
33
Beda, HEA, 47 (ed. Lapidge, II p.295). 34
Kirby 2000, p. 145.
15
II. LA CRISTIANIZZAZIONE
II.1 La nascita del Cristianesimo in Britannia
Per quanto riguarda l’arrivo del Cristianesimo in Britannia, le notizie
non sono precise: Tertulliano35
e Origene attestano la presenza di cristiani
nell’isola nel III secolo, anche se Origene precisa che il loro numero era molto
esiguo. Beda36
dà notizia di un rex Britanniarum di nome Lucio il quale,
durante il regno di Marco Aurelio, avrebbe inviato un lettera a papa Eleuterio
chiedendo di poter divenire cristiano; grazie a questa concessione, tutti i
Britanni aderirono alla fede cristiana. Il monaco, però, riferisce due errori già
presenti nei documenti che consultò per il suo racconto: la data dell’invio,
ripresa da Orosio37
, è un improbabile 911 ab Urbe condita, ovvero il 156, data
nella quale l’imperatore regnante era ancora Antonino Pio; il secondo errore è
il genitivo Bittaniarum, presente nel Liber Pontificalis38
, dal quale Beda ricava
l’intero episodio: il Lucius rex Britannius del Liber altro non sarebbe che Lucio
re di Edessa in Siria (179-216, confermando almeno che la lettera fu inviata
35
Tertulliano, Adversus Iudaeos, VII. 36
Beda, HEA I, IV (ed. Lapidge, I, p.37). 37
Orosio, Historiae adversos paganos, VII 15, I . 38
Liber Pontificalis (ed. critica e traduzione di L.R.Loomis, Columbia University Press 1916, p.16).
16
durante il regno di Marco Aurelio) e Britannia è un errore per Britium (Birtha
Edissenorum), centro non distante da tale città39
.
Alla fine dell’ VIII secolo, l’arcivescovo di Magonza Rabano Mauro
riporta, nella sua Vita di Maria Maddalena40
, un racconto secondo il quale,
accompagnando in Francia le sorelle di Lazzaro, Giuseppe d’Arimatea avrebbe
proseguito poi fino alle isole britanniche, evangelizzandole intorno al 60.
Il primo martire della chiesa britanna di cui si ha notizia risale al regno
di Settimio Severo, anche se le notizie in nostro possesso non concordano fra
loro41
: Albano, un pagano convertito, decise di salvare un chierico che da lui si
era nascosto a causa delle persecuzioni, prendendone il posto42
. Il martirio
avvenne per decapitazione nella città di Verolamium (oggi St Albans, a nord-
ovest di Londra) e nella città venne innalzata, al principio del IV secolo, una
chiesa, i cui scavi hanno riportato in luce l’altare posto in corrispondenza del
luogo del martirio43
. Grazie a Gildas, si ha notizia di altri due martiri chiamati
Aronne e Giulio, morti durante la persecuzione dioclezianea ad Vrbs Legionum
(oggi Caerleon, nel Monmouthshire) 44
.
39 Colgrave-Mynors 1969, p.24 n.2.
40 Rabano Mauro, Vita della beata Maria Maddalena e di sua sorella santa Marta, a cura di A.
Azzolini (ed. Iannone 2006). 41
E’ la Passio Albani, scritta tra il V e il VI secolo, a datare il martirio a quest’epoca (ed. Sharpe
2001). Beda e Gildas, nel De Excidio Britanniae, riprendono una seconda redazione della Passio,
ponendo l’episodio alla persecuzione di Diocleziano. 42
Beda, HEA I, VII, 16-19 (ed. Lapidge, I p.43). 43
Biddle 1986 p.1-31. 44
Gildas, De Excidio Britanniae, I-X.
17
II.2 Lo sviluppo della Chiesa britanna nel V e VI secolo
Con la Pace della Chiesa, la Chiesa britanna sembra accrescere la sua
importanza: al Concilio di Arles del 314 partecipano ben tre vescovi, i quali
diedero la loro approvazione, oltre che ad altre questioni dottrinali, alla
datazione romana della Pasqua45
; tuttavia la Chiesa britanna non seguì questa
decisione.
L’eresia di Pelagio, presbitero romano-britanno, rappresenta per Beda
una grave minaccia per la chiesa britanna della fine del V secolo: il figlio del
presbitero pelagiano Severino, Agricola, avrebbe diffuso l’eresia per tutta
l’isola. Il popolo, non riuscendo a contrastare l’espansione di tale dottrina,
chiede aiuto ai vescovi della Gallia.
Il Pelagianesimo riguardava soprattutto la questione della grazia e del
peccato: secondo il presbitero, il peccato di Adamo non si era trasmesso a tutta
l’umanità, ma aveva riguardato solamente lui e non poteva pesare sul destino
degli uomini venuti dopo. Ogni anima è creata direttamente da Dio, per ciascun
uomo, all’atto della sua nascita, ed è pura e libera, quindi ogni uomo deve
salvarsi con le proprie forze; Dio concede la grazia di conoscere ciò che è il
bene, ma lascia liberi di seguirlo o di rifiutarlo, e la salvezza si ottiene pertanto
in ricompensa di una vita virtuosa46
.
45
Pelagio, Lettera a Demetriade, 2-10. 46
Beda, HEA, I, XVII, 1-16 (ed. Lapidge I p.75).
18
All'accorato appello rispondono Germano di Auxerre e Lupo di Troyes, i
quali intraprendono un viaggio verso le coste britanniche intorno al 42947
.
Non è chiaro in che misura la dottrina pelagiana sia stata davvero una
minaccia per la Chiesa romano-britanna (essa non è, ad esempio, mai
menzionata da Gildas) né per quale motivo Beda si scagli così violentemente
contro di essa (si veda come egli presenta la visita di Germano).
Le difficoltà nelle comunicazioni, sorte dopo il crollo dell'impero
romano d'Occidente, isolarono le chiese locali -in particolare della Britannia- e
resero inevitabile il sorgere di differenze nelle pratiche religiose, nella dottrina
e nell'amministrazione delle diocesi48
: il metodo per calcolare la data della
Pasqua che veniva celebrata all'equinozio di primavera; il metodo della
tonsura, praticato dai monaci: nel cristianesimo celtico si radeva la fronte da un
orecchio all'altro, ma si accettò in seguito di radere la corona al centro della
testa49
.
L'autorità dei vescovi era generalmente attribuita agli abati o
alle badesse dei monasteri, ovvero a persone che non necessariamente avevano
l'ordine sacerdotale. In seguito, gli abati furono eletti vescovi delle diocesi,
come sostiene Hughes50
, ma questa visione delle cose è suggerita da un passo
della Historia ecclesiastica che, come altrove, fraintende e mal rappresenta le
caratteristiche della chiesa irlandese antica: l’autorità delle paruchie
monastiche si estendeva solamente al controllo dei beni materiali, mentre
qualsiasi questione di governo pastorale rimaneva di esclusiva pertinenza dei
vescovi51
.
Il battesimo era celebrato quattro volte l'anno, ma in seguito si praticò il
battesimo dei bambini entro gli otto giorni dalla nascita.
48
Augé 1992. 49
Duncan 1995, p.56. 50
Hughes 1966, p. 79. 51
Beda, HEA, III, IV, 35-36 (ed. Lapidge II p.27).
19
La confessione personale privata fu introdotta nel cristianesimo celtico,
sconosciuta altrove prima del VI secolo, mentre la Chiesa romana richiedeva
una penitenza pubblica52
.
Secondo la Chiesa romana, essa era alimentata dal sangue dei martiri,
mentre la Chiesa celtica non aveva "né martiri, né autorità": per questo motivo
Roma inviò in dono numerose reliquie.
Nonostante l’influenza della vicina Irlanda, anche personalità autoctone
intrapresero l’attività missionaria: il vescovo britanno Nynian, deciso a
evangelizzare i Pitti meridionali, pose la sua sede episcopale in un luogo
denominato Ad Candidam Casam (odierna Whithorn)53
a causa della calce
bianca usata per ricoprire all’interno ed all’esterno le murature54
.
Nel 563 il monaco Colomba, esiliato dalla nativa Irlanda, fondò
un monastero con 12 compagni a Iona, un’isola nelle vicinanze delle coste
scozzesi55
. Da questo luogo essi iniziarono la conversione al Cristianesimo dei
Pitti settentrionali e di gran parte dell'Inghilterra settentrionale.
Papa Gregorio Magno, con lo scopo di convertire gli Angli alla fede
romana, decide nel 597 di inviare, nei loro territori, una missione di monaci del
monastero di Sant’Andrea al Celio, capeggiata dal priore dello stesso
monastero, Agostino56
.
Dopo aver avuto successo nella regione del Kent, la missione gregoriana
prosegue verso i regni settentrionali dell’isola: Agostino, divenuto nel
frattempo arcivescovo di Canterbury, convoca un sinodo di vescovi britanni
per “convincerli ad intraprendere insieme, in nome del Signore,
l’evangelizzazione dei popoli, ponendo fine alle controversie religiose con
l’adesione alle regole della chiesa cattolica”57
. L’incontro avvenne in due tempi
52
Lo status di penitente era pubblico, non era pubblica l'accusa dei peccati che avveniva privatamente
davanti al solo vescovo (Vogel 2006 Penitenza (s.v.), in NDPAC pp.4013-4017, vol.III) 53
Beda, HEA, III, IV, 10-16 (ed. Lapidge II p.25). 54
Thomas 1981, pp. 275-279. 55
Beda, HEA, III, IV, 19-27 (ed. Lapidge II p.25). 56
Beda, HEA, I, XXIII (ed. Lapidge I pp.93-97). 57
Beda, HEA, II, II, 6-8 (ed. Lapidge I p.181).
20
in un luogo ricordato come “Quercia di Agostino”58
, il cui sito è sconosciuto,
anche se si sono fatte diverse ipotesi59
, e l’esito dell’assemblea fu negativo: i
vescovi britanni rifiutarono categoricamente di abbandonare le loro tradizioni e
di aiutare i monaci di Agostino60
.
II.3 Il Cristianesimo e il regno di Northumbria
L’evento che permise l’introduzione della fede in Cristo nel territorio dei
Northumbri fu di natura “matrimoniale”: il re Edwin, avendo deciso di
prendere in sposa Æthelburg, figlia del re del Kent Æthelberht, inviò
ambasciatori al fratello di lei Eadbald, il quale rispose che non era lecito per
una fanciulla cristiana andare in sposa ad un pagano. Re Edwin allora promise
che non avrebbe fatto nulla di sconveniente per la fede della fanciulla e che
avrebbe permesso di conservare a lei e al suo seguito tutte le pratiche religiose
cristiane, non escludendo di convertirsi lui stesso alla fede cristiana, ma
soltanto dopo un esame accurato condotto dai suoi saggi61
.
Nel 625 fu ordinato vescovo Paolino di York, col compito di
accompagnare la promessa sposa in Northumbria e di convincere il re ad
aderire alla fede cristiana; tale adesione avvenne due anni dopo l’arrivo di
Paolino: Edwin venne battezzato in una chiesa di legno dedicata a San Pietro,
58
Beda, HEA, II, II, 4 (ed. Lapidge I p.181). 59
Plummer 1896, p.74; Eagles 2003, pp.175-178. 60
Beda, HEA, II, II, 61-70 (ed. Lapidge I p.185). 61
Beda, HEA II, IX, 14-29 (ed. Lapidge I pp.215-217).
21
fatta costruire in gran fretta per l’occasione, nei pressi di York62
. Anche il
popolo abbracciò il cristianesimo con un entusiasmo tale che Paolino, giunto
con la famiglia reale nella residenza di Ad Gefrin, “dovette fermarsi lì per
trentasei giorni, impegnato a catechizzare e battezzare”63
.
Nel 633, a causa della morte di Edwin nella battaglia di Hatfield Chase,
Paolino dovette fuggire nel Kent, il che segnò la fine della missione gregoriana
nella Northumbria. La crisi politica che seguì la scomparsa di Edwin investì
anche la sfera religiosa: i successori del re nei due regni di Bernicia e Deira
abbandonarono la fede cristiana per ritornare ai culti antichi.
Il re di Bernicia Oswald, salito al trono nel 634 dopo essere stato in
esilio presso il monastero di Iona, e lì aveva ricevuto il battesimo, riunificò il
regno di Northumbria e volle riportare il suo popolo alla fede cristiana; per
attuare questo suo proposito chiese all’abate di Iona di inviare un vescovo: la
decisione di Oswald farsi aiutare dai missionari della Chiesa irlandese piuttosto
che alla Chiesa romana in Britannia, porterà all’introduzione del cristianesimo
celtico nella regione.
All’inizio, fu inviato un vescovo, denominato dalle fonti più tarde
Corman64
, il quale, però, tornò a Iona dicendo che la Northumbria non poteva
essere convertita, perché i suoi abitanti erano troppo ostinati65
. Al suo posto
venne inviato Aidan, che scelse come centro della missione di
evangelizzazione e come sede del suo episcopato l’isola di Lindisfarne66
: la
scelta di Aidan potrebbe essere spiegata dalla vicinanza alla residenza del re a
Bamburgh (dalla città l’isola dista solamente 2 chilometri ed è unita, da una
striscia di terra, alla costa nei momenti di bassa marea).
Alla morte di Aidan gli successe come vescovo Finàn, anche lui
proveniente da Iona, nel 651. Con lui si apre la controversia liturgica del
62 Beda, HEA II, XIV, 1-8 (ed. Lapidge, I, pp.247-249).
63 Beda, HEA, II, XIV, 28-33 (ed. Lapidge, I, pp.249-251).
64 Lo storico scozzese Hector Boece, morto nel 1536, riporta tale nome. Non vi è modo di sapere quale
fosse la fonte da cui Boece traeva questa notizia, ammesso che non si tratti di pura invenzione;
Colgrave 1969, p.229 n. 2. 65
Beda, HEA, III, V, 40-47 (ed. Lapidge, II, p.31). 66
Beda, HEA, III, III, 22-26 (ed. Lapidge, II, pp.21-23).
22
computo pasquale ed altre pratiche ecclesiastiche che si inaspriranno con il suo
successore Colmàn e che porteranno al sinodo generale di Whitby del 664.
La disputa ebbe origine dal fatto che all’interno della corte del re Oswiu,
successore e fratello di Oswald, erano in vigore due diverse procedure per il
computo della Pasqua: una seguita da Oswiu stesso, che l’aveva appresa dai
monaci di Iona durante il suo esilio e che era praticata dagli ecclesiastici della
Northumbria di origine irlandese, sostenuta dal vescovo Colmàn e dalla
badessa di Whitby Hild, l’altra seguita dalla regina Eanflæd e dal suo
cappellano che l’aveva appresa a Canterbury, praticata dal figlio di Oswiu
Alhfrith e da Wilfrid di York.
Il risultato dell’impiego di due metodi differenti era spesso sconcertante:
nel decennio precedente al 664, ad esempio, i computi avevano portato a una
coincidenza di data soltanto quattro volte (negli anni 655, 656, 659 e nel 662),
mentre negli altri anni la data era stata poco o molto diversa: una discrepanza
particolarmente appariscente si verificò nell’anno 658, quando la Pasqua era
caduta il 22 aprile secondo il metodo irlandese, il 25 marzo secondo quello
romano67
.
Queste discrepanze derivano dal fatto che gli Irlandesi seguivano un
metodo di calcolo antico, attestato dal IV secolo: il giorno di Pasqua, come per
la religione ebraica, veniva calcolato seguendo l’anno lunare; per poter
collegare l’anno solare e quello lunare si decise che ogni ottantaquattro anni si
aggiungessero trentuno mesi lunari. Poiché un ciclo di ottantaquattro anni era
scomodo in quanto troppo lungo, nel VI secolo si trovò conveniente adottare
un ciclo di diciannove anni, costituito da una combinazione di un ciclo di otto
anni con l’aggiunta di tre mesi lunari e un ciclo di undici anni con l’aggiunta di
quattro mesi lunari68
.
Naturalmente è poco probabile che re Oswiu e la sua corte abbiano
compreso i procedimenti riguardanti il calcolo della Pasqua, che
67
Holford-Stevens 2005, p.50. 68
Holford-Stevens 2005, pp.41-51.
23
presupponevano conoscenze specialistiche e non è possibile sapere se al sinodo
di Whitby si sia davvero discusso degli aspetti tecnici del problema; Beda,
comunque, nel suo resoconto non fa cenno ad una simile discussione, mentre in
un punto successivo della sua opera69
espone i vari argomenti tecnici e la loro
giustificazione teologica.
Il pronunciamento del sinodo in favore del metodo romano si basò su
argomenti che possono essere definiti speciosi: questo metodo era seguito
dall’uomo che era considerato il successore di Pietro, e se Pietro deteneva le
chiavi del regno dei cieli era necessario che tutti quelli che volevano entrare in
quel regno seguissero il metodo romano70
. La decisione di Oswiu avrà tenuto
conto anche di considerazioni politiche71
. Beda aggiunge, come postilla, che al
sinodo venne discussa anche la questione della tonsura monastica, la cui
differenza fra l’uso irlandese e quello romano è stata descritta in precedenza72
.
In seguito alla sconfitta di Colmàn e del partito irlandese, Alhfrith, con il
consenso del padre Oswiu, mandò Wilfrid a Parigi per farlo consacrare
vescovo, poiché la sede arcivescovile di Canterbury era vacante, con
l’intenzione di nominarlo vescovo di Lindisfarne al posto del dimissionario
Colmàn73
: quello che avvenne nella Chiesa northumbra in tale circostanza non
è del tutto chiaro, probabilmente perché Beda non aveva conoscenza di tutti gli
eventi.
Mentre Wilfrid si trovava in Gallia (fra la fine del 664 e il 666), Alhfrith
si era ribellato ad Oswiu ed era stato ucciso74
. Dopo la ribellione Oswiu aveva
preso la decisione di nominare un vescovo nella sede di York, che era vacante
dalle dimissioni di Paolino, avvenute nel 633, e la sua scelta era ricaduta su
uno dei discepoli di Aidan di nome Ceadda, anche lui costretto a farsi
69
Beda, HEA, V, XXI (ed. Lapidge, II, pp.431-461). 70
Beda, HEA, III, XXV, 223-240 (ed. Lapidge, II, pp.133-135). 71
Abels 1983, pp.1-25. 72
Cfr. supra p.4. 73
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 11 (ed. Colgrave, p.24); Beda, HEA, V, XIX, 114-120 (ed.
Lapidge, II, p.419). 74
Beda, HEA, III, XIV, 5 (ed. Lapidge II p.65).
24
consacrare altrove, nella fattispecie nel Wessex75
, nell’anno 666; tre anni dopo
fu deposto dalla sede di York e Wilfrid, che nel frattempo era tornato dalla
Gallia e aveva occupato la sede di Lindisfarne, anche se per lo più risiedeva a
Ripon, rimase unico vescovo in Northumbria.
Da Roma venne inviato da papa Vitaliano come un nuovo arcivescovo di
Canterbury Teodoro di Tarso, monaco del monastero ad aquas Salvias sulla
via Ostiense. Teodoro era un grande teologo, tanto da aver partecipato e
ratificato gli Acta del Concilio Lateranense del 649 sulla controversia
monotelita, che ebbero gravi conseguenze per papa Martino, avendo convocato
l’assemblea conciliare. Essa aveva condannato tale dottrina: l’imperatore
d’Oriente Costante II fece arrestare Martino, lo processò a Costantinopoli e lo
condannò a morte per tradimento, pena poi commutata in esilio sul Mar Nero76
.
Il Monotelismo (da μόνος, “uno solo”, e θέλειν, “volontà”) è una
dottrina consistente nell’affermazione che in Cristo esiste un’unica volontà o
un’unica operatività o energia (monoenergismo)77
: se Cristo avesse avuto una
libera volontà umana, distinta da quella divina, egli avrebbe potuto anche
ribellarsi a quest’ultima e dunque anche peccare, evenienza esclusa
dall'abituale fede e anche dai concili di Efeso e di Costantinopoli II, i quali
stabilirono che Cristo non peccò mai ed era immune da passioni e inclinazioni
cattive e pertanto in Cristo non vi furono mai contrasti di volontà.
Sembrerebbe, dunque, che in Cristo vi fosse sempre stata un’unica volontà
effettiva. Che tutti gli atti, umani e divini, si attribuiscano all’unica persona di
Cristo, dovrebbe voler dire che unico è il principio di tali atti, unica è l’energia
operante. D’altra parte, la mancanza di peccato in Cristo poteva essere
conseguenza di una mancanza di volontà umana e della presenza in lui di una
sola volontà divina78
.
75
Beda, HEA, III, XXVIII (ed. Lapidge II pp.145-149). 76
Ostrogorsky 1993, p.104-105. 77
Simonetti 2006 Monoenergismo (s.v.), in NDPAC pp.3340-3341, vol.II. 78
Ostrogorsky 1993, p.95-96.
25
Nel 670 la regina Æthelthryth donò a Wilfrid un terreno su un
promontorio sopra il fiume Tyne, sul quale venne fondata la chiesa monastica
di Hexham79
.
Dopo aver visitato tutte le chiese di Britannia, Teodoro, nel 673, decise
di convocare un sinodo di vescovi a Hertford per risolvere le differenze di rito
all’interno della Chiesa britanna; accolsero l’invito quattro vescovi: Bisi
dell’East Anglia, Putta di Rochester, Leuthere dei Sassoni Occidentali e
Wynfrith di Mercia, mente Wilfrid di Northumbri venne rappresentato da suoi
delegati80
. Teodoro propose ai vescovi presenti dieci disposizioni, basate sui
canoni dei concili ecumenici, riguardanti la conferma del metodo romano del
computo pasquale, la giurisdizione dei vescovi, l’indipendenza dei monasteri
dal vescovo, la libertà di spostamento di monaci e chierici e il matrimonio81
.
L’arcivescovo Teodoro continuò la propria politica ecclesiastica,
soprattutto quella di dividere i vescovati troppo grandi per crearne un numero
maggiore, ma di estensione più limitata: la conseguenza più rilevante di tale
linea fu la deposizione di Wilfrid dalla sua sede episcopale da parte del re
Ecfrith nel 67882
. Wilfrid intraprese un viaggio verso Roma per tentare di
essere reintegrato da papa Agatone e vi giunse nel 67983
.
Nello stesso anno si riunì nella pianura di Hatfield, per volere di Teodoro
un nuovo sinodo per discutere gli Acta del Concilio Laterano del 649 e per
ottenere l’adesione ad essi da parte degli Angli84
: l’imperatore Costantino IV
era ansioso di raggiungere un compromesso con il papa e le Chiese occidentali
sulla questione monotelita. Nell’agosto del 678 l’imperatore inviò un sakra
(proposta) a papa Dono, dichiarando la possibilità di aprire una discussione per
risolvere pacificamente la controversia. Dono morì prima che la proposta gli
giungesse; il suo successore Agatone stabilì di consultare le Chiese occidentali
79
BEASE 1999, p.237. 80
Beda, HEA, IV, V, 17-27 (ed. Lapidge, II, p.191). 81
Beda, HEA, IV, V 45-86 (ed. Lapidge, II, pp.193-195). 82
Beda, HEA IV, XII, 34-35 (ed. Lapidge, II, p.219). 83
Beda, HEA, IV, XIII, 2 (ed. Lapidge, II, p.221). 84
Beda, HEA, IV, XV, 4-5 (ed. Lapidge, II p.237).
26
per assicurarsi il loro appoggio alla posizione papale della volontà duale, già
certificata nel 64985
. Per questa ragione fu inviato in Inghilterra l’arcicantore di
San Pietro Giovanni con l’incarico di conoscere la posizione della Chiesa
inglese86
.
La situazione episcopale della Northumbria dopo l’allontanamento di
Wilfrid divenne più eterogenea con la nomina di tre vescovi per le sedi di
York, Hexham e Lindisfarne. Nel 680 Wilfrid tornò in Northumbria recando
con sé i documenti papali a favore del suo reintegro da mostrare al re Ecgfrith;
il sovrano non li prese in considerazione e gettò Wilfrid in prigione per nove
mesi87
. Egli poi venne rilasciato e si recò presso i Sassoni Meridionali, dai
quali giunse probabilmente nel 681 e restò nel Sussex per quattro anni, fino
alla morte di Ecgfrith, dopo la quale ebbe l’opportunità di essere reintegrato
nella sua sede episcopale88
.
Nel 685 avvenne la riconciliazione con l’arcivescovo Teodoro, cosa che
permise a Wilfrid di riprendere possesso dei monasteri di Ripon ed Hexham e
della sede episcopale di Lindisfarne, dove il suo incarico durò per circa un
anno89
: non è chiaro per quale ragione tale nomina abbia avuto un così breve
periodo; forse perché egli non era più interessato a rivestire un incarico in una
località così distante dai suoi possedimenti ad Hexham e Ripon.
Il vescovato di Wilfrid continuò ad essere travagliato: egli fu condotto
davanti al re Aldfrith, nel 692, accusato e nuovamente espulso; le cause di
questa espulsione hanno le radici nell’insoddisfazione da parte del vescovo
northumbriano per il mutato assetto che l’arcivescovo Teodoro aveva dato alla
Chiesa di Northumbria, dove per altro l’episcopato era stato diviso90
.
Qualche anno dopo, nel 702 o nel 703, l’arcivescovo Berthwald convocò
un sinodo in una località chiamata Ouestraefelda. In tale sinodo fu stabilito che
85
Ostrogorsky 1993, p.111. 86
Beda, HEA, IV, XVI, 40-44 (ed. Lapidge, II, pp.243-245). 87
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 34-39 (ed. Colgrave pp.70-78). 88
Beda, HEA, IV, XIII, 66-68 (ed. Lapidge, II, pp.225-226). 89
Beda, HEA V, XIX, 156-160 (ed. Lapidge, II, p.421). 90
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 44 (ed. Colgrave pp.90-92).
27
Wilfrid fosse privato di tutte le sue proprietà in Northumbria, con la sola
eccezione della chiesa di San Pietro a Ripon, dalla quale non gli era permesso
di muoversi91
; ma contravvenendo a tali disposizioni, Wilfrid si recò in Mercia,
sotto la protezione del re Æthelred92
, il che provocò la scomunica sua e dei suoi
seguaci93
. A questo punto Wilfrid, per la seconda volta dall’anno 679, decise di
appellarsi nuovamente a Roma, chiamando in causa a sostegno della sua
posizione l’appoggio che gli era stato dato da papa Agatone nel 679 e
ricordando, come grande onore che gli era stato attribuito, la propria
partecipazione al sinodo convocato nel 680 per risolvere la controversia
monotelita94
.
Al suo ritorno, sulle coste britanniche, con una lettera papale, Wilfrid
incontrò nel Kent, nel 705, l’arcivescovo Berthwald, il quale promise che
avrebbe mitigato la dura sentenza pronunciata al sinodo di Ouestraefelda. La
ritrattazione formale della scomunica e la restituzione delle sue proprietà
avvennero l’anno seguente in un sinodo riunito presso il fiume Nidd,
presieduto da Berthwald ed altri tre prelati della Northumbria: la deliberazione
sinodale reintegrava Wilfrid nella sede episcopale di Hexham ed anche i
monasteri di Ripon ed Hexham, con le rendite ad essi connesse95
, fino alla sua
morte sopraggiunta quattro anni più tardi.
91
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 47 (ed. Colgrave pp.95-96). 92
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 48 (ed. Colgrave pp.97). 93
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 49 (ed. Colgrave pp.97-98). 94
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 53 (ed. Colgrave pp.108-114). 95
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 60 (ed. Colgrave pp.128-132).
28
III. MONUMENTI CLASSICI
La presenza in questa regione di monumenti classici si concentra lungo il
Vallo di Adriano, principalmente nei castra che gli si appoggiano e riguardano
principalmente la sfera militare e la vita quotidiana dei soldati stanziati lungo il
limes. L’unico insediamento civile e militare di grande importanza fu
Corstopium (l’attuale Corbridge), centro di raccolta dell’arsenale e degli
approvvigionamenti utili alle spedizioni al di là del Vallum.
III.1 Il Vallo di Adriano
Il Vallo di Adriano collega l’estuario del Tyne al Solway Firth, per una
lunghezza di 128 chilometri. Il muro venne costruito inizialmente con una
larghezza di 3 metri, ma le sezioni successive vennero ridotte a 2,5 metri.
L'altezza è stata stimata a circa 4 o 5 metri.
29
Lungo il muro erano posizionati quattordici forti ausiliari
come Housesteads e ottanta fortini adiacenti alle porte, ad una distanza di ogni
miglio romano.
In sezione questa barriera comprende quattro elementi: da nord verso
sud, si distingue un fossato armato con file di pali appuntiti, il muro
propriamente detto, costruito per lo più in pietra, a volte in terra (in questo caso
è sormontato da una palizzata), una strada e il vallum: due grossi argini con un
fossato nel mezzo96
: il fossato era scavato a forma di “V”, largo circa 9 metri e
profondo almeno 3 metri; oltre il fossato, da cui partiva una falsabraca larga da
2 a 6 metri, si ergeva il muro propriamente detto (Fig.5).
Il vallum probabilmente delimitava una zona militare piuttosto che essere
inteso come fortificazione principale, anche se le tribù britanniche stanziate a
sud erano anch'esse talvolta un problema.
Su pianta, si rileva la presenza di torri di controllo (ogni 500 metri) e di
segnalazione a lungo raggio mediante fuoco o fumo, porte e posti di guardia
oggi chiamati “milecastles” (ogni 1.600 metri, fig.6) e forti in cui erano
presenti coorti di fanteria e ali di cavalleria appoggiati al muro ( ogni 10
chilometri)97
, mentre i castra che alloggiavano le legioni si trovavano ad una
distanza di quasi 200 chilometri dal vallum.
La costruzione ebbe inizio tra il 122 e il 124 ad opera dell'allora
governatore di Britannia, Aulo Platorio Nepote e venne largamente completata
nel giro di dieci anni, con soldati di tutte e tre le legioni occupanti che
parteciparono ai lavori. Il percorso prescelto seguiva ampiamente la Stanegate
road da Carlisle a Corbridge, che era già difesa da un limes e da diversi forti
ausiliari, compreso quello di Vindolanda98
.
Il Vallo venne occupato quasi ininterrottamente per trecento anni, anche
se con diverse modifiche sia alla struttura del muro stesso sia in quella dei
96
Breeze-Dobson 1976, pp.16-20. 97
Le Bohec 1989, p.223. 98
Breeze-Dobson 1976, pp.20-23.
30
castra: gli alloggi delle truppe vennero completamente ridisegnati secondo le
nuove esigenze e composizione dell’esercito tardo-imperiale; le porte di
accesso vennero chiuse o destinate ad altri usi, le torrette di avvistamento non
necessarie vennero abbandonate e i “milescastles” ridimensionati.
Le torri di controllo e i forti di avamposto avevano la funzione di
garantire la sorveglianza contro le infiltrazioni ostili e di dare il preavviso in
caso di imminenti attacchi su larga scala. Le prime di solito erano costruite
direttamente nelle fortificazioni di cinta, disposte ad intervalli di circa 165 m:
esse coprivano un ampio raggio di sorveglianza, ma non erano molto utili per il
preavviso di pericoli99
.
I forti di avamposto, invece, erano situati oltre il confine e ad una certa
distanza da esso, nei quali erano alloggiate più coorti di fanteria sia ali di
cavalleria e alcuni manipoli di numerii.
III.2 I castra (Fig.7)
I castra northumbriani rispecchiano la tipica conformazione degli altri
forti dell’impero: le fortezze legionarie permanenti derivavano la loro struttura
dagli accampamenti di marcia o "da campagna". La loro struttura era pertanto
similare, pur avendo, rispetto ai castra mobili, dimensioni ridotte, pari
normalmente a 16-20 ettari100
. È vero anche che, almeno fino a Domiziano,
erano presenti lungo il limes alcune fortezze legionarie "doppie" (dove erano
acquartierate insieme due legioni), con dimensioni che si avvicinarono ai 40-
99
Birley 1953, pp.103-110. 100
Le Bohec 1989, p.215.
31
50 ettari101
. A partire, però, da Diocleziano e dalla sua riforma tetrarchica, le
dimensioni delle fortezze andarono sempre più diminuendo, poiché le legioni
romane erano state ridotte alla metà degli effettivi. Al centro della fortezza si
trovavano i Principia (il quartier generale), che davano sulla via Principalis
(2) e che formavano con la via Praetoria (3) una T all'interno del campo, in
direzione della zona riservata al quartier generale. Tutte le altre strade erano
secondarie rispetto alle prime due (es. la via Quintana, 4). Lungo la via
Praetoria si trovavano la porta Praetoria (D) e la porta Decumana (B), mentre
lungo la via Principalis si trovavano la porta Principalis dextera (C) e la porta
Principalis sinistra (A).
I Principia, ovvero quegli edifici che ne rappresentavano il centro
amministrativo, di fronte agli edifici dove era alloggiato il comandante della
legione (legatus legionis), il Praetorium (1). Le dimensioni di questi primi due
edifici variavano da fortezza a fortezza, anche se normalmente presentavano
misure pari a 70x100 metri circa102
. Accanto a questi edifici c'erano poi quelli
dei tribuni militari e gli alloggi dei legionari e dei loro centurioni. Vi erano,
infine, strutture di fondamentale importanza come il valetudinarium (ospedale
militare), gli horrea (granai), fabricae (fabbriche di armi) ed in alcuni casi
anche le terme, un carcer (prigione) ed, esterni alle mura del campo,
anfiteatri103
.
101
Le Bohec 1989, p.216. 102
Le Bohec 1989, p.213. 103
Webster 1998, pp.200-206.
32
III.3 I vici
Sotto Adriano le legioni erano alloggiate in basi fisse, da cui nella
maggior parte dei casi non si sarebbero mai allontanate. Di conseguenza, i
soldati si formavano ben presto delle famiglie illegittime negli insediamenti
che crescevano spontaneamente intorno alle basi legionarie; la parola più
conosciuta per designare questi insediamenti è canabae: essa indicava un
insieme di tipo urbano costruito non lontano dalla fortezza e che aveva una vita
collettiva propria: l’autorità era esercitata da edili, magistrati, curatori. Secondo
alcuni storici104
, le canabae accompagnavano sempre i campi legionari ed
avevano la possibilità di evolversi in municipi e colonie; in altri casi, si sarebbe
utilizzato il termine vicus, che designa un agglomerato molto meno rilevante
per superficie, anche se in Britannia i vici possiedono una grande varietà di
monumenti, terme, templi, altari ecc. come nei casi di Vindolanda e
Housesteads (Vercovicium), e si trattava di comunità “sedentarie”, dato che si
sviluppavano attorno a castra stabili, posti a difesa delle frontiere.
Storicamente vanno distinte tre fasi delle canabae: la prima, finora priva
di attestazioni archeologiche, in cui si seguivano le truppe sul campo
(attendamenti), la seconda in cui i legionari, e di conseguenza le salmerie, si
insediavano in costruzioni più solide (sempre lignee) per periodi più lunghi,
specialmente in inverno (hiberna) e una terza ed ultima fase, in cui sia le
legioni che le salmerie si acquartieravano in un luogo più a lungo, costruendo
alloggi durevoli. Ovviamente queste fasi potevano anche presentarsi
contemporaneamente a seconda delle funzioni da svolgere105
.
Come si vivesse in questi nuovi villaggi è ancora oggi leggibile grazie
alla scoperta nello scavo di Vindolanda, tra il 1973 e il 1975, di circa duecento
104
Salway 1965, pp.9-11 e 117. 105
Mason 1987, pp.148-163.
33
frammenti di tavolette lignee scritte con inchiostro, relative a cinque diversi
periodi di vita dello stesso forte, compresi tra gli anni successivi dell'85. a
quelli della costruzione del Vallo; la maggior parte delle tavolette fu rinvenuta
nella corte del praetorium e sono databili intorno al 97-107, quando a capo
della guarnigione era Flavius Cerialis, prefetto della IX cohors Batavorum106
, e
riguardano la sua corrispondenza personale, mentre le altre forniscono notizie
importantissime e preziosissime sulla vita negli stanziamenti militari romani: si
tratta di lettere di auguri, notizie che si inviavano ai familiari lontani, rapporti
giornalieri sulle mansioni assegnate quotidianamente, inventari, conti, esercizi
di scrittura.
Questi reperti ci parlano di una vita piuttosto dura e monotona per
quanto riguarda i milites semplici, con rapporti spesso non violenti, ma
complicati con i Britanni (un soldato arriva addirittura a definirli
spregiativamente Britanculi, più o meno “piccoli tozzi Britanni)107
”, mentre la
vita dell’ “aristocrazia”, cioè la vita dei famigliari degli alti ufficiali, cercava di
essere il più simile possibile a quella che i loro pari svolgevano in province più
vicine a Roma.
III.4 I templi
Al di fuori delle attestazione all’interno dei castra stessi, sono
relativamente limitate le tracce di edifici cultuali al di fuori di essi. Per lo più si
106
RIB 2445. 107
Bowman 1994, p.89.
34
tratta di altari celebrativi di privati o sempre riguardanti la sfera militare (ad
esempio, il genio della legione di appartenenza o altari dedicati all’imperatore
o alla famiglia imperiale), o divinità del pantheon celtico assimilate o accettate
dai soldati di frontiera, come un piccolo tempio romano-celtico nella zona della
porta occidentale del forte di Vindolanda o il tempio della divinità locale
Atenociticus presso Heddon-on-the-Wall (fig.8).
In questa zona è quantitativamente rilevante la presenza di mitrei e
attestazioni riguardanti il culto di Mitra, molto popolare tra le fila dell’esercito
ed osteggiato con particolare veemenza, rispetto ad altri culti, dai cristiani, i
quali vedevano i riti (come il consumo di pane sacro durante le riunioni) e la
mitologia del Mitraismo come una parodia blasfema del Cristianesimo.
Sono stati rinvenuti tre mitrei in buone condizioni di conservazione, tutti
nelle immediate vicinanze dei castra di Brocolita (Carrawburgh), Vircovicium
(Hausesteads) e Vindobala (Rudchester).
Il mitreo di Carrawburgh (fig.9), l’antico forte ausiliario di Brocolitia, si
è ottimamente conservato almeno nella sua pianta: i suoi resti furono scavati
nel 1949 e la loro analisi ha permesso di ricostruire almeno tre stadi di sviluppo
della costruzione, tutti databili intorno al III secolo108
.
Il tempio più antico, era molto più piccolo, ma comprendeva già
l’anticamera e l’usuale navata principale con i banconi laterali. Il tempio venne
successivamente ampliato, con l’allargamento dei banconi laterali e
l’inserimento di nuovi elementi come le statue di Cautes e Cautopates e lo
scavo di un pozzetto per lo scolo e la raccolta del sangue sacrificale, situato
presso l’anticamera, laddove doveva trovarsi anche un braciere rituale.
Un certo numero di oggetti risalenti a questo periodo si è conservato
all’interno del tempio, come la paletta di ferro utilizzata per mantenere vivo il
fuoco (un compito che spettava agli adepti del grado di Leo109
), che fu trovata
108
Lewis 1966, pp.67-70. 109
Bianchi 1984, p.2123.
35
appoggiata su uno dei banconi laterali e che oggi è esposta, insieme ad altri
oggetti, nel Great North Museum di Newcastle.
Il secondo tempio venne distrutto negli anni tra il 296 e il 297, ma parte
dei suoi arredi si salvò e venne utilizzata per il terzo ed ultimo tempio, quello
di cui oggi vediamo i resti. Di questi arredi fanno parte tre altari scolpiti, tra i
quali spicca certamente quello dedicato da Marcus Simplicius Simplex110
. Esso,
infatti, reca al centro la figura di Mitra, il quale indossa una tunica in stile
romano e regge con una mano la frusta tipica del dio Sole. La sua corona solare
è forata, affinché lasciasse trapelare la luce di una lampada posta nella nicchia
scavata sulla parte retrostante. Al momento del ritrovamento presentava ancora
tracce di pittura rossa e verde.
Gli altri due altari contengono invece solo delle iscrizioni: in una
troviamo la dedica di un certo Lucius Antonius Proculus111
, del quale viene
indicato il grado militare, quello di prefetto della I cohors Batavorum; il terzo
altare è dedicato da Aulus Cluentius Habitus, originario di Larinum, municipio
che si trovava sugli Appennini112
.
Una caratteristica insolita di questo mitreo è il ritrovamento al suo
interno di una statuetta raffigurante una Dea Madre: il fatto è assolutamente
particolare, essendo quello di Mitra un culto riservato ai soli uomini, al
contrario del culto alla Dea Madre. L’unica connessione tra i due culti è lo
svolgimento dei rituali in luoghi sotterranei.
Nelle vicinanze del mitreo vennero edificati anche un ninfeo ed un pozzo
dedicato alla divinità celtica Coventina, culto testimoniato da diverse epigrafi
di ex voto113
.
Pochi chilometri più ad ovest di Carrawburgh, nel sito di Hausesteads
nel 1898 vennero alla luce i resti del mitreo del forte di Verocovicium:
110
RIB 1546. 111
RIB 1544. 112
RIB 1545. 113
RIB 1522-1533.
36
l’edificio era del tutto simile a quello sopra descritto, ma oggi non ne rimane
alcuna traccia.
Su uno dei banconi vennero rinvenuti due bassorilievi, oggi al Great
North Museum di Newcastle: il primo bassorilievo è una delle più grandi e
dettagliate scene di Tauroctonia che si conoscano. La scena è quella classica, il
dio è fiancheggiato dai due gemelli portatori di torce, i Dadofori, Cautes e
Cautopates. Da notare, soprattutto, la coda del toro che si apre a formare tre
spighe di grano, ad ulteriore conferma della valenza creatrice dell’atto
compiuto da Mitra e della rinascita spirituale dell’adepto che giungeva fino
all’ultimo grado di iniziazione, quello di Pater114
.
Assai singolare, invece, è il secondo bassorilievo, che mostra Mitra che
nasce attraverso il cerchio dello Zodiaco, avente però la forma di un uovo e che
sta quindi a significare l’Uovo Cosmico. Sebbene la maggior parte dei miti
relativi a Mitra sostengano che egli sia nato dalla roccia viva (petra
genetrix)115
, mentre la nascita dall’Uovo Cosmico mette il dio persiano in
relazione con un’altra religione misterica, l’Orfismo, il cui dio creatore Phanes
nasce da un uovo generato da Crono116
(Fig.10).
Anche nel mitreo di Hausesteads erano posti tre altari: il primo riporta la
dedica di Litorius Pacatinus e, insolitamente per questo culto, di tutta la
famiglia117
; il secondo, di fattura molto semplice, menziona Pubicius
Proculinus e suo figlio Proculus118
, databile al 252 grazia alla menzione dei
consoli ; il terzo ed ultimo altare, più piccolo rispetto agli altri, è decorato con
la rappresentazione a bassorilievo del dio con la corona a sette raggi e reca la
dedica Herion119
.
Il piccolo mitreo di Vindobala sorgeva a breve distanza dal confine
occidentale dell’accampamento e venne scoperto nel 1844 da un fattore locale,
114
Bianchi 1984 p.2125 115
Bianchi 1982, p.125. 116
Arrighetti 1989, p.62. 117
RIB 1599. 118
RIB 1600. 119
RIB 1601.
37
che scavando nel suo terreno si imbatté in una statua e in cinque altari. La
statua venne successivamente rotta ed è andata perduta, mentre gli altari si
sono preservati. La posizione del mitreo venne registrata e ciò permise
all’archeologo Gilliam di rintracciarlo, nel 1953, e di compiere su di esso
indagini più approfondite120
.
Gilliam delineò nella storia del mitreo almeno due fasi di esistenza: il
tempio originale, datato tra la fine del II e l’inizio del III secolo, consisteva in
una sala rettangolare classica, con un’unica navata centrale e dei banconi sui
due lati. Una sorta di piccola anticamera precedeva l’ingresso al tempio,
addossata alla parete est e posta asimmetricamente rispetto all’ingresso del
mitreo, così che da essa non fosse possibile vedere la sala rituale in linea
retta121
.
In una fase successiva il tempio venne ricostruito, i banconi laterali
ampliati, riducendo ulteriormente il già angusto spazio riservato agli adepti e
rimuovendo la piccola anticamera. Un podio in pietra, rialzato rispetto al
livello del pavimento, venne posto nella zona absidale, probabilmente per il
sacrificio rituale del toro122
.
Non fu trovata traccia della Tauroctonia, mentre delle eventuali statue
dei Dadofori furono ritrovate solo le teste, segno di una deliberata distruzione
del sito. Indizi mostrano che il mitreo si mantenne operativo per circa un altro
secolo e che alla metà del IV secolo esso si trovava già in stato di abbandono.
Particolarmente interessanti e di buona fattura sono gli altari scolpiti: il
primo, dedicato da Lucius Sestius Castus, militante nella Legio VI Victrix,
presenta da un lato del capitello una testa di toro circondata da una ghirlanda,
dall’altra un berretto frigio del tipo di quelli indossati da Mitra. Alla base,
invece, si trova un bassorilievo che mostra il dio in lotta con il toro, prima
120
Gilliam 1954, pp.176-219. 121
Gilliam 1954, pp.180-198. 122
Gilliam 1954, pp.199-213.
38
dell’uccisione123
. Questi elementi iconografici fanno supporre che Lucio Casto
fosse stato iniziato al grado di Miles quando fece realizzare l’altare124
.
Il secondo altare, che riporta la dedica di Tiberius Claudius Decimus
Cornelius Antonius, venne realizzato in occasione del restauro del tempio,
come attesta l’iscrizione125
; il terzo è molto semplice e spartano e reca la
dedica Mitra Sol Invictus da parte di Publius Aelius Titullus126
; il quarto altare
presenta la dedica di Aponius Rogatianus al dio Sol, chiamato Apollo, Anicetus
e Mitra: si assiste qui alla compenetrazione in un’unica divinità di tre dei
solari di pantheon differenti (quello greco, quello celtico-germanico e quello
persiano)127
.
Il quinto altare è del tutto privo sia di iscrizioni sia di un qualsiasi
apparato decorativo.
123
RIB 1394. 124
RIB 1982 125
RIB 1396. 126
RIB 1395. 127
RIB 1397.
39
IV. MONUMENTI CRISTIANI
IV.1 Caratteristiche dell’architettura ecclesiastica
anglosassone
La cronologia dell'architettura nel periodo anglosassone è piuttosto
oscura. Si sono infatti conservati, più o meno integri, meno di una dozzina di
edifici e si tratta spesso di quelli meno importanti; ciò inevitabilmente fornisce
una visione distorta della qualità e della scala di quei monumenti e rende di
primaria importanza le testimonianze archeologiche, con il risultato che spesso
i resti dell'architettura anglosassone sono studiati in genere da questo
particolare punto di vista piuttosto che, come sarebbe invece auspicabile, nel
loro autentico significato e valore storico. Le due fondamentali tecniche
costruttive, in legno e in pietra, hanno ben poco in comune, appartenendo la
prima al mondo celtico e germanico e la seconda a quello romano.
La maggioranza degli edifici secolari anglosassoni era costruita in legno,
mentre le chiese venivano edificate usando entrambe le tecniche costruttive,
40
anche se di norma per i più importanti edifici di culto si preferiva la muratura
in pietra, collegandosi, in molti casi intenzionalmente, alla tradizione
dell'architettura romana128
. Gli edifici anglosassoni vengono classificati
secondo tre principali suddivisioni cronologiche: la prima va all'incirca
dall'inizio del V secolo, al momento della conversione al cristianesimo, fino al
625, la seconda abbraccia il periodo che va dalla conversione alle invasioni
vichinghe dell’VIII secolo e la terza arriva alla conquista normanna, nel
1066129
. La maggior parte degli edifici ecclesiastici qui presi in esame
appartengono principalmente al secondo periodo e presentano caratteristiche
che si differenziano leggermente a seconda dei casi.
I Sassoni portarono con loro dalla Frisia, dalla Sassonia e dallo Jutland le
proprie tradizioni edilizie, caratterizzate da un'ampia gamma di dimensioni
costruttive, dalle più modeste alle più grandiose, come gli edifici della
residenza regale di Yeavering, in cui si ha una fusione di elementi celtici,
romani e germanici.
I modelli di riferimento degli edifici ecclesiastici sono due: il modello
romano, introdotto dalla missione agostiniana nel Kent nel 597 e quindi diffuso
nella parte meridionale dell’isola, la cui pianta presenta un’unica navata
affiancata da piccoli annessi, con un presbiterio absidato orientato ad est; il
secondo modello è quello dei monasteri celtici, giunto con le missioni
provenienti da Irlanda e Scozia: l’edificio è molto semplice, senza annessi, con
un presbiterio quadrangolare. Le dimensioni delle chiese sono generalmente
molto piccole (non superano mai i 30 metri di lunghezza) e lungo i muri sono
poste porte strette e finestre di forma triangolare di dimensioni ridotte con
semplici decorazioni a nastro, che fanno entrare pochissima luce all’interno
dell’edificio130
.
128
Biddle 1986, pp.1-31 129
Gem 1986, pp.146-155. 130
Rodwell 1986, pp. 156-175.
41
La navata ed il presbiterio sono divisi da recinti piccoli e rettangolari
che, oltre a dividere la zona più sacra della chiesa da quella adibita ai fedeli,
riflettono un problema strutturale: le tecniche costruttive a degli Anglosassoni
non permettevano di aprire dei vani troppo ampi131
.
IV.2 Vindolanda (Chesterholm)
Il sito di Vindolanda offre un esempio perfetto di un castrum legionario
e dell’insediamento civile sorto al di fuori della porta occidentale.
Il forte venne costruito intorno all’anno 85 e rimase attivo fino alla fine
dell’Impero, il che lo rende il forte più lungamente occupato di tutto il Vallo.
Il sito occupa un’area di 1,43 ettari, dove le ricerche archeologiche
hanno rivelato una continuità e successione di sette castra, di cui solamente
due in pietra.
Per quanto riguarda la presenza di edifici cristiani, bisogna concentrarsi
sulla fase di vita dell’intero complesso denominato Periodo IX e Periodo X (V-
VI sec.), nei quali viene costruito all’interno del cortile del praetorium, un
edificio absidato delle dimensioni di 8x6 metri orientato verso ovest (fig.11);
tale struttura è da sempre considerata una chiesa o cappella, innalzata nel
momento in cui il praetorium aveva perso la sua funzione (vengono
riconvertiti anche degli ambienti a terme)132
.
131
Cherry 1976, pp.151-200. 132
Birley-Blake 2005
42
La presenza di una comunità cristiana nel vicus di Vindolanda è attestata
dal ritrovamento di un altare di pietra frammentario, in cui sono incise due
croci, delle quali la seconda è sovrastata da una croce più piccola circoscritta in
un cerchio (fig.12) e da un’iscrizione che merita un approfondimento.
L’epigrafe venne ritrovata negli anni ’80 del XIX secolo133
e consiste in
un cippo frammentario in comune pietra locale, di forma all’incirca
parallelepipeda. Presenta solamente la faccia inscritta con sommaria
sbozzatura. Il testo superstite su tre righe, di cui è possibile ipotizzarne una
quarta; il modulo delle lettere è incostante e il modello è la capitale
quadrata134
(fig.13).
BRIGOWAGLOS
[hic]IACIT135
[---]ṾṢ136
[---]
Le caratteristiche materiali, paleografiche (lo scambio tra le lettere M e
W, la G a forma di falcetto e la R con un grande occhiello, lo scambio di -os
per -us) e linguistiche portano a datare l’epigrafe intorno al V sec137
.
Il termine Brigomaglos è al centro di un dibattito tra gli epigrafisti e gli
storici, che ha portato alla formulazione di due ipotesi: Brigomaglos sarebbe un
antroponimo derivante dal popolo dei Brigantes, che occupava il territorio
della Northumbria all’arrivo dei Romani138
, oppure un titolo conferito a capi di
comunità dopo la partenza delle legioni (dal celtico *brigo- “alto”,
133
Bruce 1889, p.367-371 134
Sims-Williams 2003, p.361. 135
Mecalister 1945, p.475 legge per intero HIC IACIT. 136
Il medesimo autore riporta [---] ECVS. 137
Sims-Williams 2003, p.363. 138
Jakson 1953, p. 192 n.2.
43
*-magalo/*-maglo- “signore, capo”)139
.
La terza riga pone molti interrogativi: quasi tutti i commentatori140
propendono per interpretarla come un aggettivo indicante il luogo di
provenienza del defunto, mentre l’Haverfield141
, il primo a dare una
descrizione scientifica dell’epigrafe, proponeva di integrare la lacuna con [qui
et Brioc]us.
L’epigrafe di Briglomaglos e l’edifico absidato del praetorium gettano
luce sul periodo di transizione dalla dominazione romana e la creazione di
comunità britanno-romane, le quali stanno gradatamente abbandonando i riti e
le abitudini pagane in favore del Cristianesimo che si andava imponendo in
tutta l’isola.
IV.3 Vircovicium (Housesteads)
Il castrum è situato su un’altura, dominando un’ampia valle che si
estende verso nord. Anche qui, come a Vindolanda, ci troviamo di fronte ad un
forte abitato da truppe ausiliare e da un vicus di modeste dimensioni situato ad
est.
Tra il V e il VI sec., nella zona nord-ovest del campo, viene costruito un
edificio absidato simile per dimensioni alla “chiesa” di Vindolanda (10x6
metri) e con lo stesso orientamento: rinvenuto durante gli scavi del 1898,
139
Dark 1994, pp.71-74. 140
Jackson 1982, pp.62-63; Macalister 1945, pp.475-476. 141
Haverfield 1918, p.30.
44
l’edificio si presentava con una pavimentazione di grosse pietre e direttamente
su di esse si appoggiavano le murature (fig.14); la scoperta nelle immediate
vicinanze di una sepoltura posta all’interno di una cisterna (fig.15), portò gli
archeologi inglesi ad identificarlo come un edificio cultuale, quasi certamente
cristiano142
. Ad oggi non è più possibile rintracciare tale edificio né la tomba-
cisterna143
.
IV.4 Ad Gefrin (Yeavering Bell)
Abitato fin dal Mesolitico, Yeavering Bell si trova al limite occidentale
della valle denominata Glendale: si tratta di un’altura formata da due picchi
gemelli a 361 metri sul livello del mare; l’insediamento anglosassone si trova
su un terrazzamento a 75 metri d’altezza, attraversato dal fiume Glen (fig.16).
A metà del VII secolo, Ad Gefrin, il cui nome deriva dall’antico inglese
*geafringa (“collina delle capre”)144
era il centro del regno di Bernicia e
residenza del sovrano.
Durante gli scavi effettuati nella seconda metà del XX secolo
dall’archeologo Brian Hope-Taylor (fig.17) vennero rinvenuti una serie di
edifici lignei che costituivano il palazzo reale: un grande recinto, il “palazzo”
prospiciente al “teatro” (una cavea di legno utilizzata probabilmente per le
assemblee) e degli edifici di non meglio precisata funzione.
142
Bosanquet 1898, p.248-249 . 143
Rushworth 2009 pp. 321-322. 144
DEPN 1960, p.193.
45
Alle spalle del “teatro” sono state rinvenute delle zone adibite alle
sepolture sia umane che di ossa animali, vicine a degli edifici denominati
dall’Hope-Taylor con la lettera D145
, che, secondo l’interpretazione dello stesso
archeologo, sarebbero stati dei templi riconvertiti in cappelle dopo l’arrivo di
Paolino alla corte di Edwin146
e secondo le disposizioni date da papa
Gregorio147
. Alla stessa fase cronologica viene attribuito un edificio
quadrangolare di 10x10 metri con un piccolo annesso circondato da un
cimitero, situato nelle vicinanze del “palazzo”, interpretato come una vera e
propria costruzione ecclesiastica, forse voluta dallo stesso Paolino(fig.18).
IV.5 Ebb’s Nook
I resti della cappella di Ebb’s Nook, vicino a Beadneall Harbour, furono
rintracciati nel 1853 da Hodgson Hinde e descritti nel 1854 da Alfred Way148
.
Il luogo veniva e viene tuttora indicato come “St Ebba’s chapel”, riferendosi ad
un luogo di culto dedicato a Æbbe, sorella del re Oswald: Æbbe aveva fondato
un monastero nel Berwickshire, su un promontorio vicino alla citta di
Coldingham149
.
La datazione è sconosciuta: la maggior parte delle strutture sopravvissute
risalgono al XII secolo, ma la pianta ad una sola navata con cella è tipica degli
edifici ecclesiastici della metà del VII secolo, confermata dalla toponomastica,
145
Hope-Taylor 1977, p.97. 146
Vd. supra.[BISOGNA INDICARE IN QUALE PAGINA] 147
Beda, HEA, I, XXX (ed. Lapidge, I, pp.143-145). 148
Way 1854, pp.410-412. 149
Beda, HEA, IV, XVII (ed. Lapidge, II, p.247).
46
e che forse si sovrapponeva ad una più antica cappella lignea circondata da un
terrapieno (fig.19).
Al momento della scoperta i muri misuravano in alcuni punti in alzato
1,5 metri e 0,5 metri in spessore.
La planimetria (fig.20), a sviluppo longitudinale, risulta molto semplice:
alla navata (4x9 metri) si accedeva attraverso due porte poste nel lato
occidentale. Altre aperture si trovano all’interno della navata e facevano
accedere verso est ad un presbiterio quadrangolare (4x4 metri), verso ovest ad
un annesso speculare al presbiterio, ma costruito in un secondo momento (il
vano di accesso venne ricavato tagliando parte del muro occidentale).
In questi mesi sono in corso degli scavi per la salvaguardia del sito, che
rischia di venire sommerso dal mare.
IV.6 Acomb
Il villaggio di Acomb sorge a poca distanza verso nord dalla città di
Hexham. Beda150
riferisce, in modo molto preciso, di una mansio situata ad un
miglio e mezzo circa (2 chilometri) dalla chiesa di Hexham: il luogo
corrisponde ad un alto sperone che domina il fiume Tyne, dove oggi sorge la
chiesa St. John Lee. Il luogo in antico inglese doveva chiamarsi Erneshou, in
latino Mons Aquilae secondo i cronisti medievali151
.
Dalla descrizione che fornisce Beda appare chiaro che il sito aveva una
cappella dedicata all’arcangelo Michele, che fungeva da oratorio, isolata da un
150
Beda, HEA, V, II, 8-14 (ed. Lapidge, II, p.333). 151
Richard di Hexham, “The priory of Hexham: its chroniclers, endowments and annals”, IV (ed. Andrews
and Co., Durham 1894, p. 15).
47
terrapieno e un fossato e circondata da un rado bosco, almeno un edificio
adibito ad abitazione ed un cimitero. La dedica all’arcangelo Michele sarebbe
la più antica in Inghilterra per un edificio sacro152
. Il suo accostamento ad un
luogo di carattere funerario potrebbe derivare da un riferimento della lettera di
Giuda153
, nella quale si dice che l’arcangelo ha conteso il corpo di Mosè con il
demonio e dai racconti apocrifi della Transito della Beata Vergine Maria154
: è
in questa sua “qualità” che l’arcangelo viene venerato qui ad Ascomb.
Un’altra spiegazione può essere data se accettiamo come vera la notizia
riportata da Richard di Hexham155
che tale cappella fosse stata innalzata da
Wilfrid al suo ritorno in Northumbria, come ex voto all’arcangelo che, in una
visione avuta durante la sua malattia in Gallia, gli aveva preannunciato la
guarigione grazie all’intercessione della Vergine.
Dal racconto di Beda è possibile ricavare un termine ante quem (l’anno
687) con il quale datare tutto il complesso, mentre, se diamo peso al cronista
Richard, la data dovrebbe essere spostata a dopo l’estate del 705.
Purtroppo, a parte queste informazioni, non è più possibile rintracciare
tali edifici.
152
Jones 2006, p.17. 153
Bibbia, Giuda v.9. 154
Pseudo-Melitone di Sardi, Transitus Mariae, v.17 (ed. Bover 1947 p. 235). 155
Richard di Hexham, The priory of Hexham, IV (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p. 18).
48
IV.7 Bebba (Bamburgh)
La cittadina di Bamburgh, per ben quattro secoli principale residenza
dei sovrani della Northumbria, è situata su un promontorio roccioso alto sul
mare e rivolto verso l’isola di Lindisfarne: fu fondata da Ida, primo re di
Bernicia, in una posizione che ne consentiva una migliore difesa156
. Il suo
toponimo deriverebbe dal nome di regina157
, ma non è chiaro di quale monarca
fosse la sposa.
Gli scavi effettuati negli anni ’60 e ’70 del XX secolo hanno dimostrato
una lunga continuità di vita nel luogo dove sorge il castello, fin dall’Età del
Ferro158
.
Nella prima fase anglosassone della fortezza (V-VI sec.), all’interno
delle mura, venne costruita una cappella dedicata a San Pietro, dove vennero
custodite le reliquie del corpo di re Oswald: durante la battaglia di
Maserfelth159
contro l’esercito della Mercia, nel 642, il re rimase ucciso e il suo
corpo fu smembrato in diverse parti dopo la battaglia e la testa e le mani su
delle picche160
, le quali furono recuperate da Oswiu, fratello di Oswald, in uno
scontro successivo col il re di Mercia Penda. Le membra di Oswald ebbero
destini differenti: la testa venne sepolta nel monastero di Lindisfarne e
successivamente posta nel sarcofago di San Cuthbert161
, dove è rimasta fino ad
oggi, le braccia e le mani vennero custodite in una teca argentea posta
156
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 60 (ed. Colgrave pp.128-132). 157 Beda, HEA, III, VI, 26-27 (ed. Lapidge, II, p.35). 158
Hope-Taylor 1960, pp. 11-12. 159
Il nome antico inglese di questa località non si è mantenuto nell’inglese moderno e per questa ragione non
c’è accordo fra gli studiosi sulla sua identificazione. Ad oggi sembra più probabile l’ipotesi di Stancliffe la
quale, dopo un’ampia disamina del problema, identifica il luogo con Oswestry nello Shropshire,
nell’Inghilterra occidentale, un nome che etimologicamente significa “albero di Oswald” (Stancliffe-
Cambridge 1995 pp.84-96). 160 Beda, HEA, III, VI, 26-27 (ed. Lapidge, II, p.35). 161
vedi infra paragrafo IV.11.
49
all’interno della cappella di San Pietro a Bamburgh, mentre il corpo e le gambe
non furono mai ritrovati.
Per rintracciare l’edificio, andato perduto e conosciuto solamente dalla
citazione che ne fa Beda, nel 2000 vennero eseguite delle prospezioni
geologiche nel cortile interno, dove sorgono i resti di una cappella del XII sec.
intitolata a San Oswald: questa indicazione ha portato gli archeologi del
Bamburgh Research Project a indagare la zona alla ricerca di evidenze
riguardanti la cappella di San Pietro (fig.21). La resistività e il georadar
rivelarono la presenza di una camera voltata di 3x3,5 metri corrispondente ad
una cripta, dove erano contenute con tutta probabilità le reliquie di Oswald;
vennero rilevate delle anomalie nella resistività anche nella parte occidentale
della cappella, che potrebbero corrispondere all’arco trionfale anglosassone.
Dopo avere studiato i risultati delle prospezioni geologiche, nel 2004 si
decise di aprire due trincee di 5x3 metri orientate da est ad ovest (fig.22): la
prima venne aperta al di sopra della possibile cripta, mentre l’altra, posta al
centro della navata della cappella medievale, aveva lo scopo di verificare la
presenza delle fondamenta dell’arco trionfale. I risultati delle trincee162
hanno
smentito la presenza di una cripta, ma in compenso hanno portato alla luce
tracce di murature in pietra datate tra l’ultima parte del periodo romano-
britanno e la metà del periodo anglosassone, che conferma la notizia di Beda.
162
Wood-Young 2006, pp.6-8.
50
IV.8 Bywell
Bywell è un piccolo villaggio sulla riva settentrionale del fiume Tyne,
sulla strada tra Hexham e Newcastle. La particolarità di questa piccola
comunità risiede nell’aver, ad una distanza di 500 metri, ben due chiese di
epoca anglosassone dedicate a San Pietro e Sant’Andrea: questa particolarità è
data dal fatto che i due edifici in epoca normanna si trovavano al confine di due
distinte baronie, Bywell e la non più esistente comunità di Styford.
La chiesa di San Pietro (fig.23) ad oggi consiste in un massiccio edificio
del XIII secolo, costituito da una torre occidentale che funge da ingresso
principale dal quale si accede alla navata principale, affiancata a sud da
un’altra navata. Il presbiterio, di forma rettangolare, si presenta più sviluppato
longitudinalmente (25x4 m, compresa la torre) rispetto ad altri della stessa
epoca, ma esaminando nel dettaglio le murature, si evince che il presbiterio
sassone fosse più piccolo163
(fig.24); ad esso si poteva accedere da una porta, in
un secondo momento murata (fig.25).
All’esterno del muro settentrionale sono presenti delle imposte di archi
che fanno pensare ad un portico, ma senza un’indagine archeologica è
impossibile avanzare ipotesi sulle dimensioni dello stesso (fig.26 e 27).
Della prospiciente chiesa di sant’Andrea (fig.28) non rimane nessuna
traccia riconducibile al secondo periodo anglosassone, se non una pietra incisa
con motivi geometrico-vegetali, forse da interpretare come un parte di un
crocifisso in pietra, databile intorno al VII secolo164
.
163 Taylor 1965, I, p.126. Taylor afferma che non è possibile individuare l’esatta grandezza del presbiterio.
164 Taylor 1965, I, p.128.
51
IV.9 Corstopitum (Corbridge)
L’odierna Corbridge si è sviluppata da un villaggio anglosassone sorto
nelle vicinanze della Dere Street, la strada militare romana che collegava York
al Vallo di Antonino: Corbridge, a cui si arriva attraverso un ponte in muratura
(di cui è possibile ancora vedere le fondazioni del ponte romano), era lo snodo
principale di tale via di comunicazione, l’ultimo avamposto romano prima di
lasciare la linea difensiva adrianea165
.
Il forte abbandonato di Corstopium (oppure Coria, nome con il quale
viene menzionato nelle lettere rivenute a Vindolanda, derivato dal nome di una
tribù che era stanziata nelle vicinanze166
) ha fornito per gli edifici cittadini dei
secoli successivi materiale di costruzione. Non sappiamo con sicurezza se qui,
come nel caso di Vindolanda e Housesteads, ci fosse all’interno del castrum
una comunità cristiana, ma due oggetti potrebbero portarci verso questa
direzione, anche se possediamo soltanto dei disegni e delle descrizioni.
Intorno alla metà del ‘700, tra le acque del fiume Tyne venne ripescato
un piccolo vaso, alto 10 cm e del peso di 168 g, databile tra il IV e il V secolo,
di forma ovoidale che al di sotto dell’orlo presentava la scritta incisa
DESIDERI VIVAS167
; tale augurio può essere inteso in due accezioni:
nell’accezione pagana come augurio di una lunga vita, o nell’accezione
cristiana come augurio di aver raggiunto il premio celeste (si sarebbe
cancellato il resto della frase ricostruibile come DESIDERI VIVAS [IN DEO],
formula tanto cara ai cristiani di tutto l’orbis christianus), ma tale ipotesi non è
165
Dore 1989, p.56. 166
Rivet-Smith 1979, p.258. 167
Brand 1789, I, p.608.
52
verificabile data la scomparsa del reperto subito dopo il suo ritrovamento (fig.
29).
Anche del secondo oggetto non si hanno più notizie ed è conosciuto
solamente da descrizioni e disegni: nell’estate del 1736, in uno stato di
corrosione elevato (forse poco tempo dopo andò in pezzi, è questo il motivo
della sua sparizione), si rinvenne un catino argenteo a fondo piatto che pesava
560 g per un’altezza di 10 cm e un diametro di 22 cm; il catino in sé non
presentava ornamenti, se non una rosa al centro del fondo, mentre sull’orlo più
esterno erano posti a sbalzo 57 pomelli e nello spazio risultante tra un pomello
e l’altro vennero incise girali d’acanto, intervallate da sei monogrammi
costantiniani racchiusi in una cornice quadrangolare168
(fig. 30). Probabilmente
il catino doveva avere una funzione all’interno dei riti comunitari, soprattutto
per il rito battesimale.
La chiesa di Sant’Andrea (fig.31) sorge al centro del villaggio, di fronte
si apre la piazza del mercato. L’edificio che oggi possiamo ammirare consiste
in una torre occidentale, una navata centrale affiancata da due laterali che
continuano verso ovest congiungendosi alla torre, un transetto asimmetrico ed
un presbiterio fiancheggiato da una piccola cappella nella parte settentrionale
(fig.32).
Le tracce di epoca anglosassone è possibile rintracciarle nelle murature
della navata e nella torre, la quale in origine costituiva il portico ad uno o due
piani, ma rasati in un momento successivo per costruire la cella campanaria169
.
Vista dall’esterno (fig.33), la torre presenta tracce di un ingresso, oggi chiuso
per ospitare una moderna trifora (fig.34); la porta misura 3 metri in altezza e
2,7 metri in ampiezza, senza imposte e l’arco è formato da pietre solo in
apparenza a cuneo, ma che in realtà sono semplicemente piatte. La torre venne
eretta in un periodo successivo, quando le incursioni degli Scozzesi si fecero
168
Lettera manoscritta di Robert Cay alla London Society of Antiquaries datata 28 Ottobre 1736 (Hodgson
1832 p.246). 169
Taylor 1965, I, p.173.
53
più pesanti e la chiesa aveva bisogno di difesa: a tale scopo venne sacrificato il
piccolo portico quadrangolare che dava accesso alla chiesa; l’edificio
anglosassone misura 16,8 metri di lunghezza per 6 metri di larghezza,
rimanendo nella casistica degli edifici anglosassoni del VII sec.
Per la costruzione dell’intero edificio vennero utilizzate pietre
provenienti dalla vicina Corstopitum ed anche un intero arco, posizionato in
blocco tra la porta murata della torre e l’edificio vero e proprio170
.
IV.10 Heddon-on-the-Wall
Di fondazione romana, Heddon-on-the-Wall si trova ad 11 km da
Newcastle. La cittadina potrebbe essere identificata con la località denominata
da Beda Ad Murum, facente parte dei possedimenti del re Oswiu, dove furono
battezzati il principe Alhfrith ed il suo seguito dal vescovo Finàn171
: tale luogo,
specifica il monaco, si troverebbe alla distanza di “dodici miglia dal mare
orientale e vicino alla muraglia eretta dai Romani in difesa della Britannia”172
e
Heddon rispecchia esattamente la descrizione sopra riportate. Alcuni
commentatori del testo propongono di identificare Ad Murum con il villaggio
di Wallbottle, basandosi sulla toponomastica (in sassone weall “muro” e botl
170
Taylor 1965, I, p.170. 171
Beda, HEA, III, XXI, 15-18 (ed. Lapidge, II, p.97). 172
Beda, HEA, III, XXII, 23-26 (ed. Lapidge, II, p.101).
54
“abitazione”), dato che l’antico traduttore della Historia Ecclesiatica rende il
latino Ad Murum con la forma æt Walle173
.
La chiesa di sant’Andrea (fig.35) oggi consiste in un edificio del XII-
XIII secolo, con un’unica navata molto ampia, un portico meridionale ed un
presbiterio privo di abside. Della chiesa di epoca anglosassone (fig.36) rimane
parte del muro meridionale della navata, oggi inglobato nel presbiterio:
all’esterno si nota la presenza di una porta (a), murata in epoca successiva,
sormontata da una pietra semicircolare ed un’altra simili all’interno in un
pilastro interno della chiesa (c).
Durante i restauri del 1937 è stato possibile ritracciare le fondazioni delle
mura anglosassoni, grazie alle quali è stato possibile ricostruire la planimetria
dell’edificio, la quale rispecchiava la struttura tipica degli edifici ecclesiastici
della fine del VII secolo: una navata unica terminate con un’abside, lunga una
ventina di metri (b).
Per la datazione dell’edificio si può proporre la fine del VII secolo,
basandosi sulla dedica a sant’Andrea: insieme ad Heddon-on-the-Wall, sono
tre le località nelle vicinanze che presentano la medesima dedica (Corbridge,
Bywell e Hexham), forse tutte riconducibili al vescovo Wilfrid, devoto a tale
santo.
173
Lapidge 2006 p.541.
55
IV.11 Lindisfarne (Holy Island)
Holy Island è un’isola di piccole dimensioni a due km dalle spiagge di
Bamburgh, a cui è unita da una strada costruita nel 1954 poggiante su una
striscia di terra conosciuta già in antico (vedi capitolo II, secondo paragrafo),
utilizzabile soltanto con la bassa marea (fig.37).
Già abitata durante il Mesolitico, non venne colonizzata dai Romani e fu
scelta nel 635 dal monaco Aidan come sede del suo monastero e centro della
missione di cristianizzazione della regione; la scelta di tale luogo da parte di
Aidan deriva forse da due fattori di carattere geografico: l’isola è vicina a
Bamburgh allora capitale del regno e la somiglianza con Iona, monastero dal
quale proveniva; anche Iona è separata da un braccio di mare di circa 2
chilometri dalla costa occidentale dell’isola di Mull, entrambe le isole
appartenenti alle Ebridi Interne.
All’arrivo sull’isola, Aidan costruì verosimilmente una chiesa di legno,
semplice e provvisoria, per la necessità dei suoi monaci, ma la più antica
memoria che abbiamo di una chiesa a Lindisfarne si riferisce ad una struttura di
legno costruita dal successore di Aidan come priore del monastero, Finàn:
doveva probabilmente essere più grande per adeguarla a sede vescovile, ma
ancora una volta venne preferito il legno alla pietra e il tetto venne ricoperto di
canne, “alla maniera degli Scoti”174
e dedicata dal vescovo Teodoro nel 670 in
onore dell’apostolo Pietro175
. Non è stato trovato alcun resto di chiese di legno
dell’epoca di Aidan e Finàn e la loro dislocazione è ignota.
174
Beda, HEA,III, XXV, 4 (ed. Lapidge, II, p.119). 175
Beda, HEA,III, XXV, 6-7 (ed. Lapidge, II, p.119).
56
Vestigia di un vallum monastico sono state individuate in recenti
campagne di scavo176
e nello stesso sito vennero rinvenute diverse pietre
scolpite, databili dall’VIII al X secolo177
.
Di recente è stata avanzata l’ipotesi che il monastero fosse dotato di due
chiese, disposte lungo un asse est-ovest, quella occidentale dedicata alla
Vergine, quella orientale dedicata a san Pietro e situate all’incirca dove poi
venne costruito il priorato romanico178
.
Fino alle invasioni vichinghe del 875, nel priorato era conservata il corpo
di Cuthberto, morto nel 687, posto in un sarcofago litico al di sotto dell’altare
della chiesa monasteriale. Undici anni dopo, il sarcofago fu riaperto per porlo
in un nuovo sarcofago ligneo e “per poter essere venerato al di sopra del
pavimento”179
, e, con grande sorpresa dei monaci che assistevano alla
cerimonia, il corpo del loro fratello era ancora incorrotto180
. Grazie a questo
episodio miracoloso, la fama di santità di Cutberto si estese a tutta la Britannia,
diventando uno dei santi più popolari.
Il sarcofago ligneo ora è custodito nel museo della cattedrale di Durham
(fig.38), dove riposano le ossa di Cutberto in un moderno sacello. Il sarcofago
è l’unico oggetto ligneo di una certa importanza sopravvissuto nell’Inghilterra
anglosassone: si tratta di una cassa in legno di quercia lunga 1,98 metri; nel
1889 la cassa era ormai completamente in frammenti e solamente nel 1939, dei
7000 frammenti raccolti, lo storico dell’arte Erst Kitzinger selezionò 169
frammenti che componevano la decorazione e li riunì insieme181
: sul coperchio
sono incise le immagini del Cristo circondato dal Tetramorfo (fig. 39), su uno
dei lati corti la più antica rappresentazione superstite della Vergine col
Bambino al di fuori di Roma dell’arte medievale della chiesa occidentale
176
O’Sullivan 1989, pp. 125-142. 177
Peers 1925, pp. 255-277. 178
Blair 1991, pp.47-53. 179
Beda, HEA, IV, XXVIII, 5-9 (ed. Lapidge, II, p.312). 180
Beda, HEA, IV, XXVIII, 11-16 (ed. Lapidge, II, p.312). 181 Kitzinger 1956, pp. 202-206.
57
(fig.40) e sul lato opposto gli arcangeli Gabriele e Michele, mentre sui lati
lunghi la teoria dei Dodici Apostoli e cinque angeli.
Correlati alle figure, i fautori della cassa fecero apporre di tituli
esplicativi, anche se molti di essi sono in leggibili, sia in latino che in runico.
Le uniche che è possibile leggere chiaramente sono sul coperchio:
Ihs Xpr Mat(t)[h](eus) Marcus LVCAS Iohann(i)s (RAPH)AEL
(M)A(RIA)182
Solamente i nomi dell’evangelista Luca, dell’arcangelo Gabriele e della
Vergine vengono scritti in latino, mentre il resto riporta con lettere runiche i
nomi latini. Da notare come anche il greco ΧΡΙΣΤΟΣ sia reso in con lettere
dell’alfabeto scandinavo.
Questa mescolanza linguistica non è nuova in questa parte della
Britannia dove, a partire dal IX secolo, è possibile apprezzarla su epigrafi
funerarie nel cimitero di Lindisfarne e in quello di Monkwearmouth, mentre
per quanto riguarda gli oggetti, sul cofanetto Franks, databile alla seconda metà
del VII secolo.
All’interno del sarcofago, vennero posti alcuni oggetti appartenenti a
Cutberto, posti nel tesoro della cattedrale fin dal 1827, quando la tomba fu
aperta per porre le ossa nel nuovo sacrario: una croce pettorale in oro, un
pettine in avorio, un altare portatile e una copia personale del Vangelo di
Giovanni. Inoltre venne trovato un secondo teschio che, grazie alle fonti,
sappiamo essere quello del re Oswald.
182
In minuscolo sono indicate le lettere in runico, mentre in maiuscolo le lettere riportate in latino. [Però i
nomi propri anche usando il minuscolo hanno l’iniziale maiuscola]
58
IV.12 Hexham
Una chiesa abbaziale, posta sul lato occidentale della piazza del mercato,
è un monumento imponente, risalente al XII-XIII secolo (fig.40).
Il presbiterio viene datato tra la fine del periodo normanno e l’inizio del
Basso medioevo inglese. Prima della ricostruzione della navata nel 1918, l’area
che doveva ospitarla rimase un terreno desolato per secoli: non è chiaro quanto
del progetto medievale fosse portato a termine quando i lavori subirono
l’arresto definitivo a causa delle scorrerie scozzesi, la più grave delle quali si
verificò nel 1296.
L’edificio sorge nel medesimo luogo della chiesa fatta costruire da
Wilfrid: ne è prova la cripta, la quale è identica ad un’altra fatta costruire da
Wilfrid per la chiesa di Ripon, nello Yorkshire. La cripta fu dimentica fino alla
sua riscoperta nel 1726, durante gli scavi per rinforzare i pilastri dell’angolo
nord ovest della torre campanaria: il luogo era stato riconvertito a tomba
comunitaria di una famiglia locale.
Wilfrid cominciò la costruzione tra il 672 e il 678, dopo aver ottenuto
dalla regina Æthelthryth i terreni per l’edificazione e per tale progetto, che
voleva il più maestoso della Britannia, il vescovo portò con sé maestri muratori
provenienti da Roma, dall’Italia, dalla Gallia e da altri territori
dell’Occidente183
.
Le parti originali della chiesa di Sant’Andrea, a cui è dedicato l’edificio,
ancora visibili, non riescono a dare l’idea della complicata struttura a causa
della poco e soprattutto mal studiata navata nell’unica opportunità che si
183
Richard di Hexham, The priory of Hexham, V (ed. Andrews and Co., Durham 1894 p. 20). Stefano di
Ripon riporta solamente maestranze provenienti genericamente dal nord (Stefano di Ripon, Vita sancti
Wilfridi, 14, ed. Colgrave pp.20-22).
59
presentò agli archeologi per poter scavare il sito, ovvero la costruzione della
nuova navata nel 1908 (fig.41).
La dedica all’apostolo martire in terra scozzese, deve essere stata scelta
da Wilfrid forse per una sua particolare devozione, nata durante i suoi studi
giovanili al monastero di Lindisfarne, fondato da Aidan, che si era formato a
Iona, monastero della Scozia meridionale.
Si possono distinguere due diverse classi di resti architettonici della
prima chiesa di Hexham: resti “visibili” e resti veduti e descritti da C.C.
Hodges, architetto residente nella cittadina e studioso appassionato
dell’abbazia, durante il periodo 1880-1910184
.
Resti “visibili”
Nella parte sud-est dell’edificio è possibile vedere una zona abbastanza
estesa di pavimento costituita da lastroni (a). Durante la ricostruzione della
navata, venne scoperto che tali lastroni poggiavano su un letto di malta che si
trovava al di sopra della superficie superiore della volta della cripta. La malta
risultò essere dello stesso tipo di quella usata per la cripta e per il muro
settentrionale della navata.
Dietro la pavimentazione dell’odierno presbiterio, una botola conduce ad
un’area in cui è conservata intatta la sezione orientale e parte della parete
dell’antica abside, anche se da alcuni viene interpretata come una piccola
cappella separata dal complesso ecclesiastico185
(b). Al centro dello spazio
semicircolare si trovava una cattedra in pietra, denominata Frith Stool (fig.41),
sede del vescovo durante la celebrazione dei riti, oggi posta al centro del coro.
184
Hodges-Gibson 1919. 185
Taylor 1965, I, p.305.
60
Lungo la parete semicircolare dovevano essere posti gli scranni o i banconi per
il resto del clero, posizione comune alle chiese dal V al VII secolo a Roma e
nella zona del Mediterraneo orientale (il cosiddetto synthronon).
Qui si doveva accedere passando attraverso un arco trionfale, ricco di
pitture e statue policrome ad alto rilievo186
, anche se queste descrizioni bisogna
prenderle con le dovute precauzioni: la cattedrale venne in gran parte distrutta
e data alle fiamme da una scorreria di Danesi nel 875 e l’edificio non venne
ricostruito prima del XII secolo, periodo in cui scrive Richard che
probabilmente poteva vedere solo parte della navata costruita da Wilfrid ancora
in piedi187
.
La cripta (fig.43), che si può apprezzare nella sua interezza, è l’esempio
di come la visita alle catacombe romane compiuta da Wilfrid durante i suoi
soggiorni nell’Urbe, abbia inciso sulla costruzione di questo luogo adibito alla
conservazione delle reliquie: vi si accede attraverso una scala di pietra posta al
centro della navata, che conduceva i pellegrini in un ambiente di 3,2x1,8 metri
voltato a botte dal quale, probabilmente attraverso una grata, avrebbero potuto
vedere le reliquie disposte in un ambiente più ampio rispetto al precedente, ma
anch’esso voltato (5x3 metri), con tre nicchie scavate nel terreno come
appoggio per le lampade (fig.44). Dopo aver visto le sacre spoglie, i pellegrini
passavano attraverso un passaggio, ad una piccola stanza rettangolare, nella cui
volta triangolare è possibile vedere due epigrafi (di cui una facente parte di un
altare) di età imperiale (fig.45); da qui un altro corridoio correva verso est e poi
girava verso nord, dove si trovavano le scale di uscita per i fedeli.
Dall’ambiente principale si apre un ulteriore passaggio, che conduce in
altro spazio rettangolare e volte triangolari, con uscita opposta all’altro
corridoio: con tutta probabilità questo passaggio era riservato solamente al
clero, dato che da questo passaggio introduceva direttamente nel “sancta
sanctorum”.
186
Richard di Hexham, The priory of Hexham, III (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p. 12). 187
Taylor 1965, I, p.196.
61
Per costruire la struttura vennero utilizzate pietre lavorate prese
direttamente da edifici romani o dal Vallo stesso. Notevole la notizia che vi
fossero più luoghi sotterranei: Richard di Hexham annota criptis et oratoriis
subteraneii 188
, di cui però non si ha nessuna traccia, come dell’atrium189
, di cui
non si conosce l’ubicazione, se non da un’opera di un monaco francese del XII
secolo, Ælred de Rievaulx, il quale dice che l’atrium di sant’Andrea si trovava
tra la fine della parte orientale dell’edificio e la chiesa di Santa Maria190
.
Il problema è se Richard di Hexham intendesse con questo termine lo
spazio antistante l’entrata principale della chiesa, chiuso da un quadriportico
(se corrisponde con la frase magnae spissitudinis et fortitudinis muro del testo),
come gli edifici ecclesiastici visti da Wilfrid sul continente, oppure un luogo
adibito a cimitero, se accettiamo la localizzazione data dal monaco Ælred: in
quella zona, infatti, durante i lavori del 1908 furono trovate diverse
sepolture191
.
Resti veduti e descritti dall’Hodges
Al di sotto della pavimentazione anglosassone, furono viste, dove oggi si
trovano il colonnato meridionale e quello settentrionale, delle fondazioni per
alloggiare dei pilastri che avrebbero dovuto sorreggere le arcate della navata,
vista la grandezza dei letti di malta (4 metri)192
.
188
Richard di Hexham, The priory of Hexham, III (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p. 11). 189
Richard di Hexham, The priory of Hexham, III (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p.13). 190
Ælred de Rievaulx, De miraculis, p.134 Kalamazoo, Cistercian Publications, 2005. 191
Taylor 1965, I, p.198. 192
Hodges-Gibson 1919, p.41.
62
Sembra possibile che vi fosse una piccola navata laterale, che non è stata
registrata nel suo lavoro, ma che l’Hodges riporta nella pianta da lui redatta:
dovrebbe trattarsi di tracce di muratura (d), di un muro intermedio tra i pilastri
della navata centrale e il muro settentrionale.
All’esterno, nella zona meridionale, venne ritrovata la traccia di un
muro: senza ombra di dubbio tale fondazione doveva essere quella del muro
meridionale della chiesa di Wilfrid (b) ed anche qui, dalla pianta è possibile
notare un altro muro prospiciente a questo, a formare un’altra navata (c).
Di difficile interpretazione sono le tracce di una fondazione (d) che si
estende lungo la zona meridionale del transetto per la lunghezza di 24 metri
partendo dalla sala capitolare al centro dello stesso transetto: l’idea che possa
essere un piccolo portico d’accesso, proposta dall’Hodges193
, non dovrebbe
essere del tutto scartata, visto l’esempio di San Pietro a Bywell e della
descrizione delle cronache di Richard194
.
Sempre nella sala capitolare, dove oggi si trova il coro, nel 1908
apparvero dei grandi blocchi di pietra squadrati uniti da malta, che secondo
l’Hodges avrebbero dovuto formare una piattaforma rialzata dove si sarebbe
trovato l’altare: dal piano, però, si potrebbe ipotizzare che la “piattaforma”
formasse in qualche modo un corpo unico con l’abside, il che avvalorerebbe
l’ipotesi del Taylor che l’abside precedentemente fosse un edificio estraneo,
poi inglobato nel complesso; un altro indizio in questo senso è la presenza di
sette sepolture in questa zona (e), come se fosse un piccolo cimitero
indipendente: in totale, dislocate in varie parti dell’edificio (di cui due
all’interno della navata), le sepolture ammontano a 23, di cui sono conservate
le lastre di chiusura.
Grazie alle informazioni e planimetrie fornite dall’Hodges195
è possibile
risalire alle dimensioni della chiesa di Sant’Andrea: la navata doveva misurare
193
Hodges-Gibson 1919, p.42. 194
Richard di Hexham, The priory of Hexham, III (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p. 12). 195
Hodges-Gibson 1919.
63
30,5 metri di lunghezza e 7,5 metri di larghezza, mentre la “cappella” era di 7
metri di lunghezza per 3,5 metri di larghezza, per un totale di 37 metri di
lunghezza per tutto il complesso.
Oltre a sant’Andrea, altre due chiese vennero costruite nello stesso
periodo da Wilfrid: a pochi metri di distanza dalla cattedrale si trovava un
edificio di modeste dimensioni dedicato alla Vergine, distrutto intorno al XVII
secolo, di cui rimane solamente una porzione di muratura, forse parte del
presbiterio ed una colonna, inglobate entrambe in una casa costruita sul sito e
la toponomastica della strada e la piazza sulla quale essa si affacciava, Old
Church Street e St. Mary Chare.
Le fonti antiche ci informano sul motivo della costruzione di questa
chiesa: Stefano di Ripon, il biografo di Wilfrid, e Beda196
raccontano che il
vescovo, in viaggio verso Roma, si trovava a Meaux, una cittadina francese, e
lì cadde gravemente malato e rimase in coma per cinque giorni; al quinto
giorno Wilfrid si svegliò e raccontò della visione avuta durante il sonno:
l’arcangelo Michele gli spiegò che la sua guarigione era dovuta
all’intercessione della Vergine Maria.
La piccola chiesa doveva essere usata forse come cappella aggiunta alla
cattedrale e subordinata ad esso, quindi servita da un canonico proveniente dal
complesso monasteriale e riprendeva in miniatura una chiesa italiana, vista la
presenza massiccia di maestranze provenienti dalla penisola; con tutta
probabilità, come le altre chiese della medesima zona, doveva presentarsi come
un edificio a navata unica, con un’abside rivolta ad est, al cui centro doveva
essere posto l’altare.
Richard cita anche la chiesa di san Pietro, ma la sua ubicazione è
sconosciuta197
. Anche i catasti medievali dei luoghi sacri della diocesi di
Hexham tacciono sulla sua ubicazione esatta, ma l’edificio cessa di essere
196
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi, 56 (ed. Colgrave pp.120-122); Beda, HEA,V, XIX, 194-221
(ed. Lapidge, II p.119). 197
Richard di Hexham, The priory of Hexham, IV (ed. Andrews and Co., Durham 1894, p. 15).
64
registrato dal 1310, forse distrutta a causa delle endemiche razzie degli
Scozzesi nella regione e mai più ricostruita o abbandonata e lasciata in stato di
decadimento.
IV.13 Hart
Il villaggio di Hart è situato a 5 chilometri a nord-ovest da Hartlepool.
Non si hanno notizie sul villaggio prima del IX secolo, quando il vescovo
Ecfred di Lindisfarne concede alla comunità di San Cutberto degli
appezzamenti di terra “presso Billingham nell’Heorternesse”198
: il toponimo
Heorternesse si è conservato fino al XIX secolo in Hartness, toponimo con cui
il villaggio di Hart era conosciuto, il cui significato, secondo Austin, deriva
dalle parole sassoni *heorot e *gehernes (letteralmente la “sala dell’ascolto”),
con il quale veniva indicata un’area amministrativa199
, quindi probabilmente
Heorternesse era il territorio sotto l’amministrazione del villaggio di Hart.
Non sono d’accordo completamente con la traduzione che Austin da del
toponimo: *heorot, nell’antico inglese, significa “cervo” e non “sala”200
, ma il
senso potrebbe essere sempre quello di un luogo dove si amministrava il
territorio; in aiuto ci viene un passo del Beowulf, il poema anonimo
anglosassone composto tra l’VIII e l’XI secolo, in cui viene descritta una
grande sala dove il leggendario re danese del VI secolo Hroðgar svolgeva le
198
Hart 1975, p.138. 199
Austin 1976, p.73. 200
DEPN 1960, p.222.
65
sue mansioni che viene chiamata Heorot, la “Sala del Cervo”201
. Il fatto di aver
scelto questo nome potrebbe far ipotizzare una vasta circolazione orale e forse
scritta delle leggende legate al personaggio di Beowulf, le quali arrivarono
nell’ East Anglia sembra intorno al VII secolo, viste anche le affinità tra il sito
funerario di Sutton Hoo e le genti scandinave202
.
Ancora una volta ci vengono in aiuto i toponimi del territorio di Hart che
evocano edifici e luoghi che l’archeologia non è più in grado di rintracciare: ad
un km dal centro cittadino si stende un campo posto a coltura denominato
Kirkfield, area nota anche nei catasti del 1770 come “Old Kirk”; kirk è una
parola di origine scandinava equivalente all’odierno inglese church (chiesa): il
toponimo potrebbe indicare un campo nel quale sorgeva una chiesa oppure un
fondo ecclesiastico203
.
L’unica chiesa superstite del villaggio di Hart si trova a nord della strada
principale che da Hartlepool porta a Durham, al di sopra di una piccola collina
dedicata a Maria Maddalena (fig.46).
La pianta ricorda molto da vicino gli altri edifici ecclesiastici fin qui
riportati, anche se a prima vista, non vi sono elementi architettonici che
inducano a datare il complesso prima del XII secolo, se non l’arco di accesso al
presbiterio, la cui cronologia è oggetto di controversia tra gli studiosi.
L’arco (fig.47) si trova all’interno della chiesa è chiaramente di epoca
normanna: l’uso di pietre non squadrate per la tecnica muraria sia qui che nel
resto del complesso rinvia cronologicamente al XV secolo, quando vennero
costruiti il portico e la navata meridionale204
. Da notare, però, al di sopra
dell’arcata, un’altra piccola arcatella, posta come alleggerimento della struttura
muraria sovrastante o come suggerisce Taylor, l’unica parte sopravvissuta
dell’arco trionfale di epoca anglosassone205
.
201
Beowulf, v.74-79 ed. Hudson 2007. 202
Newton 1993. 203
Watts 2002, p.126. 204
Daniels 2012, p.20. 205
Taylor 1965, I, p.288.
66
Nonostante l’incertezza sulla datazione dell’edificio, all’interno della
chiesa vengono conservate due frammenti fittili di colonnine (fig.48), forse
facenti parti di una costruzione libera all’interno della chiesa stessa. Simili
oggetti sono stati rinvenuti nel monastero di Hilda ad Hartlepool, databili tra il
VII e l’VIII secolo206
: la presenza di queste colonnine potrebbero indicare uno
stretto legame tra le due località, facenti parte dello stesso territorio
ecclesiastico, dove i chierici del monastero venivano inviati per la loro
missione pastorale. Durante scavi condotti negli anni ’50 del XX secolo,
vennero alla luce diversi fori per pali che indicavano la presenza di edifici
lignei, ma il loro stato di conservazione rese molto difficoltosa la
comprensione di tali edifici207
; con sicurezza venne rintracciata una trincea
usata per innalzare una palizzata che doveva proteggere l’area intorno alla
chiesa208
. E’ possibile che le colonnine fittili sopracitate fossero delle
decorazioni per proteggere la struttura lignea di un edificio, forse della
primitiva chiesa di Hart.
Altro particolare interessante la presenza di una meridiana (fig.49), oggi
murata nel portico meridionale, di cui si conosce solo un altro esempio nella
chiesa di Escomb, mentre in Northumbria è totalmente assente.
206
Daniels 2012, p.15. 207
Austin 1976, p.84. 208
Austin 1976, p.87.
67
IV.14 Seaham
Seaham è un piccolo villaggio di pescatori che si trova a 300 metri dalle
scogliere della costa della contea di Durham, sul versante settentrionale della
valle di Seaham Burn.
L’attuale villaggio è sorto ad un chilometro dalla chiesa di Santa Maria,
la quale era circondata dal villaggio precedente, di cui rimangono gli edifici del
vicariato e della sala per le assemblee.
La chiesa dedicata alla Vergine (fig.50) non era stata associata all’epoca
anglosassone prima del 1913, quando furono decisi dei lavori di
ristrutturazione dell’edificio e degli scavi al di sotto del terreno che circondava
la chiesa209
: gli scavi di Aird portarono alla luce le fondamenta antiche
dell’edificio, ricalcate dalla pianta normanna successiva, ma con un presbiterio
molto più piccolo (3x2 metri rispetto ai 10,7x7 metri) e un annesso occidentale,
forse un portico o un battistero, nel luogo dove oggi sorge la torre risalente al
XII secolo. Aird dedusse, confrontando la pianta e le finestre presenti sulla
navata con la cappella di Escomb, che questi due edifici dovevano essere
contemporanei, viste le loro evidenti somiglianze architettoniche, mentre altri
studiosi asserirono che le murature utilizzate per la parete settentrionale erano
caratteristiche costruttive tipiche dei lavori effettuati nei venti o trenta anni
seguenti la conquista normanna; la teoria di Aird venne avvallata anche da
Taylor, che datò il complesso tra il 650 e il 700, basandosi anche sulla pianta
dell’edificio che ricalca fedelmente le chiese sassoni della Northumbria210
.
All’interno, la navata (16,5x6 metri) presenta una muratura formata da piccole
209
Taylor 1965, II, p.534 210
Taylor 1965, II, p.535
68
pietre squadrate alternate da cunei di grandi dimensioni, anche questa
riconducibile all’epoca anglosassone.
IV.15 Sockburn
A sud di Darlington, l’ansa del fiume Tees crea un piccolo lembo di
terreno chiamato localmente “la penisola di Sockburn”: qui sorge il villaggio
che dà il nome alla “penisola” (fig.51).
Non si hanno notizie riguardanti Sockburn prima della fine dell’VIII
secolo, quando viene citata con il nome di Sochasburg in connessione alla
consacrazione dell’arcivescovo Endbald II nel 796211
e a partire dal X secolo
scompare dalle cronache, probabilmente a causa degli sconvolgimenti che il
territorio subì a causa delle razzie vichinghe e del loro successivo stanziamento
nella contea.
A pochi passi dalla Sockburn Hall, residenza dei nobili locali, i Conveys,
è possibile notare delle arcate gotiche completamente in rovina (fig.52): è ciò
che rimane della chiesa dedicata a tutti i Santi, rimasta in uso fino al 1838,
quando una nuova chiesa e parrocchia furono create a Girsby, nello Yorkshire,
sull’altra sponda del fiume Tees.
Nel corso dei secoli l’edificio ha subito vari rimaneggiamenti, come ad
esempio la navata settentrionale edificata nel XV secolo, trasformata nel ‘700
come tomba di famiglia, ma già nel 1891 l’Hodges, il primo ad averla
211
Simeone di Durham, Libellus de exordio, II (ed. Rollason, p. 155).
69
rintracciata dopo secoli d’oblio, la descrive già in stato di rovina ed
abbandono212
(fig.53).
L’unico indizio che far ipotizzare che l’edifico già esistesse durante
l’epoca anglosassone è la navata, la quale misura 8,5x5,3 metri, misure simili
alla piccola chiesa di Escomb, anche se in scala minore213
.
Durante gli scavi effettuanti nel 1900 per il restauro della tomba
familiare dei Conveys, vennero rintracciate delle fondazioni, che vennero
identificate con quelle del presbiterio della chiesa anglosassone64
.
IV.16 Staindrop
Situato a 20 chilometri a nord-ovest di Darlington, sulla strada principale
che da Barnard Castle si dirige verso Auckland, Staindrop in passato era una
cittadina di mercato di una certa importanza, soprattutto quando la potente
famiglia Neville, nel XIV secolo, dimorava nel vicino Raby Castle.
La storia del villaggio comincia nel 1018, quando il re Canuto il Grande,
in pellegrinaggio verso Durham, pone la parrocchia di Staindrop ed altre sotto
il controllo ecclesiastico della chiesa di San Cutberto a Durham214
.
212
Hodges 1894, p.65-66. 213
Taylor 1965, II, p.555. 214
Simeone di Durham, Libellus de exordio, III (ed. Rollason, p. 276).
70
La chiesa di Santa Maria (fig.54), precedentemente dedicata a San
Gregorio, si presenta come un grande edificio a pianta centrale con presbiterio,
a cui è annessa una piccola residenza a due piani per il clero.
Il primo a comprendere che le murature della navata fossero di un’età
più antica rispetto al resto dell’edificio fu il reverendo Hodgson, comparandole
a quelle della chiesa di Escomb215
, ma anche in questo caso, la prova che il
primo edificio fosse effettivamente stato costruito negli stessi anni di Escomb
è molto labile; nella parte superiore si aprono piccole finestre di epoca
normanna (fig.55).
Secondo la ricostruzione di Taylor216
, l’antica navata di Santa Maria
avrebbe dovuto misurare 12,5 metri in lunghezza e 7 metri in larghezza, che
vengono giudicate da Ryder più vicine all’architettura normanna che a quella
sassone217
.
VI.17 Escomb
Prima che diventasse un centro minerario carbonifero, Escomb doveva
essere un villaggio molto simile ai molti che si affacciano sulle rive del fiume
Wear: solamente negli ultimi anni, dopo lo sviluppo minerario del XIX secolo,
la cittadina riscoprì il suo aspetto rurale.
215
Hodgson 1889, p.83. 216
Taylor 1965, II, p.566. 217
Ryder 1999, p.23.
71
La chiesa dedicata a San Giovanni l’Evangelista (fig.56) è il più
completo esempio di chiesa anglosassone insieme alla Cappella di Odda a
Deerhurst, nel Gloucestershire, e alla chiesa di San Lorenzo a Bradford-on-
Avon, nel Wiltshire, ma, rispetto a queste due, San Giovanni ha avuto una
ininterrotta continuità di vita, eccetto per un piccolo periodo tra il 1863 e il
1867, quando venne edificata in cima ad una collina nelle vicinanze.
L’antichità dell’edificio venne rilevata già dal reverendo Hoppell e da lui
descritta ai membri della “Durham and Northumberland Archaeological
Society” nel 1879218
. Nella sua Historia Ecclesiastica, Beda non cita Escomb è
il fatto è molto strano, visto che la cittadina si trova a poca distanza dal
monastero di Jarrow, nel quale Beda passò tutta la sua vita; è possibile
ipotizzare che San Giovanni venne costruita dopo il 735, data della morte di
Beda, ma l’ipotesi non può essere totalmente accettata: il monaco nomina
chiese che sono associate ad eventi storici che in quel momento lui sta
narrando.
L’edificio nella sua struttura è molto semplice: consiste in un’unica
navata, lunga 16,5 metri per 5 metri di larghezza, terminante in un piccolo
presbiterio quadrangolare (3,5 metri per lato) a cui si accede attraverso un arco
(5,5 metri in altezza e 2,5 metri in profondità) e per le murature vennero
utilizzate le pietre asportate dal vicino campo legionario di Vinovium (odierna
Binchester), distante 2 chilometri da Escomb219
.
L’edificio presentava due camere, una settentrionale ed una occidentale,
le cui fondazioni sono state rinvenute durante degli scavi effettuati nel 1968 ed
interpretate come due portici d’accesso alla navata.
In cima ai muri della navata, ad un’altezza di 4,5 metri dal suolo, si
trovano le quattro finestre originali, costruite tutte allo stesso modo (le imposte
218
Hoppel 1879, p.380-384. 219
Oltre al tipo di pietre che presenta una lavorazione di epoca romana, sul muro settentrionale esterno è
presente una parte di un’epigrafe su cui è possibile leggere LEG VI. La Legio sexta Victrix è attestata in
Britannia dal 120 d.C., quando venne trasferita dalla Germania Inferiore a Eburacum (York) per sopperire al
vuoto di truppe creatosi con la distruzione della IX Hispana (Le Bohec 1992, p.33).
72
sono formate da due lastre di pietra strette e due lastre rettangolari più grandi
per la piattabanda e il davanzale.
L’arco di accesso al presbiterio (fig.57) presenta delle affinità costruttive
con l’arco presente all’interno della torre di San Michele a Corbridge, il che
potrebbe portare ad ipotizzare anche qui la traslazione di un arco utilizzato
precedentemente per qualche edificio del forte di Binchester. Sul lato
settentrionale, sul muro retrostante il pulpito, è incisa, a 1,8 metri dal suolo,
una piccola croce di tipo celtico, contemporanea alla costruzione dell’edificio
(fig.58).
Nella parete settentrionale si aprivano due porte, murate in un secondo
momento: da notare la presenza su uno stipite di una decorazione vegetale
(fig.59), forse una spiga di grano, che alcuni resoconti descrivono come
“l’albero della vita” perché fiancheggiato da due figure umane (Adamo ed
Eva), ma oggi è impossibile distinguere qualcosa di associabile a delle figure
umane (fig.60).
All’esterno del muro meridionale, tra due finestre, ad un’altezza di 6
metri dal suolo, si nota una meridiana posta nella muratura (fig.61), il che fa
supporre che sia contemporanea all’edificio; la meridiana si presenta come un
semicerchio litico, incorniciato in basso da un cordone e sormontato da un
serpente, entrambi in altorilievo. Sono ancora visibili distintamente tre linee,
con un’angolazione di 45° e il foro per lo gnomone. A completamento di tutto
l’apparato decorativo, una pietra sporgente dal muro che sovrasta la meridiana,
forse una testa animale appena abbozzata.
73
IV.16 Chester-le-Street
La cittadina di Chester-le-Street si trova ad 11 chilometri a sud di
Newcastle e, come molte città e cittadine inglesi, il suo nome tradisce la sua
nascita dalla presenza di un forte legionario, il forte di Concangis220
. Il forte
venne costruito intorno al 100 nelle vicinanze della Cade’s Road, il cui nome
antico è sconosciuto, il cui tragitto si snodava da Eburacum (York) fino a Pons
Aelius (Newcastle).
Il nome Concangis deriva dalla latinizzazione della parola celtica
indicante “il popolo dei cavalli”, forse riferita ad una tribù celtica che abitava il
territorio.
Dopo l’abbandono della Britannia da parte delle legioni romane, non
abbiamo più notizie della cittadina almeno fino all’inizio dell’VIII secolo,
quando l’anonimo autore della Vita Sancti Cuthberti, racconta un miracolo
giovanile del non ancora monaco Cutberto avvenuto nei pressi di Chester-le-
Street: mentre stava accingendosi ad attraversare il fiume Wear in inverno,
Cutberto trova riparo in un’abitazione vuota. Al limite delle forze per i morsi
della fame, accade il miracolo: il suo cavallo fa cadere dal soffitto del riparo
del pane caldo e della carne221
. La leggenda del miracolo di Chester-le-Street
potrebbe essere la testimonianza di un antico culto tributato al monaco
northumbriano dopo la sua morte, avvenuta nel 687, nella cittadina e
l’abitazione dove avvenne la trasposizione leggendaria della prima chiesa
lignea di Chester-le-Street. Questa connessione tra Chester-le-Street ed il santo
divenne più forte quando nel’882
220
Il forte viene elencato tra i forti della Britannia nella Notitia Dignitatum (IV-V sec., Praefectus numeri
vigilum, Concangios ) e ancora nel VII sec. nella Cosmografia ravennate con il nome di Coganges (V 31,
p.432 ed. Pinder-Parthey) . 221
Colgrave 1940, pp.70-71.
74
Arrivarono dei monaci provenienti da Lindisfarne con il corpo del santo,
per difenderlo dalle razzie vichinghe che imperversavano sull’isola e rimase
nella chiesa a lui dedicata fino al 995, quando venne nuovamente traslato a
causa degli attacchi dei pirati danesi222
.
L’attuale chiesa di Santa Maria e San Cutberto (fig.62) sorge al centro
dell’abitato, costruita al di sopra dei principia del forte Concangis, ma
solamente la parte occidentale della parete meridionale del presbiterio presenta
una muratura composta da grandi pietre, riconducibile ad un edificio di epoca
anglosassone223
.
IV.17 Monkwearmouth e Jarrow
Il doppio monastero di Monkwearmouth-Jarrow fu fondato nel 674 da
Benedict Biscop, che in gioventù era stato compagno di Wilfrid nei suoi viaggi
e successivamente abate del monastero dei santi Pietro e Paolo a Canterbury, il
quale stabilì il primo nucleo del monastero a Monkwearmouth con la
costruzione di una chiesa dedicata a San Pietro in un terreno donato dal re di
Northumbria Ecgfrith224
. La missione a cui si era votato Benedict Biscop era
di fondare un monastero modello per sostituire alla Chiesa di tradizione celtica
la tradizione romana ed ottenne, grazie ad una lettera papale inviatagli nel 678,
che il monastero non fosse sotto il controllo della corona.
222
Battiscombe 1956, pp. 19-20; Selkirk 2000, pp.336-337. 223
Taylor 1965, II, p.716. 224
Beda, Historia abbatum 1-13 (ed. Plummer 1896).
75
Nel 682 il re concesse altro terreno a Bishop e gli chiese di fondare un
secondo monastero: così nacque una fondazione monastica “sorella” a Jarrow,
costituita intorno alla chiesa di San Paolo e posta sotto il controllo dell’abate
Ceolfrith a cui si aggiunsero venti monaci provenienti da Monkwearmouth, tra
cui un giovane monaco di nome Beda.
Monkwearmouth
Monkwearmouth è un’area a nord della foce del fiume Wear. In origine
era uno dei tre agglomerati, insieme a Sunderland e Bishopwearmouth, che
sorgevano sulle rive del fiume, una zona oggi nota come East End.
La chiesa di San Pietro oggi si presenta uno sviluppo longitudinale da
ovest ad est, la cui entrata si trova nella torre campanaria. Il corpo principale
consiste in un’unica stretta navata, nella quale si apre una larga struttura
moderna sul lato settentrionale, terminate in un presbiterio.
La torre campanaria si compone di cinque piani, ma è il piano più basso
quello che desta il maggior interesse: la torre risulta poggiare sull’antico
portico d’entrata, voltato a botte, che non solo introduceva alla navata, ma
anche a delle camere che si trovavano ad ovest della navata. La “porta
occidentale” (fig.64) non era propriamente una porta, ma costituiva l’entrata
principale e venne pensata come un vano aperto, senza la presenza di una
porta. Il vano è costruito seguendo lo “stile di Escomb”, alternando pietre
posizionate verticalmente ed orizzontalmente, con l’eccezione che le pietre
verticali sono decorate: i motivi ritraggono delle strane creature con la testa
76
simile ad un uccello, le quali intrecciano il loro corpo anguiforme in una specie
di lotta, ma non più visibili225
.
Al di sotto del soffitto sulla parete occidentale corre un cordolo
composto da pannelli riccamente decorati con animali in rilievo, ma in cattivo
stato di conservazione226
.
All’interno, la navata si presenta di grande proporzioni rispetto alle altre
chiese del medesimo periodo (10 metri di altezza per 23 metri di lunghezza),
ma solamente il muro occidentale è riconducibile all’edificio voluto da Biscop,
a causa dei danni procurati dall’attacco vichingo del 794 e della distruzione
compiuta dai Danesi nel 860.
La rimarchevole altezza delle pareti laterali e la presenza di tre finestre
sulla parete orientale una al di sopra dell’altra potrebbero far ipotizzare che la
navata possedesse due piani e che ognuna della finestre fornisce la luce
necessaria a ciascun piano. Le finestre si trovano rispettivamente a 9 metri dal
suolo, quelle relative al secondo piano ed a 7 metri.
Jarrow
Il monastero (fig.65) sorge anch’esso lungo la riva di un fiume, come il
monastero gemello, ma in questo caso è il fiume Tyne, che scorre più a nord
rispetto al Wear. Jarrow viene ricordato da Beda con il nome di Gyrwum227
,
225
Taylor 1965, II, p.438. 226
Taylor 1965, II, p.438.
227 Beda, HEA,V, XXI, 12 (ed. Lapidge, II, p.432).
77
toponimo che deriva dall’antico anglosassone (æt) Gyrwum che significa
“(presso) gli abitatori della palude”228
.
La chiesa monastica di San Paolo originaria (fig.66), che occupava la
navata dell’attuale edificio, rimase in piedi fino al 1782 e venne rimpiazzata
con un nuovo edificio, anch’esso demolito un secolo più tardi, nel 1866, sul
quale venne edificata la navata attuale. E’ notevole come, nonostante i vari
rifacimenti e il decadimento occorso durante i secoli, gran parte dell’edificio
sia rimasto intatto, anche se non ci sono testimonianze precise per quanto
riguarda la struttura da parte dei “demolitori” del XVIII secolo, se non il
resoconto dell’Hutchinson nella sua History of Durham, in cui descrive alcuni
particolari della chiesa: un piccolo portico faceva da ingresso alla chiesa la cui
porta di accesso è affiancata da un pastorale [spiegare meglio cosa sia] in
pietra, forse preso da una copertura tombale più tarda. Per accedere alla navata,
la quale si trovava qualche metro al di sotto del livello del suolo, bisognava
scendere tre alti gradini, ai lati dei quali si aprivano due archi, di cui quello
orientato a sud introduceva in un altro piccolo portico utilizzato come
sacrestia229
.
La navata era molto ampia, illuminata da finestre “irregolari, sormontate
da piccoli archi, raffazzonate in più punti, il che rendeva difficile attribuire le
varie parti ad un epoca precisa”230
. Per diversi anni la navata in rovina venne
utilizzata come cimitero e soltanto il presbiterio, precisa l’Hutchinson, veniva
usato per le messe231
.
Sul muro settentrionale della navata, ricorda ancora l’Hutchinson, era
posta l’ epigrafe dedicatoria della chiesa (fig.67); oggi l’epigrafe è ancora
intatta ed è possibile ammirarne una copia al pian terreno della torre
campanaria, al di sopra dell’entrata settentrionale, mentre l’originale si trova
poco prima di entrare nel presbiterio.
228
Ekwall 1960, p.268. 229
Hutchinson 1787, p.475. 230
Hutchinson 1787, p.475. 231
Hutchinson 1787, p.475.
78
DEDICATIO BASILICAE
S(an)C(t)I PAVLI VIIII K(a)L(endas) MAI(as)
ANNO XV ECFRIGI REG(is)
-------------------------------------------------------
CEOLFRIDI ABB(atis) EIVSDEM Q(uo)
Q(ue) ECCLES(iae) D(e)O AVCTORE
CONDITORIS ANNO IIII
Tale epigrafe, però, solleva una questione su chi sia il fondatore della
chiesa e, di conseguenza, di tutto il complesso monastico; Beda riporta Biscop
come fondatore del complesso e lui stesso ne pose come abate Ceolfrith, ma la
dedica pone l’abate come conditor della chiesa.
Tale discrepanza tra le fonti scritte e la fonte epigrafica è difficilmente
spiegabile: il Plummer proponeva, basandosi sulle notizie fornite da Beda, che
in quel periodo Biscop fosse assente per uno dei suoi viaggi a Roma e che per
quest’assenza non fu elencato tra i fondatori del monastero232
. Non è possibile
accettare la soluzione proposta dal Plummer per due motivi: il primo è che un
evento importante come la dedicazione della chiesa del monastero gemello di
Monkwearmouth non poteva essere celebrato senza il fondatore dello stesso e
il promotore, stando alle parole di Beda233
, della creazione di Jarrow; Biscop
avrebbe potuto cambiare i suoi piani per il viaggio o spostare il giorno della
dedicazione.
232
Beda, Historia abbatum 1-13 (ed. Plummer 1896). 233
Beda Historia abbatum, 9 (ed. Plummer 1896 p.373).
79
Il secondo è che Beda stesso non fornisce nessuna coordinata
cronologica per il viaggio che il Plummer ipotizzò potesse essere stato
compiuto da Biscop nell’aprile del 685.
E’ possibile supporre che all’inizio Jarrow fosse una fondazione separata
e solamente dopo la morte di Biscop Ceolfrith divenne abate di entrambi i
monasteri. Se si accetta questa ipotesi, bisogna rivalutare il tipo di donazione
fatta da re Ecgfrith: Monkwearmouth venne fondata da Biscop su un terreno
donato dal re, mentre Jarrow venne fondata dal re in persona; la Vita Ceolfridi
attesta che il terreno dove sarebbe sorto il monastero di Jarrow venne donato
per l’anima del re234
: la frase pro redemptione animae suae potrebbe essere
l’eco del motivo della costituzione del monastero; quindi Ecgfrith non ha
donato il terreno né a Biscop né a Ceolfrith, ma direttamente a Dio ed essendo
una fondazione legata strettamente alla casa reale, a differenza della
fondazione gemella, Ceolfrith è l’abate del re.
Osservando il muro meridionale del presbiterio si notano tre piccole
finestre, del tutto simili a quelle presenti nella chiesa di Escomb, di cui una
conserva l’originale decorazione vitrea. Al di sopra di questa è possibile
intravedere i resti di un’entrata in seguito murata, che doveva dare accesso ad
una galleria superiore nel lato occidentale.
Per ricostruire la storia architettonica del complesso monasteriale
possiamo avvalerci di tre disegni ed una planimetria, conservati al British
Museum di Londra: il primo disegno, datato 1728 e firmato da certi fratelli
Buck (fig.68), mostra la chiesa e gli edifici monastici visti dal lato sud-ovest; il
secondo è un disegno anonimo che mostra l’interno in elevato datato 1769,
stessa data riportata sulla planimetria (fig.69). L’ultimo disegno è ancora una
veduta degli edifici firmata J. Grim, ma stavolta la prospettiva è orientata verso
nord (fig.70).
234
Vita Ceolfridi, 11 (ed. Plummer 1896 p.391).
80
Questi disegni sono di estrema importanza per mettere in connessione il
presente edificio con quelli che l’hanno preceduto.
Grazie all’anonima planimetria dell’alzato ed alla descrizione dell’
Hutchinson, è possibile ipotizzare la grandezza della basilica (doveva misurare
32 metri di lunghezza per 7 metri di larghezza, con le pareti laterali che si
alzavano per 10 metri dal suolo), con un portico occidentale a due piani e la
navata doveva essere affiancata da piccole cappelle laterali.
Il presbiterio oggi visibile, in realtà era una cappella adiacente al corpo
principale della chiesa: l’assetto dato a questi due edifici ricorda molto la
distribuzione degli edifici a Canterbury nel monastero di sant’Agostino, dove
una cappella dedicata alla Vergine si trova simmetricamente ad est della chiesa
principale. Questa somiglianza tra monasteri così lontani geograficamente, ci
riporta alla discussione sulla fondazione del complesso di san Paolo, dato che
alcuni studiosi ritengono questa similarità un indizio a favore di Biscop, il
quale per due anni fu abate proprio a Canterbury ed a questo si ispirò quando
fondò il proprio monastero235
.
Per quanto riguarda la decorazione, ancora Beda ci viene in aiuto,
dicendo che la chiesa era ornata da tavole dipinte raffiguranti Cristo ed altri
personaggi biblici236
.
La cappella e la chiesa di san Paolo furono unite in un solo edificio nel
1073 o nel 1074 dal vescovo di Durham Aldwin, il quale desiderava
ristrutturare i monasteri legati alla figura di Beda.
235
Taylor 1965, I, p.343; Radford 1954, pp.203-205. 236
Beda Historia abbatum, 6 e 9 (ed. Plummer 1896 p.369, p.373).
81
IV.18 Hartlepool
Hartlepool si trova a 9 chilometri dall’estuario del fiume Tees ed il suo
nome deriva dall’antico inglese e significa “Isola del Cervo” (da heorot, cervo
ed eg, isola)237
: è con questo toponimo che Beda (traducendolo correttamente
in Insula Cervi) si riferisce alla penisola costiera sulla quale sorgeva il
monastero di Heiu.
Intorno alla metà del VII secolo, ad Hartlepool venne fondato un
monastero doppio da Heiu, una donna di stirpe nobile che Beda afferma essere
stata la prima in Northumbria che decise di dedicarsi alla vita religiosa, con la
consacrazione del vescovo Aidan238
. Nel 655 re Oswiu mandò sua figlia
Ællflæd di appena un anno presso il monastero retto dalla badessa Hilda, poi
fondatrice del monastero di Whitby, “per essere consacrata al Signore in
perpetua verginità” in ringraziamento per aver ottenuto la vittoria su Penda re
dei Merciani, insieme a dodici appezzamenti di terreno239
.
Del monastero anglosassone oggi non rimane alcuna traccia, se non un
cimitero databile alla metà dell’VIII secolo, mentre sono stati rinvenuti buchi
per pali e solchi per staccionate di 16 edifici molto piccole (3,5 x 4,5 metri),
probabilmente case con un annesso cortile per gli animali.
237
DEPN 1960, p.222. 238
Beda, HEA, IV, XXI, 29-34 (ed. Lapdige, II, p.267). 239
Beda, HEA, III, XXIV, 36-45 (ed. Lapdige, II, p.115).
82
IV.19 Hackness
Il villaggio di Hackness, nel North Yorkshire, dista circa 22 chilometri
verso sud da Whitby, poche miglia all’interno di Scarborough, nei North York
Moors.
Hackness viene già citato da Beda con il nome di Hacanos per la
presenza di un monastero costruito dalla badessa Hild nell’anno della sua
morte, avvenuta nel 680. In epoca più recente, ma prima della conquista
normanna, nel luogo sorgevano due chiese allineate, una dedicata a San Pietro,
l’altra alla Vergine; della seconda non rimane alcuna traccia, mentre alcune
parti della prima, secondo il Taylor e risalenti al tardo VIII secolo, sono
incorporate nella attuale chiesa normanna dedicata sempre all’apostolo (fig.71).
Alcuni elenchi di reliquie, di epoca tarda, riferiscono che a Hackness si
trovavano le spoglie di una Æthelburg; una badessa di questo nome è ricordata
in un’iscrizione su una croce di pietra, databile all’VIII secolo (fig.72):
[…] ABBATISSA OEDILBURGA ORATE PRO
[…] [OEDI]L[BVRG]A SEMPER TENET COMMVNITATES
TVAE TE MATER AMATISSIMA
L’iscrizione si articola sui quattro lati della croce ed, oltre a quelle in
latino, sono presenti altre lettere appartenenti ad altri alfabeti, quello runico del
83
dialetto northumbro (fig.73) e dell’alfabeto di Ogham240
(fig.74), entrambe di
difficile interpretazione.
Secondo recenti studi241
, l’espressione in antico irlandese sarebbe da
tradurre come un invocazione di un pellegrino (“la Croce del Re Gesù, roccia
di salvezza per Angus”), mentre le tre rune anglosassoni sarebbero un
anagramma per la frase “Æthelburg mi conosce”.
IV.20 Kirk Hammerton
La chiesa di San Giovanni Battista sorge al di sopra di una collina che
sovrasta il villaggio di Kirk Hammerton, a 13 chilometri ad ovest di York.
Della chiesa anglosassone non riamane nulla se non alcuni stipiti
angolari che permettono di ricostruire la pianta dell’edificio: la navata
misurava 7,5x4,5 metri e il presbiterio 3x2 metri.
240
L’alfabeto di Ogham è un tipo di scrittura sviluppata in Irlanda nel IV secolo (Sermon 1996, pp.101-111). 241
Geake 1994; Sermon 1996, pp.107-111.
84
IV.21 Lastingham
Oggi Lastingham è uno sperduto villaggio del North Yorkshire, 5
chilometri a nord-est di Kirby Moorside, ma Beda ricorda il luogo
(Laestingaeu) come sede di un monastero.
Il monastero venne fondato da Cedd, vescovo consacrato nel 635 con la
probabile sede a Londra242
, su un terreno donatogli dal re Æthewald. Prima
della fondazione, Cedd osservò un periodo di digiuno e di penitenza “secondo
la regola dei suoi padri”243
, per purificare la zona; il luogo scelto risulta del
tutto isolato da qualunque via di comunicazione (l’antica strada che conduceva
da York a Whitby passava a circa 10 chilometri più ad est) rispetta il topos
letterario del deserto.
La chiesa dedicata alla Vergine che attualmente è possibile vedere è di
epoca normanna e, oltre alla notizia fornita dalla Historia ecclesiastica, non
abbiamo evidenze relative all’edificio più antico.
242
Beda, HEA, III, XXII, 30-40 (ed. Lapidge, II, p.105). 243
Beda, HEA, III, XXIII, 29-35 (ed. Lapdige, II p.109); non è chiaro di quale regola si stia parlando: la
Regula sancti Benedicti, ad esempio, non contiene alcuna disposizione per la purificazione del sito dove
costruire una chiesa. Nessun pontificale anglosassone è giunto fino a noi, ma il Penitenziale dell’arcivescovo
Teodoro (precedente al 690) prescrive di celebrare delle messe prima della dedicazione di una chiesa (DACL
IV, coll.374-405).
85
IV.22 Ledsham (fig.75)
Ledsham sorge a circa 8 chilometri ad est di Leeds, al limitare della
Forest of Emlet. La chiesa più antica, dedicata a tutti i Santi, oggi si presenta
con una torre occidentale annessa ad una navata centrale con una navata più
piccola e un portico meridionale, un presbiterio con una cappella ed una
sacrestia del XIX secolo.
La chiesa più antica, costruita in pietra arenaria, doveva essere un
edificio con un’unica navata e un piccolo presbiterio, di cui non rimane alcuna
traccia244
.
Le murature dei muri meridionali e occidentali sopravvivono per lo più
intatti e nel muro meridionale si apriva una porta che introduceva nel portico.
L’attuale portico è di origine medievale, ma possiamo suppore che in epoca
antecedente svolgesse la funzione di un portico laterale245
.
La quasi totalità delle finestre anglosassoni fu murata durante i restauri
del 1871, ma per quello che è possibile vedere risentono molto dello stile di
Escomb246
.
L’intero complesso ricorda molto da vicino quello di Monkwearmouth,
il che porta a datare l’edificio al VII secolo.
244
Taylor 1965, I, p.378. 245
Taylor 1965, I, p.380. 246
Taylor 1965, I, p.381.
86
IV.23 Masham
Ad 6 chilometri a nord-est di Ripon, il villaggio di Masham occupa un
altopiano sulla riva meridionale del fiume Ure.
La chiesa di santa Maria conserva la tipica muratura anglosassone di
grandi pietre squadrate sui muri settentrionale, occidentale e orientale della
navata, che potrebbe datare l’edificio al VII secolo247
.
Le dimensioni coincidono con la media delle altre chiese qui proposte: la
navata misura 22 metri in lunghezza e 9 metri di ampiezza248
.
IV.24 Ripon
Sul territorio di Ripon, situata alla confluenza di due piccoli corsi
d’acqua del fiume Ure, non si hanno notizie riguardanti insediamenti
preistorici o romani.
247
Taylor 1965, II, p.784. 248
Taylor 1965, II, p.784.
87
Le prime notizie riguardanti Ripon sono datate al VII secolo: il
monastero che sorgeva nel villaggio di Hrypum venne concesso dal re Alhfrith
a monaci di osservanza irlandese, fra i quali Eata, abate di Melrose e poi
vescovo di Lindisfarne249
, ma in seguito, intorno al 660, il medesimo re lo
assegnò a Wilfrid insieme ad Hexham250
; questi sue monasteri costituirono la
base per il potere di Wilfrid in Northumbria.
La chiesa di San Pietro (fig.76) venne costruita e consacrata tra il 671 e
il 678251
, ma dell’edificio di Wilfrid non rimane altro che la cripta, situata al di
sotto della navata.
La cripta di san Pietro (fig.77) per molti aspetti risulta simile alla cripta
di un altro monastero fondato da Wilfrid, sant’Andrea ad Hexham, ma rispetto
a questa ha soltanto due passaggi che portano alla sala principale invece che
tre.
L’ambiente consiste in un’anticamera con orientamento nord-sud e una
camera principale orientata est-ovest, sormontata da una volta a botte. Le pareti
sono costruite con grossi blocchi di pietra, nelle quali furono aperte quattro
nicchie per l’alloggiamento delle lampade, mentre nella parete orientale si
trova una grande cavità, forse usata per riporre le reliquie. Il modello a cui
Wilfrid si ispirò per le cripte furono i martyria che poté visitare di persona
durante i suoi soggiorni a Roma.
L’anticamera misura 4,5x2 metri, mentre la camera principale 4x2,5
metri, con la volta che dista 3 metri dal pavimento252
.
All’interno della chiesa si trovava anche la tomba del fondatore, al di
sotto di un altare meridionale, al di sopra del quale campeggiava una lapide
249
Beda, HEA, V, XIX, 103-105 (ed. Lapidge, II, p.417); Beda, Vita sancti Cudbercti, VII (ed. Colgrave
p.174). 250
Beda, HEA, III, XXV,57-62 (ed. Lapidge, II, p.123). 251
Stefano di Ripon, Vita sancti Wilfridi,18 (ed. Colgrave p.46). 252
Taylor 1965, II, p.517.
88
con l’epitaffio per Wilfrid253
; l’epigrafe è andata perduta, ma Beda riporta per
intero il suo contenuto254
:
Vilfridus hic magnus requiescit corpore presul
Hanc Domino qui aulam ductus pietatis amore
Fecit et eximio sacravit nomine Petri
Cui clauses caeli Christus dedit arbiter orbis
Atque auro ac Tyrio devotus vestiit ostro
Quin etiam sublime crucis radiante metallo
Hic posuit tropaeum necnon et quattuor auro
Scribi evangelii paecepit in ordine libros
Ac thecam e rutilo his condignam condidit auro
Paschalis qui etiam sollemnia tempora cursus
Catholici ad iustum correxit dogma canonis
Quem statuere patres dubioque errore remoto
Certa sua genti ostendit moderamina ritus
Inque locis istis monachorum examina crebra
Colligit ac montis cavit quae regula patrum
Sedulus istituit multisque domique forisque
Iactatus nimium per tempora longa periclis
Quindecies ternos postquam egit episcopus annos
Transiit et gaudens caelestia regna petivit
Dona Iesu ut grex pastoris calle sequatur
L’epitaffio si componeva di venti versi e per diverse ragioni è
ipotizzabile che l’autore fosse lo stesso Beda: il primo motivo è la singolare
253
Beda, HEA, V, XIX, 235-239 (ed. Lapidge vol.II p.427). 254
Beda, HEA, V, XIX, 241-260 (ed. Lapidge vol.II pp.427-429).
89
enfasi sul sostegno dato al defunto al metodo romano per il computo pasquale
(iustum… dogma), perfettamente in linea con la visione di Beda, in gran parte
eccessiva, dell’importanza di tale computo per la storia ecclesiastica inglese.
Il secondo motivo è l’abilità metrica che l’autore dimostra: in venti versi
si ritrovano tredici elisioni, mentre, in generale, i poeti latini di ambiente
anglosassone tendono ad evitare le elisioni. Fra i poeti della prima età
anglosassone soltanto Beda usa l’elisione con una frequenza paragonabile a
quella con cui la usano i poeti classici e l’autore dell’epitaffio di Wilfrid255
.
Vi sono inoltre diverse espressioni ricollegabili ad altre opere del
monaco anglosassone256
.
IV.25 Skipwith
La chiesa di sant’Elena a Skipwith, piccola cittadina ad otto chilometri a
nord-est di Shelby, oggi si presenta come un edificio del XVI secolo, ma è al
suo interno sono ancora visibili diverse tracce dell’antica struttura
anglosassone.
Della navata non rimane nulla delle murature, se non l’arco che dalla
torre occidentale (precedentemente il piano inferiore della torre costituiva il
portico di ingresso) perfettamente conservato: i montanti sono costituiti da
pietre megalitiche, mentre le imposte e le basi piccole pietre quadrate257
. L’arco
è dista dalla pavimentazione 4,5 metri e misura in larghezza 3 metri.
255
Lapdige 2006, pp.103-111. 256
Lapdige 2006, p.108. 257
Taylor 1965, II, p.551.
90
Al di sopra dell’arco è possibile vedere una porta murata, a cui si poteva
accedere soltanto attraverso la torre, che fa ipotizzare un secondo piano
dell’edificio, forse databile al successivo ampliamento della chiesa, avvenuto
dopo la conquista normanna258
.
Le dimensioni originali dell’edificio possiamo solamente ipotizzarle
confrontandole con altre chiese dello stesso periodo: l’edificio doveva essere
ad un'unica navata, lunga 9 metri e larga 6 metri, terminante in un piccolo
presbiterio quadrangolare259
.
All’interno della torre è presente una pietra con graffite delle immagini
di uomini in fuga o in preda al panico; al centro campeggia una bestia feroce
(un lupo forse) intento a divorare un uomo: potrebbe trattarsi di una scena
riferibile al mito nordico del Ragnarök, “il crepuscolo degli dei”, in particolare
la morte di Odino divorato dal lupo Fenrir260
.
IV.26 Whitby
Situata su un promontorio lungo la costa del North Yorkshire, Whitby
viene identificata con la Streanaeshalch citata da Beda261
: il monaco interpreta
il toponimo Sinus Fari262
, indizio che forse in quel luogo si trovasse una luce di
segnalazione o un’altra indicazione per i naviganti di epoca romana.
258
Taylor 1965, II, p.552. 259
Taylor 1965, II, p.553. 260
Isnardi 2011, p.181. 261
Beda, HEA, III, XXIV, 48-50 (ed. Lapidge, II, p.115). 262
Beda, HEA, III, XXV, 68-72 (ed. Lapidge, II, p.123).
91
Probabilmente il nome deriva dall’antico inglese (ge-) streon (proprietà, tesoro)
ed healh (angolo)263
, forse in riferimento ad una proprietà che era oggetto di
qualche rivendicazione.
Il nome con cui Beda indicherebbe Whitby, non ha avuto prosecuzione
nell’inglese moderno (Whitby è un nome di origine scandinava ed entrò in uso
solamente nel IX secolo con l’invasione dei Danesi) e perciò è stata avanzata
l’ipotesi che Beda si riferisse in realtà alla città di Strensall, ad 8 chilometri a
nord-est di York264
. Per quanto seducente questa ipotesi possa apparire sul
piano filologico, essa è confutata dal fatto che Beda afferma chiaramente che
Streanaeshalch si trova a 21 chilometri da Hackness265
, filiazione del
monastero di Whitby266
, una distanza che corrisponde in modo molto preciso a
quella che effettivamente separa Whitby da tale località, mentre Streansall si
trova a 44 chilometri da essa.
Il monastero di San Pietro, fondato da Hild nel 657, fu teatro del sinodo
tenutosi nell’anno 664, nel quale si discussero le divergenze tra la Chiesa di
tradizione irlandese e quella romana in materia liturgica267
.
Non ci sono tracce del monastero anglosassone, probabilmente
cancellate dalle successive strutture dell’abbazia normanna, ma gli scavi hanno
riportato alla luce alcune fondamenta riferibili ai vari edifici che si trovavano
all’interno del recinto monasteriale: grazie agli oggetti rinvenuti, è stato
possibile rintracciare le celle e il refettorio268
.
263 DEPN p.212 e 450.
264 Barnwell-Butler-Dunn 2003, pp.311-326.
265 Beda, HEA, IV, XXI, 161-162 (ed. Lapidge, II, p.275).
266 Cfr IV.19.
267 Cfr II.2.
268 Taylor 1965, II, p.654.
92
IV.27 Kirknetown
A brevissima distanza dai Scottish Borders e a 10 chilometri dalla
cittadina di Wooler, il piccolo villaggio di Kirknetown si estende lungo il corso
del College Burn, affluente del fiume Glen.
La chiesa principale dedicata a San Gregorio Magno non presenta alcuna
caratteristica delle chiese di epoca anglosassone, quindi è difficile ipotizzare la
presenza di un luogo di culto.
In una parete della torre campanaria, all’interno della muratura, è
possibile apprezzare un rilievo raffigurante i Magi: le figure sono scolpite in
modo rozzo ed un po’ approssimativo; da notare il globo che la Vergine tiene
alzato nella mano sinistra, di cui non risultano altre raffigurazioni simili.
È decisamente problematico proporre una datazione per l’opera, di cui è
anche difficile comprendere se appartenesse ad un sarcofago o alla decorazione
dell’edificio: lo stile, simile alle incisioni del sarcofago di Cutberth, potrebbero
datarlo al VII secolo pieno.
93
IV.28 York (Eburacum)
York, situata alla confluenza dei fiumi Ouse e Foss, venne fondata dai
Romani nel 71 d.C., quando la XI legione, comandata dal futuro governatore
della Britannia Quinto Petilio Ceriale, sconfisse la tribù dei Brigantes e ne
occupò il territorio e costruì un castrum ligneo, in seguito rimpiazzato da un
accampamento in pietra269
.
Durante il suo soggiorno per le campagne contro i Pitti, l’imperatore
Settimio Severo concesse alla città lo status di colonia e la proclamò capitale
della provincia della Britannia Inferior e nella quale morì nel 211.
Il significato del toponimo Eburacum risulta incerto: si ipotizza derivi
dal celtico Eborakon, formato dall’unione della parola eburos (l’albero del
tasso) ed *-āko(n), “luogo”270
; il significato del toponimo si presta a due
interpretazioni: Eburacum potrebbe essere “il luogo del tasso” oppure, se
eburos si riferisce ad una persona, “la proprietà di Eburos”271
.
Dopo l’evacuazione della provincia da parte delle truppe romane nel
410, la città vive un lunghissimo periodo di decadenza finché, nel VII secolo,
non viene reclamata insieme al territorio circostante dal re Edwin di
Northumbria, che ne farà la sua residenza.
269
Frere 1998, p.83. 270
Delamarre 2003, p.159. 271
Delamarre 2003, p.39.
94
San Pietro
La chiesa dedicata all’apostolo è la prima di cui si ha notizia: venne fatta
costruire in legno dal re Edwin nel 627 in tutta fretta per poter ricevere il
battesimo da Paolino, al fine di poter sposare la principessa Æthelburg del
Kent272
.
Dopo il battesimo, Edwin decise di costruire al posto dell’edificio ligneo,
un basilica in pietra di dimensioni più ampie. Edwin non riuscì a vedere il
completamento della chiesa, ultimata dal suo successore Oswald273
.
La dislocazione dell’edificio non è mai stata determinata in modo sicuro.
Le ipotesi avanzate sono che si trovasse sotto l’attuale cattedrale, o che fosse
nelle sue immediate vicinanze, in direzione nord, sud o ovest.
La prima alternativa non ha trovato alcun elemento di conferma nei vasti
scavi condotti sotto la cattedrale negli anni Sessanta e Settanta: vennero trovate
tracce di saccheggio di quanto rimaneva degli edifici romani, ma, oltre a
questo, nessun’altro indizio di attività ascrivibili ai secoli V-VIII274
.
Più di recente è stato proposto che San Pietro si trovasse in un recinto
quadrato adiacente alla cattedrale, ma sul lato nord-occidentale275
. Il recinto ha
lasciato un segno visibile della topografia medievale del luogo, ma non è stato
oggetto di scavi (vi è il sospetto che San Pietro, se era effettivamente in quella
posizione, sia stata distrutta nel 1940 per lasciare il posto a cisterne d’acqua da
usare in caso di emergenza)276
.
272
Beda, HEA, II, XIV, 3-10 (ed. Lapidge, I, p.249). 273
Beda, HEA, II, XIV, 11-17 (ed. Lapidge, I, p.249). 274
Carver 1995, p.194. 275
Norton 1998, pp.6-11. 276
Blair 2005, p.66.
95
Santa Maria
Generalmente considerata la chiesa più antica all’interno delle mura,
Santa Maria sorge nella zona della città chiamata Bishophill Junior, sulla
sponda occidentale del fiume Ouse.
Gli indizi a sostegno della datazione anglosassone risiedono nelle
murature: le parti inferiori delle pareti occidentale e meridionale e la parte
superiore della parete meridionale della navata presentano la stessa tecnica
costruttiva già presentata per i precedenti edifici277
.
Fino al 1961, nelle immediate vicinanze di Santa Maria, si ergeva un
altro edificio ecclesiastico, ma è impossibile valutare alcun che perché allora
era in stato di abbandono e pericolante e poco dopo fu rasa al suolo278
.
IV.29 Catterick
La località di Catterick sorge vicino al fiume Swale, che scorre
all’estremità orientale del villaggio.
Il nome romano-britanno del luogo era Cataractonium, derivato
probabilmente dal latino cataracta (cascata, rapide) con il suffisso britanno
277
Taylor 1965, II, p.699. 278
Taylor 1965, II, p.700.
96
*-on(o); le rapide in questione si trovano a monte di Catterick, in direzione di
Richmond279
. Più di recente Rivet e Smith280
hanno supposto che i romani
possono aver frainteso una parola britanna composta da *catu- e *ratis, dal
significato di “bastione di difesa” e l’abbiano reinterpretata trasformandola
nella parola latina cataracta.
Beda riferisce che nella città soggiornarono per qualche tempo re Edwin
e Paolino per portare la fede nella regione dei Deiri. A causa della mancanza di
oratoria o baptisteria, Paolino fu costretto a praticare il rito del battesimo per
immersione nel fiume Swale281
. E’ interessante notare come questo passo sia il
primo, ed anche l’ultimo, che parli di battisteri nell’Inghilterra anglosassone.
Blair suppone che l’associazione della parola baptisterium con basilica possa
derivare da una fonte scritta, forse proveniente da Canterbury, che impiegava
per questi edifici ecclesiastici la terminologia in uso in Italia282
.
IV.30 Campodonum
Campodonum è una tenuta reale la cui dislocazione è sconosciuta; il
nome non ha avuto continuità in un toponimo moderno. Sulla base della notizia
riferita da Beda che si trovasse nel territorio di Loidis283
(oggi Leeds), Rivet e
279
Jackson 1953, p.409. 280
River-Smith 1979, pp.302-304. 281
Beda, HEA, II, XIV, 39-43 (ed. Lapidge, I, p.251). 282
Blair 2005, p.70. 283
Beda, HEA, II, XIV, 44 (ed. Lapidge, I, p.251).
97
Smith hanno avanzato la plausibile ipotesi che Campodonum fosse un forte di
cui non è rimasta traccia alla confluenza del fiume Sheepscar Beck con il fiume
Aire284
; ma sono state proposte anche altre possibili dislocazioni come Slack285
,
circa 30 chilometri a ovest di Leeds, e Dewsbury286
, 10 chilometri a sud-ovest
di Leeds.
La forma originaria del nome era chiaramente Cambodunum, dal
britanno *cambo- (curvo, tortuoso) e -dunum (forte) e il significato era dunque
“forte sull’ansa del fiume” ( Cambo- divenne poi Campo- per l’interferenza
con il latino campus).
Qui Paolino edificò una basilica287
, ma anche qui sorge, come per
Catterick, che cosa Beda intendesse con quel termine.
284
River-Smith 1979, pp.292-293. 285
Plummer 1896, p.105. 286
Wallace-Hadrill 1988, p.75.
98
V. IL COFANETTO FRANKS
V.1 Storia del ritrovamento
Il Cofanetto Franks (conosciuto anche con il nome di “Coffret d’Auzon”
o “Franks Casket”) è un oggetto molto particolare: nel 1857 l’antiquario
inglese Augustus Wollaston Franks comprò in un negozio di antichità di Parigi
una piccola cassetta rettangolare in osso di balena, con incise scene narrative e
delle iscrizioni in runico288
. Dieci anni più tardi, come Custode del
Dipartimento di Antichità Britanniche e Medioevali del British Museum,
Franks presentò l’oggetto, ad eccezione del pannello destro, scoperto nel 1890
nel Museo del Bargello di Firenze.
Il pannello destro era arrivato al Museo del Bargello come lascito
ereditario da un certo Carrand di Lione, il quale lasciò anche un resoconto
scritto di come fosse venuto in possesso del manufatto e la sua storia
precedente: facente parte da generazioni delle proprietà di una famiglia
d’Auzon, un piccolo villaggio dell’Alta Loira, veniva utilizzato come scatola
per il cucito e dal quale furono tolte le cerniere argentee che tenevano insieme i
pannelli per fare un anello. I pannelli, tranne il destro, furono comprati da un
professore di nome Mathieu di Clermont-Ferrand, che in seguito li vendette
all’antiquario di Parigi dove Franks li trovò289
.
288
Vandesall 1972, pp.17-19. 289
Vandesall 1972, pp.21-23; Paroli 1997, pp.277-304.
99
V.2 Descrizione (fig.77)
Il cofanetto si presenta di forma rettangolare, alto cm 22,9 per cm 19 di
profondità e cm 10,9 di altezza. E’ inciso con immagini ed iscrizioni su cinque
facce; le iscrizioni sono per lo più in alfabeto Fuþorc, un alfabeto runico in uso
presso gli Anglosassoni e i Frisoni a partire dal V secolo, ma si trova anche un
frase in latino nel pannello posteriore. Si notano alcuni tituli indicanti i nomi di
alcuni personaggi delle scene.
Le iscrizioni, che inquadrano le scene correndo sui bordi, sembrano
essere state ideate in un crescendo di artificiosità: sul lato frontale, le rune
corrono radialmente in senso orario a cominciare da sinistra; al contrario sul
bordo inferiore sono voltate verso sinistra dato che, girando, la lettura in quel
punto va da destra a sinistra. Anche sul lato sinistro la scritta è circolare, ma sul
bordo inferiore le rune sono capovolte, in modo che, girando in senso orario,
questo tratto si legge come se si tenesse capovolto il pannello.
Sul lato destro, la scritta corre allo stesso modo che sul lato sinistro.
Sul pannello posteriore, oltre alle normali rune anglosassoni, vi sono
delle parole latine, in un testo che è dunque non solo bilingue ma anche “bi-
alfabetico”.
La parte latina a sua volta è prima in lettere latine e poi in rune.
100
V.3 Il coperchio (fig.78)
Il coperchio, l’unico pannello in cui non sono presenti iscrizioni,
presenta una scena di battaglia: nella parte sinistra si vede una schiera di
uomini armati, alcuni di maggiore rispetto agli altri, intenti all’assedio di una
cittadella; degli assedianti giacciono morti sul terreno. La cittadella, sulla
destra è difesa da un unico uomo, un arciere identificato dal titulus al di sopra
della sua spalla Ægili. Dietro di lui, all’interno di un edificio, un’altra figura
sembra assistere allo scontro. Il pannello sembra essere incompleto, tanto che
lo Webster ipotizzò la presenza di ulteriori immagini incise su delle lastre
argentee poste sopra e sotto la scena, oggi perdute290
.
Il personaggio indicato con il nome di Ægili sembra da identificarsi con
l’eroe Egil, fratello di Völund (il quale troverà spazio nel pannello frontale),
formidabile arciere, intento a difendere la fortezza in cui risiede insieme a sua
moglie, la valchiria Ölrun, figlia dell’imperatore romano (il Kiar di Valland)291
.
Nel mito norreno non vi è traccia di una tale battaglia tra Egil e schiere
di assedianti: qui l’eroe Egil potrebbe rappresentare per antonomasia tutti i
valorosi caduti in battaglia che soggiornano nel Valhalla, “paradiso” dei
guerrieri, dove vengono portati dalle Valchirie per ingrossare le fila
dell’esercito che durante il Ragnarök dovrà combattere, al fianco di Odino, le
forze del male. Seguendo questa ipotesi, la fortezza dove risiedono Egill e
Ölrun sarebbe la sala del Valhalla, mentre le schiere degli assedianti
rappresenterebbero i Múspellsmegir, i “giganti di fuoco”, che assaliranno gli
dei durante gli ultimi giorni292
.
290
Webster 1991, p.102. 291
Völundarkviða (ed. Kunh, I, pp.117-129). 292
Isnardi 2011, pp.186-188.
101
Come altra ipotesi, lo Wolf293
e lo Becker294
danno alla scena un valore
apotropaico, come a voler dire che l’oggetto è ben protetto e inaccessibile ai
profanatori o dalle potenze maligne essendo l’arco, per i popoli scandinavi, il
simbolo del sole che con i suoi raggi (le frecce) sconfigge l’oscurità295
.
V.4 Il pannello frontale (fig.79)
Sulla fronte, il cofanetto presenta due scene con elementi provenienti dal
mito norreno e dalla religione cristiana: nel riquadro a sinistra la scena viene
divisa in tre momenti che riguardano le vicende del fabbro Völund, mentre a
destra vi è la rappresentazione dell’Adorazione dei Magi.
Völund, fabbro di eccezionale abilità, venne rapito dal re di Svezia
Niðuðr per poter appropriarsi delle sue ricchezze e per poterlo rendere schiavo.
Il re, per impedire una sua fuga, fece recidere i tendini a Völund e venne
condotto su un isolotto, dove preparava gioielli per la famiglia reale296
.
Durante la sua prigionia, Völund meditava vendetta e l’occasione si
presentò quando i due figli di Niðuðr si presentarono dal fabbro: i ragazzi
volevano vedere le ricchezze di Völund e questi, mentre i giovani ammiravano
293
Wolf 1969, p.230. 294
Becker 1973, p.50. 295
Isnardi 2011, p.646. 296
Völundarkviða 1-17 (ed. Kunh, I, pp.117-122).
102
gli ori, tagliò loro la testa e con i crani fece delle coppe preziose297
. Questa è la
prima scena del riquadro (fig.80): si vede Völund nella sua fucina, circondato
dagli attrezzi, che offre una delle coppe ricavate dai principi (il corpo di uno
dei quali si trova al di sotto dei piedi del fabbro) alla figlia del re Böðvildr, la
quale si era recata alla fucina per la riparazione di un anello.
La seconda scena (fig.81), inquadrata da motivi ornamentali, presenza
una donna velata che reca in mano un cesto contenente un recipiente: ci
troviamo davanti al momento successivo alla visita della principessa al fabbro,
ossia nel momento in cui Völund consegna una bevanda magica per farla
assopire per poi abusare di lei e completare la sua vendetta298
.
L’ultimo riquadro (fig.82) propone un particolare aggiuntivo al mito non
presente nella Völundarkviða (“Il lamento di Völund”): per sfuggire dall’isola
lo storpio fabbro utilizza delle piume di uccelli, preventivamente cacciati dal
fratello Egil, per fabbricarsi delle ali299
.
L’Adorazione dei Magi300
(fig.83) presenta affinità con la canonica
rappresentazione iconografica dell’evento evangelico, ma aggiunge alcuni
particolari. I tre astrologi si avvicinano da sinistra verso la Vergine con il
Bambino nel grembo, posti su di un trono. Al di sopra della coppa recante l’oro
splende la stella che ha guidato i Magi fino a Betlemme, mentre al di sotto
della coppa compare un volatile: la sua presenza può essere spiegata ricorrendo
ancora una volta alla mitologia nordica, nella quale all’atto della nascita a tutti
gli uomini, ma in special modo agli eroi, viene affidato un fylgja (“seguire”),
uno spirito protettore in forma di animale che accompagna e protegge
l’individuo per tutta la sua vita o appaiono per lasciare messaggi o presagi,
spesso di morte301
.
297
Völundarkviða 20-25 (ed. Kunh, I, p.125). 298
Völundarkviða 26-29 (ed. Kunh, I, p.125-126). 299
Thidrekssaga 72-79 (ed. Haymes, pp.268-273). 300
Massara 2000, Magi (s.v) in Bisconti 2000. 301
Isnardi 2011, p.355.
103
Un ulteriore segno che rimanda alla morte è il simbolo posto al di sopra
della spalla del primo dei Magi dalla sinistra, il quale trasporta un arbusto che
dovrebbe essere la mirra, formato dall’incrocio di tre triangoli: si tratta del
Hrungnis hjarta (“cuore di Hurugnir”) o Valknut (“nodo dei caduti”), nome che
lo mette in relazione con i morti caduti in battaglia302
.
I simboli di morte presente nella scena dell’Adorazione potrebbero
alludere anche alla Passione, nella quale il Cristo, morendo per tutti gli uomini,
dona la remissione dei peccati e la vita eterna.
I temi preponderanti in questo pannello sembrano essere la morte e il
dono, ripresi anche dall’iscrizione che incornicia le scene:
hronæs ban/fisc . flodu . / ahof on ferg/ enberg/ warþ ga:sric grorn þær he on
greut giswom
“Osso di balena. La marea scaraventò il pesce sugli scogli costieri; il
mostro fu triste quando approdò sulla riva sassosa”303
.
L’iscrizione presenta la storia del recupero del materiale con cui è stato
confezionato il cofanetto: la morte dell’animale “dona” agli uomini un
materiale raro e straordinario, quasi magico, con il quale si deve creare
solamente un contenitore per qualcosa di altrettanto straordinario. Per questo
motivo potrebbero essere state scelte le scene di Völund, artefice leggendario
di gioielli e tesori, e dei Magi, che portano ricchi doni al nuovo re d’Israele.
302
Isnardi 2011, p.138 e p.145. 303
Webster 1991, p. 229.
104
Ancora all’interno dell’iscrizione è possibile notare la ripetizione di due
rune e cioè feoh e gifu ( le nostre F e G) che significano proprio “ricchezza,
tesori” e “dono”304
.
L’alfabeto runico dei popoli scandinavi aveva anche un valore numerico
e il Fuþorc non fa eccezione: il numero dei segni dell’iscrizione del pannello
frontale, ma anche degli altri eccetto il coperchio che non presenta iscrizioni, è
di 72, cioè tre volte 24 che è il numero portafortuna dell’alfabeto305
. Il numero
quindi parrebbe avere intenti beneauguranti ma, oltre ad essere legato alla
“magia runica”, il numero 72 rientra anche nella simbologia cristiana: 72 sono
infatti i libri della Bibbia e i discepoli inviati da Cristo per le città della
Giudea306
.
V.5 Il pannello sinistro (fig.84)
La scena di questo pannello attinge a tutt’altra tradizione rispetto ai tre
precedenti, ma forse non è del tutto scollegata dai miti nordici e le leggende
anglosassoni.
I personaggi si trovano all’interno di una foresta. Al centro si trovano
due giovani uomini sdraiati al suolo allattati da una lupa e sopra di loro sembra
accorrere un altro lupo. Alla scena assistono dei guerrieri armati di lancia
inginocchiati, posti due per parte.
304
Bosworth-Toller 1898, p.276 e p.475. 305
Krause 1959, p.46. 306
Lc 10, 1 e Lc 10, 17.
105
Come indicato dall’iscrizione si tratta del mito dei gemelli Romolo e
Remo ma, anche qui, gli artefici o i committenti apportano delle modifiche: il
futuro fondatore di Roma e suo fratello non sono degli infanti, ma adulti; oltre
la lupa che allatta i fratelli, è presente un altro lupo; i gemelli e l’animale non si
trovano al riparo nella grotta del Lupercale, ma il tutto si svolge all’interno di
un bosco; non figurano Faustolo o altri pastori, ma dei guerrieri armati.
Queste incongruenze con il mito romano potrebbero essere tutte
spiegate: per prima cosa bisogna chiedersi perché si ricorre ad un episodio
della storia romana. Una leggenda anglosassone, riportata da Beda, narra che i
primi capi delle nuove genti giunte dal Kent furono i fratelli gemelli Hengist e
Horsa, discendenti di Odino307
. Un ulteriore indizio sull’ipotesi di Hengist e
Horsa potrebbero essere il raddoppiamento dei lupi, animale sacro ad Odino e
nelle saghe viene detto che il dio supremo possedeva due lupi Geri e Freki308
, e
la presenza dei guerrieri rientrerebbe nell’ambito degli eroi fondatori. Inoltre,
la scelta dei gemelli romani deriva anche da un motivo di carattere linguistico:
i nomi di Hengist ed Horsa inizierebbero con la runa hægl che indica la rovina,
il dolore e sarebbe di cattivo auspicio.
oÞlæ unneg /Romwalus and Reumwalus / twœgen gibroðær a /fœddæ hiæ wylif
/in Romæcæstri
“Lontano dalla patria. Romolo e Remo(lo) due fratelli. Li nutrì una lupa nella
città di Roma”309
.
307
Beda HEA, I, XV, 29-35 (ed. Lapidge p.71). 308 Isnardi 2011, p.580. 309
Webster 1999, p. 232.
106
Anche qui troviamo un'altra allitterazione: per tre volte viene ripetuta la
runa rad, “viaggio, cavalcata”310
, la quale è strettamente collegata alla prima
frase “lontano dalla patria”. Forse qui si voleva esprimere l’idea del viaggio ed
è forse questo il motivo principale del ricorso alla storia romana, la quale
poteva fornire già pronti tre nomi inizianti con R-.
V.6 Il pannello destro (fig.85)
Il lato destro è il più difficile ed enigmatico da interpretare, sia per
l’iscrizione che per le immagini: sulla destra sono presenti tre figure
incappucciate, al centro una donna con un calice si trova presso un tumulo, al
cui interno si vede un corpo, insieme ad un cavallo fra le cui zampe è possibile
vedere due Valknute. Alla sinistra un guerriero armato di tutto punto fronteggia
una creatura mostruosa assisa su di una roccia o su una sepoltura.
All’interno della scena sono presenti tre parole, tutte nella parte centrale:
wudu (“bosco”)311
, risci (“ramo”)312
e bite (“morso”)313
.
L’iscrizione risulta problematica per quanto riguarda alcuni vocaboli che
si prestano a diverse interpretazioni:
herh os sitæþ on hærmberge/ agl(ac) drigiþ swæ hir i ertae gisgraf/ sær
den sorgæ and sefa tornæ
310 Bosworth-Toller 1898, p.781.
311 Bosworth-Toller 1898, p.1277.
312 Bosworth-Toller 1898, p.806.
313 Bosworth-Toller 1898, p.105.
107
La prima frase herh os è stata interpretata dal Becker come un nome
proprio di una divinità legata al bosco o ai tumuli314
, mentre il Bouman315
e il
Page316
leggono her hos e traducono con “Qui Hos”. Il Bouman riconduce Hos
al nome di Horsa, considerando la creatura sulla sinistra come lo spirito di
Horsa e la scena centrale con i funerali dello stesso a cui partecipa il fratello
Hengist in forma di cavallo (Hengist significa “stallone”)317
, interpretando il
pannello come la morte di Horsa; anche l’Osborn dà come lettura her hos, ma
traducendo “Qui un gruppo”318
.
Il Simmons319
al contrario legge e traduce il vocabolo herh con “idolo”,
dando al pannello un’interpretazione cristiana: l’idolo sarebbe Satana
controllato da Inferno (il guerriero armato) come raccontato nel
Descensus Christi ad Inferos, parte del Vangelo di Nicodemo, ma circolante
anche autonomamente320
, e le tre figure sulla destra rappresenterebbero
l’arresto di Cristo nel giardino del Getsemani. La scena centrale raffigurerebbe
la Natività, per altro già presente in qualche modo nel pannello frontale.
Isolatamente Peeters vede nel pannello l’illustrazione del libro biblico di
Daniele e il simbolo della cattività babilonese321
.
In parte mi trovo d’accordo sulla traduzione proposta dal Becker, ma
alcuni vocaboli sono stati interpretati in modo troppo letterale ed hanno portato
ad un significato distorto della materia figurativa.
314
Becker 19733, p.96. 315
Bouman 1965, p.244. 316
Page 1995, p.179. 317
Bouman 1965, p.247. 318
Osborn 1972, pp.666-667. 319
Simmons 2010, pp.13-16. 320
Descensus Christi ad Inferos, VII (ed.Craveri p.356). 321
Peeters 1996, pp.20-33.
108
herh os sitæþ on hærmberge/ agl(ac) drigiþ swæ hir i ertae gisgraf/ sær
den sorgæ and sefa tornæ
“Qui la divinità siede sul tumulo della sventura. Porta disgrazia come a lei il
destino prescrisse. Fossa di dolore, angoscia e tormento dell’anima”.
Il os (“dio”, “divinità”) secondo me è da intendere più come “individuo
soprannaturale”, dato che la creatura sembra più un mostro che una divinità del
pantheon nordico, sempre rappresentate in forme antropomorfe. Anche il
“mostro” ha la parte inferiore simile a quella umana e possiede delle mani, ma
il corpo ricorda quello di un uccello e il capo ha le sembianze di un serpente o
di un drago (fig.86).
Il serpente nell’immaginario nordico incarna lo spirito dei defunti
(concezione dovuta forse all’abitudine dell’animale di scavarsi una buca nel
terreno come tana) che può essere funesto per i vivi, ma anche guardiano
pericoloso di tesori322
. Nel mito, il serpe-drago più famoso, cui è affidata la
custodia di un immenso tesoro, è Fafnir, un nano con il potere di mutare forma,
ucciso da Sigurðr, conosciuto meglio con il nome di Sigfrido, il quale poi si
impadronirà del tesoro ed è proprio il duello tra l’eroe e il drago ad essere qui
immortalato. Il “tumulo della sventura” sul quale siede Fafnir è la sua tana,
ricordata anche più avanti nell’iscrizione, dove è custodito il tesoro e l’anello
che può incrementare la ricchezza: entrambi sono stati maledetti dal loro primo
possessore il nano Andvari, dei quali era stato privato dal dio Loki per risarcire
l’uccisione di Otr, fratello di Fafnir323
; il tesoro e l’anello portano la “sventura”
e “disgrazia” a Fafnir stesso poi a Sigurðr e ai Nibelunghi.
322
Isnardi 2011 p.574. 323
Isnardi 2011 pp.386-388 e 390.
109
La scena centrale (fig.87) presenta forse ancora più problemi delle due
che la affiancano, data la presenza anche delle parole wudu, risci e bite, degli
animali e di alcuni oggetti. La parola bite, “morso”, forse venne posta per
interpretare meglio il quadrupede, che quindi dovrebbe essere un cavallo:
l’animale forse fa parte della scena precedente oppure ricorda un mito a sé
stante ovvero il ritrovamento da parte di Sigurðr del cavallo Grani, figlio del
cavallo di Odino Sleipnir324
; wudu sarebbe il luogo dove la scena si svolge; il
ramo o il giunco indicato dalla parola risci dovrebbe essere il vegetale visibile
tra il muso del cavallo e il tumulo funerario: forse si riferisce la quercia legno
usato per le pire funerarie325
.
L’uomo posto nel “tumulo” sembra avvolto in bende e accanto a lui si
notano dei piccoli segni verticali, interpretabili come la stilizzazione dei pali
che costituiscono la pira funeraria.
La figura femminile con l’asta in mano, del tutto simile con la figura
all’interno del recinto sul coperchio, potrebbe essere una valchiria, in
particolare Brunilde la quale, dopo aver causato la morte di Sigurðr per
vendetta, si suicida mentre l’eroe brucia sulla pira.
A corredo della “morte di Sigurðr” vengono posti due oggetti che ancor
di più indirizzano l’osservatore verso lo scioglimento della scena: nell’istante
stesso in cui Sigurðr perde la vita, tutte le coppe che si trovavano nella sala
vibrarono (il calice vicino “Brunilde”) e le oche del cortile starnazzarono (il
volatile sotto le zampe del cavallo)326
.
Il “destino già scritto” citato dall’iscrizione è qui rappresentato dalle tre
figure incappucciate (fig.88), le Norne che stabiliscono e conoscono la sorte
degli uomini e degli dei327
.
Se questa fosse l’interpretazione da dare alle varie figure, il pannello
presenta i temi della disgrazia, della morte e del destino ineluttabile, a cui
324
Isnardi 2011 p.386. 325
Isnardi 2011 p.537. 326
Isnardi 2011 p.394. 327
Isnardi 2011 pp.303-304.
110
nessuno può sottrarsi, e l’allusione alla sventura è rimarcata anche dalla
ripetizione della runa hægl e dalla troncatura della parola aglac per evitare che
l’accumularsi di queste rune sinistre portino davvero sfortuna. Non è
nemmeno un caso che questi temi siano posti sul lato sinistro della cassetta:
l’est il luogo dove si trova l’aldilà328
.
V.4 Il retro (fig.89)
L’ultimo lato, quello posteriore, ci porta ad un episodio chiarissimo della
storia romana: la conquista di Gerusalemme da parte dell’imperatore Tito nel
70 d.C. Anche l’iscrizione è chiara e del tutto didascalica:
her fegtaþ titus end giuþeasu HIC FUGIANT HIERUSALIM afitatores
“Qui combattono Tito e i Giudei. Qui gli abitanti giungono da Gerusalemme”.
L’impianto figurativo ricorda molto da vicino i sarcofagi paleocristiani a
doppio registro, segno che l’artista o i committenti avevano potuto vederne
qualche esemplare.
328
Isnardi 2011 p.475.
111
Al centro si erge un arco decorato con temi vegetali ed animali, forse
simboleggia Gerusalemme stessa o il Tempio329
, che divide in due la scena: la
guerra vera e propria e, in basso, l’imperatore il quale, assiso su di un trono,
amministra la giustizia, come indica la parola alla sinistra del seggio, dom
(“giudizio”)330
, dall’altra parte la Diaspora del popolo ebraico e la presa dei
prigionieri, anche qui esplicitata dalla parola anglosassone gisl (“ostaggio”)331
.
Su questo pannello il numero delle rune è 42 e non è un numero casuale:
è il numero dei mesi durante i quali Gerusalemme verrà calpesta dai gentili
secondo l’Apocalisse332
di Giovanni.
Anche qui si trova la ripetizione di una runa, questa volta la runa tyr nel
nome di Tito: questa runa porta il nome del dio Tyr, dio collegato alla guerra e
protettore delle assemblee333
, significati questi che ben si accordano con
l’episodio di un imperatore vittorioso che giudica e detta legge.
E’ possibile che nel latino afitatores, espresso in rune, sia stata preferita
una grafia senza l’aspirazione, per evitare anche qui la runa hægl. Per quanto
riguarda la forma fugiant si può proporre un errore di lettura dove a ed u
insulari erano facilmente confondibili ed è probabile che anche la prima frase
sia una trascrizione da un testo in lettere latine334
.
Tutto l’insieme evoca concetti di conquista, gloria, vittoria e trionfo.
329
Becker 1973 p.108. 330
Bosworth-Toller 1898 p.207. 331
Bosworth-Toller 1898 p.478. 332
Ap 11, 2. 333
Isnardi 2011 p.218. 334
Ball 1991 p.121.
112
V.5 Interpretazione
Il cofanetto deve essere stato commissionato da una personalità
estremamente colta e facoltosa, visto il dono costoso, per un altro individuo
abbastanza colto anch’esso da poter capire i vari piani di lettura che le
immagini e le iscrizione suggerivano. Gli unici luoghi della Northumbria ad
avere biblioteche così ben fornite da creare tale personalità si trovavano nei
monasteri di Monkwearmoth, Jarrow e York, quindi si può ipotizzare che il
dono sia stato pensato in ambito ecclesiastico.
Il senso di lettura delle immagini doveva partire dal pannello frontale e
proseguire in senso orario per poi completarsi sul coperchio; il significato delle
immagini potrebbero essere il ciclo della vita laica, di un guerriero o di un re:
nel pannello frontale viene elogiato l’oggetto come estremamente ricco e
prezioso, degno dei gioielli di Völund e dei doni dei Magi, forse fatto per
onorare una nascita. Il cofanetto dovrà fare un viaggio lontano per arrivare a
destinazione, ma sarà degno di eroi e re quali Romolo e Remo o Hengist ed
Horsa. Sarà un capo glorioso e saggio, ma anche gli eroi più forti e coraggiosi
sottostanno al dolore ed al destino e infine muoiono, ma se saranno degni
dell’aldilà. Questa concezione della vita rispecchia la mentalità dei popoli del
nord, ma ora impregnati della fede cristiana: infatti al di sopra dei valori laici,
vi è una sovrastruttura di valori cristiani: come i 72 discepoli, il re o il nobile
deve portare la fede in tutto il suo territorio e fondare un nuovo regno cristiano,
così da poter, con l’aiuto di Dio, vincere i propri nemici ed i pagani ed essere
saggio nell’amministrare la giustizia. Nonostante questo, la morte è ineluttabile
ma, se si è stati fedeli a Dio, il premio nell’aldilà sarà la felicità eterna.
113
Non credo, come ipotizzato da alcuni335
, che il cofanetto fosse un
reliquiario o un oggetto ad uso liturgico, perché non vi sono scene che si
possano ricondurre alla vita di santi oppure di Cristo, a parte l’adorazione dei
Magi, ma fosse solamente un dono ricco, un contenitore di preziosi, che
presuppone un’enorme dottrina ed erudizione per poter comprendere i diversi
piani di lettura.
Il cofanetto Franks, anche se non sono ancora chiari la sua funzione e
alcune delle immagini istoriate, testimonia comunque un genere di arte
funzionale, in cui le immagini non si limitano a illustrare il testo, né le
iscrizioni sono pure e semplici didascalie alle immagini, ma tutte e due si
integrano in un disegno generale, un progetto globale. Sono immagini e
iscrizioni che in ogni caso testimoniano del vivace ambiente culturale della
Northumbria altomedievale, in cui era stata raggiunta una notevole autonomia
e maturità concettuale ed espressiva.
335
Peeters 1996 p.32.
118
Fig.5 Ricostruzione grafica del Vallo di Adriano
Fig.6 Esempio di “milecastle” e sua ricostruzione
129
Fig.18 Pianta del sito di Yeavering Bell (da Hope-Taylor). In rosso
gli edifici ipotizzati come cristiani.
132
Fig. 22 Gli scavi del 2004 della Cappella di San Oswald (da Wood-
Young)
Fig.23 Bywell, chiesa di San Pietro
139
Fig.30 Lettera di Cay alla London Society sul ritrovamento del
catino argenteo di Corbridge (da Hodgson)
141
Fig.32 Planimetria di Sant’Andrea a Corbridge. In grigio le
murature di epoca anglosassone (da Taylor)
145
Fig.36 Planimetria di Sant’Andrea, Heddon-on-the-Wall. In rosso la
probabile pianta dell’edificio anglosassone.
146
Fig.37 Monastero romanico di Lindisfarne
Fig.38 Sarcofago di San Cutberto, Durham Museum
Fig.39 Il Tetramorfo sul coperchio del sarcofago di San Cutberto
(da Kitzinger)
151
Fig.43 Pianta della cripta di Sant’Andrea, Hexham
Fig.44 Ambiente principale della cripta di Sant’Andrea, Hexham
156
Fig.49 Meridiana nel portico meridionale, Santa Maria Maddalena,
Hart
Fig.50 Seaham, chiesa di Santa Maria
161
Fig.56 Escomb, chiesa di San Giovanni Evangelista
Fig.57 Arco trionfale, Escomb, chiesa di San Giovanni Evangelista
163
Fig.59 Porta anglosassone murata nel muro settentrionale, Escomb,
chiesa di San Giovanni Evangelista
170
Fig.66 Planimetria della chiesa di San Pietro a Jarrow. In colore più
scuro la chiesa anglosassone (da Taylor)
171
Fig.67 Epigrafe dedicatoria della chiesa San Paolo a Jarrow
Fig.68 Disegno del monastero di Jarrow datato 1728 (Londra,
British Museum)
172
Fig.69 Disegno dell’alzato e della planimentria di San Paolo a
Jarrow datato1769 (Londra, British Museum)
188
CONCLUSIONI
Volendo offrire una panoramica generale dell’elaborato appena concluso, si
evince quanto il regno di Northumbria fosse una regione aperta alle
problematiche inerenti a questioni dottrinali e disciplinari provenienti dal
continente e all’interno della Chiesa britanna.
I contatti con il resto dell’Europa non vengono mai meno grazie all’arrivo
sull’isola di ecclesiastici, convocati dalla gerarchia della chiesa locale o inviati
189
direttamente da Roma, portatori di codici e di idee e maestranze artistiche che,
entrando in contatto con l’arte sassone, crea un nuovo stile, quello
anglosassone, in cui gli elementi prettamente nordici, come la pianta ad un’
unica navata, includono esperienze mediterranee, come le cripte che hanno
come modello i martyria catacombali presenti a Roma.
Per quanto riguarda le decorazioni presenti all’interno degli edifici, non è
possibile dare una valutazione vista la quasi totale assenza di tracce e
solamente in un caso, quello della chiesa di Sant’Andrea ad Hexham, abbiamo
un a tarda descrizione dell’apparato figurativo ma, purtroppo, del tutto
generica.
Come ho potuto constatare, la decisione di costruire degli edifici ecclesiastici
in zone remote o presso che desertiche e lontane dai grandi centri urbani, oggi
all’interno di piccoli villaggi, spesso deriva dal fatto che tali fondazioni erano
volute da monaci e monache che prediligevano luoghi appartati e impervi per
poter evadere dal mondo e seguire il loro percorso di ascesi e preghiera.
Oltre all’impulso di evangelizzazione e preghiera, anche la casa reale di
Northumbria diede un forte sostegno alla costruzione di chiese e monasteri fin
dal VII secolo, quando essa si convertì al Cristianesimo e fu tale lo zelo con cui
i sovrani protessero la nuova fede che molti di loro vennero proclamati santi.
L’arco cronologico nel quale si collocano gli edifici varia dalla metà del VII
secolo ai primi decenni del VIII secolo: la ricerca di chiese anteriori all’anno
650 è resa quasi impossibile dal fatto che il tipo di costruzione era quella
lignea, come le fonti ci attestano, ed il clima delle isole britanniche non
permette la conservazione di tali strutture. Per quanto riguarda la tecnica
costruttiva, le chiese vennero innalzate utilizzando il materiale preso dai castra
romani (come è possibile constatare dalla presenza all’interno delle murature di
epigrafi di legionari o in onore degli imperatori) o dagli edifici, sempre di
epoca romana, presenti all’interno della città stessa, come attesta l’esempio di
York; la planimetria, anche se spesso è difficilmente rintracciabile a causa dei
190
rifacimenti successivi, richiama molto da vicino le “longhouses”, le abitazioni
tipiche delle popolazioni scandinave e germaniche consistenti in un unico
ambiente a sviluppo longitudinale e terminante in una piccola “abside”.
Purtroppo non sono pervenuti oggetti e arredi liturgici o iscrizioni che possano
farci comprendere appieno quanto la comunità dei fedeli partecipasse con
donazioni alla gloria della Chiesa o semplicemente mostrare uno spaccato della
società cristiana del regno di Northumbria, almeno per quanto riguarda i ceti
medio-bassi.
Si può presupporre che vivessero all’interno della popolazione tre “anime”
(quella romana, quella sassone e quella cristiana) che si compenetravano e
attingevano l’una all’altra, creando una commistione di immagini e di racconti
e di lingue che difficilmente si riscontra in altre parti d’Europa e ciò ha portato
alla creazione di un oggetto straordinario, di una profondità culturale e di una
capacità di unire queste tre “anime” in una sola cosa: il Cofanetto Franks.
Questo lavoro vuole far scoprire e spingere ad approfondire le ricerche su un
luogo ed un aspetto che l’archeologia cristiana non ha studiato a sufficienza,
lasciando il compito agli esperti di architettura e storia anglosassone inglesi,
ma come già detto, il regno di Northumbria non è distaccato dal resto dell’orbis
christianus, ma da esso riceve e rielabora le varie esperienze e correnti con un
esito del tutto originale.
Vista la scarsità di notizie sugli edifici più antichi, sarebbe auspicabile
intraprendere indagini archeologiche a livello di fondazioni, allo scopo di
confrontare i dati forniti dalle fonti con le evidenze stratigrafiche.
191
BIBLIOGRAFIA
Abels 1983 Abels R., The Council
of Whitby: A Study in
Early Anglo-Saxon
Politics in “Journal of
British Studies” XXIII,
pp.1-25, The North
American Conference
on British Studies 1983
192
Arrighetti 1989 Arrighetti G.,
Frammenti orfici, TEA
1989
Augè 1992 Augé M., Liturgia,
Storia, celebrazione,
teologia, spiritualità,
San Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 1992
Austin 1976 Austin D., Fieldwork
and Excavation at Hart,
Co Durham 1965-1975
in Archaeologia
Aeliana V, VI (1976),
pp. 69-132
Ælred de Rievaulx De miraculis
Hagustaldensis
ecclesiae, in The
Historical Works , ed.
Dutton M.L., Cistercian
193
Fathers 56, Kalamazoo
Cistercian Publications,
2005
Ball 1991 Ball C., Inconsistencies
in the Main Runic
Inscriptions on the
Ruthwell Cross in Old
English Runes and their
Continental
Background a cura di
Bammesberger A.,
Heidelberg 1991
Barnwell-Butler-Dunn 2003 Barnwell P.- Butler
L.A.S.- Dunn C.J., The
Confusion of
Conversion:
Streanaeshalch,
Strensall and Whitby
and the Northumbrian
Church in The Cross
goes North: Process of
Conversion in Northen
194
Europe, A.D. 300-1300
a cura di Carver M.,
York 2003
Battiscombe 1956 Battiscombe C.F., The
Relics of Saint
Cuthbert, Oxford 1956
BEASE The Blackwell
Encyclopedia of Anglo-
Saxon England, edd.
Lapdige M.-Blair J.-
Keynes S.-Scragg D.,
Oxford 1999
Beda il Venerabile Historia ecclesiastica
gentis Anglorum, ed.
Lapdige, Cambridge
2010
Beda il Venerabile Historia abbatum
monasterii huius, ed.
Plummer, Londra 1896
195
Becker 1973 Becker A., Franks
Casket. Zu den Bildern
und Inschriften des
Runenkästchens von
Auzon, Regensburg
1973
Beowulf Beowulf ed. Hudson
M., Wordsworth
Classics 2007
Bianchi 1984 Bianchi U., La tipologia
storica dei misteri di
Mithra, in Aufstieg und
Niedergang der
römische Welt, II 17
1984, pp.2116-2134
Biddle 1986 Biddle M.,
“Archaeology,
Architecture and Cult
of Saints”, in Anglo-
Saxon Church: Papers
on History,
196
Architecture and
Archaeology in Honour
of Dr. H.M. Taylor a
cura di Butler L.A.S. –
Morris R.K., Londra
1986, pp.1-31
Birley 1953 Birley E. B., Roman
Britain and the Roman
Army, Londra 1953
Birley 1961 Birley E.B., Research
on Hadrian’s Wall,
Kendal 1961
Birley-Blake 2005 Birley A.- Blake J.,
Vindolanda: the
Excavations of 2003-
2004, Bardon Mill 2005
Blair 1991 Blair J., The Early
Churches at Lindisfarne
in Archaeologia
Aeliana, XIX (1991),
pp.47-53
197
Blair 2005 Blair J., The Church in
Anglo-Saxon Society,
Oxford 2005
Bosanquet 1898 Bosanquet R.C., The
Roman Camp at
Housesteads in
Archaeologia Aeliana
II, XXV (1898), pp.
110-136
Bosio-Dal Covolo-Maritano 1993 Bosio G.- dal Covolo
E.- Maritano M.,
Introduzione ai Padri
della Chiesa. Secoli III
e IV, Torino 1993
Bosworth-Toller 1898 Bosworth, J.-Toller T.
N., An Anglo-Saxon
Dictionary, Oxford
1898
Bouman 1965 Bouman A.C., The
Franks Casket’s Side
and Lid in
198
Neophisiologus XLIX
(1965), pp. 155-168
Bover 1947 Bover J.M., La
Asunciòn de Maria.
Estudio teològico
històrico sobre la
Asunciòn de la Virgen a
los cielos, Madrid 1947
Bowman 1994 Bowman A.K., Life and
letters on the Roman
frontier. Vindolanda
and its people, Londra
1994
Breeze-Dobson 1980 Breeze D.J.-Dobson B.,
Hadrian’s Wall, Londra
1980
199
Brand 1789 Brand J., The History
and Antiquities of the
Town and Country of
the Town of Newcastle
Upon Tyne, Including
an Account of the Coal-
trade of that Place and
Embellished with
Engryved Views,
Londra 1789
Bruce 1889 Bruce D., A Christian
inscription from
Chesterholm in
Archaeologia Aeliana
,II, XIII (1889), pp.367-
371
Carver 1995 Carver M.O.H., Roman
to Norman at York
Minster in Excavation
at York Minster a cura
di Phillips D.-
Heywood F., Londra
1995
200
Cassio Dione Historia Romana, voll.
IV, V, VI, ed. Stroppa
A., Milano 1995
Cesare Ottaviano Augusto Caesaris Augusti Res
Gestae, ed. Benario
H.W., Detroit 1990
Cherry 1976 Cherry B.,
Ecclesiastical
Architecture in In The
Archaeology of Anglo-
Saxon England a cura
di D.M.Wilson, Londra
1976, pp.151-200
Colgrave 1940 Colgrave B., Two Lives
of St. Cuthbert: A Life
of an Anonymous Monk
of Lindisfarne and
Bede’s Prose Life,
Cambridge 1940
Colgrave-Mynors 1969 Colgrave B.- Mynors
R.A.B., Notes in Bede’s
201
Ecclesiastical History
of English People,
Oxford 1969
Cosmographia Ravennatis Cosmographia
Anonimy Ravennatis,
ed. Pinder M.-Parthey
G., Londra 1896
Costanzo Vita sancti Germani,
ed. Borius M. in
Sources Chrétiennes,
112, Parigi 1965
DACL H. Cabrol- H. Leclercq,
Dictionnaire
d’archéologie
chrétienne et de
liturgie, Parigi 1907-
1953
Daniels 2012 Daniels R., Anglo-
Saxon Hart, Hartlepool
2012
202
Dark 1994 Dark K., Civitas to
kingdom. British
political continuity,
Leicester 1994
Davey 2004 Davey J., The Environs
of South Cadbury in the
Late Antique and Early
Medieval Periods in
Rob Collins & James
Gerrard), Debating Late
Antiquity in Britain
AD300-700 in British
Archaeological Review,
2004, pp.83-96
Delamarre 2003 Delamarre X.,
Dictionnaire de la
langue gauloise, Parigi
2003
DEPN The Concise Oxford
Dictionary of English
Places, Oxford 1975
203
Descensus Christi ad Inferos Descensus Christi ad
Inferos, ed. Carveri in I
Vangeli apocrifi a cura
di Carveri M., Torino
2005
Diodoro Siculo Bibliotheca historica,
ed. Gianotti G.F.,
Palermo 1986
Dore 1989 Dore J.N., Corbridge
Roman Site, Londra
1989
Duncan 1997 Duncan A., Cristianità
Celtica, Milano 1997
Eagles 2003 Eagles B., Augustine’s
Oak in Medieval
Archaeology XLVII,
pp.175-178
Ekwall 1960 Ekwall E., The Concise
Oxford Dictionary of
English Place-Names,
Oxford 1960
204
Frere 1998 Frere S., Britannia. A
History of roman
Britain, Londra 1998
Gaio Giulio Cesare Commentarii de bello
Gallico, ed. Carena C.,
Milano 1991
Geake 1994 Geake E., Aethelburg
knows me… in New
Scientist IX (1994), pp.
20-29
Gem 1986 Gem R., ABC: How
Should We Periodize
Anglo-Saxon
Architecture? in Anglo-
Saxon Church: Papers
on History,
Architecture and
Archaeology in Honour
of Dr. H.M. Taylor a
cura di Butler L.A.S. –
Morris R.K., Londra
1986, pp.146-155
205
Gildas De excidio Britanniae,
a cura di Giuriceo S.,
Rimini 2005
Gilliam 1954 Gilliam J.P., The
Temple of Mithras at
Rudchester,
in Archaeologia
Aeliana IV, XXXII
(1954), pp.176-219
Hart 1975 Hart C.R., The Early
Charters of Northern
England and the North
Midlands, Studies in
Early English History,
6, London 1975
Haverfield 1918 Haverfield F., Early
Northumbrian
Christianity and the
altars to the ‘Di
Veteres’
in Archaeologia
206
Aeliana, III, XV (1918),
pp.22-43
Hodges 1894 Hodges C.C., Pre-
Conquest churches of
Northumbria in
Reliquiary VIII (1894),
pp.1-18
Hodges-Gibson 1919 Hodges, C.C. -Gibson,
J., Hexham and its
Abbey, Hexham 1919
Hodgson 1832 Hodgson J.F., A History
of Northumberland,
Newcastle 1832
Hodgson 1889 Hodgson J.F., Staindrop
Church in Trans of the
Architectural and
Archaeological Society
of Durham and
Northumberland III,
Durham 1889
207
Holford-Stevens 2005 Holford-Stevens L., The
History of Time: A Very
Short Introduction,
Oxford 2005
Hope-Taylor 1960 Hope-Taylor B.,
Excavation Comitee,
report for 1960,
Bamburgh in University
of Durham Gazette,
VIII, 2, 1960, pp.11-12
Hope-Taylor 1977 Hope-Taylor B.,
Yeavering: An Anglo-
British centre of early
Northumbria, Londra
1977
Hoppel 1879 Hoppel R., On a perfect
Saxon church at
Escomb in the county of
Durham in Jurnal of
British Archaeological
Association I, XXXV
(1879), pp.380-384
208
Hughes 1966 Hughes K., The Church
in Early Irish Society,
Londra 1966
Hutchinson 1787 Hutchinson W., History
of Durham, Newcastle
1787
Isnardi 2011 Isnardi G.C., I Miti
Nordici, Milano 2011
Jackson 1953 Jackson K.H.,
Language and History
in early Britain. A
chronology survey of
Brittonic languages, 1st
to 12th
c. A.D.,
Edimburgo 1953
Jackson 1982 Jackson, K, 1982
Brigomaglos and St.
Briog in Archaeologia
Aeliana, V, X (1982),
pp.192-206
209
Jones 2006 Jones R., Myths and
Legends of Britain and
Ireland, Londra 2006
Kirby 2000 Kirby D.P., The
Earliest English Kings,
Londra 2000
Kitzinger 1956 Kitzinger E., The
Coffin-Reliquary in The
Relics of Saint
Cuthbert, a cura di C. F.
Battiscombe, Oxford,
1956, pp.202-304
Krause 1959 Krause W., Erta, eine
anglischer Gott in Die
Sprache V, Berlino
1959
Lapidge 2006 Lapdige M., Historia
ecclesiastica gentis
Anglorum, Cambridge
2006
210
Le Bohec 1989 Le Bohec Y., L’esercito
romano. Le armi
imperiali da Augusto
alla fine del III secolo,
1989
Lewis 1966 Lewis M.J.T., Temples
in Roman Britain,
Cambridge 1966
Liber Pontificalis Liber Pontificalis ed.
critica e traduzione di
L.R.Loomis, Columbia
University Press 1916
Macalister 1945 Macalister R.A.S.,
Corpus Iscriptionum
Insularum Celticarum,
vol.I, Stationary Office,
Dublino 1945
Maddicott 1997 Maddicott J.R., Plague
in seventh-century
England, in “Past and
211
Present” n.156, pp.7-54,
Oxford 1997
Mallory-Adams 1997 Mallory J.P.-Adams
D.Q., Encyclopedia of
the Indeoeuropean
culture, Fitzroy
Dearborn 1997
Mason 1987 Mason D.P.J., Chester:
The Canabae Legionis,
in “Britannia” XVIII,
1987, pp.143-168
NDPAC Nuovo Dizionario
Patristico e di Antichità
Cristiane, Genova-
Milano 2006-2009
Newton 1993 Newton S., The Origins
of Beowulf and the Pre-
Viking Kingdom of East
Anglia, Suffolk 1993
Norton 1998 Norton C., The Anglo-
Saxon Cathedral at
212
York and the
Topography of the
Anglian City in Journal
of the British
Archaeological
Association CLI (1998),
pp.1-42
Notitia Dignitatum Notitia utraque cum
Orientis tum Occidentis
ultra Arcadii
Honoriique Caesarum
tempora, ed. Birley
A.R. in Acta
Archaeologica
Academiae Scientiarum
Hungaricae LVIII
(2007)
Orosio Historiae adversos
paganos, Milano 2001
Osborn 1972 Osborn M., The
Grammar of the
Inscription on the
Franks Casket, right
213
Side in
Neuphilologische
Mitteilungen LXXIII
(1972), pp.663-671
Ostrogorsky 1993 Ostrogorsky G., Storia
dell’impero bizantino,
Torino 1993
Page 1995 Page R.I., Runes and
Runic Inscriptions,
Woodbridge 1995
Paroli 1997 Paroli T., The Carrand
Pannel of the Auzon
Casket: Stories and
History in Germanic
Studies in Honor of
Anatoly Liberman a
cura di Goblirsch K.G.,
Odense 1997
Peers 1925 Peers C.R., The
Inscribed and
Scolptured Stones of
Lindisfarne in
214
Archaeologia, LXXIV,
1925, pp.255-270
Peeters 1996 Peeters L., The Franks
Casket: a Judeo-
Christian interpretation
in Amsterdamer
Beiträge zur ältern
Germanistik XLVI
(1996), pp.17-52
Pelagio Lettera a Demetriade, a
cura di Ogliari D.,
Milano 2010
Plummer 1896 Plummer C.,
Venerabilis Baedae
Opera Historica,
Oxford 1896
Rabano Mauro Vita della beata Maria
Maddalena e di sua
sorella santa Marta, a
cura di A. Azzolini,
Bologna 2006
215
Radford 1954 Radford C.A.R., St.
Paul Church, Jarrow in
Archaeological Journal
III (1954), pp.203-205
RIB 1965 Collingwood R.G. e
Wright R.P., The
Roman Inscriptions of
Britain (RIB), Oxford
1965
Richard di Hexham The priory of Hexham:
its chroniclers,
endowments and annals
ed. Raine J., Durham
1854
Rivet-Smith 1979 Rivet A.F.L.-C.Smith,
The Place-Names of
Roman Britain, Londra
1979
Rodwell 1986 Rodwell W., Anglo-
Saxon Church Building:
Aspects of Design and
Construction in Anglo-
Saxon Church:Papers
on History,
Architecture and
Archaeology in Honour
of Dr. H.M. Taylor a
cura di Butler L.A.S.-
216
Morris R.K., Londra
1986, pp.156-175
Rushworth 2009 Rushworth A.,
Housesteads Roman
Fort: the grandest
station. Excavation and
Survey at Housesteads,
1954-95, I, Londra
2009
Ryder 1999 Ryder P.F., Escomb
Saxon Church
Archaeological
Assesment, Durham
2005
Salway 1965 Salway P., The Frontier
People of Roman
Britain, Cambridge
1965
Selkirk 2000 Selkirk R., Chester-le-
Street and Its Place in
History, Birtley 2000
Sermon 1996 Sermon R., The
Hackness Cross Cryptic
Inscriptions in
Yorkshire
217
Archaeological Journal
LXVIII (1996), pp.101-
112
Sharpe 2001 Sharpe R., The Late
Antique Passion of St
Alban, in Henig-
Lindsley Alban and St
Albans. Roman and
Medieval Architecture,
Art and Archaeology,
“The British
Archaeological
Association Conference
Transactions” XXIV
2001, pp.188-194
Simeone di Durham Libellus de Exordio
atque Procursu istius,
hoc est Dunhelmensis
Ecclesie, ed. Rollason
D.W., Oxford 2000
Simmons 2010 Simmons A., The
Cipherment of Franks
Casket, Austin 2010
Simon-Rig 1997 Simon J.-Rig V.,
Britain and Celtic Iron
Age, Londra 1997
Sims-Williams 2003 Sims-Williams P., The
Celtic inscriptions of
Britain: phonology and
chronology, c. 400-
1200, Oxford 2003
218
Stancliffe-Cambridge 1995 Stancliffe C.-
Cambridge E., Oswald.
Northumbrian king to
European Saint,
Stamford 1995
Stefano di Ripon Vita Sancti Wilfridi, ed.
Colgrave, The Life of
Bishop Wilfrid by
Eddius Stephanus,
Cambridge 1927
Strabone Γεωγραφικά, Harvard
University Press 1932
Svetonio De vita Caesarum,
Garzanti 2008
Tacito Agricola, Milano 2008
Tacito Annales, Milano 2008
Tacito Historiae, Milano 2008
219
Taylor 1965 Taylor H.M., Anglo-
Saxon Architecture,
Cambridge 1965
Tertulliano Adversus Iudaeos,
Bologna 1998
Thomas 1981 Thomas C., Christianity
in Roman Britain to
A.D. 500, Londra 1981
Thompson 1984 Thompson E.A., Saint
Germanus of Auxerre
and the End of Roman
Britain, Woodbridge
1984
Thidrekssaga Thidrekssaga, ed.
Haymes E. R., New
York 1988
Vandersall 1972 Vandersall A.L., The
Date and Provenance
of the Franks Casket in
Gesta XI, II (1972),
pp.9-26
220
Vita Ceolfridi Vita Ceolfridi, ed.
Plummer C. in
Venerabilis Bedae
Opera historica,
Oxford 1896
Völundarkviða Völundarkviða, ed.
Kunh, Heidelberg 1962
Watts 2002 Watts V., A Dictionary
of County Durham
Place-Names, Durham
2002
Way 1854 Way A., Chapel near
Ebb’s Nook in
Archaelogical Journal
XI (1854), pp.410-412
Webster 1969 Webster G., The Roman
Imperial Army of the
First and Second
Centuries A.D., Londra
1969
221
Webster 1991 Webster L., The Franks
Casket in The Making
of England. Anglo-
Saxon Art and Colture,
A.D. 600-900 a cura di
Webster L.-Backhouse
J., Londra 1991
Webster 1998 Webster G., The roman
imperial army of the
first and second century
A.D., Oklahoma 1998
Wolf 1969 Wolf A., Franks Casket
in literarhistorischer
sicht in
Frühmittelalterliche
Studien III (1969),
pp.227-243
Wood-Young 2006 Wood P.- Young G.,
Chapel of St. Oswald,
Bamburgh Castle.
Archaeological
TrialTrenching Report,