Métodos y Tecnologías en el Beneficio Colonial del Cobre ...
Teologia del Miserere. Da Savonarola al Beneficio di Cristo 1490-1543
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Teologia del Miserere. Da Savonarola al Beneficio di Cristo 1490-1543
TEOLOGIA DEL MISEREREDA SAVONAROLA AL BENEFICIO DI CRISTO 1490-1543
Luigi Lazzerini
Una interpretazione originale di un’epoca ricca di controversie come il Rinascimento. Questa la proposta dell’autore grazie alle possibilità offerte dalle rete che gli hanno permesso di mettersi
in modo nuovo al servizio di antiche domande. Una lettura “elettronica” di testi noti, e di altri riscoperti, fa emergere un Savonarola teologo, oltre che profeta e politico, che ispirandosi a Paolo e
Agostino si oppone, in nome della interiorità e della grazia, alla religione delle opere e agli sfarzosi quanto vuoti rituali della vita religiosa fiorentina quattrocentesca. Un Savonarola che gioca un ruolo decisivo nella genesi della Riforma e di quell’Evangelismo italiano di cui il Beneficio di Cristo è il testo più rappresentativo. Sullo sfondo si muovono le grandi figure della civiltà rinascimentale, da Machia-velli a Michelangelo, da Piero di Cosimo a Raffaello, da Giovanni Pico e suo nipote Gianfrancesco a
Guicciardini, da Erasmo a Valdés a Lutero, conventi e comunità di laici sparsi in tutta Italia, uomini di corte e grandi prelati, tutti in misura minore o maggiore legati all’insegnamento
del frate e alla sua teologia del Miserere.
Luigi Lazzerini ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Europeo ed è stato fellow dell’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Villa I Tatti, Firenze. Oltre a numerosi saggi, apparsi su riviste italiane e straniere, ha pubblicato Nessuno è innocente.
Le tre morti di Pietro Pagolo Boscoli (Olschki 2002).
LUIG
I LAZ
ZER
INI T
EOLO
GIA
DEL M
ISERERE
22
Girolamo Savonarola, Predica del arte del bene morire; Antonio Tubini editore, Firenze, 1502 ca., libro a stampa con 4 illustrazioni xilografiche, cm. 20 x 14 x 0,7,
Fondo Harris Brisbane Dick, 1925 (25.30.95).© 2013 The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / Scala, Firenze
copertina: progetto grafico di Tiziana Di Molfetta realizzato da Eicon (Torino)impaginazione: Segnalibro, Torinostampa testo e copertina: Pde Legoprint, Lavis (TN)
in copertina: Masaccio, Cacciata dal Paradiso, particolare dei busti di Adamo ed Eva, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci. © 2013 Foto Scala, Firenze / Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno
La legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000 n. 248, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l’archiviazione, anche parziali e anche per uso didattico, con qualsiasi mezzo, sia del contenuto di quest’opera sia della forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da clearedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
prima edizione italiana, ottobre 2013© 2013 by Rosenberg & Selliervia Andrea Doria 14, 10123 Torinofax 011.8127808
www.rosenbergesellier.it
isbn: 978-88-7885-219-8
INDICE
9 Introduzione
19 1. Il santo e il peccatore
29 2. Rituale e interiorità
77 3. «Bizzarrissime fantasie». Il carro dei morti di Piero di Cosimo
85 4. Machiavelli e Savonarola
101 5. Il mistero dell’iniquità
121 6. Dal Miserere al Beneficio
181 Indice dei nomi e dei personaggi
9
InTRoDuzIone
nei saggi che state per leggere mi sono avvalso dei nuovi strumenti offerti da internet per interrogare due oggetti tra di loro a mio parere strettamente connessi.
Il primo di questi oggetti è il pensiero teologico evangelico di Girolamo Savonarola così come emerge dai numerosi testi savonaroliani che ci sono stati tramandati: raccolte di prediche, ma anche brevi trattati e commenti ai salmi, ognuno dei quali possiede una propria inimitabile cifra stilistica. Definisco questo primo oggetto “teologia del Miserere” in riferimento al più significativo dei testi, ma non l’unico, nei quali Savonarola espresse la sua teologia evan-gelica: il commento al salmo L (LI) Miserere mei, Deus, composto dal frate alla vigilia della morte, nei primi mesi dell’anno 1498, mentre si trovava nel carcere dell’Alberghetto. nello stesso lasso di tempo Savonarola commentò un altro salmo, il XXX (XXXI), conosciuto come In te, Domine speravi, con esiti e proposte teologiche analoghe: di più, tanto profondamente simili che si deve parlare di un unico testo e di un’unica proposta teologica.
L’altro oggetto è uno dei più misteriosi che la storiografia italiana si sia trovata a esaminare: il Beneficio di Cristo. Pubblicato nel 1543 a Venezia, questo libro fu presto preso di mira dalla censura, che riuscì a far sparire tutte le numerose copie stampate in Italia. Se non fosse stato grazie alla sco-perta a metà ottocento di un esemplare della edizione italiana del libro in una biblioteca di oxford lo si sarebbe dovuto considerare perduto. I misteri non erano però finiti, perché del libro non si conosceva l’autore, né si è mai riusciti a individuarne con chiarezza l’autentico messaggio teologico. Gli stu-diosi negli ultimi due secoli hanno provato a mettere il Beneficio sotto la lente di ingrandimento per cercare di caratterizzarlo, nella convinzione che in tal modo si sarebbe potuto meglio caratterizzare la peculiare dottrina dei gruppi riformatori italiani. Di volta in volta, come si vedrà, il Beneficio è apparso un testo valdesiano, erasmiano, calvinista, luterano, benedettino, senza che si sia riusciti a giungere a una conclusione precisa.
Ho provato a mettere a confronto il Beneficio con la teologia del Miserere, mediante ricerche tematiche e per parola dettagliate. A mio parere il confronto elettronico, fondato essenzialmente su quanto offerto dalle stringhe di ricerca di Google Books, dà risultati nuovi e stringenti che restituiscono ai due oggetti una fisionomia nuova e inaspettata: riletto alla luce del Miserere, il Beneficio perde la sua natura di oggetto isolato e indecifrabile e si rivela frutto di una
10
tradizione teologico-dottrinaria e riformatrice, quella savonaroliana, che ave-va preso piede in Italia sin dalla fine del Quattrocento. Allo stesso modo, la teologia del Miserere, riletta alla luce della spiritualità del Beneficio, mostra il suo volto autenticamente evangelico e svela una insospettata relazione con gli atteggiamenti spirituali propri dei movimenti di Riforma che si affermeranno nella prima metà del secolo successivo alla morte del frate ferrarese.
ne emerge, almeno così mi auguro, una visione nuova della Riforma prote-stante, dei suoi esiti in Italia, dei rapporti tra protestantesimo e savonarolismo. Questo risultato scientifico è stato reso possibile dai nuovi mezzi tecnici che lo sviluppo dell’informatica mi ha messo a disposizione. Ho lavorato sugli stessi testi sui quali avevano lavorato, dal Settecento in poi, gli studiosi che mi hanno preceduto, con intenti non dissimili e metodologie in definitiva analoghe, paragonando, confrontando, andando alla ricerca di convergenze tematiche e di eventuali identità testuali. Per compiere questo lavoro, tuttavia, un erudito del secolo scorso avrebbe impiegato tutta la vita. A me è occorso un tempo infinatamente inferiore.
Il 12 marzo 1610 Galileo Galilei diede alle stampe un’opera intitolata Sidereus nuncius, nella quale descriveva i monti della luna e i quattro satelliti di Giove, mai prima osservati, cui aveva imposto, in omaggio al granduca di Toscana suo protettore, il nome di Medicea sidera o Pianeti medicei. Queste scoperte erano senz’altro il frutto della sagacia e delle conoscenze dello scienziato pisano. Ma Galileo non avrebbe potuto in tempi tanto brevi compiere ritrovamenti così straordinari se non si fosse potuto servire di un nuovo mezzo tecnico. Qualche anno prima un artigiano tedesco naturalizzato in olanda, Hans Lippershey, aveva inventato uno strumento capace di amplificare singolarmente la vista di oggetti lontani. Galileo era stato messo al corrente dell’invenzione ed era forse entrato in possesso di un esemplare di cannocchiale. Dopo aver rielaborato e potenziato lo strumento, lo scienziato pisano l’aveva ufficialmente presen-tato, il 21 agosto 1609, al governo veneziano, che, entusiasta della scoperta, gli aveva raddoppiato lo stipendio e l’aveva assunto in pianta stabile come astronomo a Padova. I governanti veneziani erano naturalmente attirati dalle applicazioni belliche. Venezia era infatti allora una grande potenza navale e militare. Ma Galileo aveva subito pensato ad altre possibili utilizzazioni, di minor utilità pratica ma di enorme portata teorica. Il cannocchiale poteva mutarsi in un grimaldello in grado di forzare i misteri dell’universo. nei mesi successivi lo scienziato si era dedicato a osservazioni sistematiche del cielo, i cui esiti erano stati straordinari.
A pochi studiosi e ricercatori capita l’opportunità di potersi avvalere di uno strumentario tecnico nuovo e di tale eccezionale portata. L’invenzione degli elaboratori elettronici e la loro diffusione nella forma di computer per uso personale, capaci di comunicare attraverso una rete a cui sono costante-mente connessi, non può tuttavia essere giudicata meno importante di quella del cannocchiale. L’impatto di questi strumenti è stato altrettanto se non più rilevante, sia che si consideri la vita pratica, sia che si guardi agli aspetti più eminentemente teorici dell’attività di ricerca. Potrà a molti sembrare che le ricerche che si compiono in una disciplina come la storia siano infinitamente
11
meno importanti di quelle degli astronomi, dei medici o dei biologi. e tuttavia non c’è dubbio che anche nel campo della ricerca storica strumenti come la rete internet e i computer abbiano gettato le basi per progressi importanti, della cui portata non ci siamo forse ancora completamente resi conto.
Sin da quando furono messi in circolazione i primi computer a schede perforate, gli storici incominciarono a utilizzarli nelle loro ricerche. Si aprì allora l’epoca in cui i dati riguardanti le balle di cotone che erano transitate nel porto di Manchester potevano essere elaborati e disposti in una serie. nacque quella che si definì la storia cliometrica o quantitativa. Fu così che studiosi come Pierre Chaunu poterono elaborare le grandi serie statistiche del traffico atlantico che aveva la propria base nel porto di Siviglia. Di questa storia quantitativa ci si stancò abbastanza presto. Gli studiosi presero atto del fatto che la storia era per eccellenza disciplina idiografica, rivolta per sua natura allo studio di fatti unici e irripetibili. Quando ho incominciato i miei studi, la cliometria era caduta in discredito. Caratteristico, da questo punto di vista, l’itinerario di studiosi come Robert Darnton che avendo preso le mosse dalla storia quantitativa se ne sono venuti progressivamente allontanando per votarsi infine a un modello di storia qualitativa e narrativa.
una nuova rivoluzione informatica si stava però preparando, quella che aveva al centro la rete. Grazie a internet il lavoro degli storici fu enormemente semplificato. Bastava ormai un click per accedere al catalogo elettronico on line delle biblioteche di tutto il mondo. La preparazione delle bibliografie e delle schede, una operazione che si svolgeva faticosamente e a mano, diventò un gioco da ragazzi. I tempi di preparazione di un articolo si accorciarono e la produttività degli storici crebbe. La sostanza delle ricerche qualitative non era stata ancora sfiorata e bisognava procedere in modo tradizionale. Per confrontare due libri che si riteneva potessero essere in qualche modo collegati non restava che consultarli entrambi nella sala di lettura di qualche biblioteca ed elaborare delle schede tematiche. Finché un’ultima straordinaria innovazione, il libro elettronico, non mise il contenuto stesso dei libri dispersi nelle biblioteche di tutto il mondo a disposizione dei lettori.
I libri non sono sempre stati uguali a come li vediamo adesso. nell’antichità essi apparivano, si sa, sotto forma di rotoli di papiro. Quando Catullo chiama la sua opera novum libellum allude a un rotolo e non a un parallelepipedo di fogli di carta. Più tardi il papiro venne sostituito dalla carta pecora utilizzata nel medioevo per vergare i manoscritti e, più di recente, dalla carta. Questo mondo cartaceo rischia oggi di soccombere di fronte alle pagine, composte di bit impalpabili, dei libri elettronici. I lettori comuni si sentono minacciati dalla eventualità che siano loro sottratti certi aspetti della lettura come l’odore della carta, la possibilità di sfogliare le pagine o di riempire i bordi del libro di annotazioni scritte a matita. nessuna nostalgia mostrano invece i ricerca-tori e gli studiosi. La maggior parte di essi è semplicemente entusiasta delle nuove opportunità che la lettura elettronica offre. Si possono consultare da casa documenti come la Magna Charta, i taccuini di Isaac newton, o la prima versione manoscritta e illustrata di Alice in Wonderland di Lewis Carroll. La natura del lavoro dello studioso, e dello storico in particolare, cambia rapi-
12
damente: il tempo trascorso davanti al terminale si accresce a svantaggio di quello passato in biblioteca o in archivio. Ma c’è un secondo aspetto, non meno importante, su cui vorrei richiamare l’attenzione. I libri di carta pote-vano essere interrogati in modo parziale. uno studioso dotato di immensa pazienza e con un tempo pressoché infinito davanti a sé poteva rintracciare tutte le occorrenze di una parola all’interno del testo. Ma la fatica era spesso vana e i risultati tutt’altro che sicuri. Il libro elettronico può essere al contrario interrogato con estrema facilità. un qualsiasi elaboratore collegato a Google Books fa immediatamente emergere tutte le occorrenze della parola. Si prenda il caso del libro per eccellenza: la Bibbia. Fino a una ventina di anni fa l’unico modo di interrogarla in maniera plausibile era ricorrere a repertori come le chiavi bibliche, immensi dizionari che consentivano di risalire da un singolo lemma al versetto. oggi qualsiasi citazione di un versetto o di una singola parola riemerge semplicemente interrogando siti specializzati che ospitano tutte le diverse versioni del testo biblico che si sono succedute nel tempo: dalla Vulgata fino alle più recenti, autorizzate dalla Conferenza episcopale Italiana. Di fronte a simili possibilità il ricercatore è inevitabilmente preso da un senso di vertigine. e si chiede dove tutto ciò potrà condurre. In termini molto semplici e franchi egli non si cura dell’odore della carta, della possi-bilità di leggere a letto o di annotare ai margini i volumi con la matita. non se ne cura perché gli sono stati concessi i poteri di un mago rinascimentale. Perché si sente improvvisamente possessore della più potente ed efficace delle mnemotecniche, gli pare di aver in mano ciò che Jorge Luis Borges definiva l’aleph, il misterioso strumento che metteva a disposizione di chi lo possedesse il dono dell’ubiquità. La biblioteca di Babele si spalanca davanti a lui, ma non deve percorrere gli ottagoni colmi di libri con il rischio di morire di fame o di sete come gli antichi guardiani. Tutto il sapere della biblioteca si presenta di fronte ai suoi occhi e non gli resta che attingervi. Come l’eroe del film di Greenaway Prospero’s book egli detiene un sapere universale i cui singoli elementi possono essere collegati e acquistare un senso, in omaggio alla sentenza aristotelica fatta propria da Dante nel Convivio secondo la quale non c’è scienza senza che quanto abbiamo appreso sia inserito all’interno di un sistema coerente di conoscenze.
Mutatis mutandis, perché qui si ragiona di eretici e inquisitori, di libri proibiti e di aneliti di Riforma, e non dell’universo in senso astronomico e cosmologico, si può affermare che le tecnologie attuali mi hanno consentito di guardare ai testi oggetto della mia analisi da un’ottica altrettanto dettagliata e ravvicinata quanto era dettagliata e ravvicinata la visione che il telescopio permetteva a Galileo dei monti della luna e dei pianeti medicei.
Il mio metodo di indagine si può riassumere così: ho individuato una serie di parole chiave, frasi e versetti biblici all’interno del testo del Beneficio e ne ho ricercato le occorrrenze nei testi savonaroliani. Si è trattato di un lavoro artigianale, perché sono ancora numerosi i limiti che il mezzo elettronico pone. In primo luogo mancano le edizioni critiche più recenti. Può accadere di poter consultare per intero un incunabolo savonaroliano dei primi del Cinquecento, ma non l’ultima edizione dello stesso testo pubblicata negli
13
anni Settanta del novecento. In secondo luogo la ricerca per parole-chiave è ostacolata dall’incapacità che Google Books ha al momento di riconoscere i caratteri tipografici antichi. Talvolta una parola come «fede» o «gratia», se scritta in caratteri gotici, può essere miracolosamente rinvenuta, altre volte ciò si rivela più difficile. Quanto ai libri più recenti, se non si possono consultare per intero, se ne possono avere delle visualizzazioni più brevi (chiamate snip-pet) e altre più lunghe definite preview, che si estendono fino a comprendere un intero capitolo. Il lavoro sulle prediche savonaroliane sulla Prima lettera di san Giovanni, uno dei testi più presenti nelle mie ricerche, è proceduto così: ho trovato su internet una edizione ottocentesca che si è rivelata mol-to attendibile e che mi ha permesso molte utili ricerche per parole-chiave. Citazioni e rimandi sono stati successivamente ricontrollati sull’ultima e più aggiornata edizione delle stesse prediche pubblicata con testo italiano a fronte dal padre Armando Verde e da elettra Giaconi. Poiché ogni lavoro di ricerca implica una scomposizione e una ricomposizione non mi sono infine limitato a citare dei frammenti ma ho cercato di far vedere come le corrispondenze testuali e scritturali implicassero una più significativa coincidenza tematica e ideologica. La somiglianza tra i libri oggetto dei miei confronti e analisi, insomma, non è solo formale, ma, almeno a mio parere, sostanziale. Quando tutti i testi presenti nelle grandi biblioteche saranno a disposizione ed esiste-ranno software in grado di riconoscere ogni tipo di scrittura, il lavoro sarà ulteriormente semplificato e altre e più approfondite ricerche diventeranno possibili. Anche così tuttavia i risultati che si possono ottenere sono, mi pare, estremamente suggestivi.
non si creda tuttavia che il mio lavoro sia consistito nello schiacciare alcuni bottoni e nel far lavorare una macchina. Tutte le fasi della ricerca, dalla formulazione dell’ipotesi, alla verifica documentaria, alla stesura, erano naturalmente sotto il mio diretto controllo. Le domande a cui ho cercato di rispondere venivano da lontano, da testi come la Recitazione del Boscoli di cui mi ero già occupato in passato: testi caratterizzati da una profonda ten-sione religiosa, di cui non si riusciva a comprendere la natura e l’origine. e d’altronde, come è stato osservato, gli uomini del nostro tempo godono di una condizione particolare e per così dire anfibia. uno studioso ed erudito del secolo scorso aveva trascorso tutta la sua vita in mezzo ai libri cartacei. un bambino che nasca oggi conoscerà principalmente, se non esclusivamente, i libri elettronici. Gli uomini della mia generazione sono stati educati in un mondo di libri di carta, ma si trovano ora a vivere in un mondo di libri com-posti di bit immateriali. I vantaggi di questa doppia condizione sono evidenti. Gli studiosi di oggi possono sfruttare la tecnologia per rispondere ad antiche domande. Quelli del futuro, se ancora ne esisteranno, potrebbero rivelarsi tanto abili nel maneggiare le nuove tecnologie, quanto estranei al passato e incapaci di interrogarlo.
I sei capitoli di cui il libro è composto affrontano lo stesso identico problema da diverse angolazioni. Il primo (Il santo e il peccatore), intenzionalmente privo di note, serve da prologo e fornisce alcune informazioni fondamentali. Il secondo (Rituale e interiorità) e il sesto (Dal Miserere al Beneficio) sono,
14
rispettivamente, una rilettura della teologia del Miserere alla luce del Beneficio e del Beneficio alla luce della teologia del Miserere. Il lettore disposto ad af-frontare gli ardui sentieri della teologia cinquecentesca è invitato a compiere un percorso di andata e ritorno. Il percorso di andata prende le mosse dalla teologia del Miserere, e si snoda attraverso le fasi iniziali del savonarolismo e della Riforma in Germania e in Italia, per approdare infine al Beneficio. L’itinerario opposto muove dal Beneficio per rintracciare nelle sue pagine le tracce nascoste della teologia del Miserere. Sullo sfondo si intravede un muta-mento che appartiene alla storia della mentalità prima ancora che alla teologia: quello che induce a contestare, in nome dell’interiorità e dell’autenticità, gli sfarzosi quanto ripetitivi rituali del cristianesimo tardomedievale. I capitoli intermedi mirano a cogliere, attraverso differenti approcci microstorici, aspetti particolari di un fenomeno più generale: l’ossessione che si manifesta nella cultura rinascimentale per la teologia del Miserere. Vediamo di volta in volta affiorare questa ossessione in un carro di carnevale che Piero di Cosimo ideò e fece sfilare durante il carnevale del 1512, a pochi mesi soltanto dalla caduta della prima repubblica fiorentina («Bizzarrissime fantasie». Il carro dei morti di Piero di Cosimo), in un sermone attribuito a niccolò Machiavelli (Machiavelli e Savonarola) e nelle pagine apologetiche del piagnone Benedetto Luschino (Il mistero dell’inquità).
I termini cronologici indicati nel titolo si riferiscono a una stagione della spiritualità italiana che ho inteso delimitare: il 1490 è l’anno in cui Girolamo Savonarola rimette piede a Firenze dopo un temporaneo allontamento e incomincia la parte più importante, e documentata, della sua attività di pre-dicatore; il 1543 è l’anno di uscita della prima edizione a stampa del Beneficio di Cristo. non si tratta di una scelta neutra, perché suggerisce di ripensare e retrodatare la genesi della Riforma e dell’evangelismo italiano di almeno due decenni. e di collocare Savonarola al centro di quella crisi religiosa del Cinquecento della quale continua per molti aspetti ad apparire, a mio parere ingiustamente, una figura marginale.
Poiché la ricerca è un work in progress caratterizzato da una inevitabile dialettica tra punti fermi e nuove acquisizioni, i lettori troveranno che questo libro in parte conferma le vecchie ipotesi del mio precedente saggio Nessuno è innocente, per altri versi le integra e le modifica. non mi pare che vi siano tuttavia mutamenti sostanziali. non mi sono in altre parole pentito o come si diceva nel linguaggio dei processi per eresia, “ridetto”. Su di un unico punto intendo correggermi. Quando ho pubblicato Nessuno è innocente ho scelto come immagine di copertina un quadro relativamente poco noto di Hans Holbein il Giovane che si trova conservato presso la national Gallery of Scotland, e che costituisce una sorta di rappresentazione visiva della teoria protestante della giustificazione per fede. L’argomento del libro avrebbe invece richiesto una illustrazione che rimandasse più direttamente al contesto storico e artistico savonaroliano e fiorentino. Ho inteso, perciò, rimediare. Scartata l’ipotesi di ricorrere agli affreschi del Pontormo in San Lorenzo, di cui pos-sediamo solo i disegni preparatori, la mia scelta è caduta su di un’opera che mi pare rispecchi pienamente i temi affrontati in queste ricerche: l’affresco del Masaccio raffigurante la cacciata di Adamo ed eva dal Paradiso terrestre,
15
che decora le pareti della bella e appartata chiesa fiorentina del Carmine. Il gesto di Adamo che si copre il volto, come i gemiti e le lacrime di eva, mi sembrano ben rappresentare una cultura figurativa, filosofica e religiosa che, a differenza di quanto pensava De Sanctis, non si era ancora sgravata dal peso del peccato: originale e attuale.
nel momento di congedare questo volume vorrei ringraziare prima di tutto Mario Rosa, che nel corso della stesura e revisione di questi saggi ha avuto la pazienza di rileggere più volte quanto avevo scritto e mi ha incoraggiato e aiutato con consigli e osservazioni sempre puntuali e frutto di una straordinaria competenza ed erudizione. Ho trascorso ai Tatti il più bell’anno di ricerca della mia vita. e di quella comunità continuo a sentirmi parte. Il saggio su Piero di Cosimo contenuto in questa raccolta era stato scritto originariamen-te in lingua inglese per la Festschrift dedicata a Joseph Connors, che è stato direttore ai Tatti nel mio periodo di fellowship. Dal mio sodalizio tattiano con il caro amico Wlodzimierz olszaniec, anche lui fellow nel mio anno, è nata l’idea di una edizione in polacco dei commenti savonaroliani ai salmi Miserere e In te, Domine, speravi, di cui ripubblico qui, in italiano, l’introduzione. Gli altri saggi nascono da un intenso rapporto di collaborazione con la “Rivista di storia e letteratura religiosa”, di cui mi piace ricordare, oltre ai direttori e collaboratori, i membri della redazione, Linda Bisello e Davide Scotto. Anna Lazzerini ha rivisto con me i testi e verificato, da provetta classicista, l’esattezza e congruità delle numerose citazioni latine. ugo Rosenberg, dopo aver ricevuto il progetto, ha deciso di far parte del mio destino e di mettere a mia disposizione le sue competenze di autentico editore. La partecipazione di Franci a fasi diverse della elaborazione di questo libro è uno di quei «mi-racoli segreti», come li definiva Isaac Bashevis Singer, che talvolta accadono.
Viareggio, 30 giugno 2013
luigi lazzerini
16
nota editoriale
I saggi che fanno parte del volume sono apparsi, con qualche variazione, nelle sedi di seguito indicate. Sono grato alle case editrici Leo S. olschki, che pubblica la “Rivista di storia e letteratura religiosa”, Marek Derewiecki e Villa I Tatti per avermi permesso di ripresentarli in questa raccolta.
1. Il santo e il peccatore Con il titolo: Święty I Grzeszinik in W. olszaniec, L. Lazzerini (a cura di), G.
Savonarola, Medytacje więzienne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010 (Biblioteka europejska), pp. 5-17.
2. Rituale e interioritàCon il titolo: Rituale e interiorità. Teologia e Riforma in Girolamo Savonarola, “Rivista
di storia e letteratura religiosa”, LXVIII (2012), n. 2, pp. 249-304.
3. «Bizzarissime fantasie». Il carro dei morti di Piero di CosimoCon il titolo: “Bizzarrissime fantasie”: Piero di Cosimo’s Pageant Wagon of the Dead
and Girolamo Savonarola, in M. Israëls, L.A. Waldman (a cura di), Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Firenze, Villa I Tatti, II, 2013, pp. 91-101.
4. Machiavelli e Savonarola Con il titolo: Machiavelli e Savonarola. L’esortazione alla penitenza e il Miserere,
“Rivista di storia e letteratura religiosa”, LXIV (2008), n. 2, pp. 385-402.
5. Il mistero dell’iniquitàCon il titolo: Simul iustus et peccator. Passione e morte di Girolamo Savonarola
secondo i Vulnera Diligentis di Benedetto Luschino, “Rivista di storia e letteratura religiosa”, XXXIX (2003), n. 3, pp. 541-559.
6. Dal Miserere al BeneficioCon il titolo: Dal Miserere al Beneficio. Fonti savonaroliane della Riforma italiana,
“Rivista di storia e letteratura religiosa”, XLIX (2013), n. 1, pp. 63-132.






























![[2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313aecbc32ab5e46f0c8759/2004-a-ferrarese-quia-ubi-non-est-ordo-ibi-est-confusio-gian-matteo-giberti.jpg)

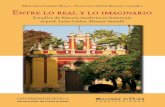




![HCMC 8/2016 [2018] HKCFI 1543 IN THE HIGH COURT OF ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d4bbb7051d371800fde7b/hcmc-82016-2018-hkcfi-1543-in-the-high-court-of-.jpg)

