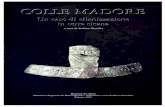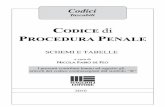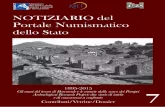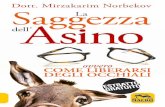Dal pirata hostis humani generis alla pirateria contemporanea. Verso un diritto penale universale?
La rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
Transcript of La rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
La rilevanza penale dell'uso di gruppo di sostanze
stupefacenti
I. Introduzione
La recente sentenza 2 marzo 2011, n. 83661 della Corte di Cassazione ripropone la
problematica relativa al trattamento sanzionatorio da comminare al cosiddetto uso o
consumo di gruppo di sostanze stupefacenti.
Si tratta di un fenomeno complesso, sia dal punto di vista materiale
dell'inquadramento del “fatto”, sia dal punto di vista giuridico dell'individuazione del
trattamento sanzionatorio (con il pensiero che va alla sua collocazione nell'alveo
della rilevanza penale ovvero in quello della mera rilevanza amministrativa).
Sotto un primo profilo è d'uopo mettere in luce che nella nozione di “uso di gruppo”
possono rientrare due distinte fattispecie: quella del soggetto che proceda all'acquisto
e alla successiva cessione della sostanza per consumarla in gruppo unitamente ai
terzi mandanti (che in precedenza avevano affidato al soggetto in questione
l'incarico, secondo lo schema del mandato ad acquistare) e quella dell'“acquisto in
comune” propriamente detto (situazione nella quale una pluralità di soggetti acquista
la sostanza drogante per poi consumarla insieme successivamente)2.
In secondo luogo occorre sottolineare come vi siano dei contrasti in giurisprudenza
ed in dottrina in merito all'inquadramento del “consumo di gruppo” nell'ambito del
penalmente rilevante o degli illeciti amministrativi.
Oltre a ciò occorre evidenziare come questo tema non rilevi unicamente da un punto
di vista dogmatico3 ma anche da un punto di vista pratico (vista la diffusione dell'uso
1 Cass., 2 marzo 2011, n. 8366, in CED Cass.2 AMATO, Sull'“uso di gruppo” di sostanze stupefacenti, in Cass. pen., 1997, 1504; Id., Piena rilevanza penale anche all'uso di gruppo, in Guida dir., 2006, 12, 79; Id., L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, in Guida dir., 2011, 12, 68.3 In relazione alla disciplina penale degli stupefacenti, vds., ex plurimis, PALAZZO, Consumo e traffico di stupefacenti, Padova, 1994, passim; RONCO, Il controllo penale degli stupefacenti, Napoli, 1990, passim; STORTONI, voce Stupefacenti, in Noviss. dig. it., 1971, XVIII, 573 ss.; GRILLO, sub Art. 73 d.p.r. n. 309/1990, in PALAZZO-PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali speciali, Padova, 2007, 2742 ss; INSOLERA, La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2008, passim; nella letteratura straniera, v., KALMTHOUT, (Eds.), Drug Policies in Western Europe, 1989; con riferimento alle modifiche apportate dalla l. n. 49/2006, v., AMATO, Per gli indizi della giurisprudenza arriva la “promozione” a norma, in Guida dir., 2006, 12, 69 ss.; Id., Il funzionamento della nuova disciplina degli stupefacenti: parametri indiziari e regola dell'“al di là del ragionevole dubbio”, in Cass. pen., 2006, 4181; MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi
1
di sostanze stupefacenti nel nostro Paese e, in generale, nell'Unione Europea4 e la sua
incidenza fortissima sulla penalità c.d. “materiale”5).
In questo breve elaborato, dopo aver sinteticamente illustrato la quaestio iuris
affrontata dal Giudice di legittimità, verrà dapprima analizzata la normativa
precedente al D.P.R. 309/1990, la legge 685/1975, e la risoluzione della problematica
dell'“uso di gruppo” alla luce di quel testo normativo. In un secondo momento si
illustrerà la legge attualmente in vigore (ponendo particolare attenzione alle
modifiche apportate al Testo unico sugli stupefacenti dall'esito del referendum del
18-19 aprile del 1993 e alle novità introdotte con il novum normativo introdotto dalla
legge n. 49/2006).
Da ultimo verrà evidenziato il contrasto attualmente esistente tra la seconda e la sesta
sezione della Corte di legittimità.
II. La vicenda processuale
La Corte è stata chiamata ad affrontare, su ricorso del Procuratore generale presso la
Corte di appello dell'Aquila avverso una sentenza di assoluzione che aveva ritenuto
l'“uso di gruppo” di rilevanza meramente amministrativa, la questione del
trattamento sanzionatorio da riservare al mandato ad acquistare (la sostanza
costituzionali in materia penale, in Dir. pen. e proc., 2006, 823; POTETTI, L'enigmatico comma 1 bis dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, in Cass. pen., 2007, XX; MANES, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, Relazione tenuta all’incontro di studi sul tema “Il punto sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope a due anni dalla legge n. 49 del 2006”, organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione dei magistrati presso la Corte di Cassazione, Roma, 20 maggio 2008.4 Secondo la relazione elaborata dall'OEDT (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), in concerto con la Commissione europea, l'Europol, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dal 2003 il numero di decessi indotti dal consumo di droga è in aumento nella maggior parte dei Paesi europei, così come l’età delle vittime (fattori indicativi di una popolazione di consumatori cronici in invecchiamento). I dati provvisori indicano un modesto aumento dei decessi correlati al consumo di stupefacenti segnalati nel 2008, con 7371 casi stimati negli Stati membri dell’Unione e in Norvegia nel 2008, rispetto a 7021 nel 2007. Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia dell'Unione europea in materia di droga per il periodo 2005-2012. Essa si prefigge di raggiungere un elevato livello di tutela della salute e di benessere integrando l'azione degli Stati membri destinata a prevenire e ridurre l'uso di droga e la tossicodipendenza. Mira inoltre ad assicurare un elevato livello di sicurezza per la popolazione intraprendendo azioni intese a contrastare la produzione di droga e il traffico transfrontaliero di droga nonché rafforzando i meccanismi di coordinamento comunitari, in modo da garantire che le misure siano complementari a livello nazionale, regionale e internazionale. Per altre informazioni relative alle politiche dell'Unione Europea in tema di lotta alla diffusione degli stupefacenti si rinvia al sito istituzionale europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/index_it.5 PETRINI, Per una disciplina giuridica degli stupefacenti che sostenga il disagio senza criminalizzarlo, Droghe e diritto: quali risposte?, in Legislazione penale, 2007, 479.
2
stupefacente, nello specifico 18 pastiglie di ecstasy, era stata acquistata dal solo
imputato, d'accordo con alcuni amici, che gli avevano rimborsato la loro quota, e con
i quali la droga doveva in un secondo momento consumata). Nel recente arresto
giurisprudenziale la sesta sezione della Suprema Corte ha ritenuto di dover
concludere che tale condotta deve ritenersi penalmente irrilevante, non ostando a
tale soluzione la formulazione dell'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del D.P.R. n.
309/1990, come novellato dalla legge n. 49 del 2006, che riconduce all'ambito del
penalmente rilevante le condotte qualificate dalla destinazione della droga a un uso
“non esclusivamente personale”. Per il giudice della nomofilachia l'utilizzo
dell'avverbio esclusivamente, infatti, non autorizzerebbe la conclusione di annettere
l'uso di gruppo all'ambito del penalmente rilevante.
III. Il quadro normativo precedente al D.P.R. 309/90
La legge antecedente al D.P.R. 309/90, la l. 685/1975, prevedeva all'art. 71 un'ampia
rosa di condotte (produzione, fabbricazione, estrazione, offerta, messa in vendita,
distribuzione, acquisto, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, fornitura ad altri,
trasporto, importazione, esportazione, passaggio in transito e detenzione) che
venivano ritenute penalmente rilevanti allorquando commesse senza autorizzazione e
al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 72 e 80, id est in quanto concernenti
quantitativi di sostanze stupefacenti non integranti una “modica quantità” e non
destinati ad uso personale terapeutico o non terapeutico. Le pene erano diversificate
in funzione della differente sostanza stupefacente oggetto di reato, individuata
secondo il sistema tabellare6.
L'art. 72 prevedeva un trattamento sanzionatorio più mite per le condotte (di
detenzione, trasporto, offerta, acquisto, messa in vendita, distribuzione o cessione
anche a titolo gratuito) aventi ad oggetto “modiche quantità” di sostanze stupefacenti
o psicotrope, destinate ad un uso non terapeutico di terzi. La fattispecie era foriera di
non poche questioni applicative laddove il concetto di “modica quantità” risultava
non determinato, rimesso alle valutazioni discrezionali dei giudici e dunque soggetto
ad interpretazioni non omogenee nella prassi giurisprudenziale7: secondo
6 BASSI, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, Padova, 2010, 10.7 CANEPA, La disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, Relazione per la prima settimana di tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 destinati a svolgere
3
l'orientamento prevalente, la nozione aveva natura essenzialmente oggettiva e doveva
essere definita avendo riguardo delle caratteristiche della sostanza, di tal che la
quantità poteva essere definita modica nelle ipotesi in cui essa non superasse il
quantitativo necessario per qualche giorno da parte di un'unica persona8; secondo
l'indirizzo minoritario invece la nozione di modica quantità si fondava su due
parametri, oggettivo e soggettivo, e si doveva tenere conto, oltre che della
caratteristiche tossiche della sostanza, delle condizioni psicofisiche del soggetto
agente, di tal che andava valutato il grado di tossicomania dell'autore9, ovvero
considerata quale termine di raffronto la figura del piccolo spacciatore10.
L'art. 80 della legge del 1975 sanciva la non punibilità dell'acquisto e della
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico, in quantità non
eccedenti in modo apprezzabile la necessità di cura, e per uso non terapeutico, di
modiche quantità11.
Nella vigenza della l. n. 685/1975 la giurisprudenza si era espressa quasi in modo
univoco per l'esclusione delle condotte di codetenzione e uso di gruppo dalla
disciplina dell'art. 8012. Si osservava infatti che la disciplina dell'uso personale,
disciplinata nella legge del 1975 dall'art. 80, doveva intendersi come uso strettamente
personale.
Inoltre, in relazione ai criteri di quantificazione della sostanza detenuta ai fini di
determinarne la modicità, la giurisprudenza prevalente aveva affermato doversi
considerare ciascun soggetto codetentore dell'intero quantitativo di sostanza. Di
conseguenza, la detenzione in comune di droga da parte di una pluralità di persone
determinava una fattispecie di concorso nel reato di detenzione in relazione all'intera
quantità13.
funzioni requirenti, Roma 11 maggio 2006, 4.8 Ex multis, Cass., 14 giugno 1990, n. 1991, in CED Cass.9 Cass., 10 ottobre 1985, n. 2352, in Cass. pen., 1986, 1864.10 Cass., 30 settembre 1985, n. 12036, in Cass. pen., 1989, 159.11 CANEPA, La disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, Relazione per la prima settimana di tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 destinati a svolgere funzioni requirenti, Roma 11 maggio 2006, 4.12 INSOLERA (a cura di), Le sostanze stupefacenti, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da BRICOLA-ZAGREBELSKI, Torino, 1998.13 Ex multis, Cass., 21 aprile 1981, n. 5375, in CED Cass.; Cass., 19 gennaio 1981, n. 1775, in CED Cass.; Cass., 16 dicembre 1983, n. 2171, in CED Cass; Cass., 23 gennaio 1986, n. 4426, in Cass. pen., 1987, 1840; Cass., 14 aprile 1988, n. 1451, in Cass. pen., 1990, 509; Cass., 2 ottobre 1989, in Riv. pen., 1990, 743.
4
La Corte della nomofilachia in più pronunce aveva infatti sottolineato che “l'esimente
di cui all'art. 80 (legge 22 dicembre 1975, n. 685) sulla disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope, è applicabile solo quando la droga sia detenuta per uso
personale e non già quando venga ceduta a terzi, nel qual caso è sufficiente la
semplice traditio ad altri delle sostanze stupefacenti, sicché risultano del tutto
irrilevanti le ragioni per cui detta cessione viene effettuata, come, ad esempio, la
liberalità, la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, la restituzione, l'uso in
comune”14.
Oltre a ciò, la Suprema Corte insegnava che anche nell'ipotesi di acquisto per conto
di più persone, alla luce del principio contenuto nell'art. 110 c.p., doveva ritenersi “la
sussistenza di un fatto unitario a carico di tutti i consumatori, avendo ognuno
apportato un contributo causale nell'azione criminosa”15.
Tale orientamento si fondava sull'asserita contraddittorietà tra l'elemento soggettivo
specifico previsto dal dettato normativo all'art. 80 e la condotta materiale dei
codetentori 16.
L'uso di gruppo finiva per concretare, per la richiamata giurisprudenza, quella
cessione a terzi che era estranea al “concetto di detenzione per uso esclusivo e
personale dello stesso detentore, elemento necessario per l'applicazione della causa di
giustificazione, in presenza della modica quantità di sostanza detenuta”17.
E' d'uopo però richiamare anche un altro orientamento giurisprudenziale minoritario,
espresso in particolare in talune sentenze dei giudici di merito.
Si era al riguardo sostenuta l'applicazione della divisibilità della sostanza in “quote”
destinate all'uso personale di ciascuno dei compossessori, apparendo artificiosa la
differenziazione, relativamente al trattamento sanzionatorio, di due situazioni
sostanzialmente identiche, come quella in cui gli acquirenti abbiano immediatamente
diviso tra loro le quote acquistate, così che ciascuno detenga la sua parte rientrante
nei limiti di cui all'art. 80 della l. n. 685/1975 e quella in cui tale operazione di
divisione non sia ancora avvenuta, onde la sostanza è ancora in possesso per intero di
uno solo18.
14 Cass., 12 dicembre 1985, n. 2365, in CED Cass.15 Cass., 27 aprile 1983, n. 2142, in Cass. pen., 1984, 269.16 INSOLERA, cit., 394.17 Cass., 12 marzo 1987, n. 12806, in Riv. pen., 1988, 1022.18 App. Torino, 3 marzo 1988, in Riv. it. dir. proc pen., 1988, 1210, con nota di GROSSO.
5
Secondo tale impostazione ermeneutica era la stessa ratio legislativa a richiamare
una strategia differenziata nella lotta agli stupefacenti; strategia che prevedeva una
limitata decriminalizzazione delle ipotesi di reato c.d. “senza vittima”19.
Per avvalorare questo orientamento si indicavano anche ragioni di ordine sistematico,
ritenendosi di non poter qualificare come attività di spaccio la consegna di sostanza
stupefacente da un soggetto ad un altro in un contesto in cui il consegnatario fosse
già sostanzialmente proprietario di quanto gli viene attribuito per averlo già
acquistato come quota di un quantitativo indiviso20.
In relazione alla determinazione del concetto di “uso personale”, si richiamava
l'attenzione sugli elementi differenziatori dell'uso di gruppo rispetto alle condotte di
spaccio e cessione a terzi. Nell'ipotesi di codentenzione e di consumo di gruppo, la
condotta non era realizzata in funzione di un terzo (acquirente) ma in funzione del
proprietario medesimo per il suo uso personale21.
Non sono mancate in tal senso considerazioni di tipo sociologico, legate alla prassi
del fenomeno del consumo di droga; né il richiamo ai lavori preparatori relativi alla l.
n. 685/197522. E' stato così sottolineato che il rituale dell'assunzione di certi tipi di
stupefacenti (si pensi, ad esempio, alla cannabis) richiedeva l'uso collettivo,
caratterizzato dal passarsi la sostanza tra i membri del gruppo; da ciò si giungeva alla
conclusione che tutte le attività esecutive svolte in gruppo e finalizzate al consumo di
sostanze stupefacenti andavano ricondotte alla finalità di uso personale: “ricezione,
detenzione e cessione sono aspetti di un'unica fattispecie che non può essere mutilata
dall'ultimo tipo di condotta (la cessione) senza mancare di adesione alla realtà”23.
Si sosteneva, d'altro canto, che la disposizione ex art. 80 l. n. 685/1975
ricomprendesse tutto ciò che comportava l'acquisizione, la preparazione, il
reperimento e l'uso delle sostanze stupefacenti da parte del soggetto, seppure
attraverso l'uso in gruppo della sostanza, la ratio della norma dovendosi ricercare
nella volontà di colpire e reprimere le condotte non collegate all'uso, bensì motivate
19 App. Torino, 3 marzo 1988, in Riv. it. dir. proc pen., 1988, 1210, con nota di GROSSO.20 App. Napoli, 26 maggio 1986, in Riv. pen., 1987, 411, che sottolinea inoltre che “tale condotta avrebbe costituito mera attività esecutiva dell'atto di divisione del bene comune, mentre a realizzare la condotta criminosa si riteneva necessaria una attività esecutiva di trapasso del dominio sul bene da un soggetto ad un altro”.21 App. Napoli, 26 maggio 1986, in Riv. pen., 1987, 411.22 INSOLERA, cit., 394.23 Trib. Firenze, 5 ottobre 1977, in Riv. pen., 1978, 507, con nota di POSTIGLIONE.
6
da uno scopo di lucro. Se si fosse voluto limitare il concetto di uso personale ad una
accezione restrittiva e racchiudere nella norma penale tutte le ipotesi di cessione a
terzi (anche nell'ambito del consumo di gruppo o di tutte le attività ad esso
finalizzate) non avrebbe avuto ragion d'essere l'inciso previsto dall'art. 72, “fuori
dalle ipotesi di cui all'art. 80”24.
IV. Il quadro legislativo alla luce del D.P.R. 309/90 e gli arresti giurisprudenziali
sul tema del consumo di gruppo
Con la legge 26 giugno 1990, n. 162 e quindi con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è
stato approvato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
La legge de qua è caratterizzata da una decisa marcia indietro rispetto ai principi che
avevano guidato la normativa del 1975, preso atto del fallimento del regime di non
punibilità che non aveva comportato alcuna riduzione della diffusione degli
stupefacenti, accompagnata dalla volontà di risolvere le questioni interpretative ed
applicative intorno al concetto di modica quantità, sostituito con quello,
assolutamente oggettivo e predeterminato (con decreto ministeriale), della “dose
media giornaliera” (DMG)25.
In particolare, si è tornati al regime di punibilità del detentore e dell'acquirente di
sostanza stupefacente per uso personale, comminando soltanto sanzioni
amministrative allorché la condotta abbia ad oggetto quantitativi di sostanza non
superiori alla dose media giornaliera (artt. 75 e 76) e prevedendo invece la sanzione
penale allorché la condanna concerna quantità eccedenti tale soglia (art. 73). In
particolare, nella formulazione originaria, l'art. 72 puniva, al primo comma, l'uso
personale di sostanze stupefacenti ed, al secondo comma, fissava i requisiti affinché
la detenzione di stupefacenti potesse ritenersi legittima, a tal fine richiedendo, per un
verso, che la detenzione fosse giustificata da una finalità terapeutica, per altro verso,
che fosse legittimata da una prescrizione medica conforme ai requisiti formali
previsti dalla legge e congrua rispetto alle esigenze terapeutiche del paziente26.
24 Trib. Parma, 29 febbraio 1980, in Riv it. dir. proc. pen., 420, con nota critica di BENINCASA.25 BASSI, La disciplina sanzionatoria in materia stupefacenti, Padova, 2010, 11.26 BASSI, cit., 12.
7
Sono state riconfermate le fattispecie incriminatrici concernenti le condotte
caratterizzate dalla destinazione della sostanza a terzi, anche in quantità inferiori alla
soglia della dose media giornaliera.
Il sistema della dose media giornaliera è stato sottoposto allo scrutinio della Corte
Costituzionale con riguardo a diversi profili di contrasto con la Carta Fondamentale
(in particolare con gli artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.). Con la sentenza n. 333 dell'11 luglio
199127, il giudice delle leggi ha respinto le censure sollevate dietro l'osservazione che
la scelta del legislatore nel senso di delimitare la non punibilità della detenzione di
sostanze stupefacenti, attuata mediante la riduzione della quantità di sostanze la cui
detenzione non costituisce reato, non appare irrazionale, irragionevole o arbitraria
laddove è volta a combattere più efficacemente il mercato della droga, limitando, con
il divieto di accumulo, la quantità di sostanza stupefacente detenibile dal soggetto
senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il
pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre
la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da
costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, sì da renderne più difficile la
pratica. Tale scelta, ad avviso del Giudice delle leggi, non viola neanche il principio
della offensività, in quanto quest'ultima deve ritenersi di norma implicita nella
configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore.
Analoghi principi sono stati ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale del 27
marzo 1992, n. 13328.
Il Testo unico è stato temporaneamente modificato con il decreto legge 12 gennaio
1993, n. 3, con il quale è stata ampliata l'applicazione delle sanzioni amministrative,
correlativamente riducendo l'area del penalmente sanzionabile, nel caso di
importazione, acquisto e detenzione per uso personale di quantità non superiore al
triplo della dose media giornaliera. Tale decreto non è stato tuttavia convertito in
27 Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Cass. pen., 1992, 576; in Foro it., 1991, I, 2628, con osservazioni di GIORGIO e nota di FIANDACA, La nuova legge antidroga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa; in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, III, 285, con nota di PALAZZO, Dogmatica ed empiria nella questione di costituzionalità della legge antidroga; in Riv. pen., 1991, 889, con nota di POTETTI, Le risposte della Corte Costituzionale ai giudici in materia di T.U.stupefacenti.28 Corte Cost., 27 marzo 1992, n. 133, in Cass. pen., 1992, 2612, con nota di MANZIONE, La legge sugli stupefacenti ancora all'esame della Consulta; in Foro it., 1992, I, 2915, con osservazioni di GIORGIO.
8
legge29.
L'impostazione di fondo del Testo unico sugli stupefacenti ha subito una profonda
trasformazione con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, emanato a seguito del
referendum, svoltosi il 18 e 19 aprile 1993, abrogativo del parametro della dose
media giornaliera30. A seguito di questa modifica, non costituiscono più reato, ma
solo un illecito amministrativo, l'acquisto e la detenzione per uso personale di
sostanze stupefacenti, a prescindere dal superamento di un quantitativo
predeterminato di sostanza: in tal caso, sono applicabili unicamente le sanzioni
previste ex art. 75 di competenza del Prefetto e non anche le sanzioni applicabili
dall'Autorità giudiziaria (già contemplate nell'abrogato art. 76)31.
Rimane in ogni caso ferma la punibilità di qualunque condotta avente ad oggetto
sostanze stupefacenti destinate a terzi32.
Successivamente all'esito referendario, la detenzione di sostanza stupefacente per uso
personale costituisce soltanto un illecito amministrativo, e non più un reato,
indipendentemente dalla quantità detenuta, né un limite quantitativo alla detenzione
non punibile può essere desunto dalle sentenze della Consulta o dalle convenzioni di
New York del 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs)33 e di Vienna del 198834
(Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances).
Il quantitativo di sostanza assume perciò rilevanza esclusivamente come elemento
probatorio, dimostrativo della destinazione ad un uso non personale35.
Prima del referendum abrogativo del 1993, la giurisprudenza assolutamente
maggioritaria riconosceva la punibilità della c.d. codetenzione per uso di gruppo,
ritenendo che essa integrasse gli estremi del concorso nel reato in relazione all'intero
29 BASSI, cit., 12.30 In particolare, è stata eliminata dall'art. 75 comma primo la seguente frase “in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma primo dell'art. 78”; sono stati abrogati l'intero 76 e l'intero comma secondo dell'art. 72, nonché altre parole o parti degli artt. 2, 73, 75, 78, 80, 120 e 121.31 CANEPA, cit., 7.32 BASSI, cit., 13.33 Il testo integrale è consultabile al sito http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html; per ulteriori informazioni sulla Convenzione di New York del 1961, MCALLISTER, Drug Diplomacy in the Twentieth Century, London, 1999.34 Il testo integrale è consultabile al sito www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html. 35 Ex multis, Cass., 3 maggio 1994, n. 8311, in CED Cass.; nel caso in cui sia accertato che il soggetto detenga la sostanza in parte per uso personale e in parte per lo spaccio, il giudice deve operare una valutazione quantitativa, con ragionevole approssimazione,e commisurare alla parte destinata allo spaccio la gravità del fatto ai fini della pena e dell'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R 309/1990.
9
quantitativo, e non già la detenzione di una quota ideale da parte di ciascun
appartenente al gruppo, e che la ripartizione dello stupefacente tra i codetentori
importasse una cessione di porzioni del quantitativo codetenuto, non dissimile da
ogni altra forma di cessione o scambio di sostanza stupefacente36.
La Corte della nomofilachia insegnava infatti che la condotta del singolo concorrente
risultava priva di autonomia perché avente ad oggetto gli obiettivi comuni perseguiti,
in varia e diversa misura, dagli imputati37.
Successivamente all'esito referendario38 e alla riscrittura delle fattispecie
incriminatrici in materia, erano emersi in giurisprudenza tre orientamenti
ermeneutici.
Secondo un primo orientamento, l'esito del referendum non aveva avuto alcuna
ricaduta sulla punibilità della codetenzione per uso di gruppo. Questa posizione
portava a sostegno di tale conclusione una pluralità di argomenti: in primo luogo si
osservava che il termine “uso personale” andava interpretato restrittivamente, di tal
che doveva ritenersi penalmente rilevante qualunque fatto previsto dall'art. 73 e
quindi anche la detenzione che, travalicando il limite rigoroso della persona
dell'assuntore, comportasse qualunque forma di rapporto con altro soggetto,
riguardante comunque sostanze stupefacenti39. Il Supremo Consesso sottolineava
inoltre che, siccome il consumo di gruppo implica la cessione sia pure parziale della
droga a terzi, era da escludere almeno in parte l'uso personale. In secondo luogo
veniva evidenziato dall'orientamento de quo che ogni situazione di acquisto in
comune o di codetenzione determinava un vincolo solidale tra i membri del gruppo,
in funzione del quale ciascuno viene ad agire, oltre che nell'interesse proprio, anche
nell'interesse altrui, originando una gestione di fatto societaria dell'atto di acquisto e
del successivo possesso, nonché dell'utilizzazione della sostanza, sicché la singola
condotta è destinata ad esulare dall'esclusiva sfera individuale per ridondare sulla
36 Cass., 19 settembre 1992, n. 900, in CED Cass., n. 192060.37 Cass., 19 settembre 1992, n. 900, in CED Cass., n. 192060; Cass., 13 luglio 1994, n. 10071, in Giur. it., 1995, 7, 418.38 La sentenza della Corte costituzionale 4 febbraio 1993, n. 28, che ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare avente per oggetto la disciplina delle sostanze stupefacenti o psicotrope, può leggersi in Foro it., 1993, I, 648; vd, inoltre, AMATO, La disciplina degli stupefacenti dopo il referendum abrogativo, in Foro it., 1993, II, 541; ID, Ancora qualche notazione sulla disciplina degli stupefacenti dopo il referendum abrogativo, in Foro it., 1994, I, 374.39 Cass., 25 maggio 1994, n. 2441, in Cass. pen., 1996, 320.
10
posizione e sugli interessi degli altri membri del pur occasionale sodalizio, il che
costituisce il nucleo essenziale di rilevanza penale della fattispecie pur a seguito delle
modifiche determinate dal referendum abrogativo del 199340. Oltre a ciò si rimarcava
che la cessione di droga, anche se conseguente ad acquisto per uso personale proprio
e del cessionario, rientra nella rosa delle condotte tipizzate nell'art. 73, fra le quali
figura qualsiasi forma di procacciamento a terzi di sostanze stupefacenti e financo la
semplice consegna della medesima41.
Secondo l'orientamento opposto, all'esito della modifica di cui all'art. 75 D.P.R. n.
309/1990 con il referendum, la codetenzione per l'uso in comune di sostanze
stupefacenti non doveva più ritenersi punibile. Questo indirizzo giurisprudenziale
riconduceva questo mutamento alla rinnovata ratio legislativa, in virtù della quale
alla condizione del consumatore-detentore si addicevano, più che sanzioni penali,
sanzioni di carattere amministrativo, nel convincimento che la sola misura repressiva
penale, da un lato, non adempiva ad un'adeguata funzione preventiva (in
considerazione dello stato psico-fisico del destinatario della norma) e, dall'altro, non
garantiva condizioni di sostegno personale nell'attività di recupero del
tossicodipendente (più congeniali alla funzione amministrativa che a quella
criminale)42.
Il Supremo Consesso evidenziava inoltre che, ritenendo che ciascun concorrente
avesse detenuto l'intero, si sarebbe pervenuti, nella valutazione giuridica, allo
sdoppiamento di un fatto storicamente e funzionalmente unitario (imponendo a
ciascun concorrente l'applicazione sia delle misure amministrative, per la parte di
droga destinata al consumo personale, sia della sanzione penale, per la parte destinata
al consumo personale degli altri codetentori), con il risultato, in virtù della
prevalenza, anche cronologica, delle sanzioni penali, di vanificare, per tutti i
concorrenti, l'applicazione delle misure amministrative e di determinare
l'assoggettamento alla vecchia regolamentazione (penale), per il solo fatto di aver
unito le loro forze nell'acquisto della droga, soggetti che sul piano sostanzialistico
40 Cass., 6 novembre 1995, n. 5548, in Cass. pen., 1996, 3138; Cass., 31 gennaio 1994, n. 6895, in Cass. pen., 1995, 3079.41 Cass., 2 ottobre 1996, n. 9182, in Guida dir., 1997, n. 9, 78; Cass., 18 gennaio 1994, n. 2534, in Nuovo dir., 1994, 269.42 Cass., 29 novembre 1993, n. 3809, in Cass. pen., 2230.
11
andavano considerati consumatori43.
Si evidenziava ancora come, ciascuno dei partecipanti al gruppo dovesse ritenersi
avere acquistato, sin dall'inizio, quella parte della sostanza corrispondente alla
somma versata con destinazione al suo uso personale, ponendo dunque in essere in
quello stesso istante l'illecito amministrativo proprio di chi acquista stupefacente per
uso personale; era dunque da escludere qualunque rilevanza penale all'atto della
successiva divisione della sostanza tra gli acquirenti, in quanto tale azione andava a
realizzare non un trasferimento della sostanza dalla disponibilità esclusiva dell'uno
alla disponibilità dell'altro o degli altri, e perciò reato, ma una semplice operazione
volta a consentire a ciascuno di venire in possesso del quantitativo fin dall'inizio
destinato al suo uso personale44.
Per poter parlare di codetenzione non punibile si riteneva tuttavia necessario che
fosse acquisita la prova rigorosa che la droga era stata acquistata in comune, cioè con
il denaro di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo
esclusivo dei medesimi, poiché solo in questo caso risultava irrilevante che la
sostanza fosse detenuta da uno solo dei partecipanti al gruppo degli assuntori, in
quanto l'intero quantitativo era idealmente divisibile in quote corrispondenti al
numero dei partecipanti; al di fuori di questi presupposti, a carico del detentore
doveva essere configurato il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi della
sostanza45. Allo stesso modo, la condotta di cessione era punibile allorché la
sostanza, pur assunta congiuntamente dai diversi imputati, fosse stata procurata da
uno solo di essi del tutto autonomamente ed al di fuori di un preventivo accordo46.
Fra questi due orientamenti contrastanti si era poi sviluppato un terzo filone
ermeneutico intermedio, alla stregua del quale doveva essere distinto il caso di chi,
anche mediante suddivisione interna, avesse procurato ad altri della droga per il
consumo comune o di gruppo (da ritenere penalmente rilevante), dal caso in cui una
pluralità di persone avesse codetenuto la droga in forma collettiva al fine del comune
uso, invece non punibile47.
43 Cass., 29 novembre 1993, n. 3809, in Cass. pen., 2230.44 Cass., 1 marzo 1995, n. 6483, in CED Cass.; Cass., 5 novembre 1996, n. 4775, in Guida dir., 1997, n. 9, 78.45 Cass., 12 luglio 1996, n. 8013, in Cass. pen., 1997, 1502; Cass., 29 aprile 1996, in Guida dir., 1996, n. 41, 80.46 Cass., 20 novembre 1996, n. , in Cass. pen., 1997, 1504.47 In questo senso Trib. Vicenza, 25 gennaio 1995, in Foro it., 1995, II, 259; in senso conforme in
12
A comporre il contrasto ermeneutico è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite
con la nota sentenza Iacolare, che ha recepito l'orientamento nel senso della non
punibilità della detenzione e dell'acquisto di gruppo48.
In primo luogo, il massimo Consesso di legittimità ha richiamato e fatto proprio
l'insegnamento della Corte Costituzionale (nelle note sentenze n. 360/199549 e n.
296/199650), laddove ha sancito che l'esito del referendum del 18 e 19 aprile 1993 ha
consentito di isolare la posizione del tossicodipendente (ed anche del tossicofilo)
rispetto a quella dei vari “protagonisti” del mercato degli stupefacenti, e perciò di
delineare l'area della “cintura protettiva” riservata al consumo personale contro i
rischi di sanzione penale, nella quale vanno a ricadere i comportamenti
immediatamente precedenti ad esso, essendo di norma la detenzione (spesso
l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione. Il Supremo
Collegio ha quindi evidenziato che è l'elemento teleologico della destinazione a
caratterizzare in termini di “immediatezza” il rapporto detenzione-consumo ed a
costituire la ragione stessa della depenalizzazione: ciò che esclude la rilevanza penale
dottrina AMATO, Sull' “uso di gruppo” di sostanze stupefacenti, in Cass. pen., 1997, 1504.48 Cass., S.U., 28 maggio 1997, n. 4, in Riv pen., 1997, 805 con nota di TENCATI, Assunzione collettiva di stupefacenti e depenalizzazione; in Cass. pen., 1998, II, 399, con nota di POTETTI; in Riv. pol., 1997, 8, 553, con nota di DUBOLINO, Irrilevanza penale dell'acquisto su mandato di sostanza stupefacente per uso di gruppo: una decisione che non convince; in Guida dir., 1997, n. 33, 62 con nota di AMATO, La destinazione a una “somma” di usi personali toglie rilevanza penale alla detenzione; ID, in Foro it., 1997, 9, 529, L'intervento delle Sezioni Unite sul trattamento dell'”uso di gruppo di sostanza stupefacenti.49 Corte Cost., 16 agosto 1995, n. 360, in CED Cass., che ha insegnato che “la scelta della non criminalizzazione del consumo in sé (che rappresenta una nota costante di tale disciplina di settore, pur nelle alterne formulazioni ispirate a maggiore o minor rigore) implica necessariamente anche, in qualche misura, la non rilevanza penale di comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione”. La Consulta ha inoltre sottolineato in questa pronuncia che “La linea di confine di queste condotte che, per il fatto di approssimarsi all'area di non illiceità penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di una valutazione di maggiore tolleranza, è stata segnata prima dalla modica quantità, poi dalla dose media giornaliera, infine dall'uso personale; ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura protettiva del nucleo centrale (id est il consumo) per evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti, che il legislatore ha ritenuto da ultimo di contrastare appunto con la comminatoria di sanzioni solo amministrative per le condotte ritenute più immediatamente antecedenti, possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. La coltivazione invece è esterna a quest'area contigua al consumo e ciò già di per sè rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata”.50 Corte Cost., 14 agosto 1996, n. 296, in CED Cass., n. 22952, che ha evidenziato che “l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale, al quale è altresì riservata la valutazione della nocività dei vari tipi di droga, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantità, qualunque sia il fine perseguito dal cedente, appare giustificato nonché corrispondente ad un preciso obbligo internazionale di inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere”.
13
e qualifica il fatto come illecito amministrativo è il consumo “personale”, a
prescindere dalla quantità della sostanza e dalle modalità della detenzione, così come
fa ben intendere l'avverbio “comunque” con il quale la norma connota la detenzione
stessa. Rimane invece penalmente rilevante il rapporto tra cedente e consumatore,
qualunque sia il fine da costui perseguito o la quantità della sostanza ceduta,
risultando tale condotta comunque offensiva dell'interesse a contrastare la diffusione
della droga51.
Da tali premesse, il giudice della nomofilachia ha inferito, quale corollario, che
nell'ambito della “cintura protettiva” delineata dal legislatore intorno al consumo
personale non possono non farsi rientrare anche l'acquisto e la detenzione della
sostanza che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche degli altri
soggetti, essendo certa sin dalla prima fase l'identità dei medesimi nonché manifesta
la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale.
Il Supremo Collegio a composizione allargata ha infatti sottolineato che l'omogeneità
teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti
del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si
ponga in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con
conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione. Devono
dunque essere equiparati, rientrando nell'area dell'illecito amministrativo, sia il caso
di acquisto contestuale da parte degli appartenenti al gruppo, che insieme detengono
e poi suddividono la sostanza (ipotesi pacificamente depenalizzata), sia il caso in cui
un componente acquisti anche per conto degli altri e successivamente proceda a
suddividere la sostanza (ipotesi invece controversa52), in quanto entrambi i casi
attengono pur sempre ad una codetenzione quale antecedente immediato rispetto al
consumo da parte dei componenti del gruppo, con la sola differenza che nel secondo
caso l'acquirente-assuntore agisce sulla base di un mandato ricevuto dagli altri, con
effetti però equivalenti quanto ad acquisto e a disponibilità della sostanza53.
A supporto della tesi “de qua”, la Suprema Corte ha fatto riferimento ai principi
51 BASSI, cit., 122.52 Distingue le due ipotesi di “acquisto in comune” e di “mandato ad acquistare” AMATO, La destinazione a una “somma” di usi personali toglie rilevanza penale alla detenzione , in Guida dir., 1997, n. 33, 62, ritenendo che solo la prima possa rientrare nella previsione di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990.53 BASSI, cit., 123.
14
civilistici sanciti ex artt. 1388 e 1706 del codice civile per indicare gli effetti
dell'acquisto operato dall'acquirente-assuntore sulla base del mandato ricevuto dagli
altri componenti del gruppo54. La ripartizione della sostanza stupefacente da parte
dell'acquirente o detentore costituisce perciò un'attività meramente esecutiva di
consegna di un quantitativo ad un soggetto che ne è già sostanzialmente proprietario,
per averlo già acquistato come quota di una quantità indivisa, di tal che si è al di
fuori delle ipotesi di cessione punibile55.
Parte della dottrina, pur condividendo le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni
Unite, ha criticato il riferimento fatto dal Giudice di legittimità all'istituto del
mandato con rappresentanza per giustificare la rilevanza amministrativa dell'acquisto
effettuato dal singolo per conto del gruppo56.
In particolare, sono state avanzate tre riserve sull'utilizzazione del vincolo giuridico
del mandato con rappresentanza per collegare l'acquisto della sostanza stupefacente
da parte del singolo con l'assunzione della stessa da parte del gruppo nel suo
complesso.
In primo luogo, è stato evidenziato che, anche se è vero che l'istituto del mandato
senza rappresentanza consente di escludere il perfezionarsi della condotta della
“cessione”, non si può negare l'avvenuto perfezionamento di un'altra condotta
penalmente rilevante ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, quella del “procurare ad
altri”.
In secondo luogo, si è osservato che la stessa qualificazione di mandato con
rappresentanza non persuadeva del tutto. Questo orientamento ermeneutico ha infatti
sottolineato come si trattasse, in realtà, di mandato senza rappresentanza: “non
risponde, infatti, a sana concretezza ritenere che l'acquirente si rechi dallo spacciatore
ad esempio a nome di Tizio, Caio, Sempronio. Se così fosse”, si aggiungeva, “l'esatto
momento dell'insorgenza della proprietà in capo ai mandanti sarebbe tutt'altro che
54 In dottrina è stata peraltro criticata l'impostazione “de qua”, osservando come il Giudice di legittimità non abbia tenuto conto del fatto che l'art. 73 D.P.R. 309/90 sanziona espressamente anche la condotta di intermediazione, cioè la condotta di colui che procuri ad altri sostanza stupefacente, in quanto condotta che comunque realizza un'illecita diffusione a terzi della sostanza stupefacente, e come il richiamo agli istituti tipici del diritto civile non escluda l'offensività penale della condotta, incidendo semmai nei soli rapporti interni tra i soggetti coinvolti: così AMATO, Stupefacenti. Teoria e pratica, Roma, 2006, 125.55 BASSI, cit., 123.56 VECCHI, L'uso di gruppo di sostanze stupefacenti nella giurisprudenza della Corte Suprema, in Dir. pen. e proc., 1999, 769.
15
incontroverso. In base alla regola sancita dall'art. 1388 c.c., infatti, il contratto
concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del
rappresentato soltanto nel caso in cui il primo abbia speso il nome del secondo57”.
Da ultimo, è stato rilevato che la causa e l'oggetto di tale contratto sono illeciti e che
quindi il contratto stesso sarebbe comunque nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c58.
Diversa dall'ipotesi del mandato ad acquistare è invece quella nella quale
l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, ovvero non abbia avuto alcun
mandato all'acquisto o alla detenzione: in tal caso, la condotta risulta priva della
finalità dell'uso personale o comunque si pone in rapporto di diversità teleologica
rispetto a quella degli altri componenti del gruppo ed appare riconducibile allo
schema del traffico di droga penalmente rilevante59.
La Suprema Corte con la sentenza Iacolare ha perciò chiarito che il giudice dovrà di
volta in volta verificare in concreto se sussistano o meno elementi sintomatici della
finalità di spaccio che, nella detenzione individuale così come quella di gruppo,
possono essere rappresentati dalla quantità e qualità di sostanza rapportate alle
condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare; dalla composizione
della sostanza (in quanto, se questa non è già pronta per il consumo personale ed
immediato, è ragionevole presumere una destinazione allo spaccio); dall'eterogenea
qualità della sostanza detenuta; dalla disponibilità di attrezzature per la pesatura o di
mezzi per il confezionamento delle dosi60.
La giurisprudenza di legittimità successiva si è attestata sull'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione61. In particolare, la Corte ha ribadito che, se
l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è
irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero
quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati
57 VECCHI, cit., 769, che sottolinea che solo taluni orientamenti della dottrina civilistica (con il pensiero che va alla tesi del “doppio trasferimento automatico”), ritengono che gli effetti prodotti dal mandato senza rappresentanza, avente ad oggetto cose mobili, siano equivalenti a quelli esplicati dal mandato caratterizzato da una espressa spendita del nome dei mandanti.58 DUBOLINO, Sulla pretesa liceità della detenzione di gruppo, per uso personale, di sostanze stupefacenti, in Riv. polizia, 1997, 221.59 BASSI, cit., 123.60 BASSI, cit., 123.61 Ex multis, Cass., 29 settembre 1997, n., in Cass. pen., 1998, 6, 1797 con nota di LAZZARI, ; Cass., 1 marzo 2007, n. ,in CED Cass., n. 237274; Cass., 5 maggio 2005, n. 27393, in Guida dir., 2005, n. 40, 81; Cass., 3 giugno 2004, n. , in CED Cass., n. 2292272.
16
partecipanti; in difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione a terzi, sia
pure gratuita, di sostanza stupefacente62.
In giurisprudenza, l'orientamento prevalente ha ribadito che, affinché la detenzione al
fine di consumo di gruppo di sostanza stupefacente non sia punibile, occorre che la
sostanza venga acquisita da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato
degli altri, in vista della futura ripartizione ed attraverso una partecipazione di tutti
alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, così che si possa affermare che
l'acquirente agisca come longa manus degli altri e che il successivo frazionamento
della sostanza acquisita sia solo un'operazione materiale di divisione senza
trasferimento dall'uno all'altro di valore63. E' dunque necessario il conferimento
espresso di un mandato, che sia rigorosamente provato e che sia stato dato da
soggetti determinati, con la preventiva consegna del denaro64. Quando il
procacciatore non agisca per conto altrui e quindi sulla base di un accordo
preventivo, o agisca unicamente su mandato di terzi senza essere a sua volta
assuntore, viene meno quella comunione di fine che rende assimilabile, agli effetti
dell'art. 75 D.P.R. n. 309/1990, la detenzione per uso personale alla detenzione per
uso di gruppo65. In particolare, i presupposti dell'uso di gruppo sono stati esclusi alla
luce: delle risultanze oggettive acquisite, convergenti nel senso della destinazione
della droga, quanto meno in parte, ad attività di spaccio, quali la diversità delle
sostanze cadute in sequestro (hashish e marijuana), le modalità di occultamento delle
sostanza stesse, il rinvenimento di materiale per il confezionamento di dosi, gli
accertati contatti dell'imputato con alcuni giovani osservati nei pressi del luogo di
abitazione dell'imputato stesso; nonché della mancata allegazione da parte degli
imputati di elementi oggettivi certi ed univoci circa l'asserito acquisto della droga in
comune, con denaro di tutti, da destinare esclusivamente all'uso dei partecipanti al
62 Cass., 10 luglio 2007, n. 35682, in CED Cass., n. 237776, che inoltre ha precisato “che la contraria prova della destinazione della droga allo spaccio spetta all'accusa, mentre non incombe all'imputato l'onere inverso di dimostrare la propria innocenza”. 63 Ex multis, Cass., 14 gennaio 2009, n. 7939, in CED Cass., n. 243870; Cass., 3 giugno 2003, n. 28318, in CED Cass., n. 225684; Cass., 11 maggio 2000, n. 12001, in CED Cass., n. 217893; in Rivista pen., 2001, 2, 116.64 Cass., 11 maggio 2000, n. 12001, in CED Cass., n. 217894.65 Cass., 4 giugno 1999, n. 9075, in CED Cass., 214070; in Cass. pen., 2000, 1054, con nota di PISANI, In tema di uso di gruppo di sostanze stupefacenti; in Cass. pen., 2000, 520, con nota di AMATO, Auspicabile un maggior rigore probatorio per ritenere l'“uso di gruppo” di droga; in Foro it., 2000, 244, con nota LA GRECA, Polemiche poco informate sulla politica penale in tema di stupefacenti; in Giust. pen., 2000, 235.
17
gruppo66. Ancora, si è esclusa la detenzione per uso di gruppo nel caso del soggetto
che, durante le feste, metta a disposizione degli ospiti della cocaina laddove dai fatti
non emerga che gli altri partecipanti ai c.d. festini abbiano avuto, fin dall'origine (e
cioè fin dal momento dell'acquisto), un autonomo potere di fatto sulla sostanza
stupefacente (con la conseguenza che, in mancanza di esso, l'acquirente deve
considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura
come una cessione)67.
L'irrilevanza penale della condotta va anche esclusa nei casi in cui vi sia stata la
cessione al gruppo di un quantitativo di droga eccedente quello inizialmente
richiesto68.
Richiamando il citato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha
anche affermato, in tema di estradizione per l'estero, che non soddisfa il requisito
della doppia incriminabilità, di cui all'art. 2 della Convenzione europea di
estradizione69, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione
relativa a fatti di acquisto e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale,
che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando
sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e sia manifesta la volontà di procurarsi
le sostanze destinate al proprio consumo. Ne consegue che non può essere
pronunciata sentenza favorevole all'estradizione, rientrando il fatto oggetto della
domanda nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 70.
E' d'uopo peraltro mettere in luce un orientamento giurisprudenziale più estensivo,
assai criticato da una parte della dottrina71, secondo il quale può essere configurato
l'acquisto per consumo di gruppo anche nel caso di mandato tacito o addirittura
66 Cass., 1 marzo 2007, n. 37078, in CED Cass., n. 237274, che ha escluso l'uso di gruppo nella detenzione di un quantitativo complessivo di oltre 1600 dosi di eroina da parte dell'imputato.67 Cass., 29 novembre 2000, n. 10745, in CED Cass., n. 21877868 Cass., 9 settembre 2009, n. 35017, non massimata. 69 Testo consultabile sul sito internet del Consiglio d'Europa www.conventions.coe.int. Il trattato di Parigi è stato ratificato con la legge n. 300 del 30 gennaio 1963.70 Cass., 5 aprile 2007, n. 21178, in CED Cass., n. 236585. Il caso di specie riguardava l'acquisto da parte di un cittadino straniero, in occasione della sua festa di compleanno, di due dosi di morfina da consumare successivamente insieme ad un amico personale (la Suprema Corte ritenendo, che sussistessero tutti gli “elementi sintomatici” del previo accordo, ha stabilito che si trattava di un'ipotesi di consumo di gruppo).71 AMATO, Stupefacenti. Teoria e pratica, Roma, 126; ID., Osservazione a g.i.p., Trib. Vicenza 3 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, 2, 534; ID., L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, in Guida dir., 2011, 12, 68.
18
conforme ad una prassi instauratasi tra gli appartenenti al gruppo e diretta a
disciplinare le modalità di approvvigionamento della droga72, senza che sia
necessaria una preventiva colletta con anticipo del denaro al mandatario73.
Alcune pronunce hanno ampliato l’ambito della destinazione all’uso di gruppo fino a
ricomprendervi casi nei quali la droga sia inizialmente stata acquistata da un singolo,
senza alcun preventivo incarico all’acquisto: “non può escludersi una situazione di
uso di gruppo nel caso in cui più persone decidano concordemente ed unitariamente
di consumare della droga già detenuta da uno di loro, in quanto anche in questo caso
ricorre quella affinità teleologica che caratterizza la codetenzione di gruppo”74.
Questo orientamento è stato criticato dalla dottrina prevalente che ha sottolineato
come la pronuncia de qua non tenga in considerazione il fatto che il reato si consumi
all’atto dell’acquisto di droga destinata alla cessione (anche a titolo gratuito) del
singolo (e sul punto la motivazione nulla dice), e che pertanto il successivo consenso
dei terzi alla consumazione di gruppo possa, al più, incidere sulla quantificazione
della pena ex art. 133 c.p.75.
V. Le novità introdotte dalla l. 49/2006 (c.d. legge Fini-Giovanardi) e i contrasti
attuali in giurisprudenza
La disciplina degli stupefacenti è stata in parte modificata dal decreto legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2006,
n. 476.
72 Cass., 4 giugno 1999, n. 9075, in CED Cass., n. 214070; in Cass. pen., 2000, 1054, con nota di PISANI, In tema di uso di gruppo di sostanze stupefacenti; in Cass. pen., 2000, 520, con nota di AMATO, Auspicabile un maggior rigore probatorio per ritenere l'“uso di gruppo” di droga; in Foro it., 2000, 244, con nota LA GRECA, Polemiche poco informate sulla politica penale in tema di stupefacenti; in Giust. pen., 2000, 235.73 Cass., 4 giugno 1999, n. 9075, cit.; Cass., 18 giugno 2002, n. 43670, in CED Cass., n. 222811.74 Cass., 10 marzo 2008, n. 29174, in CED Cass., n. 240580. Nel caso di specie, relativo ad una condotta verificatasi prima della riforma introdotta dalla legge n. 49 del 2006, non vi era stato alcun preventivo incarico all'acquisto poichè la sostanza stupefacente si trovava già nella disponibilità dell'imputata, presso la cui abitazione si erano recati gli altri imputati 75 BELTRANI, Relazione all'incontro di studio sul tema “Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti:tecniche investigative e stupefacenti:tecniche investigative e problemi applicativi”, 26, Roma, 30 novembre 2009, consultabile al sito www.csm.it. 76 BASSI, cit., 14. Sulle modifiche introdotte dalla l. 49/2006 si rinvia ad INSOLERA, La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2008; AMATO, Per gli indizi della giurisprudenza arriva la “promozione” a norma, in Guida dir., 2006, 12, 69 ss.; ID., Il funzionamento della nuova disciplina degli stupefacenti: parametri indiziari e regola dell'“al di là del ragionevole dubbio”, in Cass. pen., 2006, 4181; MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale, in Dir. pen. e proc., 2006, 823; POTETTI, L'enigmatico comma 1 bis dell'art. 73 del
19
In primo luogo, il legislatore ha raggruppato sotto la Tabella I gli oppiacei, i derivati
della cannabis ed ogni altra droga di derivazione sintetica, con la conseguenza di
unificare la disciplina sanzionatoria per tutte le sostanze stupefacenti, ed ha inserito
nella Tabella II i prodotti di natura farmaceutica contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope77.
Con la riforma del 2006 è stata inoltre abbassata la pena minima edittale per il reato
previsto dall'art. 73 commi 1 e 1-bis (passando, quanto alla pena detentiva, da 8 a 6
anni) ed, al comma 1-bis, è stato previsto che, ai fini della punibilità delle condotte di
importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione (per le quali può
assumere rilievo scriminante la destinazione all'uso personale), uno dei parametri da
considerare per valutare se la sostanza sia o meno destinata “ad un uso non
esclusivamente personale” sia costituito dal superamento dei limiti edittali indicati
con decreto ministeriale (del Ministro della salute di concerto con il Ministero della
giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga). In particolare, nel nuovo comma 1-bis, sono state isolate,
fra le condotte già previste dal comma 1 dell'art. 73 previgente, quelle la cui
punibilità con sanzione penale, anziché amministrativa, dipende dalla finalizzazione
dell'azione “all'uso non meramente personale”, destinazione che può essere desunta:
dalla quantità della sostanza (in particolare se superiore ai limiti massimi previsti con
decreto ministeriale), dalle modalità di presentazione dello stupefacente (avuto
riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato) o dalle altre
circostanze dell'azione78.
D.P.R. n. 309 del 1990, in Cass. pen., 2007, XX; MANES, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, cit; CHERCHI, Problematiche e contrasti giurisprudenziali in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, Incontro di studio sul tema “Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti:tecniche investigative e problemi applicativi”, Roma, 30 novembre 2009, consultabile al sito www.csm.it; BELTRANI, cit., 26; MAZZARA, Questioni vecchie e nuove in materia di stupefacenti: le prassi applicative nel processo penale, Formazione decentrata del CSM, Palermo, 5 maggio 2010, consultabile al sito www.csm.it.77 E' dunque venuta meno la differenziazione ai fini del trattamento penale fra le sostanze stupefacenti tradizionalmente qualificate come “leggere” e quelle “pesanti”. Sul punto si rinvia a ZANCANI, La riforma dei delitti di produzione,traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti , in AA.VV., Commento pratico sistematico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti , a cura di RIONDATO, Padova, 2006.78 Sebbene, nella dichiarata intenzione del legislatore, la previsione della “quantità massima detenibile (QMD) stabilita con decreto dall'autorità amministrativa fosse volta ad introdurre una soglia quantitativa superata la quale doveva sempre ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, con ciò nella sostanza reinserendo nel sistema un parametro analogo a quello della dose media giornaliera (DMG) spazzato via dal referendum abrogativo del 1993, nella lettura data dalla giurisprudenza e
20
Alla luce del novum normativo, occorre domandarsi se, alla stregua dell'espresso
riferimento al carattere esclusivo che deve connotare l'uso personale della sostanza
stupefacente, vi sia ancora uno spazio per ritenere non punibile la codetenzione per
uso di gruppo e conseguentemente la detenzione e l'acquisto di un quantitativo di
stupefacente finalizzato all'uso di un gruppo di persone.
In dottrina, alcuni Autori hanno sostenuto che l'uso della formula indeterminativa
“uso esclusivamente personale” consenta l'inquadramento nell'area di rilevanza
meramente amministrativa delle condotte finalizzate all'uso esclusivamente personale
anche di persone diverse dal reo79. Questo orientamento ermeneutico osserva come la
formula “esclusivamente personale” possa essere interpretata non solo come
detenzione tesa ad un consumo individuale, ma anche (propendendo gli Autori in
questione per questa seconda soluzione interpretativa) come detenzione con una
finalità di consumo “personale” nel senso di non destinato alla cessione a terzi, ma
non necessariamente solitario (in quanto usufruibile da più persone)80.
La prevalente dottrina si è invece orientata, alla luce del dato letterale della norma,
nel senso di ritenere punibile anche la condotta di colui il quale detenga per conto e
nell'interesse degli altri componenti del gruppo81.
Alcuni Autori sottolineano di conseguenza che si dovrà ammettere la rilevanza
penale, non solo dell’uso di gruppo qualificato dal conferimento, esplicito o
implicito, da parte degli appartenenti al gruppo del “mandato ad acquistare” la droga
solo ad uno o ad alcuni di essi, ma anche dell’“uso di gruppo collettivo”, qualificato
dall’acquisto in comune della droga, da parte di tutti gli appartenenti al gruppo per la
successiva assunzione in comune82.
In giurisprudenza è possibile individuare due orientamenti ermeneutici.
Secondo un primo filone giurisprudenziale, in seguito alla riforma del 2006 il
della dottrina prevalente, al parametro quantitativo (come agli altri contemplati dalla norma) va assegnata una valenza esclusivamente indiziante. Così BASSI, cit., 15.79 In tal senso, ZANCANI, La riforma dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, in AA.VV., Commento pratico sistematico alle modifiche del Testo Unico sugli stupefacenti, a cura di RIONDATO, Padova, 2006, 31.80 ZANCANI, cit, 32.81 Ex plurimis, PIFFER, Commento all'art. 73 T.U. Stupefacenti, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, I, Milano, 2011, 5416; AMATO, Definite le disposizioni sull'uso di gruppo; rilievo penale anche per l'acquisto collettivo, in Guida dir., 2007, 5, 62; BELTRANI, cit, 30.82 CANEPA, La disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, Relazione per la prima settimana di tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 destinati a svolgere funzioni requirenti, Roma 11 maggio 2006, consultabile sul sito www.csm.it .
21
consumo di gruppo deve ritenersi integrare gli estremi del reato punibile a norma
dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 (dovendosi, quindi, ritenere superata la giurisprudenza di
legittimità che, sul punto, aveva optato per la non punibilità)83.
I giudici della II sezione della Suprema Corte, nella pronuncia 23574 del 2009,
hanno in primo luogo sottolineato le modifiche introdotte dalla legge Fini-
Giovanardi. Prima del 2006, l'art. 75 D.P.R. 309/1990 disponeva che “chi detiene per
farne uso personale sostanze è sottoposto alla sanzione amministrativa”; in seguito
alla novella legislativa del 2006 la non punibilità penale si desume dal combinato
disposto dei novellati artt. 73 1-bis e 75, in base ai quali è sanzionato
amministrativamente chiunque detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che, per
quantità o per qualità, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale.
Inoltre, è mutata anche la struttura semantica della frase: è stato infatti aggiunto
l'avverbio “esclusivamente” che non esisteva nel previgente art. 75.
Oltre a ciò, la Corte allarga lo sguardo alla novella normativa nel suo complesso,
constatando some sia di “immediata evidenza” la circostanza che il legislatore abbia
inteso reprimere in modo più severo ogni attività legata alla circolazione, vendita e
consumo di sostanze stupefacenti (tant'è che ha equiparato ogni tipo di sostanza
stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e
prevedendo nuove misure repressive84).
L'introduzione dell'avverbio “esclusivamente” assume, secondo i giudici della
seconda sezione della Suprema Corte, un significato particolarmente pregnante
proprio sotto il profilo semantico “perché una cosa è l'uso personale di sostanze
stupefacenti, altra e ben diversa cosa è “l'uso esclusivamente personale” (frase, si
sottolinea, che, proprio in virtù dell'avverbio, non può condurre ad un'interpretazione
più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data del
sintagma “uso personale”). Il corollario cui giunge la Suprema Corte è che non può
più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del
83 Cass., 6 maggio 2009, n. 23574, in CED Cass., n. 244859.84 In merito all'equiparazione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, vd. MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale, in Dir. pen. e proc., 2006, 7, 829 ss.; AMATO, La normativa in tema di stupefacenti, Incontro di studio organizzato dal CSM “La disciplina prevista dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49: le nuove fattispecie penali” , Roma, 24 ottobre 2007, relazione consultabile sul sito www.csm.it; PETRINI, Per una disciplina giuridica degli stupefacenti che sostenga il disagio senza criminalizzarlo, in Droghe e diritto: quali risposte?, in Legislazione penale, 2007, 479.
22
c.d. uso di gruppo, all'interno del quale è inclusa sia l'ipotesi in cui un gruppo di
persone dà mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l'altra ipotesi
in cui l'intero gruppo procede all'acquisto di stupefacente destinato ad essere
consumato collettivamente.
I giudici di legittimità sottolineano in primis che l'acquisto per il gruppo presuppone,
per assioma, l'acquisto di un quantitativo di stupefacente che, per quantità e/o per
modalità di presentazione, appare necessariamente destinato ad un uso non
esclusivamente personale. In secondo luogo si fa riferimento alla ratio legis, ossia al
chiaro intendimento del legislatore di contrastare il fenomeno della diffusione della
droga con il rendere più difficile l'acquisto, la diffusione e il consumo.
La Suprema Corte conclude perciò insegnando che, a seguito della riforma del 2006,
il baricentro si è spostato dal “consumo personale” (che veniva sanzionato in via
amministrativa a prescindere dal fatto se la detenzione fosse destinata al singolo
possessore o al gruppo) al “consumatore”, nel senso che sfugge alla sanzione penale
unicamente colui il quale sia trovato nel possesso di un quantitativo di droga che
appare destinato ad un uso “esclusivamente personale” ossia ad essere consumato
solo ed unicamente dallo stesso possessore.
Occorre però sottolineare un secondo orientamento, concretatosi nella sentenza in
commento, che ha ritenuto l'uso di gruppo non penalmente rilevante. La sesta sezione
della Corte di legittimità, nella recentissima sentenza n. 8366/201185, ha in primo
luogo ripercorso l'iter formativo della legge n. 49/2006, sottolineando però che
l'esame dei lavori preparatori e la lettura del resoconto stenografico della seduta n.
947 del 26 gennaio 2006 non consentono di chiarire in modo univoco il contesto che
ha connotato l'approvazione definitiva delle norme in tema di stupefacenti.
La Suprema Corte ha quindi messo in risalto le due antipodiche interpretazioni del
valore attribuibile alla novella normativa: da un lato, per le opposizioni la matrice
sostanzialmente repressiva della equiparazione tra droghe leggere e pesanti e della
equivalenza tra uso e spaccio; dall'altro, per il governo e la maggioranza, un
provvedimento, chiesto dalla Consulta per le tossicodipendenze, idoneo ad affermare
con chiarezza l'antigiuridicità del consumo delle sostanze stupefacenti, ed in grado di
85 Cass., 26 gennaio 2011. n. 8366, in Guida dir., 2011, 12, 64.
23
proporre al Paese un nuovo modo di interpretare il fenomeno86.
Dopo queste riflessioni preliminari, il Supremo Collegio si è interrogato sulla
questione se l'inserimento nel testo di legge dell'avverbio “esclusivamente” possa
essere ritenuto sufficiente per “paralizzare” l'uso di gruppo o se, invece, sarebbe stata
essenziale, a tale effetto interpretativo, una esplicita ed inequivoca indicazione del
legislatore (tanto più necessaria, sottolinea la Corte, avuto riguardo all'esito
referendario del 1993, e tenuto altresì conto che l'espressione “non esclusivamente
personale” ha il medesimo intercambiabile significato di “tassativamente personale”,
suggerendo così all'interprete la ragionevole impressione di un'aggiunta ridondante,
superflua e pleonastica). La sesta sezione risponde in senso opposto rispetto alla
seconda sezione del Supremo Collegio (pronuncia n. 23574/2009), sottolineando che
l'uso della forma indeterminativa “un uso esclusivamente personale” consente
inquadramenti nell'area di rilevanza meramente amministrativa di condotte
finalizzate all'uso esclusivamente personale (anche) di persone diverse. La Corte
rileva così che, “se la finalità era quella di sanzionare comunque l'uso di gruppo,
nelle due variabili dell'uso di gruppo vero e proprio (strictu sensu) e dell'uso comune,
di un bene che (come nella fattispecie) è stato oggetto di previo mandato ad
acquistare, essa è stata male espressa, con la conseguenza che, in ogni caso, nel
dubbio interpretativo, vale l'opzione più favorevole al reo”. Secondo l'orientamento
della sesta sezione, quindi, la norma in esame non è dotata di quel grado di
determinatezza sufficiente a fornire all'interprete una via indiscussa nell'individuare i
nuovi pretesi percorsi applicativi, ove l'intenzione del legislatore, fosse stata quella di
escludere in radice la legittimità dell'uso di gruppo, nei termini indicati dalle S.U.,
tanto doveva essere affermato in modo esplicito e non certo mediante sintagmi,
variamente interpretabili, e con sequenze lineari (sostantivo-negazione-avverbio-
aggettivo) in grado di produrre equivoci ed incertezze che, come tali, vanno
necessariamente valutati pro reo.
86 L’on. Mantovano, Sottosegretario dell’Interno, affermò dinanzi alle Commissioni II e XII della Camera, riunite in seduta comune: “la finalità principale del provvedimento in esame è quella di riequilibrare l'assetto normativo creatosi sul testo unico in materia di tossicodipendenza del 1990 a seguito del referendum svoltosi nel 1993 e dalle relative pronunce giurisprudenziali che sostanzialmente hanno dato luogo ad una situazione per la quale è possibile per chiunque detenere droghe senza limiti a meno che non si provi la loro destinazione allo spaccio” (DOVERE, La nuova disciplina in materia di stupefacenti alla prova dell’applicazione giudiziaria, Incontro di studio organizzato dal CSM, Roma, 26 ottobre 2008, consultabile sul sito www.csm.it).
24
Il Massimo Consesso sottolinea successivamente che in dottrina l'utilizzo di sostanze
droganti (quale forma specifica e qualificata dell'uso personale), è stato analizzato e
pesato come condotta assimilabile alle vere e proprie cause di giustificazione. La
ragione è stata individuata nella considerazione che il comportamento ritenuto
astrattamente illecito (essere in possesso di sostanze stupefacenti), finisce per essere
privato di quell'immanente carattere di antigiuridicità, laddove si rinvengano
elementi conformi che permettano di ricondurre la condotta, altrimenti penalmente
rilevante (e sanzionabile), in un contesto extra-penale. L'analisi del fatto e delle sue
connotazioni, secondo i giudici di legittimità, consente così di modificare il profilo di
illiceità qualificante le condotte in esame. Il risultato non è quello di rendere lecita, o
meritevole di tutela giuridica, tale condotta, ma ciò che viene a mutare è il grado di
offensività della stessa, che determina l'inserimento della fattispecie in una piuttosto
che in un'altra categoria di illeciti.
La Suprema Corte richiama perciò l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria
per quanto concerne i requisiti richiesti per la configurazione del consumo di gruppo:
I) l'adesione preliminare dei componenti del gruppo; II) che l'acquirente-mandatario
sia anche lui uno degli assuntori87; III) che sia certa sin dall'inizio l'identità dei
componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi
la sostanza destinata al paritario consumo personale88 e si sia del pari raggiunta
un'intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo89; IV) che gli effetti
dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi
mediati90.
Alla luce di queste considerazioni, secondo la recente pronuncia del giudice della
nomofilachia l'avverbio “esclusivamente” non lede la validità della ricostruzione
fatta dalla giurisprudenza prima della riforma legislativa del 2006 e il consumo di
gruppo è da considerarsi una forma di uso “esclusivamente personale”.
Da ultimo la Suprema Corte ha sottolineato come debba assumersi una diversa
conclusione per tutte le altre residue “condotte di consumo di gruppo”, nelle ipotesi
in cui, nell'assenza del preventivo mandato (in ragione della futura ripartizione e
87 Ex plurimis, Cass., 10 luglio 2007, n. 35682, in CED Cass., n. 237776.88 Cass., 1 marzo 2007, n. 37078, in CED Cass., n. 237274.89 Cass., 3 giugno 2003, n. 28318, in CED Cass., n. 225684.90 Cass., 4 luglio 2006, n. 31443, in CED Cass., n. 235213.
25
destinazione all'esclusivo uso personale), più persone decidano, concordemente e
unitariamente, di consumare droga, già detenuta da uno di loro. In tale evenienza,
infatti, non si concretizza affatto la previsione di “uso non esclusivamente
personale”, e, quindi, il comportamento del detentore risulta ora penalmente
sanzionabile, trattandosi di due situazioni diverse e non omologabili, per la difforme
potenziale lesività delle condotte, nelle quali il cedente è ab origine in posizione di
estraneità rispetto agli altri consumatori, i quali, pertanto, non possono in alcun modo
essere considerati come codetentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto (da
cui essi sono rimasti estranei91) con evidente necessaria amplificazione ed
aggravamento della negativa realtà del fenomeno dell'uso di sostanze droganti.
Occorre sottolineare che nel diritto pretorio, anche precedentemente al recente
arresto della sesta sezione della Suprema Corte, vi erano già state delle pronunce che
avevano ritenuto l'uso di gruppo solo amministrativamente rilevante. In questo senso
si era espresso il Tribunale di Milano (sezione Giudice per le indagini preliminari)
che aveva sottolineato che la novella legislativa del 2006, pur mossa dall'evidente
ratio di non lasciare impunita alcuna condotta di manipolazione di stupefacente
estranea all'utilizzo personale da parte del detentore, non poteva essere forzata al
punto di attrarre nel suo alveo anche l'acquisto di gruppo, inteso quale
approvvigionamento concorsuale da parte di più consumatori che, pagando ciascuno
la propria parte, abbiano come unico scopo quello di accedere alla quota di rispettiva
spettanza a fini di utilizzo personale92.
Dopo aver evidenziato l'attuale contrasto giurisprudenziale tra la seconda e la sesta
sezione della Corte di Cassazione (che, in tutta probabilità, per la sua radicalità,
meriterebbe di essere risolto dalle Sezioni Unite), occorre da ultimo rilevare come sia
stata prospettata, da parte della dottrina93, una soluzione intermedia rispetto ai due
orientamenti antitetici della seconda e della sesta sezione della Corte di legittimità.
91 Cfr. in termini, Cass., 4 giugno 1999, n. 9075, in Giust. pen., 2000, 235.92 Trib. Milano, sezione G.I.P., 29 aprile 2010, n. 48229, consultabile al sito www.osservatoriopenale.it. Il Giudice per le indagini preliminari evidenziava che “non è dato intravedere, sotto il profilo del disvalore e del senso dell'incriminazione, quale differenza corra fra la situazione sostanziale uniformemente rappresentata da tutti gli indagati, creazione di un fondo comune in danaro, formato da 4 parti identiche, ed acquisto congiunto di un quantitativo di eroina da suddividere in quattro parti parimenti identiche, e quella tipicamente scriminata, e rilevante solo in via amministrativa, del tossicodipendente che paga la propria dose e poi la consuma”. 93 AMATO, L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, cit., 68.
26
Questo orientamento ermeneutico propone una soluzione compromissoria che
distingue le due diverse situazioni di interesse (“acquisto in comune” e “mandato ad
acquistare”). Il filone dottrinario suddetto sottolinea che il contrasto interpretativo
non può essere risolto limitando l'attenzione unicamente al significato
dell'espressione “uso esclusivamente personale” (che, si evidenzia, può prestarsi a
dubbi perché i lavori preparatori non spiegano il definitivo utilizzo dell'espressione
“uso personale”, al posto dell'espressione “uso individuale”, che durante i diversi
passaggi parlamentari aveva qualificato il dato normativo). Alla luce di detta
espressione, possono infatti ammettersi entrambe le interpretazioni: quella che in tal
modo sarebbe consentito anche l'uso personale “collettivo” e quella che tale uso
sarebbe invece vietato perché la modifica è solo frutto di un lifting formale94.
Questo orientamento ermeneutico ritiene che, dopo la riforma del 2006, debba
ritenersi penalmente rilevante l'“uso di gruppo” quando questo si caratterizzi nella
forma del cosiddetto “mandato ad acquistare”. Si sottolinea infatti che trattasi, a ben
vedere, della condotta del “procurare ad altri”, espressamente prevista e sanzionata
penalmente nell'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. Questi Autori sostengono che
tale condotta non sia meno pericolosa delle altre sanzionate dallo stesso art. 73, “ove
si consideri che anch'essa finisce con il realizzare un'illecita diffusione (a terzi) della
sostanza stupefacente non foss'altro perché, ove non vi sia chi si assuma l'incarico di
procurare la droga, gli altri appartenenti al gruppo non ne potrebbero ottenere la
disponibilità e/o, comunque, per soddisfare il proprio bisogno personale, dovrebbero
organizzarsi diversamente (accettando, ad esempio, il rischio di un acquisto
effettuato in prima persona). Del resto, si evidenzia, che l'intenzione del legislatore
del 2006 sia stata quella di sanzionare penalmente tutte le condotte che si risolvono
nella destinazione “ad altri” della droga non può essere messo in discussione,
leggendo con attenzione i lavori preparatori95.
Si ritiene invece che una diversa soluzione debba essere adottata per l'“uso di
gruppo” caratterizzato dall'acquisto in comune della droga da parte degli assuntori
(che, invece, la Suprema Corte nella sentenza 8366/2011 non ha trattato). In questa
seconda ipotesi, si sottolinea, si è in presenza di una condotta che non realizza
94 AMATO, L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, cit., 70.95 Consultabili al sito www.camera.it/parlam/leggi/06049l.htm.
27
un'indebita diffusione della sostanza stupefacente da chi materialmente acquista la
droga a chi si limita ad assumerla, giacché all'operazione procedono congiuntamente
tutti i soggetti. La soluzione, anche in questo secondo caso, non può essere ricavata
fissandosi esclusivamente sull'espressione “uso non esclusivamente personale”, per
le apprezzate ambiguità interpretative. Occorre, infatti, valutare la peculiarità di
questa seconda fattispecie in cui non vi è un'indebita diffusione della sostanza a
soggetti diversi da chi l'abbia acquistata (come nel mandato ad acquistare), poiché
tutti i componenti del gruppo intervengono all'atto dell'acquisto, contribuendo pro
quota all'acquisizione della porzione di sostanza da riservare al proprio fabbisogno
personale, pur in vista di una progettata assunzione in comune96.
Trattasi di una situazione che, del resto, ponendosi nella prospettiva del singolo
compartecipe all'acquisto, non è diversa da quella che si verificherebbe laddove
questi si inducesse all'acquisto “da solo”. Questa empirica considerazione consente di
ricondurre la condotta de qua nell'ambito del penalmente irrilevante, senza dover
ricorrere anche stavolta a delicate letture interpretative del significato
dell'espressione “uso non esclusivamente personale”, si da farvi rientrare anche l'uso
personale (anche) di persone diverse, ergo anche l'uso personale collettivo97.
Per addivenire alla soluzione ammissiva della rilevanza solo amministrativa
dell'“acquisto in comune” occorre valorizzare il proprium dell'illecito penale, che è
stato costruito, dal legislatore del 2006, sulla destinazione a terzi della sostanza
stupefacente: le condotte non chiaramente dimostrative di tale destinazione (quelle di
importazione, esportazione, ricezione e, soprattutto, acquisto e detenzione), sono
sanzionate dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a), del D.P.R. 309/1990 solo se qualificate
dalla positiva dimostrazione di tale illecita destinazione. Si può allora pervenire ad
un'interpretazione che, valorizzando il profilo della destinazione della sostanza,
conduca a ricondurre nell'ambito del rilevante solo amministrativamente quelle
condotte di acquisto che, pur collettivamente realizzate, siano inequivocabilmente
dimostrative solo di un'assunzione “personale” del singolo acquirente, il quale, a
bene vedere, con la propria condotta si limita ad acquistare pro quota unicamente la
96 AMATO, L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, cit., 72.97 AMATO, L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, cit., 72.
28
sostanza destinata al proprio fabbisogno, pur se in ipotesi da consumare insieme ad
altri, senza in tal modo contribuire alla diffusione a terzi della sostanza.
In sintesi l'orientamento dottrinario richiamato, diversamente dalla recente pronuncia
del Giudice della legittimità, ritiene che rimanga pacifica la rilevanza penale del
mandato ad acquistare, laddove, anche in presenza di un contributo economico
anticipato di tutti i mandanti, la condotta del mandatario si risolve comunque nel
“procurare ad altri” la droga: ergo integra una condotta oggettivamente favorente
quella diffusione della droga che il legislatore vuole chiaramente prevenire e
reprimere.
Questi Autori ritengono infine che, in linea invece con le conclusioni raggiunte dalla
Suprema Corte, rimanga pacifica, a fortiori, la rilevanza penale della condotta di
consumo di gruppo nell'ipotesi in cui, in assenza addirittura del preventivo mandato,
più persone decidano, concordemente e unitariamente, di consumare droga, già
detenuta da uno di loro.
29