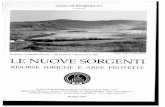Seasonal physiological responses of Argania spinosa tree from Mediterranean to semi-arid climate
A. Spinosa, La “nuova” litoranea Sperlonga – Gaeta: un paesaggio da salvare, in Roberto Pane...
Transcript of A. Spinosa, La “nuova” litoranea Sperlonga – Gaeta: un paesaggio da salvare, in Roberto Pane...
Roberto Pane tra storia e restauro
Architettura, città, paesaggio
Marsilio
a cura diStella Casiello
Andrea PaneValentina Russo
roberto pane tra storia e restauroarchitettura, città, paesaggio
Atti del Convegno Nazionale di Studi
Università degli Studi di Napoli Federico iiCentro Congressi 27-28 ottobre 2008
con il contributo di
Università degli Studi di Napoli Federico ii
Dipartimento di Storia dell’Architetturae Restauro
Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei beni architettonici
Scuola di Specializzazione in BeniArchitettonici e del Paesaggio
Istituto Banco di Napoli-Fondazione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per il paesaggio, le bellearti, l’architettura e l’arte contemporanee
Soprintendenza per i Beni ArchitettoniciPaesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia
Comitato scientificoStella Casiello (coordinamento)Aldo AvetaRenato De FuscoLeonardo Di MauroGiuseppe FiengoBenedetto GravagnuoloFabio MangoneGiulio PaneRenata Picone
Segreteria scientificaFrancesco DeliziaGianluigi de MartinoAndrea PaneGiuseppina PuglianoValentina Russo
I curatori del volume esprimono un particolare ringraziamento al professoreGiulio Pane che, con generosadisponibilità, ha favorito la consultazionedell’archivio paterno per l’approfondimentodi temi trattati in più saggi pubblicati nei presenti Atti e, con partecipazione, ha seguito la preparazione editoriale di questi ultimi.Un sentito ringraziamento va, inoltre, al personale amministrativo delDipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Napoli Federico ii per la fattivacollaborazione prestata nell’organizzazionedel Convegno e per la pubblicazione degli Atti.
A circa venti anni dalla scomparsa di Roberto Pane e dalla pubblicazione di una raccolta di suoi saggi è sembrato doveroso rendere omag-gio, con un Convegno di cui qui si pubblicano gli Atti, a un Maestro che ci ha insegnato che «la cultura non può difendere e conservarela propria autenticità se non affermando una sua politica; e che questa politica non può essere quella del potere, poiché le spetta il com-pito – e insieme il coraggio – di essere critica, intransigente ed autonoma da qualsiasi potere» (R.P., Introduzione, in Id., Attualità e dia-lettica del restauro, antologia a cura di M. Civita, Chieti 1987, p. 7).A me sembra che questo volume possa rappresentare la testimonianza del rispetto di tale autenticità; infatti, i numerosi contributi pre-senti hanno voluto fornire non solo l’aggiornamento della lettura delle opere di Roberto Pane, ma, anche attraverso il cammino dell’in-terdisciplinarità intesa «come colloquio a confronto delle diverse conoscenze», leggere il suo pensiero sotto diverse angolazioni per trarneun possibile indirizzo di azione futura.La suddivisione del Convegno in tre sessioni – Architettura, Città, Paesaggio – non è stata una strumentale ripartizione ma, piuttosto,ha inteso riproporre gli aspetti di una personalità che non ha mai separato questi tre argomenti tra di loro, riferendoli sempre a una visio-ne unitaria e soprattutto non contraddittoria. Al tempo stesso, come anche il titolo del Convegno dimostra, i lavori e la pubblicazionedelle relazioni tenute a Napoli il 27 e 28 ottobre 2008 hanno messo in evidenza l’intreccio indissolubile esistente tra il fare storia dell’ar-chitettura e restaurare; un intreccio che, come è noto, Roberto Pane ha tenuto costantemente ben saldo nel proprio percorso culturaleaffrontando, sempre in modo speculare, ogni riflessione teorica e storico-critica anche in funzione di un impegno sul campo.Nel volume si ritrovano riflessioni, condotte da studiosi appartenenti a più generazioni, su temi fondativi nel pensiero di Roberto Panema anche su questioni finora meno esplorate e pur meritevoli di ulteriori approfondimenti. In particolare, emergono le affinità ma anchele distanze dal magistero di Croce, con il quale Pane ebbe lunga dimestichezza, così come accadde con tante altre personalità che con luicondivisero una stagione culturale molto intensa, anche animata dallo spirito della ricostruzione postbellica. Si sottolinea in alcuni sag-gi come, in campo storico-critico, egli abbia perseguito una strada distinta sia dalla prevalente impostazione giovannoniana sia dall’al-ternativa posta da Adolfo Venturi, specificatamente nel mettere in luce il rapporto tra documento e opera d’arte. Emerge, al presente,come nel campo proprio del restauro Pane abbia individuato una forma poco praticata, ma necessaria soprattutto in tempi difficili, chesi potrebbe definire quella della pietas nei confronti dell’opera oggetto d’intervento. Analogamente, attraverso più scritti si chiarisce ulteriormente come, mediante le sue profonde e anticipatrici riflessioni, si sia pervenuti connovità e difficoltà all’importante estensione della tutela ai valori ambientali, oggi sfociata nella generale e conclamata – quanto poco prati-cata – questione del paesaggio. Uno degli argomenti al centro dell’attenzione di Roberto Pane, approfondito in più saggi presenti nel volume,è costituito, com’è noto, dalla problematica dei centri storici, che lo studioso ha individuato secondo una lettura articolata e complessa e cheha costituito l’oggetto, tra l’altro, di una specifica applicazione per il centro antico di Napoli. In tal senso, uno degli interrogativi più vivi èalimentato proprio dal confronto tra tali elaborazioni, le successive normative urbanistiche e i possibili sviluppi futuri. Sia queste che le altreargomentazioni coinvolgono con evidenza il ruolo assunto dalla Facoltà di Architettura ieri e oggi e il rapporto con le moderne poetichearchitettoniche. Si tratta di questioni sul cui sfondo vi è sempre stata una viva dialettica, come anche si comprende da alcuni saggi che si pub-blicano; non privo d’interesse, a tal proposito, potrà essere il necessario argomentare, ancora, in merito ai conclamati (e vituperati) valoriambientali, la cui definizione metodologica e programmatica attende tuttora un’applicazione puntuale e generalmente sentita e condivisa.In parallelo alle tematiche sopra delineate, alcuni saggi del volume si riferiscono a un settore, ancora poco esplorato, relativo alla attività pro-gettuale di Roberto Pane, non solo riferita ai pochi e noti episodi maggiori, ma soprattutto all’articolazione sensibile di alcune realizzazioniper l’INA-Casa, molto vicine a quel senso ambientale e umano del quale Pane si è fatto a lungo promotore attraverso scritti e convegni.Dai saggi contenuti nel volume emerge come i numerosi relatori del Convegno – docenti di chiara fama e giovani studiosi – abbiano sta-bilito una dialettica con i più remoti saggi di Roberto Pane e con quanto già pubblicato in merito alla sua riflessione, apportando ulte-riori e diverse interpretazioni; tutto ciò allo scopo di cogliere quanto, del lavoro profuso dal Maestro, possa oggi essere ancora oggetto dicontinuità e di estensione, sia pure problematica.
stella casiello
in copertinaCostiera amalfitana, la marina di Furorenegli anni ottanta del secolo scorso (foto R. Pane)
cura redazionale e impaginazionein.pagina s.r.l., Mestre-Venezia
© 2010 by Marsilio Editori® s.p.a. in VeneziaPrima edizione: luglio 2010
isbn 978-88-317-0633
www.marsilioeditori.it
Guido Trombetti, rettoredell’Università degli Studi di NapoliFederico ii
Roberto Cecchi, Ministero per i Benie le Attività culturali, direttoregenerale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici
apertura dei lavori
Benedetto Gravagnuolo, preside della Facoltà di ArchitetturaL’Umanesimo reinterpretato al di là dei confini storiografici
Claudio Claudi de Saint Mihiel,preside eletto della Facoltà di ArchitetturaRoberto Pane tra cultura della sostenibilità e cultura materiale
architettura
Stella CasielloL’eredità culturale di Roberto Pane:riflessioni e considerazioni
Amedeo BelliniGiudizio critico e operatività nel pensiero di Roberto Pane
Giovanni CarbonaraRoberto Pane, Cesare Brandi e il “restauro critico”
Renato De FuscoStoriografia e restauro sui generisdi Roberto Pane
Giuseppe Rocchi Coopmans de YoldiIl tempo di Roberto Pane
3
4
6
9
12
17
22
28
31
Aldo TrioneLa ragion poetica in Roberto Pane
Cettina LenzaPoesia e letteratura architettonica
Anna Lucia Maramotti PolitiFu abbandono o solo approfondimento?Croce e Pane un legame profondo
Francesco Paolo FioreRoberto Pane e il Rinascimentonell’Italia meridionale
Francesca PassalacquaRinascimento meridionale: ricercastorica e cultura architettonicanell’opera di Roberto Pane
Lucio SantoroL’architettura difensiva del Napoletanodurante il regno aragonese e il viceregnospagnolo (secoli XV-XVI)
Adriano Ghisetti GiavarinaPalladio e i valori ambientali del Veneto
Alberto GrimoldiL’architettura dell’età barocca in Napoli e gli studi sul baroccoitaliano dal tardo Ottocento alla prima metà del Novecento
Paolo Mascilli MiglioriniRoberto Pane studioso di GiambattistaPiranesi
Gregorio E. RubinoNapoli e i “Cavalli di bronzo”,riflessioni sulle due culture
Maria Antonietta CrippaPane, interprete d’eccezione di AntoniGaudí
33
36
42
48
52
59
65
69
77
80
86
Alessandra MuntoniRoberto Pane e Bruno Zevi studiosi di Gaudí: due metodi storiografici a confronto
Carlos Alberto CacciavillaniRoberto Pane, l’architettura di Gaudí e la escuela gaudiniana
Rosalba Ientile«Estática y estética»: Roberto Panecommenta Gaudí
Piero PierottiGaudí didascalico
Riccardo de MartinoLe architetture di Roberto Pane
Saverio CarilloL’aula basilicale di Roberto Pane alla Mostra d’Oltremare
Alessandro CastagnaroRoberto Pane architetto alla Mostrad’Oltremare
Marco Dezzi BardeschiCura dell’antico e qualità del nuovo.La crociata di Roberto Pane per il rinnovamento della cultura del restauro in Italia
Luigi GuerrieroPer una teoria critica del restauro: note su Roberto Pane
Claudio VaragnoliGiovannoni nella casa natale di Croce;con alcune riflessioni sull’eredità di Roberto Pane
B. Paolo TorselloIl restauro e la memoria dell’abitare
92
98
102
108
111
117
125
131
136
138
142
Indice
VII
Lucina NapoleoneChe cosa conservare? L’oggetto del restauro, tra opera d’arte,monumento, bene culturale, ambiente
Bianca Gioia MarinoLuoghi esterni, immagini interne:attualità del percorso della conservazionedell’architettura in Roberto Pane
Caterina GiannattasioLo spazio esistenziale e l’istanzapsicologica: attualità del pensiero di Roberto Pane
Valentina RussoTra cultura archeologica e restaurodell’antico. Il contributo di RobertoPane nella prima metà del Novecento
Franco TomaselliRoberto Pane e Franco Minissi:accostamento del nuovo all’anticonell’ambito del restauro archeologico
Emanuele RomeoRoberto Pane e il restauro archeologico:alcune riflessioni
Stefano GizziRoberto Pane e il problema delmantenimento delle aggiunte. Il casosardo di San Gavino a Porto Torres
Ferruccio Canali«Ricomporre» il monumento: RobertoPane e il restauro del TempioMalatestiano di Rimini (1947-1957).Dalla Commissione ministeriale per il restauro del Tempio Malatestianodi Rimini alle riflessioni sul «Restaurodi necessità» per una nuova Teoria del Restauro
Antonella CangelosiRoberto Pane al Congresso di Storiadell’architettura del 1950 a Palermo e il dibattito contemporaneo sul restauro
Maria Rosaria Vitale, Giuseppe ScaturroIl VII Congresso di Storiadell’architettura a Palermo (1950). Il contributo di Roberto Pane e l’attività di tutela e restauro in Sicilia
Zaira Barone, Carmen GenoveseRoberto Pane e il tema dellareintegrazione nel dopoguerra. Spuntidi approfondimento su alcuni casisiciliani
Rosario ScadutoL’impegno di Roberto Pane per lavalorizzazione, tutela e conservazionedelle ville vesuviane del Settecento
145
149
154
159
170
178
188
196
204
210
222
230
Gianluca VitaglianoConoscenza e conservazionedell’architettura rurale in Terra di Lavoro. Il contributo di Roberto Pane
Francesco DeliziaRoberto Pane e la vicenda del maschiodel castello d’Ischia
Gianluigi de MartinoArt. 33. «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». RobertoPane e l’autonomia culturaledell’Università
Chiara OccelliContinuità della cultura nel progetto di architettura
Rossella de Cadilhac, Lucia SerafiniLa continuità di una scuola: da Roberto Pane a Mauro Civita
Marida SalvatoriNote sulla tutela dell’antico in RobertoPane
Emanuele MorezziRoberto Pane e l’istanza psicologica:sviluppi di un concetto nel caso-studiodi Hiroshima
Manuela MattoneLe costruzioni in terra cruda:«letteratura architettonica» da conservare e valorizzare
città
Aldo AvetaRoberto Pane e l’urbanistica dei centriantichi
Vittorio Franchetti PardoIl progetto urbano e la storia
Gianfranco SpagnesiCentri storici e trasformazioni urbane:metamorfosi di un concetto
Arnaldo VendittiArchitettura e valori ambientali
Guido ZucconiPane e la nozione di ambiente, tra primo e secondo Novecento
Renata PiconeCapri, mura e volte. Il valore coraledegli ambienti antichi nella riflessionedi Roberto Pane
Corrado BeguinotUn brano di storia di Roberto Pane.Aprile 1949-ottobre 2008
238
245
252
256
261
272
277
283
288
294
300
304
308
312
320
Francesco ForteRoberto Pane, la sfida urbanistica
Guido D’AngeloRoberto Pane e la ragionevole tutela dei beni culturali
Luigi Fusco GirardGiudizio critico, sapere professionale,sapere civile
Maurizio De VitaL’antico e nuovo di Roberto Pane: un insegnamento senza tempo per il progetto di Restauro
Calogero BellancaRoberto Pane e le vicende dellaricostruzione postbellica nell’Europacentrale
Andrea PaneRoberto Pane e gli Stati Uniti:immagini, riflessioni, influenze. Dal viaggio del 1953 alle lezioni di Berkeley del 1962
Serena PesentiLa declinazione del concetto di “attualità urbanistica del monumentoe dell’ambiente antico” in ambitomilanese: identità e differenze con il pensiero di Roberto Pane
Carolina Di BiaseRoberto Pane ed Ernesto Nathan Rogers:dibattito sugli inserimenti nellepreesistenze ambientali
Maria Grazia VinardiRicostruzioni e restauri della città:“antico e nuovo” tema di un dibattito
Michela Benente“Antico e nuovo” nel secondodopoguerra a Torino
Riccardo Dalla Negra, Rita Fabbri,Keoma Ambrogio, Veronica Balboni,Annalisa Conforti, Luca Rocchi“Ferrara, antico e moderno”: a cinquant’anni dal convegnosull’edilizia artistica ferrarese, alcuneriflessioni in merito al dibattito traRoberto Pane e i suoi contemporanei
Gianluca BelliMonumenti, centri storici e distruzionibelliche. L’elaborazione critica di Roberto Pane nel caso di Firenze
Emanuela VassalloRoberto Pane e la ricostruzione dellacittà storica nel secondo dopoguerra a Napoli: riflessioni sulla dimensioneurbanistica del restauro
322
327
331
333
337
346
358
364
370
377
383
389
393
VIII
Sergio VillariGuerre aux bâtisseurs. La polemica di Roberto Pane contro la speculazioneedilizia negli annidell’amministrazione laurina
Alfredo BuccaroMetodologie di indagine sulla cittàstorica: una testimonianza di continuità della scuola napoletana
Luigi RondinellaNuovi dati per la sistemazionepostbellica dell’ insula di Santa Chiarain Napoli
Pasquale Rossi«Antico e contemporaneo» nel centrostorico di Napoli. L’immagine di Castelnuovo e il “progetto” di unospazio urbano dall’Ottocento ad oggi
Rosario Paone, Carmine MegnaIl colore delle città nel pensiero e nelleopere di Roberto Pane con riferimential caso di Napoli. Storia, attualità e prospettive
Renata PresciaRoberto Pane e la culturaarchitettonica e urbana siciliana degli anni cinquanta
Cinzia AccettaAntico e Nuovo: Palermo, l’architetturamoderna e la speculazione edilizia
Alessandra AlagnaArchitettura moderna nei contestiantichi come interpretazionedell’“istanza psicologica”. Il caso del centro storico di Naro come“museo fuori dal museo” nel progetto di restauro di Franco Minissi
paesaggio
Giuseppe FiengoL’opera di Roberto Pane in difesa della natura e dei valori ambientali
Paolo FancelliPaesaggi perduti
Maurizio BorianiRoberto Pane e il paesaggio:«architettura rustica», «coralità»,«stratificazione storica», «ecologiaumana»
Stefano F. MussoArchitettura rurale e paesaggio, a venti anni da Roberto Pane: tra «rudimentale necessità» ed «equivoci della cultura»
398
403
405
412
420
426
430
436
446
451
456
462
Lionella ScazzosiRoberto Pane e il paesaggio: attualitàdel pensiero
Giuseppina PuglianoL’istanza ecologica nel pensiero di Roberto Pane
Francesco StaraceRoberto Pane. Dalle ville Poggioreale e Duchesca ai giardini cinesi
Luigi ZangheriI giardini e il paesaggio cinese di Roberto Pane
Maria Adriana Giusti«Una strada come opera d’arte».Visioni, montaggi, valori di paesaggionella ricerca di Roberto Pane
Salvatore Di LielloRoberto Pane e Procida
Arianna SpinosaLa “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”:un paesaggio da salvare
Rossano AstaritaRoberto Pane e Sorrento e la costa
Luigi D’OrtaIl progetto di PRG per Sorrento di Roberto Pane (1946-1963)
Alessandro Dal PiazL’esperienza innovativa del pianoterritoriale e paesistico dell’areasorrentino-amalfitana 1974-1977
Ignazio CarabelleseValori dell’architettura e dell’ambientepugliese. Alcune immagini inedite di Roberto Pane
Maria Raffaela Pessolano«Natura de’ siti» ed esigenze della guerra.Temi per la lettura del territorio storico
Ugo CarughiLe scale dimensionali della tutela. Da Roberto Pane al “Codice Urbani”
Claudia AvetaLa tutela dell’ambiente: la riflessione di Roberto Pane e gli attualiorientamenti legislativi
Alessia BelloneRoberto Pane e la conservazione del paesaggio: frammenti e memoriadel territorio di Venaria Reale
465
470
478
487
490
498
505
513
517
523
526
534
540
547
552
tavola rotonda
Benedetto GravagnuoloIntroduzione
Giuseppe Cruciani FabozziRoberto Pane, profeta disarmato
Leonardo Di MauroLa mia Napoli imprevista attraversoRoberto Pane
Nicola PagliaraPer Roberto Pane
Aldo Loris RossiDal paradigma meccanicista alla città ecologica
Giulio PaneAttualità di Roberto Pane
testimonianze
Arnaldo BruschiUn ricordo
Mario ColettaScienza e coscienza nell’insegnamentodi Roberto Pane
Gianni MezzanotteRoberto Pane a «Casabella»
Mimma Pasculli FerraraIl paesaggio urbano: un bene da tutelare
Maria Luisa ScalviniRoberto Pane, in memoriam
Nicola SpinosaL’«Evviva» di Roberto Pane, per il patrimonio artistico e perché non vada tutto in degrado
Bibliografia degli scritti di Roberto Panea cura di Giulio e Andrea Pane
Bibliografia degli scritti su Roberto Panea cura di Andrea Pane
558
559
561
563
564
566
570
571
573
575
577
578
580
599
VIII IX
504 505
Di particolare valenza paesaggistico-culturale è lo scenario che sulfinire degli anni cinquanta del secolo scorso si apriva dinanzi a co -loro che percorrevano in auto per la prima volta la Flacca, la stradacostiera denominata “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”: un’operadi ingegneria delle infrastrutture che ha segnato le sorti e le vicen-de urbanistiche di uno dei tratti più belli della costa laziale. Nel 1958, in occasione dell’inaugurazione della nuova arteria stra -da le, che prendeva il nome dalla più antica strada romana1, Ro -berto Pane interviene sull’argomento dalle pagine di «Le vie d’Ita-lia», nella rubrica Paesaggi da salvare2, commentando con pa rolemolto dure la realizzazione della nuova infrastruttura. Questa erastata accolta con molto slancio sia dalle amministrazioni lo caliche ne erano coinvolte, tra cui il Comune di Gaeta, promotoredel progetto, sia dalla comunità scientifica, soprattutto per la ri -conosciuta qualità delle opere – l’insieme dei viadotti, gallerie eponti – che ne componevano l’ossatura portante. Progettata dal-l’ingegnere Gastone Maresca e finanziata dall’appena nata Cassaper il Mezzogiorno3, allora presieduta dal ministro Pietro Campil-li, l’imponente opera, già nelle vesti del Progetto preliminare dellaStrada litoranea Terracina-Sperlonga-Gaeta, si presentava innanzi-tutto come un’«eccezionale attrattiva turistica», volano della ri -pre sa economica e sociale dell’intero comprensorio4. Per comprendere appieno le vicende su cui si fondano in partico-lare le note critiche di Roberto Pane ripercorriamo, brevemente, imomenti principali che hanno caratterizzato la costruzione dellaFlacca.Il progetto nasceva innanzitutto dall’esigenza da parte dei comu-ni sopracitati di potenziare i collegamenti tra di loro e per tutto iltratto costiero, quindi della parte bassa della giovane Provincia diLatina5, all’interno del più ampio ripensamento della viabilità in -terregionale tra Roma e Napoli6. A questo si aggiungeva il deside-rio di liberare Gaeta dal secolare isolamento7, prigioniera dellamemoria del suo glorioso passato, causa anche di una condizioneeconomica da troppo tempo stagnante8. Il territorio, secondo ilnuovo progetto, si sarebbe andato a dotare dunque di un doppiosi stema di collegamento longitudinale. Il tracciato della nuovaFlacca, infatti, si presentava come alternativa alla già esistenteAppia, la quale però non toccava i comuni costieri di Gaeta e diSperlonga. Ambedue le strade poi, in prossimità di Latina, sem-pre secondo il progetto preliminare, si andavano a connettere conle infrastrutture risalenti alla bonifica delle paludi pontine di epo-ca fascista e da qui verso Roma.
La proposta così formulata e presentata dalle amministrazioni co -munali all’ente provinciale si colloca sullo sfondo di un generaleclima di ripresa economica e sociale del paese intero, di cui le in -frastrutture diventano segno tangibile, intese come produttriciveloci di progresso e di economia9. Il progetto veniva affidato auna delle personalità più importanti del tempo nel campo dell’in -gegneria stradale, il professore Gastone Maresca, inizialmentechiamato dal Comune di Gaeta10 per il ripristino della ferrovia,danneggiata durante l’avanzata degli Alleati, e per delineare in viapreliminare le varianti al piano di ricostruzione11, già obsoleto enon rispondente alle esigenze di espansione urbana della città. Maresca riesce tuttavia a strutturare il progetto, già nella sua faseiniziale, secondo delle vere e proprie linee guida che verranno ri -spettate anche dopo la sua prematura scomparsa, alla quale succe-derà il collaboratore più stretto, l’ingegnere Erno Bellante. Nono-stante la giovane età, l’ingegnere Gastone Maresca, prima assi-stente e poi professore alla cattedra di Costruzioni stradali e ferro-viarie all’Università di Roma “La Sapienza”12, vantava un ap pro -fon dimento degli studi in Europa, e conosceva le esperienze piùaggiornate dei parkways negli Stati Uniti, fondati sul principiodell’insieme strada-parco-panorama. Esperienze che in fluen ze -ran no moltissimo l’idea attuata nella nuova strada13, in cui vi ri -troviamo i tratti di un approccio alla progettazione delle in fra -strutture secondo i più moderni criteri estetico-culturali. Di lui ilpiù vicino collaboratore, Bellante, nell’impresa della costruzionedella Flacca, dirà: «Gastone Maresca ha riunito scienza e tecnica,insegnamento e progettazione nell’armonica fusione dell’uomodi genio»14; ancora Piero Grassini, capo del Servizio viabilità eopere pubbliche, nel 1955, in merito alla persona di Maresca, af -fermava: «[...] quest’opera rimane per i tecnici italiani comevivente testimonianza delle alte doti d’intelletto e di cuore delcompianto professore Gastone Maresca, della sua entusiasta sen-sibilità artistica, della sua profonda tecnica»15.Fin dal principio il progettista, accogliendo le criticità dei collega-menti infrastrutturali che la provincia da tempo lamentava, dàconcretezza a quella che fino ad allora era considerata solo unaremota alternativa, alquanto radicale, per un nuovo sistema stra-dale a servizio di tutta la riviera che correva da Terracina a Gaeta.L’ingegnere, grazie alla sua rinomata fama nel campo delle infra-strutture, era riuscito difatti a convincere, nonostante le numero-se perplessità, i vertici della Cassa per il Mezzogiorno a finanziarel’imponente opera e ad affidargli il progetto esecutivo. Dunque la
Arianna SpinosaLa “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”: un paesaggio da salvare
506
Arianna Spinosa
nuova litoranea, denominata la “panoramica”, nasceva con tuttigli auspici del dopoguerra: nel giro di pochi anni essa diviene ri -flesso di un successo politico da parte delle amministrazioni edegli enti del Mezzogiorno d’Italia. Realizzata in poco più di unde cennio, l’infrastruttura è ricordata come una delle prime operepubbliche attuate dalla Cassa per il Mezzogiorno16, grazie allaconvergenza di eccellenze tecniche, all’interesse degli enti locali eall’impegno di forze politiche. Non si può capire fino in fondo l’importanza che al tempo ebbela costruzione della Flacca senza ricordare che l’Italia, sempre nel1950, aveva sottoscritto la Convenzione di Ginevra, formulata dalGruppo di Lavoro della Strada, istituito dal Consiglio Economi-co e Sociale delle Nazioni Unite: la convenzione forniva nuoviindirizzi per la pianificazione delle infrastrutture a livello nazio-nale e internazionale secondo criteri moderni, anche in termini dicomfort e di sicurezza17. L’Italia si impegnava così con la costru-zione e la rimessa in efficienza di ben 6000 chilometri di infra-strutture e autostrade di nuova concezione secondo gli standardeu ropei. Nonostante tali premesse, tuttavia, già da un bilancio del1957, si evidenziavano le mancanze verso l’accordo internaziona-le18 e la nuova litoranea, appena inaugurata, costituiva l’unica stra-da giudicata come migliore realizzazione italiana, sia sotto il pro-filo paesistico che estetico19: «la più bella strada panoramica d’Eu-ropa», caldeggiava uno slogan del periodo20. Un risultato piena-mente raggiunto, così come al tempo appariva, di una strada ec -cellente dal punto di vista strutturale e concepita in stretta rela-zione con il paesaggio, nel pieno rispetto della conformazionepaesistica dei luoghi che attraversava. Come si è detto il nuovo asse viario prendeva spunto dal preesi-stente tracciato dell’antica via romana, fatta costruire nel ii secoloa.C. dal censore Lucio Valerio Flacco, di cui ancora oggi è possi-bile scorgere cospicue tracce e il cui intero percorso è stato rico-struito da illustri studiosi all’inizio del Novecento21. Questa però,nata probabilmente per servire le numerose ville marittime collo-cate lungo il litorale, soprattutto in prossimità di Sperlonga, neipressi del tratto del Malopasso, si allontanava dalla costa per risa-lire sulle pendici del sistema collinare, proprio per l’asperità deicostoni rocciosi. In questi tratti la progettazione della nuova stra-da compie delle imprese di notevole interesse, mantenendo il co -stante contatto con la costa, superando passi ripidi e frastagliati eattraversando, tramite gallerie, i piccoli promontori che scende-vano fino a mare, così da godere pienamente del magnifico pano-
rama, aprendo di volta in volta la visuale sul litorale.Ritornando alle vicende della costruzione, appena accolta la pro-posta preliminare nel 1951, il progetto generale, così come pensa-to dal Maresca, viene appaltato e ha inizio la costruzione del pri-mo tratto dell’infrastruttura, suddivisa in sei tronchi principali22,ciascuno dei quali presenterà delle proprie peculiarità nello svol-gimento del cantiere, pur non mancando molteplici controversie.Nel complesso i lavori procedono abbastanza velocemente, tantoche già nel 1953 la costruzione del primo tronco – in cui ricadeuno dei due viadotti più importanti, quello che nasce alle pendi-ci del promontorio delle Scissure verso la spiaggia dell’Ariana – èconclusa.Dinanzi alla difficoltà di superare la sinuosità della costa e i nu -merosi problemi tecnici, il progetto dell’ingegnere Maresca ri -spondeva attraverso la progettazione di impegnative opere d’arte,anche nell’attraversamento dei comuni di Gaeta e di Sperlonga,con piccoli espedienti infrastrutturali come raccordi, cavalcavia,ponti, sottovie ferroviarie, che comportarono non solo il ri -pensamento della viabilità interna23 ma condizionarono, nonpoco, le scelte successive in fase di redazione dei piani regolatori.Al professore Maresca, tra l’altro, andava il merito di aver saputoconiugare, nella nuova infrastruttura, un disegno pensato in ter-mini di estetica con l’impiego di tecnologie costruttive e concezio-ni strutturali assolutamente all’avanguardia24.Gli esiti di questi espedienti ingegneristici furono al tempo consi-derati talmente straordinari e avanzati che Bruno Zevi25, nel 1957,accolse nella rivista da lui diretta «L’Architettura», nella rubricaStrutture, un articolo di Erno Bellante26, collaboratore di Maresca,sul progetto e il cantiere di costruzione del viadotto del vallone diBazzano, esemplare dal punto di vista sia strutturale che formale.Si trattava di un impalcato di cemento armato in curva solidale,con due coppie di gambe inclinate che si andavano a innestarenello sperone roccio-sabbioso; una composizione snella e propor-zionata, che provoca ancora oggi un intenso afflato soprattutto aguardarla da sotto il mare e che permise di superare un trattomolto malagevole con curve assai strette, poco più di 20 metri diraggio, pendenze assai forti, in qualche rampa superiori al 10% evisibilità deficiente – così come scrive Erno Bellante27 – e la cuirealizzazione fu possibile solo dopo quella dei tronchi laterali «perfar partire da essi le due bocche di perforazione a livello perfetta-mente noto»28.A rendere ancora più affascinante l’impresa della costruzione del-
1. Grafico descrittivodell’andamento dellanuova litoraneaTerracina-Gaeta-Formia, allegato al Progettopreliminare redattodall’ingegnereGastone Maresca e presentato allaCassa per il Mezzogiorno nel1950 (da La vialitoranea Flacca1958-2008, a cura di P.G. Sottoriva,Latina 2008, p. 53).
2. «La spiaggiadell’Arenauta, biancastriscia di sabbia nelpaesaggio ancoraperfettamentelibero» (foto e didascalia di R. Pane, 1958).
[1.] [2.]
506 507
La “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”: un paesaggio da salvare
[3.] [3a.]
3. Grafici delprogetto dellestrutture relativo allacampata centrale delviadotto pressoSperlonga, architettiGastone Maresca ed Erno Bellante (da «L’architettura»,15, 1957, p. 687).
3a. Grafici delprogetto dellestrutture del Viadottopresso Sperlonga,architetti Gastone Maresca ed ErnoBellante (da «L’architettura»,15, 1957, p. 686).
la Flacca fu, inoltre, la lunga vicenda che seguì i ritrovamentiarcheologici della villa marittima di Tiberio e dell’Antro29, nel-l’estate del 1957 ad opera sempre dell’ingegnere Bellante, ricorda-to anche per la sua passione verso i temi dell’archeologia. Unevento che risuonò sulla stampa nazionale e internazionale e por-tò l’attenzione sui tesori marmorei di Sperlonga – da secoli som-mersi nelle piscine della grotta e oggi conservati nel Museoarcheologico, fortemente voluto dalla cittadinanza nello stessosito30 – di tutta la comunità scientifica del tempo. Questi, ancoraoggi, costituiscono la testimonianza materiale della ricchezza ditali luoghi, non solo dal punto di vista paesaggistico ma anchecome “stratificazioni ambientali” di presenze antiche. L’entusiasmo generale che suscitò la costruzione di un’infrastrut-tura così importante in un’area considerata al margine della reteprovinciale, ma a cavallo delle regioni Lazio e Campania, in real-tà non accolse al tempo alcun parere negativo che rimandasse auna maggiore attenzione verso la tutela del paesaggio31. Dissonante fu la posizione assunta da Roberto Pane: nel brevescritto in questione, l’autore, oltre che decantare le bellezze deiluoghi (grazie anche all’ausilio di ampie foto, da lui stesso scattate,che mostrano semplicemente la naturalità dei siti che la nuovastrada andava a toccare32) in quanto aspetti di quel “paesaggio clas-sico” che, come uno scavo archeologico, veniva scoperto ed espo-sto al grande pubblico e quindi alle condizioni inevitabili di de -gradazione, in prima battuta ammonisce gli amministratori dinon aver adottato nel giusto tempo strumenti per una conservazio-ne attiva del territorio. L’attenzione, in effetti, era tutta rivolta ver-so la costruzione della nuova arteria stradale e le esigenze di tuteladi quelle forme paesistiche che tanto la caratterizzavano furonoposte in secondo piano. Il criterio progettuale seguito, se condo ilquale si andava a privilegiare a tutti costi il contatto della stradacon il «bene ambientale»33, anche se in alcuni tratti si ma nifestavain un’indiscussa commistione tra le bellezze naturali e quelle inge-gneristiche, aprendosi verso inedite prospettive, in al tri punti rive-lò esiti non felici, come nel caso della piana di Sant’Agostino.Quest’ultimo infatti si presentò come uno dei cantieri più contro-versi, anche dal punto di vista tecnico, innanzitutto per la presen-za, non preventivamente controllata, di numerosi residui bellici.In tal caso l’eccessiva vicinanza della strada al mare aveva compor-tato la distruzione e la rettifica delle caratteristiche dune di sabbia,di cui oggi ne rimangono imbarazzanti cenni34; in questi luoghiinfatti la nuova infrastruttura ha compromesso mag giormente la
naturalità del sito, andando a incidere enormemente sull’ecosiste-ma esistente35. Una scelta giustificata da Maresca36, dinanzi alle tan-te polemiche, in primo luogo dalla necessità di superare esigenzedi natura tecnica, per la consistenza, solo in questa fascia, di unsottofondo più stabile per il manto stradale, rispetto a quello più amonte di natura paludosa37. Per la prima volta, grazie all’articolo di Roberto Pane, si poneval’accento sulla questione ambientale. Il litorale laziale diventavaesemplificativo di tutta quella serie di abusi perpetrati a danno delpaesaggio, che lo studioso napoletano nel corso degli anni do -cumenta e richiama all’attenzione della collettività38, nel sostenerela conservazione di quei valori ambientali, parte integrante dellamo derna cultura, intesi innanzitutto come «patrimonio inaliena-bi le della nostra memoria, prima ancora di essere documento dellastoria urbana, oggetto di contemplazione ed obiettivo turistico»39.La descrizione del paesaggio laziale da parte dell’autore si struttu-ra attraverso una serie di appunti visivi di un viaggio durante ilquale, andando da Napoli verso Roma, annota le varietà paesisti-che che di volta in volta incontra, di cui in parte già conosce levicende politico-urbanistiche. A tal proposito la rilettura dell’articolo di Roberto Pane ci con-sente, non solo di richiamare nuovamente l’attualità del suo pen-siero in merito alla questione ambientale40, oggi di particolare va -lenza anche e soprattutto come impegno etico e civile, ma anchedi cogliere, con la giusta distanza storica e senso critico, le trasfor-ma zioni che questi territori in così breve tempo hanno subito,alla luce degli obiettivi perseguiti dai più recenti strumenti di tu -tela. Le parole dell’autore, che rinnovano «l’assoluta inseparabili-tà del problema riguardante il paesaggio vegetale da quello degliinsediamenti urbani»41, ci proiettano in un contesto paesaggisticodi cui oggi se ne conserva solo un remoto ricordo, tanto da consi-derarlo oramai un paesaggio perduto. Questo si presentava minac-ciato nella propria integrità e lanciato verso un’irreparabile mani-polazione per adattamento alle esigenze del turismo di massa,tenendo fede d’altronde agli auspici per cui l’opera era nata42.La descrizione dunque entra nel dettaglio nel momento in cuiPane, incontrando la città di Gaeta, ne coglie gli aspetti anchecontrastanti che la caratterizzano. Ci parla della bellissima spiag-gia di Serapo su cui si affaccia una «folla di case caoticamente am -massate», lontano ricordo di un utopico progetto di città-giardi-no di inizio secolo, quasi completamente distrutta durante la se -conda guerra mondiale43, e il «fumo di due ciminiere» di un ex ve -
508
Arianna Spinosa
treria che ancor oggi versa in stato di totale abbandono, adagiatasulle rive della spiaggia; richiama l’attenzione verso l’incantevolecentro storico medievale, che al tempo appariva del tutto ab -bandonato e lacerato dalle ferite della guerra, ancora non rimargi-nate, in attesa di un congruo strumento di pianificazione. «Unodei centri di maggiore interesse artistico e storico in tutta l’Italiame ridionale», sostiene Roberto Pane, dinanzi alla ricchezza deivalori corali che manifestava44. Da qui si articola la descrizione delpercorso della Flacca, che da Gaeta si snodava fino a Sperlonga,lungo il quale viene attratto da numerosi episodi paesistici che ri -chiamiamo brevemente: dalle insenature della spiaggia dell’Aria-na, di quella dell’Arenauta, dalle torri costiere, poste sui promon-tori che scendono a picco sul mare, come quello di Torre Viola emonte Scissure e altri che in questo tratto si susseguono. La sor-presa che manifesta lungo la piana di Sant’Agostino45 dove, nel ri -trovarsi dinanzi a una realtà di grande valore ambientale che an -cora appariva così selvaggia, egli afferma: «sembra impossibile chenel mondo moderno possa ancora sussistere una tale condizionedi natura inviolata e solenne»46, non soggiogata ai processi di an -tropizzazione contemporanei. Alle presenze naturali si andavanoad accompagnare quelle archeologiche, relative sia all’antica viaFlacca, di cui in alcuni punti si potevano scorgere ancora cospi-cue tracce, che ai numerosi ruderi in opus incertum di ville roma-ne, in alcuni casi utilizzati anche come depositi per usi agricoli:una commistione di valori umani e presenze antiche che Pane ef -ficacemente denomina «perfetta intonazione ambientale»47. Lostorico, dunque, sensibile a cogliere i particolari di una condizio-ne paesaggistica e di una vita rurale che stava per essere violata dai“mezzi moderni”, in una visione romantica dell’ambiente allo sta-to naturale, suggerisce interventi subordinati innanzitutto al sen-so del rispetto e della discrezione. Ancora dinanzi agli occhi di Roberto Pane emergono con parti-colare stupore le timide trasformazioni, che in quel momento sistavano avviando, soprattutto in corrispondenza dei litorali sab-biosi, mutamenti che nel tempo sarebbero diventati prassi comu-ne e specchio di una politica di insediamento priva di logica alcu-na e soggiogata all’abuso, che in questi luoghi ha operato indi-sturbata. Una prassi che ricorre nei siti costieri italiani, tanto chelo stesso autore in una riflessione sulla tutela della costiera amalfi-tana, tema a lui sempre caro, eletta a “paradigma” delle bellezzedella Campania48, sosterrà con fermezza che «l’edilizia realizzatain questi ultimi decenni (e specialmente quella alberghiera, come
più impegnativa in rapporto alla occupazione del suolo, alle con-siderevoli volumetrie, alle vaste opere accessorie richieste dai di -slivelli, dai relativi contenimenti del terreno, dai parcheggi, ecc.)si è dimostrata nettamente contraria a quelle esigenze qualitativeche in nome dei requisiti ambientali occorreva soddisfare»49, benlontana dal «volere una condizione di vita che favorisca l’incontrofra l’antico e il nuovo e quindi una continuità di cultura»50.In ultimo, durante il percorso, brevi cenni sono dedicati alla villadi Tiberio, nonostante l’importanza internazionale che il sito inquel momento stava riscuotendo, di cui Pane rimprovera anzil’ec cessiva attenzione, riservata nel renderlo accessibile, rispettoalla totale noncuranza verso le molteplici altre presenze archeolo-giche al pari importanti. Pane dunque mette in luce e denuncia quegli aspetti di un pae-saggio che senza un’adeguata gestione da parte delle amministra-zioni locali e centrali avrebbero subito un’irreparabile deturpazio-ne. In realtà, giustappunto, preannunzia quello che nel giro dipochi anni sarebbe avvenuto, a partire da una privatizzazione del-la costa, dal lato della litoranea verso il mare, soprattutto per l’in-sediamento di strutture alberghiere invadenti per forma e permasse, e una lottizzazione eccessiva e selvaggia dei terreni con unproliferare di seconde case di dubbia fattezza architettonica.L’articolo qui ricordato, d’altronde, ricade in un momento fonda-mentale per l’autore, in cui sono oramai maturi nella sua riflessio-ne teorica, soprattutto all’interno della disciplina del restauro, itemi afferenti la sfera della nozione di ambiente51. Molte, del resto,sono le battaglie che egli affronterà nel corso degli anni, a partireda una sensibilizzazione del mondo culturale verso la tutela delpaesaggio in senso ampio, auspicando sempre maggiori riflessinel campo normativo e operativo52. Tutto ciò andrà a confluirenelle proposte avanzate nel 1964 a Venezia, recepite nella notaCarta del restauro53. Un’occasione che, grazie al suo fondamentalecontributo, unito a quello di Gazzola, segna definitivamente ilpassaggio dall’idea di monumento, come unico bene da tutelare,all’idea dell’insieme ambientale, così come è già richiamato nelprimo articolo della carta, di cui ne ricordiamo il passo: «La no -zio ne di monumento storico comprende tanto la creazione archi-tettonica isolata quanto l’ambiente urbano o paesistico che costi-tuisce la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzionesignificativa o di un avvenimento storico [...]». Questione dive-nuta centrale degli interessi della vita associata e bene culturale dasalvaguardare e tutelare alla stregua di un bene monumentale, in
4. Il ponte chescavalca Capovento-Malopasso,particolare delle duecoppie di pilastriinclinati che si vanno a innestarenello sperone di roccio-sabbioso(da La via litoraneaFlacca 1958-2008, a cura di P.G.Sottoriva, Latina2008, p. 291).
[4.]
508 509
La “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”: un paesaggio da salvare
quanto in perenne mutamento e non riproducibile, rispetto alquale bisogna porsi in continuità storica. La Carta di Venezia, in realtà, è solo uno dei passaggi fondamenta-li dell’attività multiforme di intellettuale di Roberto Pane54, ca -ratterizzata fin da subito dall’interesse per i valori d’insieme delpaesaggio, anche dal punto di vista ecologico, come testimonia,nel suo piccolo, lo scritto che dedica alla nuova Flacca; solo di po -chi anni prima è il memorabile volume Sorrento e la costa55, in cuiricorrono temi affini e tutti quei nodi cruciali che ruotano intornoal riconoscimento e alla tutela del patrimonio naturale e che nel1958 ritroviamo, anche se appena accennati, su «Le vie d’Italia». Questo momento, inoltre, è caratterizzato da un certo fervore cri-tico, dovuto innanzitutto a un primo bilancio sugli esiti delleesperienze del dopoguerra e della pressione edilizia, causa dei pri-mi scempi ambientali, a danno non solo dei vecchi centri urbanima anche del paesaggio. In seguito si scatenarono le prime rifles-sioni sul ruolo della tutela di tipo vincolistico e repressivo rispet-to a quella di tipo governativo, fortemente voluta da RobertoPane, di un territorio che in ogni modo si manifestava in accele-rata trasformazione. Saranno sempre più numerose le denunce daparte dell’opinione pubblica e anche in questo caso l’accoratoappello di Pane verrà ripreso nel 1960 da Cesare Brandi che, dallepagine del «Corriere della Sera», farà sentire la sua voce con l’arti-colo Difendere la solitudine della Flacca56. L’articolo di Brandi inrealtà ha un sapore ancora più amaro poiché denuncia un proces-so di urbanizzazione dei luoghi della parte bassa della costa lazia-le già irreversibile: «è questo il tratto che bisogna salvare ad ognicosto», riferendosi a quello tra Sperlonga e Gaeta, alla luce delledifficoltà che il piano paesistico stava incontrando, soprattutto daparte dei privati e dei Comuni che ostacolavano una drastica tu -tela del litorale. L’attenzione di Cesare Brandi verso questo sito èmolteplice: innanzitutto il sempre maggior interesse attorno aquella che sarebbe divenuta a breve una delle più importanti sta-zioni archeologiche, con le notevoli rivelazioni dei gruppi sculto-rei sperlongani e la questione relativa alla conservazione in situdelle opere rinvenute e poi verso le vicende più propriamente ditipo urbanistico, circa l’approvazione del piano territoriale paesi-stico, che stentava a decollare, nonostante l’urgenza di porre unfreno alle trasformazioni del territorio, governato da interessi spe-culativi. In ultimo Brandi, con spirito fortemente critico, lamen-tava una limitata azione di controllo da parte degli enti preposti ela mancanza di un costante e continuativo monitoraggio dei luo-ghi da parte della Soprintendenza regionale. Come accennato in precedenza, già verso la fine degli anni cin-quanta, Roberto Pane è un tenace sostenitore del concetto chenon può esistere alcuna tutela, soprattutto in materia ambientale,«se non in stretta coerenza con una generale ed organica previsio-ne urbanistica che si ispiri ad una più vasta esperienza di cultu-ra»57, un concetto definitivamente sancito nella Dichiarazione diAmsterdam nel 197558. Pane, infatti, nella parte conclusiva dell’ar-ticolo, ricordato in questa sede, rimanda a quello che in realtàrimase solo una proposta dell’Ente provinciale per il turismo diLatina, cioè a un Piano generale paesistico della fascia costiera Tir-renica tra Terracina e Gaeta del 1957: «Ma intanto – avverte –come ho già accennato, se non si attua un rigido controllo, la si -tuazione rischia di essere compromessa in modo irreparabile epri ma che il definitivo piano sia entrato in vigore»59. Come ac cen -nato, il piano che concepiva il litorale nella sua totalità, come ununicum, rimase solo una sterile proposta, presentata a seguito delprimo vincolo di tutela di tutta la zona costiera dei comuni diSperlonga, Gaeta e Formia, approvato con decreto ministerialedel 1956 ai sensi della 1497 del 1939, la cui delimitazione costeg-
giava per quasi tutta la sua estensione la nuova strada60. Come sappiamo tuttavia, nel caso del tratto di costa che va daGaeta a Terracina, nonostante i numerosi appelli, ci vorrà moltotempo prima che l’amministrazione centrale risponda con unanormativa attenta ed esaustiva; a questo si aggiunga che ciascunintervento sarà fortemente ostacolato non solo dai privati maanche dagli stessi enti locali, vedendo in queste iniziative un frenoa quel processo di rilancio economico e turistico che la costruzio-ne della nuova strada aveva innescato. «Il piano territoriale paesi-stico regionale nel prevedere una diversa disciplina del territorioco munale mostra di voler interdire completamente ogni possibili-tà edificatoria prevista dal piano regolatore generale sia per quan-to riguarda l’edilizia residenziale, sia la ricettività turistico-alber-ghiera sia per gli insediamenti Industriali e Artigianali. Non sipuò assoggettare genericamente a vincolo di inedificabilità tutto oquasi il territorio comunale», esclamavano alcune delle osservazio-ni da parte del consiglio comunale di Gaeta al piano paesistico, incorso di approvazione, «si tratta di una forzata e non mo tivataimposizione diffusa di vincoli generici sul territorio e non di indi-cazioni di criteri indicatori per le modificazioni e le trasformazio-ni del territorio con finalità di “tutela attiva” del paesaggio»61. Le vicende del piano paesistico arrivano fino ai nostri giorni. An -che se il Comune di Sperlonga riuscì a dotarsi di uno strumentodi tu tela già nel 1968, un piano di prima generazione62, «uno deirari casi di strumento di pianificazione formulato dal Ministerodella Pubblica Istruzione in applicazione della legge n. 1497 del1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche»63 –che solo in parte ostacolò un’eccessiva lottizzazione del litorale –bi so gna attendere i dettami della legge Galasso. Questa compor-tò, per tutta la regione Lazio, l’adozione di ben ventinove pianiterritoriali paesistici, limitatamente alle aree già vincolate, tra cuiil tratto li toraneo in questione, il quale però fu frammentato indue diversi piani64, già approvati nel 1986 ma adottati con leggeregionale n. 24 del 1998.Tali piani sono stati recentemente sostituiti da quello unico perl’intero ambito regionale adottato nel 200865, che ha innanzituttotra gli obiettivi annunciati quello di accordare secondo critericomuni una situazione troppo frammentata per norme e carto-grafia, accogliendo tra l’altro le direttive di un quadro legislativoin materia ambientale profondamente mutato.Il nuovo piano regionale, sulla scorta dei limiti della legge Galas-so, innanzitutto per l’aver ampliato l’azione di tutela a un ambitotroppo genericamente definito ambientale-ecologico, intende an -che, e soprattutto,
ridefinire la sfera di competenza della pianificazione paesaggistica, attra-verso un più ampio approccio settoriale che comprenda e disciplini l’in-sieme dei beni del patrimonio naturale e culturale del territorio dallastessa interessato, assumendo così le funzioni di un piano quadro setto-riale con valenza territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori cul-turali, del paesaggio del patrimonio naturale quale sistema identitariodella Regione Lazio intesa sia come comunità che come territorio66.
La redazione tuttavia si è fondata su due fasi principali: la primadi tipo ricognitivo e conoscitivo del territorio, di cui si può con-statare un accurato approfondimento che ha restituito, nel trattoin questione, una situazione territoriale complessa ma nello stes-so tempo multiforme e variegata nella ricchezza delle presenzeam bientali afferenti a varie tipologie, la seconda di pianificazione.Il piano in questione si configura, per l’appunto, come uno stru-mento di pianificazione territoriale di settore con specifica consi-derazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico natu-
510
Arianna Spinosa
rale e culturale del Lazio67, un tema ampiamente presente nella le -zione che Pane ci ha trasmesso a partire dalla metà del secolo scor-so, richiamato anche nel breve articolo dedicato alla Flacca. Tral’altro una delle più importanti novità introdotte, che ci limitia-mo a segnalare in questa sede, è quella dell’aver individuato diver-si sistemi di paesaggio che presentano caratteristiche omogenee68
a cui dedicare diversi livelli di tutela e miglioramento della quali-tà del paesaggio e una previsione di strumenti di “tutela attiva”volti a una promozione paesaggistica e socioeconomica del terri-torio.
conclusioni
A distanza di cinquant’anni dall’inaugurazione della Flacca ci sipone di fronte a una condizione paesaggistica dei luoghi che essaattraversa profondamente mutata. Il monito avanzato da RobertoPane, subito dopo l’apertura del primo tronco, è rimasto sostan-zialmente inatteso. Allo stato attuale sono molteplici le proble-ma tiche che si fanno avanti, a partire dalla presenza di un trafficoveicolare troppo pesante e intenso, per cui la litoranea, progettatasecondo gli standard europei, comincia a manifestare carenze ditipo tecnico, rispetto ai canoni odierni; a questo si aggiunga l’esi-genza di una corretta amministrazione di vaste aree demaniali in -debitamente occupate, fino alla pianificazione di interventi incui, come nel tratto, più volte citato, della piana di Sant’Agosti-no, si individui – così come annunciato nel nuovo piano – un’or -ganica e culturalmente consapevole azione di miglioramento del-la qualità del paesaggio, attraverso una necessaria riqualificazionedegli elementi naturali presenti. A questo si deve necessariamenteaccompagnare una continuativa presenza sul territorio degli entilocali e centrali nello svolgimento delle attività di controllo emonitoraggio, nella giusta applicazione degli strumenti di tutela.Ciononostante ancora attuale risuona l’incipit con cui RobertoPane apre lo studio relativo al piano paesistico della costiera amal-fitana, in cui ci ricorda che «malgrado gli orrori provocati dallacostante sopraffazione, esercitata dall’interesse privato su quellopubblico, si deve riconoscere che, in Italia, la gran parte delle bel-lezze d’arte e di natura è ancora presente, ed è quindi da difende-re e da salvare»69.
1 Così come descritta dalla letteratura classica, di cui alcuni stralci, come quelli di Tito
Livio e di Strabone, sono riportati in La litoranea Flacca. Archeologia, letteratura, co -
struzione, a cura di E. Vaudo, pubblicazione del Museo del centro storico culturale di
Gaeta, agosto-settembre 2008. 2 R. Pane, La nuova litoranea Sperlonga-Gaeta, in «Le vie d’Italia», lxiv, 10, ottobre
1958, pp. 1324-1330. 3 Ricordiamo che la Cassa per il Mezzogiorno viene istituita con legge del 10 agosto
1950, n. 646, allo scopo di promuovere la valorizzazione economica e sociale del Mez-
zogiorno d’Italia. 4 In occasione del cinquantenario dell’inaugurazione della Flacca in tutta la provincia
di Latina si sono avvicendate manifestazioni, convegni, mostre, e pubblicazioni che ne
hanno ripercorso le vicende non solo costruttive. Tra queste ricordiamo innanzitutto
il volume La via litoranea Flacca 1958-2008, a cura di P.G. Sottoriva, Latina 2008. L’au-
tore sulla base di un’ampia ricerca archivistica ricostruisce in modo abbastanza esausti-
vo e completo gli eventi che hanno caratterizzato il fervore di quegli anni, dotandosi
di documenti e immagini inedite riprese anche dagli archivi privati dei progettisti.
Ricordiamo anche il contributo di F. Giannini, Storia di una strada (la litoranea Sper-
longa-Terracina-Gaeta), in «Viabilità», 1, gennaio 1958. Ancora si richiama il libretto
già citato La litoranea Flacca. Archeologia, letteratura, costruzione, dove sono stati
ripubblicati documenti e articoli di difficile reperimento, tra cui però lamentiamo la
mancanza dell’articolo di Roberto Pane, dal quale ha preso le mosse il presente contri-
buto. 5 La provincia di Littoria fu istituita nel 1927, Latina nel 1945. Per il riassetto politico-
amministrativo tra Lazio e Campania si veda Atlante storico-politico del Lazio, Roma-
Bari 1996, pp. 141-142. Solo a partire dal 1934 il Comune di Gaeta entra a far parte del-
la Provincia di Latina. Cfr. L. Cardi, Lo sviluppo urbano di Gaeta dal ’500 al ’900, Gae-
ta 1979, in part. il capitolo Gaeta nel Novecento, pp. 43-65.6 Vedi La via litoranea, cit., in part. il capitolo Le strade del dopoguerra, pp. 27-41.7 «Fino al 1958 la città è rimasta esclusa dalle grandi vie di comunicazione regionali;
ma, proprio in quell’anno, essa vide interrotto il suo stato di secolare isolamento, gra-
zie all’apertura della strada litoranea Terracina-Gaeta-Formia, che rappresentò la via
più rapida di collegamento tra Napoli e Roma, prima della costruzione dell’Autostra-
da del Sole. La arteria diede notevole impulso allo sviluppo dell’economia locale e sta-
bilì le premesse per la valorizzazione turistica di tutta la fascia costiera da Capovento a
Fontania, zone fino ad allora pressoché inaccessibili, e dello stesso centro antico» (G.
Fiengo, Gaeta: monumenti e storia urbanistica, Napoli 1971, p. 107).8 Cardi, Lo sviluppo urbano, cit., pp. 43-65.9 La via litoranea, cit., p. 94.10 Delibera n. 163 del 10 giugno 1950, oggetto: Incarico al prof. dott. Maresca Gastone
per lo studio dell’utilità economica risultante dal prolungamento nel centro abitato del
tronco ferroviario Gaeta-Formia e per lo studio tecnico finanziario dei benefici industria-
li, commerciali e turistici derivanti dalla costruzione della strada litoranea Gaeta-Sperlon-
ga-Terracina. «Rilevato che l’incarico per lo studio e compilazione della relazione eco-
nomica del prolungamento ferroviario e per lo studio e relazione tecnico-finanziaria
della strada litoranea Gaeta-Sperlonga-Terracina può essere affidata al prof. dott. ing.
Maresca Gastone di Roma, professionista di notoria fama, che si è dichiarato disposto
ad accettare l’incarico» (Archivio Storico Comunale di Gaeta, B. 83, n. 2, pubblicato
in La litoranea Flacca. Archeologia, letteratura, costruzione, cit., pp. 52-53). 11 A. Rigillo, M. Zocca, Gaeta e il suo piano regolatore, Gaeta 1979, p. 71.
5. Spiaggia delvallone di Bazzano,con lo sfondo delpromontorio ovesorgono le case delcentro storico di Sperlonga (foto R. Pane, 1958).
6. Spiaggia di Sperlonga verso la grotta di Tiberio e la successione dei promontori che si estendono fino a mare (foto 2009).
[5.] [6.]
510 511
La “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”: un paesaggio da salvare
[8.][7.]
7. Gaeta, viadotto e galleria delloScarpone dopo la piana di Sant’Agostino (foto 2009).
8. Gaeta, piana di Sant’Agostino. In questo tratto la costruzione dellaFlacca, che corre in stretta vicinanzacon il mare, ha rettificatol’andamento delledune (foto 2009).
12 Nel 1952 Gastone Maresca vince il concorso e diviene titolare della cattedra di
Costruzioni stradali all’Università di Bari, chiamato poi a Roma anche per ricoprire il
ruolo di direttore dell’Istituto di costruzioni stradali e ferroviarie. Le notizie biografi-
che sono tratte dal capitolo Gastone Maresca, un protagonista sfortunato, in La via lito-
ranea, cit., pp. 57-59.13 Vedi E. Morelli, Disegnare linee nel paesaggio, tesi di dottorato di ricerca in Progetta-
zione paesistica, coordinatore G.G. Rizzo, settembre 2004.14 Da E. Bellante, Viadotto presso Sperlonga, in «L’Architettura. Cronache e Storia», ii,
15, gennaio 1957, p. 688. 15 P. Grassini, La nuova strada Terracina - Gaeta - Formia nell’opera di Gastone Maresca,
in «L’Ingegnere», 6, 1955, ripubblicato in La litoranea Flacca. Archeologia, letteratura,
costruzione, cit., pp. 39-40.16 Sostiene Bellante «Ma indubbiamente la nuova strada rappresenterà uno degli inter-
venti più interessanti e proficui, sul piano produttivo e sociale, e di valorizzazione, del-
la Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha volenterosamente apprestato il cospicuo
finanziamento e seguito tecnicamente l’opera sì da realizzarla con la maggior moder-
nità di concetti, ed ha così validamente contribuito allo sviluppo economico della
Provincia di Latina» (E. Bellante, La strada litoranea Terracina-Sperlonga-Gaeta, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Latina, Latina 1958, ripubblicato in La litoranea
Flacca. Archeologia, letteratura, costruzione, cit., p. 45).17 «quella convenzione stabilisce certe caratteristiche per le strade, che divide in 3 cate-
gorie: la prima della larghezza di m. 7, la seconda della larghezza di m. 7+7 e la terza,
a carattere provvisorio, della larghezza di m. 10,50» (M. Coppa, Le autostrade in Italia,
in «Urbanistica», 22, 1957, p. 132). 18 Ibidem.19 Espressione del professore Francesco Fariello e riportata in Morelli, Disegnare linee
nel paesaggio, cit., p. 72, nota 55.20 Ibidem, p. 78, nota 70. 21 S. Ferraro, Di una via aperta dal censore L. Valerio Flacco nell’agro formiano, Roma
1912, rist. anast., Gaeta 2008. 22 Il primo tronco venne appaltato il 28 giugno 1951 con una procedura veloce e i lavo-
ri furono assegnati alla ditta Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo. Per la
descrizione della costruzione dei sei tronchi si rinvia al volume già citato La via litora-
nea, cit., che ce ne fornisce un’esauriente ricostruzione anche in merito alle traversie
burocratiche e alle piccole polemiche scaturite in seno ai vari appalti, nonché tutta la
documentazione tecnica a corredo. Il secondo tronco prevedeva il tratto tra l’Arenau-
ta e Monte a Mare, il terzo la piana di Sant’Agostino, il quarto tra lo Scarpone e Baz-
zano, il quinto il vallone di Bazzano e la piana di Sperlonga che si innesta con le ope-
re della bonifica pontina. In La via litoranea, cit., pp. 73-85. 23 Rigillo, Zocca, Gaeta e il suo piano regolatore, cit., p. 70. Vedi anche il capitolo L’at-
traversamento di Gaeta, in La via litoranea, cit. 24 Ricorda sempre Piero Grassini le discussioni iniziali con il progettista Gastone Ma -
resca sull’opportunità di utilizzare per i ponti archi in pietra, così da intonarsi con la
natura. 25 Ricordiamo che Bruno Zevi conserverà un longevo legame verso le problematiche
urbanistico-paesistiche del litorale in questione, tanto che nel 1986 sarà uno degli
autori del piano paesistico per Sperlonga.26 Bellante, Viadotto presso Sperlonga, cit., pp. 685-688. 27 Id., La strada litoranea Terracina-Sperlonga-Gaeta, cit., p. 40.
28 La via litoranea, cit., p. 79. 29 Per un approfondimento relativo alle vicende dei ritrovamenti del gruppo marmo-
reo nella grotta di Tiberio si rimanda a B. Conticello, Come nacque “l’Odisseo di mar-
mo”, in La via litoranea, cit., pp. 149-224.30 Su di un’iscrizione all’ingresso del Museo archeologico di Sperlonga si legge: «Chi
entra in questo Museo di Sperlonga, tempio omerico d’Occidente, unico nel mondo,
al margine del mare Ulisse, sotto l’aquila di Zeus re degli Immortali e di Tiberio reggi-
tore dell’impero di Roma erede di Ilio, custodisca sempre nel cuore il ricordo dell’au-
tunno 1957, quando il popolo di Sperlonga, impedì con tenace impegno, che i prezio-
si resti appena scoperti fossero trasportati nell’onnivora Roma, gloria, alle fiere don-
ne in stola nera, agli uomini maturi e ai ragazzi impavidi, amantissimi della terra
natia, per avere intuito che il bene archeologico deve restare là dove è venuto alle pro-de della luce testimonianza-memoria-storia perenne. Dettò Marcello Gigante in occa-sione del premio Grotta di Tiberio 1998» (riportata in 1998-2007. Sperlonga. Arte e Cul-
tura, a cura di G. Raimo, Roma 2008). 31 Solo l’attraversamento del comune di Formia fu oggetto di un animato dibattitoproprio per la rottura che la nuova strada procurava tra l’abitato con il fronte a mare el’attraversamento di importanti presenze archeologiche. 32 È significativo che nelle immagini riportate da Roberto Pane a corredo dell’articolonon ricorre mai la nuova strada con le affascinanti opere strutturali, ma bensì unica-mente vedute panoramiche che si aprivano sulle bellezze paesistiche della costa. 33 I beni ambientali, secondo Roberto Pane, traggono significato «proprio dal loro sta-re insieme». Puntualizza Giuseppe Fiengo, il bene ambientale è una «categoria checomprende sia il paesaggio naturale e agrario, che reca i segni della millenaria presen-za dell’uomo, sia gli stratificati tessuti edilizi e urbanistici tradizionali dei centri picco-li e grandi: in una parola, il complesso delle tracce sul territorio delle trascorse civiltà;le quali, allo stato attuale, sono ancora prive di adeguata protezione e proprio per que-sto, sono oggetto di continue manomissioni» (G. Fiengo, La conservazione dei beni
ambientali e le carte del restauro, in Restauro. Criteri, metodi, esperienze, a cura di S.Casiello, Napoli 1990, p. 26). 34 Le “dune” nella più recente normativa in materia ambientale, nuovo piano territo-
riale paesistico regionale del Lazio, sono individuate come «elementi geomorfologici»
connotanti il «paesaggio naturale», soggette a norma regolamentare per cui si prevedo-
no interventi di conservazione, integrazione, riqualificazione e valorizzazione.35 Lo stesso Pane ci descrive che «sulla soffice sabbia grigio-dorata ho visto i piccoli
gigli bianchi che mi avevano tanto sorpreso anni fa sul lido di Cuma, il miracolo di un
fiore odoroso che spunta dall’arena ardente» (Pane, La nuova litoranea, cit., p. 1329).36 Il professore Gastone Maresca era un esperto del settore; ricordiamo alcune delle sue
pubblicazioni che trattano delle pavimentazioni stradali: Comportamento statico delle
pavimentazioni cementizie, Roma 1952 («Quaderni scientifici e didattici»); Introduzio-
ne allo studio dei materiali stradali. Sul comportamento plastico, Roma 1952 («Quaderni
scientifici e didattici»); Osservazioni sulle sollecitazioni indette da variazioni di tempera-
tura nelle pavimentazioni cementizie, Roma 1952 («Quaderni scientifici e didattici»). 37 La via litoranea, cit., p. 74. «Furono in definitiva utilizzati modelli progettuali che
oggi susciterebbero qualche reazione: un’accentuata litoraneità del percorso, il taglio
ed anzi la demolizione della duna, l’uso della sabbia dunale come base del sedime stra-
dale, il tutto per consentire una percorrenza panoramicamente gradevole ma anche
veloce».38 Parte di questi contributi sono riuniti nelle sue quattro principali raccolte di scritti
512
Arianna Spinosa
d’arte, di metodologia del restauro e dell’urbanistica dei centri antichi: Architettura e
arti figurative (Venezia 1948); Città antiche edilizia nuova (Napoli 1959); Attualità del-
l’ambiente antico (Firenze 1967); Il canto dei tamburi di pietra (Napoli 1980). Riportia-
mo uno stralcio della premessa all’ultimo dei volumi: «malgrado abbia dovuto registra-
re, nel mio sforzo a partecipare alla difesa del patrimonio d’arte e di ambiente, quasi
esclusivamente degli insuccessi, ciò è servito a provare – non foss’altro che a me stesso
– di non poter essere ridotto alla rassegnazione. [...] Le cose – continua – sono andate
nel peggiore dei modi possibili; e se qualche margine ambientale appare tuttora rispar-
miato, lo si deve ad accidentali e particolari circostanze» (p. 7).39 In R. Pane, Un domani per il restauro, parte introduttiva alla relazione presentata al
Convegno di Ravello il 23 settembre 1976, in «Napoli nobilissima», xvi, iv, luglio-ago-
sto 1977, p. 155.40 Per ripercorre le tappe principali dell’evoluzione del pensiero di Roberto Pane in
merito alla questione ambientale si veda R. Picone, Il contributo di Roberto Pane alla
moderna tutela ambientale, in «Napoli nobilissima», xxvi, i-vi, gennaio-dicembre
1987, pp. 144-148.41 R. Pane, Unità di criteri fra paesaggio vegetale e paesaggio edilizio, in «Napoli nobilis-
sima», xvi, ii, marzo-aprile 1977, nella rubrica Antico e Nuovo, p. 76, e Id., Tutela
ambientale e rapporti tra Stato e Regione, in Id., Il canto, cit., p. 248.42 «il tracciato percorre una fascia costiera, finora scarsamente conosciuta, nella quale
si fondano in bella armonia le attrattive del clima, del paesaggio e degli insediamenti
umani, dagli antichissimi ai recenti: è facile prevedere, anche se qualitativamente, il
notevole flusso di traffico turistico che verrà ad esservi incanalato» (Bellante, La stra-
da litoranea Terracina-Sperlonga-Gaeta, cit., p. 44).43 Vedi Cardi, Lo sviluppo urbano, cit., p. 57. 44 Vedi il volume di Fiengo, Gaeta: monumenti, cit., in cui si esamina il centro storico
secondo un approccio metodologico, condiviso dai professori Roberto Pane e Ro ber-
to Di Stefano, nella comprensione dei valori ambientali che lo caratterizzano, dati da
una commistione di presenze storiche, artistiche e naturali. Nel capitolo conclusivo
vengono avanzate anche interessanti proposte di “restauro ambientale”, come premes-
se culturali a un piano di risanamento e restauro del centro antico di Gaeta.45 Si segnala che l’immagine fotografica, indicata da Roberto Pane nella didascalia
come la spiaggia di Sant’Agostino, in realtà corrisponde alla piana di Bazzano, nei
pressi di Sperlonga.46 Pane, La nuova litoranea, cit., p. 1324.47 Ibidem, p. 1329.48 R. Pane, Documentazione ambientale della Costiera amalfitana, in «Napoli nobilissi-
ma», xvi, i, 1977, p. 3.49 Id., Tutela ambientale, cit., p. 245. 50 Id., Passaggio dall’idea del monumento isolato a quella dell’insieme storico-artistico, in
Id., Attualità dell’ambiente antico, cit., p. 84.51 R. Picone, Roberto Pane (1897-1987). Antologia degli scritti, in Che cos’è il restauro?
Nove studiosi a confronto, a cura di B.P. Torsello, Venezia 2005, pp. 81-84.52 Pane, Passaggio dall’idea, cit., p. 84, e ripreso da Picone, Il contributo di Roberto Pane,
cit., p. 144. Il piano territoriale paesistico dell’area sorrentino-amalfitana rappresenta
per Roberto Pane l’esemplificazione in prassi operativa delle questioni teoriche relati-
ve alla tutela del paesaggio. 53 Cfr. R. Pane, Per un parziale emendamento della Carta del restauro italiana, in Id.,
Attualità dell’ambiente antico, cit., pp. 25- 32; Id., Conférence introductive, in Il monu-
mento per l’uomo, Atti del ii Congresso internazionale del restauro (Venezia, 25-31
maggio 1964), Padova 1971, pp. 1-13. 54 Per un approfondimento del carattere interdisciplinare degli interessi e dell’attività
di Roberto Pane, con particolare riferimento all’ambito del restauro, si richiama il
contributo di A. Pane, Roberto Pane (1897-1987), in «’ANAΓKH», 50-51, 2007, pp. 24-
33. Si veda anche L. Guerriero, Roberto Pane e la dialettica del restauro, Napoli 1995, in
part. il capitolo La vita e l’opera, pp. 21-66. 55 R. Pane, Sorrento e la costa, Napoli 1955.56 C. Brandi, Difendere la solitudine della Flacca, in «Corriere della Sera», 24 marzo
1960, pubblicato in Id., Terre d’Italia, a cura di V. Rubiu, Milano 2006, pp. 409-413, e
in La litoranea Flacca. Archeologia, letteratura, costruzione, cit., pp. 28-32.57 R. Pane, Restauro dei monumenti e conservazione dell’ambiente antico, in Congresso
internazionale indetto dall’xi Triennale di Milano, Attualità urbanistica del monumen-
to e dell’ambiente antico (28-30 settembre 1957), in «Urbanistica», xxvii, 23, marzo
1958, p. 111. 58 Dichiarazione finale del Congresso sul patrimonio architettonico europeo, organiz-
zato dal Consiglio d’Europa (Amsterdam, 21-25 ottobre 1975), a conclusione dell’An-
no del patrimonio architettonico europeo, 1975. Cfr. R. Di Stefano, Il recupero dei
valori, Napoli 1979, pp. 189-200. 59 Pane, La nuova litoranea, cit., p. 1330.60 Decreto ministeriale del 17 maggio 1956, dalla «Gazzetta Ufficiale», 133 del 30 mag-
gio 1956, p. 1903. La zona costiera sita nell’ambito dei comuni di Sperlonga, Gaeta e
Formia era stata già inclusa dalla Commissione Provinciale di Latina per la protezione
delle bellezze naturali nell’adunanza del 4 giugno 1952 nell’elenco delle cose da sotto-
porre a tutela paesistica. Detta zona è costituita da «un insieme di quadri naturali di
singolare bellezza panoramica». Tra l’altro Roberto Pane di tale vincolo asserisce: «Ho
saputo che esiste un vincolo paesistico per tutta la costa che la nuova strada offre oggi
al turismo; ma tale vincolo, come altrove, non è sufficiente ad impedire l’arbitrio; e
ciò, sia per le difficoltà di un’adeguata sorveglianza, sia perché le stesse autorità locali
concedono permessi di costruzione senza trasmettere, come dovrebbero, i progetti alla
Soprintendenza di Roma» (Pane, La nuova litoranea, cit., p. 1330).61 Da «Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale», oggetto:
Os servazioni del Comune di Gaeta al Piano Paesistico Territoriale - Ambito territ. n. 14,
“Cassino-Gaeta-Ponza”, del 3 agosto 1988. Conservate presso gli archivi dell’Ufficio
tecnico del Comune di Gaeta in faldoni sciolti. 62 Insieme a quello dell’Appia Antica e del Comprensorio del Terminillo, furono gli
unici piani a essere redatti e adottati per tutta la Regione Lazio. Vedi Piano Territoria-
le Paesistico Regionale [P.T.P.R.], Relazione, a cura della Regione Lazio, Assessorato
Urbanistica Regionale Territorio e Urbanistica, novembre 2007, p. 2. 63 Sperlonga 1948-1968. L’architettura della ricostruzione, a cura di C. Carbone, S.
Richter, Roma 2008, p. 118. 64 In particolare per l’ambito 13 Sperlonga, progettisti arch. B. Zevi, arch. P.M. Lugli,
arch. A. Montenero, ing. L. Passarelli, arch. M. Picciotto, arch. S. Rossi, arch. G.
Rusponi; per l’ambito 14 Cassino-Gaeta-Formia-Isole Ponziane, progettisti, ing. G.
Imbevi, arch. V. Bacigalupi, arch. C. Canestrani, ing. F. Guerrieri, ing. P. Iacobelli,
arch. F. Sapio, arch. G. Vighi. 65 Ai sensi degli articoli 21-22-23 della legge regionale n. 24 del 1998. 66 Vedi Piano Territoriale Paesistico Regionale. Relazione, a cura della Regione Lazio, As -
sessorato Urbanistica Regionale Territorio e Urbanistica, novembre 2007, p. 3.67 In particolare il piano intende per paesaggio «le parti del territorio in cui i caratteri
distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni
nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso espri-
me quali manifestazioni identitarie percepibili come indicate nell’art. 131 del Codice».
Vedi Piano Territoriale Paesistico Regionale. Norme, a cura della Regione Lazio, Asses-
sorato Urbanistica Regionale Territorio e Urbanistica, novembre 2007, p. 4. 68 Sono state individuate quattro principali categorie: sistema del paesaggio naturale,
sistema del paesaggio agrario e sistema del paesaggio insediativi e aree con caratteri
specifici. Vedi P.T.P.R., Relazione, cit., pp. 23-27.69 Pane, Documentazione ambientale, cit., p. 3.