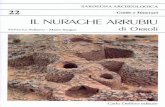«Più pro fa il pane asciuto in casa sua...». Formule proverbiali e sentenziose in Pietro Aretino,...
-
Upload
unitusdistu -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of «Più pro fa il pane asciuto in casa sua...». Formule proverbiali e sentenziose in Pietro Aretino,...
Cinquecento plurale Gruppo di ricerca interuniversitario
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali Università della Tuscia
Cinquecento - Testi e Studi di Letteratura italiana Comitato scientifico Lina Bolzoni Iain Fenlon Giorgio Inglese Mario Pozzi Paolo Procaccioli (coord.) Brian Richardson
IL PROVERBIO NELLA LETTERATURA ITALIANA DAL XV AL XVII SECOLO
Atti delle Giornate di studio
Università degli studi Roma Tre - Fondazione Marco Besso Roma 5-6 dicembre 2012
a cura di Giuseppe Crimi e Franco Pignatti
VECCHIARELLI EDITORE
Pubblicato con il contributo di:
Dipartimento di Studi Umanistici
© Vecchiarelli Editore S.r.l. - 2014 Piazza dell'Olmo, 27 00066 Manziana (Roma) Tel. 06 99674591 Fax 09 99674591 [email protected] www.vecchiarellieditore.com ISBN 978-88-8247-365-5
INDICE
Premessa Paolo Rondinelli, Il Liber proverbiorum di Lorenzo Lippi
e la paremiografia umanistica 11 Davide Canfora, Umanità del proverbio
e umanesimo della parola 35 Luca Marcozzi, Minima adnotanda
sui Motti di Pietro Bembo 47 Paolo Marini, «Più pro fa il pane asciuto in casa sua...».
Formule proverbiali e sentenziose in Pietro Aretino 67 Carlo Alberto Girotto, Schede sull’uso dei proverbi nelle opere
di Anton Francesco Doni 113 Marco Faini, «Ad Modenam ursum menare bisognat».
Il proverbio nelle opere di Teofilo Folengo 139 Luca D’Onghia, Sull’uso dei proverbi nelle Lettere
di Andrea Calmo 161 Giuseppe Crimi, I Proverbi del Farina: storia di una
fortunata raccolta di distici 183 Franco Tomasi, Osservazioni sul proverbio nella lirica
quattro-cinquecentesca 217 Franco Pignatti, Frottola e proverbio nel XVI secolo.
Con qualche notizia sulla perduta raccolta paremiografica di Marcantonio Piccolomini 247
Renzo Bragantini, La spola del racconto: dal proverbio alla novella, e viceversa 283
Ida Caiazza, Proverbio e sentenza in Alvise Pasqualigo
(e una nuova fonte del Giardino di ricreazione di John Florio) 315 Lorenzo Carpanè, Educare con i proverbi: Orlando Pescetti
tra letteratura e pedagogia 341 Anders Toftgaard, I proverbi italiani nell'Europa del Nord.
Il significato d'alquanti proverbi dell'italica favella di Giacomo Castelvetro 367
Massimiliano Malavasi, «Son sentenze i proverbi arciprovate».
Il proverbio nel poema eroicomico secentesco 395 Marco Catucci, Il proverbio in commedia. Da Giovanni
Andrea Moniglia a Jacopo Angelo Nelli 429 Enrico Parlato, Luoghi comuni in immagine. Da Erasmo
ai florilegi secenteschi 449 Laura Lalli, I proverbi del Cinquecento nella biblioteca
di Marco Besso 469 Indice dei nomi 485
7
Premessa
Negli studi sulla nostra letteratura si può dire che l'interesse per il proverbio abbia registrato un apice agli esordi della critica moderna, quando gli studiosi non disdegnarono di chinarsi su testimonianze minori e minime, remote dai lasciti più illustri della nostra storia ci-vile e letteraria, considerate meritevoli di attenzione in una idea del-la letteratura come disciplina storica. Valga per tutti il nome di Fran-cesco Novati, che sulle pagine del Giornale storico delle letteratura ita-liana con le Serie alfabetiche proverbiali condusse in più tappe, dal 1890 al 1909, la riesumazione di testi fino ad allora non lambiti dalla criti-ca e che apparvero invece degni di essere recuperati.
In una indagine che spostava l'attenzione dal valore intrinseco dei testi, basato sull'intuizione estetica, all'insieme dei fenomeni e al loro svolgersi nel tempo come un processo evolutivo, la ricerca sul proverbio trovò l'habitat adatto ed è con questo spirito che gli studio-si si accostarono ad esso dal punto di vista specifico delle discipline letterarie, cioè attraverso un approccio essenzialmente filologico – concentrato sulla lingua, la metrica, la ricerca delle fonti –, in anni in cui la nascente disciplina antropologica si volgeva invece al prover-bio come portato della cultura popolare viva e dava luogo a grandi opere di censimento e repertoriazione. La più celebre, i Proverbi sici-liani di Giuseppe Pitrè.
Nelle epoche successive la nostra critica letteraria non ha manife-stato per il proverbio un interesse paragonabile alla temperie che abbiamo brevemente descritto. Nel secolo che ci ha da poco lasciato di rado gli studiosi afferenti a quella disciplina che ha per oggetto specificamente il proverbio, la paremiografia (o la sua variante più altisonante, la paremiologia), si sono applicati ai testi letterari, né gli studiosi di letteratura delle diverse epoche hanno guardato con co-stanza al proverbio come a un possibile strumento per leggere e in-terpretare i testi.
Vero è che il proverbio è presente nel catalogo delle forme brevi del discorso antiche e moderne, ma esso non si può ridurre a un e-nunciato classificabile retoricamente e a tratto distintivo di uno stile o di un genere. Al contrario, in quanto universale sprovvisto di un
8
profilo rigido, il proverbio presenta una liquidità tale da renderlo adatto a tutti, o quasi, i contesti enunciativi e livelli stilistici, sicché non stupisce che ciò abbia dissuaso dal polarizzare l'analisi di un te-sto letterario su qualcosa che è res nullius e in buona sostanza idonea a qualsivoglia impiego, invece che sugli aspetti più inerenti ai pro-cessi di formalizzazione in cui consiste per definizione il prodotto letterario.
Con quanto appena detto non si intende proporre una sorta di rovesciamento delle gerarchie vigenti e conferire al proverbio una funzione strutturale tale da tenere in piedi da solo un testo. Ciò vale, naturalmente, per opere come le serie proverbiali, da cui abbiamo preso le mosse, che sono a tutti gli effetti sillogi incardinate su una precisa architettura (ad esempio le serie alfabetiche o numeriche o quelle incentrate sui mesi e i lavori agricoli a essi legati), o per pro-dotti più sofisticati come le epistole interamente intessute di prover-bi che ebbero corso in special modo nel XVI secolo, espressione di un elevato interesse paremiografico che diede luogo a risultati estremi e paradossali, nei quali il proverbio si impadroniva dell'intero spazio testuale.
Il punto di partenza della presente raccolta di saggi è, piuttosto, quello di vedere se in una situazione, diremo così, "normale" il pro-verbio possa fungere da chiave per comprendere autori o testi o ge-neri, ai quali finora ci si è accostati da altri punti di vista. La scelta di concentrare l'indagine su un arco cronologico che va dalla fine del XV secolo alla fine del XVII nasce dalla convinzione che questa epo-ca sia il momento in cui il proverbio è stato recuperato da parte degli uomini di lettere a una piena dignità espressiva e di senso. Non si può, ovviamente, tacere il nome di Erasmo da Rotterdam. I suoi A-dagia rappresentano la vetta di questo fenomeno, che non si limita alla sfera erudita, ma innerva la civiltà letteraria in maniera diffusa. In modo più netto, ci è parso che in questa epoca il proverbio abbia compendiato i tratti di un sapere condiviso da tutti e a disposizione di tutti, e insieme, nel segno di Erasmo, la capacità di concentrare i portati culturali di una intera civiltà. È questo innalzamento del pro-verbio a un rango che non aveva conosciuto nelle epoche precedenti e la capacità di attrarre nella sua sfera di competenza altre forme di
9
discorso breve (favola, apoftegma, sentenza, esempio, motto), che avevano avuto nella retorica classica – e avrebbero avuto in quelle successive – statuto autonomo, che conferisce al proverbio inedite potenzialità espressive, di cui gli autori cinque-secenteschi furono pienamente consapevoli e che sfruttarono con larghezza nei campi più disparati.
La presente raccolta ha come sua finalità quella di illustrare la funzione del proverbio in opere e autori individuati nei contributi con la più grande libertà nell'arco di tempo proposto. Essa non aspi-ra in alcun modo a essere un panorama sistematico, né si propone finalità metodologiche in senso stretto. Il risultato d'insieme che si è ottenuto ci pare unitario. Lo si propone agli studiosi con l'intento di fornire un panorama stimolante su una componente della letterarie-tà rinascimentale, cui non può non andare lo studio avvertito di chi si applica per lavoro o per passione alla letteratura di quell'epoca.
Infine, i nostri ringraziamenti vanno alla Fondazione Marco Bes-so di Roma e all’ex Dipartimento di Italianistica dell’Università degli studi Roma Tre (ora confluito nel Dipartimento di Studi Umanistici), grazie ai quali l’organizzazione delle giornate di studio e la pubbli-cazione degli atti sono state possibili.
* * * Nelle note le opere sono indicate con il nome dell'autore o con il tito-lo seguiti dalla data di pubblicazione; le sigle sono sciolte nei Regesti bibliografici in calce a ciascun saggio. Il numero dopo i due punti indica la o le pagine o carte, preceduto, se necessario, dall'indicazio-ne del volume in numeri romani. Altre indicazioni di partizioni in-terne, a esempio il numero di una lettera o di una poesia in raccolte o una nota, sono precedute, indistintamente, da «n.». Le eccezioni alla norma sono illustrate caso per caso.
67
PAOLO MARINI
«PIÙ PRO FA IL PANE ASCIUTO IN CASA SUA...». FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO*
Osservata nell’ottica inclusiva proposta da Franca Brambilla Ageno,1 verso una considerazione globale dei sintagmi rigidi che caratterizza-no la lingua, l’opera aretiniana appare strutturalmente condizionata da un tasso di proverbialità assai elevato. Il dato è notorio e si impone in tutta la sua evidenza, benché a riguardo si registrino solo menzioni sporadiche nei contributi sin qui dedicati alla lingua di Aretino, a oggi ancora priva di uno studio monografico di ampio respiro.2
Meno scontate, invece, le ragioni profonde di una presenza così pervasiva di frasi proverbiali, proverbi e wellerismi, nonché, su ver-santi contigui ma ben distinti, di sintagmi latini e di sentenze. La fun-zione stilistica e il vario grado di incidenza di queste tessere testuali in rapporto ai diversi generi letterari praticati da messer Pietro, dalla pa-squinata all’agiografia, andranno indagati nel quadro sempre valido dell’edonismo linguistico cinquecentesco e dell’idea che le polarità opposte di natura e artificio vadano ricondotte nella sostanza a due facce della medesima medaglia.3 Lo spunto per fissare un primo, cru-ciale, caposaldo utile a incardinare il discorso su quella peculiare for-ma di moralismo che anima la penna aretiniana, mi pare si possa rica-vare dal proemio dell’Astolfeida, tra i poemi cavallereschi forse il più curioso, se non altro per la complessa concrezione paratestuale che lo introduce. Il testo è infatti preceduto da una dedica fittizia dell’autore a Pasquino e Marforio «amatori del vero»:
* Sono grato a Luca D’Onghia, Carlo Alberto Girotto, Enrico Parlato e
Paolo Procaccioli per i consigli con cui hanno contribuito a questo saggio. 1 Mi riferisco a BRAMBILLA AGENO 2000c. Sulla continuità, a distanza, con
l’impostazione inclusiva del Flos di Monosini si veda PIGNATTI 2010: 247 e n. 113.
2 Lo stato, tutt’altro che florido, degli studi sulla lingua di Aretino è pre-sentato in PATOTA 2008: 77-80.
3 Cfr. SEGRE 1991: 371-372.
PAOLO MARINI
68
sotto l’umbra del vostro vero mando al sole l’Astolfeida [...]. Io so che sapete che i paladini furono valenti e da bene, ma non quanto se ne ra-giona. I paladini furono uomini come gli altri; il mondo fu sempre d’una sorte.4
La contaminazione dei generi, così frequente nello scrittoio aretinia-no, si ripropone qui in un curioso ibrido di musa pasquinesca e mu-sa eroicomica che salda il rovesciamento giocoso, e di per sé frivolo, della materia epica cavalleresca al grande tema del vero, o meglio dell’urgenza impellente della proclamazione del vero cui è ab origine stretta, in un vincolo quasi sacerdotale, l’attività del poeta satirico.5 Alla dedica segue un sonetto-avviso di Pasquino ai lettori, in cui A-retino è a sua volta consacrato «del vero amante».6 E si continua a bat-tere con insistenza sullo stesso tasto nelle prime ottave del poema:
Dir male e dire il ver genera sdegno sogliono dir gl’ipocriti e piangioni.7
La sanzione del nodo maldicenza-verità, stretto nel primo verso con una formula che potrebbe sintetizzare l’intera carriera di Aretino-Pasquino ben oltre la sbandierata conversione del 1539, è espressa tramite la parafrasi dell’adagio erasmiano di matrice terenziana «Ob-sequium amicos, veritas odium parit» (Andria, I, I, 68),8 arricchito dalle specifiche poetiche aretiniane del dire il vero e del conseguente, inelu-
4 Astolfeida: 239-240. 5 Si pensi al celebre assunto dell’io-satirico ariostesco, «esser non so se
non verace» (Satire, III, 12), la cui figura morale è debitrice della maschera del satirico codificata dalla grande tradizione latina da Orazio a Persio a Giovenale. E si noti, a margine, come di tale maschera il pasquinista condi-vida solo alcuni tratti, impegnato com’è in una vituperatio ad personam poco interessata alla proposta di una pars construens (la questione è affrontata in CORSARO 2006: 35-37). Più che esplicito in tal senso il botta e risposta finale della Farza, dove Silvano definisce Aretino «schietto e puro» (v. 227) e Ca-landro chiude con l’eloquente esclamazione «Dio ne guarde ciascun da la sua lingua» (v. 231; Operette politiche e satiriche: 48).
6 Astolfeida: 241. 7 Ibid.: I, 4, 1-2. 8 Erasmo, Adagia, n. 1853. Sullo specifico WADDINGTON 2009: 184.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
69
dibile, dire male. Nella riduzione operata da Aretino il primo emisti-chio dell’adagio, che allude alla laudatio, non è nemmeno preso in con-siderazione. Nel «Veritas odium parit» replicato all’infinito su meda-glie, ritratti silografici e marche tipografiche, così come nell’altro cele-bre vessillo condiviso con Francesco Marcolini, quel «Veritas filia temporis» ricavato da Aulo Gellio (Noctes Atticae, XII, 11, 7), ma, a sua volta, concettualmente incluso nel collettore degli Adagia erasmiani,9 è semmai visibile in filigrana la postura recriminatoria del sedicente exul inmeritus, fuggito suo malgrado da Roma in quanto vittima della fedeltà alla propria funzione di araldo del vero e fustigatore dei vizi di corte. Da qui, a ben vedere, l’infinita polemica sciorinata per tutto il corpus delle Lettere contro i detrattori mossi da invidia nei confronti dell’«odiato e povero, per dire il vero»,10 cui il tempo non potrà che dare ragione, e Roma, finalmente grata, nuova e solenne accoglienza, magari sotto forma di un cappello cardinalizio.11 Si torni al proemio
9 Si tratta dell’adagium 1317 di Erasmo, «Tempus omnia revelat»: «Plutar-
chus in Problematis causam inquirit, cur antiquitus operto capite res divina Saturno fieri consueverit, atque id significatum arbitratur, quod veritas ple-rumque tecta ignorataque sit, sed eadem aperitur tempore». Per un’analisi dettagliata dei due adagia nel contesto aretiniano rinvio a PIERGUIDI 2008: 113-118 e WADDINGTON 2009: 182-201, dove è tra l’altro raccolta e discussa la bi-bliografia prodotta dal saggio di Fritz Saxl in avanti sulla complessa polise-mia di Veritas filia temporis. Sui rapporti tra Aretino ed Erasmo cfr. FALASCHI 1977 e CAIRNS 1985: 57-68. Una bella testimonianza a proposito di Aretino lettore di Erasmo paremiografo è offerta da una lettera di Ludovico Dolce a Pietro del 21 febbraio 1540: «Mi disse l’amorevolissimo Corso, che vostra Signoria desiderava di vedere i Proverbi di Erasmo, i quali ho avuto a quest’ora, e gliele mando» (LSA: I, 337).
10 Lettere: I, 150; al cardinale Bernardo Cles, 22 gennaio 1537. 11 Anche una volta sistemato in Laguna nelle vesti di letterato organico
alla Repubblica, Aretino non smette di guardare con rammarico a Roma come alla sua sede naturale. Danilo Romei ha giustamente sottolineato il da-to dell’assenza di Roma dal primo libro delle Lettere (ROMEI 1999: 53-55). In seguito, tuttavia, l’ansia di una riconciliazione completa con la Curia roma-na, anche metaforicamente incarnata dalla corsa al cardinalato, anima la vi-cenda biografica di Pietro sino alla morte, trovando talora espressione nel vagheggiamento di impossibili nóstoi come quello adombrato nella postfato-ria a Francesco Priscianese che accompagna la Vita di santa Caterina: «Ma
PAOLO MARINI
70
dell’Astolfeida. Ciò che ancora di più preme mettere in luce in questa sede è la conclusione che occupa l’ottava successiva:
Or stien lontani da l’istoria mia quei che vendon la logica a le scuole; [...] vadi a le forche questa e quella arpia che sputa perle in cambio di parole.12
Come si vede, la topica presa di distanza dalla pedanteria libresca si conclude in un discorso di stile, dove la dichiarazione di poetica, e-spressa implicitamente in negativo nel rifiuto di una lingua ispirata ai canoni dell’artificio retorico, è prodotta proprio attraverso l’impiego di una frase proverbiale come «sputare perle». Si ricorre cioè a una colo-ritura linguistica “popolare” bassa, non priva di una certa scurrilità, che viene sfruttata in ossequio al canone opposto, quello che rinvia alla natura come criterio supremo di giudizio. Beninteso, una natura quanto mai artificiosa, ammantata di una patina espressiva dosata con sapienza, agli antipodi dei prodotti della letteratura popolare irrifles-sa,13 e tuttavia di ineguagliabile efficacia nella propria funzione di me-dium linguistico di quel vero su cui è plasmato il profilo artistico e pro-fessionale del poeta. Nello schema idealmente proposto da Aretino, in cui il polo positivo costituito dalla coppia vero-natura si oppone a quel-lo negativo della coppia falso-artificio, l’azione morale (o moralistica)
spero (se le stelle non ci rubano lo effetto de le promessioni loro) che Roma, non più rifugio de le genti, non più madre de le virtuti, non più patria de le generosità, non più capo del mondo, non più albergo dei santi e non più seggio di Cristo, ritornarà, noi vivendo, e seggio di Cristo, e albergo dei san-ti, e capo del mondo, e patria de le generosità, e madre de le virtù, e rifugio de le genti. Per la qual cosa i giusti essulteranno ne la felicità di cotal giorno. E io, correndo a la corte che or fuggo, venuto nel concilio degli amici veri, alimentarò il mio animo con la dolcezza de la conversazione del chiaro Al-dovrandini, del buon Nardi» (Opere religiose: 609).
12 Astolfeida: I, 5, 1-2, 5-6. 13 Il «trattamento iperletterario del parlato» e la filiazione della «naturale
favella» dall’«artificioso discorso» sono ampiamente illustrati in TESTA 1991: 80-81 a proposito delle Sei giornate.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
71
del poeta non può che sostenere la propria ruvida concretezza su un’adozione calibrata del codice linguistico popolare, di cui le forme proverbiali, così come le simulazioni di parlato, fanno costitutivamen-te parte.14
In questo senso l’impiego massiccio di proverbi e sentenze andrà letto in funzione di una vena censoria che attraversa tutta l’opera dell’«acerrimus virtutum ac vitiorum demonstrator», e che si esprime in una speciale propensione alla formulazione gnomica, diffusa uni-formemente dalle prime prove poetiche degli anni romani alle com-medie, alle Lettere, fino alla definizione da parte della Nanna di una paradossale precettistica della cortigianeria non immune dalla propo-sta di una morale spicciola, di un’etica funzionale al quotidiano gal-leggiamento in un universo corrotto.
Non stupisce, in tale prospettiva, l’attenzione dedicata alla materia paremiografica e alla fraseologia proverbiale tout court da uno dei pa-dri della filologia aretiniana moderna, Giovanni Aquilecchia. Fra gli apparati della sua edizione delle Sei giornate sono inclusi un Indice dei wellerismi e un Elenco dei proverbi, con un rinvio al fondamentale Glos-sario per quanto riguarda il censimento e l’illustrazione delle frasi proverbiali, definite con le parole della Brambilla Ageno «quelle [...]
14 Non si contano i luoghi aretiniani in cui l’identità vero-natura è riven-
dicata all’origine di uno stile alternativo a quello di coloro che si trincerano dietro il principio di imitazione, forti della conferma offerta dalla proposta classicistica bembiana. Valga per tutti un passo della dichiarazione di poeti-ca contenuta nella lettera 155 del primo libro, indirizzata prima a Niccolò Franco e poi a Ludovico Dolce con data 25 giugno 1537. Qui, tra le altre co-se, Aretino presenta anche le proprie credenziali di scriba Naturae: «imparate ciò ch’io favello da quel savio dipintore, il quale, nel mostrare a colui che il dimandò chi egli imitava una brigata d’uomini col dito, volse inferire che dal vivo e dal vero toglieva gli essempi; come gli tolgo io parlando e scri-vendo. La natura istessa, de la cui semplicità son secretario, mi detta ciò che io compongo; e la patria mi scioglie i nodi de la lingua» (Lettere: I, 231-232). In un testo la cui importanza è comprovata dal cambio di destinatario intro-dotto nel 1542, appare assai significativa la scelta dell’impiego massiccio di formule proverbiali e calchi del parlato consequenziale all’adozione di un codice linguistico naturale; l’unico adatto, nell’ottica aretiniana, a esprimere la professione di fedeltà al vero.
PAOLO MARINI
72
che “contengono un’immagine e non hanno forma di sentenza o di considerazione generale, né contenuto didascalico”».15 L’impaccio terminologico rivelato da Aquilecchia nell’introdurre un elenco che «comprende tutte le sentenze proverbiali – siano esse tradizionali ov-vero originali – contenute nelle Sei giornate» è spia della difficoltà che si incontra nello sforzo classificatorio di ordinare una delle porzioni della cultura scritta più sfuggenti, proprio in ragione dell’intrinseco metamorfismo che le deriva dal canale sempre aperto con l’oralità.16
L’ambiguità dell’espressione «sentenze proverbiali» si spiega con l’effettiva presenza nell’Elenco di sentenze miste a proverbi, mentre l’ammissione della presenza indistinta di formule «tradizionali ovvero originali» tocca uno dei nervi scoperti della paremiologia. Come tale, infatti, il proverbio non può non essere tradizionale, ovverosia condi-viso, frequentato, laddove la sentenza, pur se accomunata a esso dalla caratteristica brevitas e dall’eventuale componente figurale arguta, non necessita in sé di alcun tipo di popolarità e può manifestarsi come au-tonoma enunciazione di un singolo autore.17
15 Sei giornate: 518-522. Aquilecchia cita la definizione proposta in un
saggio del 1959, ora BRAMBILLA AGENO 2000b: 381. La cura speciale per gli apparati linguistici dell’edizione Aquilecchia si spiega anche con la parteci-pazione diretta all’impresa di Gianfranco Folena, il quale, infatti, nel prezio-so allegato che accompagna il volume in forma di quarta di copertina, loda la «serie di preziosi indici, dei riferimenti letterari e folclorici (citazioni, pro-verbi, modi di dire tipici)», nonché il «ricchissimo glossario» (FOLENA 1997: 135; sull’importanza di tale allegato si sofferma PATOTA 2008: 78). Come mi-nima integrazione all’Elenco, in linea con TPMA 1996: 334, andrà acquisito il secondo emistichio del proverbio «chi sempre beve non ha mai troppo sete; e rade volte ha fame chi sta sempre a tavola» (Sei giornate: 116 rr. 25-26), di cui Aquilecchia registra solo la prima parte.
16 Sei giornate: 520. La confusione terminologica prodottasi negli studi linguistici è segnalata da CHIECCHI 1975-1976: 119-120.
17 Utili e più dettagliati distinguo, con ampio rinvio alle poetiche medie-vali, in CHIECCHI 1975-1976: 121-122 e in BRAMBILLA AGENO 2000c. Notevole, anche in considerazione dell’importanza che gli scavi paremiografici avran-no in prospettiva nell’allestimento del primo vocabolario della Crusca, la definizione di proverbio offerta da Pier Francesco Giambullari: «Il proverbio [...] è un motto celebre et frequentato: et che arreca seco qualche cosa notabi-
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
73
Dallo spoglio delle opere aretiniane, condotto ove possibile con l’ausilio dei rispettivi glossari, sono emerse alcune costanti riconduci-bili da un lato alle differenti specifiche dei generi praticati e dall’altro, nell’ambito del medesimo genere, all’alternanza delle voci apparte-nenti ai singoli attori della fictio letteraria. Le sentenze sono diffuse ovunque, ma restano le uniche tessere gnomiche nei contesti retori-camente strutturati nel segno della gravitas, dai quali sono invece e-scluse tutte le espressioni proverbiali di matrice bassa, del resto incon-cepibili quando Aretino si misura con la facies artificiosa del suo per-sonale edonismo linguistico. Mi riferisco in primo luogo alle opere re-ligiose e in particolare, come si vedrà più oltre, alle agiografie.
Tutte le formule proverbiali, con annessi sintagmi latini, sono in-vece trasversalmente radicate nella produzione satirico-pasquinesca, nei poemi eroicomici, nelle commedie, nei dialoghi e, all’occorrenza, nelle Lettere. E si noti che in tutti questi casi, in linea con la poetica del vero e del naturale, l’espressività proverbiale è in realtà sottoinsieme di un codice linguistico di matrice culturale studiatamente bassa, ri-conducibile alle categorie del popolare e talora persino dell’osceno, che rimane, non a caso, appannaggio di figure depositarie di una spe-ciale forma di conoscenza, di una sapienza delle cose del mondo este-sa alle trame del gioco letterario. È la voce del servo e delle figure so-cialmente subalterne nella commedia; è la voce della Nanna e della Comare nei dialoghi; è infine la voce dello stesso Aretino nelle vesti, volta a volta, di io-satirico celato dietro la maschera di Pasquino, di io-narrante nell’Astolfeida e nell’Orlandino, e, infine, di io-mittente nell’epistolario. Le Lettere Spicca per imponenza l’immissione di frasario proverbiale di varia na-tura in quei passi nodali dell’epistolario in cui Aretino elabora le cele-bri dichiarazioni di poetica anticlassicistica. Si legga, a esempio, un brano della lettera a Sebastiano Fausto da Longiano del 17 dicembre 1537, la 297 del primo libro:
le, non sempre interamente dichiarata in quelle parole» (GIAMBULLARI 1986: 278).
PAOLO MARINI
74
Io non mi son tolto da i andari del Petrarca, né del Boccaccio, per i-gnoranza, che pur so ciò che essi sono, ma per non perder il tempo, la pacienza, e il nome ne la pazzia del volermi trasformar in loro, non essendo possibile. Più pro fa il pane asciuto in casa sua, che l’accompagnato con molte vivande a l’altrui tavola. Io me ne vado passo passo per il giardino de le muse, non mai cadendomi parola che sappia di lezzo vecchino. Io porto il viso de l’ingegno smascarato, e il mio non sapere un’acca, insegna a quegli che sanno la elle e la emme. Tal che oggi mai doverebbe acquetarsi chi non crede che il cielo abbia migliore scola che il Dottrinale novellis. Imita qua, imita là, tutto è fava si può dire a le composizioni de i più; per la qual cosa i Lettori se ne vanno come i nimici de l’astinenzie ne l’appicarsigli una vigilia di quel-le bestiali a le spalle. «Portatici altro che insalata», gridano color c’han fame.18
L’affrancamento dal principio di imitazione, presupposto cardine del classicismo selettivo di ispirazione bembiana, qui chiamato in causa con la menzione delle due corone, viene marcato attingendo a quel codice proverbiale che di per sé solo implica una scelta di campo al-ternativa e, insieme, la costruzione di una nicchia professionale indi-pendente, in cui l’ossequio ai canoni della tradizione non riveste alcun valore. Quale miglior risposta da opporre alla retorica artificiosa degli epigoni di Petrarca e Boccaccio che l’acutezza disarmante di un pro-verbio vulgato e per di più attinto dall’esperienza del quotidiano? «Più pro fa il pane asciuto in casa sua, che l’accompagnato con molte vivande a l’altrui tavola».19
La brevità icastica dell’enunciato, autonomo dal punto di vista sin-tattico e, tuttavia, perfettamente vincolato al contesto senza bisogno di connettivi, in virtù soltanto di tramiti argomentativi impliciti, dà la stura alla verve aretinesca, che si esibisce in un pezzo di repertorio in-farcito di materia proverbiale. Il tutto funzionale a ribadire la piena e immediata attuazione della scelta stilistica appena proclamata. Se-guono così, a cascata, il rifiuto del lessico cavato dal fiorentino aureo che «sappia di lezzo vecchino», a sostegno dell’opzione della lingua
18 Lettere: I, 409. 19 Si veda la registrazione in GIUSTI 1853: 168. Il primo emistichio del
proverbio è costituito da un endecasillabo.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
75
viva;20 la presa di distanza dalla cultura scolastica con l’assunzione della maschera del saggio ignorante nella frase proverbiale «Non sa-pere un’acca»,21 di cui Aretino da vero auctor in materia può permet-tersi di proporre uno sviluppo autonomo («insegna a quelli che sanno la elle e la emme»); l’ulteriore stoccata alla mentalità pedantesca col rinvio a un testo simbolo quale la grammatica di Alessandro di Ville-dieu, allusa nel sintagma latino Dottrinale novellis;22 la denuncia, col
20 Probabile adattamento dell’espressione lezzo caprino alla polemica anti-
classicistica contro il vecchiume della tradizione. Per lezzo caprino si vedano GDLI: s.v. caprino, 3; l’attestazione negli Amori pastorali di Dafni e Cloe di An-nibal Caro che ricavo da BibIt e, soprattutto, l’occorrenza aretiniana di Sei giornate: 205 rr. 24-25.
21 Cfr. GDLI: s.v. acca, 2. Si veda l’espressione affine «sapere due acche» di Filosofo: II, 7, 1.
22 Il sintagma latino è confezionato secondo la consueta prassi del cita-zionismo aretiniano (cfr. BECCARIA 2010: 29 e n. 23). Il principio di vischiosi-tà dei processi intertestuali osservato nell’opera di Ariosto (cfr. SEGRE 1966: 57-58) si apprezza bene anche nella produzione di Aretino, che, anzi, su questo meccanismo connaturato al funzionamento della memoria letteraria costruisce un gioco parodico corrosivo dell’armamentario culturale alto me-diato dalla lingua latina (sia essa veicolo della tradizione biblica e ecclesia-stica o della letteratura classica). La menzione del Dottrinale si trascina dietro la coda del primo esametro della grammatica che gli studenti imparavano a memoria: «Scribere clericulis paro Doctrinale novellis» (DE VILLA-DEI 1974: 7). In Marescalco: III, 10, 1 questo verso è messo in bocca al Pedante che, come specifica la didascalia, entra in scena addirittura «cantando» l’incipit del Dot-trinale. Altrove lo stesso tipo di trattamento del latino produce la nominaliz-zazione di interi sintagmi proverbiali, come nel caso di «omnia vincit amor» per "amore" (Pronostico dello anno MDXXXIIII, in Operette politiche e satiriche: 175, 181; Marescalco: V, 6, 2), formula altresì impiegata col valore gnomico originario (Filosofo: II, 9, 1; cfr. WALTHER 1963-1969: n. 20.097 e TOSI 2011: 179). Infine, a fianco di sintagmi sostantivati a seguito di una risemantizza-zione della tessera latina (si pensi al diffuso «leva eius» per "fuga" (Cortigia-na 1534: I, 11, 1; Marescalco: III, 15, 1; Sei giornate: 225 rr. 16 ss.), generato dall’incrocio del versetto «laeva eius sub capite meo», Cantico dei cantici, 2, 6, con levare), si incontrano sintagmi desemantizzati, parodia del procedimento mnemonico scolastico ed ecclesiastico, per la cui lettura si potrà utilmente ricorrere alle categorie di comico del significante definite in ALTIERI BIAGI 1980. È il caso dell’espressione «poeta que pars est» di Cortigiana 1525: Prol. 8,
PAOLO MARINI
76
proverbio «Tutto è fava»,23 della vanità di un’imitatio buona soltanto a produrre una massa di repliche indistinte; e, infine, il wellerismo "Por-tatici altro che insalata", gridano color c’han fame»,24 che sintetizza mirabilmente l’aspirazione di Aretino a farsi interprete dei gusti e del-le tendenze di un mercato editoriale avido di novità sostanziose.
In un’altra lettera-manifesto della poetica aretiniana, la celeberrima a Gian Iacopo Leonardi sul sogno di Parnaso, parimenti ispirata ai ca-noni espressivi del vero e della natura, si ha la possibilità di assistere alla nascita di un wellerismo che rappresenta nel contempo un caso notevole di memoria interna all’opera aretiniana:
Ma eccomi in uno albergo fatto a posta per chiapare gli assassini de la poesia. Come io fui dentro non mi potei tenere di non esclamare: «Chi non è stato a la taverna, non sa che paradiso si sia, disse il Cappa».25
L’atmosfera burlesca della lettera consente ad Aretino di gettare un ponte in direzione della commedia. Il «Chi non è stato a la taverna, non sa che paradiso si sia», attacco, nella Cortigiana del 1534, di un a solo memorabile del Cappa su un tema topico del repertorio del servo come quello del cibo e della fame atavica, che attanaglia l’umanità do-lente del tinello,26 diventa qui, attraverso l’estrapolazione welleristica,
dove il termine poeta trascina con sé il ricordo fonico cantilenato di un passo del cosiddetto Donatello, riduzione a uso scolastico dell’Ars minor di Donato («Poeta quae pars est? Nomen est»).
23 Cfr. MONOSINI 2010: 320; GDLI: s.v. fava, 7. L’andamento colloquiale del contesto («Imita qua, imita là...») induce anche qui a riconoscere nel materia-le proverbiale una costola di quel codice linguistico naturale di cui la simula-zione di parlato è funzione primaria.
24 L’immagine dell’insalata non rinvia qui al tradizionale campo seman-tico della mescidanza, ma piuttosto a quello della povertà di un piatto poco allettante e per nulla nutriente, cui allude il proverbio riportato in TB: s.v. insalata: «L’insalata non fa collottola (non fa ingrassare)».
25 Lettere: I, 385 (6 dicembre 1537). 26 Si noti che in Cortigiana 1525: II, 1, 1 la stessa frase veniva pronunciata
da Rosso nella battuta iniziale di una scena a due che coinvolgeva lo stesso Cappa. In SPERONI 1953: n. 46 è invece censito un wellerismo affine pronun-ciato da Rosso in Cortigiana 1534: III, 8, 2: «Dolce cosa è la taverna, disse il Cappa».
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
77
espressione della voce dell’io autoriale alla prese con la definizione del proprio profilo di poeta e di profeta del naturale che culmina, po-che pagine dopo, nell’incoronazione al cospetto di Apollo. Le commedie Veniamo allo specifico del teatro aretiniano. Qui, in linea con mecca-nismi consolidati della tradizione comica volgare, la materia prover-biale risulta impiegata nella coloritura dello scontro tra codici lingui-stici animato dalla contrapposizione basso-alto, che prende volta a volta corpo nella dialettica servo-padrone, povero-ricco, incolto-colto, giovane-vecchio ecc. In tutti questi casi la lingua delle figure subalter-ne, paradossalmente dotate di una lucida intelligenza dell’azione sce-nica, si colora di una speciale venatura proverbiale che conferisce con-cretezza e verità al loro argomentare, appagando nel contempo le at-tese del pubblico. Come ha ben sintetizzato Maria Luisa Altieri Biagi, «il servo deve agire da servo [...] e deve parlare da servo, con un lessico tutto caratterizzato in senso popolare, con quella impotenza sintattica che si rivela nella brevità delle frasi giustapposte, nelle ridondanze, nello sfruttamento di elementi linguistici cristallizzati, pronti per l’uso (proverbi, locuzioni popolari, imprecazioni ecc.)».27
Il che non impedisce che il servo possa occasionalmente pronun-ciare sentenze anche attingendo al patrimonio sapienzale illustre. Ma, nel rispetto dei principi di decoro propri della poetica degli stili, si tratterà di norma di un prelievo da un repertorio vulgato e condiviso piuttosto che di apprendimenti libreschi. Questo almeno sembra e-mergere dalla palinodia giocosa sviluppata nella lettera a Francesco Angelo Coccio dell’aprile 1548 e ripresa nella singolare lettera «A i comici antichi» del maggio dello stesso anno. Senza indugiare in di-stinzioni tra enunciati proverbiali e sentenziosi, Aretino si dichiara pentito di non aver creduto la voce del servo capace di una funzione gnomica complessa:
Io a tutti i propositi de le comedie, ho sempre tassato i loro autori, cerca il porre in ciascun proposito le sentenzie in bocca de i servi; parendomi che male osservassero il decoro ne le qualità di tali. [...] ecco Lucietta e
27 ALTIERI BIAGI 1980: 20.
PAOLO MARINI
78
Madalena, una badessa de la mia cocina, e l’altra governatrice de la mia camera, che mi chiariscono del tutto. Conciosia che quella nel sot-tosopra gettarsele una paneruzzola piena di frascariuole, gridò contra colei che disavedutamente versolle: «La discrezione è madre de la vir-tù»; e questa [...], nel dirle io: «Perché stai tu sì muta?», «Perché – rispo-semi ella – il tacer non si scrive». Ponendosi poi meco in ciarlia isfoderò tanti proverbi fuor de la lingua, che mi avvidi che non senza quale chi gli introduce in la scena, gli fa parlar come parlano. Imperoché l’uso gli insegna a tenere a mente ciò che sentano da qualunche bene e mala fa-vella.28 [...] ho chiesto perdono a la memoria di tutti quanti i nomi vostri immorta-li, nel caso de la mia ignoranza, circa il ridermi del poco giudizio che mi pareva che aveste in porre in bocca de i servi cotante gravi senten-zie. Ma sentendole tuttavia fioccare da la lingua d’una mia balia, come la neve, a falde, in ginocchioni ve ne domando venia. «L’amore è com-pagno de la riverenza», «la vergogna è tintura de la virtù», «il compra-re insegna a vendere», «chi dice mal d’altri, non loda sé», «l’aspetto scopre il core». [...]. E dimandandole io chi sì belle chiacchere le aveva insegnate, mi rispose: «Il mercato», inferendo che i proverbi sono co-muni a ognuno.29
Fatto sta che nel vivacissimo dialogo della Cortigiana in cui il giovane cameriere Flaminio istruisce il vecchio Sempronio sulla decadenza della corte e sulle mutate condizioni di vita dei cortigiani, è per l’appunto il primo a farcire le proprie battute di sintagmi e frasario proverbiali mentre il secondo se ne astiene pur comprendendone il significato:
FLAMMINIO. Udite questa. I nostri padroni hanno trovato il mangiare una volta il dì, allegando che duo pasti gli occide; e fingendo far la sera colatione alzano il fianco solus peregrinus in camera. E questo fanno non 28 Lettere: IV, 296. I contenuti di queste due lettere sono discussi in FALA-
SCHI 1977: 199-200. Segnalo che nella Zucca la sentenza «La discrezione è madre de la virtù» viene messa in bocca proprio ad Aretino (DONI 2003: 129; già in NANI MIRABELLI 1514: 127r col. a: «discretio omnium virtutum mater esse dignoscitur»).
29 Lettere: IV, 344; Il proverbio «il comprare insegna a vendere» è registra-to in MONOSINI 2010: 384.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
79
tanto per parer sobri, quanto per cacciar via qualche virtuoso, che si va intrattenendo alla lor tavola. SEMPRONIO. Si contano pur miracoli d’i Medici. FLAMMINIO. Una fronde non fa primavera. SEMPRONIO. Così è. [...] SEMPRONIO. Perché tu ridi? FLAMMINIO. Perché stanno in conclavi utriusque sexus, e dalla mucciaccia e dal mozzo mui lindo e agradables si fanno legger philosophia.30
La scioltezza d’eloquio esibita da Flaminio si sostiene su una sintag-matica che rispecchia la sua organicità al sottobosco della Roma medi-cea. Della corte, infatti, egli può esibire una conoscenza di prima ma-no, evidente anche nella padronanza dell’impasto linguistico in uso in quel contesto. Si susseguono a breve distanza la frase proverbiale "al-zare il fianco", 'riempirsi la pancia',31 cui si affianca la tessera latina so-lus peregrinus ricavata dall’episodio evangelico di Emmaus narrato in Lc, 24, 18, qui, al solito, risemantizzata con allusione ironica al fatto che gli unici fianchi ad alzarsi siano in realtà quelli dei padroni.32 Se-gue il proverbio «Una fronde non fa primavera», che stronca sul na-scere l’entusiasmo del vecchio credulone, costretto seduta stante a ri-conoscere la verità delle parole di Flaminio con una formula assevera-tiva («Così è») che esprime la condivisione di un codice linguistico non usato ma compreso alla perfezione da Sempronio. Per finire con la battuta di Flaminio che svela impietosamente la depravazione pra-
30 Cortigiana 1534: II, 6, 8-9; significativo l’ampliamento della scena in
confronto alla corrispettiva di Cortigiana 1525: II, 5. 31 Tra le varie occorrenze aretiniane «Vivian vivachiava a scrocco in cor-
te, | con tutti alzando il fianco a corpo sciolto» (Astolfeida: I, 24, 1-2); «alzato il fianco come lo alza uno alloggiato a discrezione, ritornaro alla vigna» (Sei giornate: 49 rr. 13-14); «E rassettandomi l’appetito ne lo stomaco, deliberava di alzare il fianco per una volta» (Lettere: I, 385 rr. 45-46); «alzeremo il fianco a la prelatesca» (Talanta: II, 1, 5). L’espressione è registrata in GDLI: s.v. alza-re, 5. Notevoli per la diffusione in ambito burlesco due attestazioni ricavate tramite BibIt dal secondo capitolo Del bisogno di Agnolo Bronzino e dal capi-tolo In lode della sete di Agnolo Firenzuola.
32 Il sintagma è registrato in TONELLO 1970: 286.
PAOLO MARINI
80
ticata nelle segrete stanze dei signori col ricorso al sintagma latino «in conclavi utriusque sexus»33 e alle tessere lessicali spagnole.34 Lo scontro tra codici linguistici può esprimersi anche in forma più vio-lenta, come nel caso dei dialoghi fra il servo e il padrone innamorato. Si arriva talora al limite dell’incomunicabilità, del dialogo fra sordi, come nella scena della Cortigiana che culmina in un’accusa reciproca di pazzia tra Rosso e Parabolano:
PARABOLANO. [...] è dolce cosa l’amare et essere amato. ROSSO. Dolce cosa è la taverna, disse il Cappa. PARABOLANO. Dolce sarà Livia! ROSSO. Son fantasie: io per me faccio più stima d’un boccal di greco che d’Angela Greca. PARABOLANO. Se tu gustassi l’ambrosia che stillano l’amorose bocche, i vini ti parrebbeno amari a comparatione. ROSSO. [...] io n’ho gustate la parte mia, e non ci trovo la melodia che ci trovate voi. PARABOLANO. Altro sapore hanno le gentil madonne. ROSSO. È vero, perché non pisciano come l’altre. PARABOLANO. È pazzia a parlare. ROSSO. È pazzia a rispondere [...].35
I due versanti dell’edonismo linguistico cozzano qui rumorosamente, generando uno straordinario effetto comico: da una parte la logorrea petrarchevole di Parabolano (nomen omen), dall’altra l’espressività sguaiata del servo, anche qui intrisa di fraseologia proverbiale bassa al
33 L’espressione, ricavata dal latino ecclesiastico (cfr. ancora TONELLO
1970: 286), ricorre nel Pronostico del 1534 (Operette politiche e satiriche: 175, 181). La chiara allusività di utriusque sexus nei passi della Cortigiana e del Pronostico all’area semantica dell’omosessualità o della bisessualità induce a spiegare utriusque ‘deretano’ di Sei giornate: 24 r. 16 proprio a partire da que-sta espressione; Aquilecchia glossa invece «propriam., per dev.[iazione] sem.[antica], ‘l’una e l’altra natica’» (ibid.: 581).
34 Il passo fa tornare alla memoria un contesto “comico” delle Satire ario-stesche, quello di II, 70-93, con la scena dell’anticamera. Sulle forme e i signi-ficati dell’impiego del lessico spagnolo cfr. BECCARIA 1985: 282-291.
35 Cortigiana 1534: III, 8, 2-3. Analoghe dinamiche nel dialogo fra il servo Biffa e il padrone innamorato Armileo in Talanta: III, 18.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
81
limite dell’osceno.36 Nella migliore delle ipotesi si procede rovescian-do l’affermazione dell’interlocutore, come nelle prime tre battute. Pa-rabolano attacca con la sentenza «Dolce cosa è l’amare et essere ama-to» di sapore, forse, agostiniano.37 Rosso risponde da par suo con un wellerismo che sposta beffardamente l’obiettivo, per così dire, dal cuore al ventre. Si procede così sino alla nuova sentenza di Parabolano («Altro sapore hanno le gentil madonne») che colpisce il nervo sempre scoperto della differenza di classe, rimarcando la superiorità delle no-bildonne rispetto alle pari grado di Rosso. Il quale risponde piccato col costrutto antifrastico «È vero, perché non pisciano come le altre», che parafrasa un’espressione proverbiale impiegata anche nelle Sei giornate proprio a proposito dell’uguaglianza ab origine di tutte le femmine.38
La fraseologia proverbiale è funzione talmente connaturata alla e-spressività del servo che Rosso si esibisce, non senza un certo compia-cimento, in vere e proprie sequele in cui si arriva persino a giocare sul-la canonica formula introduttiva «dice il proverbio».39 Così in un suo a solo della Cortigiana del 1525:
ROSSO. Chi la fa, l’aspetti, dice l’avverbio; e chi asino è e cervio essere si crede, perde l’amico e dinari non ha mai. So ch’io t’ho reso pan per fo-caccia [...].40
La stessa storpiatura, evidente richiamo burlesco al lessico grammati-cale, viene messa in bocca anche al fornaio Arcolano, che nella Corti-giana del 1534 sentenzia: «Chi ha capre, ha corna: tutti gli avverbi son
36 Siamo di fronte a un meccanismo comico ampiamente sfruttato in tut-
to il teatro rinascimentale (cfr. ALTIERI BIAGI 1980: 5-6, 13). In precedenza Rosso si era già cimentato in un a solo parodico del frasario petrarchesco di Parabolano (Cortigiana 1534: II, 4); si veda in proposito TONELLO 1970: 249.
37 Cfr. AGOSTINO, Conf., III, 1, 1: «Amare et amari dulce mihi erat magis». 38 «La vita visse sempre a una foggia [...] e sempre pisciaro le donne per
il fesso» (Sei giornate: 9 rr. 3-4); «Chi piscia come le altre è come le altre» (i-bid.: 121.20).
39 La storpiatura della formula è segnalata in TRIFONE 1994: 111. 40 Cortigiana 1525: IV, 4, 1.
PAOLO MARINI
82
veri».41 Le due occorrenze aretiniane di «dice l’avverbio» comportano in realtà la ripresa di una tessera comica tra le più diffuse nella coeva commedia rusticale senese.42 E non sarà allora privo di significato che l’attacco della battuta di Rosso nella redazione del 1534 venga tra-sformato in una sorta di wellerismo che chiama in causa proprio l’auctoritas di uno dei principali interpreti del teatro villanesco di Sie-na, Leonardo Maestrelli detto Mescolino:
ROSSO. «Chi asino è et cervio esser si crede, perde l’amico e denar non ha mai», disse Mescolino da Siena. Io t’ho pur renduto pan per ischiac-ciata, ser Zugo.43
I debiti contratti dall’Aretino commediografo nei confronti del milieu senese sono già stati opportunamente segnalati.44 Non va del resto dimenticato che in quel contesto culturale Pietro si è formato e, in qualche modo, continua a vivere anche a Roma nella brigata stretta
41 Cortigiana 1534: IV, 10, 1. La chiosa «tutti gli avverbi son veri», a sua
volta proverbiale, rinvia a quella stessa fede cieca nel repertorio paremiolo-gico comune a tutti i personaggi di bassa levatura sociale della commedia, non solo aretiniana, e che si ritrova, a esempio, tra i fondamenti della precet-tistica della Nanna.
42 Cfr. Coltellino, v. 354 (Commedie 2004: 44); La partigione, v. 275 (ibid.: 73); Il targone, v. 535 (ibid.: 103); Commedia di Pidinzuolo, v. 451 (ibid.: 133, segnala-ta in ALTIERI BIAGI 1980: 38). Avverbio per proverbio ricorre anche nell’incipit del capitolo Ravanello villano segnalato in MAZZI 1882: 271 e nelle Stanze vil-lanesche (30, 1) attribuite a Celso Cittadini in FANFANI 1864: 44.
43 Cortigiana 1534: IV, 4, 1. Cfr. GIUSTI 1853: 33; SPERONI 1953: n. 185. Il proverbio non trova tuttavia riscontro nelle opere note di Mescolino. Ho spogliato senza successo sia i testi raccolti in Commedie 2004 sia l’Egloga II overo farsetta di kal. di maggio, Siena, S. Nardi, 1519 (CNCE 69570; esemplare della Biblioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana, 130 b 12); l’Egloga pastorale di maggio, s.n.t. (CNCE 63538; esemplare della Biblioteca nazionale di Firenze, Palat. E 6 7 58 I, int. 17), l’Egloga rusticale di Piera, Siena, S. Nardi, s.d. (CNCE 64696; esemplare della Biblioteca nazionale di Firenze, Palat. E 6 7 58 II, int. 3) e il Trionfo di Pan dio de pastori opera rusticale, Siena, G. Landi, 1546, stampato insieme con una commedia dello Strascino (CNCE 8796; e-semplare della Biblioteca apostolica Vaticana, Chig. VI 1132 1, int. 13).
44 Si vedano in particolare CLUBB 1995 e PIERI 2010: 18-19, 32-39.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
83
sotto l’ala protettiva di Agostino Chigi. È opportuno tuttavia rilevare nelle commedie senesi e nel capolavoro aretiniano una comune predi-lezione per lo stravolgimento giocoso dei sintagmi rigidi apprezzabile, oltre che nella storpiatura della formula introduttiva, anche nel rove-sciamento logico-concettuale degli stessi enunciati proverbiali.45 Si legga, a esempio, questo passo dell’anonima Commedia di Pidinzuolo:
Dice l’averbio: chi vence la dura, el colpo per un arbol non s’achina, e negrigenti aita la ventura.46
A un gusto analogo per la rottura degli schemi cristallizzati della tra-dizione paremiografica andrà ricondotto il passo della Cortigiana del 1534 in cui viene prospettata la necessità di ingoiare delle pillole a un riluttante Messer Maco in procinto di esser trasformato in cortigiano:
MAESTRO ANDREA. Noi siamo d’accordo del prezzo, e messere, con ani-mo sanese, si arrischierà di pigliar pillole. MESSER MACO. Le mi mettono un gran pensier, mi mettono. MAESTRO MERCURIO. Pilolarum romanae curiae sunt dulciora. GRILLO. Scherzate co santi e lasciate stare i fanti. MESSER MACO. Perché dici tu cotesto? GRILLO. Non odite che il medico bestemmia come un giocatore?47
È appena il caso di notare che Maco e, verosimilmente, il suo fami-glio vengono da Siena. Fatto sta che nel solito scontro di codici lin-guistici che anima l’azione, Grillo fraintende il latinorum del medico e, credendo che questi si sia prodotto in una bestemmia, segnala l’infrazione capovolgendo ad hoc il proverbio vulgato «Scherza coi
45 Un simile gusto per il rovesciamento dei sintagmi proverbiali si riscon-
tra in un epigono di Aretino quale Girolamo Ruscelli. Si veda, a esempio, l’espressione «zucca in sale» che chiude un brano dell’avviso ai lettori del Tempio stilisticamente improntato a una vis polemica di chiara marca areti-niana, con tanto di rinvio esplicito a una battuta di Messer Maco nella Corti-giana (cfr. RUSCELLI 2011: 107-108).
46 Commedia di Pidinzuolo, vv. 451-453 (Commedie 2004: 133). 47 Cortigiana 1534: IV, 1, 1.
PAOLO MARINI
84
fanti e lascia stare i santi».48 Non siamo però, a ben vedere, di fronte a un mero espediente comico in sé concluso. Questo, almeno, mi pare si possa ricavare dal prosieguo della scena, quando Maestro Andrea im-pone a Messer Maco un giuramento solenne, da compiere nientemeno che sul nome di Dio:
MAESTRO ANDREA. Altro non c’è da fare se non che giuriate, quando sa-rete fatto cortigiano e cardinale, di farmi carezze; perché non è sì tosto uno entrato in corte che muta verso, e di dotto, savio, e buono, diventa ignorante, pazzo e tristo. [...] MESSER MACO. Volete vuói ch’io dica di Domeneddio? MAESTRO MERCURIO. Co’ santi e lasciate stare i fanti, disse dianzi Grillo. MESSER MACO. Io vo’ contentare il maestro, voglio. MAESTRO ANDREA. Non vi ho io detto che la bestemmia è necessaria al cortigiano? MESSER MACO. Sì, ma egli m’era scordato, m’era.49
La ripresa della battuta di Grillo chiarisce così che la logica stravolta del proverbio rovesciato è in realtà specchio fedele di quel particolare mondo alla rovescia rappresentato dalla corte romana. Chi entra a far parte del suo universo da «dotto, savio, e buono, diventa ignorante, pazzo e tristo» e deve imparare alla svelta a scherzare coi santi, visto che in tale contesto la bestemmia, lungi dall’essere proibita, diventa addirittura tramite espressivo necessario. Di paradosso in paradosso, il ripristino della corretta sequenza del proverbio è affidata nelle Sei giornate alla precettistica ruffianesca della Comare che, forte di un con-formismo attento a non scalfire gerarchie e istituzioni tradizionali, rimprovera severamente la Balia riconducendola all’ordine:
BALIA. La mi par la novella dei boti.
48 Si veda in proposito TONELLO 1970: 239: «La massima popolare ormai
cristallizzata ed esattamente prevedibile, viene stravolta e caricata così di una tensione blasfema che avrà il suo svolgimento qualche battuta più avan-ti».
49 Cortigiana 1534: IV, 1, 4-5.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
85
COMARE. Non poniam la lingua nei boti, perché si dee scherzar con i fanti e non con i santi: e fai bene a darti ne la bocca, dicendone tua col-pa come tu fai.50
Nella messa in scena del Marescalco, sensibilmente lontana per temi e ritmi da quella della Cortigiana, si assiste a una condivisione della sin-tagmatica proverbiale che accomuna quasi tutti i personaggi della cor-te mantovana, dai servi alle figure di rango più elevato, tutti in realtà ugualmente sottomessi all’arbitrio del duca e, per conseguenza, com-plici del sadico rituale burlesco celebrato ai danni del protagonista. Nemmeno qui, tuttavia, Aretino rinuncia alla funzione comica che si origina dalla frizione dei codici linguistici caratteristici delle diverse maschere. Si osservi, a esempio, questo scambio di battute tra il Ra-gazzo e il Pedante:
RAGAZZO. Io vi intendo, io vi ho per il becco, sì, sì. Voi eravate seco a i ferri per conto de la in mulieribus, eh? PEDANTE. Tu lo hai detto, tu dixisti. RAGAZZO. Beh! Torralla o non la torrà? PEDANTE. Spero in Dio che lo legherò con tanto efficaci ragioni che lo piegheremo, perché verba ligant homines, taurorum cornua... RAGAZZO. I par tuoi! PEDANTE. ...funes, idest vincula. RAGAZZO. Oh buono! PEDANTE. Tu non penetri sì acuto senso. RAGAZZO. Come no? PEDANTE. Madenò. RAGAZZO. Non dite voi che gli uomini legano l’erba e le funi i pazzi? PEDANTE. Ah, ah!51
L’incomprensione totale tra i due scatena alla fine il riso del Pedante – oltre che, s’intende, del pubblico –, ma l’esito è già scritto in partenza nella distanza incolmabile fra i registri espressivi. Da una parte il ser-vo cadenza il discorso con tratti mimetici del parlato («sì, sì») proce-dendo a forza di frasi proverbiali di matrice bassa («vi ho per il bec-co», «eravate seco a i ferri») condite dal sintagma latino in mulieribus,
50 Sei giornate: 350 rr. 13-16. 51 Marescalco: I, 11, 2.
PAOLO MARINI
86
ricavato dall’Ave Maria e, al solito, risemantizzato e nominalizzato.52 All’opposto, il Pedante insiste nel suo incedere magniloquente sempre sostenuto sull’asse di un bilinguismo che pende, appena possibile, verso il formulario latino colto, qui rappresentato dal proverbio «Ver-ba ligant homines, taurorum cornua funes».53 Davvero emblematica di tale distanza è l’adozione di una sorta di volgare standard, a grado zero di figuralità, che viene introdotto, a mo’ di lingua franca, per con-fezionare una sorta di traduzione dei rispettivi codici, altrimenti non comunicanti: «Io vi intendo, io vi ho per il becco», «Tu lo hai detto, tu dixisti».
Il proverbio latino al centro del misunderstanding, portato della e-rudizione scolastica del Pedante, offre tra l’altro il destro per una pun-tualizzazione mai abbastanza marcata.54 Dall’opera di Aretino non è esclusa una sintagmatica proverbiale di matrice colta individuabile, a esempio, tra gli ingredienti della retorica artificiosa caratteristica della maschera comica dell’innamorato. Si osservi questo a solo di Prelio nell’Ipocrito:
PRELIO. Lo avviso, che ha dato costui, riducano in calma la procella, che tempestandomi intorno accennavano di rompere la mia vita ne gli sco-gli de la perdizione. Onde da che io compresi ciocché si fussero pensie-ri non sentii mai riposo simile a questo che ora riduce i miei nel porto de la quiete [...]. Peroché mi era durissimo stimolo il volere triomfare di quel voto, che la valorosa diligenzia mia aveva vinto, pugnando con lo esercito de le difficultà, che a chi ama è facile l’impossibile.55
Notoriamente, la metaforica della nave in tempesta di cui Prelio infar-cisce il suo frasario proverbiale («Riducano in calma la procella», «Rompere la mia vita ne gli scogli de la perdizione», «Riduce i miei
52 Il sintagma ricorre in Sei giornate: 267 rr. 8-9. 53 Cfr. WALTHER 1963-1969: n. 33.064. 54 Si veda però RUOZZI 2011: 30: «La produzione gnomica, non solo uma-
nistica e rinascimentale, interseca costantemente piani alti e bassi, confron-tando la saggezza popolare con quella colta»; in proposito anche TOSI 2011.
55 Ipocrito: V, 5, 1.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
87
nel porto de la quiete») «è cosa tutta letteraria».56 E anche la sentenza conclusiva, «A chi ama è facile l’impossibile», potrebbe vantare illustri ascendenti classici.57 D’altro canto, al polo opposto della questione, non deve stupire che, all’occorrenza, proverbi vulgati possano essere messi in bocca a figure appartenenti a un livello più alto della gerar-chia sociale. Il meccanismo doveva tra l’altro replicare, magari nella forma ipercaratterizzata tipica della trasposizione comica, una situa-zione di fatto esperibile nella quotidianità. Mentre l’espressione lin-guistica del servo era di norma limitata dal suo stesso stato di minori-tà culturale all’ambito del “popolare”, il signore dotato di un buon li-vello di istruzione disponeva di ampie possibilità di variazione del re-gistro stilistico colloquiale sull’asse natura-artificio, tali da consentirgli una fruizione sia passiva che attiva dell’intero repertorio proverbiale. Questo fenomeno si apprezza molto bene nella scena che introduce l’agnitio risolutiva dell’Ipocrito. Brizio accusa Tanfuro di essersi inta-scato la collana, che, invece, il servo ha consegnato nelle mani di colui che credeva essere Brizio, ossia il simillimo Liseo:
BRIZIO. Tu sai il proverbio del chi fura pecca una volta, e chi si lascia furar, mille. TANFURO. Io per me vi ho restituito la catena e le perle, che mi facevate portare adosso. [...] BRIZIO. Penso, ripenso, e pensando e ripensando ti so dare una buona novella. TANFURO. Sì, crucifiggete le genti, e poi basciategli le piaghe. BRIZIO. La mia mente traendo le frecce de la considerazione con l’arco del pensiero ha dato nel segno.58
Non c’è nemmeno bisogno di esplicitare l’accusa: Brizio fa leva sulla pregnanza brachilogica del proverbio «Chi fura pecca una volta, e chi
56 BRAMBILLA AGENO 2000c: 422. La metaforica della nave in tempesta è
censita in CURTIUS 1992: 147-150, 487, 511-512. 57 Si pensi al ciceroniano «Nihil difficile amanti» di Orator, X, 33 (cfr.
WALTHER 1963-1969: n. 16.630a). 58 Ipocrito: IV, 20, 1-2.
PAOLO MARINI
88
si lascia furar, mille»59 con la certezza di essere inteso alla perfezione da Tanfuro («Tu sai...»), che, infatti, reagisce subito protestando la propria innocenza («Io per me vi ho restituito la catena...»). Questa in-cursione nel repertorio caratteristico del servo conferisce incisività e concretezza all’argomentare di Brizio, il quale, tuttavia, qualche battu-ta dopo non ha nessuna difficoltà a tornare a esprimersi in termini ar-tificiosamente astratti («le frecce de la considerazione», «l’arco del pensiero») ordinati per metafore complesse («La mia mente [...] ha da-to nel segno»).
Per Tanfuro, invece, come per le altre figure umili dell’universo comico aretiniano, il proverbio costituisce uno dei vertici di un oriz-zonte culturale angusto, stretto nei limiti delle poche nozioni utili alla sopravvivenza quotidiana. Lo stesso orizzonte su cui, non a caso, si orienta la ruffiana Gemma alle prese con un progetto didattico, di-remmo, di scuola popolare per fanciulle, che potrebbe far concorrenza a quello della Nanna e della Comare:
GEMMA. È forza s’io voglio vivacchiare di tenere un pocolino di scuola: dieci bamboline mi bastano, a le quali insegnarò la «Santa Croce fatimi bene imparare», a dire de i proverbi, a infilare gli aghi, a contare il pa-ne che va al forno, a benedire la tavola, a fare le riverenzie, a stare cor-tesi.60
Come a dire che nel profilo professionale di una futura serva, o poten-ziale cortigiana, l’alfabetizzazione di base conta né più né meno che l’acquisizione di una certa destrezza nei lavori domestici e di un tocco di galateo alla buona, e si spinge al massimo, sul versante della parola parlata, al dominio del repertorio proverbiale e delle orazioni, e
59 GIUSTI 1853: 118: «Chi ruba, pecca uno; chi è rubato, pecca cento»; an-
che se non credo che la spiegazione offerta da Giusti – «Perché sospetta di molti, e fa giudizi temerari» – illustri l’accezione che Aretino intendeva met-tere in bocca a Brizio, il cui peccato sembrerebbe piuttosto quello di avere mal riposto la propria fiducia, facendosi così fregare da Tanfuro.
60 Ipocrito: II, 16, 1.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
89
sull’altro, quello della parola scritta, ai manuali per principianti come la Santacroce.61 Le Sei giornate Uno dei cardini del sistema etico proposto dalla Nanna consiste preci-samente nella fede incondizionata riposta nei proverbi e nel messag-gio di verità genuina di cui questi frammenti di vox populi cristallizza-ta sono latori.62 Antonia, sua allieva zelante, dimostra di avere assimi-lato bene la lezione aprendo la seconda giornata sulla vita delle mari-tate con un proverbio che sintetizza mirabilmente la prima, dedicata alla condotta scandalosa delle monache:
Veramente son chiara delle suore [...]. E poi i proverbi non sono da far-sene beffe, e bisogna credere a quello che dice che le suore son le mogli dei frati, anzi del popolo; e non pensai a tal detto ieri, che non ti arei dato lo impaccio che ti diedi in farmi contare gli andamenti loro.63
Nella cadenza gnomica che caratterizza la retorica della Nanna si può, peraltro, osservare in prospettiva l’esito di una costante isolata da
61 Sul cui specifico rinvio a LUCCHI 1978: 602-605. La formazione del sin-
tagma «Santa Croce fatimi bene imparare» («giaculatoria da scolaretto» se-condo INNAMORATI 1962: 90) è analoga a quella osservata sopra alla n. 22 per il Dottrinale novellis.
62 Cenni sulla funzione del repertorio proverbiale nel tessuto stilistico delle Sei giornate si leggono in TESTA 1991: 72, 76 e MARCONI 2011: 58-59.
63 Sei giornate: 49 rr. 16-28. La fede nel contenuto sapienzale dei proverbi è più volte esplicitata dai personaggi delle Sei giornate, convinti che in esso risieda una chiave sicura del quieto vivere degli umili, al riparo delle insidie del mondo (cfr. a es. «non esser mai prosuntuosa nei tuoi andari, e atienti al proverbio il qual dice “Non motteggiar del vero e non ischerzar che dol-ga”», ibid.: 200 rr. 14-16). Eppure la Nanna, da vera autorità in materia, può permettersi persino di mettere in dubbio la veridicità di un proverbio smon-tandone la logica interna in forza della propria esperienza di vita: «e son baie quelle che dicono che tanto caca un bue quanto mille mosche: perché ci sono più mosche che buoi, e per un gran maestro che ti venga in casa do-nandoti una buona posta, ce ne son venti che ti pagano di promesse, e mille di quelli che non son gran maestri che ti empieno le mani» (ibid.: 104 rr. 2-6).
PAOLO MARINI
90
Giuseppe Chiecchi nello specifico del Decameron.64 Superfluo dire che siamo di fronte a uno dei modelli di prosa più compulsati da Aretino, al di là dei proclami anticlassicistici di facciata.65 Nel capolavoro boc-cacciano la massiccia immissione nel discorso di sentenze e proverbi riguarda principalmente gli esordi e le conclusioni della singola unità narrativa, e ha una funzione sintetica utile a orientare la lettura della novella. Un fenomeno analogo è in certa misura apprezzabile anche nello svolgimento dialogico delle Sei giornate. Qui enunciati sentenzio-si e proverbiali marcano con i medesimi obiettivi inizio e fine delle u-nità narrative, costituite dalle lunghe sequenze in cui la dottrina della Nanna si esplica nella presentazione di una serie infinita di casi parti-colari in forma di micronovelle o di brevi sequenze normative di trat-tatistica comportamentale spicciola. Ciascuna di queste unità viene sintetizzata in una formula gnomica che può essere pronunciata diret-tamente dalla maestra oppure dedotta dall’allieva. Segue, di norma, conferma immediata dell’interlocutrice. Ecco un passaggio esemplare:
NANNA. Quanti denari ho io guadagnati con mettere in mezzo questo e quello! [...] NANNA. Per duo ducati feci intendere a uno come il suo nimico veniva due ore inanzi dì solo solo a corcarsi meco: che appostato da lui, fu ta-gliato a pezzi. ANTONIA. [...] Ma dimmi, perché ci veniva due ore inanzi dì?
64 «Parallelamente all’impiego strutturale delle sentenze che classificano
le novelle oppure, all’interno di queste, singoli segmenti del racconto, i pro-verbi diventano essi stessi indici paradigmatici della narrazione, e perciò si pongono in luoghi privilegiati, riservati dalla dottrina della dispositio alla dichiarazione delle funzioni narrative. L’exordium è, per eccellenza, il luogo in cui si compendiano le narrazioni e se ne anticipano gli scopi. Gli fa riscon-tro la conclusio che al momento di ricapitolare il materiale della narrazione, richiama alla memoria quelle stesse motivazioni che erano state anticipate nell’exordium. [...] In definitiva, il proverbio concorre con la sentenza a for-mare i princìpi orientativi della lettura del Decameron, nelle posizioni rile-vanti degli esordi e delle conclusioni, negli spazi autorevoli delle leggi e del-la morale dimostrativa» (CHIECCHI 1975-1976: 142, 147).
65 Sulla questione PATRIZI 1995 e PROCACCIOLI 2013.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
91
NANNA. Perché in quella ora si partiva da me uno altro che non ci po-teva restar più. Ma tu ti credi forse che si bene dormiva uno amoroso, che fosse solo a fregarmela, ah? Io mi levai mille volte da lato al merca-tante, fingendo scorrenza di corpo o di stomaco, e giva a contentare questo e quello nascoso per casa [...]. ANTONIA. Tutto è perduto quello che si lascia. NANNA. Non c’è dubbio [...].66 NANNA. [...] tu in cervello; e tacendo e parlando fa sì che il favellare e lo star queta paia bello ne la tua bocca; e accadendoti di rivolgerti ora questo e ora a quell’altro, miragli senza lascivia, guardandogli come guardano i frati le moniche osservantine; [...] e ne lo essere chiamata a cena, se bene sarai sempre la prima a lavarti le mani e andare a ta-vola, fattelo dire più d’una volta: perché se ringrandisce ne lo umi-liarsi. PIPPA. Lo farò.67
Nel primo caso Antonia condensa in una didascalia in forma di pro-verbio («Tutto è perduto quello che si lascia») il senso del racconto delle avventure della Nanna appena concluso. Anche qui, in linea con quanto già osservato nelle commedie, la condivisione del codice pa-remiologico si esplica nella classica formula di assenso («Non c’è dub-bio»).68 Nel secondo brano è la stessa Nanna a tirare le fila di un suo breve trattato di bon ton con la sentenza «se ringrandisce ne lo umiliar-si», che rinvia al tradizionale paradosso dell’umiltà, virtù cardine del sistema etico cristiano, qui svilita a banale maschera di etichetta. La spiccata propensione gnomica definisce anche lo stile della Comare che istruisce la Balia nella terza giornata del Dialogo. Nel passo che se-gue la osserviamo infilare una serie sentenza-proverbio-sentenza nella medesima, peraltro brevissima, battuta:
66 Sei giornate: 109 r. 24-110 r. 16. 67 Ibid.: 153 r. 23-154 r. 5. 68 Si veda supra l’analisi del passo di Cortigiana 1534: II, 6, 8: «FLAMMINIO.
Una fronde non fa primavera. SEMPRONIO. Così è». Numerosi i passi so-vrapponibili delle Sei giornate; tra i tanti: «NANNA. [...] Ed è chiaro che la fa-tica sta nel mantenersi gli amici, e non in acquistarsegli. PIPPA. Non ci è dubbio» (Sei giornate: 170 rr. 26-28).
PAOLO MARINI
92
COMARE. Pazienzia: non si pò esser santa e ruffiana insieme; e caso che ella paghi i debiti del corpo ne l’altro mondo, potrà pur dire «Chi gode una volta non istenta sempre»; e poi ci è tempo a pentirsi. BALIA. Egli è vero.69
Il dato è di per sé evidente e si impone anche dalla considerazione di questi pochi esempi: nelle Sei giornate la condivisione del patrimonio sapienziale dei proverbi tra le cinque attrici del dialogo è, se possibile, ancor più profonda che nelle commedie. Tra maestre e discepole, in-fatti, non sussiste alcuna differenza di livello sociale e identici risulta-no perciò i riferimenti culturali di massima. Alla Nanna basta talora accennare un proverbio per essere intesa al volo:
ANTONIA. Non ci son delle suore, delle maritate, delle vedove e de le puttane buone? NANNA. Coteste quattro generazioni son come il proverbio dei denari, senno e fede. ANTONIA. Stiamo bene adunque! Torna, torna alle nozze della cavalie-ra. [...] NANNA. Si suol dire «Dio mi scampi dalle mani dei villani». Ma ve-gnamo un poco in su le allegrezze.70
Come di consueto, in calce a uno degli infiniti inserti novellistici che punteggiano la struttura policentrica delle Sei giornate, la Nanna si serve delle cadenze gnomiche per ricavare dalla singola vicenda e-semplare – qui le nozze infelici della cavaliera con un villano – una serie di precetti di portata universale. La storia della vedova facoltosa che si risposa col villano le suggerisce in conclusione, prima di passare alla successiva “novella”, il modo di dire proverbiale «Dio mi scampi dalle mani dei villani». Poco prima, stimolata dal quesito dell’Antonia, aveva condensato la sua visione pessimistica sulla possibile persistenza di un barlume di bontà tra tutte le categorie dell’universo femminile nel pa-
69 Ibid.: 331 rr. 26-30. Passi ad alta densità gnomica come questi non scar-
seggiano nemmeno nel repertorio della Nanna. Si legga, a esempio, la sua battuta di pp. 103 r. 34-104 r. 11, nella terza giornata del Ragionamento.
70 Ibid.: 68 r. 31-69 r. 8.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
93
rallelo col proverbio «Denari senno fede | ce n’è manco l’uom crede».71 La certezza di essere intesa con la sola allusione del primo settenario le veniva confermata dalla deduzione istantanea dell’interlocutrice («Stiamo bene adunque!»), che addirittura, nel seguito del dialogo, rie-voca il passaggio, dimostrando così di averne colto appieno il senso.72 Ferma restando l’organicità del repertorio proverbiale popolare a un codice linguistico comune, non si può trascurare il fatto che questo e-nunciato composto da un distico di settenari a rima baciata appartiene a una categoria di proverbi popolari a più alto tasso di memorabilità.73 S’intende che l’ampiezza della diffusione di un proverbio è direttamen-te proporzionale all’incremento di questo tasso e che, in tale prospetti-va, un sintagma formulato col supporto di metrica, rima e, talora, per-sino canto risulterà tanto più radicato nel patrimonio espressivo della lingua viva. Le Sei giornate conservano due testimonianze significative di questa tipologia di proverbio cantilenato in cui la tradizione canzo-nettistica si fonde con quella paremiologica:
NANNA. Perché dice il canto figurato che
Chi s’alleva il serpe in seno le intervien come al villano: come l’ebbe caldo e sano, lo pagò poi di veleno.74
COMARE. [...] do in iscritto il conoscere il dì di San Pavolo converso, cioè:
S’è sole o solicello, noi siamo a mezzo il verno;
71 Cfr. GIUSTI 1853: 262. 72 «ANTONIA. È possibile che le buone sieno come i denari, senno e fede
che tu dicesti? NANNA. Sono» (Sei giornate: 88 rr. 30-32). 73 Sul distico nei proverbi cfr. quanto scrive Vittorio Cian in BEMBO 1888:
103-105. 74 Sei giornate: 224 rr. 32-36. Secondo Aquilecchia canto figurato "canto po-
lifonico" va inteso, qui come nell’altra occorrenza di p. 18 rr. 19-20, come «amplificazione scherzosa di canto». Si tratta di quattro ottonari canonici con accento di terza, a rime incrociate. Sulla «diffusione dei proverbi in canzoni popolari» testimoniata dal Decameron si è soffermato CHIECCHI 1975-1976: 134.
PAOLO MARINI
94
se fulmina o se piove, del verno siamo fore; s’è nebbia o nebbiarella, carestia o coticella.
Io non me ne rammento più, tanto è che non la dissi.75
Mi pare rilevante in questo secondo caso che la riflessione finale della Comare riguardi precisamente la memorabilità di un proverbio com-plesso, un tempo da lei praticato con maggiore frequenza («tanto è che non la dissi»), il cui possesso viene vantato tra le movenze espres-sive di un repertorio di «ipocresie» religiose che la mestierante con-sumata intende ora condividere con la Balia.
75 Sei giornate: 336 rr. 11-19. Il proverbio si compone di tre distici di sette-
nari in assonanza (prima e seconda coppia) e in rima (terza coppia). Sembre-rebbe trattarsi di una variante del diffusissimo «Per la Santa Candelora, | se nevica o se plora, | dell’inverno siamo fuora. | Ma s’è sole o solicello, | noi siam sempre a mezzo il verno» (GIUSTI 1853: 188). Del resto, la conversione di san Paolo viene celebrata il 25 gennaio, pochi giorni prima della Candelo-ra (2 febbraio). Il proverbio è censito da John Florio, che con ogni probabilità lo ricava dalle Sei giornate (FLORIO 1993: 243). Il distico finale «s’è nebbia o nebbiarella, | carestia o coticella» è recuperato da Giovanni Veneroni, che ne offre una spiegazione poco convincente. Da «coticella, petite couaine» si pas-sa a «coticella, pour abondance», sotto il cui lemma viene riportato il prover-bio, così illustrato: «c’est à dire que le brouillas est quelquefois cause de di-sette et quelquefois d’abondance» (VENERONI 1698: 208). All’opposto, secon-do Aquilecchia coticella vale «crosta sottile di terra, forse meton. ‘raccolto scarso’» (Sei giornate: 542), mentre in DU CANGE: s.v. coticella, si rinvia a cotel-la ‘couz pour aguiser’. Dovrebbe dunque trattarsi di un diminutivo da una base CUTEM ‘cute’ o COTEM ‘mola di pietra’, confezionato forse ad hoc per esi-genze rimiche (nebbiarella : coticella). Resta tuttavia da definire l’accezione precisa della parola nello specifico contesto proverbiale. Uno spunto utile potrebbe venire da PADOAN 1978: 218: «affezione cutanea sarà anche la code-sela “cuticola” (lo strato corneo dell’epidermide) grande, secondo quel che talvolta accade anche nelle affezioni di cheratosi». Se anche il nostro coticella indicasse una malattia acquisterebbe senso la corrispondenza con l’altro termine del binomio, carestia.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
95
Le agiografie e la sapienza salomonica Resta da gettare uno sguardo sull’altro côté dell’opera aretiniana, quel-lo tradizionalmente meno frequentato dalla critica. Lo speciale punto di vista offerto dallo studio del formulario proverbiale e sentenzioso radicato nei poemi eroicomici, nelle Lettere, nelle commedie e nei dia-loghi permette, infatti, di apprezzare da un’altra prospettiva la novità della proposta artistica costituita dalle prose religiose, e in particolar modo dalle agiografie. Se è vero che questi testi, oltre che in risposta a committenze accolte per calcolo opportunistico, nascono anche come tentativo di mettersi alla prova sull’altro versante dell’edonismo lin-guistico, è comprensibile che dall’elaborazione di uno stile grave so-stenuto sul ritmo dell’artificio retorico magniloquente Aretino scelga di escludere quasi del tutto la materia proverbiale, in speciale modo quella di matrice popolare più vicina ai moduli del parlato. Tracce minime se ne rilevano qua e là con cadenza sporadica, mai tale da de-terminare inversioni di tendenza nel canone stilistico adottato. È il ca-so, a esempio, dell’espressione "si reca in ciancia", 'si disinteressa, di-sprezza', impiegata in un excursus misogino della Vita di san Tommaso in cui il santo illumina un marito disperato con una serie di precetti de re uxoria.76
Rimane invece, e prende maggior corpo, la gnomica sentenziosa di ascendenza colta che si coagula attorno agli snodi nevralgici del testo secondo movenze apprezzabili anche nell’Orazia.77 Del tutto eccezio-nale per densità un luogo dell’agiografia dell’Aquinate che costituisce, tra l’altro, un documento prezioso della tendenza all’ibridazione dei generi connaturata alla maniera aretiniana. L’episodio, frutto della fantasia dell’autore e privo di riscontro nelle fonti biografiche, riguar-da una predica che Tommaso avrebbe pronunciato a Parigi davanti a una folla di fedeli acclamanti:
76 Opere religiose: 565. 77 Notevole il livello di sentenziosità che caratterizza le battute della Nu-
trice (cfr., a esempio, Orazia: I, 377-385). Altrettanto significativa la conso-nanza di alcuni cupi inserti gnomici della tragedia con analoghi passaggi de contemptu mundi delle agiografie. Si confrontino, a esempio, l’ingresso della Nutrice nel terzo atto con l’inizio del terzo libro della Vita di santa Caterina (Orazia: III, 11-29; Opere religiose: 405-408 in specie i parr. 16-17).
PAOLO MARINI
96
Avendo i prieghi di genti infinite constretto l’umanità de l’umile uomo a favellare di cose appartinenti al ben vivere ne la maniera dei proverbi di Salamone (forse per parer loro che i suoi detti non fusser meno sal-si), ecco che prese a dirgli: «[...] Tutti siamo nasciuti de la massa origi-nalmente dannata. Chi ama sé odia Cristo e chi ama Cristo odia sé [...]. La ragione dee comandare e lo appetito ubbidire. [...]. Si semina con le lagrime quel che si dee mietere con la letizia. La sanità conserva il cor-po e la scienza l’anima. Tra tutte le battaglie del mondo niuna è più dura pugna che quella de la castitade, però che ci è assidua guerra e ra-ra vittoria. I buoni non peccano per amore de la virtù e i rei per timore de la pena [...]». [...] le genti che l’avevon ascoltato, nel portarsene impressa nel core parte dei suoi detti e parte dei suoi ricordi [...], parevono candele di varie sorti accese al lume d’un torchio grande [...]. Mentre le persone instrut-te da le sentenzie del pio Tomaso se ne ritornavano [...].78
In apparenza, dunque, ci troviamo di fronte a un inserto omiletico. Ma, se affrontata in tale prospettiva, la lettura integrale del passo, vero e proprio monstrum di 38 sentenze affastellate in coordinazione asin-detica senza soluzione di continuità, delude le attese e confonde le i-dee. Nessuna predica così formulata avrebbe mai trovato riscontro presso un uditorio reale e, del resto, nulla di simile si ricava dal con-fronto con l’omiletica quattro-cinquecentesca. L’impiego di formule gnomiche non è affatto estraneo, a esempio, all’arte oratoria di Rober-to da Lecce, ma nelle sue omelie l’immissione di sentenze ricavate dal-la Bibbia e dalla patristica è dosata con sapienza, laddove i singoli e-nunciati appaiono sempre contestualizzati nella loro funzione di sup-porto all’argomentazione principale.79 È la finzione letteraria che con-sente ad Aretino di prodursi in un esperimento retorico in cui trova sfogo quel gusto per l’accumulo e l’enumerazione abnorme così fami-liari al lettore delle tre agiografie.80
78 Opere religiose: 551-552 (libro II, parr. 175-182). 79 Si osservino, a esempio, il trattamento delle citazioni dalla patristica e
l’impiego delle sentenze bibliche nella predica De la orazione raccolta in CA-
RACCIOLO 1993: 91-95. 80 Sullo specifico si rinvia a FASOLI 1995: 626-627.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
97
Non interessa qui esprimere giudizi sull’efficacia estetica di un e-sperimento che avvalora la tesi di quanti hanno individuato nella fase finale della produzione religiosa aretiniana un’involuzione (o evolu-zione) retoricistica in direzione “prebarocca”. Va invece registrato l’esercizio stilistico che riguarda il trattamento del materiale gnomico da parte di un moralista sui generis come Aretino. In un sofisticato gio-co di incastri, una quarantina di massime relative a «cose appartinenti al ben vivere» vengono elencate in un contenitore anomalo, una pre-dica a sua volta inserita in un’agiografia. Inoltre, il passo è accompa-gnato da indicazioni di genere orientate in direzioni ben diverse. Ver-so la conclusione le «sentenzie del pio Tomaso» sono infatti definite prima «detti» e poi «ricordi», con esplicito riferimento a prodotti della letteratura gnomica tradizionale. Una sorta di assaggio, insomma, di un’improbabile silloge di dicta Aretini, accennato con la solita esube-ranza di chi si sentiva abile a qualunque prova letteraria, senz’altro scopo recondito che dar prova della propria confidenza con i canoni dei generi più disparati e consolidare, nel contempo, il profilo severo della nuova figura autoriale confezionata dopo la svolta del 1539.
Il modello con cui viene innescato il consueto dialogo emulativo tipico dell’anticlassicismo aretiniano è addirittura quello fissato dalla sapienza biblica. Come si specifica in via preliminare, è lo stesso popo-lo parigino a chiedere che il santo si esprima «ne la maniera dei pro-verbi di Salamone», nella convinzione che i suoi detti non siano «me-no salsi» di quelli del libro dei Proverbi, attribuito nella Bibbia al sovra-no la cui saggezza diventerà poi, a sua volta, proverbiale.81
81 L’arguzia gnomica di san Tommaso è celebrata anche in un passo del
terzo libro dove compare una serie di brevi facezie in cui il santo si confron-ta con il demonio in un serrato botta e risposta. Significativa la chiosa di A-retino a quest’altro gruppo di detti memorabili: «Molto arguta e piacevole era sua illustre riverenzia nei motti, però rispondeva a chi lo dimandava piacevolmente e argutamente» (Opere religiose: 576). Superfluo rinviare ai numerosi contesti letterari in cui viene a vario titolo celebrata la saggezza di Salomone. Oltre ai volgarizzamenti del fortunatissimo Dialogo di Salomone e Marcolfo, ricordo soltanto i luoghi decameroniani di VI, 8, 10 e VI, 10, 16, e l’intera novella IX, 9. Tra le occorrenze aretiniane più importanti, quelle del sonetto Al Cardinale Ravenna, v. 4 (Operette politiche e satiriche: 198), di Mare-scalco: II, 8, 2 e di Lettere: IV, 280 r. 1. Notevole, inoltre, nell’ambito della lette-
PAOLO MARINI
98
L’analisi dell’omelia ha dimostrato che per confezionare questa se-quela di sentenze salomoniche Aretino – o chi per lui filtrava le fonti – rielabora tessere prelevate dal corpus della latinità aurea e della tradi-zione biblica e patristica, non è dato sapere se per via diretta o media-ta attraverso centoni e collettori come la Polyanthea. Si va da sentenze di ambito veterotestamentario («Si semina con le lagrime quel che si dee mietere con la letizia»),82 a formule di ascendenza agostiniana («Tutti siamo nasciuti de la massa originalmente dannata»),83 a prelie-vi dal corpus tomistico («La sanità conserva il corpo e la scienza l’anima»),84 attraverso cui sembra talora essere filtrato lo stesso Ago-stino («Tra tutte le battaglie del mondo niuna è più dura pugna che quella de la castitade, però che ci è assidua guerra e rara vittoria»),85 per arrivare a passi desunti dalla tradizione di classici come Cicerone («La ragione dee comandare e lo appetito ubbidire»)86 e Orazio («I
ratura cavalleresca, dal Morgante all’Inamoramento de Orlando, agli stessi po-emi di Aretino, la figura del saggio re di Bretagna che risponde al nome di Salomone (o Salamone), spesso, e non a caso, accostato a Namo.
82 Cfr. Ps, 125, 5: «Qui seminant in lacrimis, in exultatione metent». 83 Cfr. De civ. Dei, XV, 1: «[...] ex eadem massa oritur, quae originaliter est
tota damnata». 84 Cfr. Sum. Theol., I, q. 76, a. 1: «sanitas est forma corporis et scientia
animae». 85 Cfr. Sum. Theol., IIa-IIae, q. 154, a. 3 ad 1: «et inde est quod Augustinus
dicit in libro de agone Christiano, quod inter omnia Christianorum certamina duriora sunt praelia castitatis, ubi est quotidiana pugna, et rara victoria», dove si cita un passo di Agostino, Serm., 293, 2: «Inter omnia enim Christianorum certamina sola duriora sunt praelia castitatis; ubi quotidiana est pugna, et rara victoria». Il luogo agostiniano compare anche nella Polyanthea, s.v. casti-tas (cfr. NANI MIRABELLI 1514: 66r col. b). Se, come pare, la sentenza in que-stione è ripresa proprio nella formula volgarizzata da Aretino nel trattato etico-politico di ROSSI 1639: 80 («Tra tutte le battaglie de’ Christiani le più dure sono le brighe della castità, dove è assidua guerra, e rara vittoria»), ci troviamo dinnanzi a un’ulteriore testimonianza della ricezione delle opere religiose di Pietro in età barocca.
86 Cfr. De off., I, 101: «Ita fit, ut ratio praesit, appetitus obtemperet».
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
99
buoni non peccano per amore de la virtù e i rei per timore de la pe-na»).87
Luoghi come questo contribuiscono a far luce sul nodo ancora in-soluto della creatività aretiniana e rendono, tra l’altro, ragione dell’episodio descritto nella 233 del sesto libro delle Lettere, dove si dà conto di una minaccia sventata. Stando all’epistola, Ortensio Lando avrebbe ventilato l’ipotesi di raccogliere tutte le «sentenzie che son nei volumi de le lettre» per poi attribuirle «in una sua opra a questo e a quel filosofo», ma in seguito «ammonito da la coscienza, di propria mano squarciate in pezzi l’avea».88 Capolavoro di dissimulazione l’autodifesa in attacco di un Aretino già ai tempi invischiato nel dibat-tito sulla natura colta o incolta del suo anticlassicismo:
[...] gli risposi che molto mi era d’ingiuria il non porre in istampa cotal cosa [...]. Caso che si conoscessero per trovate da me, mi reputavo uo-mo degno de la laude in la memoria di tali; e quando pure a essi si rif-ferissero, dimostravo che al paro de gli altri dotti sapevo prevalermi de i furti che rubbano tuttavia ne gli studi. Sì che in capo de le fini i littera-ti, in cambio del giudicarmi ignorante, per maestro di ogni scienza mi ascrivono.89
Tale è del resto il dominio del materiale gnomico da parte di Aretino, che egli può persino permettersi di farne motivo comico in una scena del Filosofo (II, 5). L’efficacissimo scambio fra il servo Salvalaglio e il padrone, filosofo e pedante, Plataristotele è qui, ancora un volta, gio-cato sullo scontro tra codici culturali e linguistici alternativi:
87 Cfr. Epist., I, 16, vv. 52-53: «oderunt peccare boni virtutis amore. | Tu
nihil admittes in te formidine poenae». La sentenza è tuttavia tradotta a par-tire da una riduzione proverbiale del passo diffusa in età medievale: «ode-runt peccare mali formidine poenae, | oderunt peccare boni virtutis amore» (ORAZIO 1989: 109 in apparato; si veda in proposito BENEDETTI 2000: 121). Il distico oraziano è citato in questa forma, a esempio, nel Moralium Dogma at-tribuito a Guillaume de Conches (GUILLAUME DE CONCHES 1929: 71).
88 Lettere: VI, 215; sullo specifico delle sentenze nelle Lettere rinvio a FALA-
SCHI 1977. 89 Lettere: VI, 215.
PAOLO MARINI
100
MESSER PLATARISTOTELE. Eccomi sul furor divino. SALVALAGLIO. Iesus! MESSER PLATARISTOTELE. Il moto de le mani è interprete de i sensi. SALVALAGLIO. A punto. [...] MESSER PLATARISTOTELE. La ragione è quasi un rivo che discende dal fonte di Dio [...]. SALVALAGLIO. E ben venga maggio. MESSER PLATARISTOTELE. La invidia e la ippocrisia sono i manigoldi de i lor seguaci. SALVALAGLIO. Trentatré tenche fritte. [...] MESSER PLATARISTOTELE. Iddio ha due ministre: la natura e la fortuna. [...] MESSER PLATARISTOTELE. Chi confessa la sorte, nega Iddio. [...] MESSER PLATARISTOTELE. L’arte manca dove la violenza domina. SALVALAGLIO. Detti usciti di Salamoia. MESSER PLATARISTOTELE. Eccomi tornato in la fragilità umana. SALVALAGLIO. Non importa una frulla, perché non se n’è scappolata la divinità, che vi pose il grillo in frenesia [...].90
A partire dall’analisi dell’espressione proverbiale «menare le lanche su per le banche», Luca D’Onghia ha chiarito come «alcune delle bat-tute di Salvalaglio, che paiono a tutta prima estranee al discorso del filosofastro, sono in realtà versi d’attacco di canzoni», intonate come «motivetti popolari per creare un contraltare ridicolo all’arruffato ra-gionamento del padrone».91 In preda a una sorta di trance declamato-ria esplicitamente dichiarata («Eccomi sul furor divino [...] Eccomi
90 Filosofo: II, 5, 2-5; la scena a due ripropone lo schema di I, 5. Anche in
quel caso Plataristotele si produce in una lunga sequela di sentenze. Alla fine, distratto dal contrappunto incessante di Salvalaglio, commenta indi-spettito: «Errore imperdonabile è veramente quello che mi ha interrotto il sentier de i proverbi, che mi scaturivono i fonti del mio intelletto» (ibid.: I, 5, 4).
91 D’ONGHIA 2005: 34.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
101
tornato in la fragilità umana»),92 Plataristotele prorompe in una se-quenza del tutto casuale di sentenze illustri che Salvalaglio chiosa bef-fardo come «detti usciti di Salamoia».93 Detti cioè «ne la maniera dei proverbi di Salamone», come quelli dell’omelia parigina nella Vita di san Tommaso.
La dinamica della scena sembra riproporre il pattern del Dialogo di Salomone e Marcolfo: da un lato il colto sentenziare del signore,94 dall’altro il contrappunto, talora completamente irrelato, del servo che
92 Il perenne invasamento di Plataristotele è oggetto di burla da parte del
servo, che al termine dello sproloquio del padrone sottolinea come «non se n’è scappolata la divinità, che gli pose il grillo in frenesia». L’espressione «porre il grillo in frenesia» vale in prima istanza "eccitare sessualmente"; grillo ‘pene’ è attestato con quattro occorrenze in BOGGIONE - CASALEGNO
2004: 262, e risulta tuttora diffuso nell’aretino popolare (cfr. BENIGNI 2010: 100).
93 Nel Glossario Alessio Decaria segnala che Salamoia va inteso come stor-piatura per Salomone. Così anche Aquilecchia per la formula "sputare salamo-ia" ricorrente nelle Sei giornate: «sputare sentenze (con probab. avvicinamento scherz. a Salomone)» (Sei giornate: 576). Come suggerisce l’introduzione alla predica di san Tommaso, alla base di queste metafore andrà registrato l’incrocio con espressioni tipo detti salsi che alludono appunto all’arguzia, alla salacia degli enunciati sentenziosi: «Avendo i prieghi di genti infinite constret-to l’umanità de l’umile uomo a favellare di cose appartinenti al ben vivere ne la maniera dei proverbi di Salamone (forse per parer loro che i suoi detti non fusser meno salsi)» (Opere religiose: 551).
94 «Il moto de le mani è interprete de i sensi» ricorda un passo della re-dazione a stampa del Libro de natura de amore: «non però devemo tenere le mani ociose, ma moverle a tempo quasi interpreti de’ nostri sensi» (EQUICO-
LA 1525: 175r), a sua volta dipendente dai fondamenti di chironomia esposti in CICERONE, De or., III, 59, e QUINTILIANO, Inst. or., XI, III, 85 ss. (cfr. SCHMITT 1991: 32-36). Sulle modifiche a questa porzione del libro V approntate in vi-sta della stampa si veda VILLA 2006: 170. Si legga invece PETTERUTI 2006 per un approfondimento sulla maschera pedantesca attribuita già in vita a Equi-cola. In «Iddio ha due ministre: la natura e la fortuna» viene forse ripreso un concetto boccacciano di Decameron, VI, 2, 6, dove si parla appunto della natu-ra e della fortuna come delle «due ministre del mondo» (il luogo è recupera-to anche in TASSO 2000: 52). «Chi confessa la sorte, nega Iddio» è registrato in GIUSTI 1853: 137.
PAOLO MARINI
102
schernisce la magniloquenza dell’interlocutore attingendo alle infinite risorse comiche della tradizione popolare, tra sintagmatica proverbia-le, canzonette e nonsense.95 Ne esce un dialogo fra sordi, un cozzare fragoroso fine a sé stesso, che risulta tanto più significativo della di-stanza abissale tra due universi sociali e culturali paralleli ma non co-municanti. Al termine dello scambio Plataristotele si rivolge compia-ciuto a Salvalaglio nella convinzione di averlo messo a parte di un i-nestimabile patrimonio sapienziale. Ma alla vacuità del diluvio gno-mico del filosofo viene opposto ancora l’argine dello sberleffo, in no-me di un ritorno all’ordine e alla verità delle cose che prende corpo nel materialismo istintivo proprio della maschera comica del servo e della sua funzione linguistica secondo natura:
MESSER PLATARISTOTELE. Tu possiedi tesori imperdibili. SALVALAGLIO. Il potergli spendere saria l’importanza.96
95 «E ben venga maggio», oltre che un celeberrimo attacco canzonettisti-
co, è anche una frase proverbiale impiegata con valore interiettivo per salu-tare l’arrivo di una persona amica che non si vedeva da tempo (cfr. MONO-
SINI 2010: 284; la formula è registrata senza didascalie anche in CROCE 2006: 157), in linea con formule di saluto del tipo di «Ecco Calandro, | o ben vegna Calandro, mio galante» della aretiniana Farza (vv. 5-6, Operette politiche e sa-tiriche: 42); la stessa frase può esprimere totale indifferenza per qualcosa (cfr. GDLI: s.v. maggio, 8). Quindi la battuta di Salvalaglio potrebbe essere inter-pretata come un ironico cenno di benvenuto rivolto alla scempiaggine del filosofo, oppure come un volgare "E chi se ne importa?". Uno spunto curio-so, infine, a proposito di «Trentatré tenche fritte», settenario allitterante cer-tamente ripreso da un «motivetto in stile burchiellesco» (D’ONGHIA 2005: 35). Nella smorfia napoletana il 33 è precisamente il numero assegnato alle tinche fritte (cfr. COSENTINO 2008: 405; sulle origini del gioco del lotto rinvio a FIORIN 1989 e 1997). Difficile spingersi oltre, ma non è improbabile che l’abbinamento del numero a una tra le più popolari pietanze della cucina italiana di un tempo (cfr. FACCIOLI 1992: 203) sia in qualche modo legato alla circolazione della canzonetta qui accennata.
96 Filosofo: II, 5, 5.
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
103
REGESTO BIBLIOGRAFICO Opere di Pietro Aretino97 Astolfeida
Astolfeida, in Poemi cavallereschi, a cura di Danilo Romei, Roma, Sa-lerno Editrice, 1995, pp. 237-281
Cortigiana 1525 Cortigiana (1525), a cura di Paolo Trovato, in Teatro I: 29-204
Cortigiana 1534 Cortigiana (1534), a cura di Federico Della Corte, in Teatro, I: 205-409
Filosofo Il filosofo, a cura di Alessio Decaria, in Teatro, III: 165-293
Ipocrito Lo ipocrito, a cura di Carmine Boccia, in Teatro, II: 153-338
Lettere Lettere. Libro I (-VI), a cura di Paolo Procaccioli, Roma, Salerno Edi-trice, 1997-2002, 6 voll.
LSA Lettere scritte a Pietro Aretino. Libro I (-II), a cura di Paolo Procaccioli, Roma, Salerno Editrice, 2003-2004, 2 voll.
Marescalco Il marescalco, a cura di Giovanna Rabitti, in Teatro, II: 9-152
Opere religiose Opere religiose, II, Vita di Maria Vergine. Vita di santa Caterina. Vita di san Tommaso, a cura di Paolo Marini, Roma, Salerno Editrice, 2011
Operette politiche e satiriche Operette politiche e satiriche, II, a cura di Marco Faini, Roma, Salerno Editrice, 2012
Orazia L’Orazia, a cura di Federico Della Corte, in Teatro, III: 9-164
97 Per l’Astolfeida il rinvio è al libro, all’ottava e al verso (alla pagina solo
per l’epistola dedicatoria e il sonetto di Pasquino ai lettori); per le commedie all’atto, alla scena e al paragrafo; per l’Orazia all’atto e ai versi; per le Lettere e le Sei giornate alla pagina e, se necessario, alla o alle righe. In tutti gli altri casi il rinvio è alla sola pagina.
PAOLO MARINI
104
Sei giornate Sei giornate, a cura di Giovanni Aquilecchia, Bari, Laterza, 1969
Talanta Talanta, a cura di Enrico Garavelli, in Teatro, II: 339-503
Teatro, I Teatro, I, Cortigiana (1525 e 1534), a cura di Paolo Trovato e Federico Della Corte, Roma, Salerno Editrice, 2010
Teatro, II Teatro, II, Il marescalco. Lo ipocrito. Talanta, a cura di Giovanna Rabit-ti - Carmine Boccia - Enrico Garavelli, Roma, Salerno Editrice, 2010
Teatro, III Teatro, III, Il filosofo. L’Orazia, a cura di Alessio Decaria e Federico Della Corte, Roma, Salerno Editrice, 2005
Altre opere e bibliografia secondaria ALTIERI BIAGI 1980
Maria Luisa A.B., Dal comico del «significato» al comico «del significan-te», in Ead., La lingua in scena, Bologna, Zanichelli, 1980, pp. 1-57
BECCARIA 1985 Gian Luigi B., Spagnolo e spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Torino, Giappichelli, 1985
BECCARIA 2010 Gian Luigi B., Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell’italiano e nei dialetti, Milano, Garzanti, 2010
BEMBO 1888 Pietro B., Motti inediti e sconosciuti, a cura di Vittorio Cian, Venezia, Tipografia dell’Ancora (I. Merlo Editore), 1888
BENEDETTI 2000 Stefano B., Boccaccio lettore di Orazio, in Testimoni del vero. Su alcuni libri in biblioteche d’autore, a cura di Emilio Russo, «Studi e testi ita-liani», 6, 2000, pp. 107-129
BENIGNI 2010 Piero B., Vocabolario aretino, Arezzo, Editrice Aretina, 2010
BibIt Biblioteca italiana, banca dati a cura dell’Università degli Studi di
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
105
Roma “La Sapienza”, <http://www.bibliotecaitaliana.it/> (ultima consultazione: dicembre 2012)
BOGGIONE - CASALEGNO 2004 Valter B. - Giovanni C., Dizionario del lessico erotico, Torino, UTET, 2004
BRAMBILLA AGENO 2000a Franca B.A., Studi lessicali, a cura di Paolo Bongrani - Franca Ma-gnani - Domizia Trolli, Bologna, CLUEB, 2000
BRAMBILLA AGENO 2000b Franca B.A., Le frasi proverbiali di una raccolta manoscritta di Lionardo Salviati (1959), in BRAMBILLA AGENO 2000a, pp. 358-393
BRAMBILLA AGENO 2000c Franca B.A., Premessa a un repertorio di frasi proverbiali (1960), in BRAMBILLA AGENO 2000a, pp. 400-432
CAIRNS 1985 Christopher C., Pietro Aretino and the Republic of Venice. Researches on Aretino and his circle in Venice. 1527-1556, Firenze, Olschki, 1985
CARACCIOLO 1993 Roberto C., Opere in volgare, a cura di Enzo Esposito, Galatina, Congedo, 1993
CHIECCHI 1975-1976 Giuseppe C., Sentenze e proverbi nel «Decameron», «Studi sul Boccac-cio», IX, 1975-1976, pp. 119-168
CLUBB 1995 Louise George C., Theatrical examples for Aretino, «Da Siena studiante in libris, venuto a Roma», in Pietro Aretino 1995, pp. 981-1008
Commedie 2004 Commedie rusticali senesi del Cinquecento, a cura di Bianca Persiani, saggio introduttivo di Pietro Trifone, Siena, Betti, 2004
CORSARO 2006 Antonio C., Poesia satirica e poesia pasquinesca, in Ex marmore. Pa-squini, pasquinisti, pasquinate nell’Europa moderna, Atti del colloquio internazionale (Lecce-Otranto, 17-19 novembre 2005), a cura di Chrysa Damianaki - Paolo Procaccioli - Angelo Romano, Manziana, Vec-chiarelli, 2006, pp. 35-50
PAOLO MARINI
106
COSENTINO 2008 Matilde C., I sogni e i numeri. La smorfia vincente del lotto. L’antica smorfia napoletana aggiornata con le voci della nostra nuova realtà, Fi-renze, Giunti, 2008
CROCE 2006 Giulio Cesare C., Selva di esperienza, in Id., L’eccellenza e Trionfo del Porco e altre opere in prosa, a cura di Monique Rouch, Bologna, Pen-dragon, 2006, pp. 151-196
CURTIUS 1992 Ernst Robert C., Letteratura europea e medioevo latino, a cura di Ro-berto Antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992
DE VILLA-DEI 1974 Das Doctrinale des Alexander de Villa-Dei, a cura di Dietrich Rei-chling, Berlin, Hofmann, 1893
D’ONGHIA 2005 Luca D’O., Un venetismo aretiniano: «menare le lanche su per le ban-che», «Lingua e stile», XL, 2005, 1, pp. 21-36
DONI 2003 Anton Francesco D., Le novelle, II, La zucca, a cura di Elena Pierazzo, Roma, Salerno Editrice, 2003
DU CANGE Charles Du C., Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Niort, Favre, 1883-1887, 10 voll.
EQUICOLA 1525 Mario E., Libro de natura de amore, Venezia, L. Lorio, 1525
FACCIOLI 1992 Emilio F., L’arte della cucina in Italia, Torino, Einaudi, 1992
FALASCHI 1977 Giovanni F., La manipolazione della fonte: Erasmo (Apoftemmi) e le Lettere, in Id., Progetto corporativo e autonomia dell’Arte in Pietro Are-tino, Messina-Firenze, D’Anna, 1977, pp. 181-208
FANFANI 1864 Pietro F., Stanze villanesche, «Il Borghini», II, 1864, 1, pp. 39-52
FASOLI 1995 Paolo F., «Con la penna della fragilità». Considerazioni sull’Aretino a-scetico, in Pietro Aretino 1995: 619-639
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
107
FIORIN 1989 Alberto F., Lotto, lotterie e altro ancora, in Fanti e denari. Sei secoli di giochi d’azzardo, Catalogo della mostra omonima (Venezia, 15 gennaio - 29 aprile 1989), Venezia, Arsenale, 1989, pp. 122-153
FIORIN 1997 Alberto F., Nascita e sviluppo delle lotterie a Venezia, «Homo ludens», VII, 1997, pp. 101-128
FLORIO 1993 John F., Giardino di ricreazione, a cura di Luca Gallesi, Milano, Greco & Greco, 1993
FOLENA 1997 Gianfranco F., «Sei giornate» di Pietro Aretino (1969), in Id., Scrittori e scritture. Le occasioni della critica, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 130-135
GDLI Grande dizionario della lingua italiana, diretto da Salvatore Battaglia e Giorgio Bàrberi Squarotti, Torino, UTET, 1961-2002, 21 voll.
GIAMBULLARI 1986 Pierfrancesco G., Regole della lingua fiorentina, a cura di Ilaria Bo-nomi, Firenze, Accademia della Crusca, 1986
GIUSTI 1853 Giuseppe G., Raccolta di proverbi toscani, Firenze, Le Monnier, 1853
GUILLAUME DE CONCHES 1929 Das Moralium Dogma Philosophorum des Guillaume de Conches, latei-nisch, altfranzösisch und mittelniederfränkisch herausgegeben von John Holmberg, Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1929
INNAMORATI 1962 Giuliano I., Aretino, Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, IV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1962, pp. 89-104
LUCCHI 1978 Piero L., La Santacroce, il Salterio e il Babuino. Libri per imparare a leg-gere nel primo secolo della stampa, «Quaderni storici», 38, 1978, pp. 593-630
MARCONI 2001 Giampietro M., Una aemulatio... a degrado (P. Aretino, giornata 2, 2: del barone e della signora), Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici
PAOLO MARINI
108
internazionali, 2001 MAZZI 1882
Curzio M., La congrega dei Rozzi di Siena nel secolo XVI, Firenze, Le Monnier, 1882, 2 voll.
MONOSINI 2010 Agnolo M., Floris Italicae linguae libri novem, Venezia, V. Guerigli, 1604, ed. anast. con indici di Giuseppe Crimi, in PIGNATTI 2010
NANI MIRABELLI 1514 Domenico N.M., Polyanthea cum additionibus, Savona, S. Bevilacqua, 1514
ORAZIO 1989 Quinto O. Flacco, Épitres, a cura di François Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres, 1989
PADOAN 1978 Giorgio P., Esercizi di traduzione e di restauro testuale della «Pastoral» (1974 e 1977), in Id., Momenti del Rinascimento veneto, Padova, An-tenore, 1978, pp. 208-226
PATOTA 2008 Giuseppe P., Aretino, l’aretino e le altre lingue di Toscana, in In utrum-que paratus. Aretino e Arezzo, Aretino a Arezzo: in margine al ritratto di Sebastiano del Piombo, Atti del Colloquio internazionale per il 450° della morte di Pietro Aretino (Arezzo, 21 ottobre 2006), a cura di Paolo Pro-caccioli, Roma, Salerno Editrice, 2008, pp. 77-95
PATRIZI 1995 Giorgio P., Aretino e Boccaccio, in Pietro Aretino 1995: 143-156
PETTERUTI 2006 Pietro P., La maschera dell’Equicola, fra satira e parodia. Il Dialogus in lingua Mariopionea e le due redazioni del Pentecontametron, in Auc-tor/Actor: lo scrittore personaggio nella letteratura italiana, a cura di Gilda Corabi e Barbara Gizzi, Roma, Bulzoni 2006, pp. 121-148
PIERGUIDI 2008 Stefano P., “Dare forma humana a l’Honore et a la Virtù”. Giovanni Guerra (1544-1618) e la fortuna delle figure allegoriche da Mantegna all’Iconologia di Cesare Ripa, Roma, Bulzoni, 2008
PIERI 2010 Marzia P., Lo Strascino da Siena e la sua opera poetica teatrale, Pisa,
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
109
ETS, 2010 Pietro Aretino 1995
Pietro Aretino. Nel cinquecentenario della nascita, Atti del convegno di Roma-Viterbo-Arezzo (28 settembre - 1 ottobre 1992), Toronto (23-24 ot-tobre 1992), Los Angeles (27-29 ottobre 1992), Roma, Salerno Editrice, 1995, 2 voll.
PIGNATTI 2010 Franco P., Etimologia e proverbio nell'Italia del XVII secolo. Agnolo Monosini e i Floris Italicae linguae libri novem, con edizione anasta-tica dell'edizione Venezia, V. Guerigli, 1604, indici di Giuseppe Crimi, Manziana, Vecchiarelli, 2010, 2 voll.
PROCACCIOLI 2013 Paolo P., Dalle dieci alle sei giornate e dalle cento alle mille novelle. Are-tino emulo dichiarato di Boccaccio, in Boccaccio e i suoi lettori. Una lunga ricezione, Atti del Convegno internazionale di studi (Bologna-Ravenna, 7-9 novembre 2012), a cura di Gian Mario Anselmi, Bologna, il Mu-lino, 2013, pp. 307-323
ROMEI 1999 Danilo R., L’‘assenza’ di Roma nelle Lettere di Pietro Aretino, «Roma nel Rinascimento», 1999, pp. 53-60
ROSSI 1639 Pio de' R., Convito morale per gli etici, economici, e politici, Venezia, V. Guerigli, 1639
RUOZZI 2011 Gino R., Autori e modelli di forme gnomiche umanistiche e rinascimenta-li, in Tradition et créativité dans les formes gnomiques en Italie et en Eu-rope du Nord (XVIe-XVIIe siècles), a cura di Perrine Galand - Gino Ruozzi - Sabine Verhulst - Jean Vignes, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 11-31
RUSCELLI 2011 Girolamo R., Dediche e avvisi ai lettori, a cura di Antonella Iacono e Paolo Marini, Manziana, Vecchiarelli, 2011
SCHMITT 1991 Jean-Claude S., Il gesto nel medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1991
SEGRE 1966 Cesare S., Esperienze ariostesche, Pisa, Nistri-Lischi, 1966
PAOLO MARINI
110
SEGRE 1991 Cesare S., Edonismo linguistico nel Cinquecento (1953), in Id., Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana, Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 369-396
SPERONI 1953 Charles S., The Italian Wellerism to the End of the Seventeenth Century, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1953
TASSO 2000 Torquato T., Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di Claudio Gigante, Roma, Salerno Editrice, 2000
TB Niccolò Tommaseo - Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italia-na, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1861-1879, 7 voll.
TESTA 1991 Enrico T., Simulazione di parlato, Firenze, Accademia della Crusca, 1991
TONELLO 1970 Mario T., Lingua e polemica teatrale nella «Cortigiana» di Pietro Areti-no, in Lingua e strutture del teatro italiano del Rinascimento, Padova, Liviana, 1970, pp. 203-289
TOSI 2011 Renzo T., Precedenti classici di proverbi italiani, in Ragionamenti intor-no al proverbio, Atti del II Congresso internazionale dell’Atlante pare-miologico italiano, in memoria di Paola Chicco (Andria, 21-24 aprile 2010), a cura di Temistocle Franceschi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, pp. 179-194
TPMA 1996 Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi. Lexicon der Sprichwörter des ro-manisch-germanischen Mittealters, begründet von Samuel Singer, he-rausgegeben vom Kuratorium Singer der Schweizerisches Aka-demie der Geistes- und Sozialwissenschaften, II, Bisam-erbauen, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1996
TRIFONE 1994 Pietro T., L’italiano a teatro, in Storia della lingua italiana, a cura di Luca Serianni e Pietro Trifone, II, Scritto e parlato, Torino, Einaudi, 1994, pp. 81-159
FORMULE PROVERBIALI E SENTENZIOSE IN PIETRO ARETINO
111
VENERONI 1698 Giovanni V., Dittionario italiano, e francese. Dictionaire italien, et français. Arricchito più nobilmente, e da notabili errori con diligenza ri-corretto [...], Venezia, L. Baseggio, 1698, 2 voll.
VILLA 2006 Alessandra V., Istruire e rappresentare Isabella d’Este. Il Libro de na-tura de amore di Mario Equicola, Lucca, Pacini Fazzi, 2006
WADDINGTON 2009 Raymond B. W., Il satiro di Aretino. Sessualità, satira e proiezione di sé nell’arte e nella letteratura del XVI secolo, Roma, Salerno Editrice, 2009
WALTHER 1963-1969 Proverbia sententiaeque Latinitatis Medi Aevii, Gesammelt und hrsg. von Hans Walther, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1963-1969, 6 voll.





































































![La carestia del 1346-47 nell'inventario dei beni di un monastero del contado aretino [RSA 1970-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fa72e9c87e0c090fe974/la-carestia-del-1346-47-nellinventario-dei-beni-di-un-monastero-del-contado-aretino.jpg)