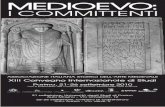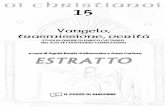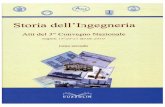Milano dopo Bramante : la torre di Palazzo Stampa e il tiburio di Santa Maria della Passione
Il pane spezzato. La cena del Signore nella passione di Matteo
Transcript of Il pane spezzato. La cena del Signore nella passione di Matteo
Facoltà di Teologia di Lugano
Anno accademico 2013-2014
Il pane spezzato
NTSO - Il racconto della Passione in Matteo
Studente
Elisabetta Tisi
Docente
prof. dott. Mauro Orsatti
2
Indice
Introduzione ........................................................................................................... 3
1 In una storia di passione ................................................................................ 5
2 E prepararono la pasqua ................................................................................ 7
2.1 Azzimi e pasqua ........................................................................................ 7
2.2 Schiavitù e resistenza ................................................................................ 8
2.3 Fare la pasqua .......................................................................................... 10
3 Tradimento e dono ....................................................................................... 12
4 Mangiatene tutti. La nuova alleanza ............................................................ 16
Conclusioni .......................................................................................................... 22
Bibliografia .......................................................................................................... 24
3
Introduzione
La celebrazione della cena del Signore viene definita in modo diverso nel-
le varie chiese cristiane. La chiesa cattolica parla di celebrazione eucaristica, nel-
le chiese evangeliche si usa Santa Cena o Cena del Signore, nelle chiese ortodos-
se si celebra la Divina Liturgia o Sinassi (cioè unione, riunione comunitaria). Si
sono formate nel tempo modalità differenti di celebrazione ma questa diversità,
piuttosto che essere feconda e arricchente, ha generato conflitti che hanno reso
impossibile una Cena del Signore in comune. Le Chiese ad oggi sono incapaci di
condividere fino in fondo lo stesso Cristo.
«Fate questo in memoria di me» (1Cor 11,24): come annunciare riconci-
liazione, pace, mentre le nostre mense sono divise, quando spesso sono i più fra-
gili e i più soli ad essere esclusi? È davvero la memoria di ciò che ha voluto Gesù
il Cristo quella che noi facciamo quando non condividiamo il pane?
L’argomento è vasto e tantissimi temi si aprono ad ogni parola del testo.
Non ho potuto, in questa sede, affrontarli tutti, ma si è resa necessaria una sele-
zione; volevo, però, che l’esigenza del corso di uno studio metodologicamente
fondato con una spiegazione puntuale dei vari versetti biblici non togliesse al te-
sto il suo sapore, ciò che evoca, ciò che non dice; per questo motivo ho scelto di
mettere in nota, dove possibile, le parti più tecniche o problematiche. Fare esege-
si significa analizzare il testo al fine di comprenderne il significato. Fare esegesi
biblica, però, non può prescindere da un Amore ricevuto che muove verso il te-
sto. E l’amore spesso richiede discrezione e luci soffuse. Spesso si ricercano i fat-
ti storicamente accaduti o le ipsissima verba, la comprensione scientifica procede
con idee chiare e distinte1, prodotto della mente; quanto più ricco, però, dopo tut-
to ciò, mantenere la narrazione con la sua ricchezza, le sue allusioni, i chiaroscu-
1 R. CARTESIO, Discorso sul metodo, Cinisello Balsamo 2003.
4
ri. Troppe spiegazioni distruggono una battuta, la musica, la stessa liturgia va ce-
lebrata, non spiegata. In latino sapere e gustare hanno la medesima radice: sápere
e in italiano di questa ricchezza è rimasta traccia in sapere e sapore. Conoscere
qualcosa è gustarne il sapore: «Gustate e vedete quant’è buono il Signore» (Sal
34,9).
5
1 In una storia di passione
Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù costituisce il cuore di o-
gni Vangelo. Ogni cosa acquista senso alla luce della morte e risurrezione di Ge-
sù. E’ alla luce di questi eventi che gli apostoli danno l’annuncio di salvezza per
l’umanità.
L’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli è parte fondamentale di questa
storia di passione e risurrezione. È infatti inserita in questi capitoli conclusivi (Mt
26-28). L’istituzione dell’eucaristia, che avviene durante questa cena, viene nar-
rata nei vangeli sinottici (Mt 26, 20-30; Mc 14,17-26; Lc 22,14-23) e nella prima
lettera ai Corinzi (1Cor 11, 23-25), mentre nel vangelo di Giovanni si ha una ri-
flessione che cerca di comprendere l’Eucaristia nel contesto più ampio di tutta
l’esistenza di Gesù. Il testo più antico riguardante la cena del Signore si ritiene
essere la Prima Lettera di Paolo ai Corinzi, degli anni 50. I racconti rivelano
un’origine di tipo cultuale, descrivendo, più che le esatte parole pronunciate da
Gesù, il culto della comunità primitiva. Si possono notare le rassomiglianze tra
Matteo e Marco che, secondo la critica moderna, si rifanno alla tradizione pale-
stinese primitiva. In loro si nota il riferimento all’alleanza del Sinai, riportando
«questo è il mio sangue dell'alleanza»2, un richiamo esplicito al valore sacrificale
del sangue3, mentre Luca e Paolo riportano «questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue»4 in cui riecheggia la nuova alleanza di Geremia
5, rifacendosi alle ce-
lebrazioni sorte in terra straniera, tradizione questa chiamata antiochena.
Fin dall’inizio, dunque, non vi è stato un unico modo di celebrare
l’eucarestia, ma varie forme. L’eucarestia, infatti, è legata alla vita: il popolo di
Dio celebra e ringrazia e invoca lo Spirito affinché renda presente il Cristo nella
comunità, alla comunità cristiana.
2 Mt 26,28; Mc 14,24
3 Vedi Es 24,4-8.
4 Lc 22,20; 1Co 11,25
5 Espressione che ricorre nell’Antico Testamento soltanto in Ger 31,31.
6
Il racconto dell’ultima cena in Matteo si articola in tre parti:
- la preparazione della cena (Mt 26,17-19)
- l’annuncio del tradimento (Mt 26, 20-25)
- l’istituzione dell’eucaristia (Mt 26, 26-30)
7
2 E prepararono la pasqua
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove
vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose:
«Andate in città da un tale6 e ditegli: «Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la
Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Ge-
sù, e prepararono la Pasqua. (Mt 26,17-19).
2.1 Azzimi e pasqua
La questione della datazione precisa dell’ultima cena è sorta fin dai tempi
più antichi: per i vangeli sinottici sembra che Gesù abbia celebrato la cena il pri-
mo giorno degli azzimi, mentre, stando alla narrazione di Giovanni, sembra che
nel giorno degli azzimi avvenga la crocifissione, quando, cioè, al tempio veniva-
no immolati gli agnelli da consumarsi poi nella cena pasquale. Va poi tenuto con-
to del fatto che dai ritrovamenti di Qumran si conosce che al tempo di Gesù era
in vigore un altro calendario, oltre a quello ufficiale, che poteva essere usato an-
che al di fuori della comunità. Il racconto dei Vangeli è, in realtà, finalizzato a
trasmettere una testimonianza di fede, una comprensione degli eventi di cui si
narra e della salvezza da loro portata; era una cena ebraica o un semplice pasto
comunitario?7 La tensione è legittima: da un lato c’è la continuità tra Pasqua e ul-
tima cena, dall’altro è ovvio che le prime comunità cristiane avessero compreso
fin dal principio la differenza con la pasqua ebraica poiché non sembra proprio
che il memoriale venisse compiuto solo una volta all’anno. Dunque la cena sta in
6 In greco è presente l’articolo, quindi è preferibile tradurre il tale, indicante una persona probabilmente
conosciuta. 7 Riguardo alla discussione se Gesù abbia celebrato la pasqua ebraica o un pasto comunitario come quello
delle comunità essene, molti studiosi attualmente argomentano che quella di Gesù non era una cena pa-
squale anche perché Gesù, secondo queste ricostruzioni sarebbe stato crocifisso il pomeriggio prima della
Pasqua (avvalorando la testimonianza di Giovanni) e dunque cercano nei testi evangelici tutte le assenze e
le differenze tra la cena di Gesù e una cena pasquale ebraica (anche se non si conosce con esattezza come
questa venisse celebrata ai tempo di Gesù). In questo lavoro si ritengono comunque valide le argomenta-
zioni di Jeremias nella sua opera L’ultima cena di Gesù – un convito pasquale a difesa del carattere pa-
squale della cena di Gesù.
8
un rapporto di continuità con la pasqua ebraica ma si differenzia decisamente da
essa.
Le due festività, Azzimi e Pasqua, originariamente, erano sorte in contesti
culturali e storici molto diversi e lontani nel tempo. La pasqua8 era una festa di
carattere nomadico, tipica dei pastori, che, dopo l’inverno, all’inizio della prima-
vera, riprendevano a muoversi con le loro greggi in cerca di pascoli. La festa de-
gli Azzimi, massôt (pani senza lievito), era una festa agricola, stanziale, che du-
rava una settimana e segnava l'inizio della mietitura dell'orzo9. Il popolo ebraico
incominciò a praticare questa festività dopo il suo ingresso a Canaan10
e, proba-
bilmente, Israele l’acquisì dalle popolazioni cananee. Durante questa festa si
mangiava pane con farina nuova, senza lievito e senza nulla che provenisse dal
vecchio raccolto. Si trattava, quindi, di un nuovo inizio. Con la riforma di Giosia
(622 a.C.) le due festività vennero associate, sia perché la Pasqua era celebrata
anch'essa con pani azzimi sia perché le due festività facevano memoria dello
stesso evento salvifico: liberazione dalla schiavitù egizia e insediamento nella
Terra promessa.
Matteo associa, dunque, fin da subito il suo racconto della cena alla pa-
squa ebraica. Associa ma distingue: quello che Gesù compie non è il rito della
pasqua ebraica ma, sullo sfondo degli eventi salvifici narrati dalle Scritture, Gesù
pone la sua Pasqua.
2.2 Schiavitù e resistenza
Quando si parla della pasqua ebraica si ricorda l’epopea di un popolo libe-
rato, protetto e guidato da Dio. Mi permetto qui di far notare solo alcune cose,
8 In ebraico pesah,in relazione alla radice verbale che significa zoppicare, saltare (2Sam 4,4; 1Re פסח
18,21). In Es 12,13.23.27 YHWH salta le case con gli stipiti tinti di sangue, dove si stava celebrando la
Pasqua. 9 Dt 16,8-10
10 Es 13,3-8
9
piccoli dettagli che spesso si tralasciano e che sono a mio parere importanti, so-
prattutto alla luce della pasqua compiuta da Gesù.
Universalità. Innanzitutto nella pasqua ebraica non esce solo il popolo e-
braico dall’Egitto ma con Israele partì anche una gran massa di tante altre genti11
.
Dunque questa liberazione è universale fin dalle origini e ancor più lo sarà con la
liberazione portata da Dio attraverso suo Figlio.
Resistenza delle donne. Se si leggono le prime pagine dell’Esodo, inoltre,
si nota come il popolo ebraico venga sempre più schiacciato e reso schiavo dal
faraone, eppure quando il popolo finalmente griderà un lamento, esso risulta di-
sarticolato, non vi è alcuna invocazione verso un qualche dio come se il popolo
non fosse in grado neppure di pensarsi libero. Mentre gli uomini mostrano un at-
teggiamento passivo e fatalista, anche poco solidale tra loro12
, le donne, ancor
prima che Dio esca dal suo silenzio, hanno un ruolo attivo di resistenza, basti ri-
cordare le due levatrici di cui si ricorda perfino il nome, Sifra e Pua13
e la madre
di Mosè, che disobbediscono al faraone, la figlia del Faraone che si prende cura
del bambino, la sorella di Mosè, Miriam, che veglia da lontano e interviene al
momento opportuno. Allora anche nella pasqua di Gesù vedremo come gli uomi-
ni si lasceranno abbattere dalla paura, si nasconderanno, mentre le donne conti-
nueranno a seguire Gesù, lo veglieranno da lontano come Miriam, continueranno
a cercarlo e proprio a loro si mostrerà risorto.
Un lungo cammino. Dio mise in atto un lungo cammino pedagogico per
suscitare il desiderio di libertà nel suo popolo, perché riuscissero a credere che
fosse possibile uscire da quella terra di schiavitù. Strappare la schiavitù dal cuore
fu l’impresa più ardua. Uno stesso cammino pedagogico fu fatto fare da Gesù ai
suoi discepoli per liberarli da pregiudizi, dalla schiavitù della legge, affinché si
liberassero dalle immagini del Messia guerriero e liberatore e potessero cogliere
11 Cfr. Es 12,38
12 Es 1,11-14
13 Es 1,15. Cfr. L. MAGGI, Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile, Torino 2009.
10
il Messia mite ed umile di cuore14
. Da tempo Gesù comunicava ai suoi discepoli
la sua determinazione ad andare a Gerusalemme dove avrebbe incontrato la mor-
te, eppure essi continuavano a rimuovere, continuavano a litigare per i posti mi-
gliori15
, continuavano ad immaginarsi un Messia a proprio uso e consumo. Il suo
tempo è vicino eppure essi non capiscono: la verità spesso non la si vuole udire, è
assurda (ab surdus, sordo).
2.3 Fare la pasqua
v. 18 «Farò la pasqua da te con i miei discepoli». In greco al presente,
faccio. Questa espressione ha due significati: celebrare la pasqua ma è anche una
perifrasi semitica per dire fare l’agnello. L’agnello sgozzato è un elemento im-
portante nella pasqua ebraica e un segno teologico importante per quella cristia-
na. Simbolo di un banchetto ma anche di un pericolo scampato, il pericolo
dell’angelo sterminatore: allora questo simbolo è anche un ricordo tremendo, di
un Dio che stermina i primogeniti. Come comprendere questo Dio che sembra ri-
spondere colpo su colpo ai maghi del faraone ma non sembra distanziarsi così
tanto dalla violenza degli dei del tempo? La violenza è nel mondo, non in Dio. E
l’Agnello è l’offerta che Dio fa al mondo violento e distruttivo: non una violenza
ancora più grande, non il giudizio, non il castigo divino ma, con la croce, offre di
farsi carico fino in fondo di tutto il male, mostrando all’uomo fino a che livello di
malvagità può arrivare, mostrando anche, con la morte fuori dalla città santa,
morte fortemente voluta dai sacerdoti, la violenza che può annidarsi in ogni reli-
gione. Ora è il tempo dell’uccisione dell’Unigenito: l’Agnello sgozzato sarà ritto
in mezzo al trono e sarà degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché
immolato ha riscattato per Dio con il suo sangue uomini di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione16
. L’agnello, però, nella cena di Gesù, non viene menzionato e
questo rappresenta un indizio decisivo: per i cristiani d’ora in poi l’agnello pa-
14 Cfr. Mt 11,29
15 Mt 20,20-21
16 Ap 5,6.9
11
squale non è più quello che è consumato nella cena pasquale, ma quel Gesù che
con la sua morte reintegra la relazione dell’umanità con Dio.
12
3 Tradimento e dono
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità
io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha
messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne
va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene
tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». 25Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». (Mt 26, 20-25).
v. 20 «venuta la sera si mise a tavola». La sera, nei Vangeli, non è solo
indicazione temporale ma indica buio, incomprensione. Nel vangelo di Giovanni,
quando Giuda esce per andare a consegnare Gesù, si sottolinea appunto questo
buio, l’ora delle tenebre17
.
L’espressione si mise a tavola, letteralmente è sdraiatosi. Questo modo,
che sembra richiamare il modo greco-romano, è un segnale che mostra l’esser di
fronte a una cena pasquale che lo prevedeva: questo uso è un segno di libertà,
poiché solo le persone libere potevano mangiare in questa posizione, mentre gli
schiavi mangiavano in piedi o a terra. Troviamo lo stesso verbo nei racconti della
moltiplicazione del pane e dei pesci. In Matteo, infatti, troviamo due racconti,
una moltiplicazione in terra d’Israele (Mt 14,13-21), la seconda in terra pagana
(Mt 15,32-39) e in entrambi viene sottolineato come Gesù ordini alle folle di
sdraiarsi, da uomini e donne libere: i discepoli saranno i servi18
. Gli stessi disce-
poli avevano suggerito a Gesù di lasciare libere le folle perché potessero andare a
comprare cibo, seguendo una normale logica umana, poiché dopo la predicazio-
ne di Gesù, dopo il nutrimento dello spirito, facendosi tardi, bisognava pensare al
corpo. Gesù cambia verbo, vivendo nella logica del dono: date loro voi stessi da
mangiare (Mt 14,16) con un chiaro doppio significato. Gesù poi recita la benedi-
17 «Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte» (Gv 13,30).
18 Giovanni mette in luce come tema centrale dell’ultima cena questo essere servi attraverso la lavanda
dei piedi.
13
zione19
, rende grazie20
, spezza il pane, lo dà ai discepoli e i discepoli alle folle,
tutto in una terminologia tipicamente eucaristica.
v. 21 «mentre mangiavano». La stessa espressione si ritrova al versetto 26,
in cui avviene l’istituzione eucaristica. Questa ripetizione è dunque voluta poiché
in questo modo Matteo collega il momento del pane e del vino a quello
dell’annuncio del tradimento di Giuda, unendo così il tema della cena con quello
del tradimento e della morte.
Il verbo usato è παραδίδωμι cioè consegnare. In latino il termine è tradere
che è a sua volta consegnare, non propriamente tradire, che in latino si dice pro-
dere e in greco προδίδωμι. Giuda ha il compito di consegnare Gesù. Questa diffe-
renza semantica non può, però, essere usata per scagionarlo: il contesto è chiaro,
si sta consumando il dramma dell’amico21
che consegna l’amico alla morte. Ri-
cordare, però, con più fedeltà il testo evangelico permette un chiaro richiamo al
messaggio dell’eucaristia come un consegnarsi e come dono. È infatti in questo
momento, tra l’annuncio del tradimento di Giuda e il tradimento di Pietro, in cui
Gesù sceglie di spezzare il pane e donare il calice del nuovo patto.
Gesù si sta nascondendo con i suoi, poiché sta vivendo un pericolo ester-
no. Anche questo aspetto accomuna questa pasqua di Gesù alla pasqua ebraica,
ma ecco che Gesù introduce un elemento nuovo ma importante per questa cena:
il pericolo interno. Gesù è in pericolo mortale non perché altri lo cercano ma per-
ché qualcuno dei suoi l’ha già venduto. Questo tradimento non mette solo in pe-
ricolo la comunione di Gesù con i suoi discepoli ma anche la comunione dei di-
scepoli tra loro. Proprio in questo momento di tradimento, in cui il gruppo si è
diviso, Gesù pone un gesto di unità, di condivisione, di dono.
19 Mt 14,19
20 Mt 15,36
21 «E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Ge-
sù e lo arrestarono». (Mt 26,50)
14
Nella notte in cui fu tradito, celebra ogni comunità cristiana. Non si dice, nella
notte in cui fu arrestato, lo sguardo non è all’esterno, lo sguardo è sulla comuni-
tà. Non si può perdere di vista questo tradimento mentre si fa memoria di Cristo.
I primi a ricevere il pane e il vino sono Giuda, che lo tradisce, Pietro che lo rin-
nega, i discepoli che lo abbandonano e fuggono. Gesù accoglie i peccatori e si
dona a loro non quando chiedono perdono dei loro peccati e hanno ricevuto
l’assoluzione ma li accoglie e li nutre proprio perché sono peccatori. Questa cosa
ci scandalizza e spesso viene rimossa facendo della cena eucaristica la misura
dell’essere o meno in comunione con la Chiesa. Eppure Gesù non si è offerto per
una élite di persone che lo comprendevano, ma a persone confuse e peccatrici,
che proprio allo spezzare del pane, non prima, come i discepoli di Emmaus, lo ri-
conoscono, iniziano a comprendere e a vedere, non chiede conto della fedeltà, ma
nutre affinché siano fedeli. In Paolo la presenza di divisione umana e sociale ren-
de impossibile la celebrazione dell’Eucaristia e dunque l’espressione
«perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno, sarà
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso
e poi mangi del pane e beva dal calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere
il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna». (1Co 11,27-29)
non ha nulla di moralistico, ma riguarda l’ingiustizia nella comunità, dove non si
vive la condivisione. Questo testo, interpretato in maniera moralistica e estrapo-
lato dal contesto, ha causato e causa sofferenza per tante persone, che per la loro
situazione, si sentono indegni di avvicinarsi all’Eucaristia. Se facciamo divenire
l’eucaristia da divina medicina a pane dei puri tradiamo questa gratuità, tradiamo
un amore che oltrepassa tutto, saremmo come Giona che voleva restringere ai
buoni e ai puri l’amore di Dio.
Tornando al testo, colpisce il fatto che i discepoli chiedano a Gesù «sono
forse io?», come se non fossero sicuri di loro stessi, mostrando di sapere bene
che potrebbero cedere e non essere fedeli e, invece di rassicurare Gesù, sono loro
che chiedono a Lui rassicurazioni! Lo chiamano, però, Signore, cominciano, cio-
è, a riconoscere che Egli non è un semplice Rabbi, si stanno avvicinando a chi
15
realmente sia il Figlio dell’Uomo. Giuda non ce la fa. Di fronte a Gesù che non
lo accusa pubblicamente ma che gli offre un’ultima possibilità di tornare sui suoi
passi, si nasconde e si associa al coro, chiedendo anche lui «sono forse io?», ma
lui lo sta chiedendo al Rabbi, non al Signore che ha seguito, forse, nell’attesa di
una sommossa popolare o comunque aspettando che quest’uomo soddisfasse le
sue attese messianiche. Non vede oltre all’umano e compie la sua scelta.
16
4 Mangiatene tutti. La nuova alleanza
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane22
, recitò la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi
prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è
il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati9Io vi
dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo ber-
rò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». (Mt 26, 26-30).
Matteo sta scrivendo a una comunità giudaica, che conosce le Scritture.
Questi due segni posti da Gesù sono i nuovi segni dell’alleanza che richiamano
l’alleanza sul Sinai e i due segni posti da Mosè23
: il libro della legge e
l’aspersione con il sangue. Mosè ha preso un libro, una legge esterna, Gesù pren-
de un pane, alimento che diventa vita. Gesù, che si identifica al pane, non è una
legge, una dottrina a cui aderire, ma un alimento, l’alimento quotidiano di cui nu-
trirsi. Mosè ha imposto una alleanza tra servi e il loro Signore basata
sull’obbedienza alla legge di Dio; Gesù, il figlio di Dio, offre un’alleanza tra i fi-
gli e il loro Padre. La legge divide tra buoni e cattivi, tra puri e impuri. Con Gesù
il rapporto con Dio non è più basato sull’obbedienza di una legge che discrimina
tra le persone, ma sull’accoglienza di un amore. La legge non tutti la possono os-
servare, l’amore tutti quanti lo possono accogliere.
v. 26 «lo dava ai discepoli». Prima si parlava dei dodici, ora si parla di di-
scepoli. Non è solo una scelta stilistica per evitare ripetizioni, ma, come
nell’alleanza al Sinai, si aspergono i dodici in rappresentanza di tutto Israele poi
segue il pasto a cui sono invitati gli anziani del popolo, simboleggianti le nazioni,
22 In greco ¥rton, un pane, termine riferito al pane comune, lievitato, anche se viene detto che è la sera
degli azzimi. Per questo, seguendo l’antica tradizione, le chiese orientali usano per la divina Liturgia, a
differenza della tradizione occidentale, il pane lievitato. L'usanza di impiegare pane azzimo fu introdotta
in epoca piuttosto tarda, e solo nel IX secolo viene adottata da tutta la cristianità latina. La Chiesa cattoli-
ca fa uso di pane azzimo permettendo però alle chiese di rito orientale di usare pane lievitato. 23
Es 24,1-8.
17
e su loro scese lo Spirito, anche qui dai dodici in rappresentanza di Israele si al-
larga il dono, si invitano al banchetto tutte le nazioni24
.
«mangiate». Solo Matteo aggiunge mangiate; non basta prendere Gesù,
bisogna mangiarlo cioè assimilarlo. Quando si mangia, i vari alimenti, ognuno
con un nome diverso, colori e proprietà diverse, entrano nel corpo, cessano di es-
sere ciò che erano. Vengono assimilati (lat. ad similis), diventano come il corpo,
vengono incorporati, divengono una cosa sola con il corpo. In realtà siamo noi
che diventiamo ciò che mangiamo (siamo quel che mangiamo ha detto giusta-
mente Feuerbach). Il pane e la Parola sul pane ci trasformano. Pane e Parola. Ge-
sù dice al tentatore nel deserto di poter sopportare la fame perché ha parole da
mangiare25
. E l’angelo, nel libro dell’Apocalisse, dice al veggente di mangiare il
libro26
. Ci è precluso il paradiso da un mangiare il proibito, ci si riaprono le porte
dei cieli attraverso il mangiare la Pasqua di Gesù, il vero Agnello sacrificale che
si dona a noi nei segni del pane e del vino, non semplici elementi ma alimenti na-
ti dall’unione dei doni di Dio e l’opera umana, l’alimento di base e l’alimento
della festa, l’alimento della necessità e l’alimento della gratuità.
«questo è il mio corpo», toàtÒ ˜stin tÕ sîm£ mou: a cosa si riferisce il pro-
nome dimostrativo questo, toàto? Il termine pane, ¥rtoj a cui dovrebbe riferir-
si, è di genere maschile, invece questo, toàto è al neutro. Questo spazio gramma-
ticale dell’evangelista può essere spazio teologico e dunque non riferirsi sola-
mente al pane ma a tutta l’azione che lo accompagna, quindi la benedizione, lo
spezzare, il prendere, il mangiare. Questo è il corpo del Signore. Il corpo del Si-
gnore è la comunità dei credenti che prende il pane, lo benedice, lo spezza e si fa
pane per gli altri. La teologia di Paolo è proprio basata su questo.
24 Anche se Matteo non ne parla, sappiamo da Luca dei 70 discepoli inviati da Gesù (Lc 10,1) figura delle
nazioni in Gen 10 e dei 70 anziani di Israele in Es 24,1 (cfr. Nm 11,16 ss). Nei manoscritti di Luca si tro-
va sia 70 che 72; Luca può aver scritto 72 perché è il numero delle nazioni attestato in Gen 10 nella LXX
e ai 70 anziani al seguito di Mosè che ricevettero l’effusione dello spirito, si devono aggiungere i 2 assen-
ti che erano rimasti al campo, Eldad e Medad (Nm 11,25-26). 25
Mt 4,4 26
Ap 10,9
18
v. 27 «e prese il calice». Letteralmente: e prese un calice. Il termine calice
è già comparso nell’annuncio che Gesù ha dato della sua morte ai due figli di Ze-
bedeo: «potete voi bere il calice che io sto per bere?» (Mt 20,22). Il calice è sem-
pre associato alla morte di Gesù. Infatti Gesù nel Getsemani dirà: «Padre mio se
è possibile passi da me questo calice» (Mt. 26,39).
Gli esegeti hanno riflettuto a che punto della cena e su quale calice Gesù
abbia pronunciato le parole e, avvalorando la testimonianza di Paolo e Luca che
ricordano che Gesù prese il calice dopo aver cenato27
, concordano su quello che
nel rito ebraico si prende dopo aver cenato, la terza coppa di vino, definita la
coppa della redenzione che simboleggia il sangue dell’agnello che salvò Israele
dallo sterminio degli innocenti.
«bevetene tutti». Ciò che è da osservare, al di là del trovare il calice corri-
spondente, è che qui Gesù fa bere tutti allo stesso calice (l’haggadah pasquale
prevede invece un calice per ognuno), pone, dunque, un gesto nuovo nel rituale.
Non è sufficiente dare adesione a Gesù, mangiando il pane, ma è necessario an-
che bere al calice, condividere la sorte, condividere la sua vita.
v. 28 «perché questo è il mio sangue». Le parole di Gesù sono urtanti per un e-
breo: il sangue nel mondo ebraico è la vita ed esiste la proibizione assoluta di be-
re sangue28
, e nessun ebreo lo avrebbe fatto neppure simbolicamente. Nel vange-
lo di Giovanni, molti abbandonano Gesù dopo la sua dichiarazione: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita.» (Gv 6,53). Nel vangelo di Marco Gesù,
nell’ultima cena, prima passa il calice e invita a bere e solo dopo nomina il san-
gue29
.
«il sangue dell'alleanza». Luca e Paolo diranno della nuova alleanza, in
contrapposizione a quella antica. Matteo fa riferimento al rito di alleanza tra Dio
27 Lc 22,20; 1Co 11,25
28 Cfr. Gen 9,4-6; Lv 17,10-14 ; Dt 12,16
29 Mc 14,23-24.
19
e il suo popolo30
: il sangue di Gesù è sparso in remissione dei peccati. Invece del-
le due aspersioni compiute da Mosè, ve n’è una, in cui Gesù gioca un ruolo di
mediatore e di vittima, rappresentante messianico di Dio e, allo stesso tempo,
mediatore garante del popolo davanti a Dio: Gesù in persona garantisce la rispo-
sta di Israele. Diversamente da quanto era avvenuto ai piedi del Sinai, i discepoli
non sono aspersi con il sangue di Gesù, ma devono berlo: ciò significa che la
legge della nuova alleanza, cioè l’amore stesso di Gesù, deve entrare in loro, rea-
lizzando quella trasformazione interiore preannunciata da Geremia.
Solo Matteo sottolinea questo carattere sacrificale della cena pasquale:
«per il perdono dei peccati» è letteralmente in condono dei peccati, espressione
propria di Matteo. Il perdono presuppone un’azione dell’uomo; il condono è un
gesto unilaterale di Dio.
La tradizione liturgica latina ha, purtroppo, per vari motivi, tolto
l’accesso al calice ai fedeli dall'alto Medioevo fino al Vaticano II, facendo sì
che un segno di comunione divenisse segno di divisione soprattutto tra clero e
laici, dando origine a lotte intestine che hanno portato alla frammentazione
della cristianità in varie confessioni (una per tutti quella hussita). Sarebbe bel-
lo, come tutte le altre Chiese hanno mantenuto, in fedeltà agli insegnamenti di
Cristo, poter donare il pane e il vino ai fedeli in ogni celebrazione.
«Versato». Nella cena pasquale ebraica, dopo il quarto calice che veniva be-
nedetto e bevuto si recitava il salmo 79:
30 «Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il
libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: “Quanto il Signore ha ordinato, noi lo fa-
remo e lo eseguiremo!”. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: “Ecco il sangue
dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!”» (Es 24,6-8).
20
«versa l’ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il
tuo nome» (Sal 79,6)31
.
Con Gesù non si versa l’ira di Dio ma il sangue del Figlio, che si versa su tutti.
Al momento della morte di Gesù, tutto il popolo si prenderà la responsabilità del-
la sua morte dichiarando: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli
(Mt 27,25). Nella cena, il sangue di Gesù ricade sul suo popolo, ma non come
espressione di vendetta o di castigo, ma di perdono, perdono che viene esteso pu-
re ai colpevoli della sua morte. Ancora, questo verbo versare nella Bibbia viene
adoperato per indicare l’effusione dello Spirito: la vita stessa di Gesù entra in
noi, si fonde con noi e realizza quello che l’evangelista aveva presentato fin dal
primo momento: Gesù è il Dio con noi.
«per molti»: indica la moltitudine, pollo…, non significa non tutti32
. È un semiti-
smo e in ebraico questa parola (rabbim) significa le moltitudini, cioè tutti. Ha un
senso inclusivo e indefinito che possiamo trovare anche in altre parti delle Scrit-
ture33
. Nessuno è escluso dall’amore di Dio. Queste parole erano chiare fin
dall’inizio per i cristiani. Il rimando biblico è al Canto del Servo di Isaia34
: il pro-
31 Si è preferita qui la traduzione precedente della CEI (1985
6) alla nuova del 2008.
32 L’interpretazione del molti contrapposto a tutti proposta da Benedetto XVI in Gesù di Nazaret. Seconda
Parte. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione solleva forti riserve. Infatti, affermando che
l'eucaristia ha un differente raggio d'azione rispetto alla morte in croce di Gesù, una portata più limitata,
che raggiunge molti ma non tutti, si separa eccessivamente, restringendolo, il rito eucaristico dalla morte
e risurrezione redentrice. Inoltre la polemica che ruota attorno alla traduzione esatta delle parole di Gesù
non nasce da un problema esegetico bensì liturgico. Fin dall’antico canone romano la formula liturgica
della consacrazione del calice riunisce in sé il per molti presente in Matteo e Marco e il per voi di Luca
ma ciò in realtà non rispetta né tiene conto del senso originario dei contesti di destinazione del messaggio.
Le parole di Gesù, così espresse, non si trovano in nessuna scrittura neotestamentaria ma si tratta di un far
concordare due redazioni diverse per esigenze liturgiche.
D’altra parte, anche la versione in lingua italiana delle parole sul pane hanno aperto discussioni. Infatti, si
afferma: «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi», espressione assente dai testi biblici, assente
in ogni altra lingua, poiché assente nella versione latina dell’editio typica che si attiene invece al dettato
scritturistico: «Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur». 33
« Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli
altri alla vergogna e per l'infamia eterna» (Dn 12,2). Vedi anche Is 52,14-15. 34
«Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giusti-
ficherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli
farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli» (Is 53,11-12a).
21
tagonista, che dona la vita, preannuncia il Cristo della passione. In Gesù, ora Dio
mantiene per tutti le sue promesse.
vv. 29 «Io vi dico che d’ ora in poi non berrò più di questo frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». A diffe-
renza di Marco, Matteo aggiunge d’ora in poi a significare la svolta decisiva del-
la storia della salvezza. Aggiunge anche con voi: dopo questo pasto di alleanza,
sono un unico corpo: «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo» (Ger7,23).
In tutti i racconti della cena non compare mai la parola vino e molti stu-
diosi vedono in questo un tentativo di evitare qualunque riferimento alla cena pa-
squale. Il frutto della vite è il tema conduttore di una delle ultime parabole di Ge-
sù, quella contro i vignaioli omicidi che per interesse uccidono il figlio del pa-
drone (Mt 21,33-46).
Gesù non si limita ad annunciare la propria morte, ma prospetta il trionfo
su questa con una immagine di pienezza di vita, l’immagine del mangiare e del
bere insieme nel regno del Padre. Il frutto della vite è nuovo35
, il vino nuovo che
ha bisogno di otri nuovi per essere contenuto. Il messaggio di Gesù è così potente
che non si può inserire nelle vecchie strutture dell’istituzione religiosa e proprio
per esprimere la sua comunione con Dio avrà bisogno di creare qualcosa di origi-
nale.
35 (In greco kainÒn ). L’aggettivo nuovo nella lingua greca può essere espresso con nšoj che significa
giovane, aggiunto nel tempo, oppure con il termine usato in questo versetto, kainÒj, cioè senza preceden-
ti, di una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Lo stesso termine viene usato per indicare la nuova
alleanza in Luca (cfr. Lc 22,20) e il comandamento nuovo di Gesù (cfr. Gv 13,34).
22
Conclusioni
L’Eucaristia è un pasto in comune; in ogni passo delle Scritture in cui si
parla della cena del Signore, si parla sempre di un contesto domestico, c’è sem-
pre di mezzo una casa. E questa dimensione, questo clima di intimità e condivi-
sione familiare va riportata nel nostro far memoria. Nei secoli si è enormemente
ritualizzato il gesto di Gesù, caricandolo di tutto un apparato religioso, liturgico e
di norme precise che lo regolano. Ciò che Gesù ha istituito, però, è un pasto in
comune e il mangiare insieme è patrimonio di tutta l’umanità, riguarda la casa, la
quotidianità e questo pasto, nei primi secoli, veniva consumato nelle case dei fe-
deli, era lì che ci si riuniva. Nelle nostre liturgie non c’è danza, non ci si tiene per
mano, il bacio santo si è trasformato in una formale stretta di mano, esse diventa-
no spesso cerebrali; ci troviamo di fronte invece a un corpo donato, una vita par-
tecipata, un mangiare e bere condivisi che abbiamo fortemente ritualizzato: certo,
le ragioni che hanno portato a ciò possono essere storicamente giustificabili, inol-
tre nel rito si mantiene tutto l’essenziale, ma non tutta la ricchezza di ciò che si è
ritenuto superfluo.
Soprattutto, la celebrazione dell’Eucaristia non è un atto di devozione, ma
l’affermazione di voler vivere come Gesù è vissuto, di fare come Lui ha fatto.
Questo gesto, che la Chiesa compie per affermare la propria appartenenza
a Cristo, deve avere in memoria il tradimento, il conflitto alla base del gesto per
ricordare che da soli non possiamo essere comunità, abbiamo bisogno del suo
pane e il suo vino: il Signore, dunque, invita alla sua mensa, non nostra e non
chiede conto della nostra fedeltà ma vuole nutrirci per renderci
li. L’accoglienza eucaristica di fatto nel nostro tempo sta per essere progressi-
vamente scoperta in tutta la sua radicalità e saranno inevitabili contrasti e tempo
di assestamento (basti ricordare il contrasto tra il Vaticano e la Conferenza Epi-
scopale tedesca sulla riammissione dei divorziati ai sacramenti). Si tratta di una
mensa attorno alla quale ci si siede insieme: l’eucaristia non viene da noi, ma è
23
prima di tutto dono e azione dello Spirito che rende presente il Cristo tra noi.
Ogni celebrante ricordi che spezzare il pane e versare il vino è ciò che fanno i
servi, non i capi.
«E affinché comprendessimo che l’eucaristia è questo – altrimenti non è, ma si ridu-
ce a cena religiosa, sontuosità e falsità – Gesù ha anche affidato ai discepoli un ge-
sto che la spiega e la interpreta: la lavanda dei piedi. In quel curvarsi di Gesù, in
quel compiere il gesto dello schiavo nei confronti dei fratelli, Gesù ha detto parole
che risuonano anche per noi oggi: “Avete capito ciò che vi ho fatto?”, avete capito
che lo spezzare il pane e bere al calice è servizio ai fratelli, servizio quotidiano as-
sunto come stile, lo stile del Signore e del Maestro? L’eucaristia è questo! E se lo è
autenticamente, allora può solo essere fonte di riconciliazione, di comunione, di a-
more fraterno»36
.
L’eucaristia è tutto questo: pasto, dono, comunione, cibo di vita eterna ma
soprattutto presenza. Le varie e differenti comunità cristiane, fin dalle origini,
hanno riconosciuto il Risorto in mezzo a loro nello spezzare il pane. Per questo è
necessario che il momento fondamentale, culmine e fonte37
del vivere secondo
Gesù Cristo, non sia momento di separazione, ma di comunione fra tutti i suoi di-
scepoli, e che le differenze teologiche e giuridiche non siano di ostacolo alla
semplice parola di Gesù detta a tutti coloro che credono in lui: “Fate questo in
memoria di me”. Senza padroni, senza esclusioni.
36 E. BIANCHI, L'eucaristia, magistero del «ma voi non così», in Jesus n. 7, 07/2011, 83.
37 Cfr. LG 11
24
Bibliografia
Manuali e strumenti
BROWN, R.E, FITZMYER, J.A., MURPHY, R.E., Nuovo grande commentario bibli-
co, Brescia 20022, 1936
Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Brescia 20006, 2095
Autori e studi
ALVES, R.A., Parole da mangiare, Magnano (BI) 1998, 208
CASATI, A., Ospiti alla tua cena, Milano 2012, 316
CARTESIO, R., Discorso sul metodo, Cinisello Balsamo 2003, 720
JEREMIAS, J., Le parole dell’ultima cena, Brescia 1973, 368
MAGGI, L., Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile, Torino 2009, 156
ORSATTI, M., Solo l’amore basta, Milano 2001, 256
WELKER, M., Che cosa avviene nella Cena del Signore?, Torino 2004, 204
Risorse web
http://www.statusecclesiae.net/it/il-vangelo-che-abbiamo-ricevuto-
documenti/roma-relazione-di-g-ruggieri-la-questione-eucaristica-oggi/
http://www.statusecclesiae.net/it/il-vangelo-che-abbiamo-ricevuto-
documenti/eucarestia-e-comunita-testo-di-germano-pattaro/


























![VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI L’ANGELO [DEL SIGNORE] ALLA PISCINA DI BE¯THZATHA´/BE¯THESDA´ DI GERUSALEMME (GV 5,3B-4) E LA ‘GUERRA DEI SEI GIORNI’ (5-10 GIUGNO 1967)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63452beb6cfb3d4064098ef6/voci-dal-passato-per-loggi-langelo-del-signore-alla-piscina-di-bethzathabethesda.jpg)