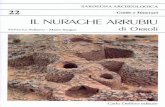Il fiordo inesistente. Il territorio di Crapolla in Massa Lubrense tra degrado ambientale e recupero...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of Il fiordo inesistente. Il territorio di Crapolla in Massa Lubrense tra degrado ambientale e recupero...
Pubblicazione periodica del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana, stampata con il contributodel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Campania
Direzione e Amministrazione: Via Annunziatella, 44 – 84011 Amalfi (SA) Tel. 089-871170 – Fax 089-873143
info@centrodiculturaestoriaamalfi tana. it @www.centrodiculturaestoriaamalfi tana. it
Direttore: Giuseppe Cobalto
Direttore Responsabile: Sigismondo Nastri
Comitato di Redazione: Domenico Camardo, Aldo Cinque, Rita Di Lieto, Crescenzo P.Di Martino, Salvatore Ferraro, Amalia Galdi, Olimpia Gargano, Antonio Milone, PasqualeNatella, Maria Russo
Segretario di Redazione: Michele Cobalto
In copertina: Maestro della Leonessa, Aff resco del Cristo Pantocratore (sec. XIV), Amalfi ,Cimitero Monumentale.
ISSN 1974-692XProprietà letteraria privataRegistrazione Tribunale di Salerno n. 533 del 09 marzo 1981
Stampa Tipolitografi a Giammarioli – Via Enrico Fermi, 10 – 00044 Frascati (Roma)
R A S S E G N ADEL CENTRO
DI CULTURA E STORIAAMALFITANA
51/52Gennaio-Dicembre 2016
Nuova Serie
XXVI (XXXVI dell’intera serie)
INDICE
Saggi
7 Documenti in scrittura amalfitana nell’archivio cavensedi Carmine Carleo
31 La «Porta del Mare» nella cinta muraria di Durazzo e la chiesa di S.Maria degli amalfitani: ipotesi di identificazione del sito
di Mario Gaglione, Eduard Shehi67 La società amalfitana in età normanna (1131-1194). VIII – 1135-1137:
Amalfi e Pisa in guerra – l’ascesa sociale di Scala e di Ravello di Giuseppe Gargano101 De tuitione regii demanii status amalphiae. Scrittura storico-legale
di Giovan Battista Confalone di Ersilia Fabbricatore145 Mazzeo Di Stasio (1532-1574): il diavolo è nei particolari di Giacinto Tortolani
Beni Culturali
171 Il disegno architettonico ed urbano della Costiera Amalfitana di Maria Russo203 Un modello di studio per la rete viaria storica: Pontone di Matteo Dario Paolucci247 Il fiordo inesistente. Il territorio di Crapolla in Massa Lubrense
tra degrado ambientale e recupero culturaledi Gaspare Adinolfi
Note e osservazioni
311 Nota in margine alla pubblicazione de “Il monello di Amalfi” di Angelo Tajani
di Gaetano Afeltra
315 Amalfi città creativa, una best practice nella politica
di conservazione urbana integrata del suo patrimonio culturale
di Teresa Colletta345 La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi, il primo poema epico
femminile nell’Italia del 1600
di Olimpia Gargano
Ricordi
353 Ricordo di Antonio Lombardi (1949-2016)di Giuseppe Cobalto e Marianna Balfour
Recensioni
363 Gaetano AFELTRA - Francesco JOVINE - Salvatore QUASIMODO, Amalfi Repubblica delle lettere (Alessandro Quasimodo); Francesco BATTIMELLI,I Battimelli (Pasquale Natella); Roberta BIGNARDI, Il funambolo in scena. Léonide Massine tra avanguardie e periodo “sinfonico” (Francesco D’Episcopo); Carmine CARLEO, I repertori delle pergamene dell’ArchivioCavense (Pasquale Natella); Angelandrea CASALE - Felice MARCIANO, Il sedile dei nobili di Ravello con particolare riguardo al Sei-Settecento (Alfredo Franco); Codex diplomaticus cavensis, vol. XI; Codex diplomaticus cavensis, vol. XII (Alfredo Franco); Maria Antonietta DEL GROSSO - Vittoria BONANI,Il verde antico e l’ampio Golfo di Salerno, celebrata meta dei viaggiatorieuropei. Cinquecento - Primo Ottocento (Giovanni Camelia); Michele DI GERIO - Aniello ANASTASIO, La pesca nel Mediterraneo antico. I popoli,le specie acquatiche e l’economia (Michele Cobalto); Carlo DI LIETO, La scrittura e la malattia. Il “male oscuro” della letteratura (Ugo Piscopo); Rita DI LIETO, Il lavoro delle Donne (Teresa Nastri); Dizionario Biografi co dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), I (A-Les), II (Lev-Z) (Giuseppe Gargano);Teodore Duclère 1812-1869. Disegni e dipinti dell’Italia meridionale nellecollezioni Correale (Pietro Paolo Paolillo); Michele MANCINO - GiovanniROMEO, Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiasticinell’Italia della Controriforma (Michele Cobalto); Fiorenzo FerdinandoMASTROIANNI, Insediamenti di Cappuccini e Cappuccine in Campania.Sintesi storiche (1530 – 2000) (Antonio Amatruda); Antonio e GianpaoloSCHIAVO, “co’ nu felillo ’e voce” - Ricordo di Mario Schiavo nel centenariodella nascita (Antonio Porpora Anastasio); Giacinto TORTOLANI, La ceramica a Vietri e nel Salernitano dal VI al XIX secolo (Rino Mele); SilvioZOTTA, Scacco al cardinale. Lo “stato” di Amalfi a rischio infeudazione(1611 e 1642) (Francesco Barra).
403 Biblioteca
405 Catalogo delle pubblicazioni
247
IL FIORDO INESISTENTEIL TERRITORIO DI CRAPOLLA IN MASSA LUBRENSE
TRA DEGRADO AMBIENTALE E RECUPERO CULTURALE
G A
Ricordando il prof. Carmine Conforti
Premessa
Riguardo alla Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturaledella Penisola sorrentina, a partire dal 2008 il Dipartimento di Via Mon-teoliveto della maggiore Università di Napoli ha coordinato, nelle personedi Stella Casiello e Valentina Russo, una ricognizione delle evidenze ar-chitettoniche ne Il fi ordo di Crapolla. Trascorso un quinquennio e più daquell’approdo specialistico, di cui già si dava conto a Massa Lubrense inuna autunnale Giornata di studî (2009), la navicella partenopea riprendeil largo e, solcata la rotta del Paesaggio come architettura, restituisceall’Istituzione fridericiana una particolare intelligenza sopra Identità e con-servazione del sito culturale di Crapolla.
Sulla scorta di una lettura incrociata dei resoconti stampati – prima per “Arkos”, trimestrale di ‘Scienza e restauro’ (luglio 2010), poi da NardiniEditore (dicembre 2014) – emerge, come in epigrafe, la nozione polisemi-ca di “Paesaggio”: è la stessa curatrice del volume bilingue a ricordarne,tra le altre, la defi nizione sancita nel 2000 dalla Convenzione Europea delPaesaggio: «“Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors» (chap. I, art. 1, let. a).
* Desidero ringraziare i proff . Felice Senatore, Enzo Puglia e Aldo Cinque per la letturacritica del testo in bozze e l’amico Francesco Raff aele per un paio di indicazioni bibliogra-fi che.
Gaspare Adinolfi
248
Recepito il dettato della Carta fi orentina, ratifi cata dall’Italia nel 2006,anche i contributi successivi all’Introduzione sembrano informare il vo-lume miscellaneo di quella unità d’intenti che – metodicamente mossa da«un riconoscimento dei plurimi valori del sito»1 e necessariamente matu-rata a traverso nuovi rilievi2 e inediti documenti3 – sostiene, fi nalmente, ilmonumento-Crapolla per «un’azione di tutela che, mediante la necessaria collaborazione con gli Enti di competenza, si estenda dall’ambito del pae-saggio a quello dell’architettura»4.
Per l’insenatura ai piedi di Torca si è dunque concertato un progettometadisciplinare che, in un certo senso, fa il paio con l’omologa propostaecomuseale concepita, oltre un decennio fa, per il non lontano territorioMalacoccola-Sant’Elia5. Chiusi entrambi gli elaborati nel cassetto dellebuone intenzioni, si ripresenta – almeno per gli ambientalisti6 – il dibattito
1 V. R , Il paesaggio di Apollo. Rischio, interpretazione, conservazione’, sintesi etraduzione ital. di Apollo’s landscape. Risk, interpretation, conservation’, in V. R (a curadi), Landscape as architecture. Identity and conservation of Crapolla cultural site / Paesag-gio come architettura. Identità e conservazione del sito culturale di Crapolla, Firenze 2014,(pp. 13-32), p. 377.
2 L’incomprensione circa «l’articolazione degli spazi dell’antica importante abbaziabenedettina» lamentata a Crapolla da S. C , Insediamenti benedettini nella Penisolasorrentina, in La Badia di Cava, a cura di G. F e F. S , Cava dei Tirreni 1990,pp. 373-402, rif. p. 392 sembra del tutto superata anche negli esiti grafi ci della più modernaelaborazione informatica (cfr. V. R , Memory and conservation of fragile ruins. The Ab-bey of St. Peter at Crapolla, in Landscape as architecture cit., p. 83, fi g. 15).
3 Tutti compulsati presso l’Archivio Storico Diocesano in Sorrento (d’ora in poi ADS), inau-gurato il 18 febbraio 2011 (cfr., tra gli altri, A. C , A Sorrento si aprono gli archivi dellaCuria, in “Agorà della Penisola Sorrentina” (Settimanale di informazione e cultura), a. XIV - n. 7,26 feb. 2011, p. 3. Per una lettura critica di tali fonti ms. giova avvertire che in più di un’occasionecitazioni e transunti proposti in R , Landscape as architecture cit. (in part. alle pp. 84 s.) nonrispondono, come già era stato in S. C - V. R (a cura di), Conservazione e valorizza-zione del paesaggio culturale della Penisola sorrentina. Il fi ordo di Crapolla, Atti della Giornata di Studi (Massa Lubrense, 14 novembre 2009), Numero speciale di “Arkos. Scienza e restauro”(Periodico trimestrale), luglio 2010 (ad es. a p. 80, nt. 22), ai più elementari criteri fi lologici.
4 R , Il paesaggio di Apollo cit., in E ., Landscape as architecture cit., p. 377.5 Cfr. G. G , Una proposta ecomuseale per il territorio Malacoccola-Sant’Elia, in
“Genius loci” (Annuario del Centro Studi e Ricerche F.M. Crawford) n. 5, Sant’Agnello2003, pp. 15-21.
6 Una rifl essione del WWF Penisola sorrentina sui temi in discorso, già partecipata allaTavola rotonda del 14 nov. 2009, si legge a p. 99 del Numero speciale di “Arkos” del lugliodel 2010.
Il fi ordo inesistente
249
sulla fruizione dei luoghi di pregio7: in questa sede si valuterà il solo casodel “fi ordo” di Crapolla, recentemente assurto all’attenzione dei media dimassa per il ritorno di fi amme dopo l’insolito ardore, fuor di metafora,dell’inverno 20158.
Per una migliore comprensione dei temi a seguire s’impone, a causapure di ricorrenti ambiguità terminologiche, una rifl essione sopra
La ria di Crapolla nel contesto geomorfologico della penisola diSorrento, con particolare riferimento al suo versante ‘amalfi tano’
Inserita tra due aree ribassate dalla tettonica (Piana Campana a Nord,Piana del Sele a Sud), la Penisola sorrentina inarca la sua dorsale carbo-natica dalla sella strutturale di Cava de’ Tirreni alla monoclinale calcareadel San Costanzo, ultimo rilievo di Massa Lubrense9. Tra queste estremitàterritoriali, rispettivamente proiettate verso i golfi di Salerno e di Napoli,detta Penisola copre una superfi cie di 298,74 km2 10 con andamento Est-Nord-Est/Ovest-Sud-Ovest.
L’intero sistema orografi co, impostato su potenti successioni di dolo-mie e calcari del Mesozoico, tocca i 1000 e più metri sul livello del marecon tre assi distinti dei Monti Lattàri (Avvocata - Finestra - S. Angelodi Cava; Cerreto - Cervigliano - Colle Sughero; Faito - Cerasuolo - Co-nocchia), fi no a superare i 1400 m col gruppo del S. Angelo a Tre Pizzi.
7 Vd. § Spunti fi nali di rifl essione sopra le recenti «Strategies for conservation and fruition enhancement» del sito di Crapolla, infra.
8 Cfr. Un patrimonio naturale in fumo. In due giorni bruciati ettari di vegetazione estoria: a fuoco Crapolla, San Costanzo e Torca, in “Agorà della Penisola Sorrentina” (Setti-manale cit.), a. XX - n. 292, 27 agosto 2016, p. 16 e infra, nt. 161.
9 La prima parte di questo paragrafo muove da G. A , Introduzione alla geologiadel comprensorio sorrentino-amalfi tano’, in I ., ′e vvie sulitarie. L’Alta Via dei Monti Latta-ri con Giustino Fortunato alpinista da Cava de’ Tirreni all’isola di Capri lungo la penisoladi Sorrento, Sorrento 2011, pp. 342-344 (con ampia bibliog. prec.) e G. A , Introduzio-ne alla geologia e alla geomorfologia del territorio di Punta della Campanella, in I ., Puntadella Campanella: Sito d’Interesse Comunitario o luogo di interessi particolari?, in I . - F.S , Promunturium Minervae (in margine a una nuova interpretazione di esskazsiúmin RIX St CM 2 e a i recenti restauri di Via Campanella), in “Oebalus. Studi sulla Campanianell’Antichità”, n. 10 (2015), Roma 2016, pp. 275-369, rif. a pp. 344-346.
10 Secondo F. C , La Penisola Sorrentina, vol. 1 dei “Quaderni del Laboratoriodi Geografi a Economica dell’Istituto Universitario Navale di Napoli”, Napoli 1968, p. 80.
Gaspare Adinolfi
250
Quote, queste ultime, che non impressionerebbero i fi siografi se i fi anchidelle culminazioni orografi che non fossero generalmente acclivi, in speciesul versante meridionale. Per contro, il deposito di Ignimbrite campana ha colmato e così addolcito (ca. 40.000 anni fa) la depressione tettonica com-presa fra Meta ed il capoluogo peninsulare11.
Passato il terrazzo di tufo grigio, la Penisola va rastremandosi verso Termini dove, superati i terreni terziarî della frazione lubrense, immergeverso l’isola di Capri, suo naturale prolungamento12. A Punta della Cam-panella è dunque il termine geografi co ma non geologico della Penisola,che nella sua unità morfo-strutturale ‘riemerge’ con la propaggine nord-orientale della più celebre isola del Golfo partenopeo.
Evitando di retrocedere nel tempo fi no al Pleistocene medio (700.000-120.000 a.C.), epoca dello sprofondamento tettonico che determinò l’insu-larità di Capri13, basterà portarsi verso l’Ultima glaciazione del Quaternario(70.000-15.000 anni fa) per constatare che, durante il progressivo ritirarsi del mare (la massima regressione avvenne 18.000 anni fa: -120 metri), Ca-pri risultò collegata alla terraferma a partire dal superamento dell’isobatadei 70 metri: la sella che unisce l’Isola alla Penisola (P.ta Baccoli), oggi sommersa, corre proprio a quella profondità14.
Nello stesso torno di tempo, ci riferiamo al Würm, i torrenti che scor-revano lungo il versante meridionale della Penisola hanno ulteriormente approfondito le loro stesse valli, o gole, toccando livelli inferiori all’attualequota zero e «creando così le premesse – spiega il prof. Aldo Cinque – per la comparsa di quelle strette insenature (vedi i casi di Furore, Praia eCrapolla) dovute alla sommersione delle antiche foci ad opera del mare in
11 Cfr. A. C - G. I , Storia geologica del «Piano» di Sorrento e della suafalesia, in Piano di Sorrento. Una storia di terra e di mare, Atti del I, II e III ciclo di confe-renze (2010-2011) sulla storia del territorio di Piano di Sorrento e della Penisola Sorrentina,a cura di C. P e F. S , Roma 2012, pp. 1-27.
12 Cfr. A. C (a cura di), Guida alle escursioni geomorfologiche. Penisola sorren-tina, Capri, Piana del Sele e Monti Picentini, Atti della Riunione annuale del Gruppo Na-zionale Geografi a Fisica e Geomorfologia (Amalfi , 9-12 giugno 1986), Napoli 1986, p. 49.
13 Cfr. A. C , Assetto geologico e geomorfologico della Penisola Sorrentina, inC. A L (a cura di), Archeologia a Piano di Sorrento. Ricerche di Preistoria eProtostoria nella Penisola Sorrentina, Catalogo della mostra (Piano di Sorrento, 7 dicembre1990 - 20 gennaio 1991), Napoli 1990, p. 17.
14 Cfr. A. C , Evoluzione del paesaggio nel corso del Pleistocene Superiore edell’Olocene, in A L (a cura di), Archeologia a Piano cit.
Il fi ordo inesistente
251
risalita»15. È con tale risalita (trasgressione marina), conclusasi circa 5.000 anni fa, che i valloni di erosione torrentizia assurgono a rías16 – impropria-mente detti fi ordi17.
Un tentativo di tutela itinerante: da Punta della Campanella a Crapolla
Sotto l’alto patronato di Minerva18 si naviga idealmente, suggeriamo inkajak19, tra le diverse falesie della Baia di Iéranto20. Una serie di faglie tradi loro ‘parallele’ ha sdoppiato l’originaria unità strutturale in due minori monoclinali, che seguono lo stesso orientamento (N-E S-W) e la medesimaimmersione degli strati (N N-W)21.
I tempi orogenetici, è noto, non sono quelli dell’uomo; tuttavia, le forzetettoniche intercorse per dislocare a levante il braccio tricuspide di Iéran-to (Mortella-Montalto-Penna) rispetto al fi anco meridionale del monte S.
15 A. C , Viaggio nella geologia della Costiera Amalfi tana, in Il sentiero degli Dei.Documenti ′99, Catalogo della mostra a cura di M. B , Agerola 1999, (pp. 9-15), p.15; per lo specifi co episodio di Crapolla cfr. A. C - P. R , Segnalazione di nuoveevidenze di antiche linee di riva in Penisola sorrentina (Campania), in “Geogr. Fis. Dinam.Quat.”, 13 (1990), (pp. 23-36), p. 31.
16 Cfr. pure N. R , Natura, ambiente, paesaggio, in N. R , Parco Regionale dei Monti Lattari. Guida al territorio, Pescara 2008, p. 27.
17 «I fi ordi sono invece delle valli di escavazione glaciale nelle quali entra poi il marequando il suo livello risale. In Italia i ghiacciai non sono mai scesi fi no al livello del mare ed in Italia del Sud, in particolare, durante le fasi climatiche più marcatamente fredde, si sonoavuti piccoli ghiacciai solo sulle cime appenniniche che superano i 1600 metri», avverte lostesso A. C in Breve storia geologica dei Monti Lattari, articolo pubblicato il 27 aprile2006 sul blog “da Jerula ad Agerola” (visitato il 15 sett. 2016).
18 «Ex quo alta procelloso speculatur vertice Pallas» riferisce L.A. S , Epist.,LXXVII, 2. Per un approfondimento sopra il carattere marittimo de Il culto di Atena a Puntadella Campanella, a fi rma di F. S , cfr. G. A - F. S , L’incanto delleSirene, a cura di C. P , Napoli 2014, pp. 85-87.
19 Dunque avvalendosi di G. V , Le coste di Sorrento e di Amalfi . Toponomasticaantica moderna e dialettale, Napoli-Milano 1991, cap. V.
20 Strutturale la prima (Monte S. Costanzo), morfologica la seconda (Punta Penna): cfr.L. B , Note di morfologia costiera sulla cala di Ieranto presso Punta Campanella(Penisola Sorrentina), in “Bollettino della Società Naturalisti in Napoli, LXXVI (1967), pp.255-269.
21 Cfr. ibid., pp. 255 s.
Gaspare Adinolfi
252
Costanzo22 (fi g. 1), hanno pure destabilizzato le già vaghe nozioni topogra-fi che degli autori antichi, se è vero che «il promontorio di Ieranto, e non ilsuccessivo promontorio Ateneo, fu considerato il discrimine tra il golfo di Cuma e quello di Poseidonia»23.
Qualunque sia stato il Finis terrae di Sorrento costeggiamo ora la fale-sia strutturale del S. Costanzo24, distratti da una teoria di cavità più o menoemerse sopra il livello del mare, la più nota delle quali è la “Grotta delPresepe”25. Possiamo invece solo immaginare le grotte sommerse, altret-tanto numerose e interessanti26.
Sul fondo della Baia incombe il cono detritico che il S. Costanzo ro-vesciò nell’ultimo periodo glaciale (Würm)27: nella coltre di frammen-ti cementati fa breccia l’azione marina, che ha così contribuito alla for-mazione della leggendaria spiaggetta di Mangalà28 (non vi è consentito
22 Ciò dovette verifi carsi dalla fi ne del Pleistocene inferiore al medio Pleistocene, te-nendo presente che a partire da 120.000 anni fa la Penisola entrò nel periodo di stabilitàtettonica che ancora perdura (cfr. C , Evoluzione del paesaggio cit., p. 19).
23 B. D’A , Le sirene e la scoperta della Penisola sorrentina, in “La Terra dellesirene” (Bollettino del Centro di studi e ricerche “B. Capasso”) n. 9, Sorrento 1994, pp. 14s. Sulla vexata quaestio dello «scoglio a tre punte» (skópelos trikóryphos) di eratostenicamemoria (apud S ., Geog., I 2, 12) cfr. da ultimo F. S , Il santuario delle Sirene inPenisola Sorrentina’, in A -S , L’incanto delle Sirene cit., pp. 53 ss.
24 È quella impostata su un versante di faglia, ragion per cui essa mostra in elevato lacaratteristica giacitura a reggipoggio dei blocchi calcarei: cfr. B , Note di morfolo-gia cit., pp. 257 s.; C (a cura di), Guida alle escursioni cit., p. 49.
25 Cfr. V , Le coste di Sorrento cit., p. 116. Questa cavità di erosione marina fi guranell’elenco catastale delle Grotte naturali della Campania: CP 1043 in Grotte e speleologiadella Campania. Atlante delle cavità naturali, a cura di N. R , S. D P , I. G e A. S , Avellino 2005, p. 608.
26 Al contributo illustrato di L. C , Le grotte nella baia di Ieranto, in “Antiqua”(pubblicazione bimestrale dell’Archeoclub d’Italia), a. VII - n. 2, marzo-aprile 1982, pp.14-21 seguirà la puntuale ricognizione di F. A , Esplorazione delle grotte marine traPunta Campanella e Positano, in “Notiziario sezionale” del Club Alpino Italiano - Sezionedi Napoli, n. 3, dic. 1989, pp. 8-15.
27 Cfr. B , Note di morfologia cit., pp. 260-263 e 266; C , Le grotte nella baia cit., p. 19; C -R , Segnalazione di nuove evidenze cit., p. 32.
28 «The beach is long and straight, but not deep, ending abruptly at each side below gi-gantic cliff s, and backed by a perpendicular wall of fl inty rock», F.M. C , Coasting bySorrento and Amalfi . With pictures by Harry Fenn, in “The Century Magazine”, vol. 48, issue3, july 1894, p. 328; il brano è anticipato, poi seguito, da un suggestivo profi lo de «the old manof Ellera, who lives in his cave over the sea from May to November» (la preziosa testimonianza
Il fi ordo inesistente
253
l’approdo29), e contribuisce, impercettibilmente, all’arretramento della li-nea di costa. A questa azione erosiva si oppone, da par suo, una crescenteprateria di Posidonia, che da ottima pianta superiore ossigena dai fondali le acque dell’Area Marina Protetta e dissiperebbe, nel collettivo a matte, l’impeto del moto ondoso rivolto alla terraferma30.
Invertendo la rotta, in pochi colpi di pagaia si è al traverso del Ca-pitello, abbastanza isolato come capo da esser scambiato per un isolottodal Gabbiano corso (Larus audouinii(( )31, che vi staziona fi no a quando nonha inizio la stagione balneare o il mobbing del congenere L. michahellis. Allora il promontorio piccolo tra i promontori grandi torna ad essere un de-posito a cielo aperto di testimonianze paleontologiche32 ed archeologiche33, sulle quali crescono in primavera alcune orchidee spontanee34.
odeporica si ripropone, tradotta in italiano da A. Calvano, nella crawfordiana antologia In bar-ca a vela da Sorrento ad Amalfi ed altre storie, a cura di A. C , Capri 2004, pp. 28-31).
29 Un’immagine eloquente del divieto si coglie in R. P , Le 100 spiagge della Costiera Amalfi tana da Vietri a Punta Campanella, Amalfi 2008, p. 164.
30 Per una prima comprensione dell’importanza ecologica rivestita non da un’alga, mada una fanerogama, si legga Le praterie sommerse del Mediterraneo, a cura del Laboratoriodi Ecologia del benthos della Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli, Ischia 1986.
31 Poiché esso «nidifi ca su piccole isole e scogli isolati e mai o quasi sulla terraferma»(F. P , Esclusi dall’arca. Animali estinti e in via di estinzione in Italia, Milano 1978,p. 207) rimandiamo a V. C - D. Z - C. D’A , in M. F -D. M (a cura di), Atlante degli uccelli nidifi canti in Provincia di Napoli (2007-2009), Monografi a n. 9 dell’Associazione Studi ornitologici Italia Meridionale (ASOIM),[Pozzuoli] 2010, p. 116, i quali hanno rilevato la presenza e l’attività riproduttiva del rarocaradriforme sugl’isolotti di Isca e Vetara (Massa Lubrense).
32 «Sul piccolo promontorio che divide in due il fondo della insenatura è conservato unpiccolo lembo di scogliera a Cladocora legato ad un solco di battigia posto a circa 8 metri diquota», si osserva in C (a cura di), Guida alle escursioni cit., p. 49 riguardo alla presenzaidi coralli fossili.
33 Cfr. da ultima T. B , La ricerca archeologica in Penisola sorrentina: un contri-buto per la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio antico, in C -R (a curadi), Conservazione e valorizzazione cit., pp. 37 s.
34 Nel mese di aprile 2015 sono state rilevate dallo scrivente Anacamptis pyramidalis(L.) Rich., Ophrys sphegodes OO subsp. classica (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz, Orchisitalica Poiret e Serapias lingua L., tre delle quali già note per la vicinissima Punta Penna: cfr.E. F , La Baia del Fiore sacro, Napoli 2007, passim.
Gaspare Adinolfi
254
Nel tentativo di fi ssare a Capitello l’ubiquitario santuario delle Sirene35, la benemerita coppia di studiosi Mingazzini-Pfi ster vi raccolse, tra le altre,una scheggia di ossidiana usata come raschiatoio: «documento del traffi comarittimo che già in tempi preistorici toccava questa insenatura»36. Il recuperoagli studî di questo strumento di vetro vulcanico se litologicamente indirizza aPalmarola, possibile giacimento del reperto, come crede lo stesso Mingazzini,culturalmente rimanda ad altri insediamenti (neolitici) che hanno restituito lamedesima roccia ignea, tra i quali emerge l’offi cina caprense a Le Parate37.
La conoscenza di un siff atto documento litico ci sarà d’ausilio, in pro-gresso di spazio, a comprendere la distribuzione ed il numero dei ricoverirupestri; ed a distrarci, nel frattempo, dalle più note tradizioni dei luoghimitici. Alla demolizione di questi ultimi, tanto per cominciare, concorre mezzo secolo di attività estrattiva nel più meridionale dei Tre Pizzi, cheoff re oggi alla Baia l’enorme fauce rocciosa spalancata a colpi di dinamite:«La marina di Jeranto – osservava Gino Doria nel lontano 1927 – ha giàperduto la purezza classica del suo contorno e sempre più le mine scavanoi fi anchi della montagna come un tarlo inesorabile»38.
L’estiva ma non estemporanea denuncia del bibliofi lo napoletano nonscalfì, per quanto ne sappiamo, le coscienze imprenditoriali; vano fu pure l’appello di un altro lungimirante uomo di lettere, Edwin Cerio, che dalle colonne del quotidiano “Il Mattino” prima informava che a Iéranto «esplo-dono le mine, e la montagna si deve lacerare, perché occorre il pietrameper le massicciate delle strade, occorrono i blocchi per le opere portuali»,quindi faceva voti affi nché Autorità ed Enti preposti alla tutela del pae-
35 Sull’argomento, ancora dibattuto, cfr. da ultimo F. S , Il santuario delle Sirene in Penisola Sorrentina, in A -S , L’incanto delle Sirene cit., pp. 53-84.
36 P. M - F. P , Forma Italiae. Regio I - Latium et Campania, vol. II - Sur-rentum, Firenze 1946, p. 85.
37 Cfr. A. L - V. M , Le ossidiane di Capri: origine e composizione, in Ca-pri antica. Dalla preistoria alla fi ne dell’età romana, a cura di E. F ed E. M ,Capri 1998, pp. 61-66; C. G , L’isola di Capri dal Neolitico alla prima età del Ferro,ibid., pp. 78-79 (con successive note e bibliog. prec.); C. S , La preistoria a Capri.Cronaca delle ricerche all’epoca di Ignazio Cerio, Capri 1999, passim.
38 G. D , Figure di paesi, “Il Giorno”, Napoli 20 luglio 1927; il ritaglio dell’articolosarà applicato dallo stesso autore in Ricordi di una escursione nella Penisola Sorrentina (14-15 luglio 1927), una cartella di 19 fotografi e originariamente eseguite da Guido Spinazzolasibi et suis amicis, poi digitalizzate da G. Visetti per gli utenti del blog Discettazioni erranti(visitato il 24 sett. 2014).
Il fi ordo inesistente
255
saggio «vorranno salvare l’integrità d’un luogo il cui nome solo rievoca la grandiosità d’un tempio e lo splendore d’un culto di cui sopravvive solo laBellezza, divinità immortale» (Napoli, 5 marzo 1937)39.
In realtà le attività estrattive intraprese qui e altrove, lungo la medesimacosta40, non cessarono neppure in forza della Legge sulle “Protezione dellebellezze naturali” (29 giugno 1939 - nr. 1497) o in ossequio dell’art. 9 dellanostra Costituzione (1948), tant’è che si dové attendere fi no alla metà inol-trata del secolo per salutare l’abbandono defi nitivo del sei volte decennalecantiere di Iéranto (ca. 1895-1954)41.
Allo squarcio della cava si è tentato di rimediare applicando una pezza acolori, cioè a verde: il recupero vegetazionale iniziato nel ’90 ha celato di pocol’incelabile voragine a cielo aperto42, pur stimolando inaspettate fi tocenosi43.
Sull’opposto versante del promontorio sfregiato è la falesia di Montal-to44, aereo ricetto del Falco pellegrino45. È l’unico uccello stanziale capace
39 Devo il possesso di una riproduzione digitale dell’art. cit. alla cortese disponibilitàdel Centro Documentale dell’Isola di Capri, nella persona di Enzo Di Tucci.
40 Per un elenco puntuale cfr. S. R , La costa lubrense tra incanto e disincanto, in P. E - S. R (a cura di), La Lobra, culla della città di Massa Lubrense, Castel-lammare di Stabia 2000, pp. 173-175.
41 Cfr. in part. A. D A , Ieranto, in I ., Contatti, persone e personaggi nella terradelle sirene, Capri 2003, pp. 179-197.
42 Non va dunque taciuta la proposta di un più generoso ripristino ambientale avanzatada Giulio Pane («recovery of the natural morphology»), come lo stesso docente di Storia dell’Architettura ricorda in Fuenti, Jeranto, Ravello auditorium: three equivocal cases of landscape protection, in R (a cura di), Landscape as architecture cit., pp. 324-327.
43 Cfr. da ultimo G. A , Le orchidee spontanee della Penisola Sorrentina. Un iti-nerario a pretesto sui Monti Lattari, in “La Terra delle Sirene” (Rivista del Centro di studi ericerche “B. Capasso”), n. 29, Sorrento 2010, (pp. 85-100) pp. 90 s.; I ., A passeggio col mito.Itinerari tematici in Penisola sorrentina, in I . - S , L’incanto delle Sirene cit., pp. 128-131.
44 Altra falesia strutturale: cfr. L. B , Genesi e caratteri delle forme costie-re nella Penisola Sorrentina, in “Bollettino della Società Naturalisti in Napoli”, LXXVII(1968), (pp. 247-274), pp. 259-260.
45 Cfr. G. F - L. F , Avifauna costiera e migratrice, in V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit. (pp. 253-263), p. 257. Per approfondimenti rimandiamo a C. M -
- G. M , Biologia e conservazione del Pellegrino (Falco peregrinus(( ) sui Monti Lat-stari, Sorrento 1999; M. F , Falco pellegrino (Falco peregrinus(( )s , in I .-M(a cura di), Atlante degli uccelli cit., pp. 102-105.
Gaspare Adinolfi
256
di rintuzzare l’aggressiva presenza del Gabbiano reale46 o di dirottare laPoiana, altro rapace diurno, verso areali meno precipiti. Sulle pareti stra-piombanti di Iéranto si intravede il Pellegrino nidifi care, o spiccare il voloverso prede che ghermisce in fulminea picchiata, meritando così il primato di animale più veloce al mondo47. Ribaltando la prospettiva, esso off re allelenti del birdwatcher una sagoma scura, che fende o asseconda le correntied i fl ussi dell’aria contraendo o distendendo la superfi ce alare, chiudendoo aprendo a ventaglio le penne timoniere. Così facendo può capitare che,ammirando il volo di un falconide dall’alto di monte S. Costanzo, si pensi di metterne a confronto la sagoma col profi lo ornitomorfo dei Tre Piz-zi48, magari recuperando il microtoponimo Falconera, associato dal Per-sico a «Montealto […] perche ivi li Falconi fanno i loro nidi»49, oppure rammentando l’etimologia con cui l’autore della monumentale Storia di Massa Lubrense, ricusato un prudente «hierón»50, propone un coraggioso
46 Cfr. G. C , La fauna terrestre, in Coste marine rocciose. La vita fra le roccee salsedine, vol. n. 7 della collana “Quaderni habitat”, a cura di A. Minelli per il Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per il Museo Friuliano di Storia natura-le - Comune di Udine, ivi 2008 (I ediz. 2004), pp. 88-92; D. D R , Gabbiano reale (Larus((michahellis)s , in F -M (a cura di), Atlante degli uccelli cit., pp. 118 s.i
47 Cfr. tra gli altri P , Esclusi dall’arca cit., p. 137.48 Secondo R. P , Sorrento e la costa, Napoli 1955, p. 38 «La caratteristica del mo-
vimentato promontorio che forma la piccola insenatura di Jeranto è specialmente visibiledalla marina del Cantone con la sua curiosa e rara conformazione a strapiombi successivi».
49 G.B. P (a cura di), Descrittione della Città di Massa Lubrense, Napoli 1644, cap. IX, p. 41. Ci risulta diffi cile ricondurre l’osservazione del primo storiografo di MassaLubrense nell’àmbito della zoofi lia o della disinteressata ornitologia: riteniamo, piuttosto,che l’A. della secentesca Descrittione fosse ben informato sopra pratiche legate alla fal-coneria (cfr. ad es. M. C , Annali delle Due Sicilie dall’origine e fondazione dellaMonarchia fi no a tutto il regno dell’augusto sovrano Carlo III Borbone, vol. I, Napoli 1841,p. 194), già documentate per la seconda metà del XIII sec. (cfr. in part. C. M R , Brevi notizie intorno all’Archivio angioino di Napoli dopo le quali si pubblica per la primavolta parte di quei registri ora non più esistenti, Napoli 1862, p. 86), e richiamate nell’ul-tima rubrica «De nisis seu spreveriis deperditis» delle antiche Consuetudini della Città di Sorrento, raccolte agli inizi del Trecento e impresse nel 1869 a cura di Luigi V ; sull’argomento cfr. V. R , Sorrento medievale, Sorrento 1978, pp. 49-50.
50 Cfr. pure F.S. M , Massalubrense antica, a cura di B. I , Aggiuntavi laprima traduzione italiana de La costa fi no all’Ateneo di Julius Beloch, Massa Lubrense1977, p. 23 (la 1ª ediz. dell’opera maldaceana fu impressa nel 1881).
Il fi ordo inesistente
257
«iérax», falcone51, per giungere – omettendo la trafi la linguistica – all’o-dierno Iéranto. Si converrà che tale esegesi52, qualora non fosse esatta, hail pregio della originalità.
Aggirata la Punta turrita53 è la caletta di Mortella, diff usa stazione delmirto eponimo e sede perduta, ma non del tutto, di una tonnarella all’i-taliana54. Fu dismessa entro la prima metà del Novecento55, quando tra ipesci irretiti si trovò di tutto tranne il tonno, ironizza Douglas, «which has wisely ceased to visit these regions»56.
Ancóra più diffi cile è supporre che i grandi pelagici transitanti da questeparti abbiano variato il regime alimentare del primo Homo della Penisola,frequentatore non occasionale della prossima grotta dello Scoglione. Essa,a causa di un potente riempimento, di primo acchito sembra solo un riparosotto roccia, malcelato dalle conifere che vorrebbero stabilizzare la faldadetritica aperta, a ferro di cavallo57, sotto gli ultimi terrazzi agricoli di Spri-to. In realtà quella dello Scoglione è una cavità in cui, dal piano superioredi stalagmite al piano inferiore di spiaggia fossile58, si leggono almeno trelivelli con industria musteriana (Paleolitico medio), il più antico dei quali
51 Cfr. R. F C , Storia di Massa Lubrense, Napoli 1910 (rist. anast.Napoli 1991), p. 96, nt. 1.
52 Ripresa poi, non senza una confusione tra fonti (Gargiulli-Persico), da P. ZM , Monete antiche della Campania, in M. R , Punta della Campanella.Epigrafe rupestre osca e reperti vari dall’Athenaion, a cura di P. Z M , Roma1990, pp. 273-274.
53 Per inquadrare la cd. ‘Torre Isabella’ (m 110 s.l.m.) nel contesto del locale sistemafortifi cato rimandiamo essenzialmente a R. E , Le torri anticorsare vicereali, in “Ge-nius loci” cit., n. [3], Sant’Agnello 2001, pp. 31-33 ed I. M , Le torri costiere inpenisola sorrentina, ivi, pp. 34-38.
54 Cfr. B. C , Le Città del Mare. La pesca con le tonnare in Italia, Cava de’ Tirreni1999, pp. 46 ss. (con bibliog. prec.).
55 Nel 1929, secondo V , Le coste di Sorrento cit., p. 121.56 N. D , Siren Land, London-New York 1911, cap. VIII, p. 155.57 Nell’àmbito delle unità quaternarie depostesi «dopo la fi ne dei moti surrettivi e disgiun-
tivi nella dorsale dei Monti Lattari» si metta a confronto questo episodio con il cono detriticoosservato a monte della spiaggia grande di Iéranto (vd. nt. 27, supra), anch’esso indicato conla sigla CNa3 nel Foglio 466-485 ‘Sorrento-Termini’ della Carta geologica d’Italia (2014).
58 Secondo F. F , Penisola Sorrentina. Nerano, in Campania archeologica. Guida turi-stica, a cura di F. F e G. G , Novara 1984, p. 16, trattasi di «un lembo di spiaggia‘tirreniana’ interglaciale»; tracce di paleolivelli marini si osservano, nel settore costiero fra Iscae P. Penna, a circa m 6 s.l.m.: cfr. C -R , Segnalazione di nuove evidenze cit., p. 32.e
Gaspare Adinolfi
258
associato a resti di grandi mammiferi terrestri59. Cervi, stambecchi ed orsi,in eff etti, ebbero agio di brucare e di cacciare dalla terraferma a Capri fi ndall’età glaciale del Riss (250.000 - 150.000 anni fa), come attesta il giaci-mento paleontologico sottostante l’hôtel Quisisana60, non confrontato conl’omologo, benché misconosciuto, sito della marina di Nerano61.
La presenza dell’uomo di Neanderthal allo Scoglione anticipa dunquequella di un altro troglodita locale, che trovò ricovero, appena più a monte,nella grotta erroneamente detta delle Noglie62. Qui, tra la fi ne degli anniCinquanta e la prima metà degli anni Sessanta del ’900, la studiosa olande-se Maria Wilhelmina Stoop, ravanando in un modesto castellum aquae –da cui il vernacolo ’rotta [d’] ’o Castiello –, rilevò tracce di frequentazioneantropica: rimontavano a periodi distinti entro l’Età neolitica e la primaEtà dei Metalli, giusta la presenza di alcuni frammenti ceramici (tipici ad es. dello stile di Diana Bellavista)63 e di scarso materiale litico (due lamette
59 A.M. R , Campania. Penisola Sorrentina, in “Rivista di Scienze preistoriche”,vol. XX - fasc. 2, Firenze 1965, p. 366; I ., Campania. Penisola Sorrentina, ibid., vol. XXI - fasc. 2, Firenze 1966, p. 419.
60 Cfr. C. B , Mammiferi e molluschi continentali pleistocenici dell’isola diCapri (Campania, Italia), in Almanacco caprese n. 6, Capri 1993, pp. 23-31 e, per l’effi cacecorredo grafi co a supporto dei testi, Capri preistorica (300.000-3.000 anni fa), a cura di F. B , M. P , C. S , Capri 2005, pp. 34-37.
61 «Dove si ritrovò un cadavero d’un Gigante», testimonia P , Descrittione cit.,cap. IX, p. 42; episodio ricordato, in relazione al preteso museo paleontologico di Augustoa Capri (cfr. S ., Aug. II, 72), da N. C , Storia delle Due Sicilie dall’antichità piùremota al 1789, t. II, Napoli 1845, p. 451, nt. 3. Altre indagini presso «la marina di Neranoverso il golfo di Salerno» mostrarono a C. B , Monumenti antistorici scoverti dal 1863al 66 nelle Province napoletane, Napoli 1866, p. 7 «giganteschi ossami di animali diluviani»(devo la consultazione di questo opuscolo alla cortese disponibilità del Centro Caprense “I.Cerio”, nella persona della dott.ssa Carmelina Fiorentino, auspice l’amico Felice Senatore).
62 Cfr. N. I , Il Pollio ovvero Capo S. Fortunata e suoi dintorni. Descrizioni sor-rentine, Napoli 1895, p. 31 e F C , Storia di Massa Lubrense cit., p. 10,nt. 2. Questa cavità terrestre ad andamento sub-orizzontale fi gura nell’elenco catastale delleGrotte naturali della Campania: CP 720 (Grotta al Castello) in Grotte e speleologia dellaCampania cit., p. 605.
63 Per una lettura aggiornata di questi reperti, orientata verso la facies di Taurasi, cfr.C. A L , La Campania media e la Penisola sorrentino-amalfi tana dall’età del Rame all’età del Ferro: alcune situazioni a confronto, in F. S - M. R (a cura di),Sorrento e la Penisola Sorrentina tra Italici, Etruschi e Greci nel contesto della Campaniaantica, Atti della giornata di studio in omaggio a Paola Zancani Montuoro (1901-1987) (Sor-rento, 19 maggio 2007), Roma 2010, pp. 153-154.
Il fi ordo inesistente
259
di ossidiana e di selce). Decontestuata dall’ambiente carsico, sebbene dipoche centinaia di metri, un’accettina di pietra verde64.
Va da sé che tra le due cavità di Nerano (fi g. 2) non corre solo un saltodi quota, poco più di duecento metri, ma un’autentica ascensione culturale: nel passaggio dall’essere nomade, perché cacciatore e raccoglitore, al dive-nire sedentario, perché produttore di risorse, è la misura del progresso so-cio-economico che interessò l’uomo preistorico a partire dal Mesolitico65.
Percorrendo a ritroso l’itinerario devozionale di S. Antonio66 si giunge, dipila in pila, a vista della Torre nel campeggio, non più «bellissima – ricordail Persico – qual fece edifi care Berardino Turbolo per difesa, & guardia de’Turchi»67. Ecco, cavalcando l’onda lunga di una guerra politica, prim’anco-ra che di corsa68, la notte del 13 giugno 1558 «posero in terra nella marinadi Nerano due mila Turchi bene armati – registra il medesimo storiografo–, con ordine che se ritrovassero resistenza se ne ritornassero indietro ad imbarcarsi»69. Al contingente ottomano non fu opposta alcuna resistenza ra-gionata, tant’è che esso poté ascendere, con ricca messe di vittime70, all’o-dierna S. Agata sui due Golfi . Patita una perdita inaspettata, la banda armata
64 Cfr. M.W. S , La grotta delle «Noglie» presso Nerano (Penisola Sorrentina), Na-poli 1966 (estratto dal vol. XL dei Rendiconti dell’Accademia di Archeologia e Belle Arti diNapoli, ivi 1965, pp. 111-116); C. A L , Massalubrense: La grotta delle Noglie, in E (a cura di), Archeologia a Piano di Sorrento cit., p. 33.
65 Cfr. amplius E. B , L’Italia preistorica. Un viaggio a ritroso nel tempo traluoghi suggestivi della nostra penisola alla riscoperta della straordinaria avventura dell’uo-mo dalle origini più remote all’invenzione della scrittura, Roma 1983.
66 Cfr. C , Le città del mare cit., p. 51, nt. 84; G. A , Marina del Cantone.Un infedele alla festa di S. Antonio, in “Agorà” (Settimanale di informazione e cultura), a.VII - n. 219, 20 giugno 2005, pp. 10 s.
67 Cfr. P , Descrittione cit., cap. IX, p. 42.68 Si ricorda che il Regno di Napoli, ricadendo nell’impero di Carlo V, pagò le conse-
guenze dell’accordo sancito nel 1536 fra il re di Francia Francesco I ed il sultano Selīm II:cfr. tra gli altri L. S , Torri in costiera da Rovigliano a Vietri, in “Apollo” (Bollettinodei Musei Provinciali del Salernitano), XVI - 2000, Napoli 2002, (pp. 17-113), p. 26.
69 P , Descrittione cit., cap. VIII, p. 34.70 Per una migliore comprensione di tali eff eratezze rimandiamo essenzialmente, una
volta appurate le incongruenze non solo numeriche della tradizione storiografi ca (cfr. A.T , La Penisola Sorrentina. Lineamenti storici, Casamari1986, pp. 97 s.), ai bendocumentati Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. Ricerche e narrazioni storiche di Barto-lommeo Capasso, Napoli 1866 (rist. anast., con Postfazione di A. Paolella, Napoli 1997), pp. 138 ss. e F C , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 227 ss.
Gaspare Adinolfi
260
calò a Sorrento (verosimilmente) via Circumpiso, nell’intento di saldarsiquanto prima alla restante parte degli aggressori: notevole, a parte il bottino,fu la dimestichezza degli infedeli colla rete sentieristica localei 71.
Per uno strano scherzo del destino, il fl usso dei pirati odierni è inveceregolato da una strada ampia e panoramica, realizzata in tempi di gran-de incoscienza urbanistica, ancor prima che ambientale: il prosieguo della carrozzabile Capo d’Arco-Nerano iniziò nel 195672 con lo sventramento diun irripetibile spazio di aggregazione sociale73, a Nerano, e si compì in ungenerico Largo Argentina (1958-59)74, dove non potevano non condurre ifalsi rettilinei e gli arditi tornanti di Via Amerigo Vespucci…
A Nerano la nuova strada ha off erto la ricchezza e probabilmente una prospetti-va di celebrità, considerando il progressivo deterioramento del «mito» di Capri e il riserbo in cui cerca di rinchiudersi Positano. Tuttavia essa le ha tolto l’at-mosfera «magica» che le era propria. Era uno scotto da pagare e gli «indigeni»,in defi nitiva, sono stati ben lieti di pagarlo, così come pure i vari «operatorituristici» che sul futuro della Marina di Cantone fanno grandi progetti75.
All’insegna dunque di un baldanzoso progressismo viario76, perfi no ri-badito dalla consacrazione odonomastica77, si consegnò marina del Canto-
71 Per uno spunto di rifl essione, a partire dalle fortifi cazioni erette lungo tale percorso,cfr. G. A , Le case-torri di Sorrento. Una passeggiata tematica, in “Agorà” (Settima-nale cit.), a. VII - n. 215, 23 maggio 2005, pp. 10-11 (parte II).
72 Cfr. F. M , Massa e il territorio lubrense dal XVI al XIX secolo, Napoli 1999, p. 95.73 Come rivela l’eloquente microtoponimo «Sieggio» (cfr. F.S. M , ′O paese mio. Po-
ema in dodici canti, Massa Lubrense 1991 (I ediz. 1969), p. 125, nt. 149; G. A , ′e vvie′e miez’. Itinerari storico-naturalistici a Massa Lubrense (Guida ai sentieri), Sorrento 2007,p. 95, nt. 13).
74 Cfr. C. D S , Il sacco della penisola sorrentina, in I ., Città, territorio e Mezzo-giorno in Italia, Torino 1977, (pp. 100-109), p. 106.
75 E. M , A Nerano «trafugata» dal turismo è svanita l’atmosfera d’incanto. La nuovastrada ha reso accessibile la bella località, “Il Tempo”, a. XVIII - n. 244, 3 sett. 1961, p. 5.
76 Per verifi care la temperie futurista dell’epoca rimandiamo essenzialmente a C. F ,Nerano, Massa, Sant’Agata: dall’abbandono al boom, in “Roma”, a. CIII - n. 85, 26 marzo1964, p. 13 (con due signifi cativi disegni di A. Asturi) per il caso in discorso, ed alle paginericcamente illustrate di E. R , Le mani su Sorrento, in “Panorama”, a. VI - n. 122, 15 agosto1968, per un approfondimento sulle trasformazioni allora in atto nell’intera Penisola.
77 La targa “Largo Argentina” dovrebbe ricordare il locale fenomeno di emigrazionetransoceanica (cfr. in part. L. S , Spigolando, vol. n. 2, Massa Lubrense 2007, p.18); vd. pure ultra, nt. 199.
Il fi ordo inesistente
261
ne a quei «grandi ingorghi di traffi co»78 che dalla fi ne degli anni Sessantasi ripresentano puntuali ad ogni stagione balneare per incoraggiare, sotto le mentite spoglie di un problema stradale, la realizzazione di infrastrutture più o meno private79. Così facendo si è giunti ad ignorare lo sbocco a maredel Rivo Iossa che, dopo aver percorso l’ampia valle di Nerano per oltreun chilometro e mezzo, a partire dalla pineta di Termini80, in dirittura dellaspiaggia scompare – almeno sulla carta – presso il limite orientale del par-cheggio. È lo stesso corso d’acqua che, ingrossato da un intenso periododi piogge invernali, il 19 febbraio del 1963 attivò un enorme movimento franoso che, avanzando di circa 10 metri all’ora, investì parzialmente l’a-bitato di Nerano, causando l’evacuazione di 686 persone da 150 nuclei familiari qui residenti81. Episodio che, pur collocandosi all’ultimo postonella cronologia delle principali manifestazioni di dissesto idrogeologico di questa zona a terreni fl yschoidi82, impermeabili per natura, correrebbe ilrischio di passare per un evento isolato se non si recuperassero due tracce scritte, brevi ma signifi cative. La prima ci giunge dal Persico storiografo,
78 A. C , Il sistematico scempio della riviera sorrentino-amalfi tana, in I ., La distruzione della Natura in Italia, Torino 1975, p. 292.
79 «Lottizzazioni fra gli ulivi in alto, alberghi e parcheggi immediatamente a ridosso dellaspiaggia, case costruite sugli scogli e saldate con essi: blocco progressivo della costa, riempi-mento delle pendici, sfarzo di ville per privilegiati e sudiciume di baracche e stabilimenti per la «massa», disordine, frastuono, congestione», denunciava lo stesso Cederna nella secondaparte de Il suicidio della penisola sorrentina, inchiesta pubblicata dal “Corriere della Sera” intre uscite (28 dic. 1968, 2 gen. 1969, 8 gen. 1969), opportunamente riproposta nel quadernoAntonio Cederna e la Penisola Sorrentina, a cura del C.M.E.A., Sorrento 1999, pp. 37-47.
80 A valle della stessa, ed a monte di Via Grottone, rileviamo la presenza di due taxa diAnuri per il medesimo sito, ignoto tanto per Bufo bufo quanto per Rana italica ai compilatoridelle carte di distribuzione regionale in F.M. G , G. A , V. C , N. M , G.O , O. P (a cura di), Atlante degli Anfi bi e dei Rettili della Campania, Napoli2012, pp. 139 e 163.
81 Due preziosi documenti fi lmati prodotti dall’Istituto Luce nei giorni immediatamenteseguenti la scampata tragedia (Nerano. Un paese risparmiato dalla frana(( , 27 feb. 1963 e La frana e la neve. Le conseguenze di una frana a Nerano, 2 marzo 1963), oggi liberamenteconsultabili on line (www.archivioluce.com), ci sollevano da una emerografi a dei titoli piùsignifi cativi con cui le maggiori testate giornalistiche dell’epoca, non solo nazionali, segui-rono quotidianamente la vicenda. Per uno sguardo scientifi co sulla frana Termini-Neranorimandiamo essenzialmente a A. I , Su alcuni aspetti idrogeomorfi ci dell’area sorrenti-no-amalfi tana, Presentazione di G. Acocella, Napoli 1976, pp. 59 s. e a C (a cura di),Guida alle escursioni cit., pp. 69 e 82-84.
82 Cfr. B , Genesi e caratteri cit., p. 266.
Gaspare Adinolfi
262
che sulla marina di Nerano ricorda incombere, all’inizio del Seicento, un movimento terra «di più di 50. moggi piena d’olive, e vigne» che, ivi esau-riti i moti di scoscendimento e colamento, «si attuff ò nel mare»83. Per laseconda testimonianza occorre recuperare il secondo volume dei Travels in the Two Sicilies di Henry Swinburne (London 1785), dove al termine delsuo ‘Return from Pæstum’ l’autore sbarca a «Donerana, the last hamlet onthe south side of cape Campanella». È qui che il celeberrimo viaggiatore-enciclopedista, già impressionato dalle vigne insidiate dai lentischi («the common plant that over-runs the country»), responsabili a suo avviso dellequalità astringenti del liquore prodotto, constata la precarietà di un «im-mense heap of stones» giacente a mezza costa accanto alla locanda delpaese, lì scaricato dal nostro corso d’acqua dolce: è suffi ciente una zuff a trasorci, attirati sui ciottoli dagli avanzi dei pasti, a causare fragorosi distacchidal cumulo alla riva. Rovina che, sebbene ripetuta nel tempo, non basta «to frighten these ignorant people».
Ebbene, ragionando sopra i monumenti antichi delle costiere amalfi tanae sorrentina Amedeo Maiuri imputò al ripetuto «fl agello delle alluvioni edelle frane»84 la scomparsa degli episodi più rappresentativi dell’antichità,che ovviamente non comprendevano le evidenze di una non meglio spe-cifi cata struttura presso Marina del Cantone85, già annoverata da NormanDouglas tra gli inediti edifi cî marittimi di età imperiale86.
Avulso da questo specifi co contesto è invece un rocco di colonna pian-tato dinanzi alla singolare costruzione de la Certosa: l’emblema ricavatonel granito tradisce la sua provenienza da Crapolla, dove «qualche milite ingannò gli ozi della solitudine scalpellando sul fusto liscio delle colonne il fascio littorio»87.
83 P , Descrittione cit., cap. IX, pp. 41 s.84 A. M , Le vicende dei monumenti antichi della costa amalfi tana e sorrentina alla
luce delle recenti alluvioni, estratto dal vol. XXIX (1954), dei Rendiconti dell’Accademia diArcheologia Lettere e Belle Arti di Napoli, Napoli 1955, p. 13; I ., Passegiate sorrentine, a cura di B. I , Sorrento 1990, pp. 55-73.
85 Cfr. M -P , Surrentum cit., p. 163.86 «There is contorted ruin of a Roman building on the beach at Cantone, below the
large tower, not far from a spring which gushes into the sea. The bricks, unfortunately, bear no stamp» (D , Siren Land cit.d , cap. III, p. 46, nt. 1).
87 A. M , Il covo delle Sirene (luglio 1949), in I ., Passeggiate campane, Firenze 1950, (pp. 240-245), p. 243; cfr. pure Frammenti di storia dagli inizi di questo secolo ad
Il fi ordo inesistente
263
Via mare o via terra siamo giunti all’ampia marina di Nerano. La dividedalla più modesta spiaggia di Recommone il promontorio di S. Antonio, i cui terreni miocenici si ritrovano acconciati nella prossima Torre cadente88.
Dimessa per la natura litica delle sue strutture murarie89, dismessa inforza del regio decreto del 30 dic. 186690, la Torre di Recommone nullapoté contro l’ultima aggressione alla sua insenatura che, lo vedremo, ha inciso sulla roccia un segno ancora più evidente rispetto a quello impressosu tutto il paesaggio circostante dalla surriferita vicenda di epoca vicereale. La iattura, ancora una volta, calò dall’alto: una traccia viaria proveniente dal Petrale, aggirata a nord la collina di S. Antonio, puntò al Rivo Acchiun-go, nel quale più a valle si riversava, ed al presente ancora si riversa, il Rivo Sciulia. Mortifi cando la complessa rete idrografi ca, la mano dell’uomo so-vrappose l’ultimo tratto della strada privata all’alveo dei rivoli riuniti (Rivo ((di Recommone), stendendo dalla confl uenza di questi fi no ai primi ciottolidella spiaggia ben duecento metri lineari di cemento91. Va da sé che per il carattere vernotico del nostro rivolo non è raro che, a seguito di pioggeinvernali o acquazzoni primaverili, le acque meteoriche fl uiscano impetuo-samente sul letto artifi ciale, travolgendo quanto risulti in sosta o, peggio
oggi. Raccolta di Elisabetta Aversa (1929-1990), Castellammare di Stabia 1991, p. 230. Per un rilievo di questa testimonianza tra gli spolia di Crapolla vd. nt. 208, ultra.
88 Per un itinerario tematico, di torre in torre, da Torca a Marina del Cantone, cfr. A -, ′e vvie ′e miez′ cit., pp. 63-83 (in part. p. 80).
89 Contrariamente a quanto sostiene E. S , The cantieri masonry of St. Pe-ter’s Tower. Building techniques and similarities in the peninsular context, in R (a cura di), Landscape as architecture cit., p. 135, che propone un confronto stringente tra questobaluardo e la Torre di Crapolla, le cui murature non presentano ‘tènere’ pietre arenarie. Per una panoramica geologica sul promontorio di Recommone rimandiamo allo stop 9.10 del nono Itinerario proposto dalla ‘Guida Geologica Regionale’ n. 11 (Campania e Molise), a cura di D. C , B. D’A , L. F , G. P , P. P , Roma 2016, pp. 194-195.
90 Cfr. S , Torri in costiera cit., pp. 48 e 70; F. R , Le torri anticorsare vicere-ali con particolare riferimento a quelle della costa campana, s.l. 2001, p. 293.
91 La denuncia di tale scempio, già noto a V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit., p. fi
126, è stata rilanciata di recente: cfr. p. es. C. ’E , È fuorilegge la strada nel fi ume per Recommone!!! Interdetta dalla Forestale e dal Genio Civile in attesa di ordinanza sindacale, in “Sireon” (Periodico di cultura, politica, sport e turismo a cura del Centro Studi “don L. Sturzo”di Sorrento), a. IX - n. 9, 23 maggio 2014, p. 16; J. A , Recommone, dossier in Procura.L’alveo del fi ume diventa parcheggio: denuncia del Wwf. La perla naturale di Massa Lubrensedeturpata dalle auto, in “Metropolis” (Edizione Sud), a. XXI - n. 227, 20 agosto 2014, p. 14.
Gaspare Adinolfi
264
ancora, quanti stiano percorrendo a piedi il tratto più basso dell’Alta Via dei Monti Lattari92. Con buona pace della scienza toponomastica, è notoche da Res communis93 a res privata il passo, nel silenzio-assenso delleIstituzioni, è fi n troppo breve. Tant’è che per questo tradizionale male sitoandrebbe attualizzata la leggenda dello «specter of a mounted carbineer»94.
Alla costa alta di Recommone si oppongono le piccole quote dei di-rimpettai isolotti d’Isca (m 31 s.l.m.) e di Vetara (m 36 s.l.m.), seguiti dalmini-arcipelago de Li Galli (m 54 s.l.m.): sarebbero rimasti cime di monta-gna se l’ormai noto collasso del Pleistocene non avesse ribassato nel Golfo di Salerno la medesima successione di falde carbonatiche che li accomuna ai più prossimi rilievi continentali95. Oltre questo vero e proprio gradinotettonico, a Sud delle nostre isole corre una scarpata sottomarina profon-da circa mezzo chilometro (faglia Capri-Salerno)96, già stratigrafi camentenota all’inizio del Novecento97.
Un più modesto cabotaggio, d’altro canto, avvicina l’osservatore a sot-tovalutate emergenze ambientali come possono esserlo, incrociando a Le-vante, le grotte de li Palummi98 e della Perciata99, rispettivamente apertesullo scoglio maggiore di Recommone (Scruopolo) e sull’isolotto d’Isca.Del tutto invisibile ai natanti è invece la semisommersa Grotta dello Zaffi -ro, che cela ad un pugno di metri sotto il livello del mare il primo dei suoi ingressi alla grande sala dove, in ambiente atmosferico, la cupola rocciosa
92 Per approfondimenti su questo particolare passaggio dell’itinerario tematico cfr. A -, ′e vvie sulitarie cit., p. 113.
93 Scil. «demanio»: M , ′O paese mio cit., p. 126, nt. 151.94 Cfr. C , Coasting by Sorrento and Amalfi cit., pp. 325-336 e D , Siren
Land cit., cap. VII, p. 127.95 Cfr. p. es. A. D M , Guida naturalistica di Napoli e dintorni, [Napoli] 2004,
p. 96.96 Cfr. B , Genesi e caratteri cit., p. 256 e amplius G. A - C. D ,
La geologia marina e subacquea del Golfo di Napoli e della Penisola Sorrentina, in Piano di Sorrento cit., pp. 29-57 (vd. in part. fi gg. 3, 4 e 6).
97 Cfr. G. D L , Geologia e Geografi a Fisica dell’Italia Meridionale (con 70fi gure nel testo), Bari 1904, p. 99, fi g. 24.
98 Cfr. V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit., p. 128.fi99 Cfr. ibid., p. 129; un paio di scorci panoramici da questa cavità si apprezzano in R.
F C , Sorrento e la sua penisola (con 142 illustrazioni), monografi a n. 82della serie “Italia artistica”, Bergamo 1929 (I ediz. 1917), pp. 22-23.
Il fi ordo inesistente
265
rifl ette nella quieta superfi ce del laghetto salato il suo drappeggio di sta-lattiti100.
Per questa grotta è stata ipotizzata una speleogenesi risalente ad un’e-poca di clima temperato (Würm I) del Pleistocene superiore101, quando laregressione glacio-eustatica consentiva di accedervi a piedi, e non pinneg-giando. Prende dunque consistenza l’ipotesi che il materiale litico qui rin-venuto sia stato impugnato da un cavernicolo non distante, per tipo di inse-diamento ed orizzonte culturale, da quello già documentato tre chilometri più a Ovest, nella grotta dello Scoglione102.
A monte della preziosa cavità ipogea è il brullo pendio del Monte diMonticchio, appena rinverdito dalle conifere piantate fra Cuparo e Spi-na. La sopravvivenza della giovane pineta, voluta dall’uomo nel tentativodi mitigare il rischio idrogeologico, è seriamente insidiata dall’endemicobracconaggio: le frange più estreme di questo esercizio venatorio non esi-tano ad adeguare al suolo innumerevoli ettari di vegetazione spontanea per la sola ragione di agevolare, bis in anno103, posta e abbattimento dell’avi-fauna migratrice104. Una testimonianza tanto autorevole quanto inascoltatadi tale illecito ambientale ci giunge da un osservatorio privilegiato, dall’i-solano buen retiro del più celebre drammaturgo partenopeo:
100 Cfr. C , Le grotte nella baia cit., pp. 15-16; L. F , La grotta dello Zaffi ro,in “Notiziario sezionale” del Club Alpino Italiano - Sezione di Napoli, n. 3, dic. 1988, pp.20-24. Per un approccio turistico alla caverna, presente nell’elenco catastale delle Grottenaturali della Campania (CP 1080 in Grotte e speleologia cit., p. 608), cfr. F. Q - L.T , Punta Campanella. Area Marina Protetta, Roma 2005, pp. 28-33; G.C. C- G.F. R , I sentieri del mare delle sirene. Percorsi subacquei, Napoli 2006, pp. 1-3.14.
101 Cfr. F , art. cit., p. 23.102 Cfr. pure C. A L , La Penisola Sorrentina nella Preistoria e nella Proto-
storia, in E (a cura di), Archeologia a Piano di Sorrento cit., p. 23.103 «Nel mese d’Aprile, e di Maggio entrano le Quaglie in tanta copia, che pare che
piovano dal Cielo […] Nel mese d’Agosto, e Settembre ritornano in maggior copia, e sonopiù grasse, sono tante», scrive P , Descrittione cit., cap. XI, p. 47; per approfondimentisulla caccia alle quaglie in Penisola sorrentina cfr. F , Storia di Massa Lubrense cit.,pp. 731 s.; M. F , Le caccie curiose. Le quaglie a Sorrento, in “Le Vie d’Italia” (Rivistamensile del Touring Club Italiano), a. XXVIII - n. 10, ottobre 1922, pp. 1021-1024 e, daultimo, A. D A , Li Cuonti. La collina degli uccelli di passo, Post-fazione di G. Gugg,Capri 2015, pp. 53-59.
104 Cfr. F - F , art. cit., p. 262.
Gaspare Adinolfi
266
La rigogliosa macchia mediterranea della terraferma sta bruciando. Il fumo oscura il sole, brandelli di alberi e cespugli, alcuni ancora incandescenti, pas-sano volando sull’Isola [scil. Isca]. Ahimè, succede ogni anno. Cacciatori cri-minali incendiano la sterpaglia così che quando tra poco, a settembre, ci sarà ilpassaggio delle quaglie, gli uccelli non troveranno nascondigli per difendersi dai loro maledetti fucili105.
Con il Monte di Monticchio ha inizio la serie di pareti e scogliere calca-reo-dolomitiche di età cretacica che si sviluppa, apparentemente ininterrot-ta, fi no a Vietri sul Mare106. La prima imponente ‘cesura’ nella tormentataserie mesozoica si osserva a Portiglione, dove le acque del rivo Corbo-Scrivanessa, compiuto un salto di quota di oltre 200 metri, addolcisconolo specchio di mare antistante la caletta. Nell’inospitale ma lussureggiante insenatura conviene soff ermarsi per almeno un paio di motivi: apprezzarei molteplici esiti dei fenomeni carsici107, che trovano in questo precipuosettore costiero la loro più varia manifestazione (non mancano esempi dif-fusi di carsismo epigeo108), e rimuginare sul nome stesso del luogo, non
105 I. Q D F , In mezzo al mare un’isola c’è…, Capri 2002, p. 67 (si legganopure le pp. 59 e 78). Per una analisi di più ampio respiro sul fenomeno degli incendi boschivi, apartire dalla crisi dell’economia rurale in Costiera amalfi tana, rimandiamo al ben documentato C.C , La Costiera amalfi tana tra consumo e tutela. Il destino di un paesaggio italiano, a cura della sezione WWF per la Costiera Amalfi tana, Maiori 1991, pp. 26-33 (cfr. pure C. C - R.A , Breve storia dell’agricoltura amalfi tana, a cura della Associazione culturale “La Feluca”,Maiori 2013, pp. 23-25). Sugli aspetti più schiettamente ecologici del rapporto fuoco-macchiacfr. G. P - S. P , Aspetti vegetazionali, in La macchia mediterranea. Formazioni sem-preverdi costiere, vol. n. 6 della collana “Quaderni habitat”, a cura di A. M per il Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare,e e per il Museo Friuliano di Storia Naturale- Comune di Udine, Udine 2008 (I ediz. 2002), pp. 27-29.
106 Cfr. D M , Guida naturalistica cit., p. 92.107 Ricordiamo che il carsismo è l’insieme dei processi chimici che causa la dissoluzio-
ne di determinate rocce sedimentarie: le acque meteoriche, rese leggermente acide dall’ar-ricchimento di CO2 atmosferica, formano infatti una soluzione in grado di sciogliere roccecarbonatiche (calcari e dolomie) e rocce evaporitiche. Il carsismo prende il nome da unaregione situata al confi ne tra Italia e Slovenia, il Carso, dove le forme di erosione superfi cialie sotterranee sono particolarmente evidenti: cfr. A. B , Storia geologica d’Italia. Gli ultimi 200 milioni di anni, Bologna 2005, p. 126 e, in part., N. S - A. S , Il carsismo e la formazione delle grotte, in Grotte e speleologia cit., pp. 39-48.
108 Cfr. ibid., pp. 40-41 (l’immagine del karren toccato dall’Alta Via del CAI sarà ripro-posta in R , Parco Regionale cit. p. 17, fi g. 10).
Il fi ordo inesistente
267
esclusivo di queste parti109, che andrebbe piuttosto letto, giusta la presenzadi taluni chirotteri negli anfratti circostanti, come uno zoo-toponimo110. Aproposito di cavità, vale la pena ricordare che alla testata della forra è lagrotta di Cuparo111: ancor prima del deposito interno di molluschi marini,vi si scorge quello esterno di elettrodomestici, che con l’industria di tipomesolitico associata ai Gasteropodi112 ha, ovviamente, nulla a che fare…
Proseguendo nella navigazione si giunge in breve a Crapolla (fi g. 6),dove conviene approdare col Maiuri:
s’entra nella baia di Crapólla sopra un mare di turchese e d’opale tra due altepareti di roccia che si richiudono al fondo in un canalone inaccessibile in mezzo a un groviglio di sterpi. Né un molo, né un pontile di sbarco: la chiglia s’insab-bia nella ghiaia con un fruscìo metallico e le barche gialle azzurre e vermiglietirate in secco sul greto, una accanto all’altra, sono la sola cosa viva e smaglian-te in quell’ombroso speco113.
Sfrondato dell’impalcatura immaginifi ca, questo brano ormai arcinotodi don Amedeo introduce correttamente il lettore nella forra ai piedi di Torca (fi g. 4): un’insenatura profonda («tra due alte pareti di roccia») che,essendo in realtà un vallone di erosione fl uviale, invaso poi dal mare inrisalita («la chiglia s’insabbia nella ghiaia»), esce dal novero dei turisti-
109 Portiglione è un «toponimo identico a quello attribuito alla parte occidentale dellaBaia di Puolo», osserva V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit., p. 131.
110 Per la sinonimia pipistrello-«sportiglione» cfr. ad es. il Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal dialetto toscano, con alcune ricerche etimologi-che degli Accademici fi lopatridi, t. I, Napoli 1789 e O.- G. C , Fauna del Regno di Napoliossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni di questo Regno e leacque che le bagnano…, Napoli 1839, p. 5.
111 Purtroppo questa interessante cavità terrestre, ben evidente dal sentiero marcato dalCAI a valle di loc. Corbo-Cafariello (cfr. A , ′e vvie ′e miez′ cit., p. 76, fi g. 21; I . ′evvie sulitarie cit., p. 113), non fi gura tanto nella ‘Carta dei Beni Culturali’ de I Beni Cultu-rali di Massa Lubrense. Contributo alla conoscenza, a cura della Sez. di Massa Lubrensedell’Archeoclub d’Italia, Castellammare di Stabia 1992, quanto nel più recente elenco cata-stale delle Grotte naturali della Campania in Grotte e speleologia cit.
112 Cfr. A.M. R , Campania. Penisola Sorrentina, in “Rivista di Scienze preisto-riche”, vol. XX - fasc. 2, Firenze 1965, p. 366.
113 A. M , Il covo delle Sirene (luglio 1949), in I ., Passeggiate cit., 1950, p. 242.
Gaspare Adinolfi
268
ci fi ordi locali per entrare, in compagnia di Furore, tra le autentiche riasamalfi tane114.
L’abusato confronto con la ria a valle di Agerola115 (fi g. 5) sollecital’osservatore a familiarizzare con quello scenario costiero che, per unairripetibile comunione tra opera della Natura e operato dell’uomo, è sta-to effi cacemente defi nito «vertical landscape»116. Un paesaggio percepitocome «verticale» ha sì nella costa d’Amalfi il suo tòposò , ma si ritrova comecompendiato a Crapolla, dove la combinazione ‘simbiotica’ cui si facevacenno invita a distogliere lo sguardo dalla «petrosa calvizie»117 del profi lorivierasco per indagare i più remoti recessi. Inoltrandosi dunque lì dovel’acqua ha fatto e fa il suo corso giornaliero comprendiamo in manieratangibile come tale elemento naturale abbia strutturato prima e modellatopoi le componenti abiotiche e biotiche del sito.
Tratto di «Costiera amalfi tana tra Nerano e Positano» sui «Fonda-li marini di Punta Campanella e Capri»: il territorio di Crapollacome Sito di Importanza Comunitaria
La Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta dai rappresentanti di 153 Paesi118 alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su “Ambientee sviluppo” (Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992), ha sancito l’importanzadella conservazione del patrimonio biologico del Pianeta, riconoscendogli
114 Cfr. § La ria di Crapolla nel contesto geomorfologico della penisola di Sorrento, con particolare riferimento al suo versante ‘amalfi tano’. Bisogna poi ricordare che A. F -
, Aspetti strutturali del paesaggio lubrense, in I Beni Culturali di Massa Lubrense cit., pp. 128-130 accosta morfologicamente la ria di Crapolla a quella di Cesiglione, un’insenaturaa sud di Marina della Lobra (cfr. V , Le Coste di Sorrento e di Amalfi cit., pp. 99-100).
115 Solcata dal torrente Penise-Schiatro: cfr. C (a cura di), Guida alle escursionicit., p. 17.
116 Cfr. L. V , Il paesaggio verticale: Positano, in D. R (a cura di), Alla ricerca del Sud. Tre secoli di viaggi ad Amalfi nell’immaginario europeo, Catalogo dellamostra (Amalfi , 24 giugno - 31 agosto 1989) in collaborazione con il Centro di Cultura eStoria Amalfi tana, Scandicci 1989, pp. 233 ss.
117 Per dirla con M , Le vicende dei monumenti cit., p. 12.118 La Convenzione è stata ratifi cata in Italia il 14 feb. 1994 con Legge n. 124.
Il fi ordo inesistente
269
un «valore non solo ecologico e genetico, ma anche culturale, educativo,scientifi co ed economico»119.
Una oculata gestione dei valori radicati nella diversità biologica120 èlegata alla Direttiva 92/43/CEE121, varata dall’Unione Europea al fi ne di«salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat na-turali, nonché della fl ora e della fauna selvatiche nel territorio europeo de-gli Stati membri al quale si applica il trattato» (art. 2).
L’obiettivo della Direttiva Habitat è stato dunque quello di creare, en-tro l’anno 2000 (da cui la denominazione Natura 2000), una prima Rete europea di zone speciali di conservazione attraverso la quale garantire ilmantenimento e, all’occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e dellespecie d’interesse comunitario elencati nei suoi allegati122. La rete ecolo-gica Natura 2000 si pone così come il principale strumento della politicadell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità.
Estesa su tutti i 27 Stati della UE, Natura 2000 è costituita da Siti diInteresse Comunitario (SIC), identifi cati dagli Stati Membri secondoquanto stabilito dalla Direttiva Habitat e successivamente designati qualiZone Speciali di Conservazione (ZSC)123. La Rete ecologica comprendepure le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che di fatto hasostituito l’omologa Direttiva 79/409/CEE124.
119 Biodiversità e protezione della Natura, a cura del Ministero dell’Ambiente, Romas.d. (ma 1993), p. 5.
120 Tra le numerose defi nizioni di questa locuzione (= biodiversità) quella più ampia-mente accettata a livello giuridico recita: «la variabilità degli organismi viventi di ogni ori-gine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed icomplessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e trale specie degli ecosistemi» (art. 2 della Conv. cit.).
121 La cd. Direttiva “Habitat” fu recepita nell’ordinamento italiano col D.P.R. 8 sett.1997, n. 357.
122 http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/ (collegamento del 15 feb. 2016).123 La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione
di Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito-specifi che e off re una maggiore sicurezza per la gestione della Rete e per il suo ruolo strate-gico, fi nalizzato ad arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020 (http://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate) (ibidem).
124 http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 (ib.). Non a torto è stato osser-vato che «L’insieme delle aree SIC e ZPS costituirà però un’eff ettiva rete ecologica soloquando saranno state realizzate le connessioni tra i siti individuati, in base alla concezione
Gaspare Adinolfi
270
L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia è di competenza delMinistero dell’Ambiente, che a questo scopo ha promosso il “ProgettoBioitaly” (Biotopes Inventory Of Italy), conclusosi nel dicembre del 1998 con la redazione di un primo elenco di Siti di Interesse Comunitario, oltre 2000, da sottoporre al vaglio della Commissione Europea per l’eventuale ratifi ca125. In progresso di tempo, in Italia sono stati individuati dalle nostreRegioni 2314 SIC, dei quali 522 sono stati designati ZSC e 610 ZPS (datiaggiornati a gen. 2016)126. Poiché la costruzione della “Rete Natura 2000”è un processo dinamico, le liste delle ZPS127 e dei SIC128 sono periodica-mente riviste dal Ministero dell’Ambiente e dalla Commissione europeasulla base degli aggiornamenti proposti dalle Regioni italiane.
Per meglio comprendere il criterio informatore di Natura 2000 bisognatener presente che il territorio dell’Unione Europea è stato suddiviso in 9regioni biogeografi che129, vale a dire àmbiti territoriali con caratteristicheecologiche omogenee. Il territorio italiano è interessato dalle regioni Al-pina, Continentale e Mediterranea130, nell’ultima delle quali ricadono per intero i 13.670,95 km² della Campania.
In Penisola sorrentina sono stati individuati 12 siti “Natura 2000” (8 SICe 4 ZPS) per una superfi ce complessiva di oltre 25.000 ettari; estensioneche, posta in relazione con i 16mila ha del Parco Regionale dei Monti Lat-
[…] dei corridoi ecologici che dovrebbero consentire lo spostamento di specie animali evegetali, superando le barriere interposte dall’urbanizzazione del territorio» (E. B -L.C -L. N , Paesaggio e conservazione degli habitat in Italia: realizzazioni e prospet-tive, in La cultura del paesaggio. Le sue origini, la situazione attuale e le prospettive future,Atti del convegno (Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, 3-6 nov. 2003) a cura di R. C -
V e K. T , Firenze 2004, pp. 172-173).125 In Italia tanto l’individuazione dei pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti)
quanto delle ZPS è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmet-tono i dati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Ministero,dopo la verifi ca della completezza e congruenza delle informazioni acquisite (comprese dicartografi e), trasmette i dati alla Commissione Europea (http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000) (collegamento del 16 feb. 2016).
126 http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia (ibid.).127 http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps (collegamento del 17 feb. 2016).128 http://www.minambiente.it/pagina/liste-dei-sic (ibid.).129 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/in-
dex_en.htm (ibid).d130 http://www.minambiente.it/pagina/le-regioni-biogeografi che (ibid.).
Il fi ordo inesistente
271
tari131 e con i 1.128 ha della Area Marina Protetta “Punta Campanella”132,copre buona parte del vasto ed articolato patrimonio ambientale e paesag-gistico della Penisola sorrentina e delle acque che la bagnano. In questocontesto il territorio di Crapolla, che a tutti gli eff etti rappresenta la pro-iezione a mare di Torca, frazione collinare di Massa Lubrense, ricade per intero nel SIC denominato ‘Costiera amalfi tana tra Nerano e Positano’,occupando circa 25 dei complessivi 980 ha del Sito IT8030006. Dallo spe-cifi co formulario, disponibile in Rete con la relativa cartografi a133, si rica-vano dati codifi cati che possiamo sciogliere, per gli Habitat types present on the site, come indicato nella tabella alla pagina seguente
SIC ‘Costiera amalfi tana tra Nerano e Positano’ (cod. IT8030006)
Codice Habitat Tipologia di Habitat Regione biogeografi cao regione marina
1240 Scogliere con vegetazionedelle coste mediterranee
(con Limonium spp. endemici)
Continentale (= C),Mediterranea (= M)
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
Alpina (= A), C, M
5320 Formazioni basse di euforbievicino alle scogliere
M
5330 Arbusteti termo-mediterraneie pre-desertici
C, M
131 Istituito con Decreto presidenziale della Giunta Regionale della Campania n. 781 del13 nov. 2003, il Parco interessa il territorio di 27 comuni della Penisola, dall’entroterra allazona costiera (http://www.parcoregionaledeimontilattari.it/) (collegamento del 18 feb. 2016).
132 Il 12 dic. 1997 il Ministero dell’Ambiente istituisce l’Area Marina Protetta PuntaCampanella ai sensi della legge quadro sulle Aree Protette n. 394 del 6 dic. 1991 (http://www.puntacampanella.org/) (ibidem).
133 http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografi e (ib.).
Gaspare Adinolfi
272
SIC ‘Costiera amalfi tana tra Nerano e Positano’ (cod. IT8030006)
6220 Percorsi substeppicidi graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea
A, C, M
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
A, C, M
8330 Grotte marine sommerseo semisommerse
Mar Mediterraneo
9340 Foreste di Quercus ilexe Quercus rotundifolia
A, C, M
In relazione a questi 8 tipi di habitat sono state inserite 22 entità nell’e-lenco delle Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC, che raggruppiamo in Anfi bi (1),Invertebrati (2), Mammiferi (2), Rettili (1), Uccelli (16), e 14 taxa nell’e-lenco codifi cato delle Other important species of fl ora and fauna: 2 di an-fi bi, 1 di invertebrato, 7 di piante, 4 di rettili.
Occorre inoltre rilevare che sul versante più meridionale della ria di Crapolla si compie, com’è naturale, l’interessante passaggio dalle emer-genze terrestri a quelle marine, tant’è che in relazione ai 3 tipi di habi-tat indicati nel formulario standard del SIC/ZPS ‘Fondali marini di Punta Campanella e Capri’
SIC-ZPS ‘Fondali marini di Punta Campanella e Capri’ (IT8030011)
Codice Habitat Tipologia di Habitat Regione biogeografi cao regione marina
1120 Praterie di posidonie (Posido-((nion oceanicae)
Mar Mediterraneo (= MM)
1170 Scogliere MM
Il fi ordo inesistente
273
SIC-ZPS ‘Fondali marini di Punta Campanella e Capri’ (IT8030011)
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
MM
annoveriamo 8 (4 + 4) entità inserite negli Allegati I (specie per lequali «sono previste misure speciali di conservazione») e II-B (specie che«possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sonomenzionate») della Direttiva “Uccelli” ed 1 taxon di cui all’Allegato II(«Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazionerichiede la designazione di zone speciali di conservazione») della Direttiva“Habitat”. A queste 9 specie di animali d’interesse comunitario – 8 di uc-celli, 1 di mammifero – vanno ad aggiungersi 7 specie di invertebrati, 2 dipiante, 3 di pesci per un totale di 12 Other important species of fl ora and fauna. Ciò premesso, nel tentativo di tratteggiare gli
Aspetti fauno-fl oristici dell’ecosistema costiero di Crapolla alla luce dipassate testimonianze letterarie
Rispolveriamo alcune note erudite che Giambattista Folengo (1490-1559), fratello del più noto Teofi lo, volle affi dare alla memoria dei torchitipografi ci una volta compiuto il forzato ritiro lubrense (ca. 1530-33)134.Si tratta di etimologie «De nomine eremi Caprollae. Et Massae Urbis»esposte in un immaginario dialogo intercorso fra Crisogono, pseudonimodell’autore, e Lisandro, indigeno di Massa Lubrense; interrogato da que-sti sul signifi cato dei toponimi in epigrafe, Crisogono aggira la rispostacon una pia digressione ideologica, primo autentico tema del tredicesimoPomilio, salvo tornare in argomento, cioè a Caprolla: «quam tamen Ca-
134 Sul soggiorno a Crapolla dei fratelli Folengo cfr. L. C , L’autore della“Maccaronea” in penitenza a Sorrento, in Minerva Sorrentina (Rivista mensile illustrata diStoria, Cultura ed Arte), a. II - n. 1, gen. 1934, pp. 2-3; B. I , Monaci e Sirene. Il singolaredestino di Crapolla, “Roma”, a. CXIX - n. 190, 24 agosto 1980, p. 3; E. P , Due eremitinella Terra delle Sirene: Giambattista Folengo, Pomilio XIII, in “La Terra delle sirene” (Ri-IIvista del Centro di studi e ricerche “B. Capasso”) n. 1, Sorrento 1981, (pp. 36-43), pp. 36-37.
Gaspare Adinolfi
274
pronam libentius appellaverim: pronam videlicet comam a capite»135. Per motivare l’enunciato Crisogono invita l’amico ad alzare lo sguardo fi noalla cima del monte, dove è una parete rocciosa che gli pare la fronte sulvolto di un cristiano: da lì si distendono, a mo’ di graziosa capigliatura, prima gli ulivi, poi un mirteto con generici arbusti.
L’antropomorfi zzazione della Natura è un espediente letterario nonignoto agli umanisti; ad esso ricorre pure il minore dei Folengo, che inten-de suggestionare il suo (improbabile) interlocutore con aforismi classici as-serviti all’intelligenza testuale. Classicheggianti sono pure l’immancabile olivo di Minerva e l’odoroso mirto dioneo136, che in àmbito mediterraneosono così diff usi da non essere d’ausilio né alla distinzione di un luogodall’altro né alla defi nizione del paesaggio vegetale. Indistinta, per quantovariopinta, resterà pure la campagna che Costanzo Pulcarelli associa, nellaclassica concezione estetica, alla sua «rosea sublime Crepilla / LubrenseElysium, & vario sata rure voluptas»137.
Meno generica sarebbe stata la «palma» cantata all’omonimo presule daPaolo Portarelli138, fratello di Costanzo, se il più sconosciuto dei germaniumanisti – ad onta del cognome adottato le porte del vero successo letterariorimasero, per lui, alquanto socchiuse139 – non avesse preferito le curative
135 Si cita il Folengo dalla trascrizione di P , Due eremiti cit.i , p. 40, pur disponendo online dell’intera opera digitalizzata (http://www.folengo.com, collegamento del 15 marzo 2015).ePer una rifl essione sulla dotta lezione Caprona – rimonta infatti a Lucilio presso Nonio Marcel-lo: cfr. D. S , Il nome di Capri e la toponomastica insulare dell’Italia antica, in Capriantica cit., p. 122, nt. 45 – segnaliamo il «Banno per lo fare et accomodare de alcune Turre nelemarine de regno» (21 maggio 1566), in cui tra le altre è menzionata «La Torre de Santo Pietri ad crapona» (cfr. in part. R. E , Il sistema difensivo medievale di Massa Lubrense, in I BeniCulturali di Massa Lubrense cit., p. 79; S , Torri in costiera cit., p. 34).
136 Non possiamo non rimandare, rispettivamente, a V ., Georgica, I, 18-19 e I .,Bucolica, VII, 61-62.
137 C. P <1568-1610>, Ad Franciscum Prignanum è societate Iesu responsio,in I ., Carminum libri quinque, Bologna 16514; una recente edizione dei versi, tradotti ecommentati in italiano, in Blandissima tellus, a cura di B. I e E. P , Massa Lubrense1978, pp. 16 s.
138 P. P , Carmi per il Vescovo Palma. Tradotti da Laura Celentano, presentatida Benito Iezzi, Massa Lubrense 1983 (I ediz. Napoli 1586).
139 «L’opera di Paolo, diversamente da quella di Costanzo, non ha storia o sviluppointeriore, urgenza di ispirazione e disegno letterario», avverte B. I nel suo Umanisti mi-nori del ’500. Bio-bibliografi a di Costanzo e Paolo Pulcarelli, Massa Lubrense 1977, p. 36.
Il fi ordo inesistente
275
sabbie di Puolo140 agli inerti ciottoli di Crapolla. Risalendo la china il sa-cerdote massese avrebbe potuto scorgere, sgravato di qualche tomo il suobagaglio d’erudizione, i ventagli sempreverdi dell’unica specie di Palma checresce spontaneamente in Italia. Con un campione della Palma di S. Pietro,a prescindere da Crapolla141, il Portarelli avrebbe potuto avvalorare la suaopera d’esordio e segnalare, in tempi non sospetti, la prima stazione locale diChamaerops humilis, autentico relitto della vegetazione di tipo tropicale che,all’inizio del periodo Terziario, era diff usa in tutta l’Europa meridionale142.
Sorpassata la vegetazione delle rupi recuperiamo un brano del canonico Iovino, sottovalutato cultore di patrie memorie, che calando da S. Agata verso gli ultimi oliveti di Torca nel radioso 20 gennaio 1899, ad un certo punto si trovò dove i rivoli provenienti da Nula, da Pigna e da Cafariello– «i diversi poggi [che] si elevano nella abbassata valle» – si accorpano inun unico «rivo, che s’apre il corso nella sassosa roccia fra le querce che sorgono ai lati»143. L’osservazione del dinamico sacerdote è particolarmen-te interessante se confrontata all’itinerario stavolta pedestre intrapreso dal Maiuri per la marina di Crapolla: «vi si giunge calandosi quasi a capofi ttodalle ultime case di Torca per un vallone che doveva essere un tempo unsolo grande querceto»144.
Una lettura sul campo delle ultime citazioni oltrepassa il dato pertinente la qualità dell’area boscata per evidenziare – già a distanza di mezzo se-colo – l’impoverimento tanto della singola specie (Quercus pubescens)145
quanto dell’alleanza vegetale cui essa aff erisce nell’Orizzonte mediterra-
140 Tenendo presente Neapolitanae Historiae a Iulio Caesare Capacio eius urbis a se-cretis et cive conscriptae, Neapoli MDCVII, t. I, lib. II, cap. XII, p. 511 si legga P ,Carmi per il Vescovo Palma cit., p. 11.
141 La Palma nana o di S. Pietro vegeta pure sulle rupi di Capo d’Orso, unica stazionebotanica fi nora segnalata per la Costiera amalfi tana (cfr. da ultime G. C - L. C -
, Il paesaggio vegetale della Costa d’Amalfi , Roma 2007, p. 67), e nell’insenatura a sud di Punta Lagno (Massa Lubrense), in sinistra idrografi ca sul Rio Annunziata (cfr. V , Lecoste di Sorrento e di Amalfi cit., p. 100).
142 Cfr. S , Particolarità botaniche, in V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit., p. 246.
143 N. I , Il Monte della Selva ovvero i lavori del secolo ventesimo in Sorrento con-templati al lume dello stato attuale del territorio e della storia-patria, Napoli 1901, p. 41.
144 M , Il covo cit., in I ., Passeggiate cit., 1950, p. 241.145 Secondo D , Siren Land cit., cap. VII, p. 116 tale essenza fu assai richiesta dai
cantieri navali di Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia.
Gaspare Adinolfi
276
neo (Quercion ilicis), ovvero in quella fascia bioclimatica che dal livellodel mare si estende fi no ai convenzionali 500 metri sopra di esso. Impo-verimento non assoluto, ma relativo rispetto all’espansione di un’altra for-mazione arborea, il castagneto, che è stato retrocesso dalla Fascia sannitica(dai 500 ai 1000 metri s.l.m.) a quella mediterranea per assecondare esi-genze colturali146.
A sua volta anche la selva impiantata sulla spalla ponentina del Rivo Ia-rito ha contribuito a custodire l’habitat di alcune specie animali e vegetalidi pregio: ad esempio, tra i detriti vegetali e rocciosi addossati alle prodee ombreggiati dai castagni (Castanea sativa), avrebbe trovato rifugio la Salamandrina dagli occhiali147 (fi g. 11), più agevole a scorgersi quando lefemmine di questo endemismo del nostro Meridione si recano in acqua nel periodo di ovodeposizione148.
Di gran lunga più evidente rispetto all’anfi bio è Orchis provincialis (fi g. 12), orchidea spontanea tipica del sottobosco, qui osservata in antesidall’aprile 2005149. Entrambe le entità considerate, a dire il vero, patisconoil disturbo delle attività antropiche, che tendono a sottrarre sempre più spa-zio vitale al già martoriato territorio collinare e costiero. Il pericolo mag-giore per il mimetico urodelo è l’inquinamento delle acque del Rivo Iarito,specie di quelle che calano dal versante più densamente abitato di Torca.Quanto all’orchidea dalle foglie maculate, il drastico taglio del castagneto
146 A proposito del bosco ceduo in Penisola Sorrentina e sulla Costiera Amalfi tana cfr.G. C - V. L - L. Z - L. C - R. G , I paesaggi culturali ele loro trasformazioni nel tempo, in C -C , Il paesaggio vegetale cit., pp. 174-181; F. F , La vegetazione e la fl ora interessante dei Monti Lattari e della PenisolaSorrentina, in Piano di Sorrento cit., pp. 64-65.
147 In attesa di validare la segnalazione raccolta dalla locale Associazione del Panda(WWF Terre del Tirreno, già WWF Penisola sorrentina), si prefi gura un caso di sintopia trail rarissimo urodelo (Salamandrina terdigitata) e la comune Rana appenninica (Rana italica(( )(fi g. 10), qui rilevata da chi scrive fi n dal marzo 2011.
148 Per questo evento così delicato tanto per Salamandrina perspicillata quanto per S.terdigitata rimandiamo all’esperienza diretta di G. M , La Salamandrina. The Spec-tacled salamander, coll. I tesori nascosti della Costiera amalfi tana, s.l. 2009, che da oltre quarant’anni osserva la seconda nel Vallone Porto di Positano, ed al contributo scientifi codi M. M , S. V e G. O in G -A -C -M -O -P (a cura di), Atlante degli Anfi bi cit., pp. 101-106.
149 Nelle immediate vicinanze si scorge pure la più comune Orchis italica: cfr. ampliusA , Le orchidee spontanee cit.
Il fi ordo inesistente
277
rinselvatichito (2009)150 ha letteralmente cancellato dal sentiero la sua mo-desta ma signifi cativa stazione, scoperta dallo scrivente appena dieci annifa e riconfermata fi no e non oltre lo stesso periodo dell’incauta ceduazione.
A lungo si potrebbe indugiare nella vegetazione riparia, volgendo losguardo dalle più patenti fanerogame alle malcelate crittogame, a traversopiccole felci che coi muschi quasi si confondono, come Selaginella denti-culata. Così facendo nel taccuino del naturalista prenderebbe consistenzaun elenco di taxa abbastanza articolato da poter ragionevolmente avanzareun parallelo tra il primo attore di questo ecosistema, il rivo Iarito151 (fi g. 9),ed il suo omologo nel territorio di Scala, il torrente Chiarito, che ad Amalfi conclude l’operoso attraversamento della Valle dei Mulini.
Al nostro claretus come sinonimo medievale di fi ume152 si è preferitoun dotto «ëerateîon, ossia “santuario” (ma anche “clero”)»153 che rimon-terebbe, sulla scorta delle Denominazioni greche antichissime del Gargiul-li154, alla presenza di una rocca di Apollo (Ἀpóllwnoj \kra) in quel diCrapolla155.
150 Si legga il comunicato stampa Scempio a Crapolla, la denuncia del WWF. I respon-sabili dell’associazione ambientalista documentano lo spietato taglio di alberi e mandanola documentazione a forze dell’ordine e Soprintendenza, ripreso dal settimanale “Agorà”nell’uscita del 21 aprile 2009, p. 14.
151 Equivale a R. Viarito in carta al 25.000 dello I.G.M. (cfr. pure L. B - P. T -, A piedi lungo le coste d’Italia. Passeggiate ed escursioni, Novara 1987, p. 78).
152 Cfr. G. G , La città davanti al mare. Aree urbane e storie sommerse di Amalfi nel Medioevo, Amalfi 1992, p. 111, I ., La protoindustria nella Costa d’Amalfi , in “Rasse-gna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana” a. VIII - nn. 15/16 n.s., Amalfi 1998, p. 254,da cui A , ′e vvie ′e miez′ cit., p. 74, nt. 40 e I ., ′e vvie sulitarie cit., pp. 112 e 121,nt. 9. Diversa esegesi idronomastica fornisce L. C , Lessico idronomastico dellaCampania, vol. n. 2 della collana ‘Quaderni di AIΩN’ (n.s.), Napoli, Istituto UniversitarioOrientale - Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, 1999, p. 26.
153 Cfr. R , Il paesaggio di Apollo cit., pp. 21-22; E ., Memory and conservationcit., pp. 73-77.
154 Cfr. O. G , Denominazioni greche antichissime. Di molti luoghi, che postisono tra il fi ume Sarno e il Promontorio Ateneo, conservate presso il volgo de’ rispettivipaesi: e spiegazioni delle medesime, in Memorie della Regale Accademia Ercolanese diArcheologia, vol. I, Napoli 1822, pp. 309-333; il saggio fu riproposto da B. Iezzi nel 1990per conto del massese Centro studi popolari “Il Cerriglio”.
155 Secondo J. B , Surrentum im Alterthum / Sorrento nell’antichità, hrsg. von / a cura di A, Russi, San Severo 1993 (I ediz. Genf 1874), p. 118 «Il nome di Crapolla si faderivare da # Akron Ἀpóllwnoj».
Gaspare Adinolfi
278
A questo acrocoro immaginario dovettero giungere, secondo i grecistidi ieri e di oggi, delle legazioni sacre al dio del Sole e della poesia; corteiche, in Via eff ettivamente Teorica, avrebbero lasciato traccia del loro pas-saggio nel nome del casale di Torca156.
La suggestione toponomastica, è bene ammetterlo, trova riscontro nellaconsuetudine già documentata da un valente giureconsulto che, esaminan-do il Jus visitandi esercitato il 30 agosto 1652 dall’Arcivescovo di Sorrentoa dispetto del Vescovo di Massa157, adduce che per celebrare il secondogiorno pasquale all’abbazia di S. Pietro a Crapolla «sint soliti accedereplures laici, & Presbyteri è Civitate Surrenti, & præsertim ConfraternitasS. Euphemiæ»158. Ricorrenza ribadita e arricchita di particolari dal solitoProfessore di Letteratura greca159.
156 Cfr. G , Denominazioni greche cit. 1822, ad vocem QEWRIKH ñdój (n.41). Sull’etimologia del toponimo si era già espresso C , Neapolitanae Historiae cit.,t. I, lib. II, cap. XIII, p. 540, seguito quasi alla lettera da P , Descrittione cit., cap.IX, p. 43 e G. M , Storia di Massa Lubrense, Napoli 1840, p. 70: «Torca nomeche deriva da torquere, perché colui che arriva in quel Casale l’è inibito di andare avanti,perché fi nisce la strada, e cominciano le coste di Positano aspre e montuose». Vale la penasegnalare che, distaccandosi da tale tradizione storiografi ca e saltando a piè pari i contributidi L. Chiappinelli, Nomi di persona e di luogo in documenti medievali di area meridionale,in “Rassegna Storica Salernitana” (Rivista semestrale della Società Salernitana di StoriaPatria), XXIII - 1, fasc. 45 della n.s. (giugno 2006), (pp. 275-283), p. 280 e Id., Nomi di luogo in Campania. Percorsi storico-etimologici, vol. n. 5 della collana ‘I Quaderni di «LeRadici & il Futuro»’, Napoli 2012, p. 115, G. M , The archeological evidence of the Sorrento Peninsula and Crapolla, in R (a cura di), Landscape as architecture cit.,pp. 60 s. mette in relazione il nome del nostro villaggio lubrense – «in Italian it sounds like“torchio”, i.e. an olive press» – con la presenza di macchinari per la pressatura delle drupe.
157 Sulla controversia sorta fra i presuli Antonio del Pezzo (1642-1659) e Vincenzo de Juliis(1645-1672), e risorta tra i loro omologhi Didaco Petra (1680-1699) e G.B. Nepita (1685-1701),cfr. innanzitutto Julij Caponi [† 1673], Philosophi, Theologi, nec non Jurisconsulti neapolitani,ac Comitis Palatini; Disceptationum forensium, ecclesiasticarum, civilium, et moralium, pluri-bus in Casibus Decisarum, nunc primum in lucem prodit, t. I, Lugduni MDCLXXVI (di quest’o-pera si conoscono tre successive impressioni: Lione 1677; Venezia 1705, Colonia Allobrogum1737), disceptationes XLIII-XLVII e, da ultimo, V. R , Sorrento e i casali del Piano. Rapportie confl itti politico-amministrativi nel Cinque-Seicento, Castellammare di Stabia 2008, p. 82.
158 C , Julij Caponi cit., discep. XLIV, p. 212.159 «Parte, ogni anno, nel secondo giorno festivo di Pasqua da Sorrento, facendo costan-
temente la medesima strada, una processione, scortata da un prete, che, attraversando i montiSireniani, ascende a un’altura, dove la via il nome di Torca a prendere incomincia. Di là, scen-dendo alle coste bagnate dal mar pestano, si porta a visitare una cappella, detta oggi di S. Pietro
Il fi ordo inesistente
279
Confortato da un doppio segnavia, il sentiero oltrepassa elucubrazionied area umida per aff acciarsi sul Pizzo del Corvo, sassoso avamposto delMonte di Torca. Sui candelabri fi orali di Agave americana non è diffi cilescorgere l’uccello che qualifi ca il Pizzo (Corvus corax), che da «inguari-bile monogamo»160 divide il posatoio con il partner di una vita. Nel corsodell’incendio procurato il 2 gennaio 2015161, cui già si faceva cenno, lo si èvisto alzarsi dal fumo asfi ssiante con un piccolo roditore nel becco, che davittima delle fi amme è divenuto preda del pennuto necrofago.
Breve è il passo, da questa parte della forra, per uno di quei tipici sediliin pietra fabbricati al culmine di un’erta162. Quello di Crapolla, dove pureogni tanto si poggia qualche sporta di pescato, vigila sul Golfo di Salernoa traverso le pale spinose del Fico d’India (Opuntia fi cus-indica); il postoè noto col nome sonante de ’a Guardia, che associato all’esito superioredella scalea di Crapolla trova dignità di toponimo-spia163 di un’epoca tra-
Acrapolla, che si vuol fondata sulle rovine del tempio di Apollo. Visita in seguito le Sirenuse,e per la stessa via, verso la sera, al luogo, onde partì, si restituisce. Del tempo in cui sia stataquesta usanza tra i Sorrentini introdotta, aff atto non vi è memoria; ond’è che a credere siamoindotti essere la medesima un avanzo de’ costumi gentileschi» (G , Le Sirene. Poemettodi Onofrio Gargiulli Professore di Letteratura greca nella R. Università degli Studj, e Membrodella R. Accademia di Storia, e Belle Lettere. Colle note del medesimo, Napoli 1814, pp. 52 s.,nt. 11; già cit. in G. A , Tradizioni ed usi nella Penisola Sorrentina, vol. VIII della serieCuriosità popolari tradizionali, a cura di G. P , Palermo 1890, rist. anast. Sala Bolognese2007, pp. 144 s.). Per un profi lo storico di questo itinerario devozionale, che tiene conto dellasua recente ricostituzione dopo la presunta estinzione del 1860 (cfr. M , Massalubren-se antica cit., p. 29), si legga G. A , Sorrento-Crapolla: un atavico pellegrinaggio, in“Agorà” (Settimanale di informazione e cultura), a. VII - n. 220, 27 giugno 2005, pp. 10-11.
160 Così N. D , Alone. In viaggio per l’Italia, trad. it. di B. Lazzaro, Catanzaro1993 (I ediz. Alone, London 1921) 1993, p. 195.
161 Per la consueta tempestività d’informazione: http://www.positanonews.it/artico-lo/149853/massa-lubrense-incendio-devastante-a-crapolla (collegamento del 16 feb. 2015).Vale la pena ricordare che già nove anni prima (vd. il comunicato del WWF Penisola sorren-tina in “Agorà” (Settimanale cit.) del 30 luglio 2006, p. 4) quest’area era stata percorsa dallefi amme, ed altre volte ancora a ritroso nel tempo, almeno fi no all’estate del 1978, come siapprende dall’uscita del 14 luglio del quotidiano “Il Mattino”, a. LXXXVII.
162 Per un confronto col non lontano «poggio» in Via Pagliaio di Santolo rimandiamoad E. A , Cient’anne… che so’ ? “’na ’ff acciata ’e fenesta!”, Sorrento 1994, p. 144.
163 Alla stregua della omonima località presso Punta S. Elia, indicata nel f. 15 della Cartatopografi ca ed idrografi ca dei contorni di Napoli levata per ordine di S. M. Ferdinando I, Redel Regno delle Due Sicilie, dagli uffi ziali dello Stato Maggiore e dagl’ingegneri topografi negli anni 1817, 1818, 1819 / disegnata, ed incisa nell’Offi cio Topografi co di Napoli. Quanto a
Gaspare Adinolfi
280
scorsa ad avvertire, e non ad impedire164, approdi barbareschi sulla costameridionale del capoluogo.
Con immutato spirito di rapina ancora oggi si giunge da queste parti, a prescindere dalla provenienza: lo sversamento di rifi uti ordinari e specialinel rivolo, l’opinabile gestione della residua risorsa forestale, lo sfrutta-mento venatorio dei pendii, i roghi dei materiali spiaggiati (tradizional-mente anticipati rispetto al 29 giugno, ricorrenza patronale) rallentano, o impediscono del tutto, il raggiungimento di un equilibrio fondamentale per la conservazione della biodiversità. Di tutte queste azioni che concorrono ad esercitare una pressione di segno negativo sul suolo e sulle biocenosi,ci dà atto l’Asfodelo mediterraneo (Asphodelus microcarpus(( ), che non a caso esordisce in letteratura come pianta degli Inferi165. Sarà proprio questaerbacea dalle foglie nastriformi, candidamente in fi ore da febbraio a mag-gio, a bordeggiare gli innumerevoli scalini che ci riporteranno in spiaggia.
La montagna sul mare. Pescatori-alpinisti a Crapolla.
Suggeriamo di spezzare la scesa, di tanto in tanto, per concedersi alme-no il tempo di sfogliare un album della memoria; avremo cura di confezio-narlo estraendo da libri e riviste alcuni istanti di vita vissuta, a Crapolla,così come si presentarono al sapiente obbiettivo di Antonino Fiorentino166. Una volta riunite le stampe fotografi che, faremo in modo d’intercalarlenella mirifi ca prosa di Benito Iezzi, così da rinnovare in itinere il sodaliziod’intenti di due straordinari animatori culturali della Penisola sorrentina:
Crapolla è un microcosmo mediterraneo, dove le dive del mare e il nume dell’e-tra sembrano aver diff uso, in egual misura, i loro attributi. Il teso paesaggiodella costa amalfi tana, tutto vertigine di dirupi e fuga di azzurri, è qui interrotto
«Punta La Guardia» nel territorio di Vico Equense, sull’opposto versante, cfr. L. D G ,Vico Equense ed i suoi villaggi. Storia e folklore, studi e ricerche, Napoli 1929, p. 240.
164 Sull’argomento serva da spunto R , Le torri anticorsare cit., pp. 174-178.165 Cfr. O , Odissea XI, 539.166 La sua capacità di cogliere aspetti etnografi ci si apprezza pure nel reportage foto-
grafi co su Marina Grande riproposto in Antonino Fiorentino. Immagini e memorie, vol. VII della collana “I quaderni de «La Terra delle sirene»”, Sorrento 2012, pp. 9-24.
Il fi ordo inesistente
281
da una vegetazione varia e folta, che ne attenua l’impressionante tumulto, insie-me concluso e compiuto dai tre isolotti, che rendono più domestico l’orizzonte.È diffi cile raggiungere, attraverso i solchi dei tempi o delle acque, questa acro-poli dello spirito. Scendendo da Torca, più remota ad ogni passo, si avrà l’im-pressione di un tuff o nella terra. Risalendo dal mare, più fi oco ad ogni balzo,parrà un risveglio nella luce167.
Ad una luce in particolare è legata la leggenda di fondazione di S. Pie-tro a Crapolla. Si narra di alcuni pescatori impegnati nottetempo al largodell’insenatura168; al loro rientro avrebbero trovato ad attenderli uno sca-ricatore calato da Torca, come da segnale convenuto. Al primo lume che bucò l’oscurità si vogò di gran lena verso la marina, ben presto realizzando che più si riduceva la distanza fra la prora e la battigia, più il bagliore siaffi evoliva, indietreggiando nelle tenebre. L’inspiegabile intermittenza delfenomeno convinse i pescatori a sobbarcarsi all’ultima fatica: approdaronoe fecero da soli. Appena giunti in paese interrogarono l’atteso collaboratoresulla sua assenza, stavolta giustifi cata da un’involontaria dormita. Mossidunque da prevedibile curiosità, i pescatori si recarono nel luogo della lu-minosa epifania, trovandovi fi nalmente le reliquie petrine169.
Al Santo in carne ed ossa, ignorata la tradizione lubrense, rimonterebbel’origine della Chiesa sorrentina, giusta la prima elucubrazione di FilippoAnastasio: «Surrentinam Ecclesiam a sancto Petro Apostolorum Principe,quando Antiochia Romam versus profectus est, fundatam […] communis est Surrentinorum traditio»170. Poggiando dunque sull’autorità di storici e agio-grafi a lui precedenti171, il Patriarca d’Antiochia cercò di ‘nobilitare’ la cat-
167 I , Monaci e Sirene cit.168 Si entrerà in atmosfera grazie all’ispirato D , Siren Land cit., cap. VII, pp.
137-138.169 Cfr. V , Le coste di Sorrento e di Amalfi cit., p. 134; I . (a cura di), Leggende
di Crapolla, in http://www.massalubrense.it (collegamento del 22 marzo 2015); sull’argo-mento vd. pure D. M , Raccolta di storie, leggende, misteri e superstizioni in PenisolaSorrentina, Castellammare di Stabia 2006, pp. 98-99.
170 Lucubrationes in Surrentinorum Ecclesiasticas civilesque antiquatates nuncupatæ Sanctissimo Domino Nostro Clementi XII. Pont. Max. a Philippo Anastasio Patriarcha An-tiocheno Pridem Archiepiscopo Surrentino, Romæ MDCCXXXI, lib. I, cap. I, p. 4. Sull’ar-gomento si legga, con maggior profi tto, B. C , Memorie storiche della chiesa sorrenti-na, Napoli 1854 (rist. anast. Bologna 1971), pp. 1-5.
171 Cfr. p. es. F. U , Italia sacra sive de Episcopis Italiæ, et insularum adjacen-tium, t. VI, Venezia 17202, coll. 594-595.
Gaspare Adinolfi
282
tedra del suo proprio episcopato impetrando a Clemente XI la ragione stessadel pio convincimento, ossia l’abbazia di S. Pietro a Crapolla. Correva l’anno1719, ventesimo da presule per l’Anastasio (1699-1724)172. L’annuale rendi-ta abaziale di «quattrocento ducati, moneta di Regno», inizialmente stimatasuffi ciente ad appoggiare vecchiaia incalzante e bisogni giornalieri del Mon-signore, fu presto ripensata alla luce delle condizioni strutturali della chiesain parola, «così sformata che più non vi si può celebrare»173, e dei suoi terri-tori produttivi, che «per la mala cultura si trovano oltremodo malmenati»174. A suff ragio di quanto aveva appreso de auditu dal suo agente ministeriale,l’Arcivescovo si recò a Crapolla per la Santa Visita del 1720, constatandovide visu la fatiscenza dell’ex complesso benedettino175. Ad ogni buon conto, ilbilancio complessivo degli introiti ed esiti dové soddisfare il nostro quandoalla pensione ricavata da Crapolla si aggiunse, per successiva concessionedi Innocenzo XIII, quella in dote all’Abbazia di S. Pietro a Cermenna176. Il titolo di abate commendatario della prima, ancor più che della seconda, testi-monierebbe – a parte le rendite – il non lieve peso onorifi co del monastero diCrapolla177. Una prima comprensione delle sue vicende storiche rimonta al‘Notamento dell’Archivio della Santissima Trinità delle Monache d’Amal-fi ’, compilato e annotato da Francesco Pansa per la sua Istoria dell’anticaRepubblica di Amalfi , pubblicata postuma in due tomi da Giuseppe Pansa,nipote dell’autore178. Compulsando il regesto amalfi tano si leggono due attinotarili in cui, a distanza di ottant’anni, Sergio Presbitero e Zarsia dei Comite
172 Per un suo profi lo bio-bibliografi co cfr. da ultimi T , La Penisola Sorrentinacit., pp. 161-220 e P. F , La Chiesa sorrentina e i suoi pastori, Sorrento 1991, pp.189-196.
173 Così il Presule sorrentino in corrispondenza epistolare col card. Paolucci: cfr. T -, La Penisola Sorrentina cit., p. 175.
174 Ibid., p. 176.175 Cfr. R , Memory and conservation cit., in R (a cura di), Landscape as archi-
tecture cit., p. 81, nt. 37.176 Cfr. C , Memorie storiche cit., p. 103; T , La Penisola Sorrentina cit.,
pp. 176 s. e I ., Monasteri e conventi della Penisola sorrentina. Studio storico, Casamari1996, p. 82.
177 Cfr. F C , Storia di Massa Lubrense cit., p. 652.178 Per un approccio critico all’opera cfr. G.G. C , La memoria storica di Amalfi
medievale nell’erudizione dei secoli XVIII-XIX: Francesco Pansa, Gaetano Mansi e Mat-teo Camera, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, a. XVIII - n. 36 n.s.,Amalfi 2008, pp. 107-135 (in part. pp. 110-113).
Il fi ordo inesistente
283
legarono al «Monasterium Capreolæ» (a. 1111) o «M. Caprolis» (a. 1190)alcuni beni di varia natura179.
Muovendo da questi testamenti del XII secolo180, quindi interrogandocarte a loro posteriori181, Riccardo Filangieri di Candida giunse a ricostru-ire le fasi salienti dell’istituto religioso di Crapolla182, riscontrando dellecontroversie prima sociali183 poi diocesane che turbarono, nel cuore delSeicento, non tanto il quieto vivere dell’abbazia, soppressa già alla fi ne del XIV sec.184, se non prima185, ma – lo possiamo dedurre – l’aprico soggiornodi alcuni rifugiati, calati a Crapolla per benefi ciare dell’immunità eccle-siastica186. Tali furono Giovan Battista Palumbo e Luigi Caputo, insidiatidal Governatore coi suoi birri, per non parlare di Bernardino Caputo alias «Chiovetiello», arrestato nella dipendenza agricola dell’abbazia, la grancia di S. Giacomo alla Pedara187.
Ed ancora, a distanza di due secoli e più, si era al principio del Decenniofrancese (1806-1815), non scampò alla furia omicida del Destruttore de’ Briganti un anonimo perseguitato: va compreso nel novero delle «184 testedi assassini» che, pendenti per ordine del comandante N.-P. Desvernois «dalle torri sparse lungo il litorale, dal capo di S. Pietro d’Acropulo [sic],
179 Cfr. P , Istoria cit., t. II, pp. 12 e 42-43.180 Ad essi, invero già noti a C , Memorie storiche cit., p. 114, si aggiungerà un’i-
nedita charta testamenti del 1176 menzionante un «monasterium S. Petri de Capreoli»: cfr.R. F C (a cura di), Codice diplomatico amalfi tano, vol. I, Napoli 1917, pp.354-356 (doc. CXC).
181 Quello richiamato da F D C , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 724 s., nt. 4 è un importante diploma del 1224 già edito da Marco Antonio M nella omonima Historia di famiglia (Napoli 1629), poi argomento della Illustrazione d’una carta giudiziaria dei primi anni del secolo XIII del can. G.I A (Napoli 1819).
182 Cfr. F D C , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 647-654.183 Per un approfondimento sul tema del vassallaggio rimandiamo innanzitutto a R ,
Sorrento medievale cit., pp. 42-44.184 Cfr. A. T , Vico Equense ed il suo territorio. Nuova edizione corretta ed
ampliata, Casamari 1997, p. 260, nt. 8.185 Intorno al 1308-1310, secondo A. V , Gli insediamenti monastici benedettini
nella penisola sorrentina (II), in “La Terra delle sirene” (Bollettino del Centro di studi ericerche “B. Capasso”) n. 15, Sorrento 1997, p. 32.
186 Cfr. in primis B. N , A. C. Tarusio. Massæ Lubren. Iurisdictionis pro Reverendis-simo Episcopo Massæ Lubren. contra Reverendissimum Archiepiscopum Surrentinum, s.l. 1692, cc. 404r e 406r (manu signatae nella copia in nostro possesso).
187 Cfr. C , Julij Caponi cit., discep. XLIII, p. 208.
Gaspare Adinolfi
284
che si accosta a Capri, sino a sotto Vietri, vicino Salerno»188, avrebberodovuto ammonire eventuali manutengoli.
Pensando di visitare il solo covo delle Sirene giunse a Crapolla quelMaiuri che avevamo lasciato nei pressi del querceto termofi lo, e che orarecuperiamo per aff rontare la parte terminale dell’itinerario pedestre:
gli ultimi cento metri di dislivello, tra il ciglio della rupe e il mare, si discendo-no per una gradinata rocciosa da far concorrenza alla scala fenicia d’Anacapri, a volte e risvolte come il gomitolo d’una matassa; e rocce e gradini sono così liscie consunti da prender l’opalescenza dell’onice e da far pensare alle cavità chevi ha impresso il piede nudo prensile dei pescatori che salgono e discendonocon il carico del pesce189.
Il primo tentativo di associare un nome proprio di persona a quelle ma-schere cotte dal sole si deve ad un veleggiatore non occasionale per questa costa, che con un bizzarro pescatore di Crapolla entrò più volte in conver-sazione, spuntando perfi no un’uscita in mare per una infruttuosa battutadi pesca190. Garibaldi, questo il suo soprannome, non per gli attributi fi sici– «big white beard, red cheeks, small beady eyes, and intensely black eye-brows» – ma per il suo spirito gioviale impressionò il «magnifi co» scrittoreF. Marion Crawford, che dopo l’umana delusione di Ellera-Iéranto191 con-tava fortemente su un genius loci a Crapolla: «ogni pellegrino, occasionaleod elettivo, ha fi nito per trovare quel che cercava e per innestare quel cheportava», è stato osservato da un chiaro esperto di letteratura odeporica192.
Fu così anche per Norman Douglas, che conobbe e apprezzò l’ormaisettantenne Giuseppe “Garibaldi” come esempio di virtù, abile nello sta-nare la cernia e generoso nel condividerla a tavola193. Presagendo la suaimminente scomparsa [a. 1914] il periegeta anglofono volle dedicargli la quindicesima tavola f.t. di Siren Land, recentemente riproposta con diver-
188 F. B , La Costiera amalfi tana nel Decennio francese: i Mémoires di Desvernois,in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, a. VIII - nn. 15-16 v.s., Amalfi 1988, p. 35.
189 M , Il covo cit., in I ., Passeggiate cit., 1950, p. 241.190 Cfr. C , Coasting by Sorrento cit., pp. 330-331.191 Ibid., pp. 327-330.192 B. I , Introduzione a Sorrento, pagine belle, a cura di A. C , Salerno 1987, p. 7.193 Cfr. D , Siren Land cit., cap. VII, p. 127.d
Il fi ordo inesistente
285
sa didascalia194, ed una menzione in Alone, consuntivo letterario dei suoiviaggi in Italia entro il 1921195.
Per la successiva generazione di pescatori, che fu quella osservata a piedi scalzi dal compagno-editore di Douglas196 e dal Maiuri, non mancanocoordinate onomastiche e brani di vita vissuta da servire di profi lo ad unaetnografi a di Torca con la sua marina197. Lavoro impegnativo e forse ancheutile per analizzare sia alcuni casi di fl essibilità del lavoro in un contestosquisitamente locale198, sia certi episodi di mobilità sociale a grande rag-gio199, nel quale pur rientra l’intervento di ricostruzione della cappella diS. Pietro a Crapolla, ultimata nel 1949 (fi g. 7) grazie a sostanze trasmessedall’estero200.
194 Cfr. D. I - S. R , From tangible to intangible values. Traditions inCrapolla, in R (a cura di), Landscape as architecture cit., p. 151, fi g. 2.
195 Cfr. D , Alone cit., p. 209; vedi pure il contributo anepigrafo di S. R a Il presepe vivente di Torca. Massa Lubrense - Natale 2000, Fotografi e di A. Fiorentino ed E.Gaudiello, Introduzione e didascalie di S. Cangiani, Sorrento 2001, pp. 10 s.
196 Cfr. G. O , Le avventure di un libraio, Introduzione di A. Vigevani, Milano 1988(I ediz. Adventures of a bookseller, Florence 1937), p. 218.
197 Intanto, cfr. L. M , Dal mare al monte. Culti popolari a Crapolla e a S.Costanzo, in “Campania Felix. Itinerari alla scoperta della Regione” (Mensile di turismo,cultura, storia, arte, folclore, natura, curiosità della Campania), a. II - n. 15, luglio/agosto1997, pp. 23-25; A. D A , Crapolla: il covo dei pescatori, in “Genius loci” (Annuariodel Centro studi e ricerche F. M. Crawford), n. [1], Sant’Agnello 1998-99, (pp. 35-38), p.37 (riproposto in I ., Contatti. Persone e personaggi nella terra delle sirene, Capri 2003,pp. 47-51).
198 «Marinai-contadini dunque, un piede sulla barca, un altro nella vigna»: in questocaso nell’oliveto, mutuando la fortunata espressione di M. D T , Il miracolo dell’agri-coltura amalfi tana, in I . - A. L , Amalfi medioevale, Napoli 1977, cap. II, p. 21.
199 Cfr. A. B , Famiglia, terra ed emigrazione in una comunità della costiera sor-rentina, in Storia d’Italia, le regioni dall’Unità a oggi. La Campania, a cura di P. M e P. V , Torino 1990, pp. 397-422 e E ., Mobilità ed emigrazione transoceanica in Peni-sola Sorrentina nel corso del XIX secolo, in “Spazi Nuovi” (Periodico di cultura e politica),a. VI - n. 8 (Speciale Festambiente ’92: Emigrazione e lavoro dalla Penisola Sorrentinaal Continente Americano), agosto 1992, pp. 8-10; L. S , Emigrazioni transoceani-che, in E - R (a cura di), La Lobra cit., pp. 287-297; G. A , La grande emigrazione (1880-1915), Castellammare di Stabia 2004; G. G , L’emigrazione dallaPenisola Sorrentina: note e appunti storici, in “La Lumaca. Elogio della lentezza e del con-trappunto”, a. I, n. 2, 16 nov. 2016, p. 3.
200 Cfr. G. A , Cronologia essenziale di S. Pietro a Crapolla dai tempi dell’Abba-zia a quelli della cappella, in I ., ′e vvie ′e miez′ cit., p. 88.
Gaspare Adinolfi
286
Un prezioso colpo d’occhio sopra l’edifi cio antico, che già sapevamoa tre navate con colonne di marmo e impiantito a mosaico201, si deve allacuriosità della viaggiatrice europea Mariana Starke, in Penisola negli anni Venti dell’ ’800. Riconoscendo nella sua Marina Nerano la nostra marinadi Crapolla, la si può seguire a partire da Sorrento lungo una «tolerablygood mule-path»202, oppure salpando da Marina del Cantoni per approda-re, passato l’isolotto d’Isca, nel «peculiarly picturesque Cove, called the Marina Nerano, from the Temple of the Nereides which stood there»203. Potenza evocativa dell’opera reticolata204!
Più convincente è la descrizione delle rovine seconde, romanticamenteraggiunte dalla Starke grazie ad un «narrow Path, at the brink of a Precipicewashed by the sea»205. Vide insomma, a circa quaranta metri sul livello delmare, e noi con lei per cura del Bertolotti
una chiesa, divisa in tre navate da due ordini di colonne, sei di marmo pario, le altre due di granito. Esse sorreggono alcuni piccoli archi, sui quali, come pure sulle pareti, sono dipinti fatti della santa Scrittura. Queste pitture sono del tempo del risorgimento dell’arte, ed in buono stato, se avvertasi che l’edifi zio
201 Cfr. C , Neapolitanae Historiae cit., t. I, lib. II, cap. XIII, p. 540, seguito pres-soché alla lettera da P , Descrittione cit., cap. IX, p. 42 e da Di Napoli il seno cratero esposto agli occhi et alla mente de’ curiosi, descrivendosi in questa seconda parte le ville,terre e città che giacciono all’intorno dell’uno e l’altro lato dell’amenissima riviera del suogolfo, o sia cratere, l’isole di Capri, di Procida, e d’Ischia, coll’antichità curiosissime diPozzuoli, epilogata da’ suoi autori impressi e manoscritti che ne hanno diff usamente trat-tato, opera et industria di Domenico Antonio Parrino, natural cittadino napolitano, vol. II, Napoli MDCC, p. 276.
202 M. S , Travels in Europe, for the use of travellers on the Continent, and likewisein the Island of Sicily. To which is added, an account of the remains of ancient Italy, and alsoof the roads leanding to those remains, London 18338, p. 419, nt. k.
203 Ibid., p. 418; questa paretimologia fu ripresa, alla lettera, da F.S. B , L’Osser-vatore di Napoli, Introduzione di F. Amirante, Napoli 2006 (II ediz. Napoli 1855), p. 418.
204 Insistono dunque a Crapolla, in ordine di erudizione, il tempio di Giunone Argiva(A , Lucubrationes cit., 1732, lib. II, cap. IX), il promontorio di Apollo (G ,Denominazioni greche cit., pp. 330-332; M , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 36ss.; M , Massalubrense antica cit., p. 26) ed il luogo consacrato alle fi glie di Néreo,protettrici dei naviganti e dei porti (cfr. p. es. M.V. Tescari, Compendio di mitologia classica.Con illustrazioni, Torino 1954, pp. 29-30). Sul tema cfr. pure M.M. M , Un’iscri-zione romana dall’abbazia benedettina di Crapolla riedita, “La Terra delle sirene” (Rivistadel Centro di studi e ricerche “B. Capasso”) n. 35, Sorrento 2016, (pp. 33-39), p. 38.
205 S , Travels in Europe cit., p. 419.
Il fi ordo inesistente
287
non ha tetto: il coro, tranne a’ luoghi dove lo stucco è caduto, è ornato di dipintia fresco, mezzanamente ben conservati. Alcuni pescatori ci dissero che quellachiesa era sacra a S. Pietro: essa ricorda quelle edifi cate a’ giorni di Costantino.I muri esterni sono fabbricati con vasi grossolani, sferici, collocati vicinissimigli uni agli altri…Probabilmente quelle pitture sono opere del sec. XV, come pure le camere oc-cupate da un pio romito che soccorreva i marinai in pericolo; si scoperse, non ègran tempo, sotto il tavolato della sacristia, buona copia di monete. Presso allachiesa era un cimiterio, che dirupò nel mare206.
Non senza profi tto si sosterà sul breve terrazzo di S. Pietro nel tentativodi rimessione in pristino della chiesa abbaziale, a partire dai documentipittorici del Duclère207: diserbate le strutture murarie e riabilitati i tron-coni di colonna208, dislocato di 180° l’altarino («Ecclesia extructa est abOriente versus Occidentem»209) e rintracciati i vaghi lacerti d’aff resco210,
206 A questa traduzione pubblicata nel secondo tomo de L’Italia descritta e dipinta conle sue isole (Torino 1837) manca solo, come già era stato per L’Italie, la Sicile, les ilesÉoliennes, l’ile d’Elbe… (Paris 1835), l’epigrafi ca attestazione di un risanamento dell’edifi -cio intrapreso nel 1490 dall’abate Bartolomeo Gazzo, per la quale rimandiamo a E. P ,Epigrafi latine dell’abbazia benedettina di Crapolla, in “La Terra delle sirene” (Rivista delCentro di studi e ricerche “B. Capasso”), n. 34, Sorrento 2015, (pp. 101-115), pp. 108-109(con bibliog. prec.).
207 Cfr. le tavv. CXLV e CXLVI, entrambe del 1860, in Teodoro Duclère (1812-1869).Disegni e dipinti dell’Italia Meridionale nelle Collezioni Correale, Catalogo della mostra acura di L. M , M. R ed A. F , Sorrento 2013, pp. 135 e 326.
208 «Probabilmente provengono in parte dal tempio di Minerva», osserva B , Sur-rentum cit., p. 118; sicuramente non fungevano da ‘sedili’ a metà Novecento, come si puòconstatare dai documenti fi lmati fruibili on line nell’Archivio storico dell’Istituto Luce Ci-necittà (si veda in part. Penisola sorrentina. Con i pescatori di Crapolla (26 luglio 1950),collegamento del 2 aprile 2015) e da quelli fotografi ci (cfr. A , Frammenti di storiacit., p. 230; C -R (a cura di), Conservazione e valorizzazione cit., p. 79, fi g. 20 [=RRR (a cura di), Landscape as architecture cit., p. 240]). Per un’analisi puntuale di questied altri materiali riutilizzati cfr. D. E - P. P , Two cases of reuse in Campania:the church of St. Peter in Crapolla and the bell tower of Pietrasanta in Naples, in RRR (acura di), Landscape as architecture cit., pp. 97-106.
209 Così nel transunto della Santa Visita del 1690 (ADS) di R , Memory and conser-vation cit., in RR (a cura di), Landscape as architecture cit., pp. 84-85.
210 Cfr. V. R , «Sull’orlo di un precipizio bagnato dal mare»: un percorso di cono-scenza per la conservazione dell’abbazia di San Pietro a Crapolla, in C -R (acura di), Conservazione e valorizzazione cit., p. 76; R , Memory and conservation cit., inE (a cura di), Landscape as architecture cit., pp. 83-87.
Gaspare Adinolfi
288
si fi gurerebbe in elevato la parte nobile del complesso religioso, così comeavrebbero potuto concepirlo i suoi primi artefi ci – basiliani per conget-tura211, benedettini per tradizione212. Come che sia, i monaci a Crapolla,a dispetto della evidente proiezione a mare del loro stesso insediamen-to religioso, ricavarono sostentamento e risorse da luoghi eminentementecollinari: intendiamo la vicina grancia di S. Giacomo alla Pedara213 e la più lontana dipendenza agricola in Vico Equense, abbastanza importante da denominare uno spazio compreso fra l’antico casale di Massaquano e l’ancora più antico collegamento viario tra la penisola sorrentina e la pia-na nocerino-sarnese214, a cavaliere del quale si colloca la grancia dei SS.Filippo e Giacomo a Crapolla215. Con ogni probabilità in queste aziendeagricole ante litteram si produceva quel vino che i vassalli della Badia ma-dre erano tenuti a trasportare «apud Amalfi am», lì dimorando in qualità divenditori «per octo dies»216. Attività, almeno per la grancia equense, ancorafi orente nella prima metà del Cinquecento, quando la Regia Camera della
211 Cfr. A , Lucubrationes cit., 1731, lib. II, cap. IX, p. 184; I ., Lucubrationescit., 1732, lib. II, cap. IX, pp. 247-248, subito seguito da V. D , Memorie istoriche della Fedelissima, ed antica Città di Sorrento, Napoli 1740, p. 24, da cui C , Memorie storiche cit., p. 114; della stessa opinione è pure D , Siren Land cit., cap. VII, p. 116.d
212 «Monaci negri di S. Benedetto», secondo P , Descrittione cit., cap. IX, p. 42.213 Cfr. M , Massalubrense antica cit., p. 27 e F C , Storia di
Massa Lubrense cit., pp. 604 e 653 (che legge ma non cita il f. 85 della Santa Visita del 1685di mons. Nepita; anch’essa in ADS).
214 Cfr. M. R , Il Territorio tra Stabia e Punta della Campanella nell’antichità. Lavia Minervia, gli insediamenti, gli approdi, in F. S (a cura di), Pompei, il Sarno e la Penisola Sorrentina, Atti del primo ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia(Pompei, aprile-giugno 1997), ivi 1998, (pp. 23-98), pp. 27-29.
215 Cfr. D G , Vico Equense cit., pp. 188-189; M. V , Tra Massa e VicoEquense. Monaci a Crapolla, in “Match Point” (Mensile di cultura e informazione), a. VI -n. 1, gennaio 1992, p. 3; T , Monasteri e conventi cit., pp. 28-30; I ., Vico Equenseed il suo territorio cit., pp. 258-260; S. B , La cappella dei Santi Filippo e Giacomodei Monaci di Crapolla, in E . (a cura di), Il recupero storico-ambientale della piazza del casale di San Salvatore, Castellammare di Stabia 2006, pp. 14-16 e L. M , Ex granciadell’Abbazia di Crapolla, in G. G (a cura di), Il territorio e la memoria. Paesaggio ru-rale e antichi casali a Vico Equense, Napoli 2008, pp. 76-81; tra le più remote attestazionidocumentali dell’azienda monastica sono l’atto notarile del 31 luglio 1385 in Appendice a R. C - M. V , I Cioffi di Vico Equense. Notizie e curiosità, Castellammare di Stabia1998, pp. 124 s. e quello del 15 nov. 1437 dal Cartulario Sorrento. Giovanni Raparo (2gennaio-31 dicembre 1437), a cura di S. B , Battipaglia 2012, pp. 114 s. (doc. 678).
216 Vd. nt. 181, supra.
Il fi ordo inesistente
289
Sommaria decreta che l’abate commendatario Tommaso Feltro ed i suoi«Clerici possunt extrahere vina pervenientia ex suis benefi ciis sine solutio-ne gabellae», con buona pace dell’allora feudatario Federico Carrafa, utilesignore di Vico217.
Emerge dunque fi n dal XIII sec. per Crapolla una vocazione commercia-le quantomeno singolare se confrontata all’industria dei maggiori monastericostieri, a levante del nostro case-study: a Punta S. Elia (Grancia dei napo-letani Certosini di S. Martino)218 ed a Positano (Istituto benedettino della B.Vergine e di S. Vito martire)219, tanto per non spingerci fi no ad Erchie (traCetara e Maiori), altra sede documentata di un impianto alieutico gestito dauna comunità religiosa (abati della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni)220.
Apprestamenti fortifi cati e venatori nel «Demanio» di Torca, avvian-dosi alla conclusione
Pressoché speculare rispetto alla cappella di Crapolla è l’omonima torre(fi g. 8), puntellata sul ripido Monte di Torca con il suo esercito di ferule(fi g. 3). Ne bastò una a Prometeo per trasferire il fuoco dal Sole alla Terra,dove la scintilla covata nel midollo della Ferula, sia essa glauca o com-munis, innescò l’umana civiltà221. Al titanico espediente, riproposto nell’e-sperienza infernale di sant’Antonio Abate222, protettore del focolare dome-
217 Lo rivela il XXXV («Die ultima Martij, 1536») dei DCCXXVII Arresta Regiæ Ca-meræ Summariæ Neapolitanæ raccolti da D.A. M e impressi a Lione nel 1674 (p.10). Sul bene prodotto a Crapolla cfr. pure M. V , Il vino che ricordava l’antico nomedella città, in “Agorà” (Settimanale cit.), a. XVII - n. 131, 13 luglio 2013, p. 14.
218 Subentrati agli arcivescovi di Amalfi : cfr. C , Le Città del Mare cit., pp. 44-46 e, da ultimo, V. R , Una controversia secolare per i diritti sulla pesca nel mare deiGalli, in “La Terra delle sirene” (Rivista del Centro di studi e ricerche “B. Capasso”), n. 35,Sorrento 2016, pp. 59-65.
219 Cfr. G. V , Storia di Positano, Salerno 1971, pp. 148-150 e pp. 221-222, dove sitrascrive e si traduce in italiano il decreto federiciano del 1225 con cui si assegna al Venera-bile Monastero di S. Maria di Positano il diritto di pesca ricadente nelle acque degli isolotti«quae dicuntur Gallus».
220 Cfr. C , Le Città del Mare cit., p. 27.221 «Homines antea ab immortalibus ignem petebant neque in perpetuum servare scie-
bant; quod postea Prometheus in ferula detulit in terras, hominibusque monstravit quomodo cinere obrutum servarent» (H , Fabulae, 144).
222 Come osserva E. V nella sua edizione della Teogonia esiodea, con Introduzione di E. Cingano, Milano 2004, pp. 101 s., nt. 125.
Gaspare Adinolfi
290
stico, avrebbero potuto far ricorso i torrieri di Crapolla, che nella stagionemigliore per la pirateria223 disposero del fusto ormai essiccato della nostraombrellifera, idoneo dunque alla trasmissione di un fuoco codifi cato224.
Ecco, per sottrarre la spiaggia di S. Pietro agli approdi degli infedeli o ad altrettanto infausti approvvigionamenti idrici225 – le cosiddette «acquate»226
– si diede avvio nel 1567 alla costruzione della nona e più orientale for-tifi cazione di Massa Lubrense227, completata alla vigilia della Battaglia diLepanto, nel ’70228. Se l’ultimo intervento conservativo degno di nota èquello documentato per l’anno 1670229, è evidente come la torre abbia effi -cacemente rintuzzato attacchi ben più insidiosi di quelli barbareschi, mossi insomma dal tempo edace. A questi ultimi si sono aggiunti i guasti causatidal libero accesso alla torre consentito al pascolo vaccino, che in assenza di effi caci recinzioni ha ridisegnato giorno dopo giorno, in oltre dieci anni,il perimetro della sedicente Oasi del Monte di Torca.
223 Per la congiuntura estiva dei traffi ci commerciali cfr. R , Le torri anticorsarecit., pp. 53-55.
224 Riguardo ai criteri di comunicazione di un ideale sistema semaforico cfr. lo stessoR , Le torri anticorsare cit., pp. 26-29 e 174-178.
225 Qui sboccava il «grandioso condotto d’acqua» di M , Massalubrense antica cit., p. 26, ovvero il canale rilevato da Mingazzini (cfr. M -P , Forma Italiaecit., p. 159), o l’intercapedine di M , The archeological evidence cit., in R (a cura di), Landscape as architecture cit., p. 62.
226 Cfr. da ultima M. M , La Mezzaluna e la strategia difensiva spagnola, in L’in-feudazione del Ducato di Amalfi dai Sanseverino ai Piccolomini, Atti del Convegno di Studi(Amalfi , 2-4 aprile 2003), Amalfi 2014, p. 288.
227 Il computo esclude la già nominata Torre del Cantone, realizzata per conto di unprivato cittadino: cfr. F C , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 242 e 472;F.S. M , Nelle torri di Massa Lubrense la travagliata storia della città, in “Antiqua”(Pubblicazione bimestrale dell’Archeoclub d’Italia per la conoscenza, la tutela e la valoriz-zazione dei beni culturali), a. IX - n. 3-4, maggio-agosto 1984, (pp. 42-46), p. 45.
228 Cfr. F C , Storia di Massa Lubrense cit., pp. 236-242.229 Cfr. F. S , Documenti per la storia di castelli e torri del Regno di Napoli,
Postfazione di A. Mozzillo, Sorrento 1992, pp. 64-66 (alla cui fonte tacitamente attingono siaS , The cantieri masonry cit., p. 132, nt. 8 che F. D , Architettura fortifi catain Penisola sorrentina. Conoscenza e conservazione della torre di Crapolla, in C -R , Conservazione e valorizzazione cit., p. 93, nt. 3) e, per una analisi puntuale delle tes-siture murarie, G. F , Strutture tardomedievali e moderne della costa di Amalfi (XII-XVI secolo), in Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra di Lavoro (XVI-XIX), a cura di G. F e L. G , Napoli 2008, t. I, (pp. 13-54), pp. 41 ss.
Il fi ordo inesistente
291
Il ricorso ai ruminanti, storicamente evocato anche dalla toponoma-stica230, ha contribuito a sollevare i bracconieri locali dall’incombenza diappiccare incendi stagionali, sapientemente anticipati rispetto al passaggiodelle quaglie231: così facendo, i cacciatori di frodo si son limitati ad ammac-chiare nel Monte232 cinguettanti altoparlanti, che amplifi cano nottetempogli impulsi provenienti da un impianto elettroacustico (fi g. 13b)233, a suavolta installato o blindato tra i residui muretti a secco o all’interno di alcunipagliaruli234 (fi g. 13a). Il verso artefatto si estingue all’alba, trascorse quat-tro/cinque ore di esercizio ed intercorso l’omertoso silenzio dei più viciniresidenti. In attesa dunque di comprendere in che misura questa “Oasi”contribuisca al «ripristino dell’ecosistema originario»235, o a scongiurare«due o tre incendi boschivi l’anno»236, il Monte di Torca resta solo un’abu-siva riserva venatoria.
La ripercussione sul paesaggio vegetale delle attività antropiche si leg-ge, guadagnando terreno, nel brusco passaggio dalla garìga237 ai coltivi,pressoché orfano della formazione intermedia, che è quella della macchia
230 Cfr. A , ′e vvie ′e miez′ cit., p. 69, nt. 22.231 Vd. nt. 103, supra.232 Secondo P. E , Inquadramento storico-religioso, in E -R (a cura
di), La Lobra cit., p. 63, nt. 78 «Vengono così chiamati, abitualmente, dalla popolazionequelle terre ricche di oliveti e macchia mediterranea che aff acciano sul golfo di Salerno daRecommone a Crapolla, di cui molta parte costituisce demanio comunale». Sull’argomentovedi pure A. E , Terre gravate da uso civico, in Pensiamoci su: Massa Lubrense, il paese del buon vivere, Massa Lubrense 2015, pp. 27-29.
233 Il ricorso ad un equivalente dispositivo elettromagnetico è già attestato in Per i cac-ciatori del Sorrentino Ferragosto comincia domani. Nella penisola restano coloro che nondispongono di auto, qualche «tradizionalista» e i bracconieri, una piaga che si va semprepiù estendendo, “Il Tempo”, a. XXII - n. 236, 28 agosto 1965, p. 7.
234 Altri manufatti di questo tipo si possono scorgere dal crinale del Monte S. Costanzo:cfr. A , ′e vvie ′e miez′ cit., p. 50, fi g. 8; I ., ′e vvie sulitarie cit., p. 119.
235 A. R , Un’oasi di diciassette ettari nel Monte di Torca, in “Agorà” (Settimanalecit.), a. VII - n. 179, 25 ott. 2004, p. 17.
236 Ibid. Gli ultimi due, di vastissime proporzioni, risalgono al 24-25 agosto e 4-5 set-tembre 2016.
237 Termine di origine provenzale (dal fr. garigue) che in botanica sta ad indicare unaaperta formazione xerofi la di erbe e suff rutici, spinosi e talvolta aromatici, su suoli rocciosi epoco evoluti. La gariga è spesso l’esito vegetazionale del degrado della macchia o delle fore-ste: un’ulteriore recessione porterebbe alla steppa o al deserto (cfr. La macchia mediterraneacit., e Coste marine rocciose cit., passim).
Gaspare Adinolfi
292
bassa238. Si resta pertanto nel dominio delle entità pirofi le o delle cosiddettepiante pioniere, tra le quali svetta il Tagliamani (Ampelodesmos mauritani-((cus), qui noto come «lepantine», un tempo largamente usato per intrecciarefuni o reti da pesca239. Per la medesima attività son note le qualità dei ramidi Mirto (Myrtus communis), che appaiati ai polloni d’olivo si piegano allarealizzazione di nasse ellissoidali per gamberetti240 (fi g. 15). Più su, in pa-ese, può capitare d’imbattersi in un anziano in grado di confezionarle241: ilpiacere di vederlo in azione, tuttavia, è pari almeno al dispiacere di appren-dere che lo stesso artigiano è anche l’ultimo pescatore-bombarolo di questeparti…242 Lo si ritrova, per diabolica combinazione, nel nome della viaintercettata dalla nostra Discesa Monte di Torca, una strada oscena come poche: ha inizio lì dove termina il sentiero marcato di rosso, e monta verti-ginosamente in paese, aggraziata solo dalla primaverile fi oritura di Aceto-sella degli oliveti (Oxalis pes-caprae).
Scollinando ci si affi da a Via Gesine, ricordo odonomastico di perdutiseminativi243. All’altezza del traffi cato crocevia (fi g. 14), appena moderatodal sant’Antonino maiolicato, la breve Via Botteghe di Sotto s’interpone al raggiungimento del sagrato, anch’esso rotabile, della chiesa di S. Tom-
238 Si veda tout court lo “Schema dinamico semplifi cato della vegetazione mediterra-tnea” in La macchia mediterranea cit., p. 25.
239 Cfr. V. S - G. C , Ricerche etnobotaniche in Costiera amalfi tana: gli usi marittimi, in “Informatore Botanico Italiano” (Bollettino della Società Botanica Italiana),vol. 41 - n. 1, gennaio-giugno 2009, p. 6; V. S , Usi delle piante in Costiera amalfi tana.Esplorando il rapporto tra le piante e l’uomo / Uses of plants in the Amalfi Coast. Exploring the relationship between plants and people, Amalfi 2010, p. 74.
240 Cfr. C. F , Un gamberetto ecologista. Si chiama Parapandalo e si fa catturaresolo dalle nasse fatte a mano…, “Specchio” (Settimanale di attualità, supplemento al quo-tidiano “La Stampa”) n. 347, 26 ott. 2002, pp. 125-127; S -C , Ricerche etnobo-taniche cit., pp. 6-7; S , Usi delle piante cit., pp. 74 s.; A. S , Il gamberetto di nassa di Crapolla, in “Sorrento. The hospitality magazine about the Sorrentine Peninsula”,primavera-estate 2017, pp. 96-97.
241 Cfr. G. A , Extra Moenia. Itinerari storico-naturalistici a Sorrento, Sorrento2006, p. 115.
242 Come rivelato dall’ass. Donato Iaccarino, delegato pro tempore alla Cultura del Co-mune di Massa Lubrense, dallo 8° min. e 17 sec. allo 11° min. e 40 sec. del documentofi lmato da M. Zanutto per la rubrica televisiva “Campanili”, riproposto on line dal sig. A.Terminiello in www.torca.it (collegamento del 15 aprile 2015). Già in M , Passeggiatecit. 1990 [1949], p. 96 c’è traccia di tale illecita attività.
243 Cfr. A , ′e vvie sulitarie cit., 2011, p. 92, nt. 118 (con bibliog. prec.).
Il fi ordo inesistente
293
maso244. Chiunque vi entri calpesterà già all’ingresso, come è stato nellacappella a Crapolla, il lapidario ricordo di moderni nostoi, dal Nuovo alVecchio continente. Stavolta da New York a Torca.
Spunti fi nali di rifl essione sopra le recenti «Strategies for conservationand fruition enhancement» del sito di Crapolla
Coerentemente al precedente tentativo di tutela itinerante, ideato da chiscrive per l’area archeologica di Punta della Campanella245, anche il pre-sente contributo alla conoscenza e alla salvaguardia della ria di Crapollanon poteva sfuggire alla logica di avvicinare lentamente – da cui la sceltadell’ideale natante – e progressivamente informati – abusando così dellapazienza del lettore – un altro sito d’interesse comunitario ricadente nelterritorio di Massa Lubrense. Alla stregua di Punta della Campanella, per laquale sono ormai evidenti i rovinosi esiti246 della maggiore affl uenza auspi-cata dal progettista dei lavori stradali247, anche l’intervento proposto per lagià richiamata «conservazione del sito culturale di Crapolla» non prescindedalle sue vie di accesso e dallo stato attuale della sua rete sentieristica248.Senza alcuna pretesa di entrare nel merito degli elaborati, che come quelligià licenziati sorvolano a grande altezza le emergenze naturalistiche delluogo, possiamo segnalare, per quanto ci compete, la riduzione di alcunielementi del paesaggio vegetale di Crapolla in evidenze di segno opposto:«presence of autochtonous vegetation» nel novero delle risorse, «presenceof infesting vegetation» tra i punti critici del sentiero a gradoni249. Non èforse la vegetazione ritenuta infestante dagli autori parte integrante della
244 Su questo antico luogo di culto, già esistente nel Trecento, cfr. F C ,Storia di Massa Lubrense cit., pp. 574-577.
245 Recentemente interessata da pubblici lavori di “Restauro manufatti ed abbattimentobarriere architettoniche - Via Campanella” (cfr. G. A , “A tocchi a tocchi, la campana“sona”. Il cantiere di Via Campanella riapre il dibattito sulla conservazione e la fruizione deiluoghi di pregio, in “La Terra delle sirene”, Rivista del Centro di studi e ricerche “B. Capas-so”, n. 34, Sorrento 2015, pp. 81-100; I ., Punta della Campanella cit.).
246 Si leggano, nel blog Discettazioni erranti, gli scritti a fi rma di G. Visetti pubblicati il23 e il 27 maggio 2016, il 30 agosto ’16 e il successivo 6 ottobre.
247 Cfr. A , “A tocchi a tocchi” cit., pp. 97 s.248 Cfr. L. M , The environmental context, in R (a cura di), Landscape
as architecture cit., pp. 163 s.249 Ibid., p. 165, fi g. 5.
Gaspare Adinolfi
294
vegetazione autoctona? Quali siano nello specifi co, secondo il gruppo distudio, le entità erbacee o legnose aff erenti al primo o al secondo contin-gente non è dato sapere. Quando si dice far di tutta l’erba un fascio... ivicompresa la fl ora endemica e rara tutelata in Campania dalla Legge Reg.n. 40 del 25 nov. 1994.
Un altro motivo di discussione dovrebbe riguardare, restando sul mede-simo sentiero, il sistema di illuminazione ideato per un «possible nocturnal touristic use» dell’insenatura di Crapolla, quando gli auspicati visitatori potranno ascendere in sicurezza ai ruderi dell’abbazia di S. Pietro guidati da «low-intensity luminous step markers»250.
Favorire la fruizione notturna del sito, già inaugurata nell’estate 2015 da una giovane associazione ricreativa251, signifi ca tra l’altro interferire conl’attività predatoria dei rapaci notturni252 – formidabili ‘derattizzatori’ na-turali –, disturbare la nidifi cazione dell’avifauna residente, rappresentata– qui pure – dal Falco pellegrino253, rinunciare al piacere di apprezzare, amare, diverse forme di vita bioluminescenti. Tra le possibili vittime dell’in-quinamento acustico e luminoso vanno pure considerati quei pipistrelli chedalle cavità carsiche del comprensorio di Crapolla – le più importanti sonole Grotte Vaccare254 (fi g. 16) – raggiungono le zone umide della ria a cacciadi insetti.
Altrettanto grave sarebbe l’impatto ambientale se, recuperando me-moria di un antico diritto dell’Università di Massa Lubrense, il jus taber-
250 Ib., p. 165.251 Per i dettagli delle serate rimandiamo ai seguenti comunicati stampa: Crapolla. Una
serata da dieci e lode, in “Agorà della Penisola Sorrentina” (Settimanale cit.), a. XIX - n.240, 22 agosto 2015, p. 15 e Crapolla sotto le stelle 2016. I ringraziamenti dell’AG 361°, in“Agorà della P. S.”, a. XX - n. 289, 6 agosto 2016, p. 15.
252 Tra i quali è il Barbagianni (Tyto alba) rinvenuto nell’agosto 2016 dall’amica Fran-cesca Esposito e rilevato da chi scrive il successivo 6 settembre per Ornitho.it, la piattaformacomune di informazione di ornitologi e birdwatchers italiani.
253 Presente nell’Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE (la cd. Direttiva “Uccelli”) enel formulario standard (cod. A103) del SIC ‘Costiera amalfi tana tra Nerano e Positano’,questo animale è considerato una specie «vulnerabile» per la Lista Rossa italiana.
254 Le «Cryptae Baccarum» di Nepita, A. C. Tarusio cit., cc. 402r e 410r (cfr. A ,′e vvie ′e miez′ cit., p. 69, nt. 22) risultano presenti nella Carta dei Beni Culturali di MassaLubrense 1992 (V 03-01; V 04-01; D 14-24), ma assenti nell’elenco catastale delle Grottenaturali della Campania in Grotte e speleologia cit.
Il fi ordo inesistente
295
nandi255, si concretizzasse la possibilità di destinare i magazena (volg.“monazeni”) più vicini alla battigia, oggi di proprietà privata, «ad attivitàproducenti micro redditività in grado di valorizzare le eccellenze localianche di natura gastronomica»256; attività che già rappresentano una realtàeconomica da Recommone a Nerano257.
Insomma, le strategie per la conservazione e l’incremento della frui-zione di un sito culturale come quello di Crapolla dovrebbero, in ossequioal vigente Piano Urbanistico Territoriale258, divergere dagli interventi che
255 F C , Storia di Massa Lubrense cit., p. 351 osserva che nelle taver-ne esistenti presso le marine di Puolo, della Lobra, del Cantone e di Crapolla «si vendeva ilvino e vi era la proibizione di potersi vendere in qualunque altro modo». Lo stesso introitopercepito dalla lubrense Universitas Civium nel 1624, una somma pari a 35 ducati, fi guranello «Stato de’ corpi universali a 31 agosto 1736», come F. A , La Costiera nel Sette-cento. Congiuntura economica e strutture sociali, Presentazione di B. Iezzi, Sorrento 1985,p. 57 riporta in Appendice.
256 G. V , Architetture rurali nell’ambiente del fi ordo, in C -R (acura di), Conservazione e valorizzazione cit., p. 86. In questo senso, un tentativo di spe-culazione si verifi cò una quindicina di anni fa (cfr. tra gli altri A. S , Crapolla,imminente il sequestro dei manufatti. Riscontrati abusi edilizi nella suggestiva insenatura,“Il Mattino” 4 feb. 2000, p. 30; V. M , Denuncia degli aderenti al Wwf: un ristorantenell’area protetta. L’area è il borgo di Marina di Crapolla, “Roma” 30 agosto 2002; I .,Sequestro nel borgo di Crapolla. Opere abusive su territorio demaniale nell’area di PuntaCampanella, “Roma”, 3 ott. 2003).
257 Vd. la sezione Gastronomia. Tradizione e personaggi della puntuale Guida agli al-berghi, ristoranti, agriturismo di Massa Lubrense (ivi 2000), pp. 33 ss.
258 Come è noto, ai sensi della Legge n. 431/85 (cd. Legge Galasso) ed in virtù delPiano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’Area Sorrentino-amalfi tanapubblicato nel 1977, il Consiglio Regionale della Campania approva il Piano UrbanisticoTerritoriale dell’Area sorrentino-amalfi tana con la L. Reg. n. 35/1987. Il PUT inserisce ilterritorio di Crapolla nella Zona Territoriale 1a, successivamente recepita nel Piano Regola-tore Generale di Massa Lubrense (1992) come Zona E1 di tutela dell’ambiente naturale diprimo grado. Recuperando il dettato del PUT di cui all’art. 17, il PRG prevede la seguentedisciplina per la zona: «sono vietati sbancamenti e riporti, mutamenti di destinazione del-la attuale edilizia agricola, nuove edifi cazioni sia pubbliche che private, attraversamenti distrade, funicolari, funivie […], realizzazioni di elettrodotti aerei e di acquedotti fuori terra,di impianti fognari e di depurazione […], interventi di dissodamento delle aree di vegetazio-ne spontanea e/o rimboschimenti con essenze estranee alla tradizionale fl ora locale»; sonoconsentiti, previa autorizzazione: «la manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamentoconservativo degli edifi ci documentati come esistenti al 1955; la rifazione di muretti a seccoin pietra calcarea locale a sostegno di terrazzamenti [...]; l’impianto di essenze arboree earbustive non in contrasto con la tradizionale fl ora locale negli spazi verdi di pertinenza delle
Gaspare Adinolfi
296
tendono ad urbanizzare un luogo naturalmente isolato259, dove solo rinun-ciando ad un approccio antropocentrico si può sperare, a parer nostro, dicomprendere il senso di ciascun elemento del paesaggio.
Risorse dal Web
a. Siti di interesse nazionale
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/
Portale cartografi co nazionale: http://www.pcn.minambiente.it/GN/Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): http://www.
isprambiente.gov.it/itArchivio cinematografi co “Istituto Luce Cinecittà”: http://www.archivioluce.com/
archivio/
b. Siti di interesse regionale
Sistema informativo territoriale della Campania: http://sit.regione.campania.it/portalAutorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino
idrografi co del fi ume Sele: http://www.adbcampaniasud.it/
residenze esistenti […]»; secondo lo stesso art. 39 «è d’obbligo […] la sistemazione, la ma-nutenzione o il ripristino dei sentieri pedonali che consentono l’accesso pubblico al mare oai luoghi panoramici o ai corsi dei rivoli e zone ambientali annesse». Con l’entrata in vigoredel PUT ha perso dunque consistenza la (sciagurata) proposta di Una strada per Crapollaavanzata da L. S , in “La Trocola. Su cose di casa nostra” (Periodico mensile), a.III - n. 6, 25 luglio 1976, p. 5.
259 Come lo era la più ampia ria di Furore prima del passaggio, a partire dall’ultimoquarto dell’’800, della odierna S.S. n. 163 (cfr. amplius M. R , L’avvento delle straderotabili ed il loro impatto con il paesaggio, in La Costa di Amalfi nel secolo XIX. Metamor-fosi ambientale, tutela e restauro del patrimonio architettonico, Atti del Convegno di Studi(Amalfi , 22-23 giugno 2001) a cura di G. F (vol. II), Amalfi 2005, pp. 15-64). Sullastessa celeberrima insenatura incombe oggi l’ennesimo progetto calato dall’alto: si tratta difar viaggiare un ascensore di vetro dentro e fuori la roccia strapiombante di Furore per 300metri (!), col pretesto «di ripristinare quell’equilibrio rotto dall’apertura dell’ottocentescarotabile Positano-Vietri, che nel connettere alcune aree ne ha fatalmente emarginate dellealtre», riferisce A. A per eddyburg.it in L’assalto alla Costiera Amalfi tana del 22 sett.2014 (collegamento del 18 sett. 2016).
Il fi ordo inesistente
297
Biblioteca Nazionale di Napoli: http://www.bnnonline.it/Emeroteca Biblioteca Tucci: http://www.emerotecatucci.it/
c. Siti di interesse locale
Foglio 466-485 ‘Sorrento-Termini’ della Carta geologica d’Italia edita dall’ISPRA(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel 2014: http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/466_485_SORRENTO_TERMINI/Foglio.html
Area Marina Protetta “Punta Campanella”: http://www.puntacampanella.org/Aspetti botanici e naturalistici della Penisola sorrentina: http://www.meditfl ora.com/Fonti biblio-emerografi che per la salvaguardia dell’area di Punta della Campanella:
https://ateneolubrense.wordpress.com/Scritti e immagini su “Torca, borgo della Penisola Sorrentina che guarda la Costa
Amalfi tana”: http://www.torca.it/ (con link a “Crapolla e dintorni”: http://www.crapolla.it/)
Iniziative socio-culturali dell’associazione no profi t “Torca Crapolla”: http://www.torcacrapolla.com/
Gaspare Adinolfi
298
Fig. 1 – Massa Lubrense – la baia di Iéranto in una interessante e rara ripresa aerea, s.d. (ma secon-da metà del ’900) (coll. A. D’Esposito).
Fig. 2 – Ivi – le grotte dello Scoglione e del Castello, rispettivamente cerchiate di bianco e di nero,nel settore sud-orientale del M. S. Costanzo (foto di G. Adinolfi ).
Il fi ordo inesistente
299
Fig. 3 – La costa meridionale di Massa Lubrense dal pendio di Crapolla ai “Tre Pizzi” di Iéranto(foto di G. Adinolfi ).
Gaspare Adinolfi
300
Fig. 4 – L’insenatura di Crapolla ai piedi di Torca, frazione di Massa Lubrense (foto di G. Adi-nolfi ).
Il fi ordo inesistente
301
Fig. 5 – La ria di Furore in Costiera Amalfi tana (foto di G. Adinolfi ).
Gaspare Adinolfi
302
Fig. 6 – Massa Lubrense – Crapolla e i suoi pescatori nel 1927 (foto di G. Spinazzola – coll.Doria-Visetti).
Fig. 7 – Ivi – ascesa processionale alla cappella di S. Pietro, anno 1949 (coll. L. Di Maio).
Il fi ordo inesistente
303
Fig. 8 – Massa Lubrense, Monte di Torca – la Torre di Crapolla in primo piano, sullo sfondo ilmini-arcipelago de Li Galli (foto di G. Adinolfi ).
Fig. 9 – Ivi, Via Crapolla – ricognizione naturalistica nel rivo Iarito, a valle di loc. Casalvecchio(foto di G. Adinolfi ).
Gaspare Adinolfi
304
Fig. 10 – Rana appenninica (Rana italica(( ) in accoppiamento(foto di G. Adinolfi ).
Fig. 11 – La Salamandrina dagli occhiali rilevata nei pressi diCrapolla dal WWF Penisola Sorrentina (foto di G. Adinolfi ).
Il fi ordo inesistente
305
Fig. 12 – Massa Lubrense – orchidea spontanea (Orchis provincialis) nell’antico querceto di Cra-polla (foto di G. Adinolfi ).
Gaspare Adinolfi
306
Figg. 13a e 13b – Ivi, caratteristico pagliarulo del Monte di Torca con elementi dell’impiantoelettroacustico (foto di G. Adinolfi ).
Il fi ordo inesistente
307
Fig. 14 – Torca, fraz. di Massa Lubrense – ‘canefore’ in Via Gesine (25 feb. 2004) (foto di G.Adinolfi ).
Gaspare Adinolfi
308
Fig. 15 – Torca, fraz. di Massa Lubrense, Via Torricella – fase conclusiva dell’artigianale realiz-zazione di nasse per gamberetti (26 ott. 2004) (foto di G. Adinolfi ).
Fig. 16 – Ivi, Monte di Torca – aff accio sull’isolotto di Vetara, nel Golfo di Salerno, dalle GrotteVaccare (foto di G. Adinolfi ).