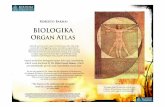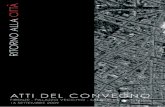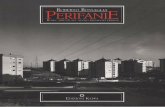Roberto Biondi Le mura della città dell'Aquila
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Roberto Biondi Le mura della città dell'Aquila
R i i i i : la Porta di Bagno.
Roberto Biondi, : la Porta di
Bagno.
In Fedelmente, rivista dell'Istituto Superiore di Scienze
Religiose "Fides et ratio" dell'Aquila, 1 (2011), pp. 193-217.
R i i i i : la Porta di Bagno.
ILLUSTRAZIONE DELLA PRASSI OPERATIVA
SEGUITA PER IL RILIEVO DELLA PORTA DI BAGNO
La P i g è p i pi i i h i i .
Si apre in una delle torri che costellano il perimetro della cinta muraria nella zona meridionale. Una
nuova strada, intitolata a Luigi Sturzo, la fiancheggia, ma il piano di calpestio è di almeno un metro
zz s p i s p h è i fi pi i p s . Si
esattamente alle spalle della Chiesa di Cristo Re, leggermente in alto dietro la chiesetta della
Madonna degli Angeli fuori Porta Napoli - porta realizzata con la caduta in disuso e la chiusura
della porta di Bagno-. Q s i più v s p s s i s i i v p i
e superficiale analisi il travaglio subito nel tempo.
R i i i i : la Porta di Bagno.
Ripetuti crolli si alternano a limitate ricostruzioni, a tamponature seguono parziali riaperture
p s i i p ss ggi p . E iffi i i i s i ip gi hi i
h h ss h s i p si i ggi i. S p ssi i i
ip si s s i p i i i p i igi i s s i ip gi
degli archi delle altre porte più o meno coeve, che fanno pensare ad un arco a sesto acuto. Quella di
un arco a sesto acuto sembra poi essere la stessa idea che il restauro del 1969 voleva probabilmente
restituire.
Antiporta di Porta di
Barete.
Porta Roiana
R i i i i : la Porta di Bagno.
Le alterne vicende si intrecciano in maniera non sempre chiara con gli avvenimenti storici
della città e con le incerte notizie rintracciate sulla stessa porta.
Dopo un studio dei documenti storici rintracciati nelle biblioteche e negli archivi della città,
p g isi f i p sp i pi iv i
nostro interesse, trovate presso la Soprintendenza, la nostra indagine si è concentrata sulla struttura
architettonica.
i ivi zi ne delle singole unità stratigrafiche murarie è stata spesso ostacolata dal
cemento, in più punti e in diversi momenti, impiegato nei vari restauri, che ha nascosto il legante
originario, raramente ancora visibile. La ricostruzione consequenziale delle diverse fasi ci ha
permesso poi di ipotizzare, con una certa sicurezza, una cronologia relativa dei diversi interventi.
I prospetti da noi realizzati sono relativi alla sola cortina muraria esterna della torretta essendo
i i p i pito da terra e lo spazio sovrastante recintato, in quanto,
ormai, proprietà privata. Resta invece demaniale la fascia di terreno sottostante. Anche questa ha
chiaramente subito nel tempo una trasformazione radicale. Nel tratto di mura sulla destra della porta
(sx di chi guarda) appoggiato sulla roccia (nella quale sono state ricavate grotte - oggi cantine
private - che da fonti orali apprendiamo essere ex- v p s zi s i s zi )
restano scoperte le fondamenta con un andamento obliquo che scendendo verso la torre dà
f i i i v ss ss i p ss p i i p i
sbancamento della parte ovest e del riempimento, quasi sicuramente contemporaneo, della zona ad
s h h s i terramento della parte bassa del portale. La Porta di Bagno doveva, a questo
punto, essere già stata chiusa, ma la sua funzione, anche se parziale, dovette essere svolta dalla
s ssiv p i p ss ggi p h ss ggi .
Del tratto di mura sono state da noi fatte diverse rilevazioni fotografiche, attente a cogliere i
v i sp i i più . E s i izz hi R f x . Nik F801
con focale a 50 mm, posta su cavalletto, messa a livello e perpendicolare al centro della sezione di
p f g f . s p i fi pi i h f i si i p i i if i .
Tutto ciò è stato possibile per la parte frontale su cui si apriva la vecchia porta, mentre maggiori
sono stati gli ostacoli che si sono dovuti superare per riuscire a fotografare le superfici laterali della
. Q i i s zi i p s g i p p i i h
ostacolato il corretto posizionamento della macchinetta fotografica sul cavalletto.
R i i i i : la Porta di Bagno.
L’Aquila: le mura e la Porta di Bagno
« i g i p i i sp ss v i i si i i i i i
da lungo tempo spariti o riconoscerne la certa esistenza in un dato periodo o persino lumeggiar
notizie che s is i i is ss h i …»1
Così esordisce L. Rivera nel presentare i risultati degli studi da lui condotti sulle piante di
Gerolamo Pico Fonticulano, matematico e cartografo del XVI secolo, e di altri cartografi
(abb i gi i si s i zz ) s p i i s i «…i
p g ssiv svi pp i g i i izi … i vi i i sf zi i
vi issi i i più pi si p p stesso e del tempo ».2
Ci s i p g i p f s i i ipi Riv p ss i
“ ” i p s zi h gi h s s i is “ i g i p i i ” fig
h g h si a dello sviluppo diacronico della morfologia della città un
modus operandi di tipo stratigrafico ante litteram.
Lasciando da parte suggestioni forse troppo fantasiose, ci sembra comunque rilevante sottolineare
s h i izi N v si f pi i i p s s è
i s i zz h si i i i i più i i i p
ricostruzione del disegno della città quale essa doveva apparire ai cartografi che tracciavano strade
e piazze, chiese e palazzi, fontane e mura di cinta.
La città era stata testimone di vicende assai intricate, di un processo storico dialettico spesso non
p iv i z v f s è i s h g i h h gi p f g
dubbi e colmare, ove possibile, vuoti di documentazione.
g si i i è i p ss p iv i pis i sig ifi ivi si “ gi i” h
concorrono a far nascere mitologie e fortunate leggende storiografiche.
Per ciò che concerne la fondazione i ppi s i i s v i i i s i
delle parole di Boetio de Raynaldo o Buccio di Ranallo, la fonte più vicina ai fatti, il quale nella sua
Cronaca così scrisse:
«Ficero la citade solliciti et uniti:
anni mille ducento cinquantaquattro giti».
1 L. RIVERA, Le piante ed i prospetti della città dell’Aquila (sec. XV-XIX) i “ . D p. . i S . P .” XVIII
i 1905 II p. 102. 2 ibidem , p. 102
R i i i i : la Porta di Bagno.
A questo punto pare legittimo ricordare le posizioni divergenti alle quali sono giunti alcuni storici
nel tentativo di dissipare nebbie più o meno fitte riguardo ai primi anni di vita della città.
Alessandro Clementi, per esempio, ritiene fondamentale e imprescindibile la presenza di una fitta
i i s i i is si g vi i i s i ( s. S. Spi i O ;
S. M i M ; S. M i i C s v …) – i s s iv i p s i iv e
una economia da secoli smorzata a causa di episodi traumatici (dominazione longobarda; scorrerie
saracene e ungare; fine della transumanza)- e tende comunque a considerare fondate le
si zi i i i i p –ossia nella prima metà del Trecento (è il periodo nel
quale con tutta probabilità Buccio compose la sua opera)- avrebbero potuto essere oppugnate da
qualche testimone oculare.3
Orlando Antonini, di contro, tende a retrodatare la fondazione della città, dando particolare risalto
a p s “sp sp i z is i h ” v ifi si s “ p ” gi p i
dai primi anni Venti del Duecento.4
Questo breve excursus sulle intricate vicende della genesi della città serve a fissare un terminus a
quo, che noi abbia i ivi p s zi i h ig isi i
i i s p ss ss i i z i i .
V s i s i h p iò h igi Civi s i g i s i i
sono sempre concordi, mentre si registra un sostanziale allineamento per quanto riguarda la genesi
delle mura urbiche.
Epis i p iò h g vi i s i i è s z is zi
certa, operata da Manfredi nel 1259, che dovette verosimilmente cancellare ogni traccia del
primiero impianto svevo.
Nella I fase di crescita della città (1229-54/1259) una cinta difensiva di incerta localizzazione
v “ i ” hi i p i s s .5
A prestare ascolto alle parole di Buccio e di Angelo Leosini sembrerebbe che, più che di mura
vere e proprie, si debba parlare di poco più che un recinto di legno e di fossati di protezione,
intervallati da un qualche lacerto di muro.6
Alle parole di Buccio: « represero la terra con fussi e con sticcati » si potrebbe prestare ascolto ,
ma Bernardino Cirillo, storico aquilano rinascimentale, nella sua opera Annali della città
3 A. CLEMENTI, Storia dell’Aquila, Bari 1998 4 O. ANTONINI, Architettura Religiosa Aquilana i 1993. I ff h s i i i
Acculi sorgesse una città romana o preromana il cui nucleo originario era costituito dal Borgo Rivera. La tradizione alla
quale si rifà, per questa interpretazione, è S. MASSONIO, Dialogo sull’origine della città dell’Aquila, 1594; ripresa poi
da A. SIGNORINI, La Diocesi di Aquila descritta ed illustrata, Aquila 1868. 5 C. FRANCHI, Difesa per la fedelissima Città dell’Aquila… N p i 1752 CC XXV. Cf . i f 9 p. 2. 6 A. LEOSINI, Annali della città dell’Aquila, cit in L. MARTELLA - A. M. MEDIN, Le mura dell’Aquila: appunti
per una rilettura organica del sistema difensivo, i “Mis ” . 4 i 1977 p. I p. 15: «…si i
sol uomo a stabilire con fossi e steccati.».
R i i i i : la Porta di Bagno.
dell’Aquila sì s iss ig p i f si i z i ia: «disegnata
si i p s i pi s i pi i ifi i
concorso grande de i popoli, et di genti atte a simili fatighe, fu il sito della città cinto in qualche
parte di fossa, et di muro tanto alto, che già vi si poteva sicuramente habitare...».7
I if s h i pp s ò i f pp M f i h
si s s p s è i f p ss hé s s p ss si s hi p
angioina e quindi del Papa.8
“S y i s s i si v s ip ”; sì i i i f ; i f i p
g i i v 1266 i f i ifi h ss s i C I i iv
i ss isp re di una città fedele, ubicata in un territorio geograficamente e
politicamente importante.
Si procedette così alla nuova edificazione della cortina muraria, con un perimetro molto meno
esteso rispetto al progetto del 1229-54/1259, che qualche storico, ha fi i “ g ”.
Il tracciato murario del 1266/1272-73 dovette essere, con tutta probabilità, quello che ancora oggi
si osserva, fatta eccezione per le mura che correvano lungo il sito oggi occupato dal Forte Spagnolo
p i si C i Collemaggio.9
gi s p zi ( i v i) f z if s i
muratura, trova riscontro nelle parole di Buccio:
«Quisto che questo fece fo miser Lochesino
F pi i v i p g i »;
Lucchesino f i i pi i i i p . E fi i i
s i si v i i izi gi i h p i . si i f s i
ricostruzione delle mura.
7 B. CIRILLO, Annali della città dell’Aquila 1570 i I p. 5. I s p s gi i
probabili motivi che spinsero ad edificare le mura in pietra e non in izi i è z i i p i . 8 Si v p pi i ppi fi h g v i P p C gi i p i g
diploma di Gregorio IX del 1229 che concedeva alle popolazioni di Forcona e Amiternum di edifi i “ p
” i . C EMENTI, Storia dell’Aquila cit, e O. ANTONINI, Architettura cit. 9 Ci sembra di capire che nelle intenzioni dei progettisti ci fosse anche quella di includere la Basilica nel perimetro
murario; in verità essa fu lasciata fuori di detto perimetro in virtù, forse, degli alti prezzi di realizzazione e delle
difficoltà che avrebbe comportato la difesa di un territorio così vasto.
Buccio dice a proposito: «Lo Colle de Collemaggio daventro lo mettero».
C. FRANCHI, nella Difesa per la fedelissima città dell’Aquila 1752, p. CVIII scrive al riguardo: « Debbono per piu
(si ) hi i ig z ss g i i i si p s i i p i i v si s zz i [… ].
Sarebbe per tanto, oltre al Recinto s g Pi ( v v g i p i i s hi pi h
i V i v ig i p ) gi più s s O i …I gi si si p s v i i
proprio locale alle suddette Terre. Ma essendo state elleno renitenti a venirvi, nel 1316 si fé di nuovo il giro delle Mura:
si ifi i ggi s ….».
“T ” i i p i F hi s i s i i S. C Pi N v i Civi g ( ggi
Civitaretenga), Bominaco, Caporciano, Bussi e S. Pio (delle Camere), tutti appartenenti alla Diocesi Valvense e sotto la
“gi is izi spi i ” i M s i i S. i i .
R i i i i : la Porta di Bagno.
«… hisi is i s f ig i fi i […] pi i
Carlo Angioino, dopo di aver fatto costruire il fonte della Rivera, volle che di mura la città si
ricingesse, la quale fino a quel tempo non aveva avuti fossi e steccati: egli adunque incominciò
farne edificare le mura intorno al 1276 con quattro porte, e la città divise in quattro quartieri,
g i f s i i i T s ».10
Dice bene il Leosini « incominciò farne edificare », perché con molta probabilità le mura, nel
1315, non erano state ancora completate.
Si apre così la III fase della costruzione della cortina muraria, che rappresentò piuttosto un
completamento delle precedenti esperienze, che, lo ricordiamo, si estesero lungo gli anni 1229-
54/1259 e 1266/1272-73; «…i pi s ss mura fu invece posteriore al 1315 ed
avvenne quando era capitano Leone di Cassia che teneva questo ufficio verso la fine del 1316. »,
sì i i f i si i i s i i i i ip is izi h
doveva trovarsi nella porta di Lavareto (o di Barete), una delle porte più importanti della città, nella
vi i “TEMPORE EONE CICCI DE C SSI ”.
A. L. Antinori a proposito di questa III fase così scrisse: « Da qualche anno prima si erano fatti
preparamenti di fornaci da calce, e di altre provisioni di pietre, cementi e cose necessarie alla
fabbrica e condotte nei siti del giro. »11
Q s i f zi i i p s h s v h i z
cinta muraria sia avvenuta in maniera “p i i ” vv si i .
Ci sembra importante ricordare, a questo punto della nostra trattazione, che il territorio aquilano
rappresenta una delle zone più esposte al rischio sismico, visto che molti e, spesso, violentissimi
furono i terremoti che si abbatterono sulla città.12
Uno di questi fu, ad esempio, quello del 1315, e più tardi -nel 1349- si gis ò s ss
violentissima, che inflisse gravi danni alle strutture architettoniche e alle mura.
La stessa tipologia muraria della cinta presentava dei difetti intrinseci, poiché si sostanziava di un
larghissimo uso di pietre appena sbozzate di piccole dimensioni, e un uso, altrettanto cospicuo, di
10 A. LEOSINI, Monumenti storici artistici della città di Aquila e suoi contorni i 1848. incongruenza tra le
date della II fase di costruzione della cinta, quella riportata dal Leosini 1276 e quella da noi indicata che non va oltre il
1273 v s i pi s . p i hé h si f pi g i i 1272-73. Cfr. A. CLEMENTI
- E. PIRODDI, Le città nella storia d’Italia. L’Aquila i 1986. p v v ss i
Lavareto (o Barete), della Rivera, di Bazzano e di Paganica. 11 Desunto da A. CLEMENTI, Statuta Civitatis Aquile, Roma 1997, p. 183 nota 1. 12Scosse più o meno violente si registrarono nel 1315-1328-1349-1398-1456-1461-1498-1592-1646-1672-1703-
1706-1750-1762-1786-1789-1791-1803-1809-1848/49-1874-1887-1893-1895-1906-1915-1916-1926, citando
ovviamente soltanto quelle che inflissero danni rilevanti alla città. Cfr. C. MERLO, L’Aquila. Ricerche di geografia
urbana, Roma 1942.
R i i i i : la Porta di Bagno.
p s g i i i fi i h i i s i v s più g v ,
i p ss sp f gi s s z .13
Gli Statuti cittadini richiamano spesso la popolazione a prestare cura e attenzione alla
manutenzione delle mura14
, le quali, verosimilmente, avevano bisogno di non pochi interventi.
Oltre ai già ricordati terremoti del 1315 e del 1349, furono pure quelli del 1461-62 e quello del
1703 che contribuirono a mutare il volto della città
Si può ipotizzare, senza troppa immaginazione, che i segni di crolli e riempimenti che si possono
leggere sul percorso murario siano anche la risultante di questo o quel sisma.
Dalle fonti che abbiamo utilizzato si evince che nello svolgimento della funzione difensiva le
mura siano state coadiuvate da un ragguardevole –imprecisato– numero di torri di
fiancheggiamento.15
h p iò h ig izi s p i è p i i zz ; si i
i p zi pp s h g i ssi i è p i zz p. Riv p. i
Paganica e quella di Lavareto, ma è lecito presumere che siano state aperte porte secondarie per
facilitare i rapporti con il comitatus.
U p h i fi i “s i ” f i g 16
(o Vagno come qualche
commentatore di Buccio riporta), situata a S-SW e testimone di alcuni fatti di sangue.
Riproponiamo le fonti più prossime che abbiamo, cioè il più volte citato Buccio di Ranallo e
i i i p s p p i s p s f v VI
Antiquitates Italicae Medii Aevi di L. A. Muratori (da noi preso in visione presso la Biblioteca S.
Tommasi nella sede distaccata di Collemaggio), edito nel 1742 a Milano, circa la suddetta porta di
Bagno:
-Buccio di Ranallo, str. 431:17
«Dalla Porta di Bagno bisognò, che rentrasse;
13 Il cosiddetto diploma di Federico II, in realtà di Corrado IV, prevedeva che le mura fossero alte quasi undici metri.
Da ciò si deduce quale potesse essere la resistenza che avrebbero potuto offrire senza una costante manutenzione. Cfr.
la trascrizione e la relativa esegesi che si riporta in G. SPAGNESI - P. PROPERZI, L’Aquila. Problemi di forma e
storia della città, Bari 1972 14 A CLEMENTI, Statuta Civitatis Aquile ila 1977, in part. i capp. 272-273-274-275. 15 Secondo il Cirillo avrebbero dovuto essere oltre cento, in CIRILLO, Annali della città cit. i . II p. 18; i
i gh i i i ip i V. DE RTHO OM EIS Cronaca Rimata di Buccio di
Ranallo, Roma 1907, p. 55 note 5-8, parla di 114 torri; il beato Bernardino da Fossa, frate francescano, commentatore
h g i i i i V. DE RTHO OM EIS Cronaca Rimata cit., p. 55 note 5-8, parla di 86 torri.
Poteva inoltre avvenire che si aprissero delle porte in queste torri come è il caso, ad esempio, della porta di Bagno da
noi esaminata. 16 Costituisce il tratto di mura da noi preso in esame nello studio stratigrafico che seguirà questa introduzione storica. 17 In L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, Milano 1742, col 597.
R i i i i : la Porta di Bagno.
Non pottono far Bagnisci che lui scavalcasse,
che non gesse ad le sbarre prima che magnasse;
Volse la sua ventura che le sbarre spezzasse».
Questa citazione riguarda la contesa degli anni intorno al 1237, tra i Pretatti e i Camponeschi, due
famiglie aquilane in lotta per il controllo della città.
Sappiamo, quindi, che la porta era aperta e funzionale prima del terremoto del 1349.
-Buccio di Ranallo, str 530:18
«Tanto fecero et dissero pur, che li assecuraro,
Vennero li cavalli et loro cavalcaro,
Paricchii Poppletani con loro accompagnaro
Fino alla porta de Bagno, poi se retornaro».
-Buccio di Ranallo, str. 580:19
«Non se fidò la parte, non lu lassò reintrare;
Lui for delle mura si prese ad cavalcare,
Alla porta de Bagno credea retirare,
Como Misser Todino credea recuperare».
Entrambe le citazioni si riferiscono agli scontri tra Pretatti e Camponeschi intorno al 1341.
-Antonio di Buccio, str. 461:20
«A dine 19. de Novembru de Sabato ad ore tri de notte,
Onne omo jacea nel letto, e dormia ben forte,
E della Porta de Bagno rotte eran le porte;
Li nemici dentro stavano con loro genti accorte».
Ancora una volta la porta servì per entrare di forza nella città, sempre nella interminabile contesa
tra Pretatti e Camponeschi.
Questa volta sono i Pretatti a volere entrare, per riprendere il potere conquistato dai Camponeschi
s g i pp ggi R i N p i.
Si s 1378 i i zi if i p è i 37 i p i .
18 ibidem, col 609. 19 ibidem, col 616. 20 ibidem, col 768.
R i i i i : la Porta di Bagno.
Cosa è accaduto nel frattempo?
Probabilmente il terremoto del 1349 aveva provocato danni ingenti, e ancora:
-Antonio di Buccio, str. 495:21
«Anche vi foro morti dicove de capistru
A la porta de Bagnu, questo è manifestu
E la porta de calce remurata fatta fone,
Perché altra fiata ne venne tradisione».
E f s s pis i inte più forti che possiamo associare alla storia di questa porta.
Siamo ancora nel 1378 e evidentemente ai Pretatti non è riuscito il colpo di mano visto che
i i h “ i ss i ”.
La porta sarà murata, ma, probabilmente, verrà presto riaperta.22
La forte sperequazione esistente fra il numero delle volte in cui viene nominata la porta di Bagno
p i p i pp i i i si zi ss h i v s p “ si
i i” p s s i i i portanza che la porta stessa ebbe nel corso del Trecento.
Rip Riv i izz s p pi i i
p i g p i i s sf zi i i i
esaminato, consapevoli del fatto che le rappresentazioni cartografiche non potevano essere proprio
is i h i s iv s i i p ss s si i ss
senza il rigore scientifico che dovrebbe essere intrinseco a tale disciplina.23
La prima pianta che abbiamo è quella redatta dal Fonticulano intorno al 1575, che riportiamo
segnalando la porta di Bagno, ma senza poter dire se svolgesse effettivamente la propria funzione.
21 ibidem, col 772. 22 L. RIVERA, Le piante ed i prospetti della città dell’Aquila cit., II p. 112. 23 I s i “ if i” s p si i i per i tempi (XVI secolo). Meno comprensibili i metodi utilizzati sia
dalla Soprintendenza B. A. A. A. S. , sia da L. Martella (Le porte dell’Aquila: note e precisazioni sulle antiche
permanenze nella cinta fortificata cittadina, i 1978: i hi i s z s s s i . p
precisazioni), visto che i rilievi grafici e i prospetti non sono supportati dal benché minimo rigore scientifico, e speso
arrivano a stravolgere la realtà.
R i i i i : la Porta di Bagno.
1. Pianta del Funticulano del 1575 ca.
Nel 1581 venne realizzato ad opera del Danti (sulla scorta di una pianta del Fonticulano) un
ff s i P zzi V i i si vi h p p i g v iv
effettivamente utilizzata come accesso alla città, uso peraltro testimoniato dal fatto che la porta è
attraversata da una strada chiaramente rappresentata.
R i i i i : la Porta di Bagno.
Porta di Bagno
2. Affresco del Danti realizzato nel 1581 ca.
Nel corso del 1600 Giacomo Lauro incise, sempre sulla base di un disegno del Fonticulano, una
pi i h p s f i gi ff s V i .
La funzionalità della porta sembrerebbe documentata, ancora una volta, dal fatto che è attraversata
da una strada.
R. Colapietra ha affermato che le porte segnate dal Fonticulano e dal Danti sono da intendersi
p “ ssi h ” p ff iv p .24
24 R. COLAPIETRA, L’Aquila dell’Antinori. Strutture sociali ed urbane della città nel Sei e Settecento, in
“ i i ” II i 1978 p. 918.
R i i i i : la Porta di Bagno.
3. Pianta del Fonticulano incisa da Giovanni Lauro nel 1600
A distanza di circa venti anni, per mano di S. Antonelli e incisa da Giacomo Lauro, fu realizzata
v pi i v è ss i vi z p i g h gi i
is i h g fi h p zi presentate, sembrava essere funzionale.
S C pi p s g i s s i izz p i g ss i
città,25
fatta eccezione per la porta di Bagno verosimilmente considerata la più agevole per gli
scambi con la parte meridionale del comitatus.
25 R. COLAPIETRA,L’Aquila dell’Antinori cit., p. 918.
R i i i i : la Porta di Bagno.
4. Pi i 1622
T s i zz s i i pi i J 1680 h è ip zi
piuttosto fedele di quella del Fonticulano del 1600, prendiamo in considerazione la pianta più
scientificamente realizzata, cioè quella del bolognese Antonio Vandi del 1753.
Allegata con la carta del Contado e della Diocesi al volume di Carlo Franchi Difesa per la
fedelissima città dell’Aquila... pis p i i i p isione nella realizzazione , tanto che
Mario Centofanti ha provato a sovrapporla alla pianta catastale del 1983, ottenendone una perfetta
congruenza26
(vedi oltre).
26 M. CENTOFANTI, L’Aquila 1753-1983 il restauro della città i 1983.
Dati questi suggestivi riscontri, possiamo ritenere decisamente attendibile la pianta, attendibilità confermata dal fatto
che il Vandi non si limita a segnare le porte, ma ne specifica anche la funzionalità.
R i i i i : la Porta di Bagno.
I più s p è h p v g is i i “ hi s ” “ p ” p a di
Bagno è segnalata tra quelle che svolgevano appieno la propria funzione.
Più h ip izz i i hi s p p ( p 1338; hi s
nel 1378; aperta nel 1381;27
chiusa nel 1581 e ancora nel 1600; aperta nel 1622), riteniamo che la
p i sv f zi i ss i f zi p 1378 si vi
lo ricordiamo, dalla str. 495 della cronaca Delle cose dell’Aquila, e della venuta di Carlo di
Durazzo dal 1363 al 1382 di Antonio di Buccio.
5. Pianta del Vandi del 1753.
E s i s i i z “g fi ” i i p i p i g s i
abbiamo potuto contare per il nostro studio.
Il Leosini28
i i i f zi : « E i s i h s i s . XVIII
vi si f ss s i pi p p s i Chi s M g i
Angeli, la quale apertura fu chiusa quando, intorno al 1820, si fece la Porta di S. Ferdinando o Porta
Nuova, oggi detta di Napoli ».
27 Cfr. infra nota 22 p. 8. 28 In L. RIVERA, Le piante ed i prospetti della città dell’Aquila cit., II p. 112. Si veda anche L. MARTELLA-A. M.
MEDIN, Le porte dell’Aquila cit., p. 16.
R i i i i : la Porta di Bagno.
In effetti anche noi abbiamo potuto ascoltare da fonti orali che questa apertura fu lasciata per
s i ss hi s extra moenia della Madonna degli Angeli.
Parziale riproduzione della sovrapposizione della pianta del Vandi con la mappa catastale del
1983 compiuta da Mario Centofanti.
R i i i i : la Porta di Bagno.
ANALISI STRATIGRAFICA E INTERPRETAZIONE
La complessità stratigrafica della porta di Bagno ha determinato una difficile interpretazione e
iffi i UNIT STR TIGR FICHE MUR RIE.
Il compito non è risultato agevole per diversi e concomitanti motivi, come, ad esempio, il progetto
di restauro che nel 196929
fu condotto al termine che ha, di fatto, impedito una più chiara
individuazione delle USM a causa del largo impiego di cemento utilizzato per rinforzare la struttura
architettonica della torre.
Ventotto sono le USM che siamo stati in grado di individuare; cercheremo di trarne alcune
considerazioni con la realizzazione di un matrix e allegando le schede delle USM e i tre prospetti
della torre da noi realizzati.
Abbiamo considerato le USM 25; 1; 9; 18; 16 e 19 come la realizzazione originaria della porta cui
segue un crollo piuttosto vasto (USM 26; 2; 14 e 23).
29 L. MARTELLA – A. M. MEDIN, Le porte de L’Aquila: note e precisazioni sulle antiche permanenze nella cinta
fortificata cittadina, i 1978 p. 16.
R i i i i : la Porta di Bagno.
Alla ricostruzione (USM 27; 13; 15 e 24) segue un nuovo crollo (USM 20 e 21) che forse
i v s ( USM 8 22) h i p (USM 10 17) izz
probabilmente, nel lasso di tempo intercorso tra i due eventi.
Nello stesso lasso di tempo fu aperta, probabilmente, una porticina (USM 11 e 40) poi murata
(USM 12), su cui si appoggia il restauro del 1969 (USM 7; 5 e 6).
Da una fotografia 30
scattata intorno al 1978 apprendiamo che sulla parte destra (di chi guarda)
della torre si incardinava un cancello in ferro (USM 3 e 4) che delimitava una proprietà privata
(frutto piuttosto di una appropriazione) recentemente riconsegnata al demanio.
E iffi i i i i i f si i s zi ndole
cronologicamente, nonostante ciò alcuni limiti possono essere posti:
1. Al tempo intercorso tra il 1229-54/59 e il 1315 si deve la realizzazione della porta.
2. Nel 1378 fu murata (come abbiamo appreso da Antonio di Buccio), ma non abbiamo
elementi certi per associare le parole di Antonio a qualche USM.
3. Nel 1381 fu ripristinato il passaggio (ancora Antonio di Buccio)
4. Fu murata nel 1820 dopo la realizzazione della porta di Napoli.
5. Nel 1969 venne intrapreso e portato a termine un restauro.
30 ibidem