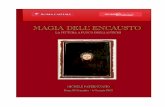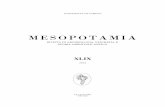PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA. DODICESIMO INCONTRO DI STUDI.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA. DODICESIMO INCONTRO DI STUDI.
CENTRO STUDI DI PREISTORIA E ARCHEOLOGIA – Onlus
Milano
COMUNE DI VALENTANO
COMUNE DI PITIGLIANO
COMUNE DI MANCIANO
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA
DODICESIMO INCONTRO DI STUDI
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli DeiGli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
Ricerche e scavi
Valentano (VT) – 12 Settembre 2014Pitigliano (GR) – 13 Settembre 2014Manciano (GR) – 14 Settembre 2014
C.S.P. Onlus
Centro Studi di Preistoria e Archeologia
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA DODICESIMO INCONTRO DI STUDI
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
Ricerche e scavi
Valentano (VT) – 12 Settembre 2014 Pitigliano (GR) – 13 Settembre 2014 - Manciano (GR) – 14 Settembre 2014
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 2
Enti promotori Centro Studi di Preistoria e Archeologia Milano Comune di Pitigliano
Comune di Valentano - Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese Comune di Manciano - Museo della Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora
Patrocinio di Università degli Studi di Milano Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Regione Toscana Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale Provincia di Grosseto e Assessorato alla Cultura Musei di Maremma Provincia di Viterbo e Assessorato alla Cultura Sistema Museale del Lago di Bolsena Fondazione Carivit di Viterbo Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano La cometa. Cooperativa sociale onlus Pitigliano
Contributi di Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano
Comuni di Valentano, Pitigliano, Manciano Fondazione Carivit Viterbo Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano La cometa. Cooperativa sociale onlus Pitigliano
Direzione scientifica Nuccia Negroni Catacchio Comitato scientifico Massimo Cardosa, Laura Guidetti, Fabio Rossi Segreteria Christian Metta, Giulia Pasquini
Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano Viale Lazio 26 - 20135 Milano [email protected], www.preistoriacsp.it
Contatti [email protected], [email protected], [email protected] Christian Metta 3316643097; Giulia Pasquini 3402727323
C.S.P. ONLUS Centro Studi di Preistoria e Archeologia
Viale Lazio, 26 - 20135 Milano Tel. 02.72023607 FAX 02.89015971
[email protected] - [email protected] www.preistoriacsp.it
Fascicolo stampato con il contributo del Centro Residenziale Le Prata di Pitigliano
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 3
INFORMAZIONI. La quota di iscrizione all’Incontro di Studi è di € 40 a persona per ciascun relatore e per il personale strutturato e di 20 per gli studenti e i non strutturati, da versare alla segreteria al momento del Convegno e dà diritto al prétirage, a uno sconto sugli Atti e sulle pubblicazioni del Centro Studi, ai pranzi di venerdì, sabato e domenica, all’ingresso gratuito ai Musei di Valentano, Pitigliano, Manciano e alla mostra Principi immortali. Fasti dell’aristocrazia etrusca a Vulci, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Vulci. Per le informazioni relative agli alberghi e ai mezzi di trasporto: Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, Valentano Tel. / fax: 0761.420018, e-mail: [email protected] Ufficio Informazioni Turistiche, Pitigliano Tel. / fax: 0564.617111, e-mail: [email protected] Manciano: Ufficio Turistico e Museo Preistoria Tel. 0564/620532, [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 4
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 5
C.S.P. – Onlus Centro Studi di Preistoria e Archeologia
RIASSUNTI
COMUNICAZIONI E RELAZIONI
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 6
Venerdì 12 settembre 2014
VALENTANO – MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E DELLA ROCCA FARNESE – SALA
CONFERENZE
ORE 9.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ FRANCESCO PACCHIARELLI, SINDACO DI VALENTANO ALFONSINA RUSSO, SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL’ETRURIA MERIDIONALE MARIA BERNABÒ BREA, PRESIDENTE ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA PAOLA PASCUCCI, RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LAZIO MARIO BRUTTI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARIVIT
Ore 10.30 Inizio dei lavori
PRIMA SEZIONE ORNARSI PER COMUNICARE CON GLI UOMINI E CON GLI DEI
Nuccia Negroni Catacchio* Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli dei. Sul filo dell'ambra...
Vengono presi in esame alcuni significati che gli oggetti di ornamento possono assumere nei vari momenti della Pre e Protostoria. Per indagare meglio il problema, viene usata come filo conduttore l’ambra, una sostanza dalle molteplici valenze utilizzata dal Mesolitico e fino ai giorni nostri per produrre gioielli di grande pregio o singoli oggetti con valore simbolico. Si prede in esame innanzi tutto la sostanza in sé, di origine divina e legata al culto solare, con proprietà terapeutiche e apotropaiche e, come tutti gli exotica, testimone dell’appartenenza ad un elevato stato sociale. I singoli oggetti poi, uniscono al valore della materia, quello specifico della raffigurazione, sia essa simbolica o figurativa. Così sul filo dell’ambra è possibile costruire ipotesi anche sui valori e i significati di altre sostanze e rappresentazioni.
* Università degli Studi di Milano e Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano; e-mail: [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 7
DAL PALEOLITICO ALL’ETÀ DEL RAME
Paola Gnesutta Ucelli*
Gioielli dall'Età Glaciale. Ornamenti personali dei cacciatori paleolitici dalla Grotta di Le Settecannelle.
Gli oggetti di ornamento, rinvenuti nella Grotta delle Settecannelle, canini di cervo perforati, conchiglie forate e colorate con ocra, un pendente in osso di uccello e pendagli di steatite decorati, provengono dai livelli dell’Epigravettiano finale, che hanno restituito anche altri manufatti artistici in pietra e in osso. I pendagli in steatite, per il loro numero e per la raffinatezza dell’esecuzione, sono indicativi di un alto sviluppo culturale e di una fiorente condizione economica, generata dalla attività di caccia. La tipologia degli ornamenti non trova stretti confronti nelle culture coeve del Mediterraneo e dell’Europa occidentale, ma piuttosto in alcune manifestazioni del Gravettiano dell’Europa Orientale. Nonostante la maggiore antichità di questi reperti e la distanza geografica, rispetto a quelli di Settecannelle, si può supporre che la somiglianza morfologica corrisponda ad un analogo contenuto simbolico e spirituale che, in ogni cultura, subisce una più lenta trasformazione, rispetto alle invenzioni della tecnica. * Università di Pisa - [email protected]
Marta Colombo*, Renata Grifoni Cremonesi**, Marco Serradimigni*** Continuità e cambiamenti: evoluzione di corredi e ornamenti dal Paleolitico superiore
all'inizio delle Età dei Metalli in Italia. Utilizzando il sito di Grotta Continenza (Trasacco-AQ) come sequenza-base, la relazione ha come obiettivo l’analisi dell’evoluzione degli elementi di ornamento e di “accompagnamento” dei defunti (parure e corredo) a partire dalla fine del Paleolitico superiore fino ad arrivare al Neolitico e all'inizio dell'età dei metalli. I singoli elementi, dalle conchiglie ai canini atrofici di cervo, presentano significative variazioni a seconda della differente fase crono-culturale esaminata e permettono di stabilire la persistenza di determinate tradizioni culturali e la scomparsa di altre. La sequenza completa, Epigravettiano finale-Mesolitico (Sauveterriano e Castelnoviano)-Neolitico antico, individuata a Grotta Continenza, si pone come base per il confronto con altri contesti chiave sul resto del nostro territorio, in modo tale da rendere un quadro esaustivo, seppure preliminare, dell’evoluzione culturale/cultuale e degli scambi, sia di idee che di materiali, in un periodo chiave della Preistoria recente come il passaggio Pleistocene-Olocene. * [email protected] ** Università di Pisa - [email protected] *** [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 8
Andrea Pessina* Gli oggetti di ornamento nel Neolitico italiano.
La relazione tratteggia un quadro generale sulle conoscenze in merito agli oggetti di ornamento in uso durante il Neolitico in Italia, anche alla luce di una serie di recenti contributi che hanno permesso di acquisire nuovi dati sulle materie prime utilizzate – materiali litici ma anche corallo e conchiglia - e sulle tecniche di produzione di alcune tipologie di oggetti. All’interno di un quadro che vede gli oggetti di ornamento relativamente poco frequenti durante il Neolitico, soprattutto rispetto ad altri periodi della Preistoria italiana, emerge l’importanza di alcune classi di oggetti, quali i bracciali in pietra levigata o conchiglia, e le collane, ma non mancano rare raffigurazioni di copricapi e acconciature. La già citata relativa scarsità di ornamenti rispetto ad altri periodi parrebbe in alcuni casi giustificata dal fatto che l’espressione di status symbol da parte delle popolazioni neolitiche italiane sembra essere stata affidata ad oggetti che venivano “portati con sé” in certe occasioni – quali ad esempio le asce da parata in pietra verde – piuttosto che ad elementi portati sul proprio corpo. La diversità della situazione italiana durante il Neolitico emerge in maniera ancor più evidente dal confronto con altre realtà neolitiche europee con le quali i gruppi italiani ebbero frequenti contatti, in alcuni casi testimoniati proprio dagli oggetti di ornamento. * Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - [email protected]
Maria Bernabò Brea* Uso e significato dei monili nel V millennio a.C. in base ai dati dalle sepolture VBQ in Emilia. Il rinvenimento di circa 250 sepolture pertinenti alla cultura VBQ nel territorio tra piacentino e reggiano ha fornito, negli ultimi anni, un campione significativo per indagare i rituali e le usanze funerarie del V millennio a.C. in area padana. In particolare, grazie alle sistematiche determinazioni di sesso e di età effettuate da Loretana Salvadei, si è osservato che nelle tombe maschili, femminili e infantili dei due sessi si rinvengono oggetti di tipi diversi, che sembrano riflettere l’esibizione dei ruoli sociali e del rango dei defunti, soprattutto nelle sepolture della fase matura, databile nella seconda metà del V millennio a.C. In questo quadro, che nelle linee generali pare ampliabile all’intero areale della cultura VBQ, rientra bene anche l’utilizzo dei monili, nei quali è evidentemente sottesa una serie di significati diversi, solo in parte intuibili. Ma oltre a questo, i monili sembrano anche offrire un'ulteriore chiave interpretativa: essi costituiscono infatti l’elemento che maggiormente riflette l’esistenza di differenziazioni regionali, finora poco evidenziate all’interno del mondo VBQ, del quale si tende spesso a sottolineare piuttosto l’omogeneità. I monili sarebbero quindi una delle più evidenti espressioni sia delle differenze all’interno della comunità, sia delle differenze tra una comunità e l’altra, leggibili attraverso la varietà delle forme, dei materiali usati e del loro uso prevalentemente femminile oppure anche maschile. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna -Museo Archeologico Nazionale di Parma - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione 9
Rocco Sanseverino*
Ornamenti e oggetti personali da contesti neolitici della puglia centro-settentrionale.
Con il progressivo affermarsi della nuova economia e, della raggiunta stabilità sul territorio, si instaura un nuovo tipo di rapporto tra le popolazioni di agricoltori-allevatori e l’essere divino, quasi sempre rappresentato da connotati femminili (Dea Madre). In questa ottica potrebbero essere ricondotte a quest’ambito, alcune tipologie di materiali che sembrano inserirsi nel rapporto tra la sfera utilitaristica e la dimensione spirituale, specialmente in particolari contesti quali quelli rituali tout court. La forte valenza rituale di certi “oggetti”, infatti, risponderebbe alla necessità di intermediazione, anche a scopo apotropaico, sia durante la vita (come oggetti di ornamento) sia al momento del trapasso. In questo lavoro sono presi in esame alcuni oggetti di ornamento personale, pressoché inediti, provenienti da contesti neolitici della Puglia centro-settentrionale. * Preistoria e Protostoria europea, Scuola di Specializzazione Beni Archeologici Università di Bari - [email protected]
Paola Aurino*, Viviana.G. Mancusi** Valore d’uso e valore d’ornamento. L’ostentazione dello status nell’Italia neolitica ed
eneolitica attraverso l’utilizzo delle asce pendenti.
Tra le ultime fasi del Neolitico antico e l’inizio del Neolitico medio, soprattutto con la comparsa di orizzonti come quello delle Bande Rosse in Italia meridionale e poi con quello di Catignano in Italia centrale, le asce polite iniziano ad essere utilizzate anche come pendenti perdendo un preciso valore d’uso e acquistando un valore d’ornamento dove il bene in questione diventa veicolo di precisi codici simbolici, trasformandosi in un oggetto indessicale e di uso rituale. Per questi manufatti vengono scelte le rocce migliori, esotiche, difficili da reperire, materie prime che ricoprivano un ruolo fondamentale all’interno dei circuiti di scambio neolitici mediterranei. Il contributo che si presenta in questa sede si propone di delineare la funzione delle asce pendenti con foro ed accenno di foro prendendo in considerazione sia contesti dell’Italia peninsulare ed insulare, dove diventano beni rituali deposti in grotte e tombe, sia in ambito maltese dove in importanti contesti sepolcrali come Hal Saflieni e Xaghra sembrano accompagnare, più che i defunti, gli idoletti votivi insieme deposti. * Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie - [email protected] ** [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
10
Ilze Biruta Loze*
Amber ornaments and its symbolic meaning in Neolithic settlements of Latvia.
This paper analyze the symbolic meaning of some amber ornaments from the Late Neolithic settlements placed in the wetland of Lake Lubans. I will pay particular attention to four amber pendants from a child grave in the Abora settlement, which represent two different figures, the grass snake realistically represented and the mythical two-headed small grass snake. Two female mother breast-shaped pendants belong also to this grave complex. the other one unique pendant from the same region (Asne settlement) looks like a three-dimensional representation of a breast or a vulva, which symbolizes regeneration. * Institute of History of Latvia - [email protected]
Daniela Cocchi* Gli oggetti di ornamento dell’età del rame dell’Italia settentrionale.
Ben documentati risultano gli oggetti di ornamento nei contesti eneolitici dell’Italia settentrionale, soprattutto nelle sepolture ma anche, più raramente, negli abitati. In alcuni casi si può identificare il loro uso e, conseguentemente, i comportamenti delle comunità che avevano adottato il rituale delle sepolture individuali o collettive, per la cui individuazione estremamente significative sono le correlazioni con gli oggetti raffigurati sulle statue-stele. Ampiamente diffusi sono i vaghi di collana talora rinvenuti al collo degli inumati non solo nelle sepolture singole ma anche in quelle collettive; tali evidenze pongono in discussione l’interpretazione di offerte data alle collane delle sepolture collettive, dove potevano essere inizialmente messe al collo degli inumati ed essere poi coinvolte, insieme agli altri elementi dei corredi, nelle pratiche di manipolazione delle ossa. Nell’insieme degli ornamenti si possono rilevare variazioni nelle materie prime e nella tipologia, mentre assumono un uguale significato nelle inumazioni primarie in cui si associano alle armi per evidenziare il prestigio dei guerrieri o, più raramente, il ruolo sociale anche di alcune donne, trovando una piena corrispondenza nelle statue-stele. Nell’articolato rituale delle sepolture collettive vengono poi ad assolvere a una funzione di offerte per venerare il mondo degli antenati al fine di consolidare la coesione tra i viventi indispensabile nel rinnovato contesto socio-economico. * Università degli Studi di Verona - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
11
Nuccia Negroni Catacchio*, Matteo Aspesi**
Gli oggetti di ornamento dell’età del rame dell’Italia centrale.
In questo intervento si è deciso di considerare gli elementi ornamentali o gli oggetti preziosi presenti nelle sepolture dell’Italia centrale durante il periodo eneolitico. Spesso questi elementi sono stati oggetto di studio marginale, soprattutto negli anni passati, rilevandone la loro importanza solo come elemento che indica lo status sociale o il sesso del defunto e raramente come indicatore archeologico. Questa classe di materiale non è mai stata considerata unitariamente come è stato fatto per la ceramica o per i reperti metallici, pertanto è sembrato opportuno considerare i gioielli e gli oggetti di ornamento come unica categoria e di considerarli come indicatori archeologici di pari dignità rispetto alla ceramica o ai metalli. Dopo aver individuato la loro distribuzione nel territorio in esame, si è cercato di capire le relazioni che intercorrono tra questi oggetti valutandoli, ad esempio, come possibili indicatori di scambio o di contatto tra popolazioni, anche lontane tra loro, che si esprimevano con usi funerari differenti. Il passo successivo è quello di tentare di comprendere quale significato veniva attribuito a questi oggetti, che talvolta accompagnavano il defunto. La prima distinzione che si tende a fare, quando ci si trova di fronte ad elementi di corredo che possono essere definiti personali, riguarda il sesso del defunto, ma forse è una visione riduttiva. In un momento in cui il culto dei defunti e probabilmente degli antenati occupa un ruolo fondamentale nella società, gioielli e oggetti preziosi, potrebbero rivestire un ruolo di primo piano nell’espressione della “pietas” da parte dei vivi verso i morti; o ancora, questi elementi potrebbero simboleggiare la particolare importanza che un defunto doveva avere in vita. * Università degli Studi di Milano e Centro Studi di preistoria e Archeologia, Milano - [email protected] ** Centro Studi di preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
Patrizia Petitti*, Carlo Persiani**, Anna Maria Conti*** Agghindati per l'ultima cerimonia. I monili rinaldoniani di Selvicciola.
Vengono presentati in maniera organica i ritrovamenti di oggetti di ornamento personale delle sepolture di Selvicciola di cui si è data notizia separatamente in precedenti convegni. Con la lavorazione della pietra, osso, conchiglia e la metallurgia è stata prodotta una varietà di monili, che attraversano tutta la durata di utilizzo della necropoli. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale - [email protected] ** Sovraintendenza ai Beni Culturali, Comune di Roma *** Società Cooperativa Arx
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
12
Paola Aurino* Gli oggetti d’ornamento nelle necropoli del Gaudo tra funzione e diffusione.
Gli oggetti d’ornamento all’interno delle ricche necropoli del Gaudo rappresentano una produzione fortemente selettiva e destinata a pochissime tombe. Si tratta di manufatti realizzati in osso o su valva di conchiglia appartenenti a poche tipologie, come le placchette forate, i pendagli e gli spilloni. L’analisi della loro attestazione all’interno e all’esterno dei contesti campani permette di seguire le direttrici di circolazione di questa produzione, che si configura indubbiamente come frutto di attività caratterizzate da un notevole livello di specializzazione, di osservare le modalità di diffusione all’interno delle necropoli del Gaudo e di ipotizzare la funzione assunta dalle diverse tipologie di oggetti nei contesti tombali in cui sono stati rinvenuti. * Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie - [email protected]
Monica Miari* Gli oggetti di ornamento in Romagna tra Eneolitico ed età del bronzo quali indicatori di
identità e scambio.
Lo studio degli oggetti di ornamento può fornire un punto di vista privilegiato per l'approfondimento delle tematiche relative alla rappresentazione di status, rango e identità culturale nelle società antiche. Per il territorio della Romagna si comincia oggi, soprattutto per le età dei metalli, a disporre di una certa quantità di dati la cui analisi, sia contestuale che diacronica, offre alcuni interessanti spunti di approfondimento. Durante l'età del rame e fino alla fase iniziale del Bronzo Antico (cd. facies della Tanaccia) gli oggetti di ornamento sono attestati in tre differenti contesti: abitati, sepolture in grotta e necropoli. Il confronto tra la ricorrenza delle diverse tipologie dei manufatti nei singoli siti mostra evidenti disparità. Infatti, mentre nelle necropoli ricorrono quasi esclusivamente oggetti di pregio, di provenienza non locale e in materiali preziosi, quali argento e ambra, nelle sepolture in grotta prevalgono ornamenti litici e in conchiglia, la cui provenienza locale è confermata dall'attestazione di produzioni in abitato. Nelle fasi successive del Bronzo Antico e con il Bronzo Medio prosegue nei villaggi la produzione di oggetti in pietra e conchiglia di tradizione locale, ma si osserva la comparsa di ornamenti in bronzo che rispecchiano le tipologie comunemente diffuse in Italia settentrionale. Questo fenomeno si accentua tra Bronzo Medio 3 e Bronzo Recente quando, in un contesto culturale fortemente legato al mondo peninsulare, tra gli ornamenti in metallo e materia dura animale prevalgono tipologie strettamente afferenti al mondo terramaricolo, che vengono talora imitate con produzioni in loco. Da chiarire, infine, il ruolo dell'ambra, sporadicamente presente nelle fasi avanzate dell'età del bronzo anche in Romagna, ma con tipologie per lo più generiche per le quali non è facile individuare itinerari prevalenti di diffusione. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
13
Sabato 13 settembre 2014 PITIGLIANO - TEATRO SALVINI
ORE 9.30 SALUTO DELLA AUTORITÀ PIER LUIGI CAMILLI, SINDACO DI PITIGLIANO MELANIA RENAIOLI, ASSESSORE ALLA CULTURA DI PITIGLIANO ANDREA PESSINA, SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA CINZIA TACCONI, ASSESSORE ALLA CULTURA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO LUIGI GIUSTI, PRESIDENTE CENTRO RESIDENZIALE LE PRATA DI PITIGLIANO STEFANO CONTI, PRESIDENTE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PITIGLIANO Ore 10.30 Inizio dei lavori
L’ETÀ DE BRONZO
Christian Metta*, Giulia Pasquini* Gli oggetti ornamentali in grotte della Maremma tosco-laziale durante le prime fasi dell'età
del bronzo, nel quadro dell'Italia centrale: tipologia e significati.
Durante le prime fasi dell'età del bronzo, all'interno di grotte e cavità naturali o rinvenuti in ambito abitativo e sepolcrale dell'area tosco-laziale, si segnalano numerosi oggetti ornamentali di diversa tipologia. Sono attestati ritrovamenti di perline in pasta vitrea, in pietra e in osso, vaghi di collana in ambra, oggetti in materia dura animale e in bronzo. Questi oggetti rappresentano indicatori di prestigio sociale all'interno delle popolazioni protostoriche e forniscono alcuni dati sui contatti interregionali e sulle materie prime utilizzate. Con l'analisi tipologica dei diversi oggetti si cercherà, in base al contesto di rinvenimento, di ipotizzare quali fattori hanno spinto all'utilizzo di tali forme ornamentali all'interno delle società protostoriche della Maremma tosco-laziale nel quadro dell'Italia centrale. * Centro studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]; [email protected]
Tomaso Di Fraia* Fuseruole o vaghi? Riesame critico di una problematica ricorrente.
L’interpretazione di quegli oggetti in ceramica che tradizionalmente e prevalentemente sono stati considerati fuseruole, cioè accessori per la filatura, è stata più volte messa in discussione da alcuni archeologi, che hanno avanzato dubbi e osservazioni critiche, proponendo interpretazioni alternative, soprattutto per esemplari della tarda età del bronzo e dell’età del ferro, esemplari spesso dotati di una certa eleganza. L’obiezione più frequente, specialmente per gli esemplari di piccole dimensioni, è che potesse trattarsi di vaghi per collane o altri monili. Altre possibili funzioni sono
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
14
state prese in considerazione, anche alla luce di alcuni documenti iconografici. In questo contributo mi propongo di esaminare gli argomenti usati da ambedue gli schieramenti e di vagliarne l’attendibilità, sia sul piano teorico che sulla base della documentazione archeologica e anche sulla scorta di alcune sperimentazioni relative alla filatura con fuseruole di pesi diversi. Purtroppo, nonostante alcuni progressi, gli studi su tale categoria di manufatti sono ancora scarsi e la documentazione non sempre è esauriente; inoltre non sono state condotte analisi traceologiche sistematiche su complessi significativi, soprattutto al fine di identificare le tracce di usura in corrispondenza del foro. Pur con queste limitazioni, soprattutto l’esame delle caratteristiche strutturali e funzionali (forma, dimensioni, peso, diametro del foro, momento di inerzia) e dei contesti di ritrovamento, nonché il confronto con vaghi e altri monili sicuramente riconosciuti come tali, consentono, a mio giudizio, di formulare una risposta soddisfacente.
* Università di Pisa - [email protected]
Sara De Angelis*, Maja Gori** I pendagli a ruota raggiata.
“Glocalizzazione” di simbologie e funzioni nella tarda età del bronzo.
L’intervento si propone di analizzare i pendagli che presentano un’iconografia riconducibile al motivo della ruota raggiata attestati in Italia, con una particolare attenzione all’area medio tirrenica e adriatica, inserendo la penisola italica in un più ampio contesto geografico e culturale che va dall’Europa centrale alla penisola Balcanica e all’Egeo (De Angelis–Francozzi–Gori 2007). Questa classe di pendagli conosce un’ampia diffusione in ambito europeo durante la tarda età del bronzo, testimoniando come comunità anche lontane e spesso non in contatto diretto tra di loro, potessero condividere uno stesso linguaggio simbolico. Dall’altro lato però questo “linguaggio globale” coesiste con le molteplici espressioni simboliche proprie di ogni singola facies archeologica, influenzandole e venendone a sua volta influenzato. I pendagli a ruota raggiata, quindi, a seconda dei diversi contesti d’uso e delle diverse aree geografico-culturali sono veicolo di un linguaggio simbolico locale, che reinterpreta e convive con quello globale, in un processo di “glocalizzazione”. Con il termine glocalizzazione (Bauman 1998) si intende il continuo processo di combinazione del locale con il globale, dove aspetti materiali e non materiali di provenienza allogena vengono reinterpretati e mischiati con elementi locali per formare nuove sintesi (Maran 2011). L’analisi presentata in questo intervento si propone, partendo dallo studio dei pendagli a ruota raggiata provenienti da diversi contesti italiani e europei, di illustrare la pluralità di significati che questi oggetti acquistano e perdono nel corso della propria “vita sociale” (Appadurai 1996), “muovendosi” o venendo replicati in aree culturali molto diverse fra loro (Hahn-Weiss 2013). * Archeologo - [email protected] ** Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie, Heidelberg - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
15
Massimo Cardosa* Cercando la collana di Armonia. Oggetti ornamentali della tarda età del bronzo in Etruria
meridionale.
Primordiale artigiano creatore di ornamenti, nel mito, è lo stesso Efesto: il dio, ospite della ninfa marina Teti, dopo che era stato scaraventato giù dall’Olimpo, crea per la sua ospite gioielli di grande bellezza, “fibbie, fermagli ricurvi, a spirale, orecchini, collane”, talmente belli da suscitare l’interesse delle altre dee e soprattutto di Hera che, scoperto chi era l’artefice degli splendidi ornamenti, ottiene che sia riammesso sull’Olimpo. Nella mentalità primitiva chi è capace di creare oggetti è anche mago, quindi, come molti degli oggetti da lui creati, anche gli ornamenti realizzati da Efesto hanno proprietà magiche: la Collana di Armonia per esempio, probabilmente il più famoso, magica ma anche maledetta, donava la bellezza a chiunque la indossasse. Si passano quindi in rassegna i rinvenimenti in Etruria Meridionale di oggetti ornamentali databili alla tarda età del bronzo (soprattutto vaghi di collana e pendenti), facendo particolare attenzione ai contesti di rinvenimento, cercando di metterne in rilievo il possibile significato magico-rituale di cui, nella chiave interpretativa che ci è tramandata dal mito, potrebbero essere stati portatori. * Accademia delle Belle Arti di Brera e Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
Francesco di Gennaro*, Marco Romeo Pitone** Osservazioni sulle fibule protostoriche.
La fibula, uno strumento ma allo stesso tempo un ornamento, nella protostoria italiana è non solo largamente attestata ma considerata dagli studiosi un determinante indicatore cronologico. Come altri manufatti anche le fibule, già a partire dai primi modelli, vengono arricchite con decorazioni legate in parte alla sfera simbolica del divino. Il contributo si sofferma, nell’ambito di questa importante categoria, su alcuni esempi che possono aiutare a comprendere sia taluni caratteri funzionali tecnologico-formali, sia significati trascendenti lo stretto ambito di utilità del dispositivo-fibula. * Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini, Roma e Museo Nazionale di Arte Orientale G. Tucci, Roma - [email protected] ** Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano; Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates, Blera - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
16
Maria Cristina De Angelis*, Rita Paola Guerzoni**, Laura Matacchioni*** Ornamenti appuntati sulle vesti: gli spilloni e le fibule in contesti funerari e
cultuali di BF-Fe 1. Alcune notazioni sulla valenza simbolica.
L’argomento del contributo riguarda particolarmente la valenza che può essere stata riferita a tali ornamenti nell’ambito della sfera ideologica-sociale e religiosa-sacrale, come può essere ipotizzata sulla base di un’articolata analisi formale, con riguardo ai particolari strutturali, e contestuale. Si presentano alcune esemplificazioni o casi-studio riguardanti le testimonianze da note necropoli del versante medio-tirrenico e, inoltre, da luoghi cultuali su altura dominante con specifico riferimento ad ambiti umbri. Per quanto concerne le fibule si tiene conto, oltre che della forma (ad arco o serpeggiante), anche del numero degli esemplari presenti nei corredi funerari analizzati, potendosi trattare di ornamenti con più valenze legate alla sfera ideologica-sacrale e socio-economica. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria; e-mail: [email protected] ** Università degli Studi di Perugia - [email protected] *** Università degli Studi di Perugia - [email protected]
Angelo Amoroso*, Francesco di Gennaro** Indicatori di status nelle comunità del Latium Vetus nel Bronzo Finale e nella prima età del
ferro. Alcune riflessioni.
La presenza di particolari oggetti, miniaturizzati e non, in alcuni dei corredi delle tombe a cremazione rinvenute nella regione in esame, consente di ipotizzare elementi di differenziazione di status e di ruolo nelle comunità laziali del Bronzo Finale e del Primo Ferro. Altri peculiari oggetti presenti nelle sepolture dell’orizzonte avanzato della prima età del ferro, contribuiscono a testimoniare le differenziazioni sempre più marcate interne alle compagini sociali delle comunità protourbane del Latium Vetus. Nei corredi funerari dei primi momenti dell’età storica la disponibilità di oggetti ornamentali di prestigio si fa ostentazione del ruolo e del rango sociale ricoperto da alcuni individui, con particolare riferimento alla sfera del sacro. * [email protected] ** Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini, Roma e Museo Nazionale di Arte Orientale G. Tucci, Roma [email protected]
Franco Marzatico* Gli ornamenti come codici di comunicazione nella Protostoria Alpina.
A distanza di quasi venti anni dall'esposizione dedicata agli oggetti d'ornamento intitolata "Ori delle Alpi", nuovi ritrovamenti permettono di aggiornare il quadro delle conoscenze. Il contributo si propone in questo senso di definire, nei limiti della documentazione disponibile che risulta molto discontinua e con un numero limitato di contesti tombali, aspetti del costume e della
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
17
moda fra l'età del bronzo e la seconda età del ferro nell'area alpina gravitante sul bacino dell'Adige. * Dipartimento Cultura Provincia Autonoma di Trento - [email protected]
Gaia Pignocchi*
Dal cielo all’acqua alla terra. Simbologia e appartenenza degli oggetti di ornamento dell’età del bronzo nelle Marche.
In questo contributo vengono presentati gli oggetti di ornamento dell’età del bronzo da contesti abitativi, funerari e cultuali delle Marche, significativi sia per tipologia e materiali usati sia per taluni elementi iconografici, che saranno analizzati non solo dal punto di vista simbolico ma anche per l’aspetto rappresentativo di genere e ruolo. Essi saranno considerati anche in relazione a rinvenimenti di oggetti simili in altri contesti peninsulari. Alcuni di questi oggetti, nei quali compaiono motivi e schemi decorativi e figurativi riferibili ad aspetti simbolici ed ideologici, implicano una particolare funzione votiva, rituale, religiosa o funeraria in relazione al contesto di rinvenimento e all’aspetto morfologico-funzionale, travalicando la sfera prettamente materiale e terrena per rivolgersi ad un livello trascendente. Altri oggetti potevano rappresentare simboli di prestigio individuale ed indicatori di rango, ma anche di genere e di ruoli in funzione della tipologia dell’oggetto e soprattutto della qualità e pregevolezza del materiale utilizzato e quindi essere rivelatori di una struttura sociale relativamente articolata. Particolari ornamenti, peculiari di genere e ruolo, possono essere, oltre agli oggetti in bronzo, anche quelli realizzati con materiali non comuni (ambra, pasta vitrea, materia dura animale, reperti malacologici) per i quali sono inoltre ipotizzabili specifiche finalità tutelari. * [email protected]
Alberto Cazzella*, Giulia Recchia** Testimonianze di elementi di ornamento dall’abitato dell’età del bronzo di Coppa Nevigata.
I contesti che in genere forniscono maggiori quantità di reperti che possono rientrare nella categoria degli ornamenti sono, ovviamente, le necropoli. Nel caso dell’abitato di Coppa Nevigata, tuttavia, la documentazione è sufficientemente significativa: alcuni elementi che rientrano nella categoria presa in considerazione provengono ugualmente da contesti funerari, riferibili all’Appenninico Antico (XV secolo a.C.), che nel caso del sito in esame, in modo alquanto anomalo nell’ambito dell’età del bronzo almeno per quel che riguarda l’Italia centro-meridionale, sono stati rinvenuti all’interno dell’area dell’insediamento; altri provengono prevalentemente dai livelli del Bronzo Recente. Anche questo secondo fenomeno appare problematico, in quanto non sembrano essersi verificati in tale periodo estesi fenomeni di distruzione improvvisa. Ci si chiede, quindi, per quale motivo elementi che potevano essere riutilizzati (a cominciare da quelli in metallo, ma anche vaghi in ambra o in cristallo di rocca e “teste di spilloni” in osso in buono stato) furono abbandonati senza la volontà di recuperarli. Il caso più interessante è rappresentato da una serie di borchiette in metallo con appiccagnolo, probabilmente applicate su un supporto in tela o in pelle, rinvenute in ordine,
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
18
come se l’intero elemento fosse stato lasciato dove era stato deposto. * Università "La Sapienza" di Roma - [email protected] ** Università di Foggia - [email protected]
Anna Maria Tunzi* Tempo della dea. Gli oggetti di ornamento negli ipogei del sud-est italiano.
Ornarsi per l'aldilà era particolarmente importante per le centinaia di defunti sepolti nell'arco di più generazioni negli ipogei della media età del bronzo di Trinitapoli. In queste imponenti strutture artificiali, nate come veri e propri templi sotterranei nel Tavoliere di 1800 anni circa prima della nascita di Cristo, si invocava il favore della divinità della fertilità. La conversione ad uso funerario degli ipogei di culto avvenne qualche tempo dopo il loro abbandono e relativa chiusura, allorquando soprattutto le strutture più grandi servirono al seppellimento di numerosi individui, maschi e femmine di ogni fascia di età. bronzo, ambra, pasta vitrea, faïence, avorio e materia dura animale sono i materiali pregiati con cui vennero realizzati i monili e i gioielli per l'eternità, circa tremila oggetti di corredo, molti dei quali comuni ad entrambi i sessi. La maggior parte è costituita da ornamenti personali soprattutto in bronzo, a cui si aggiungono in percentuale minore manufatti ceramici, soprattutto tazze, ciotole e brocchette di piccole dimensioni, forme adatte al bere in un eterno convivio nell'aldilà. Monili simili per foggia e ricchezza a quelli di Trinitapoli accompagnavano anche i defunti sepolti nella grotta Manaccora, imponente cavità naturale lungo la costa del Gargano. Dagli scavi in corso nell'ultimo ipogeo individuato emerge il legame strettissimo tra l'arte di ornarsi per affermare il proprio status symbol e l'esigenza di stabilire un rapporto simbiotico con le divinità mediante il ricorso ad oggetti di valenza apotropaica e rituale. * Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Centro Operativo di Bari - [email protected]
Ilaria Matarese* I vaghi della tomba 1 di Murgia Timone (Matera) nel quadro del Bronzo Medio in Italia.
Delle tre tombe a camera scavate da D. Ridola e G. Patroni sull’altopiano di Murgia Timone negli ultimi anni del XIX secolo, l’unica ad aver restituito un corredo ornamentale è la tomba 1, rinvenuta intatta dagli scavatori. Oltre al corredo ceramico (datato agli inizi del BM3) la tomba ha restituito un notevole corredo ornamentale, costituito da 23 vaghi in ambra, 7 in vetro, 3 in cristallo di rocca, un pendente in alabastro, un distanziatore in osso, 3 borchiette in bronzo, 7 spirali e 8 anellini in bronzo. Si tratta di uno dei corredi ornamentali più ricchi nell’ambito del Bronzo Medio italiano e che finora non era stato oggetto di uno studio accurato. Si propone, dunque, di presentare per la prima volta uno studio completo degli ornamenti della tomba 1 di Murgia Timone, inquadrati nel panorama coevo dell’Italia peninsulare, della Sicilia e dell’Egeo. Tale inquadramento ha consentito di inserire il sito di Murgia Timone all’interno dei processi di scambio di beni di lusso, riflettendo anche sulla
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
19
provenienza dei vaghi in ambra, che sono stati sottoposti ad analisi archeometriche, e sui processi socio-economici alla base di questo tipo di movimenti commerciali. A tale studio si è accompagnata una riflessione sul significato sociale attribuito a questo tipo di oggetti e sulla loro valenza rituale nell’ambito dell’inserimento nel corredo funerario della tomba 1. * Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - [email protected]
Marco Minoja*, Gianfranca Salis** "Il sacro e la”tecne”:fibule e oggetti ornamentali in rispostigli e depositi votivi della Sardegna
centro-orientale".
Le fibule sono una categoria alquanto diffusa in Sardegna, soprattutto nei santuari nuragici, anche se non mancano attestazioni in abitati e, più raramente, in sepolture. Gli esemplari rinvenuti sono prevalentemente di importazione e di provenienza italica. Il progresso degli studi e delle conoscenze ha ampliato negli ultimi anni il quadro delle attestazioni nell'isola, e fornito nuovi dati per proporre una lettura del fenomeno della diffusione di questi oggetti e delle direttrici extra-insulari lungo le quali si sviluppa. La distribuzione dei rinvenimenti e l'analisi tipologica dei reperti, soprattutto relativamente alle nuove acquisizioni, fornisce importanti indicazioni circa la modalità di recezioni di questi oggetti nella Sardegna nuragica, e offre spunti per un riesame delle relazioni commerciali e culturali che si sviluppano tra l'isola e le coste tirreniche nel Bronzo Finale e nell'età del ferro * Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e ad interim delle Province di Cagliari e Oristano - [email protected] ** Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari - [email protected]
Maria Rosaria Belgiorno*, Marco Romeo Pitone** I pendenti a pettine: simboli viaggianti.
Il sito di Pyrgos-Mavroraki, posto a est del porto antico di Amathunte, nel distretto di Limassol (Cipro) venne messo in luce nel 2003 dalla missione archeologica italiana del CNR. Da allora le ricerche effettuate hanno posto in luce una struttura produttiva pertinente ad un villaggio frequentato tra l’età del bronzo antico e l’età del bronzo medio. Fra le manifatture di tale “fabbrica” nel 2012 è stata identificata anche la produzione di monili in picrolite (una varietà di serpentino reperibile nel territorio cipriota). Fra le forme presenti si è riconosciuta quella di piccoli pendenti a forma di pettine simbolo che appare all'inizio dell'età del bronzo nelle decorazioni dei vasi e come distintivo di alcuni idoli piatti. Il pettine appeso dietro la schiena degli idoli o sul petto scompare come simbologia alla fine del Bronzo Medio, ma sembra riapparire alla fine del periodo geometrico. Oggetti similari sono stati ritrovati in diversi siti del Mediterraneo pertinenti a diversi periodi. L’iconografia del pettine suggerisce indagini che non si limitino meramente alla funzione di tale oggetto bensì ai suoi possibili significati e valori simbolici. * Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
20
- [email protected] ** Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano; Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates, Blera - [email protected]
Roberto Dan*, Artur Petrosyan** Alcune considerazioni su una particolare classe di oggetti di ornamento in bronzo
dall’Armenia.
L’utilizzo degli amuleti è attestato in Armenia a partire dal Paleolitico Medio. Nel corso degli anni in Armenia è stato scoperto un gruppo di oggetti di bronzo, caratterizzati dalla presenza di peculiari decorazioni. Questi oggetti, che sono datati tra la tarda età del bronzo e la prima età del ferro, sono stati utilizzati probabilmente come amuleti o pendenti. La maggior parte di questi oggetti è stata rinvenuta in diversi scavi archeologici, come ad esempio presso Shirakavan, all’interno di sepolture ricche riferibili a persone di alto lignaggio. Nella maggior parte dei casi gli esemplari sono stati rinvenuti in condizioni di conservazione frammentarie, mentre l’esemplare meglio conservato, pressoché intero, è stato scoperto in circostanze fortuite. Questa situazione continua a creare più di qualche problema per l’interpretazione iconografica e funzionale di questi oggetti. Nel presente contributo si è cercato di raccogliere insieme, per la prima volta, tutti gli esemplari conosciuti dell'Istituto di Archeologia ed Etnografia dell'Accademia Nazionale delle Scienze d’Armenia, con la finalità di fornirne una descrizione tipologica, presentarne le principali interpretazioni funzionali e iconografiche che sono state proposte nel corso degli anni e proporre alcune nuove possibili interpretazioni. * ISMEO - [email protected] ** Istituto di Archeologia ed Etnografia dell'Accademia Nazionale delle Scienze d’Armenia - [email protected]
Domenica 14 settembre
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
21
MANCIANO – NUOVO CINEMA MODERNO
ORE 9.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ MARCO GALLI, SINDACO DI MANCIANO GIULIO DETTI, ASSESSORE ALLA CULTURA DI MANCIANO UN RAPPRESENTANTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA MASSIMO CARDOSA, DIRETTORE DEL MUSEO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA DELLA VALLE DEL
FIUME FIORA Ore 10.30 inizio dei lavori
L'ETÀ DEL FERRO
Maria Bonghi Jovino* Per gli uomini e per gli dei. Simbolismo e significazione.
Una fibula da parata della necropoli capuana.
Nel contributo si prende in esame una straordinaria fibula da parata della seconda metà dell’VIII secolo a.C. dalla necropoli di Capua. Com’è noto tali fibule, rare e sostanzialmente rinvenute a Capua ed a Suessula, sono state così definite per le grandi dimensioni e per la complessità della struttura. L’esemplare presenta un grande disco con una complessa rappresentazione scenica che viene decrittata attraverso la scienza dei simboli. Dietro l’apparente semplicità del linguaggio si celano aspetti rilevanti quali le caratteristiche della produzione del tempo e uno spartito compositivo che si presta a più livelli di lettura mediante un simbolismo difficile da penetrare. Al momento, essendo lo studio in itinere si propongono diverse possibili interpretazioni. * Università degli Studi di Milano - [email protected]
Barbara Barbaro*, Daniela De Angelis**, Flavia Trucco***
Ornarsi oltre la vita: l'antropomorfizzazione dell'urna a Villa Bruschi Falgari (Tarquinia).
La tendenza ad assimilare l’urna al corpo del defunto è riconoscibile grazie a diverse classi di indizi. Le recenti indagini nella necropoli di Villa Bruschi Falgari permettono di verificare quanto il cinerario possa essere considerato compensazione del corpo bruciato sul rogo nell’ambito dei rituali della comunità protourbana tarquiniese. Saranno analizzati gli elementi che permettono di ipotizzare la presenza di tessuto intorno all’urna, dagli ornamenti ad esso applicati alle tracce lasciate dalla disposizione della cenere nei pozzetti, insieme alla posizione delle urne stesse ed alle caratteristiche delle coperture. Sulla base dello studio delle associazioni tra elementi attribuibili esclusivamente al “vestito dell’urna” (ad es. collane, borchiette, piccole fibule rinvenute intorno o ai piedi del cinerario),
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
22
nettamente distinti dalla parure intesa come insieme di ornamenti indossati dal defunto, si cercherà di individuare un modello che possa essere applicato anche a quei contesti privi di dati di scavo esaurienti circa l’esatta collocazione degli oggetti rinvenuti. Individuate quindi le sepolture che presentano tali caratteristiche, si cercherà di comprendere se la vestizione dell’urna fosse riservata solo a determinate classi sociali e se tutti i vasi cinerari in qualche modo simboleggiassero il busto della persona fisica.
* Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria - [email protected] ** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale - [email protected] *** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale - [email protected]
Maria Letizia Arancio*, Flavia Trucco** Corredi funerari femminili con fibule rivestite di dischi di bronzo: elementi di rango o di
identità culturale?
Le fibule con arco rivestito da dischi metallici e staffa a disco, attestate con una o più unità, caratterizzano molte delle più ricche e complesse sepolture femminili della fase iniziale della prima età del ferro. Diffuse in un vasto areale, che coincide sostanzialmente con quello in cui è presente lo stile villanoviano, queste fibule sono testimoniate in gran numero a Tarquinia, ma ancor più diffuse nella Campania meridionale, in particolare nelle necropoli di Sala Consilina e Pontecagnano. Le fibule di questa articolata famiglia tipologica si differenziano per configurazione dei dischi e per conformazione degli elementi distanziatori, elementi cui è stata riconosciuta una valenza cronologica che permette di seguirne le modifiche nel corso dell’intero periodo. In questo lavoro vengono analizzate tutte le combinazioni di corredo note contenenti tali fibule insieme a tutti gli elementi utili a ricostruire le forme rituali cui si accompagnavano allo scopo di individuare elementi ricorrenti e/o esclusivi. Tale analisi tenterà la lettura delle caratteristiche sociali dei personaggi femminili cui furono destinati questi particolari ornamenti. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale [email protected] ** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale - [email protected]
Alfonsina Russo*, Maria Anna De Lucia, Romina Laurito Tessuti, vesti e ornamenti per una vita oltre la morte.
Nell’avanzata età del Ferro sepolture eminenti del territorio falisco, che adottano il rito incineratorio, conservano evidenti tracce della pratica della vestizione del cinerario. Scavi in laboratorio hanno inoltre rivelato l’uso di un panno per la protezione dei resti combusti nonché per la protezione di oggetti personali fortemente caratterizzanti lo status e il ruolo del defunto. La preziosità dei cinerari e la ricchezza degli ornamenti collegati a questi rituali si sposano con l’uso di tessuti morbidi quale il lino, come suggerisce lo studio attualmente in corso sui resti di materiale tessile restituiti da contesti funerari ad incinerazione e ad inumazione dell’Agro Falisco e
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
23
dell’Etruria Meridionale, databili tra l’VIII e il VII sec. a.C. Anche nelle sepolture ad inumazione il dato fornito dall’analisi dei tessuti mette in evidenza l’uso di stoffe non comuni, evidentemente per abiti cerimoniali. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale
Anna De Santis*, Stefano Musco*, Paola Catalano*, Walter Pantano*, Flavio De Angelis** La morte ci fa belle. Significato degli ornamenti in alcune tombe femminili del III periodo
laziale dalla necropoli di La Rustica – Collatia.
Il centro di La Rustica che, in seguito alle ricerche effettuate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, si può identificare con certezza con l’antica città latina di Collatia, ricordata dalle fonti e legata alla più antica storia di Roma, appartiene al gruppo dei centri minori che si sviluppano nel Latium vetus fra la fine della fase laziale IIB e l’inizio del III periodo (ca. IX sec.a.C.) in posizione strategica su alcune delle principali vie di comunicazione e di scambio, in questo caso la via Collatina e il fiume Aniene. Il centro è stato individuato nel 1972, in seguito ai lavori per la costruzione del tratto di penetrazione urbana dell’Autostrada Roma - L’Aquila che hanno asportato completamente il tratto centrale della necropoli. I saggi di scavo che seguirono, effettuati nel 1975 dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e dall’Istituto di Topografia Antica dell’Università La Sapienza di Roma, hanno interessato un tratto della necropoli e alcuni lembi dell’abitato, situato sulla collina prospiciente la necropoli a SO. Ricerche svolte negli anni successivi e soprattutto la ripresa delle indagini nella necropoli negli anni 2009-2012, legate ai lavori per la realizzazione delle complanari del tratto urbano della A24, hanno arricchito notevolmente le nostre conoscenze su questo centro. I dati stratigrafici e le indagini, sia nella necropoli che nell’abitato, testimoniano una continuità di vita almeno dall’VIII sec.a.C. fino alla piena età repubblicana. Della necropoli sono state scavate complessivamente oltre 400 sepolture per la maggior parte riferibili al III e al IV periodo della cultura laziale (ca. VIII- inizi VI sec.a .C.) che corrispondono al momento di maggior fioritura del centro di Collatia. Soprattutto la composizione dei corredi femminili del III periodo laziale, particolarmente ricchi di ornamenti personali che sembrano differenziati per fasce di età, offrono dati importanti per la ricostruzione della struttura sociale della comunità di Collatia e permettono di ipotizzare alcuni ruoli rivestiti in vita dalle defunte. Inoltre, con analisi mirate sui resti antropologici, si è cercato di verificare la presenza di elementi esterni all’interno della comunità, ipotizzabile sulla base della tipologia di alcuni oggetti di corredo. * Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] ** Dipartimento di Biologia Università di Roma Tor Vergata - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
24
Enrico Giovanelli* Influssi orientali nella gioielleria tra VIII e VII sec. a.C. in Etruria.
I pendenti ad anello ellittico con castone mobile.
Scopo della comunicazione è illustrare come nell’Etruria della prima età del ferro e della prima fase Orientalizzante alcuni oggetti di ornamento provenienti dal resto del Mediterraneo, e conseguentemente i loro significati sottesi, siano stati recepiti con un certo grado di consapevolezza da alcuni esponenti delle élites locali. La classe in oggetto costituisce infatti una testimonianza di questo flusso di idee legate alla taumaturgia e alla profilassi del mondo femminile e del ciclo biotico. I pendenti ellittici recano spesso nel castone scarabei o scaraboidi, importati e di produzione locale. Se gli scarabei sono considerati amuleti fin da epoca pre-dinastica in Egitto, pendenti che richiamano la forma di quelli ad anello ellittico sono attestati nel Vicino Oriente fin dal secondo millennio a.C. Affrontando perciò la documentazione offerta dall’Etruria, che verosimilmente testimonia una produzione locale di questi pendenti, si cercherà di illustrare le dinamiche di adozione nel costume etrusco di tali manufatti, per cui un ruolo fondamentale sarebbe stato giocato da aree di forti scambi culturali quali Cipro per il contatto, la rielaborazione e diffusione di tali concezioni nel resto del bacino del Mediterraneo. * Università degli Studi di Milano - [email protected]
Veronica Gallo* L’incontro tra iconografia orientalizzante e materia prima degli dèi:
la nascita della raffigurazione in ambra in area etrusco-laziale. L’ambra risulta diffusa nella penisola italiana già dall’antica età del bronzo: vaghi, pendagli, bottoni, elementi di fibule, di orecchini, di spilloni ed altri ancora erano utilizzati come oggetto d’ornamento dalle ricche dame per ostentare, probabilmente, un alto ceto sociale. Tuttavia le prime ambre figurate compaiono soltanto nell’VIII secolo a.C., nei contesti funerari di alcuni siti dell’area etrusco-laziale. Il centro di produzione più antico sembra essere Veio: nella necropoli dei Quattro Fontanili sono state rinvenute numerose figurine sia umane, sia animali molto stilizzate. Nel VII a.C. la produzione si sposta più a nord, a Vetulonia, dove si riscontrano le medesime raffigurazioni, contraddistinte però da una maggiore attenzione per i dettagli e da una più marcata plasticità. In questo periodo si assiste ad una grande fioritura della produzione di monili in ambra figurata, con una particolare concentrazione presso Narce e Satricum; tra i soggetti più ricorrenti troviamo figure femminili nude, piccole scimmie accovacciate e altri animali, quali felini e cani. Il significato di queste rappresentazioni si aggiunge a quello che in antico era attribuito all’ambra stessa: le proprietà apotropaiche e terapeutiche della materia prima si uniscono a contenuti iconografici provenienti dal mondo vicino-orientale e mediterraneo. Questi oggetti erano quindi indossati in vita e portati poi nella tomba non soltanto come simboli di prestigio, ma anche per il significato che il manufatto stesso rivestiva nella comunità di origine. * Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
25
Faya Causey* Six orientalizing amber pendants in Malibu.
My proposal concerns a group of six Orientalizing period carved amber pendants now in the J. Paul Getty Museum, Malibu. The Female Holding a Child (Kourotrophos) (77.AO.84), Female Holding a Child (Kourotrophos) with Bird (77.AO.85), Addorsed Females (77.AO.81.1), Divinity Holding Hares (77.AO.82), Lion with Bird (77.AO.81.2), and Paired Lions (77.AO.81.3), are similar in style, technique, state of conservation, and size; and related in subject. Because of this, and because the six were part of the same donation, it is posited that they come from the same original context. As this author has argued elsewhere, the six must have been produced in northern internal Etruria in the first half (or perhaps in the third quarter) of the sixth century B.C. They have stylistic connections to Greek Arcadian and Ionian small bronzes as well as to contemporary Orientalizing Etruscan votive bronzes, relief work, and bucchero. All six can be shown to have specific ties to subjects and styles current in the Near East and Cyprus. The North Syrian and “Phoenician” aspects are salient. In this paper, I would like to probe further the amuletic aspects of the six pendants as a group, especially in regards to their role in Etruscan culture. The size alone of the largest three pendants would have signaled their exceptional value even before craftsmanship transformed the lumps of amber into traditional subjects of great power and status. As ornaments and amulets, the ambers could not but have made a spectacular impression, if only because of the optical characteristics of the rare material and its associations. The imagery enhanced the amber’s value. The age-old vocabulary that gave form to these glistening jewels made them good luck–inviting, danger-averting, protective objects. Although there are no close parallels in amber or other media for the individual works or the group, they belong to the vocabulary, iconography, and styles of Etruscan Orientalizing art. The subjects are women, children, and wild fauna—hares and migrating waterfowl. In format, the six include three heraldic compositions, a squared-up group of a lion with its prey, and two pairs of an adult and child in a side-by-side pose. Each of the six might also have been read as incorporations, or as symbolic, of a female nature divinity. This may be the principal divinity of popular Etruscan religion, who was worshipped in a variety of forms and under different names. Further study may support the identification of the large female figures as divinities with chthonic as well as afterworld aspects; the same may be true of the waterfowl and hares. Individually and as a group, the six remarkable ambers invite questions about their commissioning, making, owning, and burial. At this point, it is feasible to interpret these as the property of one or more political-ceremonial specialists, and to posit that these amulet-ornaments may have served as insignia of a very special kind. Permanent ornaments can endure beyond one human life and can connect their wearers to ancestors, thus playing a crucial role in social continuity—especially when we consider that such objects are imbued with an optical authority that words and actions often lack, or carry messages too dangerous or controversial to put into words. In life, in funeral rituals, and in the grave, the decoration of the body with jewelry and other body ornaments would have had a social function, solidifying a group’s belief systems and reiterating ideas about the afterworld. Were they made especially for death or did they serve a purpose before burial? Were they worn by a woman and even made by a woman or women? * National Gallery of art, Washington, DC (USA) - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
26
Andrea Celestino Montanaro* Non solo ornamenti. Parures e oggetti-simbolo dalle tombe dei principes indigeni dell’area
apulo-lucana. Le scoperte archeologiche degli ultimi anni e gli studi più recenti sugli usi e i costumi delle aristocrazie italiche dell’area apulo-lucana hanno aggiunto alcuni dati piuttosto significativi relativamente alla classe degli ornamenti personali e degli oggetti simbolici, elementi fondamentali alla base del fenomeno della nascita delle aristocrazie tra VIII e VII secolo a.C. Ancora più indicativo, come confermano le recenti ricerche e l’analisi approfondita di certe classi di materiali, è il legame che unisce tali aristocrazie indigene a quelle dell’area tirrenica, attivi già dal IX secolo a.C. Testimonianza di tali profondi rapporti sono gli ornamenti rinvenuti in straordinarie sepolture dell’area in questione, alcuni dei quali aggiungono, alla preziosità del materiale, la raffinatezza della lavorazione e il carattere raro ed esotico (ambra, avorio e faïence). Si pensi, ad esempio, alle sontuose parures che caratterizzano le sepolture delle principesse enotrie e nord-lucane (Alianello, Chiaromonte, Baragiano e Braida di Vaglio), caratterizzate da innumerevoli vaghi d’ambra, alcuni dei quali raffiguranti animali la cui origine affonda in credenze religiose riferibili ad epoche più remote e forse provenienti da ambienti culturali allogeni, da vaghi in avorio, bronzo, nonché da scarabei e statutette di divinità egiziane in faïence. Non meno interessanti, sebbene meno sontuose, sono le parures rinvenute nelle sepolture delle principesse daunie, contrassegnate oltre che da numerosi ornamenti personali anche dalla presenza di oggetti simbolici in metallo nobile, molti dei quali di importazione etrusco-meridionale (diademi, bastoni di comando, conocchie) che sottolineano lo status regale delle defunte con un preciso richiamo alle aristocrazie cantate da Omero nei suoi poemi. L’interesse e il richiamo ai poemi omerici appare ancora più elevato in occasione della presenza dell’insolito rituale del seppellimento dei cavalli accostato alle sepolture delle principesse daunie. Un ruolo fondamentale è senza dubbio giocato dalle ambre figurate arcaiche, potenti amuleti in grado di sconfiggere la malasorte e la paura della morte, i cui soggetti richiamano figure mitiche e personaggi legati al mondo funerario e dionisiaco, il cui compito era quello di accompagnare e proteggere i defunti nel loro lungo viaggio nel buio dell’Ade verso la “salvezza eterna”. * Consiglio Nazionale delle Ricerche, IAC-Bari - [email protected]
Giuliana Tocco Sciarelli*, Marcella Mancusi** Ornamenti ed ambre figurate dal santuario settentrionale di Pontecagnano.
Gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” presso il santuario settentrionale di Pontecagnano, attivo tra VI e IV secolo a.C. e dedicato ad una divinità femminile di tipo ctonio legata ai passaggi di status e alla fertilità, hanno restituito una gran quantità di offerte votive. Benché il vasellame ceramico risulti prevalente, è tuttavia stato portato alla luce anche un gruppo di oggetti di ornamento e di exotica che, sebbene numericamente ridotto, comprende elementi qualitativamente significativi. I rinvenimenti, emersi in contesti topograficamente e
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
27
cronologicamente distinti dell’area sacra, sono costituiti in prevalenza da fibule riferibili a tipologie ampiamente attestate nei corredi delle necropoli urbane coeve, oggetto di un lavoro di classificazione in corso di ultimazione. Tra queste spicca tuttavia una coppia di esemplari simili, realizzati in argento con decorazione in oro, cui è da affiancare un gruppo di ambre figurate di raffinata esecuzione. Tali manufatti, rinvenuti sulle sponde di un corso d’acqua che attraversa il santuario, non trovano confronti nella pur ricca evidenza restituita dalle necropoli. Oggetto di un’analisi specifica dal punto di vista stilistico e cronologico, offrono un’ulteriore attestazione dell’apertura di Pontecagnano a contatti commerciali di ampio raggio, della ricchezza della comunità etrusca ivi stanziata e del radicamento del culto alla dea cui si offrono oggetti fuori dell’ordinario. * Soprintendente archeologico MIBACT in pensione - [email protected] ** Soprintendenza per il Beni Archeologici della Liguria - [email protected]
Nunzia L. Saldalamacchia* Le fibule in ambra e oro e gli altri ornamenti della tomba 133 della necropoli SO di Calatia
(CE). La tomba 133 è una sepoltura femminile della Necropoli SO di Calatia posta a sud della via Appia, nel tratto San Nicola La Strada-Maddaloni in comune di San Marco Evangelista, località Torrioni che comprende sepolture datate dalla fine dell'VIII sec. a.C. all'età imperiale romana in una fitta sovrapposizione. La tomba 133 è datata all'Orientalizzante antico (725-700 a.C.) la qualità e la quantità degli elementi di corredo lascia intendere l'appartenenza della defunta ad uno status sociale elevato. Gli scavi di questa necropoli sono stati condotti a partire dal 1978 dalla dott.ssa C. Albore Livadie, ma la tomba 133 era stata precedentemente violata e purtroppo questo ha determinato non solo la perdita di una parte del corredo ceramico, ma ha compromesso irrimediabilmente la possibilità di ricostruire puntualmente l'apparato ornamentale. La sepoltura era a fossa semplice rettangolare con copertura a ciottoli di calcare. Il corredo ornamentale comprende: 1. circa 70-80 laminette trapezoidali in oro decorate a sbalzo, 2. circa 70-80 placchette trapezoidali in ambra (una parte delle quali decorata), 3. gli scarabei in faïence blu e 1 in pasta vitrea, 4. una fibula a staffa lunga (15 cm) con arco rivestito a perla d'ambra decorata a solcature incise (lunghezza complessiva di circa 30 cm), probabilmente in coppia con una fibula gemella parzialmente conservata, 5. circa 30 vaghi in pasta vitrea sferoidali e cilindrici, 6. vaghi in ambra a forma di bulla, trapezoidali e sferoidali, 7. circa 100 perle in ambra sferiche e anulari di diametro compreso fra 0,5 e 1,5 cm, 8. circa 3000 vaghi in pasta vitrea di colore azzurro-bianco di 0,5 cm di diametro, 9. frammenti di lamina d'argento decorati probabilmente parte di 2 (?) fibule a navicella, lO. distanziatore in ambra con tre fori, 11. frammenti di circa 12 fibule di bronzo, 12. frammenti di 2 (?) fibule in bronzo con arco rivestito da segmenti in ambra e osso,
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
28
13. una fibula in ferro ad arco ingrossato, 14. un orecchino in ambra privo di anello di sospensione, 15. 8 anelli digitali in bronzo e 1 in argento. 16. Saltaleoni in verga di bronzo. Lo studio recentissimo e attuale si concentra in particolar modo sulle laminette di oro e le placchette in ambra. Le laminette auree sono trapezoidali e rettangolari (le più grandi e le più piccole) di dimensioni digradanti (altezza compresa tra 2,5 e 1 cm). Non sembrano presentino fori intenzionali (anche se sono quasi tutte in stato frammentario), e sono tutte piegate sui quattro i lati per circa 1 mm. Tutte inoltre sono decorate a sbalzo, la maggior parte con un motivo a 4 triangoli contrapposti campiti da linee oblique, le più piccole con una sequenza di 2-3 triangolini campiti da linee oblique. Ognuna ha un lato "esterno" ripiegato sui quattro lati, ma che si distingue per una colorazione rossastra ancora da definire. Il diario di scavo non aiuta molto per la comprensione dell'originario utilizzo delle laminette che sono state in gran parte prelevate setacciando la terra. Laddove ne viene indicata la collocazione, risultano a contatto con i vaghi in ambra, i vaghi in pasta vitrea di piccole dimensioni e le placchette in ambra. Alcuni frammenti presentano sul lato "interno", dal colore più brillante e giallo, tracce di colore verde-blu. Le placchette in ambra costituiscono la seconda incognita. A prima vista sembrerebbero complementari alle laminette auree per forma e dimensioni, tanto che alcune di esse coincidono perfettamente alle altre. Generalmente però hanno una forma più varia: rettangolare, a trapezio isoscele e trapezio scaleno e l'altezza è compresa fra 2,5 e 1 cm. In base alle due superfici maggiori di distinguono due tipi: 1) il primo comprende le placchette con una superficie piatta e una curvilinea, hanno una sezione regolare e spessore compreso tra 0,5 e 0,2 cm. 2) Il secondo tipo comprende le placchette con entrambe le superfici piatte, di cui una inclinata, quindi con sezione trapezoidale e spessore decrescente. Una parte di esse, di entrambi i tipi, conserva sulla faccia piatta (non inclinata per il secondo tipo) ovvero la superficie d'appoggio, una decorazione a incisione ormai quasi completamente abrasa. Tale decorazione riproduce lungo uno o due lati dell'elemento d'ambra, una fila di meandri o denti di lupo campiti da linee oblique. Due placchette recano una decorazione a due bande separate da due linee, campite da triangolini e rombi che formano un motivo a scacchiera. Tale decorazione su una delle due placchette non è incisa ma visibile in negativo su uno strato di colore bianco-azzurro; la stessa traccia di colore tinge alcuni vaghi in ambra ed è verosimile che derivi dal contatto con le perle in pasta vitrea. Nel corso della ricerca corrente la singolarità di questi elementi decorativi è risaltata dall'assenza (finora) di confronti puntuali. Rispetto ai diademi, appliques e pettorali d'oro noti dalla letteratura archeologica (si pensi ad esempio alle brattee auree della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri, o al pettorale in oro e ambra della Tomba Galeassi di Palestrina) le lamine della tomba 133 di Calatia sono avvicinabili per spessore e tecnica di decorazione a sbalzo, ma non per motivi decorativi né modalità di applicazione mancando degli usuali fori di impuntura. I confronti più stringenti per spessore e decorazione (a triangoli campiti da linee oblique) sono dati dalle lamine auree di rivestimento dei segmenti lignei delle fibule a segmenti in ambra della collezione Castellani. Divise tra Villa Giulia, Musei Capitolini e British Museum (personalmente analizzate) si dicono provenienti da Praeneste dalle tombe Galeassi e Castellani e ad esse si aggiunge il confronto con fibule dello stesso tipo da Bisenzio (tomba Olmo Bello 2) pur scoperte a fine 800' e probabilmente rimaneggiate dai noti orafi. Confrontabili sono altre fibule con abbinamento di ambra e oro provenienti da Etruria (Veio, necropoli di Quattro Fontanili), Agro Falisco (Narce) e Latium vetus (Castel di Decima), ma anche
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
29
dal territorio piceno (Montedinove e Pitino San Severino). Le placchette in ambra del tipo con superficie curvilinea sono perfettamente accostabili ai tasselli in ambra delle fibule a castoni in osso o gabbia in bronzo di Verucchio. La forma, le dimensioni e l'assenza di fori coincidono sebbene pur nella grande varietà di decorazione in ambra delle fibule offerta da Verucchio (si pensi alla decorazione su lamina di stagno applicata ai tasselli in ambra), non via sia un confronto per la decorazione incisa. L'ipotesi "fibula" è suggestiva se si considera che il corredo della tomba comprende anche diversi frammenti di fibule di varie dimensioni presumibilmente ad arco rivestito, ma prive di rivestimento. Tuttavia la superficie rettilinea inclinata del secondo tipo di placchette è incongrua con l'alloggiamento negli eventuali castoni in osso o altro materiale deperibile da rivestimento di fibula. Naturalmente vanno prese in esame altre destinazioni d'uso: - una stola rigida sulla quale erano applicati-incollati i vari elementi; - ricamo dell'abito con tessitura di fili intrecciati o fascette di stoffa o altro materiale deperibile che inglobava le appliques senza che fossero cucite; - pendaglio o pettorale il legno o osso in cui erano incastonati i vari elementi; - la decorazione del letto funebre; -la decorazione di un cofanetto ligneo; - il prezioso ornamento di un copricapo. Inoltre non va escluso che parti del corredo siano state asportate durante il saccheggio precedente lo scavo. L'interesse di uno studio approfondito non si esaurisce con i reperti sopra descritti in dettaglio, ma l'intero corredo superstite può offrire una testimonianza della commistione di apporti culturali locali e influenze straniere etrusche, euboiche e orientali propri della prima fase dell'Orientalizzante. Non è un caso che vi siano 12 scarabei verosimilmente di importazione egizia se non di imitazione pitecusana, che attestano il radicamento di simbolismi orientali (egizi e fenici) in area campana nel corso dell'VIII sec.a.C.. La stessa lavorazione dell'oro qui documentata si inserisce nel fecondo discorso dell'oreficeria dell'Orientalizzante tirrenico, da Pithecusa a Cuma, alle tombe dei principi del Lazio e dell'Etruria. Gli scarabei presumibilmente pendevano insieme a gruppi di vaghi sferici in ambra alle fibule, particolare che si ripete in altre tombe di bambini e donne di Calatia (tomba 201). La defunta indossava inoltre 2 collane in ambra e 1 con vaghi in pasta vitrea; invece i circa 3000 piccoli vaghi in pasta vitrea bianco-azzurra potevano essere cuciti direttamente sulla veste. Gli anelli, i saltaleoni in bronzo, le numerose fibule in bronzo, le 2 (?) fibule in argento completano un apparato ornamentale eccezionale nonostante la sfortunata manomissione della tomba. A tale apparato si associa un ricco corredo ceramico (seppur lacunoso) e oggetti simbolo di prestigio come il coltello in ferro, la grattugia in bronzo, un piccolo vaso frammentario in bronzo, fuseruola e rocchetto in ceramica, le giunture in ferro della ruota di un carro e i resti di spiedo in ferro. Si auspica che la continuazione dello studio e la condivisione dei dati con la comunità scientifica possano gettare luce sulla comprensione di questo straordinario corredo che grazie alla direttrice Elena Laforgia sarà nei prossimi mesi esposto in via definitiva presso il Museo Archeologico dell'Antica Calatia (CE). * Leopold-Franzens Universität di Innsbruck - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
30
Carmelo Rizzo* L’abbigliamento funerario femminile dell’orizzonte culturale di Oliveto Citra-Cairano dal
centro alla periferia: immagine e proiezione di bellezza e identità. Il contributo si propone di puntualizzare alcune caratteristiche precipue dell’abbigliamento funerario femminile dell’orizzonte culturale noto come Oliveto Citra-Cairano. Questa popolazione di inumatori stanziati sulle alture delle valli fluviali del Sele e dell’Ofanto, alla metà dell’VIII secolo iniziò a spostarsi verso la costa tirrenica, in gruppi o singolarmente, attratta dai centri di Pontecagnano, a sud, e di Pithecusae, a nord. Il marker distintivo per il riconoscimento di queste genti in aree geografiche e in contesti sepolcrali esterni ai propri è stato l’abbigliamento femminile. La rilettura di vecchi dati, analizzati nell’intero complesso, e le nuove acquisizioni forniscono un quadro campione di riferimento per l’analisi proposta che consente di definire nuove evidenze sul tema. Le donne presentano vesti ornate da un rilevante numero di fibule cui si associano ambre, orientalia e, soprattutto, monili in bronzo: oggetti riscontrati in ambiente enotrio, adriatico e transadriatico. Tale costume funerario è caratteristico sia dei centri irpini che di quelli prospicienti la costa sul confine etrusco (Oliveto Citra, Montecorvino Pugliano, Santa Maria a Vico, Monte Vetrano), ma in particolar modo, già a partire dall’ultimo quarto dell’VIII secolo, è presente nelle necropoli di Pontecagnano e, seppur con meno rilevanza, a Pithecusae. L’abbigliamento femminile diviene ostentazione di bellezza, ricchezza, identità e differenza, consentendoci di riconoscere, su un sistema-base di oggetti e deposizione rituale, una serie di originalità che articolano nelle loro componenti i contesti. L’analisi mira a focalizzare il denominatore comune sul quale si sviluppano le micro-differenziazioni dei singoli comportamenti, partendo dagli ornamenta e relativa deposizione rituale intesa come proiezione dell’immaginario sociale.
* Seconda Università degli Studi di Napoli - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
31
C.S.P. – Onlus Centro Studi di Preistoria e Archeologia
RIASSUNTI
POSTER
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
32
Poster tema monografico
Elena M. Menotti*, Laura Pau
Oggetti di ornamento del Bronzo Finale dal Mantovano.
Con il presente contributo vengono presentati, in maniera organica, gli oggetti di ornamento del Bronzo finale provenienti dal Mantovano. Oltre a materiali editi vengono proposti reperti inediti, con particolare attenzione al complesso insediativo di Casalmoro; tale complesso è, come noto, un esteso agglomerato di ritrovamenti relativi al Bronzo Finale, costituito quasi esclusivamente da pozzi e pozzetti contenenti reperti di vario genere: ceramica, fauna, manufatti in osso e corno, bronzi e pasta vitrea. Pur se presenti in misura quantitativamente minore, i reperti in bronzo, osso e pasta vitrea costituiscono una parte significativa del record archeologico, e rappresentano una tipologia di oggetti che apre la via a numerosi quesiti e a differenti interpretazioni. Attraverso lo studio degli ornamenti provenienti dall’area oggetto della ricerca, per la maggior parte costituti da fibule, spilloni, ma anche da rotelle in osso, pendagli, perline in pasta vitrea si cercherà di comprendere la funzione e il significato di tali ritrovamenti. L’intervento si propone quindi di ampliare lo studio degli oggetti d’ornamento, durante le varie fasi di vita dell’oggetto stesso, dall’uso in contesti di vita quotidiana, fino alla deposizione finale, il cui valore può avere avuto un valore simbolico oltre che funzionale. *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - [email protected]
Diana Savella*, Savino Sbarra Le fibule del Bronzo Finale in area medio tirrenica.
La produzione di fibule in area medio-tirrenica mostra una notevole omogeneità nel corso del Bronzo Finale, quando una serie numerosa ed articolata di fogge ad arco semicircolare con una piegatura presso la staffa e con doppia piegatura è ampiamente presente in Etruria Meridionale e nel Latium Vetus. In quest’area geografica, tali tipologie non solo appaiono strettamente connesse all’ideologia funeraria, ma si configurano come indicatori di identità territoriale ed etnica, dal momento che caratterizzano contesti di differente natura. La scelta di determinate fogge di fibule nella composizione dei corredi funerari, come anche in quella dei ripostigli di bronzi, getta luce sui diversi usi e funzioni di questi oggetti d'ornamento, contribuendo così alla comprensione delle articolazioni sociali esistenti all'interno delle comunità che li adottano, alla ricostruzione di una sequenza diacronica dei diversi tipi e alla lettura delle preferenze di determinate tipologie nel tempo. La concentrazione di tali fogge di fibule nell’area etrusco-laziale risalta maggiormente se confrontata con la produzione metallurgica delle restanti zone dell'Italia centrale, dove, tuttavia, è possibile in alcuni casi riscontrare affinità e probabili influenze. *Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
33
Lorenzo Zamboni* Simboli di alterità. Ornamenti e amuleti femminili dalle necropoli dell’Emilia occidentale
orientalizzante ed arcaica.
In seguito al crollo della civiltà terramaricola, le modalità e i tempi del progressivo ripopolamento della pianura padana emiliana sono ancora avvolti da fitte nebbie: dopo secoli di apparente spopolamento, nella seconda parte della prima età del ferro assistiamo al “mal noto episodio” della cultura di “S. Ilario – Remedello”, interpretato in anni recenti come la prima fase di espansione etrusca a occidente di Felsina (Atti Orvieto 2008). Una ricerca recente condotta da chi scrive ha permesso di affrontare, per la prima volta in maniera univoca, tutta la documentazione disponibile riguardante i contesti funerari emiliani di VII e VI sec. a.C., anche grazie a nuovi dati di scavo (ZAMBONI 2008-2009; 2012; 2013; c.s.). Oggetto del presente intervento è il corpus degli ornamenti, per la maggior parte di ambito femminile: oltre a numerosi tipi di fibule, anelli, bracciali, fermatrecce, dischi fermapieghe, i due elementi distintivi della cultura sono il fermaglio di cintura decorato (tipo S. Ilario) e il pendaglio a ruota raggiata con elemento di sospensione configurato a protome zoomorfa o antropomorfa. Non mancano le collane polimateriche composte da pendenti di varia forma in ambra, in vetro e in lamina bronzea, e veri e propri amuleti come una lama in selce neolitica. Nel complesso questa parure funeraria sembra attingere in parte alle limitrofe culture a nord e a sud del Po (Golasecca, Veneto, ambito ligure - tanto da aver fatto ipotizzare la possibilità di pratiche esogamiche), ma in definitiva va a comporre una fisionomia particolare ed unica nel panorama degli studi. Se ciò si aggiunge che il rituale funerario prevedeva la rigorosa esclusione del vasellame di accompagnamento, assistiamo ad una società in via di formazione nell’ambito di una regione di frontiera, in cui interagiscono attori sociali di varie provenienza ed estrazione, al di là delle possibili etichette etniche antiche e moderne. Una cultura che, soprattutto attraverso gli ornamenti e il costume, manifesta una volontà di auto-rappresentazione e di riconoscimento ancora da investigare. * Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna - [email protected]
Maria Rosa Lucidi* La presenza dell’ambra a Tarquinia.
La recente scoperta nella necropoli della Doganaccia di Tarquinia (VT) di una tomba non trafugata, ha permesso l’osservazione delle modalità di deposizione del corredo ma anche della disposizione degli ornamenti personali della defunta inumata, probabilmente prima destinataria del monumento. Tra le numerose fibule almeno sei avevano in origine l’arco rivestito con dischetti di ambra e osso, di un tipo ben conosciuto fino alla metà del VII secolo a.C., che pongono perplessità circa la datazione del monumento se messe in rapporto al corredo ceramico di carattere alto arcaico. Le fibule potrebbero essere state ereditate da un avo della defunta? La quale nella volontà di mantenere il legame con la tradizione ha selezionato quelle evocatrici di un lusso principesco o rappresentano di fatto uno status ormai in declino? L’occasione ha sollecitato la riflessione più generale sulla presenza dell’ambra a Tarquinia dalla prima fase dell’età del ferro fino all’orientalizzante. A Tarquinia a parte qualche pendente/perlina o dischetto, la maggior parte dell’ambra è veicolata
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
34
soprattutto con l’introduzione di nuovi tipi di fibule durante “l’orizzonte IB2-IIA1” attraverso l’incremento delle relazioni con le comunità esterne specialmente della Campania e del Lazio. Molto si è scritto in proposito, con il risultato di focalizzare aspetti quantitativi il più delle volte tralasciando una più ampia disamina del portato semantico dei monili all’interno dei contesti. Per il periodo orientalizzante manca invece un corpus delle attestazioni che per il momento si confermano nell’unico tipo di fibula con arco rivestito di dischetti di ambra e osso e staffa allungata. Pur considerando la limitata disponibilità di contesti è chiaro che nella composizione dei processi formativi della nuova “visione” aristocratica una parte importante devono avere avuto quelle materie esotiche che catturano la luce, ma non è scontato che l’oggetto possa essere portatore di significati, intrinseco e estrinseco, che potrebbero viaggiare nella stessa direzione. L’obbiettivo della ricerca non risponde a quesiti di ordine classificatorio, ma pone una riflessione su un possibile “valore aggiunto” dato alle fibule decorate con ambra in un centro come Tarquinia “eccentrico” rispetto alle vie di smistamento e lavorazione della resina fossile. Ulteriore proposito sarebbe quello di indagare un eventuale relazione funzionale o simbolica dell’ambra con altre categorie di beni di prestigio se comparata per esempio con la distribuzione delle paste vitree, all’interno della ritualità funeraria. La possibilità di usare tabelle di associazioni di corredo basate su seriazioni crono - tipologiche derivate dagli studi pregressi ha il vantaggio tra l’altro di mappare le testimonianze su un piano diacronico, utile per valutare le eventuali variazioni del “simbolismo funerario” su un lungo periodo. In linea con il tema affrontato nel convegno si da spazio quindi a riflessioni sul significato simbolico e/o ideologico che l’ambra in associazione ad altri materiali “esotici” può avere assunto nei diversi periodi. * [email protected]
Valeria Barsanti*, Tonia Punzo*, Valentina Russo* Ornamenti personali e rituali dalle tombe della necropoli della prima età del ferro di S.
Antonio a Pontecagnano (SA). Gli oggetti d’ornamento costituiscono una componente della cultura materiale capace di veicolare informazioni legate sia al genere che allo status di colui che possedeva il bene impiegato nel vestiario, quale oggetto personale, simbolo di status o in taluni casi avente funzione rituale, esprimendo così la propria identità. Il presente contributo intende analizzare la presenza e la funzione delle diverse tipologie di ornamenti all’interno di alcuni nuclei di tombe della necropoli orientale di Pontecagnano, recentemente studiate o in corso di studio. L’insieme di strutture sepolcrali trattate sono state rinvenute all’interno delle proprietà Adriatica, Bisogno e Guadagno. Le tre proprietà, ancora inedite, costituiscono tre settori dell’ampia necropoli della prima età del ferro (Fase I e Fase II) posta in località S. Antonio e presentano tre tipologie tombali: a ricettacolo, a fossa e a cassa. In questa sede verranno illustrati unicamente i dati che concernano gli ornamenti personali e rituali; l’analisi di questi oggetti all’interno dei ricchi sepolcreti pontecagnanesi permette, infatti, di distinguere alcune sepolture con corredi particolarmente ricchi che comprendono tra gli oggetti d’ornamento spirali, pendagli, vaghi, anellini, cinturoni ed armille e che risultano connotate, insieme agli ornamenti, anche da altri oggetti di particolare prestigio, quali figurine plastiche, elmi articolati, cinturoni in bronzo o, in una fase più recente in prop. Guadagno, armille, vaghi in pasta
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
35
vitrea e vaghi in ambra e bulle d’oro, spirali e bottoni in argento. * Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - [email protected] ** Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - [email protected] *** Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - [email protected]
Tonia Punzo* Analisi e distribuzione degli oggetti di ornamento nelle tombe della Necropoli Orientale di
Pontecagnano in proprietà Adriatica.
Nel contributo presentato in questa sede si proverà a delineare un quadro generale della distribuzione topografica degli oggetti di ornamento all’interno di un lotto di sepolture della prima età del ferro dalla Necropoli Orientale di Pontecagnano (Necropoli di S. Antonio- prop. Adriatica). La proprietà, in località S. Antonio alla via A. Vespucci, fu oggetto di due diverse campagne di scavo nel corso degli anni 1993-92 e 1996, che portarono alla luce circa 80 sepolture distinte in tre diversi tipi: a ricettacolo, a fossa ed a cista. L’intento sarà quello di osservare il “comportamento” degli oggetti di ornamento all’interno del lotto selezionato secondo due diversi punti di osservazione: differenziazioni di genere e di struttura tombale. Le differenziazioni strutturali nei tipi tombali lasciano inoltre ipotizzare in alcuni casi differenze cronologiche che restano tuttavia da verificare.
* Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - [email protected]
Ilaria Matarese*, Paolo Pallante** Vaghi e pendenti in alabastro da contesti dell’età del Bronzo italiana: tipi morfologici e luoghi
di approvvigionamento. Nell’ambito di uno studio complessivo condotto sugli ornamenti presenti nei contesti dell’età del bronzo dell’Italia meridionale e della Sicilia, realizzato per un progetto di Dottorato svolto presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, è stato possibile individuare un gruppo di oggetti realizzati in alabastro calcareo di colore giallo paglierino, provenienti da siti dell’età del bronzo, e che non erano mai stati oggetto di uno studio specifico. Nel poster si presenta uno studio degli ornamenti individuati da un punto di vista crono-tipologico e petrologico, cercando di inquadrare questo tipo di produzione ornamentale nel comparto geografico di riferimento in base anche alla disponibilità di litotipi locali. Il gruppo principale degli ornamenti in esame sembrerebbe andare a costituire una vera e propria produzione, limitata cronologicamente e geograficamente, in quanto la maggior parte di questi vaghi e pendenti è stata individuata nelle sepolture castellucciane della Sicilia sud-orientale, è diffusa in un buon numero di necropoli del BA e il tipo morfologico è piuttosto costante. Solo pochissimi sono invece gli ornamenti in materiali affini provenienti da contesti dell’Italia meridionale. * Università “L’Orientale” di Napoli - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
36
** For.Geo. Studio Tecnico Associato, Modena
Ilaria Matarese*, Sonia Conte** Vaghi in vetro da Murgia Timone (MT): risultati di un recente studio archeometrico.
Nell’ambito di due progetti di Dottorato condotti dalle scriventi è stato avviato uno studio completo su un gruppo di vaghi in materiale vetroso provenienti da contesti dell’età del bronzo dell’Italia meridionale e della Sicilia. Si propone, dunque, un poster inerente i vaghi in materiale vetroso provenienti dalla tomba 1 di Murgia Timone (Matera), la cui frequentazione si data agli inizi del BM3, che sono stati oggetto, per la prima volta, di un’analisi alla microsonda elettronica per la quantificazione dei componenti principali e di un’analisi LA-ICP-MS (in una delle prime applicazioni su vetri provenienti da contesti dell’età del bronzo italiana) per lo studio degli elementi in traccia. Il campione MT2 (vago globulare-schiacciato) è risultato essere un vetro trasparente di colore turchese, colorato con l’aggiunta di rame e realizzato con l’impiego di un fondente sodico di natura organica, tipicamente ceneri di piante sodiche litoranee. Le analisi hanno, quindi, restituito informazioni di natura tecnologica relative al tipo di materiale vetroso in cui sono stati realizzati i vaghi (ormai quasi del tutto alterati), ma anche di risalire all’area di provenienza delle materie prime, consentendo di inquadrare il sito di Murgia Timone nell’ambito dei traffici commerciali di beni di lusso nel corso del XV-XIV sec. a.C.. * Università “L’Orientale” di Napoli - [email protected] ** Università di Modena e Reggio Emilia
Francesca D’Apruzzo* Costume e ornamentazione: ipotesi ricostruttiva delle parures femminili dell’Incoronata e
Valle Sorigliano. La figura della donna ha sempre avuto un ruolo imprescindibile nella definizione di gruppi culturali omogenei. Utile strumento d’informazione, finalizzato ad un’analisi critica delle società, risulta essere l’osservazione delle ricorrenze materiali all’interno dei corredi funerari così come l’evoluzione dell’apparato ornamentale e, più in generale, dell’abbigliamento. Data l’esiguità circa le tracce di fibre tessili che compongono il vestiario si è voluto proporre un’ipotesi di ricostruzione grafica dell’abbigliamento della donna partendo da una riflessione riguardo la funzione degli ornamenti di corredo, in base alla loro posizione rispetto all’inumata, così come registrato al momento del rinvenimento. Nell’ambito di uno studio condotto per la tesi Magistrale, relativo al costume femminile nel Mediterraneo centrale nei primi secoli del I millennio a.C., è emersa una particolare rilevanza attribuita all’apparato ornamentale dalle genti indigene della Basilicata. Le ricche parures di cui queste donne di rango dispongono sono indice di uno status elevato che ha forti nessi anche con la sfera religiosa e talvolta magica; si tratta di figure detentrici di un ruolo peculiare all’interno dell’oikos familiare. Nel poster si propone una presentazione di silhouette muliebri di due siti affini, ma distinti: le necropoli sub-costiere di Incoronata e Valle Sorigliano (MT). Le sontuose tombe prese in esame si avvalgono di oggetti caratteristici, oltre alle comuni
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
37
fibule ad occhiali e a quattro spirali, ricorrono armille bracchiali incise, anelli digitali, pendagli ad anelli multipli, borchie, dischi piatti, cinture a nastro con rotelle raggiate, falere, fermatrecce, saltaleoni, collane d’ambra o in materiale vetroso e i cosiddetti pendagli a “calcofono o xilofono”. * Università Federico II di Napoli - [email protected]
Poster Seconda sezione Ricerche e scavi
Paola Pascucci*, Fabio Rossi** Immagini, suoni, parole, gesti per comunicare la preistoria: le attività del sistema museale
PROUST.
Nel contributo vengono presentati due progetti realizzati negli ultimi anni in merito alla comunicazione di tematiche legate alle preistoria e alla protostoria nei musei, realizzate dal sistema museale per l’archeologia della Regione Lazio.
* Regione Lazio ** Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese - [email protected]
Matteo Aspesi* Una rivisitazione degli scavi della necropoli Rinaldoniana di Garavicchio alla luce dei diari
Rittatore-Cardini. In seguito alla lettura e allo studio dei diari di L. Cardini e F. Rittatore Vonwiller è stato possibile acquisire nuovi dati riguardo la necropoli di Garavicchio (Capalbio – GR). Primo elemento di novità, rispetto a quanto edito nella Rivista di Scienze Preistoriche del 1987/88 a cura di Aranguren et alii, è la presenza di gran parte delle piante di scavo delle tombe indagate dai due studiosi, dove talvolta sono presenti le indicazioni delle misure e la collocazione di ogni singolo elemento deposto nelle camere sepolcrali. In secondo luogo è possibile ravvisare alcune discrepanze tra quanto è contenuto nei diari e quanto pubblicato e comunicato alla Soprintendeza da L. Cardini e F. Rittatore. L’importanza dei dati racchiusi nei diari, in quanto sono stati scritti di proprio pugno da L. Cardini, risulta fondamentale per una maggiore comprensione di questo importante sito dell’Eneolitico toscano. Si cercherà in questa sede di presentare un quadro esaustivo e quanto più completo possibile degli elementi acquisiti dalla lettura di questi testi, dando modo così di approfondire quanto scritto circa questa necropoli. * Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
38
Christian Metta* Materiali inediti dalla Grotta dell’Infernetto (Viterbo).
Vengono presi in esame i materiali inediti conservati al Museo Fiorentino di Preistoria, provenienti dalla Grotta dell'Infernetto in località Chiusa del Vescovo (Ischia di Castro, VT). I materiali fittili non sono associati ad alcun dato stratigrafico ad accezione di alcuni dati ricavati dai resoconti di scavo di F. Rittatore e L. Cardini risalenti al 1955. Le forme vascolari e le decorazioni analizzate sono confrontabili con gli elementi provenienti dalla zona tosco-laziale e sono riferibili al Bronzo Antico e Medio. * Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
Andrea Jacopo Sala* Analisi delle strutture delle tombe a camera dell'età del bronzo antico/medio nell'Italia
centro-meridionale.
In questa sede si presenta una proposta di tipologia delle tombe a camera presenti nell’Italia centro-meridionale datate alla fase di passaggio tra Bronzo Antico e Medio. Questa analisi va ad approfondire uno studio già effettuato da F. di Gennaro nel 1999. Si analizzano le parti strutturali dei sepolcri suddividendoli in tipologie sulla base della forma della camera e dell’ingresso, dell’andamento della volta, della complessità del dromos e del vestibolo, della presenza o meno di elementi accessori quali banchine, nicchie o gradini. L’obbiettivo dello studio è finalizzato a facilitare i confronti delle singole parti costituenti di questa tipologia tombale e di aiutare nell’interpretazione funzionale degli stessi.
* Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
Anna Maria Conti*, Carlo Persiani** I ricchi frutti dell'archeoinvestigazione. L'abitato del bronzo tardo di Capodimonte (VT).
Nel convegno PPE XI era stato presentato un poster riguardante una presenza del Bronzo Recente-Finale sulla sponda sud-occidentale del lago di Bolsena. In quell’occasione era stata avanzata una ipotesi per ricostruire la giacitura originaria dei reperti, superata da nuovi dati. Le informazioni ottenute di recente permettono di mettere in collegamento più stretto i ritrovamenti con le note piroghe della fine del II millennio a.C.. * Società Cooperativa Arx ** Sovraintendenza ai Beni Culturali, Comune di Roma
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
39
Francesco Marano, Marta Narducci Il territorio di Veiano (VT) nella Protostoria: uno sguardo d'insieme.
Gli autori presentano in particolare lo studio dei materiali protostorici provenienti dalle ricognizioni del G.A.R. nel territorio di Veiano (VT), in particolare dai siti di Borgo di Veiano, Torre d’Ischia e Vigna Grande.
Patrizia Costa Nuovi materiali protostorici dal sito di Rocca Respampani (Monteromano, VT).
Nel contributo si presenta lo studio dei materiali protostorici provenienti dalle ricognizioni del G.A.R. nel sito di Rocca Respampani a Monte Romano (VT).
F. Rossi*, M. Cardosa**, I. Cappello***, A. Lepri***, M. Luciano***, M. Maturo Duna Feniglia, sede Forestale (Orbetello, GR): nuovi elementi per la conoscenza del sito della
prima età del ferro. Nel contributo vengono illustrate i risultati delle indagini archeologiche degli ultimi due anni (campagne 2012 e 2013) nel sito costiero della prima età del ferro di Duna Feniglia. * Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese - [email protected] ** Accademia della Belle Arti di Brera e Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected] *** Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano
Andrea Zifferero*, Matteo Milletti, Caterina De Angelis, Marco Pacifici e collaboratori Progetto Marsiliana d’Albegna (Manciano, GR): nuovi dati sulla formazione del centro
etrusco e saggi di scavo sul Poggio del Castello. Il Progetto Marsiliana d’Albegna, avviato nel 2002 attraverso uno stretto rapporto di collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e l’Università degli Studi di Siena, ha fatto luce sulla conformazione dell’abitato etrusco, connesso alla necropoli orientalizzante di Banditella, messa in luce dagli scavi di Tommaso Corsini tra il 1908 ed il 1919, facendone emergere la consistente articolazione topografica, distribuita tra il Poggio del Castello, l’Uliveto di Banditella e il Poggio di Macchiabuia, per un’estensione complessiva di 47 ettari, e soprattutto le tappe della formazione, risalenti al Bronzo Finale. L’esplorazione dell’area suburbana ha contribuito ad arricchire il già complesso sistema insediativo, dominato da abitati d’altura con presenze di superficie risalenti al Bronzo Finale ed intense forme di frequentazione nei periodi Orientalizzante e Arcaico. Il contributo documenta la complessità degli aspetti topografici del centro, con particolare riferimento ai saggi aperti nel 2013 sulle pendici meridionali del Poggio del Castello, che hanno messo in luce cospicui accumuli di ceramica protostorica pertinente alla fase avanzata del Bronzo Finale, insieme a testimonianze di frequentazione nel Bronzo Medio e
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
40
Recente. La ricerca in corso fornisce inoltre importanti indicazioni sull’esistenza di una presunta curtis murata alto-medievale con annesso cimitero, menzionata tra le donazioni di Carlo Magno nell’805 all’Abbazia delle Tre Fontane di Roma, alle origini del borgo fortificato di Marsiliana.
* Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e Beni - [email protected]
Clarissa Belardelli*, Silvana Vitagliano Da privato a pubblico: la collezione Tulpharum (Tolfa, Rm).
Proseguendo nella presentazione delle collezioni oggetto di schedatura da parte del Centro Regionale di Documentazione nel corso dei suoi venti anni di attività, vengono presentati in forma preliminare i materiali protostorici più antichi della collezione Tulpharum, acquisita di recente dal Museo Civico di Tolfa e relativa a materiali raccolti dai soci dell’Associazione culturale Tulpharum nel corso degli anni. Si tratta di industria litica, ceramica (figulina e impasto), oggetti metallici, di provenienza varia dal territorio dell’Etruria meridionale. * Regione Lazio - [email protected]
Clarissa Belardelli*, Patrizia Petitti** La collezione Catone-Costantini (Acquapendente, Vt)
Viene presentata la collezione Catone-Costantini, pubblicata a suo tempo solo in forma preliminare e conservata ad Acquapendente presso gli eredi Catone e Costantini. Si tratta di industria litica, di vasellame in impasto e soprattutto di oggetti metallici, di grande interesse per la ricostruzione della cronologia del territorio dall’Eneolitico alla prima età del ferro. * Regione Lazio - [email protected] ** Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale - [email protected]
Matilde Kori Gaiaschi*, Marco Romeo Pitone** Nuovi dati dal settore Vb di Sorgenti della Nova.
Il settore Vb, posto alle pendici meridionali della rupe di Sorgenti della Nova è stato oggetto di indagini tra gli anni ottanta e gli anni novanta. Elemento caratterizzante del settore è stata una struttura monumentale semi-scavata nella roccia di base che ha restituito una grande quantità di materiale databile all’età del bronzo finale. Nel 2008 si è deciso di riprendere le ricerche ampliando l’area di scavo verso nord-est. Da allora, pur non avendo ancora intercettato la continuazione della struttura monumentale presente nella porzione occidentale del settore, sono state messe in luce le tracce di una frequentazione protostorica anche in quest’area documentate dalla presenza di diverse strutture e abbondante materiale ceramico.
PPE XII ‐ Decimo Incontro di Studi Centro Studi di Preistoria e Archeologia 2014 Milano
Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei
Gli oggetti di ornamento come status symbol, amuleti, richiesta di protezione
41
In questa sede si vogliono comunicare i primi risultati degli studi effettuati. * Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected] ** Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano e Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates, Blera; e-mail: [email protected]
Marta Alberti* Filatura e tessitura a Sorgenti della Nova: studi distribuzionali e implicazioni sociali degli
strumenti ceramici per la produzione tessile. L’analisi dell’abitato di Sorgenti della Nova è stata a lungo focalizzata sullo studio delle strutture e sulla tipologia dei reperti ceramici. L’obiettivo di questo intervento è di portare all’attenzione del pubblico un terzo tipo di studi, che nasce dalla fusione dei due precedentemente menzionati: l’analisi funzionale e distribuzionale. La particolare collocazione cronologica e geografica del sito di Sorgenti della Nova lo rende una fonte preziosa di informazioni riguardanti un periodo chiave della preistoria nel territorio Etrusco-Laziale: la transizione da comunità di villaggio, caratterizzate da una struttura sociale di tipo egalitario, a comunità urbane con complessa stratificazione sociale e manifatture specializzate. L’abbondanza di ritrovamenti di strumenti ceramici legati alla filatura e alla tessitura testimonia da un lato l’importanza della produzione tessile all’interno del villaggio, dall’altro richiede, per essere compresa e interpretata al meglio, un’attenzione diversa da quella riservata alle classiche forme ceramiche. La produzione tessile, attività fondamentale in una società profondamente legata alla pastorizia ed ai suoi prodotti, assumerà nel corso dei secoli crescente importanza, distaccandosi sempre più dal modello rurale, fino a diventare un vero e proprio status symbol e pietra miliare nella formazione della donna etrusca e romana. Nella mentalità comune questa attività si configura come tipicamente femminile e solitaria, indicatrice, nel mito di Penelope come in quello di Lucrezia, di virtù e sobrietà. L’evidenza a Sorgenti della Nova apre nuove prospettive. Attraverso lo studio tipologico e funzionale dei ritrovamenti, comparando i dati ottenuti con i risultati dell’archeologia sperimentale, possiamo individuare con relativa chiarezza quali tessuti venissero prodotti. Grazie allo studio della distribuzione dei reperti alla luce delle loro funzioni, possiamo inoltre delineare il quadro di un villaggio in cui la produzione tessile, dislocata in diversi ambienti e affidata a diverse categorie femminili a seconda della fase di produzione, assume una dimensione suprafamigliare e collettiva. * Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano - [email protected]
Centro Studi di Preistoriae Archeologia
Comune di Pitigliano Comune di Valentano
Istituto Italiano
di Preistoria e Protostoria
Regione ToscanaAssessorato alla Cultura
Provincia di ViterboAssessorato alla Cultura
Provincia di GrossetoAssessorato alla Cultura
Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese
Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milanoviale Lazio, 26 - 20135 Milano C.F. 97208560157 Tel. 02-22477212www.preistoriacsp.it - [email protected]
Università degli Studi
di Milano
Enti promotori
Comune di Manciano
Museo della Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora
Patrocinio di