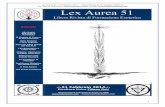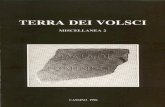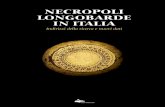Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell'attribuzione ad Herakleia
Un nuovo insediamento del Gruppo Vhò a Isorella (BS): primi risultati delle ricerche del 1997
Transcript of Un nuovo insediamento del Gruppo Vhò a Isorella (BS): primi risultati delle ricerche del 1997
ISTITUTOITALIANO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA
ATTI DELLA XXXIIIRIUNIONE SCIENTIFICA
PREISTORIA E PROTOSTORIADEL TRENTINO ALTO ADIGE/SÙDTIROL
in ricordo di Bernardino Bagolini
Trento, 21-24 ottobre 1997
Fireîze 2OO2
387
MINO tLRlNl ,IIISABFI IA 5lAJ{\lNl ,(LqUDIO D AMICO"-.CAIERINA OTTOMANO***-
UN NUOVO INSEDIAMENIODEL GRUPPO vIIÒ A ISORTLI-A. (BS):
PR]MI RISULT{II DELLE RJCERCHE DEL 1997
r. PREMESSA (M.P, E.S.)
Il sìro reolitico di Isoreila, situato in provincia di Brescia (Fig. 1), venne
segnatato nel 1992, allorché le arature porruono in superficie mmufatti litici e
. resri di fauoa in un campo nei pressi di Cascina Bocche, evidenziando una
chiazza piir scura di teneno antropico (Perini e Starnini 1992-93). Un sondag-
gio non aurorizzaLo effettuaLo nel lqql re.e neces"rrio orguirzrre uno 'r,osisremadco, volto a recuperare ll contesto di provenienza dei materiali raccold intale occasion€, tra cui un framrnento di braccìale di Spondlhu ed w frnmertodi anellone in piecraverde levigata.la prìma campagna di ricerche si è svolta nel
settenbre 1997 ed ha riguardato lo scavo globale della macchia nera intaccata
net 1993.
2. INQUADRAMENTO GEOGRATICO (M.P, E.S.)
Linsediamento neolidco è ubicato in corispondenza di un alto morfologico,
ora livellato per scopi agricoli, in un terrirorio che si presenta prevalentemente
pianeggbnte, coÍ ùna quora media di 50-5i m s.l.m. Questa parte di pianura si
estende inmediatamente a sud della linea delte risorgive, dove le acque penetra-
te a monte nel suolo risalgono naturalmente alla superflcie, e pertanto viene
denomìnata "bassa pian*"'. È.nodellata ed incisa da numerosì corsi d'acqua,
tra i quali i fiumi Chiese ad est e Gambaa a ovest, che presentmo scarpare a
volte muore. Tla i numerosi zJtri corsi d'acqua minori, dettì localmence 'vasi",
"seriold'o'ìcoli", il pii! importanre è il Mviglio di lsorella, che s@Íe profon-
_ M '. ,, . .., d, Reìede o
'' Dipartinene, di Archeologiie Filologia Clssiù, Univdrità diCenova'aa Diprrtinenú di Sciem deua Term e GeoÌogi.c,Ambìdtalì, Unitnnà di Bòlógiaa"a1 Georch€ologia s. n.c., V,a L.Co@ 2, I 161 00 Gd!.v.
MINO PERINI' 'IISABFTÍA
s.ÀRN388
damen,e nrassaro n.ua p a'ur ""'+ '1".,:i::'l:.oi;:lil::li:.
r,. An,i,rmenre e,,,,evrno vÀs,e p,iJ-d' e,'.ì"".""ì" 0.i"'"ì*.,' 0."i.-", .
denominar< rocanenrc rTj l"llli:',i:,:'i 1,.* n ,"ì -ì, " a*-u
",nue drllMll sec d C IERsAL 1988) tr !
ir1'"'"1"i: ri.r"i".,uuio'i. eer 'd u" 'mbien e deposiion"*'1 'iÌ,lj":,'". ."'*'i.'" ar" < ogrimen'lo der ghracc r'"H:::";i: :Ii,"i:ll::.ii rn,:,ron. .,.r brunr . ar. ,'e,. ..' :,:i,l .",il:"t:;. ; ._'Îu,*,.., e*s,0,,t6oranre, e a dreniggio buono detjrubrrl
1988).
oc
\l | """n*'
i"+ PIADENA '
rig
OSTIANO
a **" ,0,,. t' *d"" Bocche Ubicuione del siro n€olitico (1$snco) (dis E
! 0,n vHo ,{ isoRELú (Bsl frcERcHE DEL I997
3. LO SCAVO 1997 (M.P, E.S.)
Come già:ccennato in p'e..denza, la ca-p"gna di scavo del 1997, durata
dieci giorni, ha interesato una macchìa di terreno antropico che era srata par-
zialmente intaccata con un sondag.qio non autorizzato che peraltro non ne aveva
esposto fhtera estensione (Fig. 2). La strurrura si presentava, dopo l'asportazio-
ne del terreno agricolo effemuata con l'aiuto di un nrezzo neccanico, cone una
chizza ovaleggiante di circà 20 m:, intaccara sùperficiaimente da una canaleaa
lungo iÌ lato ovest. Anord è stato invece messo in luce ùn canale contenete mate-
c
Fig. 2 lsorella (BS),loc. Cscina Bocdre. ?hnnnedia della rrutiu( ncoÌnicà (t'ir 1) e deL
canate di eù onana (US 6) dopo l asponzìone del Li'eiL' agricoÌo (dis E. Swrini)
l
I
Iiil. 3 IsoreÍa (BS),loc. Cscinà tsócch.. SúìÒne delh rrurun neoln'cr (Pir l) (Ap- rra-ro isricoÌor il quadFro uo india il punro deL cMìpionmùro ]Er Ììnalisi mlciomodoÌogica)(riliero N. Vallo o. dis. F. Sernn,i).
Fig.4 Ìuella {BS),loc. Cddra Bocche.l.a sú,ruE neolirica alrminedello úav., pimrdell'abbariaenro deÌ rrìmo!€ ln prino pido sl lnúara€de pdk dcl c{naLe di età romana
riale di etàL romma che lmbiva la srrurrura neolitic:. Quest'ultima si è rivelatacome una depresione poco profonda, con un rìernpimento dì lorma lenticolare(Fig. 3-4) di colore molto scuro, dello spessore masimo di 30 cm, che poggiavadirettamente su1 substrato ghiiioso, concrezionaro al teno. Un campione indisturbato del riempimenro della depressione è staro analizato con il metodo detÌamicromorfologia (clr. par. 4). Asud,ll rienpimento della strumrrasfumava cortro illinite dello scavo, indicando che ;l margine della rnedesima doveva trovar-si pochissimo oltre. Tunavia, a causa dei limiri di tempo e della presenza delle
JPM VHò ^
ISORTLI,A {BS). fuCIRCHE DEL I997 39r
colture, non è srata possiblle una verfica mediante l'allarganento della trincea.
I1 ripo di suolo che caratterizza questa limìtata parte di pianura ha permesso un
eccezionale stato di conservazione dei manufatci rinvenuti durante 1o scavo della
struttura, che cornprendono, olrc alla ceramica, abbondante indusuia litica,
industria su oso ed elementi d'ornamento personale
Nùmerosi anche i repeni di interesse naturalisdco raccoÌtì, m cui resti fau-
nistici, microfaune, molluschi tnestri e d'acqua dolce, carbonil. Tuno il terre-
no di risulta dalto sqvo della strutura è staio conservato per la setacciacura ad
acqua con vagli a maglie di 0,5-1-2 mm.
Con qusta operazione, non ancora termimca. si è potuta recuperare' tra l'al-
tro, una cariosside ca$oni"fjatz, determinata da R Nisbet come Tildcazz clàhoccarn ( di dimensioni paÀ a 4,1x2,6x2,4 mm, un po' deformata, con tracce
di glune suìla superfìcie venîrale) e, recen€mente, akre c:uiossidi ài Titi"nnonococntn, dícoccun ed ae*ban (Stan:ni et al. 2000) .
4. CARAITERISTICHE MICROMORFOLOGICHE DI UN CAMPIO'NE DI RIEMPìMENTO DELLA STRUTTURA NEOLITICA (C.O.)
Si presentmo quì di seguito i risutad dell'analjsi micromorfoiogica in sezio'
ne sonile di un campione di suolo indisturbato (Murphy 198Q, prelevato dalla
sezione del riernpimento della srrumrra ne1 quadrao 84. La descrizione delle
sezioni sottili è srata effemrata secondo Bullock aral (1985)
4.7. Descr;zione del sok in sezione sotàb
La porositàL (15olo) è @stituita da vuoti ploari (diametro massirno sabbie
medie) prevalenti su carrali e canere (diametro massìno sabbie grosolme). La
microstruttùa è a plares. La frazione grosolana è costituim da sabbie fini e
ghiaie ninute e rnedie che comprendono:- cl:stì arotondati di olari fini e subordinati fiammen!' di rocce acide,
probabilmente mlcaniche, provenienti dal substrato u Ìluvionale;
- ossa molto rare parzialmente fosfatizzac:
- comuoi pedorelinì di suoli con r;vestimend argillosi e framrnenti
di rivestimenti argillosi;- commi crboni molm minuti e medi. malconservari.
Ì AlÌo sudio colhboruo: M. Ron, I. Dc Grosì Mr,lrin € s ZdrPie.i P{ l'mhcÒbÒLogia, A.
cirod per la mala@logia, R Nisbd pú b palcúoboRnica, B A Voytck per la úcoLÒgia-
392
La frzione fine è costituim da l;mi agillosi bruno scuri; la b-fabric è indif,ferenziata. l,e frgure pedologiche cornprendono:
- rivestimenti argillosi limpidi frequenri, sja in relazione con la porosirà, sia
nella marsa di loÍdor solo in rarissimi casi sono inrercalad a sottili rivesti-menti grossolani;
- rivesrimenri g o*olan: "c]ni/Frequenri. .empre sov,rppo,ri a n\errimenri
argillosi e in relazione con la porosità;- scma slcite mioocristallina, talora in rivestimentì sovrapposri a que[i argilosi.
4.2. Dí'c"ssio e
Il rienpinenro della depresione è costituito in parre da rnateriali che pro-vengono da1 substrato non antropizzato e cioè da ciottoli aroondati e da fram-menti di un suoto che evolveva nell'area prima dell'occupzione neolirica.
Questo suolo è cranoizzato dalla presena di rivestimenri argillosi, il base aiquali viene classiflcato come un Alfisuolo evolutosi sotto densa coperrura fore-srale, che denota un regime dimarìco contraddistinro da sr€iòÍi conÍaltate(Cremaschi 1990). Le figure pedologiche principali sono i rivesdmenri agillosicui si sovrappoÍgoÍo rìvestimenti grossolani, questi ultirni legari ad ambiente acopertura vegetale assenc o degradata (Cremaschi et aI 1992). CtúL a qn$reosservazioni si pùò ftntùe una ricosuuzione dell'evoluzione paleoambientale delsito: durante il Neolitico I'area venne disboscata ed insediata: non tanto la colti-vzione, che interessava solo gli orizzonti A del suolo, quanto 1o scavo di fosse e
sottostrutture, provocò il rinaneggiamento del suolo olocenico, brandelli del
quaìe si rinvengono nel riempimeÍro della depresiore. Dopo I'abbandono lavegetazione ricrebbe verosimilmente con rapidità e, in condizioni climadcheimmurate, la pedogenesi ripres€ con le sÉsse modalità del passato; su depositiantropici si impostò nuovamente un suolo che ha 1e carameristiche di un enti-suolo. Fano, questo, che indica come 1e conseguenze dell'impano antropicodovuto alla presenza delÌ'insediamento neolitico dovettero essere limitate e t:rlida non urbare sostmzialmente lecosistema circostante. La duran della fre-quentazion€ si suppoDe relativmente breve, a causa del rapido ìnpoverimentodei rcneni sonoposri a coltivazione che richiedevano un ricambio molto veloce
dei campi; per questo norivo la pozione di loresta aperta d:l disboscamento
doveva essere ristrena ad una radura (Carugati ,t rl 1996). I dvestimenti gros.
soÌ,ni soúapposd a g elli argillosi sono invece collegad ad uno scenario com-pletamence dìverso, cranerizzato da arnpì spazi disboscari e coltivati, di epoca
po'reriore aJ Neolrtlo e ouò e'.ere collocaro ror.e r pur:-e da'ler: del Brorzoa quesra fce è mche legata pane della porosìtàL ossewata.
ÌN Cr.AUùOD)srco
l]g.t-I.rcl]l ts: ...(^.inaB.q.c.t. ..,n< tri<! inlr_
1AI1r''D-derdrcllo.olfò.odrr,[email protected].:q,r.ù-_"di..,Lc.,[-g,_,,.opE,t.-vah decorah r raclc ldn. F.. ShminiJ
314
/tji)II LtrY
2
,77-\,l// \,[,\ ]DN--'/
at:l:/l/Ji [(l4 --< !
6i-t.^-L*,;-)
\ru" I
((
NÙOVO NSEDhN4ENI O DEL (;RÌ]PPO VHÒ A ISOMLL{ (BS) R]CERCÈE Dù I,,. 39t
I's 6 - koEla I bs). t.c. Cùcina Bucchc. Indurri\:: , r. s,i yr" 1y,cl,,
. p.,,;;;il,i;,';;';:?.:i:T:l,J::T::,::îl::":T,:r nrrÒDutrni disoli l\igk dcle ii{ft J h,,: Rnr:,,ùe v.gflrr-. L v. .dio .r hre,,Je di ..4, ,,,_
o''lo'1-'" Ji.l.s1o: { c- r"tJo o. -J,è
:ulli::: ;:,,;jÍ*,"- r ;;il#"ilt^1.".;íi;;.:;. i,;"Í.:ì:,:1,-:;:11;":_
Padua {Fìg. 7:t ). confermardo I jnizio del;rre conchistie sii dr que*" *.a0", .... ,.'-'J*'olazio
ne df o$en; '. J\"ri dr
r,..,p",i,-..ìs"g; ìì;,;;; ;;;il.fi #:ì'il:J*.::"J"":"#:iosi,tr,^mcnù di Lon.h;g[a bivrve. che Jd _-"J,. ;;;;;,;;;";,:;;l.i;.#:T.:",^oll""ere.,ome inizr.rmenrc suppos,o,rerin; e \rJnini r,)e2.J. , .- / ao esemprr.d, Unto nrrcruml,en,l. oer h form: e drmensionedell.etnierc. a Ma,gaùle,a ou,,,,ù";o,s,^,n,n, ,, ot. tol]o,
e
{
b7
@6
i:lt( l1 ril L l .lF,,\' \'
:fflli
Aili10r
396
ti in o$oi I frmento dj aneìlonc h pie@ levigatà (dis. E. Staminj).
5
- r- l_t\/'\\*l \ i ,i.
Ar",= llH"' tiEj
túÀ< 6
ll"-1 'h ,-l
'ffiVH
\
IPOVHÒ À sORELLÀ ([S): ÈCERCHtr DEL D97
6. RISULTAII DELLANAIISI ARCHEOMETRIC,A.DELLANELLONE IN PIETR,A. LEVIGATA (C.D.)
397
Il frmmento di anellone rìnvenuto, amibuibile al tipo A2 della Tanda (l977),r sLna 5,6 cm di lungheza 2,4 cn ót latfl:,ezza e 1,2 crn di spesore; iÌ dianetromassimo ricoscruiro è di circa 11 cm, mentre quello del foro è di poco oJtre i 6 cm(Fig 7:7). È onenuto da ua pietra fonemente maculata e scrsiata, con uo colore
na verde chìaro, avorio e nerastro, che è stata studiata in sezione soaile e XRD.La srrunura osservata è complessa e abbastanza insolita: accaato a prevalente
antigorite (oltre il 50%o) in porzioni felrrose e pennato-raggiate, vi sono abbon-danti cloriti, tremolite, clinopiroseni relìfti, cìascuno in quantità alneno del
10olo, olrre a minore presenza di magnetite e minima di mi,o. I clinopirossenisono intorbiditi, chiuamenre in via di uasformzione, con caratteri di diopside.La tremolic deriva chiaramer.rte da pirosseni, inglobandone poaioni, in parte si
accresce diablxticamente con individui fino a 5 nm di lunghezza, in pane è
rnic.rofeltrosa La clorite, incolore, appare come una Mg-clorice penninica, conindividui fino oltre 0,5 mm, intersecata con i citati componenti, con qualche
chiazza di magnetite e qualche grumeno di talco.La roccia costituence va quindi definita come serpen!inite antigoridca-clori
cica-tremolidca con relìftì clinopirossenici, e appare derivare da una peridotitericcamente pirossenica. Labbondanzadi minerali non serpenthosi la rende imo-lita úa le se+entiniti utilizzate per gli anelloni neolitici finora srudiai, comequelli di Sarnrnardenchia (D'Anico et aL 1997), Brieomo Frrcara (D'-A.mico a
"l 2000) e Azzalo Decìmo (Fasatri * a/.7994). Con qr-rest'ultimo esemplare tut-evia, vi è ir comune I'abbondanza di clorite, anche se non quella di remolite e
reliúi clinopirossenici. Le variazioni nàtùali soDo tali però da non esdudere unarelazione di parentela con quast'ultimo esemplare, mentre sembra del tuttoesclua una puentela con gli altri due cci. Non esistendo ancora una casistica
sufiìciente delle serpenriniri usare per i manufatri neolirici, si rimmda a rempisuccessivi una piùr soddisfacente companzion€. h provenienza, infine, può
riponare sia alle Alpi occidentali, sia a quelle centrali, sia:lì'asse Isrco-Adige.Solo lo wiluppo dì ulteriori conoscenze nei tunro por:L megJio predsare anche
7. CONSIDERAZIONI (E.S.)
A olte venti anni di distmza dalla deînizione del Cruppo del Vhò da partedi Bagolin; e Biasi (l975), sono ancora €renti le conosc€nze su numerosi asp€t-
ti di questa Cultura. Vari sono i motivi causa di queste lacune: la marcarza di
398INl CLAUOJO IJ'AMÌCO
]ca:, es'en.ivi !i intediamcnri che posano chiarirc to,ganizzaz;one decli abrr,,i. ù n,,mero ri.' re,,o di .iri înora indagar; e pubbt.";,"il:;.",.:j."::;o.,on d, .on,ervazione, gene'tmenre pesime. de .r.j p;j";. ;;:;;:ì;d:,rat ori as, icorr e aJ ecosrone Jei suotr ro,,.'''_. r nes,l j..
"; il;#."Jra permesso d; documentare inreranrente r
rB,sotini a at r%z ;;;.";;,;d':::.una singorr' srcura srrurrurJ abiuriv'
rDesaspai 'al imr, ì ou',,**i"i.Íi::^.11 "':., d' I ugo d; Romasnr
n nnvenurr nci pozzenr rifiuraro ed rr r",^..i:":..n', i.,--."ruiera dei reper.
.,"". a."",. .r _ai. a:; ;ù ìJ::::","'. ::Ì"T r:....u*,i:iIl:,,.,,,: 1".." ceram che complc e ed. infine. to ".-.. -r,;;;.;:;.;;;.:;.rerodologie archeomer'che nnrr,zz,(e, 1,"t,.r. r p .bk;i:"ì ;;,.;.-" "
, l .iro.di rsoreur. pur ne a rimu;reza de arer . rì. ., , o"*,ì íi,J,*1..n"la po,vhiiir, di documenrrre nuovi aspcni dcla p .a*.,; ,"*.r,,.5.,1,,jdubbio risenre delt.influsso de a rmi;óf, (
:u : :.j.*, : î;.,.;' ì il ;ì ; il il:l"-.'j l.i .t,í::il.,i fi :i: :,.I;dr Grezzana lMoser e pedrorft I99b). che :c'"pp. vhò, p";,;";;&;'#;;:ff *'o1ta oostra rorti contaftj con iì
ro srum;rr rrr qresri duc cruppi .urruraJr :nzadi r'na tine' di 'onfinerquan
_ conrani, a lunga o;s!anza,ono comprovrl d,lté p,.senzr dctlrrcUone in serpen,'n,,e d' provenienza rlpinr. e dal bracci.rte;, ,r,"rrl"
-à,.,jj,ì.oggeno. in oarri.oJare. ap.e t.inrerros:tivo circa te drrcnricj d, ,;;ì.-ilì;qurr puo esere giunro al cenrro della pianur: t"d"", I"fr,; ;. ;:;;;#;b.,ccrati d; Spondvtn.ono ampiamenre difir.j in arer;,il;;;#:.r9q4. lqqo,. dallah, dobbiamo con,iderare . h. ,"., , ."".h;i; .;,,,ct.ì,renre repenbire. rlt inrio de .Artrnri.
o. rn, he ru"É" r. -. . a.ivj,.ì"*""ocidenmle, come dimostrano i rece*; a",; ._-.i a"l. ",.'il ;.it;il;:laune marìne delk Arcne Candide (Ghisoni t997: Cade 1999). penanro non sìpuò escludere, oirre alta gìà nom direttrice det ,"...;; il;;:, #:una via occidenrale pe.I rnffìco di que,ra con,hrstl, t"f'". p; i;:;;;":;erie
unr prc.i.a Louo.",i"n. c,onot;ej.a del .ompres,o .,",.,",.';;i".;;;r.d,ruone radiom, rricJ elferruau su un campion. a .-U"".,.s.,J. "r.r.""ìf
rrboraro,o di cruninge.r rNL, ha resriruiro r: dara dr s8s0 . ?ilíì;ì"N;23645; Starnini I998)
(.Ia"oru "eg:! :a" f"anzianento CNR, prosetto Finalìz./tta Bni C ttÌrati,tonîaao 11. CT 96.01j t2.?F36. Gti ,cdtì Mno ,ta,i 4Íettuati "",,
C";r;r;;;;,M in*nale. pru. n .ú-t. t W9. nlz,ùa ta a / Dr pd ai nft ,; ;,,;;;"r:,;;;:;:4nhologr/r e Onanatrn,hc /el/.thD !,,, ca F;,r.,t ,tt I _".; " s;;,',,: ;.",,te Jìnanziati dzt Com ni dì horelk (BS) e Reneletk (Bg. St ,t;;;;;";:;;;;_
399NIOVO rNSEDllr{EN rO DEL (;nLJPrO vHÒ a rsotuLl (Ùtr RI'FR'HE DEr' r 997
menft il Sig. wFaccín detk Ditu Farcin s tt /í Visana (BS) pn auerc fnanziata
Làii' ii*',it"u,o, na {a, o hanho pa,t.dpan: it Doi 4 sanqis ct: :t't,denri Don. nceriani tS,wk à S7ùaluzazioa' tn Atth(otogl' u4tuerrtti a]
ì'r'e,.t. U.voUoh" , U,iutsiù divcaezia' E Farcio rUniuctsiù à Milaqat e i!
î" "r.C.**i aa U,'"o di Renedctlo si ringraziaao in paninhr' ftr i nuùl(
,""i ,oto,to,i, il Sip. C Zennrhini e i nenbn ùllAl-t;LR ù l:orlk ?r t' prczto'
.í' ,"í[t",*,",i i,^. a,,ane nne b Ja,, detto 'ca'zo Quesro huorc c dedra'zo
atla nenoria ddio ronparso SigCeare Zenarhini
fu F!ruMENTI BIBLIoGR-AFIcI
B^cofNì B. c Bh(ì P, 1975. It N.alítìco d'LVhò.tì Pìden', (Prenrorix Al!ìna' 1i:1'45
n^.ó.i", ".,-n*t-r
c. "
;^ct P' 1977 vhò ca ?a GrtaL: tz'ì 1977' "lreiioti^ t'lPim'
l'67 98
n*.ir"' o- n**t" c.*.vl Br^cl lÌ, cAs rLLurl r L e C'$.;u\s'Ht M ' \975' s'a'ì "elli s
" ")l))-') ì""it,," it a-p" cftlob Mò rti Pì'd' a cznord): 1 e74-1 e7e' kú àc\')<xv!'
r.lo"i.'. S.i."rin* aati.r'llìì, "ll Neoliti'o in l!!Ìi'l vol tt:455466 lnentBFRNABÒ BRFA M., r99r, /z untîebbì| dnt hLalin'o ntlEîit del Fcrrafra"o
i""ì iì*'" aj, isói i, etìineito ncotiìco dì o$ìd'a'Dlsdtì Abi (cftna a) 'et
eo 'aht'
ro anbn,.alz 41 1anonna' Mooogafi€ di "Natùra BÈriana' 22
u".- ". "i""'. rr".. ìt"^.ot n,l:ú, aiftaag rî4 t\t. ^wtt
n4d x\itt"r w F h-"ii"ti'r. ,* aJ t,adpo ,.dok i tt', d' P'ada '( '@ou NÒahaa
'//l' -\rrÚr
Brcscian{, 27:243_288
";;;ìi, t;;;n.,lo\cEùus A, sÌoors c'J e îulsttt^î ' le8i Ha"tbÒob fat sait
Thì 5ectì0, D\ùi?Lii \Nldne Reeùch Publishos' VolvcúàùPton
c.^*t,, tóis, L.k,A",c zzlt,. ìn s Tinè (a cuàdi) IrN'ati'ico ne a Q!tu detb Alen'
-,J,4 i .r . "."-s,,n"
r'.n ",(hP PJ A dreJlosi he .0:< ''l qddt+
:1rl^{.'.'M-',c\'n.LrllL.lol'olM'|\,|'Lngn'alifid.l|nna
h nk^ b. t aantul.tu l k fnglulo t Vah' ^ L t 4!t e A l'\'in" 13'Ja d'zaaz"
a.'.,.a è t ttnt /Fnha.ial 1n,lt. t\J\-tt! T,afît .
CLMÀ:, hr M., t't,t\t l?dn!.atr ddr atî,.|ra.d ú t4 ail d"1n!' il "ttu4n
o n túun "rE úkndk, Vron.g.lfie di "NatuÉ Bresci'na" 13:71-90
."^*,"v. l-,R* Ìl r\,.p,rn. Ln\. t . qî2.I i nnzsi at s.oatt.o!.s a i: l,'t,,o,,ú !::' t 1. n ur ! . po ù e ù ua ano nndato Ouzden dellr soprir'( J'n/J A'c e'i gr' r oerr
no"i-...,r.i,1:". i.\., *.\ ,,(,.' rlr{\.v. \^\.r llv.L l'.\rr\r :14-.'" '";;;l;;;;;;;;;; ;; ianm lcnchìa 6ictù. "Mtte.r' r*rcs'àph Ac@' 40' 38t-426
oar,Jc...,rnrt L \"1r Fc fiN\' 'i'^búa lLi ddr b\gano t'^zú.'tt ' '1tnabunno-t d' "', úa aarq a *l ttoht'o Aqtl o ntra rr I' na tu'ìouÍ n r' a t"'ari J',1,t.,.-*' a *t''p'm' r(inoir" All:n' Jl:r) l2l
l)r. \! r. N,'"Rn\rùA e\'rl C Ì("'s l nvdtaalto N'al i d l"!'11ì ltr1avn r_---
,4..L,'.. c rr*.a f".ú1li') Lr Neatnituzìo" îa Orenra a o'dlt'ia Aíi dclùrnvcgn(
dì Studi. Udine (A.Pril' i999): 117_124 Udinc
400 vr\o PrRr\,. d 5^P a( {i^r\ ,urDtoDAnfcc
ERSAL, t988, I tuoli delh Bútd Bftt.ìdn. fu ifuni Mellr . Ch,ile Piogm cana PedolÒgid,tugione Lombardia, Milmo
L$ÀNr L, Br^cr P, DAMco C., Sr RNrNr E. e VonEK B.A" t994, Sîdzio"è ".alhna
a Uakr(Aturo D..ino-?od.non.): ldppono pEliniiaY degli sd,i ]990-199.1, .At; dclla Socied flcrla leifoÌia e ?rclororia deUà tugiore Fridi-Ven@ja Ciulia' \,'Ill:97'113
GHrsorrl E, r 997, .t c& ,l va nolhga íi th. Qt afAma c'uulr1a in R.Mrgsi, E.s€mini e
B.A-vor€k (a c@ di), .aae Cardid?: a F,Etio"rt asd EnuirÒkh.ntul À$.sùent of th.Holrcae S.qutue (Frtu"úiaú Btubò Bdd'Czdi,ì /910'50) "Menonc d.llTs;do diÌaleÒnroìogia Uúam, 5:137-142. Rona
Mos€R L. e PcDRorrr,{, 1996, Lzbitdt, ealìtia dì L"go di Ge@rd (Unoú): tkzìo. treltniîa\ in G.tsdlDo c L.SalA i \^ cM di), Dd a 7ètu al M"\.a 23-33. Caralogo Morra,
MuRrrry C.P, 1986, Thi S{îì0" Ptpdtutian af Soìl r,/ &/rrrzÀ AB Acadcmìc lublislìqs,
OrroMANo C., 1998, &,/,./,'Ò L! tulo Èl N.olítitu lzl ttafìd Nù|arìotdlz. I @tîribùo ù aniúano{ologja, in A.Pessina e G.Mts.jo (^ cut^ .\) Lr N.otitíeziok. nn Ai.nk . Orid.rÈ,Afti deì ConvesnÒ di Sudi, Udinc (Ap.ile I999): i47-l t7. Udin€
llruNr M. c Sr ìiNr E., I 992-93, ItoÈlld (BS), b.dlnìj Cúcina BN.Le: tno ne.litio. ,Norhì^tiadella SopinrendM,{rchslogiq dc àLombardio:l3-I4
PERTNT M. e S1^tu\rNr 8., I,)97, Urd nawd rwì0rc tul Gnppo Vhò d Isodk, in A,.BrcElta,
A.Qola, L.Daì Ri, M.l!Ein€ù. R.Llu, F.M,adó, nNicolis c APedÙti (a cun di),Ridsnri dclìa IOC{lll Àùnionc Scientifia dell l.l.PP, l'reisroria e ?.ororória del ]i€nrinoAlto Adigc/sùddrol, îeno: t0
sÉfÉru,{DEs M.L., 1994, &,,bt* sacdlnpú: th, èdtli5t tuwpean lons di'tatce *chause :yî.n: a
ynbolic aai wral anhuoklml dppnach a Neolnhic ad?rLr .lorcilo o EislovujuP3leolitika, neolitika in €neolilika r Sl@eniji' )0íI:238-256
slrÉru,{DÈs M.1., 1996, Ld tuLÈ saolírhíqtue d4 spo"dlA b ld Mèdiùd .e a I' Man.h., inM.Ofte (a cùa di), N,rr.t C,hu,.EMUL" 68, vol.l:289'3t6. Uege
S]^RìiE<r E., I 995, ai,/srz cddtuia ir f;Bia$i la cttt dj,) Llawlirnùta NeaLitico di Oeinno-D,sdli Abi (Ct o"a) ,ul 'r0 CoùeiÌ Aùhi."tuL al t o,ou te, Monogrifìc di .N.tù!aBres.iar^, 22.21 '43
Sr^RNrNr E:. 1998, ?Vz,,t dnti l{tuppa dltutuL dclVhò dagli îa,i d.lliwdizn.hto dì ttudla(BEîíd), 'Nún Bt6.ina 3122, 244
SIAnNÌNj 8., GHrsorfl F., GrRoD A. e NIsBtrr R., 2000, N'oti àzti t"l Nèoliti.o a"ttÒ d.lh?ìaud Pada@ mraL dzl
'iîÒ di Lore r (BEîia), in A]/6iM € G.Múscio (a cura di) d
N.,llri%.i/ft tu Aiaî.. Oc.idat, Atti d€l Convcgno di Studi, Udine (Aprile 1999),:
231-255. Udine'l
^NDA G., 1<)77 , Gli .fllk"i li,icì itd!ìdni, 'îreatara Alpinr l3: I I I - l5 5
IPO \4ÌÒ ,{ ISOFELLA {BS)ì RICERCHE DFÌ, I
''i40t
RIASSLIIjTO - UN Nuovo INSEDL{vrlNro DFl. GRUrro VHÒ A lsoR-ErL{ (BSl:
rluMl lusurll{r] rJELI-! NCERCHE DEL 1997 - lìlavoN liesenu i ris ari dcÍà pdnÌà (mpa'gna di scavi al sito scopero in Lolirà Csclna Bocche, ù Comue di Isorelta. Labbondante ceÈmic ,p. 'tp rr' 1Jr,"to,me,ne.l,_eunlo einflL. lcll,'ulu' Ji iotro UJlr''*ù u,,sav{a, ùra màc.hià ìenticolaÈ di ciu 20 nz, proviene eràtrùisria indusria litjca, faùna, indù-rria sù o$o e rui oggmi d ornmcrto, ùa cùi ùn frmúto dj ellone in pieúa levigaù e ùnbÉc.blc di .tp,,1lr{, il primo conosciuro pe. il Neolirico A4ico ddLà val Ìrdma. Vengono pre-
senÈtì anche i risùLtatl dclìc malisl miftpedologiche di ùn cmpìone di suolo indirurbato pr+Ìeuro &l rienpinrnro della sttuftuh neolitia e dl quelc pcúóùch€oneùiche 6egùite per deteFminarc la iocciù dell melloft nì pieh lwigaÈ. I.îne, con la se€cciaún ad acqua del deposirosono rde recùpsat€ cario$'di arbonizàie di tiriun.f ài.ù n, n|"ùúcan e rtà, n.
SUMMAIY - A Nr\f srrrGMrNT or rnr VHÒ GRour Ar isoRxr]-{ (BS): rREuMr-N,crìY REsúrl.s of njl 1997 RESÈARCH - A prelìmim4 repon ofdre fir* leldworL sasor ar
the Edly Neolithi. sirc discoyeed !ùr C{dna Eocche is given. The riclì poneq, assemblageshows lew forms ùd a rrong intlu of the leighboùdog Fiorúo Culùe. lrom úc dcawcdpit, a shalÌov srucrure of3louÌ 20nr, have been also ecov{ed a large chipped flinr assenbhge,Èùnal rmtns md Èveml ommdml objtrb, múng which ue one polished scre ring liagnrnrrnd one q,,,4/ bncdet, rhe fiN so tu found at an Ea.h Neolirhic site of rhe Po llai!. Tle!6ds of dìe micrcmorphologicrl m,lsis oî.nc udisîurbed sojl smpÌc fiom dìc fìIìng ofdÉpit a.e prgented rogerhe. wirh the petroarchaeonetrical sndy of the gremone ring. lrom úcwe! sieving ofrhe sol lìlln€ úe neolid,ic tit, oryopsis of I'îien.f. dn en floroco.en^n,lrcr@m have bm recovered. one chmoal smple snt to the laborarorv of crcni.sú (NL) savem àbsolurc dale of5850180 tsP