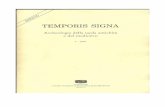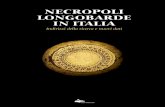Un Insediamento del TE III C nelle Cicladi: l'abitato di Grotta e le sepolture di Aplomata e Kamini...
Transcript of Un Insediamento del TE III C nelle Cicladi: l'abitato di Grotta e le sepolture di Aplomata e Kamini...
1
Archeologia dell’Alto Arcaismo Greco Sp. – A.A. 2010-2011
Un insediamento del TE III C nelle Cicladi:
l’abitato di Grotta e le sepolture di
Aplomata e Kamini a Naxos.
Thomas Milan
matr. 810554
2
Il Tardo Elladico III C nelle Cicladi:
Quadro generale
Il declino del sistema amministrativo miceneo che dal XII sec. a.C. introduce il
mondo egeo nei cinque secoli diffusamente definiti “Dark Age” o Medioevo
Ellenico,incise profondamente il sistema dei trasporti e dei commerci
marittimi, provocando naturali conseguenze nell’intero sistema insulare egeo,
primo tra tutti l’arcipelago delle Cicladi (fig. 0).
Con la fine del TE IIIB1 (circa 1250 a.C.) la stabilità che prima aveva
caratterizzato questa parte dell’Egeo viene meno. I Contatti e gli scambi con
la terraferma vengono drasticamente ridotti, come testimonia il forte calo
nelle ceramiche importate, e l’emergere di una ceramica meno standardizzata
e con caratteristiche regionali più marcate.1
Molti insediamenti cicladici inoltre si dotano di apprestamenti difensivi, come
Phylakopi, Ayos Andreas a Siphnos2, Koukounaries a Paros
3 (gli ultimi due
sorti in questo momento proprio con funzione difensiva). Fortificazioni
evidentemente necessarie, anche se a volte inutili, come dimostrano
l’abbandono di Ayios Andreas poco dopo il 1200 a.C. e la distruzione
dell’insediamento di Koukounaries in un incendio devastante che uccise sia gli
uomini che gli animali rifugiatisi all’interno in cerca di protezione. Eventi
questi che quasi certamente indicano attacchi di gruppi ostili e illustrano un
quadro denso di parallelismi con la situazione della Grecia Continentale e la
distruzione dei Palazzi micenei in questo stesso periodo.4
Nonostante il completo crollo del sistema territoriale e amministrativo
miceneo, il TE IIIC con l’inizio del XII secolo a.C. presenta una cultura ancora
micenea nei caratteri, largamente diffusa e ben lontana dalla sorte dei Palazzi
da cui essa era originata, seppur priva di qualsiasi forma di scrittura e di alto
artigianato.5
Preziosi reperti, provenienti soprattutto da sepolture, indicano una sorta di
ripresa e di allargamento dei contatti, sia all’interno che con aree al di fuori 1 BARBER 1987,p.226
2 TELEVANTOU 2001, p.191 3 DEGER-JALKOTZY 1998, p.108 4 TELEVANTOU 2001,p. 210 5 DEGER-JALKOTZY 1998, p.105
3
dell’Egeo6. L’abbandono di numerosi insediamenti della terraferma tra la fine
del XIII e l’inizio del XII sec. a.C. probabilmente portò ad una parziale
rioccupazione da parte di nuovi abitanti di alcuni siti delle Cicladi, un flusso di
persone non facilmente dimostrabile archeologicamente, poiché molti degli
abitati presentano una continuità d’uso col periodo precedente, ma i ricchi
ritrovamenti delle necropoli di Naxos fanno ipotizzare l’arrivo sull’isola di un
nuovo opulento gruppo di persone, con materiali che presentano influenze
dall’Attica orientale, da Creta, dal Dodecaneso e da Cipro.
Nella prima metà dell’XI secolo a.C. la vita nelle Cicladi e nel mondo Egeo in
generale, con l’esclusione di un paio di siti occupati da pochissimi abitanti,
sembra quasi scomparire, ma la cronologia e le cause dell’abbandono degli
insediamenti cicladici sono oscure7.
Ad Ayia Irini per esempio la vita sembra proseguire più a lungo che nelle altre
aree, ma i dati non conferiscono assoluta certezza a tale affermazione,
soprattutto se si tiene conto che l’interruzione dei contatti potrebbe aver
indotto il formarsi di diverse categorie di oggetti, specialmente per quanto
riguarda la ceramica, per noi impossibili da correlare archeologicamente.8
In assenza di segni evidenti di distruzioni, dobbiamo presumere che la
scomparsa degli insediamenti sia da immaginare come un graduale processo
di declino, legato al peggioramento del sistema economico, terminato con il
definitivo abbandono.
Dalla successiva tradizione Greca sappiamo che il “Medioevo Ellenico” fu un
periodo di spostamenti e migrazioni, un processo di transizione alla futura
cultura Ellenica certamente non facile9, in cui gli isolani delle Cicladi furono
certamente coinvolti. Le fasi finali di queste migrazioni, videro nel IX-VIII
secolo a.C. lo stabilirsi di nuovi abitanti e insediamenti in alcune delle Cicladi,
con arrivi in alcuni casi anche precedenti a questo periodo.
A Koukounaries venne costruito un nuovo abitato Geometrico al di sopra delle
rovine di una abitazione di TE IIIC; a Zagora nell’isola di Andros e a Donoussa,
6 DESBOROUGH 1964, p.147 7 BARBER 1987,p.226 8 BARBER 1987, p.227 9 DEGER-JALKOTZY 1998, p.105
4
un’isoletta a sud-est di Naxos, sorsero invece insediamenti del tutto nuovi,
fortificati, elemento che suggerisce un clima ancora difficile e insicuro.10
È tuttavia virtualmente impensabile che tutti i nuovi insediamenti dell’Età del
Ferro rappresentino le prime occupazioni in tali luoghi; è altresì più probabile
che i sopravissuti degli ultimi abitati dell’Età del Bronzo abbiano condotto
un’esistenza precaria in gruppi precari all’interno o nei pressi delle precedenti
dimore, fino alla riedificazione in quei luoghi o in aree totalmente inedite, da
parte dei nuovi arrivati.
A prova di tale ipotesi lo stesso insediamento di Grotta a Naxos, di seguito
preso in esame, dove la continuità d’uso dell’abitato è data per certa anche se
con una visibile discontinuità architettonica che vede le strutture
Protogeometriche collocate al di sopra di quelle Micenee ma con differente
allineamento. Stessa situazione nell’abitato di Koukounaries.
Ad una più attenta analisi dei dati archeologici, dire che la vita nelle Cicladi
sostanzialmente scomparve sull’iniziare del XI secolo a.C. e che la successive
culture dell’Età del Ferro si svilupparono in maniera totalmente indipendente,
senza alcun rilevante debito con il passato, sembra quindi sempre più
un’affermazione di convenienza, destinata ad essere smentita con l’emergere
di nuovi e più approfonditi studi.11
Il sito di Grotta a Naxos
un abitato del TE IIIC
Le prime ricerche archeologiche a Naxos (fig. 1) vennero condotte agli inizi
del XIX secolo da Clon Stephanos, che scavò alcune necropoli dell’ Antico
Elladico in varie parti dell’isola. Scavi successivi vennero eseguiti nel 1992
dall’Istituto Archeologico Germanico sul promontorio di Palati, a nord di
Grotta, portando alla luce reperti del Neolitico e dell’Età del Bronzo.12
Successivamente l’area di Grotta e le sepolture di Aplomata e Kamini
divennero oggetto di scavi sistematici dal 1943 al 1973 sotto la direzione di
10 BARBER 1987, p.245 11 BARBER 1987, p.246 12 COSMOPOULOS 1998, p.128
5
Nikolaos Kondoleon e della Società Archeologica di Atene. La morte di
Kondoleon vide il passaggio del testimone a Vassileios Lambrinoudakis dal
1978 al 1985, sotto la cui direzione nel 1978 emerse il primo insediamento
pertinente ad una fase di TE IIIC, aprendo la strada a indagini scrupolose dei
successivi orizzonti del Tardo Miceneo e del Geometrico.13
Scoperta che
avvenne nonostante i grossi ostacoli costituiti dal costante afflusso dell’acqua
di mare, causa del completo allagamento di un settore dell’insediamento, e dai
depositi sottili e corrotti, nonché dalla pressoché assenza di orizzonti
stratificati.
Grotta è una località situata sulla costa nord di Naxos, in un pianoro che si
estende dall’isoletta di Palati al promontorio di Aplomata, ma l’insediamento
dell’Età del Bronzo occupava anche una parte a sud della collina di Kastro e
una zona a nord ora coperta dal mare (fig. 2).14
Gli scavi hanno rivelato che la zona era abitata nel Neolitico, e
successivamente hanno portato alla luce un insediamento del Bronzo Antico e
del Medio Bronzo.15
Nelle fasi conclusive del Bronzo Finale fiorì poi un
importante centro urbano, con installazioni portuali, apprestamenti difensivi,
un’area di abitato definita, officine organizzate e zone di sepoltura delimitate.
La prima fase di abitazione di Grotta, pertinente al Bronzo Finale, si colloca
nel Tardo Elladico IIA, con ceramica di provenienza micenea e non minoica16,
ma il primo vero insediamento, (definito Town I), appartiene al TE IIIA17 e si
sviluppa con la costruzione di edifici a pianta rettangolare. Già nel TE IIIB1
l’abitato appare tuttavia in declino18, e sembra scomparire nel TE IIIB2 (fig.
3). È questo un periodo caratterizzato da una progressiva desertificazione
dell’insediamento, con solo sporadiche frequentazioni di alcuni ambienti.19
È possibile che questo abbandono sia stato causato da un terremoto e da un
conseguente innalzamento del livello del mare che ricoprì i resti degli edifici
con lo strato sabbioso rinvenuto dagli archeologi.
13 COSMOPOULOS 1998, p. 128 14 COSMOPOULOS 1998, p.128 15
COSMOPOULOS 1998, p. 128 16 COSMOPOULOS 1998, p.134 17 BARBER 1987, p.229 18 DEGER-JALKOTZY 1998, p.109 19 COSMOPOULOS 1998, p. 131
6
Un nuovo insediamento, chiamato Town II, sorse alcuni anni dopo al di sopra
dei resti del precedente abitato ma con differente orientazione, in una fase
che alcuni, ridotti, frammenti ceramici hanno consentito di datare al TE III C
Iniziale. In questo periodo l’abitato doveva essere di dimensioni davvero
ridotte e collocato principalmente sull’isoletta di Palati.20
Nel corso del TE IIIC Medio l’abitato si espande a sud e continua la
frequentazione fino al TE IIIC Tardo, con un uso insediativo che quindi supera
il secolo, spiegando in tal modo l’abbondanza dei rinvenimenti di ceramica
decorata.
Nell’abitato Town II viene abbandonata la tendenza rettangolare nelle piante
degli edifici, tipica della fase precedente, con nuove costruzioni edificate
assieme, con muri adiacenti gli uni agli altri, le aree esterne ai muri
ampiamente utilizzate, e continue aggiunte di spazi ce rendono difficile
distinguere le planimetrie degli edifici.
Piuttosto interessanti sono la grande costruzione megaroide Γ, il complesso
delle case , , , con zona di cottura e apprestamenti per lo storaggio, e i
resti delle costruzioni singole , , a nord-est e nord-ovest (fig. 4).21
Benché il grande edificio megaroide E appartenga alla fase di Town I, nel TE
IIIC viene scavato un bothros per offerte sacrificali lungo il perimetro di uno
dei muri assieme alla messa in opera di un focolare.22
A sud dell’abitato gli scavi hanno messo in luce i resti della parte est di un
muro di fortificazione del TE IIIC (fig. 5) , che doveva racchiudere un gruppo
di spazi dedicati ad attività commerciali, con officine e laboratori ceramici.
Curvando leggermente a nord-ovest, il muro fortificato doveva passare molto
vicino alle case ed è possibile che la sezione rivolta alla costa possa essere
identificata con i resti di costruzione visibili nella parte nord della zona
sommersa dell’abitato.23
Delle indagini archeologiche condotte sotto i livelli di un tempio arcaico
sull’isoletta di Palati hanno portato alla luce pregevoli ceramiche del TE IIIC
che potrebbero essere associate alla pratica di un culto ipetrale, nonostante
20 VLACHOPOULOS 2001,p. 217 21 VLACHOPOULOS 2001, p.218 22 VLACHOPOULOS 2001, p.218 23 LAMBRINOUDAKIS e PHILANIOTOU-HADJIANASTASIOU 2001, p.160
7
alcuni di questi materiali datino al TE IIIC Iniziale, una fase in cui la presenza
umana nell’area era limitata.24
Dall’analisi architettonica possono essere distinte due fasi nell’insediamento
Town II, connesse con l’aggiunta di nuovi spazi e la sostituzione di
pavimentazioni. Studi sulla ceramica hanno comunque dimostrato che non c’è
praticamente alcuna differenza nelle forme e nella decorazione dei recipienti e
che i gruppi ceramici rinvenuti nelle pavimentazioni successive delle case
sono caratterizzate dall’uniformità. Ceramiche dello stesso tipo sono presenti
nei rinvenimenti delle tombe a camera delle necropoli vicine, confermando
una contemporaneità d’uso dell’insediamento e delle zone sepolcrali durante il
TE IIIC Medio e Tardo, un periodo che è stato convenzionalmente definito
“Grotta Phase”.25
L’insediamento di Grotta venne nuovamente abbandonato alla fine del TE IIIC
per motivi che non conosciamo. Non ci sono elementi che facciano supporre
una qualche invasione esterna o un’altra catastrofe naturale come il terremoto
che aveva distrutto Town I, ma la presenza di depositi sabbiosi in alcuni livelli
stratigrafici fa ipotizzare un innalzamento del livello marino con conseguente
inabissamento dell’abitato (fig. 6).
Il periodo del Proto-Geometrico succede immediatamente i livelli di TE IIIC,
confermando l’assenza della fase Sub-Micenea presente in quel momento nel
continente greco, soppiantata nell’isola dalla “Grotta Phase”.
Durante il Proto-Geometrico, l’area di Town II di TE IIIC viene utilizzata come
necropoli, con il caso interessante di una hydria di TE IIIC utilizzata come
segnacolo di una tomba. 26
L’abbondanza di ceramica Geometrica e il rinvenimento di frammenti di Proto-
Geometrica in livelli di TE IIIC sembrano confermare in maniera piuttosto
certa la continuità d’uso di varie porzioni dell’abitato miceneo.
24 VLACHOPOULOS 2001, p. 220 25 VLACHOPOULOS 2001, p.221 26 VLACHOPOULOS 2001, p.221
8
Le sepolture di Aplomata e Kamini
Le tombe a camera di Aplomata e Kamini rappresentano l’unico complesso
sepolcrale completo databile al TE IIIC conosciuto in tutte le Cicladi27. Di tipo
miceneo,le necropoli sono situate sulla zona collinare appena sopra
l’insediamento di Grotta, cui facevano indubbiamente capo nell’antichità.
Aplomata
Le tre tombe di Aplomata (fig. 7) sono tombe a camera scavate nella roccia,
accessibili da piccoli corridoi, con ingressi chiusi da riempimenti di pietrame,
che potevano essere rimossi nel caso si dovessero aggiungere nuovi defunti
alla tomba. I rinvenimenti dalla tomba indicano l’uso del tipico rituale funebre
miceneo in cui il defunto era deposto con la dovuta cerimonia sul pavimento
della tomba. Nel caso in cui una camera non era disponibile per la sepoltura,
se ne sceglieva una già usata, il cui precedente occupante veniva posto su un
lato della stanza,accumulando così ossa e elementi di corredo.28
Benché la ceramica (fig.8-9) sia l’elemento principale del corredo nelle tre
tombe di Aplomata, il defunto era sepolto avvolto in vesti pregiate, adornato di
gioielli, armi e altri oggetti.
Dalla Tomba B provengono 85 rosette auree decorate a sbalzo, probabilmente
elementi decorativi che dovevano essere cuciti sulla veste indossata da uno
dei defunti (fig. 10).29 Altri reperti da Aplomata includono armi in bronzo,
anelli d’oro, collane di perline in pietra, leoni in lamina d’oro (probabilmente
elementi decorativi di un qualche manufatto), un sigillo cilindrico, alcuni
frammenti in avorio, in piombo e di un vaso d’argento. Sono stati ritrovati
anche dei frammenti di ferro, materiale all’epoca molto raro.
Un’area di terra bruciata e frammenti di carbone corrispondente ad alcune
ossa potrebbe essere indizio di una sepoltura ad incinerazione, che
rappresenterebbe un caso eccezionale di un rituale funebre attestato in
27 BARBER 1987, p.235 28 BARBER 1987, p.237 29 BARBER 1987, p.237
9
questo periodo solo da altri due casi in tutto l’Egeo, Eleona a Kos e Perati
nell’Attica Orientale.30
Dallo studio degli elementi di corredo della Tomba A e della Tomba B, gli
archeologi hanno supposto di indicare la Tomba A come maschile (leoni in
lamina d’oro e un pugnale) e la tomba B come femminile (ornamenti del
vestiario), ma è una teoria non ancora accertata.
Tra i reperti ceramici di Aplomata, si riconoscono importazioni da Creta e
dall’Attica Orientale, e alcuni elementi nelle decorazioni suggeriscono
relazioni con il Mediterraneo Orientale, benché la maggior parte della
ceramica appartenga chiaramente alla “Grotta Phase”.31
Kamini32
Le necropoli di Kamini, a mezzo chilometro da Aplomata, comprende tre
tombe a camera scavate nella roccia, una tomba probabilmente dello stesso
tipo, ma che ancora non è stata descritta per intero e una particolare
sepoltura (Tomba E) di un bambino, a fossa, con un lato murato.
La Tomba A ospitava almeno due sepolture, uno dei quali depositato
nell’ultimo periodo di vita della tomba, poco prima dell’abbandono. In questa
tomba vennero alla luce anche tracce di bruciato e ossa animali carbonizzate,
non riconducibili all’attuale disposizione del defunto, ma più probabilmente ad
un qualche rituale funerario.
La Tomba B conteneva i resti di sei sepolture, disposte assieme presso
l’ingresso, e di una settima collocata al centro della camera su di un livello
superiore.
Nella Tomba G era invece deposto un solo defunto. Un’apertura sul lato destro
del dromos di accesso era chiusa da un muretto, contente un vaso, forse in
origine associato alla sepoltura di una bambino.
Oltre ai reperti ceramici (circa 150 a Kamini, con decorazioni sia semplici che
elaborate), i corredi includono armi bronzee, gioielli, anelli e perline d’oro e
d’argento, lamine d’oro (alcune decorate a testa di toro, altre con
30 BARBER 1987, p.238 31 VLACHOPOULOS 2001, p. 221 32 BARBER 1987, p.238
10
rappresentazioni di bambini applicate), alcuni sigilli e perline in pietre semi-
preziose. Particolarmente interessante un pugnale o coltello in ferro e alcune
lunghe fibule bronzee di un tipo diffuso sulla terraferma alla fine del Bronzo e
agli inizi del Ferro.
All’esterno della tomba sono stati ritrovati quattro vasi decorati con scene di
danzatori, probabilmente da associare al rito funerario (fig. 11).33
Ad una analisi complessiva delle due necropoli di Aplomata e Kamini, la
distanza tra le tombe, che sembrano essere disposte a settori, piuttosto che in
maniera uniforme, cancella l’ipotesi che tali aree siano da considerare come
un singolo esteso cimitero, confermando invece la più plausibile teoria di
sepolture appartenenti a clan e in tal senso suddivise.34
Come si evince dallo studio dei corredi, non sono infatti presenti sepolture
povere ad inumazione o sepolture prive di corredo; tutti i defunti sono
accompagnati da ricche offerte funerarie quali ceramiche dipinte, armi,
gioielli, sigilli, attrezzi. Nove sepolture contenevano circa 330 vasi, tutti
databili alla “Grotta Phase” (fig. 12-13).
La ricchezza dei corredi, associata e supportata dal simbolismo rituale e
regale del leone dorato della testa di toro, ha fatto ipotizzare che i proprietari
di queste tombe potessero essere dei signori micenei rifugiatisi sull’isola.35
Le sepolture di Aplomata sembrano essere le più antiche, con la principale
fase collocabile nel TE IIIC Medio sviluppato e TE IIIC Medio avanzato,
mentre Kamini si sovrappone nel TE IIIC Medio avanzato con utilizzo fino al
TE IIIC Tardo.36
33 BARBER 1987, p.238 34 VLACHOPOULOS 2001, p. 221 35 BARBER 1987, p.238 36 VLACHOPOULOS 2001, p.221
11
La Ceramica della “Grotta Phase”
Dal sito di Grotta provengono 36 forme ceramiche differenti, pertinenti al TE
IIIC, 26 delle quali rinvenute anche nelle aree sepolcrali. Unica forma non
attestata nell’abitato è quella di una vaso zoomorfo modellato a rappresentare
un’anatra.37
La forma più attestata dalle tombe è l’anforetta a staffa (FS 175),
rappresentante il 27% della ceramica; il 60 % di tali anforette provenienti da
Kamini sono dipinte nell’ Octopus Style, la più alta percentuale a noi nota in
tutto l’Egeo in questa fase (fig.14).38
L’identificazione delle mani di almeno cinque diversi pittori ceramici ha
permesso di capire il repertorio iconografico del tempo e di creare criteri
stilistici per una cronologia relativa a supporto di quella assoluta in casi ove i
dati stratigrafici non permettano di arrivare a tale traguardo.
Sono stati individuati anche ceramiche importate di pittori riconosciuti
provenienti da Perati e dalla Creta orientale, permettendo agli studiosi di
inserire Naxos nel circuito di scambi con due dei centri principali per la
produzione di anforette a staffa in Octopus style.39
Tra i materiali ceramici, sono presenti anche anforette a staffa in Close Style
e Linear Style importate da Creta (fig. 15), Attica, Argolide, Laconia e altre
officine non identificate.
Le anforette a staffa provenienti dall’insediamento sono in quantità inferiori
rispetto a quelle rinvenute nelle necropoli e sono generalmente di piccole e
medie dimensioni, solitamente decorate in Linear e Octopus Style.
La seconda forma ceramica più diffusa a Naxos è la strainer-Hydria (FS 157) ,
con serpenti ctoni raffigurati sulla spalla del vaso (fig. 16), rinvenuti sia
nell’insediamento che nelle necropoli, dove due esemplari presentano
interessanti scene di attività sociali, in particolare una danza circolare di
uomini e un gruppo di pescatori nell’atto di ritrarre la rete.40
37 VLACHOPOULOS 2001, p.223 38 VLACHOPOULOS 2001, p.223 39 VLACHOPOULOS 2001, p.223 40 HADJIANASTASIOU 1996, p. 1435
12
Nell’abitato la forma principale è lo skyphos (FS 284-285), caratterizzato nei
suoi numerosi esempi da uniformità nella fabbricazione e nelle dimensioni, e
da una decorazione che nella quasi totalità dei casi è monocromatica, molto
raramente a fasce dipinte o completamente priva di pittura (fig. 17).
Un piccolo gruppo di skyphoi, detto Gruppo A, è decorato da triglifi, metope,
spirali e un caratteristico stile contornato di ispirazione minoica. Questi
esemplari sono datati principalmente al TE IIIC Medio e scompaiono nel TE
IIIC Tardo.
Altra forma piuttosto diffusa nell’insediamento è la tazza monoansata (FS
242), sostanzialmente priva di particolari dettagli nella forma (fig. 18-19) e
nella decorazione, che a Naxos va a sostituire le kylikes (FS 267), qui poco
frequenti e prive di decorazione.
I Crateri (FS 282) sono poco attestati nelle sepolture, ma frequenti
nell’abitato; di medie e grandi dimensioni, hanno un piede ad anello e
decorazioni sostanzialmente dello stesso tipo del Gruppo A di skyphoi, ma con
motivi più complessi, che comprendono triglifi, tratti a scacchiera, a spina di
pesce, festoni, semicerchi monocromatici, fasce ondulate, e una grande
varietà di losanghe e soggetti pittorici (fig. 20-21).
Lo stile pittorico comprende figure maschili realizzate sia a contorno che a
pittura monocromatica.
Ci sono esempi di cavalieri e uomini in processione, presenti anche in un
frammento proveniente dalla località di Yria41, e un grande cratere, detto
“Cratere Grotta” (fig. 22), ritrovato in una officina ceramica nella zona sud
dell’abitato, raffigura un uomo in piedi sul dorso di un cavallo, tutti motivi
all’epoca molto frequenti e diffusi in numerosi centri dell’Egeo e della Grecia
Continentale e specchio dell’interesse per le scene narrative di vita
quotidiana, di caccia, di navigazione, duello, guerra, compianto funebre.42
Altre forme ceramiche attestate nel sito di Grotta sono le anfore a due e tre
anse, comuni nelle tombe, ma non nell’abitato, le tazze a beccuccio, i kalathoi,
le fiaschette e i vasi per contenere l’acqua , quali hydriai, lekythoi, anfore;
41 SIMANTONI-BOURNIA 2000, p.211 42 VLACHOPOULOS 2001, p.225
13
nell’insediamento sono presenti anche una grande varietà di pithoi e tripodi
da cottura.43
La caratteristica principale della ceramica dipinta di Naxos è l’appartenenza
alla forte tradizione cicladica del naturalismo pittorico che si esprime
attraverso un repertorio di figure umane, polipi, pesci, uccelli e motivi floreali.
I pesci, elemento decorativo tra i più caratteristici, rappresentati da soli o con
altri motivi, e gli uccelli, derivanti da una generica tipologia iconografica che
rende le figure anatomiche attraverso semplici linee di contorno, sono i più
comuni elementi pittorici che vengono realizzati tra i tentacoli dell’Octopus
Style nelle anforette a staffa (fig. 23), ma appaiono anche su crateri, skyphoi,
kalathoi, tazze.
Altri soggetti pittorici sono il cervo, il cavallo, quadrupedi immaginari, la
medusa, la stella marina, le rosette a molteplici petali, le palme, le canne e
altri motivi floreali.
Motivi che invece paiono in contrasto con questi stili naturalistici, vedono la
rappresentazione di solidi semicerchi contornati, rombi, triangoli elaborati,
archi concentrici con riempimenti ad occhio, spirali e linguette antitetiche.44
Sincronismi e Diacronismi
Quasi totalmente assente nel resto delle Cicladi, tranne che per alcuni vasi e
frammenti provenienti da Keos, Melos, Kimolos e Thera, La “Grotta Phase” di
Naxos da un lato rappresenta il carattere indipendente della produzione
locale, dall’altro lascia intravedere delle somiglianze con la ceramica di altre
officine dell’area egea, con forme ceramiche simili alle fasi 2a, 2b e 3 di
Lefkandi, uno stile iconografico aperto a influenze dall’Argolide e dall’Attica,
ed un Linear Style molto singolare per la presenza di elementi del Close
Style.45
43 VLACHOPOULOS 2001, p.228 44 VLACHOPOULOS 2001, p. 228-229 45 VLACHOPOULOS 2001, p.229
14
Affinità sono presenti anche con la ceramica del TM IIIC di Creta centrale e
orientale, che ha influenzato in maniera più pesante di quanto non si credesse
soprattutto la produzione di anforette a staffa in Octopus Style.
Quasi inesistenti, almeno per l’attuale situazione degli scavi, sembrano essere
invece i contatti con le isole del Dodecaneso.46
Complessivamente, le Cicladi non presentano un quadro uniforme tra le varie
isole durante il TE IIIC e nella ceramica sembra non solo mancare un qualsiasi
sincronismo cronologico o stilistico, ma si denotano diverse sfere d’influenza
su ciascuna isola.
Questa situazione post-palaziale, riscontrabile tanto nelle Cicladi quanto nel
Dodecaneso, rende evidenti le difficoltà nel formulare un quadro generale
uniforme del periodo nell’egeo.
Benché non ci siano prove di un significativo e simultaneo aumento della
popolazione nell’intero Egeo come conseguenza di movimenti migratori di
popolazioni provenienti dal continente Greco, risulta chiaro come ogni isola
abbia seguito il proprio percorso, dettato solo dalle condizioni storiche locali,
ognuna con il proprio momento di prosperità nel corso del TE IIIC.
La mancanza di prove che supportino l’idea di contemporanee e violente
distruzioni negli insediamenti cicladici, con l’eccezione dell’abitato di
Koukounaries, è invece una forte base per ritenere il TE IIIC nell’Egeo come
un periodo di pace, privo di una comune minaccia esterna.
Il TE IIIC durò per almeno 120-160 anni, periodo in cui molti fenomeni ed
eventi storici non connessi tra loro ebbero certamente luogo, in un’area
insulare piuttosto espansa dove il commercio e la navigazione continuarono ad
esistere vigorosamente.47
La posizione privilegiata di Naxos lungo la maggiore via di navigazione
dell’Egeo e la sua tradizionale autosufficienza crearono e mantennero una
densa rete di contatti con aree fiorenti del continente greco e di Creta,
attraverso i quali nuove idee e, forse, nuovi abitanti raggiunsero l’isola.48
46 VLACHOPOULOS 2001, p.230 47 VLACHOPOULOS 2001, p.231 48 DESBOROUGH 1972, p.221
15
BIBLIOGRAFIA
BARBER 1987 = BARBER R.L.N., The Cyclades in the Bronze Age, Londra 1987.
COSMOPOULOS 1998 = COSMOPOULOS M.B., Reconstructing Cycladic Prehistory:
Naxos in the Early and Middle Late Bronze Age, in OJA 17, pp. 127-148.
DEGER-JALKOTZY 1998 = DEGER-JALKOTZY S., The Aegean Islands and the
Breakdown of the Mycenaean Palaces around 1200 B.C., in KARAGEORGHIS-
STAMPOLIDIS 1998, pp. 105-119.
DESBOROUGH 1964 = DESBOROUGH V.R.d’A., The Last Mycenaeans and their
Successors, Oxford 1964.
DESBOROUGH 1972 = DESBOROUGH V.R.d’A., The Greek Dark Ages, Londra 1972.
HADJIANASTASIOU 1996 = HADJIANASTASIOU O., A Mycenaean Pictorial Vases from
Naxos, in MIRO-GODART-SACCONI 1996, pp. 1433-1441.
KARAGEORGHIS-STAMPOLIDIS 1998 = KARAGEORGHIS V. - STAMPOLIDIS N.,
Proceedings of the International Symposium “Eastern Mediterranean. Cyprus-
Dodecanese-Crete 16°-6° cent. B.C.”, Atene 1998.
KARAGEORGHIS-MORRIS 2001 = KARAGEORGHIS V. – MORRIS C., Defensive
Settlements of the Aegean and the Eastern Mediterranean after c. 1200 B.C., Nicosia
2001.
16
LAMBRINOUDAKIS e PHILANIOTOU-HADJIANASTASIOU 2001 = LAMBRINOUDAKIS V.
e PHILANIOTOU-HADJIANASTASIOU O., The Town of Naxos at the End of the Late
Bronze Age: the Mycenaean Fortification Wall, in KARAGEORGHIS-MORRIS 2001, pp.
157-169.
MIRO-GODART-SACCONI 1996 = MIRO E. de. – GODART L. – SACCONI A., Atti e
Memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia, Roma 1996.
OJA 17 = Oxford Journal of Archaeology , 17, Londra 1998.
SIMANTONI-BOURNIA 2000 = SIMANTONI-BOURNIA E., Les premières phases du
sanctuaire d’Hyria d’après les objets retrouvés, RA 2000, pp. 209-219.
TELEVANTOU 2001 = TELEVANTOU C. A., Ayios Andreas on Sifnos: a Late Cycladic III
Fortified Acropolis, in KARAGEORGHIS-MORRIS 2001, pp. 191-213.
VLACHOPOULOS 2001 = VLACHOPOULOS A., The Late Helladic III C “Grotta Phase” of
Naxos. It’s synchronism in the Aegean and It’s non-synchronism in the Cyclades., in
LH III C Chronology and synchronism. Proceedings of the International Workshop
held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, May 7 and 8,2001. Vienna 2006,
pp. 217-234
Un insediamento del TE III C nelle Cicladi:
l’abitato di Grotta e le sepolture di Aplomata e Kamini a Naxos
Apparato Iconografico
Thomas Milan
Fig. 1 – Pianta di Naxos con evidenziata la posizione del
sito di Grotta. (da COSMOPOULOS 1998,
p.129)
Fig. 3 – Pianta generale degli edifici del TE IIIA1-IIIB1 a Grotta. L’area cerchiata indica
la possibile estensione nel TC II. ( da COSMOPOULOS 1998, p. 131)
Fig. 4 – Pianta dell’area scavata di Grotta con le fasi architettoniche di Town I e Town II (da VLACHOPOULOS 2001, p. 219).
Fig. 5 – Pianta con le strutture murarie della zona sud dell’abitato di Grotta ( da LAMBRINOUDAKIS e
PHILANIOTOU-HADJIANASTASIOU 2001, p. 161)
Fig. 10 – rosette auree (1-3) anello in bronzo (4), spada in bronzo (5) e anforetta a staffa in Octopus Style (6) dalle tombe di
Aplomata. (da BARBER 1987, p.237)
Fig. 15 – Anforetta a staffa in Close Style, importata da Creta. Rinvenuta a Kamini. (da VLACHOPOULOS 2001,
p. 224)
Fig. 16 – Strainer-Hydria del TE IIIC da Naxos con serpenti applicati sulla spalla. (da DESBOROUGH 1964,
PLATE 7, fig. d).
Fig. 19 – Frammenti di tazza con decorazioni in Linear e Close Style, da
Grotta. (da VLACHOPOULOS 2001,
p.228)
Fig. 20 – Frammenti di crateri da Grotta con
decorazioni in stile Linear, Close e Pittorico. (da
VLACHOPOULOS 2001, p.226)