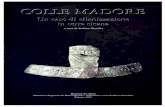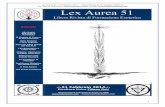Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell'attribuzione ad Herakleia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell'attribuzione ad Herakleia
1
l’obiettivo che questo studio si pone è chiarire e distinguere, sulla base di ele-menti tecnici, iconografici e stilistici, l’attribuzione delle emissioni caratterizzatedal volto di atena al dritto e eracle inginocchiato nell’atto di strozzare il leoneNemeo al rovescio.
Prima di un esame diretto su esemplari noti è fondamentale considerare le pub-blicazioni che nell’ultimo secolo hanno trattato più o meno integralmente l’argo-mento in questione.
Oscar e. Ravel, nella compilazione della collezione vlasto, inserì in una piccolanota1 una probabile attribuzione degli esemplari 1303-1308 alla zecca di Herakleia,alcuni dei quali caratterizzati da un etnico ben distinguibile, altri invece di incertalettura, forse sulla base di alcune note relative al luogo di ritrovamento lasciate daMichel Pandèly vlasto.
Quest’ultimo particolare non è determinante, considerando che esemplari di Ta-rentum ed Herakleia sono stati individuati insieme e in quantità all’interno di ritro-vamenti del sud italia.
È probabile quindi che, nell’impossibilità di esaminare etnico, simboli e sigle, icompilatori dell’opera sopracitata si siano basati su aspetti tecnici e stilistici in gradodi suggerire una soluzione piuttosto che un’altra.
Un ottimo contributo lo diede laura Breglia, pubblicando lo studio di due cospi-cui rinvenimenti2 custoditi al Museo di Taranto e ritrovati fortuitamente, il secondodei quali rinvenuto in prossimità dei resti delle mura dell’antica città di valesio,presso Torchiarolo, in provincia di Brindisi.
SU UN gRUPPO Di DiOBOli Di PieDe TaRaNTiNO:
CHiaReZZa Nell’aTTiBUZiONe aD HeRaKleiaMaRCO MigliOli e alBeRTO CaMPaNa
1 Ravel 1947, p. 139.2 BReglia 1942.
Marco Miglioli e Alberto Campana
2
Tale tesoro conteneva ben 1849 monete argentee tra didrammi e divisionali ap-partenenti a 23 zecche tra italiche e greche.
la Breglia, nello studio di suddetti frazionali, ebbe la possibilità di vedere nu-merosi pezzi appartenenti alle due zecche in questione, analizzandoli anche dal puntodi vista “tecnico”:
“Le due serie parallele di emissioni che, almeno in Taranto, continuano fino allaseconda metà del III secolo, hanno dunque gli stessi tipi non solo, ma si somiglianotanto da far pensare che, nonostante la diversità della iscrizione, esse potessero es-sere coniate materialmente in una unica zecca. In realtà però delle differenze, perquanto lievi, esistono tra le due serie e sono tali da aiutarci ad attribuire ad unacittà piuttosto che all’altra gli esemplari battuti con coni anepigrafi o quelli in cuila legenda per imprecisa coniazione è uscita fuori dal campo del tondello.
Gli esemplari di Taranto risultano piatti e sottili così da apparire spesso legger-mente scodellati, con l’impronta della testa divina sulla faccia convessa, quelli diEraclea al contrario sono più spessi, di una forma quasi lenticolare e questo nonsolo per i dioboli col gruppo di Eracle, ma anche per gli altri anteriori. La differenzanaturalmente è lievissima e percepibile soprattutto al tatto, mentre una differenzaaltrettanto lieve mi parrebbe di dover notare tra gli esemplari che esamino, nellalega diversa dell’argento.
La conservazione generalmente buona del tesoretto permette anche un confrontostilistico tra le serie delle due città, cui non nuoce molto la grande minutezza deiconi, accuratissimi nella loro piccolezza.
Dal confronto risulterebbe che nei coni tarantini il modellato è in genere piùsecco, con una decisa tendenza alla rappresentazione dei corpi agili e snelli e allavalorizzazione delle masse muscolari, ritratte nella contrazione o nella tensionedella lotta; nei coni di Eraclea avremmo invece figure più ricche di valori plastici,corpi più pesanti e robusti in cui l’efficacia del modellato non è però danneggiatadalla minore agilità e magrezza.”
le parole della Breglia sembrano evidenziare una certa sicurezza nel distinguerecaratteristiche tecniche e stilistiche relative alle zecche di Tarentum ed Herakleia eallo stesso tempo contraddicono il suo pensiero riportato nelle primissime righe, dacui si evince la somiglianza tra le emissioni delle due poleis, tale da poter ipotizzareuna stessa officina produttiva.
Frances van Keuren3 individua i frazionali di Herakleia di questa tipologia, in un
3 vaN KeUReN 1994.
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
3
arco temporale che va dal 433 al 330 a.C., quindi immediatamente successivo allafondazione della città lucana.
Tali datazioni sono riproposte con sensibili variazioni da N.K. Rutter 4, dove ilgruppo “a” della van Keuren è inserito e datato 432-420 a.C. mentre tutti gli altricon queste caratteristiche sono identificati in un unico grande gruppo datato 433-330 a.C.
la van Keuren propone nel gruppo a (433-400 a.C.) una serie di frazionali, ca-ratterizzati dall’etnico “He”, considerando per essi una datazione di fine v secolo.
l’ipotesi deriverebbe dalla grande importanza identificativa di tale sigla, che rap-presenterebbe un simbolo etnico identificativo, quasi a “pubblicizzare” la nuovaidentità etnica venutasi a formare con la fondazione della città.
la conferma, sarebbe la presenza della sigla He in crateri dell’artista amykos5,che operò in lucania proprio alla fine del v sec. a.C.
Di questo primo periodo, identificato con il gruppo a, fanno parte solo gli esem-plari n. 38 e n. 40 caratterizzati al rovescio da eracle inginocchiato, dove la sigla“He” è situata al rovescio, sopra il leone Nemeo.
in realtà il quadro risulta complesso e malgrado si possa solo ipotizzare la pro-duzione già dal v secolo, diventa difficile, sulla base di ipotesi e riferimenti stilistici,individuare, anche solo indicativamente, archi di tempo attendibili.
Nel gruppo C, la van Keuren inserisce tutte le restanti emissioni di frazionali ti-picamente appartenenti al iv secolo a.C., caratterizzate da atena al dritto ed eracleinginocchiato nell’atto di strozzare il leone Nemeo, tralasciando però una serie diemissioni molto significative per poter ipotizzare una cronologia o comunque unasequenza produttiva.
Nella brevissima serie di dioboli ipotizzati come appartenenti alla fine del v se-colo a.C., accomunati dalla sigla He è possibile notare una rappresentazione delvolto di atena, ancora influenzata da tratti di stile severo o comunque non ancoracongrui agli stili di pieno iv secolo, considerati tra i più riusciti e maturi dell’areamagno greca.
Un arco di tempo più tardo e ridotto venne proposto da Ravel, che considerò que-sta particolarissima emissione e i dioboli sopracitati, datandoli tra il 380 e il 334a.C. (Ravel considerò però solo le emissioni tarantine della collezione vlasto, nellaquale erano inseriti esemplari di Herakleia).
alla luce di studi più recenti e in base alle datazioni dei ripostigli, la determina-zione dell’effettiva partenza di produzione di questi frazionali argentei si è legger-
4 RUTTeR 2001, p. 125-1265 vaN KeUReN 1994, p. 24.
Marco Miglioli e Alberto Campana
4
mente abbassata, in riferimento anche alle prime apparizioni di eracle in lotta cometipo monetale in Sicilia e Magna grecia.
È ormai un dato di fatto che in occidente, i primi tipi monetali recanti questascena mitologica si riferiscano agli esemplari aurei da cento litre firmati da Kimoned Evainetos probabilmente di età Dionigiana e comunque posteriori alla spedizioneateniese del 413/412 a.C. e prossimi alla fine del v sec. a.C.
Secondo Renata Cantilena 6, il tiranno avrebbe scelto questa rappresentazione mi-tologica per le emissione auree, destinate al pagamento dei mercenari, evidenziandola lotta tra greci e barbari e immedesimandosi nell’eroe mitologico come difensoredella grecità e vincitore contro i Cartaginesi. la Cantilena inserisce cronologica-mente questa emissione intorno al 404 a.C., una datazione in perfetta coerenza conla successiva espansione a macchia d’olio della figura di eracle in lotta con leonein buona parte dell’area italica.
le prime emissioni monetali della zecca di Herakleia vengono così collocate damolti studiosi allo scadere del v sec. a.C. e all’alba del iv sec. a.C.
la produzione di nomos sembrerebbe essere la prova dell’accordo tra le città diThurium, che sarebbe stata la prima a coniare monete con immagine di atena in am-biente italico, e Tarentum, dove eracle godeva di grande venerazione.
Un’altra ipotesi vede l’origine del mito di eracle da Crotone, il cui attacco adopera di Dionisio i di Siracusa, intorno al 389-387 a.C., avrebbe spianato la stradaad Herakleia per diventare la nuova sede della lega italiota intorno al 374 a.C., sottola guida di Taranto.
in base a queste considerazioni, viene avvalorata la tesi di Ravel, che individuacome inizio della produzione di dioboli caratterizzati da questi tipi intorno al 380a.C.
in molti considerano la produzione di dioboli di Herakleia e Tarentum comeun’emissione federale delle due città al tempo di archita, nel periodo in cui questeerano rispettivamente sede e capo della lega italiota, nonostante si tratti di un’ipotesinon provata. Certo è che l’adozione del tipo monetale rappresentante eracle chestrozza il leone, assunse grande valenza in buona parte della Magna grecia (di pre-valente influenza ionica) ritrovando alcune eccezioni in ambiente sannitico o indi-geno, dove con buona probabilità tale culto venne assorbito e trasmesso in brevetempo.
il quadro temporale diventa quindi piuttosto incerto, senza riscontri scientifica-mente provabili o raffronti con emissioni assimilabili in altre zecche e già sufficien-temente studiate e temporalmente collocate.
6 CaNTileNa 2004.
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
5
a favore dell’ipotesi che vede il fiorire della produzione della zecca lucana dopoil v secolo, sono i rinvenimenti monetali di tutta l’area lucana e in particolar mododell’arco ionico, che testimoniano la presenza di frazionali di Herakleia solo dal-l’inizio del iv secolo a.C.
Colpisce l’assenza di tali nominali in rinvenimenti attribuibili al v secolo, parti-colare che avvalora la tesi trattata in precedenza e la circolazione di tali emissioni apartire dal iv secolo a.C.
a partire da questo periodo, sono infatti frequenti i frazionali lucani contenuti intesoretti pubblicati, appartenenti all’area lucana e gravitanti in ambiente ionico.
la serie di emissioni lucane caratterizzate al rovescio da eracle inginocchiato osu un unico ginocchio e comunemente confusa e similare alla monetazione Tarantinapuò essere riassunta nelle seguenti Tavole.
Marco Miglioli e Alberto Campana
10
Se si osservano attentamente queste emissioni, emerge una serie di caratteristichedi grande importanza.
l’ornamento dell’elmo attico di atena è sempre rappresentato dall’ippocampoalato, di pregevole fattezza, ma più schematico e dall’andamento pressoché invariato,se non in un’ultima e rara emissione di transizione tra i tipi a figura in ginocchio equelli a figura stante, dove fa la comparsa il mostro marino Scilla sull’elmo di atena,che mantiene i tipici tratti di Herakleia.
Ulteriore dato caratterizzante è il tondello generalmente più spesso e con unaconfigurazione quasi perfettamente circolare, giustificando il flan ristretto al limitedelle figure, nonostante l’accuratezza della centratura nella fase di conio.
Questo dimostra, almeno per queste emissioni, una maggior cura nella fase ultimadi battitura che avrà portato un’azione più lenta e quindi un maggior tempo per ognisingola battitura. le primissime emissioni caratterizzate dalla sigla He ed alcuneapparentemente anepigrafi e posizionate all’inizio della produzione per questi tipi,risultano piacevoli, dalle linee tondeggianti e dallo stile classico, ma non rispec-chiano le proporzioni delle reali figure, con una rappresentazione di eracle partico-larmente giovanile, quasi infantile, (come a simboleggiare una Polis giovane, ma inforte crescita) e del leone con dimensioni piuttosto ridotte (Tavola 1, n.1-2).
Ne deriva una serie di emissioni coeve e dai canoni maggiormente consoni al ivsecolo a.C., con figure ancora fuori proporzione ma accomunate da una piacevoleridondanza delle linee classiche, con muscolature tozze e grande geometria nella fi-gura complessiva.
l’etnico è forse ancora una volta He, mentre una rara emissione presenta Φ aldritto e eY al rovescio tra le gambe di eracle (Tavola 1, n.3-4).
Sono con buona probabilità più tardi gli esemplari caratterizzati da eracle piùsnello e proporzionato, dall’aspetto meno piacevole e la capigliatura in movimento(Tavola 1, n.5).
Sono ipotesi e ragionamenti basati sull’esclusivo accostamento iconografico diesemplari analoghi e dello stesso periodo, come dimostra il paragone con un’altraemissione di grande bellezza e innovazione per l’area magno-greca, un nominaleaureo siracusano
Si tratta dei pregevolissimi esemplari caratterizzati dal volto di eracle a ¾, orien-tativamente collocabili in un periodo di maturità della zecca lucana.
Questi ultimi sicuramente ispirati agli esemplari aurei da 100 litre emessi in Si-cilia tra il v e il iv secolo a.C., di stile notevole, caratterizzati dal culto e dalla rap-presentazione di eracle, poi assorbiti dalla gran parte del territorio magno greco edi conseguenza da Herakleia e Tarentum che al culto di eracle erano particolarmentelegate.
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
11
Questi esemplari da 100 litre sono normalmente databili tra il 405 e il 400 a.C.,emessi a Siracusa sotto il dominio del tiranno Dionisio i e rappresentanti al rovescioeracle con testa a ¾ nell’atto di strangolare il leone Nemeo (Fig. 1).
Dagli esemplari Siracusani alle emissioni magno greche, il passo fu breve e, nelgiro di pochi anni, la zecca lucana cominciò a rappresentare il volto di eracle a ¾,raggiungendo una definizione e uno stile di difficile imitazione, concentrando inpochi millimetri pregevoli volti dotati di minuziosi dettagli e originali acconciature.
la prima emissione, con queste caratteristiche e non inserita dalla van Keurennella sua monografia, fu con buona probabilità quella identificata ancora una voltadall’etnico HE (Tavola 1, n. 6).
gli esemplari rappresentati in Tavola 1, n. 5 e 6, consentono di apprezzare le con-gruenze comuni, quasi a dimostrare un breve passo tra le due emissioni, dove l’interafigura di rovescio pare cambiare solo per la rotazione del volto di eracle, mentre aldritto, il volto di atena si avvicina ai canoni della metà del iv secolo a.C.
a queste emissioni appartiene una serie di esemplari, forse realizzati più tardi daun artista di grande spessore, capace di rappresentare con molta plasticità tutta lascena al rovescio, dove l’etnico EP sostituisce HE (Tavola 2, n. 7)
Un’altra variante di grande qualità, con buona probabilità coeva a queste ultimeserie, è completamente anepigrafe, molto spesso erroneamente attribuita a Tarentum,ma tecnicamente e stilisticamente riferibile alla zecca lucana.
in questo caso la testa di eracle, sproporzionata rispetto al resto del corpo è rap-presentata quasi frontalmente nell’atto di lotta (Tavola 2, n. 8).
essi rappresentano un periodo più preciso e maturo dal punto di vista stilistico,aventi al rovescio una definizione nel volto di eracle pregevolissima.
Di questa emissione, non riportata dalla van Keuren, a oggi sembra noto un soloaccoppiamento di conio.
Fig. 1: Siracusa, AV, 100 litre, circa 405-400 a.C., 5,77 g, (NAC 27, 12.05.2004, lotto 119)
Marco Miglioli e Alberto Campana
12
esiste poi un’altra variante dove è rappresentato eracle con volto di ¾, molto si-mile all’esemplare rappresentato in Tavola 2, n.7, ma caratterizzato dalla sigla HPsopra il leone Nemeo (Tavola 2, n.9).
Più difficile è ipotizzare la collocazione temporale di tre serie apparentementemolto simili e figurativamente molto vicine all’esemplare rappresentato in Tavola1, n.5, ma con etnici diversi, rispettivamente HP, HI ed EP (Tavola 2, n.10-11-12).
Si tratta di emissioni potenzialmente collocabili tra la prima metà e la metà deliv secolo a.C. nonostante sia difficile individuarne la posizione in relazione ad altriconi simili.
Proseguendo, ritroviamo gli esemplari aventi etnico completo HPAKΛEIΩN insenso orario con clava sotto o con etnico HPAKΛEIΩN retrogrado, entrambi di pre-gevole fattura, dove la circolarità complessiva delle figure identifica ancora unavolta la caratteristica della zecca lucana (Tavola 3, n.13-14).
gli esemplari rappresentati in Tavola 3, n.15 e 16 ed aventi rispettivamente etnicoHPA in senso orario e retrogrado, sembrano rappresentare un periodo nuovo, semprepiù vicino ai canoni Tarantini, ma ancora molto coerenti alla globularità rappresen-tativa di Herakleia.
le linee rappresentative sia al dritto che al rovescio cambiano sensibilmente, pre-sentando proporzioni più umane e veritiere.
Caratteristiche ancora più rilevabili negli esemplari in Tavola 3, n.18 e Tavola 4,n.19 dove l’etnico EY-HPA rispettivamente in senso orario e retrogrado, fa da cornicea figure sempre più snelle e proporzionate.
Chiudono lo schema delle ultime emissioni di questo tipo ad eracle inginocchiato,gli esemplari rappresentati in Tavola 4, n.20-24, caratterizzati dall’eroe figlio di Zeusnell’atto di strozzare il leone Nemeo con il braccio sinistro, mentre tiene con la manodestra la clava verso il basso, prima di sferrare il colpo mortale.
È evidente che gli stili sono ormai lontani da quelli caratterizzanti le primissimeemissioni ad etnico HE, facendo parte, con buona probabilità, di una produzione piùvicina alla seconda metà del iv sec. a.C. le proporzioni sono curate e la muscolaturarimane possente e meno contratta rispetto agli esemplari emessi dall’officina taran-tina.
il volto di atena sebbene realistico e gentile continua a presentare elementi tipicidella zecca lucana, come il profilo dell’occhio, che risulta “vitreo” e poco prospet-tico.
Caratteristica parzialmente risolta nell’ultimo esemplare in Tavola 4, n.24, doveoltre alla rappresentazione degli occhi, compare per la prima volta Scilla a coronarel’elmo di atena.
Quello che (nell’arco di tempo ipotizzato dalla van Keuren, 433-330 a.C. più ve-
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
13
rosimilmente 380-345 a.C.), nella scuola incisoria lucana rimane invariato è la rap-presentazione sinuosa nel complesso e un andamento dei soggetti che nulla lasciaal caso e che riempie la totalità degli spazi dei tondelli regolarissimi e quasi perfet-tamente circolari.
la collaborazione tra gli artisti ideatori e incisori e chi batteva materialmente iconi, pare in questi esemplari quasi simbiotica, producendo un risultato complessi-vamente piacevole e completo (Fig. 2).
Herakleia: Coni di dritto
i primi esemplari di questa emissione, risultano artisticamente piacevoli nellaloro plasticità e nelle curve irreali che riempiono il flan con molta cura, realizzandocon semplicità un aspetto simbiotico tra arte incisoria e tecnica di coniazione.
la testa di atena, nel complesso è ben realizzata e l’andamento della cresta del-l’elmo attico sembra individuare un cerchio, nel quale è possibile inscrivere tutti idettagli pronunciati del volto, dal naso al mento, fino alla base del collo, come visi-bile nello schema seguente.
Fig. 2: Herakleia, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,17 g, (NAC 27, 12.05.2004, lotto 18)
Marco Miglioli e Alberto Campana
14
il risultato è una figura piena, gradevole, che non rispetta un profilo reale e de-natura la realtà delle forme, allungando la testa per poter raggiungere questo risultato.(Fig. 3, n.1-2-3)
l’ippocampo alato è schematico e poco dettagliato, ma nel complesso ben rea-lizzato e in continua evoluzione morfologica.
avvicinandosi alla metà del iv sec. a.C., alcuni di questi aspetti vengono meno,lasciando il posto a un tratto più attento ai valori reali. (Fig. 3, n. 4-5-6).
in questi casi il confronto tra le due zecche è più difficile, riducendosi il marginestilistico precedentemente descritto.
Ciò nonostante, l’interno dell’occhio appare costantemente meno curato e privodi vitalità, ad eccezione di alcuni esemplari di grande qualità che comunque nonraggiungono l’alto grado di precisione ottenuto dagli incisori calabri.
la rappresentazione e la finitura dell’occhio di profilo risulta “vitrea e tiroidea”e ben lontana dalla profondità tipica che contraddistingue le emissioni di Taranto.
la capigliatura che fuoriesce dal paranuca dell’elmo attico è normalmente rac-colta e contribuisce a riempire l’ipotetico cerchio di inscrizione rendendo più pia-cevole la rappresentazione. le labbra carnose e pronunciate, evidenziano ancora una
Fig. 3: Schema coni di dritto Herakleia
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
15
volta plasticità e curve nel modellato, che si affinano e assumono canoni reali negliesemplari più tardi.
Quindi risulta riconoscibile la mano di incisori lucani e nonostante un avvicina-mento alla fisionomia reale dei volti, questi caratterizzano le figure con maggiorschematicità e minor cura dei dettagli minuti.
Capelli, pendenti e ornamenti dell’elmo sono ancora poco precisi, se non in rariesemplari, recanti al rovescio il volto di eracle quasi frontale, dove i pochi elementisono in realtà ben realizzati e molto fini.
Tarentum: Coni di dritto
in queste emissioni recanti eracle inginocchiato al rovescio, i canoni della clas-sicità vengono normalmente ben rappresentati, senza nulla togliere agli aspetti rea-listici.
la figura rimane più scarna e i dettagli del volto sono sempre ben curati e minu-ziosamente rappresentati.
Fig. 4: Schema coni di dritto Tarentum
Marco Miglioli e Alberto Campana
16
l’occhio, uno dei particolari più difficili da realizzare, appare realistico e ben cu-rato, confermando un’arte incisoria matura nelle officine tarantine.
il taglio di profilo è ben lontano anche dagli esemplari più fini di Herakleia, chedifficilmente si distaccano dallo sguardo vitreo e privo di vita, ricordando le diffi-coltà di rappresentazione del v secolo.
Per gli esemplari tarantini, questo particolare anatomico è sempre ben definito(anche per quelli di minor pregio artistico) e in alcuni casi è possibile distinguere lalinea che individua il cristallino e la pupilla, entrambi di lato come visibile in Fig.5.
le decorazioni dell’elmo vanno dal mostro mitologico Scilla con teste di cane,dotato di grande movimento che ricorda alcune emissioni di Thurium, di poco pre-cedenti, all’ippocampo alato sempre rappresentato nelle emissioni lucane con eracleinginocchiato.
in alcuni esemplari caratterizzati da eracle con il ginocchio destro a terra e l’artosinistro sul piede, nel tentativo di farsi forza nella lotta, le decorazioni dell’elmosono molteplici e oltre a quelle elencate in precedenza, troviamo corone di ulivo,rosette e, in altri casi cronologicamente più tardi, anche nessuna decorazione.
la cresta dell’elmo è ben definita e realistica e il risultato complessivo è di grandemovimento e nitidezza, caratteristica che ritroviamo nella rappresentazione dei ca-pelli che escono dal paranuca, in questo caso completamente liberi e realizzati congrande cura dei dettagli.
Questi esemplari sono di norma meno piacevoli dei coni lucani che utilizzanocanoni utopici, sinuosi e surreali, ma rispecchiano a nostro parere una miglior rap-presentazione della realtà in tutti i suoi aspetti compositivi, dalla cura dei dettagli,alla capacità di dare movimento alla scena.
Fig. 5: Confronto rappresentazione occhio tra le due zecche
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
17
Herakleia: Coni di rovescio
la rappresentazione del mito di eracle in lotta con il leone Nemeo al rovescio,riflette seppur con alcune precisazioni, le caratteristiche dei coni di dritto.
Come osservato dalla Breglia, in occasione della pubblicazione del prezioso ri-trovamento di Torchiarolo,
“ ...nei coni di Eraclea avremmo invece figure più ricche di valori plastici, corpipiù pesanti e robusti in cui l’efficacia del modellato non è però danneggiata dallaminore agilità e magrezza...”.
le parole dell’illustre studiosa, che ebbe la possibilità di catalogare un così grandenumero di esemplari di numerose zecche (1719 frazionali, la maggioranza di Taren-tum ed Herakleia), sono di grande importanza e confermano uno degli aspetti stili-stici tipici della zecca lucana.
Dai corpi uniti di eracle e del leone Nemeo in questo atto di forza mitologico, tra-spare potenza e i corpi robusti e muscolosi si fondono individuando attraverso i relatividorsi, un cerchio quasi perfetto, confermando quanto già detto per i coni di dritto.
Nella maggior parte dei casi, la concavità della del tondello conferisce una migliorrappresentazione globale e concentrica dell’insieme, quasi a incorniciare la scena.
Fig. 6: Schema coni di rovescio Herakleia
Marco Miglioli e Alberto Campana
18
l’iscrizione nel cerchio ipotetico è ben rappresentabile (Fig. 6), a dimostrazioneche questo potesse essere servito all’incisore come linea guida per l’allestimento deiconi.
Nel complesso ci troviamo di fronte a rovesci molto piacevoli alla vista, dalleforme plastiche, armoniche e sinuose, nonostante un’analisi più accurata denoti unsacrificio delle proporzioni anatomiche a favore dell’aspetto globale dell’interno delconio.
i primi coni di questa emissione, fino alla metà del iv secolo, rappresentano voltidi eracle di pregevole fattura e grande movimento dei capelli, quasi a colmare le la-cune proporzionali.
Troviamo un chiaro esempio nella serie di dioboli precedentemente trattati, conil volto di eracle frontale (Tabella 2, n. 7-8-9), dove il capo della divinità, sebbenesproporzionato rispetto al corpo, risulta così curato e movimentato nella sua realiz-zazione, da diventare protagonista dell’intera scena, a dimostrazione ancora unavolta che non sempre realismo e armonia viaggino di pari passo.
Negli ultimi coni di questa emissione, il divario realistico rappresentativo tra ledue zecche si assottiglia.
i volti di eracle perdono di qualità e i corpi si snelliscono, assomigliando semprepiù ai coni della zecca calabra, mantenendo comunque nell’insieme, la solita circo-larità che li contraddistingue.
Tarentum: Coni di rovescio
“Dal confronto risulterebbe che nei coni tarantini il modellato è in genere piùsecco, con una decisa tendenza alla rappresentazione dei corpi agili e snelli e allavalorizzazione delle masse muscolari, ritratte nella contrazione o nella tensionedella lotta...”
ancora una volta, le parole della Breglia testimoniano l’importanza del suo studioe la rappresentazione della scena mitologica diventa molto curata nel complesso,meno armonica, ma di forte impatto realistico.
Se al dritto i dettagli minuti acquistano definizione e qualità, rispetto agli esem-plari lucani, al rovescio lo stile complessivo sembra venire meno, a favore di snel-lezza e agilità.
Si valorizzano le masse muscolari che interrompono la sinuosità della scena e lacircolarità, tanto cara alla zecca lucana, viene tralasciata nel rispetto delle propor-zioni reali.
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
19
Cronologicamente, si assiste a una perdita di stile, dove ai primissimi esemplari(Fig. 7, 1-2), caratterizzati da una rappresentazione estremamente realistica del corpoumano, si contrappongono le ultime emissioni (Fig. 7, 5-6) recanti eracle inginoc-chiato che presentano una conformazione un po’ sgraziata, ma sempre molto attentaalla valorizzazione delle masse muscolari contratte.
Fig. 7: Schema coni di rovescio Tarentum
Fig. 8: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,11 g, (CNG e-auction 233, 26.05.210, lotto 52)
Marco Miglioli e Alberto Campana
20
Fig. 9: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,18 g, (CNG e-auction 241, 29.09.210, lotto 5)
Fig. 10: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,29 g, (Leu Numismatik AG 86, 5.05.2003, lotto 208)
Fig. 11: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,13 g, (CNG Triton VII, 12.01.2004, lotto 33)
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
21
Fig. 12: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,31 g,NAC “N”, Ex Collezione A.D.M., 26.06.2003, lotto 1034)
Fig. 13: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,08 g, (The New York Sale XI, 11.01.2006, lotto 8)
Fig. 14: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,39 g, (Künker 124, 16.03.2007, lotto 7812)
Marco Miglioli e Alberto Campana
22
Fig. 15: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,28 g, (Roma Numismatic IV, 30.09.2012, lotto 1015)
Fig. 16: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,21 g(Munzen & Medaillen 95, 04.10.2004, lotto 1)
Fig. 17: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,10 g, (NAC “O”, 13.05.2004, lotto 1067)
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
23
Fig. 18: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,18 g, (CNG e-auction 241, 29.09.2010, lotto 5)
Fig. 19: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 0,80 g, (CNG e-auction 212, 17.06.2009, lotto 1)
Fig. 20: Tarentum, Ag, diobolo, circa 380-325 a.C., 1,20 g, (LHS Numismatik AG 100, 23.04.2007, lotto 67)
Marco Miglioli e Alberto Campana
24
Se si osservano le immagini proposte relative alla zecca di Tarentum è possibileindividuare le peculiarità stilistiche trattate nei paragrafi precedenti in aggiunta agliaspetti tecnici legati all’azione di conio che risultano chiari se raffrontati alle Tabelle1,2,3 e 4.
aldilà di una serie di lettere e simboli che ritroviamo in emissioni coeve dellastessa monetazione all’interno di differenti nominali (a, T, K, Δ, granchio, locusta,civetta, strigile, clava, erma, etc.) siano essi maggiori (didrammi, dracme) o inferiori(oboli, etc.) è effettivamente l’andamento del flan che, salvo alcuni casi di estremaregolarità, si caratterizza per la sua forma irregolare. la centratura dei soggetti quasisempre imperfetta, chiude il quadro degli elementi tecnici di valutazione, suggerendouna conclusione che sembrerebbe escludere le ipotesi di emissioni confederate o co-munque provenienti dalla stessa officina.
Conclusioni
Probabilmente le emissioni tarantine con tale iconografia e nello specifico coneracle inginocchiato sono apparse posteriormente ai primi dioboli di Herakleia re-canti questi tipi.
la maggior parte degli studiosi concorda per il 380 a.C., come partenza dellaproduzione di queste emissioni nella zecca calabra.
Come precedentemente sostenuto è ipotizzabile che Tarentum assunse questi tipinella coniazione dei propri frazionali, quasi come fosse una monetazione confede-rata: non a caso molti ritrovamenti contengono indistintamente esemplari di en-trambe le zecche.
Questi sono apparsi sistematicamente in altre città appartenenti alla lega italiota,ma è anche vero che il culto di eracle si diffuse in molte popolazioni nella penisola,etruschi, greci, Sanniti, popolazioni indigene ed altre ancora.
Questa particolare emissione è da sempre stata oggetto di errori attributivi e con-fusione nella classificazione.
l’interpretazione di questi esemplari può quindi avvenire tramite un’interpola-zione tra aspetti scientifici, stilistici e tecnici che possono chiarire il quadro attribu-tivo.
Sulla base di queste considerazioni si può asserire che l’emissione analizzata perHerakleia è caratterizzata da un oggettivo andamento del flan e da determinati e ori-ginali aspetti stilistici attribuibili alla zecca lucana.
Di contro, come in parte intuito dalla Breglia, gli esemplari di Tarentum risultanoal tatto più sottili e l’andamento del flan è normalmente irregolare e poco curato,
Su un gruppo di dioboli di piede tarantino: chiarezza nell’attibuzione ad Herakleia
25
quasi “tosato”.È probabile infatti che i tondelli tarentini, fossero tosati per raggiungere appros-
simativamente il peso prima di essere portati a incandescenza per la fase di conio.Questo particolare giustificherebbe da un lato le variazioni di peso, anche elevate,
per gli esemplari tarentini, (frutto dell’imprecisione nella manualità dell’operazione),dall’altro lato la maggiore regolarità di quelli di Herakleia, dove la preparazione deltondello era molto curata e probabilmente finita già in fase di creazione in stampo.
l’aspetto tecnico, normalmente sottovalutato, può rivelarsi determinante per co-noscere i metodi produttivi di un’officina piuttosto che un’altra, aiutando l’attribu-zione di questi esemplari.
È presumibile che il volume produttivo della zecca tarantina fosse più elevato,come dimostrerebbe la gran quantità di monete e frazionali emessi e questo aspettopotrebbe aver avuto una valenza nella cura complessiva nella fase di conio.
Per la zecca di Herakleia, la produzione di frazionali fu più limitata e curata e lacoordinazione nella fase di conio fu certamente più lineare.
Un maggior collegamento di tutte le fasi produttive, dall’incisione al colpo dimartello finale, senza mai raggiungere incisioni di altissimo livello (salvo alcunicasi esaminati), caratterizza gli esemplari lucani.
Nel complesso, la tradizione e la scuola tarantina poterono contare su un maggiorcontrollo dell’arte incisoria e della sua traduzione figurativa, basata su canoni realie dettagli mai improvvisati.
Marco Miglioli e Alberto Campana
26
B.M.C. 1873 = A Catalogue of The Greek Coinsin The British Museum, volume i, italy,london.
BReglia 1942 = BReglia l., Due tesoretti dimonete greche della Magna Grecia (Ta-ranto 1916 e Torchiarolo 1926), Memoriedella Reale accademia di archeologia, let-tere e Belle arti della Società Reale di Na-poli, volume vi, p. 125-198.
CaNTileNa 2004 = CaNTileNa R., CeRCHiai l.,PONTRaNDOlFO a., L’immagine di Eraclein lotta contro il leone nella documenta-zione del IV secolo a.C. in: Caccamo Cal-tabiano Maria, Castrizio Daniele, PuglisiMariangela, La tradizione iconica comefonte storica.Il ruolo della numismaticanegli studi di iconografia Reggio Calabria,Falzea, p. 131-150.
CaTalli 1995 = CaTalli F., Monete dell’Italiaantica, Roma.
gROSe 1923 = gROSe S. W., Catalogue of theMcClean Collection of Greek Coins, vo-lume i, Cambridge.
JaMeSON 1913-1932 = R. Jameson Collection,Tome i : Monnaies grecques antiques. De-scription et Planches, Paris.
KeviN 1979 = KeviN e., The John Max WulfingCollection in Washington University, NewYork.
MaRZaNO 1964 = MaRZaNO g., Di un tesorettodi monete greche e di un santuario a Vale-sio, Ricerche e studi, Museo Francesco Ri-bezzo, Brindisi, 1, p. 45-51.
RaTTO 1929 = RaTTO R., Collection ClaudiusCôte, Monnaies de Tarente, lugano.
Ravel 1947 = Ravel e. O., The Collection ofTarentine Coins formed by M. P. VLASTO,(Reprint Chicago 1977).
RUTTeR 2001 = RUTTeR N. K., Historia Numo-rum Italy. london 2001, p. 124-126.
SiCiliaNO & SaRCiNelli 2004 = SiCiliaNO a. eSaRCiNelli g., Metapontum – Siris/Hera-kleia: La documentazione numismatica, in:atti del Xii Convengo organizzato dal-l’Università “Federico ii” e dal Centro in-ternazionale di studi numismatici, Napoli16-17 giugno 2000, Roma.
SNg aNS 1969 = Sylloge Nummorum Graeco-rum, The Collection of the American numi-smatic society, Part i, ETRURIA –CALABRIA, New York.
SNg BUDaPeST 1992 = Sylloge NummorumGraecorum Hungary, volume i, HISPANIA– SICILIA, Part 2, Calabria – Bruttium, Bu-dapest.
SNg COPeNHageN 1981 = Sylloge NummorumGraecorum, The Royal Collection of coinsand medals. Danish National Museum.Italy. West Milford.
SNg FiTZWilliaM 1940 = Sylloge NummorumGraecorum, Fitzwilliam Museum: Leakeand general collection, Part i, SPAIN (Em-poriae, Rhoda) – ITALY, london.
SNg gale 2008 = Sylloge Nummorum Graeco-rum Australia, volume i, The Gale Collec-tion of south italian coins, Sydney.
SNg MaNCHeSTeR 1986 = Sylloge NummorumGraecorum Manchester University Mu-seum, volume vii, london.
SNg MilaNO 1989 = Sylloge Nummorum Grae-corum Italia, Civiche Raccolte Numismati-che, volume iii, Campania – Calabria,Milano.
SNg MüNCHeN 1973 = Sylloge NummorumGraecorum Deutschland, 3. Heft, Kala-brien - Lukanien, Berlin.
SNg PaRiS 2003 = Sylloge Nummorum Graeco-rum France 6,1, ITALIE, ETRURIE – CA-LABRE, Paris.
vaN KeUReN 1994 = vaN KeUReN F., The Coi-nage of Heraclea Lucaniae, Roma.
BiBliOgRaFia