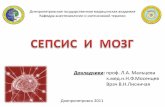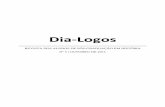Il biennio 1848-1849 a Valdagno nella cronaca di Giovanni Soster, in "Quaderni del Gruppo Storico...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Il biennio 1848-1849 a Valdagno nella cronaca di Giovanni Soster, in "Quaderni del Gruppo Storico...
quaderni delGruppo StoricoValle dell’Agno
maggio2011
GIOVANNI SOSTER
IL RISORGIMENTONELLA VALLE DELL’AGNO(parte prima)
Giorgio TrivelliGiovanni Soster, cronista e testimonedella Valdagno del XIX secolo
Annalisa CastagnaLe Memorie di Valdagno di Giovanni Soster
Silvano FornasaIl biennio 1848-1849 a Valdagnonella cronaca di Giovanni Soster
Antonio FabrisLa rivolta dei montanari di Castelvecchioa metà dell’Ottocento
19
Il biennio 1848-1849 a Valdagnonella cronaca di Giovanni Soster
di Silvano Fornasa
L’argomento di questo saggio - lo dice il titolo - sono le vicende storiche valdagnesi durante della prima guerra d’Indipendenza, in particolar modo lo scoppio rivoluzionario dei mesi marzo/giugno 1848, vicende locali ne-cessariamente rapportate agli accadimenti più generali: l’insurrezione di Venezia e l’esperienza della Repubblica di San Marco, l’eroica difesa della città di Vicenza culminata nella battaglia del 10 giugno e più in generale gli eventi storici italiani ed europei. Nello specifico, si ripercorreranno i fatti di Valdagno sulla scorta di una documentazione finora poco nota, e comunque inedita, di un testimone d’eccezione, il cronista valdagnese Giovanni Soster. La particolarità di questa fonte è di aiuto nello sforzo di restare immuni sia dalla retorica che dal revisionismo storico, tentazioni concrete e accarezzate non di rado in occasione delle celebrazioni in corso per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia: verranno presentati i protagonisti del Risorgimento locale così com’erano, con i loro entusiasmi, ingenuità, limiti.
Ritengo indispensabile premettere qualche breve nota sul Soster e sulla sua opera, e gettare uno sguardo, anch’esso rapido, sulla Valdagno di metà Ottocento.
1. L’opera di Giovanni Soster
Giovanni Soster nacque a Valdagno nel 1814 e morì nel 1893: potrem-mo quindi definirlo il testimone dell’Ottocento valdagnese. La sua famiglia, originaria dell’Altopiano dei Sette Comuni, era presente a Valdagno sicura-mente dal XVIII secolo, quando già era impegnata nella lavorazione della seta1. Anche in seguito i Soster furono tra i principali produttori di lana e seta a Valdagno: nel 1795 Giovanni Soster, zio del nostro cronista, aveva un opificio per la lavorazione della lana con 96 dipendenti2.
Di mestiere Giovanni Soster faceva l’orefice ed era in possesso di una buona istruzione, anche se non universitaria come non pochi valdagnesi di allora: le sue grandi passioni erano la conoscenza delle vicende storiche del
1. W. ANTONIAZZI, Economia e società a Valdagno tra ‘700 e ‘800, Vicenza 2001, p. 84.2. Ibidem, p. 74.
STORIAMODERNA
20 21
suo paese e la conservazione di tutta la documentazione relativa. Era quindi di famiglia benestante e suo padre Rocco fu a lungo deputato comunale, negli ultimi anni della Repubblica di Venezia, sotto i Francesi e durante la dominazione austriaca: era al vertice dell’amministrazione valdagnese anche negli anni di cui si tratta in questo saggio.
Nel 1869 il comune di Valdagno decise di ‘fare pulizia’ e mise in vendita 7000 libbre (circa 35 q) di carte che riteneva inutili; le comprò il farmacista Francesco Orsini, ma Giovanni Soster ebbe modo di visionarle, di salvarne una certa quantità e di ricopiarne molte altre3. Occorre ricordare che, oltre alla documentazione andata perduta in questa occasione, la gran parte delle carte antiche del vicariato e del comune di Valdagno era stata dispersa in occasione delle insorgenze antifrancesi del 18094.
Nel corso della sua vita Giovanni Soster raccolse una mole rilevantissima di documenti storici originali, molti altri ne trascrisse e redasse alcune brevi cronache degli eventi che ritenne maggiormente importanti. Diede alle stam-pe, in 11 opuscoli, una piccola parte della sua raccolta; poi, nel 1892, donò alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza tutta la documentazione accumulata nel corso della sua vita, raccolta in 29 buste, fascicoli e volumi. A Valdagno lasciò l’opera più significativa ed importante per la storia del paese, i 18 vo-lumi manoscritti delle Memorie di Valdagno, che coprono il lungo periodo che va dal 1836 al 1893.
Tra le buste del Soster conservate nella biblioteca vicentina, vi è una rac-colta di documenti (ms. Gonzati 3508) intitolata Valdagno. Atti uffiziali e me-morie dal 1848 al 1878 raccolti da Giovanni Soster, che inizia proprio con le pagine manoscritte intitolate Anno 1848. Ricordi della Rivoluzione, accom-pagnate da una ricca serie di documenti originali coevi. Contestualmente, il primo dei 18 volumi conservati a Valdagno, il Volume unico che va dal 1836 al 1853, contiene un’altra cronaca di questi eventi, corredata - in questo caso - da documenti valdagnesi trascritti dal Soster stesso. Questi due documenti sono alla base della presente ricerca, dove si è ritenuto opportuno anche pub-blicare ampi stralci della cronaca, afferenti a questo importante evento della storia valdagnese.
Nel 1848 Giovanni Soster aveva 34 anni, un’istruzione di tutto rispetto ed un grande attaccamento alla sua terra: va quindi considerato un testimone credibile. I suoi ricordi presentano il vantaggio di una sorta di ‘presa diretta’ e dimostrano ancora tutta la loro freschezza, indubbiamente scritti da un per-
3. G. SOSTER, Memorie di Valdagno, libro VI (1869-1870), c. 47v, ms. in Biblioteca Co-munale di Valdagno (= BCV).
4. G. SOSTER, Memorie sui briganti lasciate dal sig. Nicolò Orsini, ms. DO 61 in Biblio-teca Bertoliana di Vicenza (= BBV).
20 21
sonaggio che si contrapponeva alla borghesia valdagnese patriottica e filoita-liana (posizione che appare di striscio nella cronaca del 1848-1849, ma che sarà esplicita ed evidente nelle cronache degli anni successivi), conservatore certamente, ma tutt’altro che ottuso austriacante.
2. Valdagno intorno alla metà dell’Ottocento
Com’era Valdagno a metà Ottocento? Mi limiterò a qualche breve cenno, peraltro utile a inquadrare gli avvenimenti del 1848: mentre, infatti, alcuni aspetti di questo periodo storico sono stati adeguatamente illustrati in pubbli-cazioni recenti o meno (i personaggi più illustri, la storia politica e ammini-strativa della seconda metà del secolo) per altri mancano del tutto ricerche e studi condotti sulla documentazione reperibile sia negli archivi locali che in quelli di Vicenza e Venezia.
Valdagno nel 1848 contava all’incirca 5400 abitanti, per la precisione 5360 abitanti nel 1845, così suddivisi: Valdagno 3327, Castelvecchio 861, Cereal-to 198, Piana 974; occorre ricordare che allora Novale era comune autonomo rispetto a Valdagno5.
Il tasso di mortalità era ancora poco sotto al 40 ‰, ma era la mortalità infantile ad essere ancora altissima, simile o addirittura superiore a quella dei secoli precedenti: mediamente un neonato su tre moriva alla nascita e in qualche annata la percentuale raggiungeva anche il 50%. In una tabella dei nati e dei morti del distretto di Valdagno, raccolta e conservata da Giovanni Soster, appare un dato impressionante: nel 1820 i bambini morti entro il pri-mo anno di vita furono il 47.5% e nel 1821 il 47.6%, percentuale che saliva al 54% per i morti entro i primi 4 anni di vita6. Non ultime, tra le cause di una così elevata mortalità infantile, era l’abitudine di battezzare i bambini nei primissimi giorni di vita, soprattutto nei mesi invernali. È sorprendente, a tal proposito, una relazione sanitaria del medico condotto Giuseppe Festari:
«Generalmente il trattamento dei neonati è cattivo, in quanto durante il trasporto dalla casa alla chiesa per il loro battesimo durante l’in-verno, senza le necessarie precauzioni per difendersi, massimamente nelle parti montuose, (…) tra l’una e l’altra li portatori si trattengono a bere spesso all’osteria ed in altri luoghi per riposarsi, e lasciano esposto il neonato or sopra di una scranna, or sopra di un tavolo secondo le situazioni. Evvi poi altro disordine, che nelle comuni ove non vi sono levatrici istruite ed approvate, si consiglia la lor cura
5. BBV, ms. 3507.6. BBV, ms. DO 55.
22 23
con donnicciuole che d’ordinario sono piene di superstizioni e di false idee» 7.
L’agricoltura costituiva allora, anche a Valdagno, l’attività economica pre-dominante, nel senso che la gran parte della popolazione viveva in tutto o in larga misura di reddito da lavoro agricolo. Il contesto di arretratezza che caratterizzava ancora l’agricoltura veneta ottocentesca determinava anche da noi condizioni di vita molto precarie per la classe contadina, in particolar modo nelle frazioni collinari. La qualità della vita fra il centro e le periferie era allora nettamente differenziata: per rendercene conto è sufficiente vedere - è solo un esempio - un prospetto di quelli che i parroci periodicamente do-vevano fornire alle amministrazioni comunali, relativamente alle condizioni di vita dei loro fedeli. Il 3 marzo 1846, i «miserabili» nelle quattro parrocchie del Valdagnese erano così suddivisi:
- Valdagno: 865, pari al 26% della popolazione;- Piana: 300, pari al 31% della popolazione;- Castelvecchio: 429, pari al 50% della popolazione;- Cerealto: 150, pari al 76% della popolazione8.
Passando dal settore economico primario al secondario, si possono fare alcune brevi considerazioni. A Valdagno, come è noto, si erano da tempo svi-luppate le manifatture della lana e ancor più della seta, attività che subirono alti e bassi nella prima metà dell’Ottocento, ma che collocavano il paese ai vertici della produzione manifatturiera del Lombardo-Veneto. La famiglia Marzotto prenderà il largo qualche decennio dopo: allora era una delle nu-merose aziende, e non la principale, tra filande (15), manifatture di lana (8) e tintorie (3). Nel complesso gli addetti erano parecchie centinaia.
La documentazione che ho trovato più vicina agli anni di cui si parla è del 1845 e si riferisce alla produzione, veramente elevata, di seta a Valdagno: erano attive 15 aziende di discrete dimensioni, per un totale di 107 fornelli; quell’anno si produssero a Valdagno 16 tonnellate di bozzoli, ma i bozzoli lavorati ammontavano a 60 tonnellate (si acquistavano anche da fuori), per un totale di 60 quintali di seta prodotta9.
La terza industria era l’estrazione del carbon fossile della miniera dei Pul-li. L’attività estrattiva iniziò nel 1841, poi Matteo Bevilacqua, personaggio indubbiamente facoltoso, che in questi anni troviamo ai vertici dell’ammini-strazione comunale e del comitato provvisorio, cedette i diritti alla Società Montanistica, trattenendo il 3% e 400 quintali di carbone per la sua filanda.
7. GIOVANNI SOSTER, Documenti storici del distretto di Valdagno, in BBV, ms. 3506.8. BBV, ms. 3507.9. Ibidem.
22 23
Nella Cronaca del 1848, Soster scrisse di «grande smercio» di carbone verso Verona, impiegato per l’illuminazione della città e riportò, come dato indica-tivo, che nel 1851 la produzione fu di 130.000 quintali10.
Per quanto concerne il terziario, le attività di questo settore, quasi limitate all’essenziale nelle frazioni, a Valdagno - centro economico rilevante e capo-luogo di distretto - erano indubbiamente molto rilevanti. Riporto solamente una relazione contemporanea ai fatti di cui parleremo, sugli esercizi com-merciali di Valdagno: in essa sono elencate 4 caffetterie, 13 vendite di caffè e liquori, 11 vendite di liquori e acquavite, 3 ostarie, 17 bettole, 1 rivendita di «vini navigati di lusso» (vini pregiati che arrivavano dal sud o dalle isole del Mediterraneo e destinati alle famiglie benestanti). Gli esercizi erano dunque una cinquantina in tutto: indubbiamente un bel numero per un centro (qui si parla solo di Valdagno) di poco più di 3000 abitanti11.
Non c’è lo spazio, qui, per delineare neanche a grandi linee il ruolo delle parrocchie nella società valdagnese di allora ed il rapporto tra istituzioni, men che meno per indagini di tipo antropologico o aspetti di vita materia-le e quotidiana delle persone. Possiamo solo ricordare che, come esisteva una distanza abissale di qualità della vita fra la ristretta classe benestante e la popolazione povera, altrettanto grande era la distanza di cultura e anche di mentalità: le idee dell’illuminismo avevano toccato anche i valdagnesi più istruiti, mentre nelle contrade più decentrate resistevano tradizioni e usi tramandati da secoli. Mi piace ricordare le uniche pagine ottocentesche di carattere etnografico conservate per il nostro territorio.
Giovanni Biasi scrisse Cenni sopra Recoaro nel 1837 e lo ripubblicò nel 184412. Prima di addentrarsi nella descrizione delle virtù terapeutiche del-le acque minerali, l’autore affronta la questione del dialetto parlato anche nell’alta Valle dell’Agno fino ad allora ed espresse alcune interessanti osser-vazioni sulle profonde trasformazioni introdotte dal termalismo nel territorio recoarese. Alcune pagine, in particolare, costituiscono a mio avviso la parte più interessante dell’opera: in esse il Biasi descrive le feste ed i riti che scan-divano la vita della gente a Recoaro e documenta usi e costumi dell’alta valle e delle zone collinari, che ancora resistevano all’usura del tempo. Vediamo qualche esempio.
FUNERALE. Quando era in procinto di morire, la persona riceveva la visita dei parenti che potevano essere avvertiti. Dopo la morte si suonava la cosiddetta agonia, che terminava con due tocchi se si trattava di una femmi-
10. G. SOSTER, Memorie di Valdagno, libro unico (1836-1853), cc. 251, 324.11. BBV, ms. DO 55.12. G. BIASI, Cenni sopra Recoaro e le sue acque acidulo-marziali, Verona 1837 (ristam-
pa 1844).
24 25
na, tre se era un maschio. A quel punto arrivavano anche i parenti più lontani, che vegliavano il defunto tutta la notte «bevendo e mangiando». Il giorno successivo c’era il piagnisteo:
«Giunta l’ora in cui il sacerdote veniva a levare il cadavere, le donne tutte vestite di nero e spennacchiate si univano alla bara e in mezzo ad urli ed a pianti l’accompagnavano fino alla Chiesa, ove viemag-giormente si sforzavano a piangere ed a gridare, nulla badando né al luogo né alle funebri sacre liturgie».
Aggiunge ancora il Biasi:
«Conservasi ancora presso di noi (…) la superstiziosa costumanza di seppellire colle scarpe gli ammazzati, o mancati per morte violenta, nonché colle mule, o pantofole, ed in abito nuziale le femmine che muoiono di parto».
Questo perché si credeva che chi moriva di morte violenta o di parto va-gasse sulla terra per tutto il tempo di vita che avrebbe avuto a disposizione dal destino.
Sarebbe interessante parlare dei giochi, delle feste, delle tradizioni legate alle festività, che per Valdagno conosciamo bene grazie alle cronache del Soster, ma prima ancora di Bernardo Bocchese. Qui si riporta solamente l’in-teressante descrizione di una festa di carnevale a Valdagno, la festa dei bene-stanti in questo caso, che un professionista veneziano che alloggiava in paese per la cura delle acque fece pubblicare sulla Gazzetta di Venezia13.
«Voi desiderate sapere quali divertimenti io abbia goduti in Valda-gno l’ultimo giorno di Carnevale, ed io mi compiaccio di soddisfare la vostra curiosità. Sorgeva quel giorno sereno e ridente oltre modo e già un sonoro squillar di trombe, di cui la valle intorno echeggiava, parea che tutti invitasse al tripudio e ai piaceri. Di fatti le contrade e la piazza si affollavano di persone, che al segno di maschera onde pregiavansi, ed alla gioia che loro appariva nel volto, mostravano dover essere quel dì tutto sacro agli spassi carnevaleschi.Numerosa banda musicale rallegrava i circostanti con vivaci armo-nie, che si mesceano alle gioconde risa ed agli evviva più clamorosi. Giunto frattanto il mezzogiorno, le principali famiglie imbandirono
13. BBV, ms. 3507.
24 25
tanti conviti ai forestieri e agli amici, quando un nuovo suono di tromba diede il segnale al corso delle carrozze, che numerose ed adorne di eleganti maschere percorsero con reiterati giri le maggiori vie, gettando in copia confetture e porgendo nelle fermate a bere dei più pregiati vini d’oltremare a chiunque affacciavasi agli sportelli. Al convenuto segno si ritirarono le carrozze e comparve sopra ma-gnifico carro una figura rappresentante il Carnevale affetto da idro-pisia. Il notaio e il medico lo accompagnavano; ed avendo questi deciso disperata la malattia ed imminente la morte, fu dal notaio pubblicato il testamento tutto condito delle più argute facezie e fra generali grandissime grida il Carnevale spirò.I signori del paese, colle proprie mogli e figli in numero di 300 e più, vestiti a lutto, con torce compiangevano intorno al carro la fatal perdita, finché, spenti i lumi, a suono di tamburo scordato accompa-gnarono l’estinto al luogo della sua trasmigrazione.Alle ore 8 della notte ebbe principio la brillantissima festa da ballo, ove fino a 60 signore colla maggior eleganza abbigliate danzarono nella sala del palazzo dell’egregio signor Matteo Bevilacqua, che per la cortesia dei suoi modi e pel patrio amore che lo anima, gode la più distinta estimazione generale. V’erano, oltre la sala da ballo, stanze da gioco, botteghe di caffé e trattoria, sicché nulla mancava a rendere quel trattenimento veramente compito. Voi stupireste che in un piccolo paese si abbia potuto dare una serie di divertimenti così varii e gradevoli, ma colà dove regna fra gli abitanti lo spirito di unione, l’armonia e la buona intelligenza, dalle locali autorità man-tenute e favorite, anche in un ristretto numero di persone si possono procurare tali piaceri, da non invidiar quelli delle più popolari di città».
3. Il biennio 1848-1849 a Valdagno, nella cronaca di Giovanni Soster
Sotto la spinta di molteplici fattori e contrastanti aspirazioni, e in condi-zioni sociali e politiche le più disparate, nel corso di due mesi le fiamme della rivoluzione si sparsero per tutta Europa, risparmiando solamente Gran Bretagna e Russia: 23/24 febbraio 1848 a Parigi, 13 marzo a Vienna, 2 giorni dopo a Berlino e Budapest; nel regno Lombardo-Veneto, il 17 marzo insorse Venezia ed il 18 Milano: nelle due capitali, ma per contagio anche nelle altre città e province, le popolazioni insorte cacciarono gli Austriaci e proclama-rono governi provvisori.
Restringendo subito l’ambito di indagine al territorio veneto, sappiamo
26 27
che da Venezia la rivolta si estese rapidamente alle altre città della regione, costringendo le forze dell’esercito austriaco a ritirarsi, sotto il comando del feldmaresciallo Radetzky, nel ‘quadrilatero’ di Mantova, Legnago, Verona e Peschiera. A conferma della efficienza del servizio postale asburgico, a Valdagno la notizia dell’insurrezione di Vienna arrivò in tre, quattro giorni e quella di Venezia praticamente in tempo reale. Racconta Giovanni Soster14:
«Addì 17 Marzo pioggia. La sera di Venerdì 17 Marzo giunse a Val-dagno la notizia per lettere private che nel giorno di Lunedì 13 cor-rente mese scoppiò a Vienna la rivoluzione, e che in conseguenza di ciò fuggì il Ministro Metternich, e l’imperatore Ferdinando 1° si ritirò a Bric, luogo distante dieci miglia da Vienna. Altre lettere re-carono la notizia che il giorno d’oggi passò per Vicenza una staffetta che portava la notizia della pubblicazione della Costituzione per tut-ta la Monarchia Austriaca.Addì 18 Marzo pioggia, lampi e tuoni. In giorno di Sabato, sulla sera, alcuni dei nostri giovani andarono a incontrare il corriere che da Vicenza ritornava a Valdagno per sentire le novità; e dalla Gaz-zetta di Venezia fu annunziato la pubblicazione della Costituzione per tutto il Regno Lombardo-Veneto e subito si fece una pubblica dimostrazione di allegrezza, correndo per le contrade del paese, can-tando e gridando Evviva. Le campane della Parrocchia suonarono a festa fino alla mezzanotte, alla cui ora cessarono anche i canti e gli evviva».
Il giorno dopo la festa esplose per le vie e le piazze del paese e venne immediatamente coinvolta anche l’istituzione ecclesiastica locale. Occorre infatti ricordare come la rivoluzione del 1848 fosse iniziata - probabilmente oltre i limiti di una sua precisa scelta - sotto l’auspicio del papa Pio IX, che con alcune sue aperture aveva fatto da detonatore. Il vescovo di Vicenza, monsignor Cappellari, tenne fin da subito una posizione nettamente favore-vole e nei giorni successivi ebbe ad esprimersi con grande favore nei con-fronti dei patrioti volontari accorsi a difendere Vicenza:
«Noi dobbiamo pregare perché la Causa da voi sostenuta colle armi,
14. D’ora in avanti, tutte i brani della Cronaca del Soster sono tratti dai già citati docu-menti: BBV, ms. 3508, Anno 1848. Ricordi della Rivoluzione, e ACV, G. SOSTER, Memorie di Valdagno, libro unico (1836-1853), cc. 203 - 269. Sono state apportate lievi modifiche grafiche, ortografiche e di punteggiatura.
26 27
la Causa della Nazione sia protetta dal Dio degli eserciti. E però di cuore abbiamo benedetto e benediciamo alle vostre spade, alle vo-stre bandiere ed a chi corre o si presta in qualunque modo alla difesa della patria».
Con dovizia di particolari, il Soster riporta nella sua Cronaca:
«Addì 19 Marzo, giorno di Domenica. Alla mattina ognuno che sortiva di casa dovea portare o sul petto o sul cappello la coccar-da tricolorata, rosso, bianco, verde. Alcuni signori si sono recati dal signor arciprete per pregarlo che sia cantata la messa solenne con il Te Deum, ed infatti alle ore 10 fu celebrata la Messa con musica dei nostri Filarmonici. Molti di questi nostri giovinotti, con altri più avanzati d’età, si recarono alla chiesa preceduti da uno che portava una grande bandiera tricolore e presero posto in coro per ascoltare la santa messa, terminata la quale, essendo oggi la terza Domenica del mese, si fece nell’interno della chiesa la processione del SS. Sa-cramento.(…) Terminate le funzioni della Chiesa poco prima del mezzodì, nel sortire dalla chiesa il popolo gridò Evviva; e nel nuovo fabbricato in piazza, di proprietà del sig. Nicolò Dalle Ore, fu spiegata una grande bandiera tricolore colle parole W L’ITALIA. Dopo le sacre pomeridiane funzioni tutti giravano per le contrade del paese colla musica della banda gridando Viva l’Italia, Viva Pio IX. Le finestre ed i poggioli di tutte le case erano fornite di coperte e tappeti in segno di gran festa. Le signore portavano elle pure la coccarda ed alcune portavano un cappellino colle piume, al costume dell’antica italiana. L’allegria era manifesta in tutti; donne e uomini, vecchi e giovani, ricchi e poveri, contadini ed artigiani; tutti ballavano per le strade, cantavano e si abbracciavano e baciavano reciprocamente in segno di fratellanza e di amore, e continuamente gridavano Viva l’Italia, Viva Pio IX.Il busto in gesso rappresentante l’effigie del Sommo Pontefice Pio IX fu portato in trionfo per le contrade del paese da molti giovani e lo portaro-no sul piazzale davanti la chiesa parrocchiale, e giunti sulla porta mag-giore della chiesa lo innalzarono affinché da tutti fosse veduto e tutti, in quel momento che venne alzato, si scoprirono il capo e s’inginocchia-rono. Alla sera è stata fatta generale illuminazione e tanto sul campanile che sulla facciata della chiesa sono stati disposti vari palloncini di carta. Anche i sacerdoti avevano sul petto la coccarda tricolore».
28 29
Il giorno dopo tutti i mezzi erano buoni per raccogliere notizie immediate e fresche di stampa:
«La sera del 20 Marzo vennero a casa i nostri seminaristi che si tro-vavano agli studi a Vicenza, licenziati per ordine di monsignor ve-scovo in causa delle attuali circostanze politiche; ed alla loro venuta molti del paese corsero ansiosamente per informarsi dai medesimi delle novità di Vicenza e v’era un continuo correr per le strade e non si sentivano che gridi: Viva l’Italia. Anche i seminaristi portavano la coccarda e la medaglia coll’effigie di Pio IX sul petto.Fu atteso con impazienza l’arrivo del corriere, anzi alcuni lo andaro-no ad incontrare, chi in timonella, chi a cavallo, per avere più presto la valigia delle lettere e le gazzette. All’arrivo dunque della valigia, tutti si affollarono per le botteghe a sentire la lettura delle gazzette e le lettere private che arrivavano da Vicenza, Padova, Venezia e da Vienna. Grande era l’entusiasmo: v’era chi voleva perfino partire subito per Vicenza per assistere i Vicentini nella rivoluzione».
In tutti i maggiori centri della provincia vennero allestiti corpi di guardie civiche, guardie della rivoluzione potremmo definirle con termine estempo-raneo. L’avviso emesso dal Comitato provvisorio di Valdagno a questo scopo è stato raccolto e conservato dal nostro cronista:
«21 marzo 1848. Avviso ai concittadini di Valdagno. Si avverte che presso l’ufficio di questa Deputazione Comunale resta aperto da oggi in poi il Ruolo della Guardia Nazionale, dalle ore 9.00 antimeridiane alle 3 pomeridiane. Ognuno dovrà recare le sue armi e le sue muni-zioni e chi non le avesse sarà provveduto».
L’armamento, come si può vedere, era quel che era: in poche ore si raccol-sero 500 lire austriache «per fare acquisto di polvere da schioppo e per fare palle di piombo per istituire ed armare la Guardia Nazionale». Due giorni dopo, la struttura militarizzata volontaria era pronta e la Deputazione comu-nale di Valdagno ne rese noti i componenti:
- comandante in capo: Francesco Cengia-Bevilacqua;- capitani: Luigi Valle, Giambattista Festari, Francesco Tomba;- tenenti: Andrea Fiori, Gaetano Pizzati, Guglielmo Rubini;- sottotenenti: Gaetano Marzotto, Gaetano Cengia-Bevilacqua, Fran-cesco Bocchese;
28 29
- lascia facoltà al comandante di nominare sergenti e caporali.[firmato] I deputati: Giuseppe Cengia-Bevilacqua, Rocco Soster, Francesco Marzotto;La Giunta: Annibale Pozzan, Matteo Bevilacqua, Pietro Fiori, An-tonio Fiori;I segretari: Francesco Rottigni e Gambattista Tomba.
Si notino due cose: il sottotenente Gaetano Marzotto, che aveva allora 28 anni, è il Gaetano Marzotto senior, che già aveva assunto la direzione del lani-ficio paterno e che negli anni successivi imprimerà un decisivo salto di qualità all’azienda familiare; un componente della Giunta comunale è don Annibale Pozzan, parroco di Valdagno, a conferma del ruolo di primo piano che non di rado gli esponenti del clero assunsero nelle vicende risorgimentali.
«Addì 23 marzo, in giorno di Giovedì di mattina arrivò la notizia che i Piemontesi si sono impadroniti della città di Milano. Alle ore tre pomeridiane è venuta la nuova che a Venezia è stata proclamata la Repubblica. In questo giorno eravi in paese grande costernazione e timore che venissero dei militari tedeschi di ritorno o che calassero dai monti vicini. Fu oggi stabilito il corpo di Guardia Civica nella sala in pian terreno del palazzo del sig. Angelo Fiori, in contrà del Vicariato; e questa mattina fu l’ultima volta che si sono viste le guar-die di Polizia coll’uniforme austriaca e si sono vestite alla civile e si unirono alla Guardia civica.(…) Addì 25 Marzo, festa della Madonna, gli arruolati nella Guardia Nazionale in numero di circa 200, coi loro comandanti ed ufficiali, andarono alla chiesa parrocchiale ad ascoltare la messa solenne ce-lebrata alle ore 10. Intervennero anche la Deputazione Comunale ed il Comitato. A Venezia proclamata la Repubblica».
La pur breve cronaca Soster del giorno 23 Marzo è interessante per vari motivi. Le notizie arrivavano con tale rapidità che qualche volta anticipava-no i tempi reali: Milano non venne presa, ovviamente, dai Piemontesi ma si liberò da sola degli Austriaci; il 23 Marzo Carlo Alberto dichiarò guerra e subito dopo alcuni contingenti piemontesi passarono il Ticino ed entrarono in Lombardia. La notizia della proclamazione della Repubblica di San Marco arrivò invece in poche ore. Infine la guardia civica: i volontari valdagnesi arruolati furono 200, un numero molto consistente; a turno - ci ricorda il Soster - «cominciarono a girare per il paese in pattuglia, armati di fucile, per mantenere il buon ordine».
30 31
Torniamo ad allargare l’orizzonte. Gli Austriaci sgomberarono Vicenza il 24 marzo e subito si costituì un governo provvisorio per amministrare la città e per provvedere alla difesa, armando la guardia civica cittadina e predispo-nendo misure di sicurezza contro il prevedibile ritorno delle forze imperiali. Vicenza infatti costituiva, per le forze austriache ritiratesi nel ‘quadrilatero’, un importante nodo stradale per le comunicazioni con Vienna, che bisognava riprendere e controllare ad ogni costo.
Il 26 Marzo Vicenza aderì alla Repubblica Veneta appena proclamata, ma è utile porre attenzione alla formula di adesione e alle condizioni poste dai Vicentini, per capire le diverse scelte che di lì a pochi giorni Vicenza (ed an-che Valdagno) opereranno in merito alla forma istituzionale da dare al nuovo Stato Italiano. Gli accordi del 26 tra Vicenza ed il governo provvisorio della Repubblica di Venezia recitavano infatti:
«Le province che aderiscono alla forma repubblicana di quel Gover-no formano una sola famiglia, senza veruna disparità di vantaggi, diritti e doveri, ed invieranno in giusta proporzione i loro deputati a formare il comune statuto (…). Il governo provvisorio della città e provincia di Vicenza dichiara di aderire, siccome solennemente aderisce, alla Repubblica Veneta».
Con il senno di poi si rivelò una adesione precipitosa, anche se - come si è visto - il governo provvisorio di Vicenza pose condizioni che non pregiu-dicavano l’idea di una unione Lombardo-Veneta, né una federazione tra le due regioni, né una successiva federazione con gli altri Stati italiani. Quindi sì a Venezia, ma con dubbi e aperture a soluzioni successive, in linea con i principi fondamentali del federalismo giobertiano.
Tra i motivi di fondo di questo atteggiamento molto cauto, un’importanza notevole è da attribuire al rapporto che intercorreva, durante il passato regi-me, tra la Dominante e le città della Repubblica Serenissima. A mezzo secolo di distanza dalla fine della dominazione veneziana, i Vicentini certamente avevano ben presente il ruolo subalterno e l’assoluta esclusione delle città suddite dal governo dello Stato.
Tutto questo nonostante un generico (secondo molti, invece, convinto) attaccamento popolare alla trascorsa Repubblica di Venezia. Occorre infat-ti ricordare che, a fronte di chi immagina una sincera e convinta nostalgia popolare per il governo della Serenissima, la storiografia attribuisce questo atteggiamento non tanto al desiderio di un ritorno al passato, quanto inve-ce alle peggiorate condizioni sociali ed economiche sopraggiunte nei primi decenni dell’Ottocento, da ricondurre - molto in sintesi - alle condizioni di
30 31
lavoro della gran massa dei contadini, rese più gravose dall’incremento de-mografico e dalla crisi delle industrie manifatturiere locali, sopraggiunta nei decenni di trapasso dei vari regimi durante i primi decenni del secolo.
Questo attaccamento al passato, o meglio la tendenza a rimpiangere sem-pre quello che c’era prima, si manifestava anche nei proverbi popolari, rac-colti e tramandati. Proprio in questi anni venne pubblicata una raccolta di proverbi veneti ed uno dei più diffusi era il seguente, compresa un’appendice molto disincatata, aggiunta dopo il 1866, all’indomani dell’unificazione del Veneto al Regno d’Italia:
Co Venezia comandava se disnava e se senava.Coi Francesi, bona zente, se disnava solamente.Con la casa de Lorena no se disna e no se sena.Viva Savoja, che i n’à portà ’na fame troia!
In questi primissimi giorni di rivoluzione i Vicentini erano dunque favo-revoli ad una unione alla Repubblica Veneta e i Valdagnesi lo dimostrarono concretamente:
«Addì 26 Marzo, venne la Gazzetta della Repubblica di Venezia, il primo numero che fu pubblicato dopo la caduta del governo austria-co e fu letta con grande entusiasmo. Tutti erano allegri e gridavano Viva San Marco! Tutti si sono messi sul cappello un leone stampato di carta, essendo questo lo stemma della Repubblica di Venezia».
In queste giornate convulse, tra fine marzo e i primi giorni d’aprile, la cit-tà di Vicenza, che - come s’è detto - si trovava in una posizione geografica molto delicata, si preoccupò di raccogliere ed addestrare quante più forze di volontari possibile. Molti giovani, anche dei nostri paesi, si mobilitarono e vennero raggruppati in compagnie; presero il nome e il simbolo di ‘Crociati’: un panno a forma di croce, color rosso e cucito sull’uniforme, in genere di stoffa, di vario colore, con un cappello piumato in testa. Ce lo ricorda anche Soster, nella annotazione del 6 aprile:
«Addì 6 aprile, giorno di Giovedì, venne un ordine che uomini arma-ti debbano andare a Vicenza in aiuto di altri volontari per difendersi dai Tedeschi, i quali, viene assicurato che molti siano sortiti da Ve-rona per dirigersi nel Vicentino. I nostri della Guardia civica comin-ciarono a prepararsi e mettersi chi sul petto, chi su di un braccio una croce di panno rosso od un crocefisso».
32 33
A questo punto la Cronaca comincia a rivelare, o marcare maggiormente, una sorta di scetticismo che il Soster manifesta nei confronti di queste ener-giche manifestazioni di entusiasmo, che anche a Valdagno - come sì è visto - mobilitarono molta più gente di quanto siamo abituati a pensare. D’altronde Soster non era certo tra i patrioti, lo dimostrerà nelle annotazioni degli anni a seguire, soprattutto dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia del 1866; ma va anche ricordato che non era nemmeno un fervente filoaustriaco.
In queste prime avvisaglie di scetticismo usava l’arma dell’ironia. Conti-nua così la Cronaca del 6 aprile:
«Tutti indistintamente, giovani e vecchi, non possono farsi vedere in pubblico se non portano almeno la coccarda tricolore, perché senza di questa non si tiene per un buon italiano, ma piuttosto del partito Tedesco. Ho detto che almeno si deve portare la coccarda, perché moltissimi ve ne sono che oltre la coccarda portano le medaglie coll’effigie di Pio IX, di Carlo Alberto, la Croce d’argento, il leone di San Marco e le piume sul cappello ed i calzoni col bordo rosso. E questi tali forniti con tanti segnali sono i veri italiani, i valorosi difensori della patria. Sono stati avvertiti anche i nostri contadini per armarsi ed unirsi a quei del paese per marciare, onde difendersi dai Tedeschi. In diverse case del paese sono stati preparati dei sassi sui granai per gettarli sui Tedeschi nel caso che passassero per qui diretti a Recoaro».
Anche nel nostro territorio, quindi, si formarono pattuglie di Crociati. A Valdagno - lo abbiamo appena visto - una pattuglia di volontari, che scal-pitava per andare a difendere Vicenza, cominciò a ritagliare le croci rosse e appuntarle sul petto nei primi giorni di aprile ed il giorno 6 arrivò per loro l’invito perentorio di partire subito alla volta della città. Erano - come ve-dremo subito - pattuglie molto spesso male armate e del tutto impreparate, soprattutto ad affrontare un esercito ben organizzato come quello austriaco. Va aggiunto poi che in quei giorni convulsi non c’era minimamente il tempo di operare una sia pur minima selezione; di conseguenza si arruolavano per-sonaggi di ogni genere: patrioti idealisti, renitenti alla leva, disertori, giovani desiderosi di intraprendere un’avventura.
Da tutta Italia (Regno delle Due Sicilie, Toscana e soprattutto Stato Ponti-ficio) arrivavano volontari arruolati nei corpi franchi, anche dopo che Pio IX (con l’allocuzione del 29 aprile) aveva dichiarato che non intendeva affatto partecipare alla guerra contro l’Austria. Vicenza era sotto tiro degli Austriaci e alzava barricate in tutta la città.
32 33
Questi giovani volontari, ancora inesperti e a volte poco disciplinati, eb-bero il ‘battesimo del fuoco’ nello scontro avvenuto l’8 aprile sulle alture fra Gambellara, Sorio e Montebello, in una spedizione contro gli Austriaci riti-ratisi in Verona, e che facevano qualche puntata verso Vicenza. 3000 Crociati provenienti dal Vicentino, da Venezia, ma anche da tutta Italia, guidati in modo approssimativo dal generale Sanfermo (di lui si tramanda la frase mol-to eloquente riferita all’esercito austriaco: “Mi go fato el me piano, mi me li bècolo”) vennero sbaragliati e tornarono precipitosamente verso Vicenza.
E qui occorre registrare - e Soster non mancò certo di farlo, visto anche l’incipiente scetticismo verso di loro - la magra figura dei Crociati nostrani, in primo luogo di Valdagno e Recoaro, ma sicuramente di altri della Valle dell’Agno. Così dunque Soster descrisse la loro partenza per Sorio e soprat-tutto il loro mancato arrivo:
«Addì 8 Aprile, in giorno di Sabato, di buon mattino arrivò qui un espresso coll’ordine che i nostri volontari debbano partire. Alle ore 10 si unirono questi giovani che devono marciare e si recarono alla chiesa parrocchiale per ascoltare la santa messa e far benedire la nuova bandiera tricolorata. Il reverendo signor arciprete celebrò la messa, poi diresse alcune parole dall’altare ai giovani soldati ani-mandoli a combattere colla croce per la santa causa dell’Italia, per la difesa della patria. Assistevano pure alla messa i deputati comunali, il comitato, il clero, e molte altre persone private. Poi si sono radu-nati li suddetti volontari nel corpo di guardia ed alle 2 pomeridiane (giacché il tempo cessò di piovere) sono partiti tutti armati, capita-nati dal reverendo cappellano comunale don Giuseppe Gozzetto, che portò la bandiera. Al momento della partenza i volontari ebbero gli Evviva di tutta la popolazione, ed erano in 80, dei quali alcuni per non aver il fucile portavano delle frecce. Le madri piangevano per la partenza dei loro figli, altri ancora piangevano di tenerezza per ve-dere questi nostri giovani così coraggiosi partire per battersi contro i Tedeschi, per la difesa della patria».
Qualche ora dopo si misero in moto anche i Crociati di Recoaro, ancor più numerosi. Prosegue la Cronaca dell’8 aprile:
«Circa le ore 6 pomeridiane (8 aprile) si seppe qui che i giovani vo-lontari di Recoaro erano in viaggio per Valdagno, onde unirsi coi no-stri per partire in compagnia ed andare alla guerra contro i Tedeschi. Allora i nostri cercarono di radunare alcuni suonatori per andarli ad
34 35
incontrare fino alla Machina del signor Marzotto; e difatti là si in-contrarono: i Recoaresi erano circa 120 armati di fucili e lance. Ave-vano essi pure il loro cappellano ed avevano per capitano il signor Costante Maltauro e fra gli applausi e gli Evviva dei valdagnesi che andarono ad incontrarli, entrarono in paese e si fermarono al corpo della guardia civica».
L’impreparazione dei nostri Crociati e la mancanza di una guida esperta balzano agli occhi con una evidenza disarmante: a Sorio e Montebello si stava già combattendo e i nostri prima di partire attesero che cessasse di piovere, salutarono le madri in lacrime e via di seguito. Non parliamo poi dell’armamento: pochi fucili, archi e frecce per i valdagnesi, lance per quelli di Recoaro.
Quando i crociati valdagnesi arrivarono alle Tezze di Arzignano le sorti della battaglia erano già decise; intrapresero subito la via del ritorno, riac-compagnati a casa dai paesani che erano andati a prenderli.
Ancor più magra figura per quelli di Recoaro: a Valdagno erano arrivati la sera dell’8 aprile, quindi a battaglia già conclusa e passarono la notte a Val-dagno, nei locali della guardia civica. La mattina seguente videro i Valdagne-si di ritorno e ripartirono il giorno stesso per Recoaro. Ci informa il Soster:
«Ma sulla sera venne la notizia che a Montebello gli Italiani fino al mezzodì d’oggi erano vincitori dei Tedeschi; ma che poi furono gli Italiani circondati da molti Croati e così i nostri, essendo in pochi e scoraggiati, si sbandarono e fuggirono. Nella notte stessa ritornò a casa il tenente signor Guglielmo Rubini. I Valdagnesi, avendo senti-to queste tristi notizie, pensarono di mandare a prendere quei volon-tari che stamattina sono partiti e che non erano arrivati che sino alle Tezze di Arzignano. Questa stessa notte ritornarono tutti a casa.Addì 9 Aprile, in giorno di domenica, alle ore 10 di mattina, i volon-tari recoaresi, che avevano qui passata la notte, ritornarono al loro paese».
Non c’è da meravigliarsi più di tanto dei contrattempi e della disorganiz-zazione che spesso caratterizzavano l’azione dei volontari, data la rapidità con cui gli eventi evolvevano; va ricordato d’altronde che a Sorio l’unico corpo franco di Crociati vicentini presente l’8 aprile fu quello di Schio.
Vedendo questi numeri, si potrebbe aprire una parentesi sulla partecipa-zione, sulla consistenza e l’estrazione sociale dei protagonisti. La storiogra-fia, e in particolar modo i testi scolastici, hanno consolidato l’idea di una
34 35
partecipazione elitaria alle guerre del Risorgimento italiano e soprattutto al contributo di idee e di proposte circa l’assetto istituzionale da scegliere dopo l’indipendenza e l’unificazione della penisola italiana.
A mio avviso, dopo aver scorso le pagine lasciate dal nostro cronista, tutto questo non è così scontato, o comunque merita una ricerca ed un approfon-dimento. Certamente, anche a Valdagno i protagonisti della ‘rivoluzione’ del 1848 furono esponenti della borghesia locale, intellettuali e studenti aperti alle idee che circolavano nonostante il rigido controllo dei dominatori au-striaci. Certamente la classe contadina nella sua quasi totalità e soprattutto la popolazione delle contrade e delle frazioni erano sostanzialmente estranee ai fatti ed alle idee. Ma, come documenta la Cronaca del Soster, furono alcune centinaia i volontari che a Valdagno (ed in misura notevole successe lo stes-so anche nei centri limitrofi di Recoaro e Cornedo), parteciparono in armi o comunque in modo attivo agli eventi storici della primavera del 1848. Due, trecento persone, in massima parte giovani, che rispondono idealmente e concretamente, che controllano armati il paese in vista di un eventuale ritiro di soldati austriaci, che accorrono in difesa di Vicenza, che si portano ripe-tutamente - come si vedrà fra poco - a Campogrosso e a Pian delle Fugazze per tagliare la strada ai rinforzi in arrivo di truppe austroungariche, sono un numero di tutto rilievo per un paese, Valdagno centro, che contava allora poco più di 3000 abitanti. I nomi riportati e la logica ci dicono inoltre che un notevole contributo arrivò dagli artigiani e dagli operai, che avevano a Valdagno una consistenza ed una importanza molto rilevanti. Si tentò perfi-no di coinvolgere la classe contadina ed a dircelo è ancora il Soster, quando scrive nella pagina del 6 Aprile: «Sono stati avvertiti anche i nostri contadini per armarsi ed unirsi a quei del paese per marciare, onde difendersi dai Te-deschi».
I giorni che seguirono la sconfitta di Sorio furono ovviamente giorni di apprensione e di profughi in arrivo, che il Soster registra puntualmente:
«Addì 9 Aprile arrivarono qui molte famiglie di contadini coi loro animali e carri carichi di pastura; famiglie di possidenti civili con carrozze e timonelle, artigiani con carretti, tutti fuggiti da Monte-bello, Sovizzo, Sorio ed anche da Castelgomberto, spaventati ed intimoriti dalle stragi e dai danni che fanno i Tedeschi ove sono di passaggio o di stazione.Addì 10 Aprile, giorno di Lunedì, poco prima di sera si è sparsa nel paese la voce che alla Selva, Quargnenta e Piana suonavano campa-na martello, perché erano stati visti dei Tedeschi fuggitivi. A siffatta notizia qui vi fu un grande scompiglio. Le donne piangevano e si
36 37
nascondevano e si chiusero tutte le botteghe. La guardia civica gi-rava in pattuglie. Fortunatamente nulla avvenne di sinistro ed alla mattina dell’11 si è saputo che a Nogarole erano stati arrestati otto Croati disertori».
Serve ancora ribadire - per quanto riguarda le compagnie dei volontari Crociati e i componenti delle Guardie civiche - che all’entusiasmo e al pa-triottismo si accompagnavano impreparazione, armamento inadeguato e tal-volta l’indisciplina di chi non era mai stato sotto le armi. Il Soster stesso, nel giro di pochissimi giorni, nei loro confronti passò dall’ironia al sarcasmo. Scriveva infatti il 19 aprile:
«Addì 19 Aprile, in giorno di Mercoledì Santo, poca pioggia. Alle ore 3 pomeridiane arrivò a Valdagno una compagnia di Crociati in numero di sessanta circa, la maggior parte Vicentini, armati tutti di fucile. Furono ricevuti col suono delle campane dalla banda civica e dalla guardia nazionale. Aveano per loro capo un sacerdote che portava la bandiera, ed un frate francescano stava di dietro alla com-pagnia. Entrarono tutti a riposarsi nel corpo di guardia. A motivo del cattivo tempo si trattennero qui anche il Giovedì Santo.Addì 21 Aprile, il giorno di Venerdì Santo, li suddetti Crociati sono ripartiti per andare ad Arzignano. In questa compagnia vi erano delle figure che facevano paura, perché sembravano tanti assassini da stra-da. Una delle sue tante azioni di eroismo operate fu quella di levare alcuni piccoli stemmi di latta coll’Aquila Imperiale, che servivano per indicare al pubblico che queste case ove stavano esposti erano assicurate dagli incendi».
I volontari valdagnesi ebbero comunque modo, di lì a qualche giorno, di riscattarsi e di far valere la loro determinazione. Alcuni giorni dopo si ve-rificarono infatti scontri armati nella zona di confine Pian delle Fugazze /Campogrosso ed un centinaio di Crociati valdagnesi partirono subito. Soster annota, passando disinvoltamente dalla critica ai Crociati all’ammirazione:
«Addì 25 Aprile, giorno di Martedì, terza festa di Pasqua e San Mar-co, venne qui la notizia che alcuni Croati si battono sul Pian della Fugazza, coi volontari di Valli e di Schio; perciò anche dei nostri volontari, circa venti, partirono subito per andare ad aiutare i loro fratelli.Addì 26 Aprile partirono da qui altri settanta volontari allo scopo di
36 37
accorrere in aiuto agli altri. Poco prima della sera calarono giù dai monti di Castelvecchio, per la strada di Campotamaso e provenienti da Chiesanuova, i Crociati per andare a Recoaro in assistenza agli altri che ivi si trovavano, per battersi coi Tedeschi e difendere le strade del Tirolo.Addì 27 Aprile, in giorno di Giovedì, alla sera ritornarono a Valda-gno alcuni dei suddetti volontari che sono stati sino a Vallarsa e gli altri sono ritornati il giorno 28.Addì 29 aprile, giorno di Sabato, circa alle ore 11 antimeridiane, venne la nuova che in Campogrosso vi son dei Tedeschi e fu detto che anche a Valli vi è un combattimento. Questa notizia ha fatto mettere in agitazione tutto il paese».
Oltre un mese dopo, a Campogrosso ci furono ancora scontri con reparti austriaci ed accorsero anche i volontari valdagnesi:
«Addì 8 Giugno, di mattina sono partiti per Campogrosso alcuni de’ nostri volontari per dare rinforzo a quelli di Schio e di Recoaro che combattono contro i Tedeschi.Addì 9 giugno (…). Questa mattina fu recato qui l’avviso che sul Pian della Fugazza vi è un combattimento e che occorre un rinforzo a quei volontari che son partiti ieri; perciò sul mezzodì partirono altri giovani armati volontari».
La Deputazione comunale ed il Comitato provvisorio valdagnesi sentivano comunque l’esigenza di avviare forme di addestramento dei volontari, per inculcare un po’ di disciplina, soprattutto nel delicato compito della sorve-glianza. Tra i documenti originali che Soster raccolse e conservò c’è - ed è solo un esempio - questo rapporto inviato dalla pattuglia di ispezione al Comitato valdagnese, circa l’indisciplina che non di rado dimostravano le guardie di sorveglianza poste sul campanile:
«Guardia Civica di Valdagno. Nella notte 16 maggio, ore 1 e un quarto antimeridiane, Angelo Pozzan sergente d’ispezione e Michele Pizzati caporale d’ispezione rappresentano come, essendosi porta-ti verso il campanile nell’ora suddetta, trovarono la sentinella ivi collocata per nome Rella Giovanni, profondamente addormentata e sdraiata sulla soglia, con il fucile abbandonato ad un pilastro della soglia medesima. Il caporale tolse il fucile, al chè la sentinella diede segno di svegliarsi, di sognare, e pareva anche tuttora trasportata dal
38 39
vino. Ripresa severamente e minacciata di severo castigo, partimmo e qui recati estendemmo il presente rapporto, che da noi sottoscritto si rassegna al Comando, affinchè prenda le misure che crederà con-venienti. Angelo Pozzan, Michele Pizzati».
Ecco allora le iniziative per l’addestramento, che Soster più volte riporta; qualche esempio:
«29 Aprile. Nella Corte vicina alla sala del Corpo di Guardia civica s’istruiscono quelli che volontariamente si sono inscritti nella Guar-dia civica. Gli istruttori sono Andrea Fiori di Angelo ed Agostino Fontana di Federico, il quale è stato militare. Le manovre si fanno nel praticello dinanzi la chiesa di San Cristoforo. Dal corpo di guar-dia si levano ogni giorno cinque guardie, le quali fanno la sentinella all’ufficio commissariale, alla regia Pretura, all’ufficio comunale, alla casa del primo deputato sig. Giuseppe Cengia-Bevilacqua, in casa del quale vi sono le radunanze del Comitato ed al campanile; al campanile la sentinella vi sta anche di notte e si dà il cambio ogni due ore. Il signor Girolamo Marangoni fu anche lui, benché in avanzata età, tutto armato sulle montagne di Recoaro per unirsi alli Crociati e combattere col nemico, se gli si fosse presentata l’occasione. Ora da pochi giorni in qua, egli radunò molti giovanetti del paese, dell’età di circa 15 anni e li armò di piccolo schioppo e li istruisce a maneg-giarlo e qualche volta li fa girare pel paese a due a due tutti colla loro arma sulla spalla, affinché siano veduti pubblicamente».
Un piccolo salto, ora, dagli eventi alle idee. A Vicenza - lo si è visto in pre-cedenza - c’era stata fin dall’inizio una certa freddezza verso l’idea di entrare nel progetto di una Repubblica Veneta autonoma. Il partito filoveneziano perse rapidamente terreno e si fece definitivamente strada il partito filosabau-do, favorevole alla creazione di uno stato unitario guidato dalla monarchia piemontese.
Anche nei nostri paesi i più informati partecipavano a queste scelte: come si può ben immaginare erano i giorni convulsi delle decisioni rapide, prese giorno per giorno. In una lettera del 24 aprile, il canonico Ludovico Gonzati scriveva al padre Vincenzo dei marchesi Gonzati, che aveva villa di residen-za e beni a Cornedo, dove la famiglia era radicata da oltre quattro secoli: «Il nome di Carlo Alberto ora torna grato e desiderabile a tutti e odioso quello della Repubblica Veneta, la quale diede ben a vedere che voleva solo pensare
38 39
a sé e non stendere il pensiero alla grande unione italiana».E puntualmente Soster ci ricorda come a Valdagno ci si apprestava alla
scelta filopiemontese: lo fa riportando due sottoscrizioni che il comitato lo-cale fece girare il 27 e 28 aprile:
«Nei giorni 27 e 28 Aprile il signor Giobatta Tomba, uno dei segre-tari di questo Comitato, andò in giro per il paese a ricevere le sotto-scrizioni sotto la Protesta che si deve fare contro la Repubblica di Venezia; e nello stesso tempo far sottoscrivere da tutti un Indirizzo da presentarsi a sua maestà Carlo Alberto, nel quale dichiariamo di sottomettersi a lui».
Il 16 maggio 1848 il Comitato provvisorio di Vicenza, ormai apertamen-te votato alla causa unitaria monarchica, indisse un plebiscito da estendere a tutta la popolazione della città e della provincia. La gente era invitata a esprimere la preferenza fra l’immediata adesione al Piemonte e il rinvio della scelta dopo la definitiva liberazione dall’Austria.
Anche in questo caso Soster trascrisse il proclama che arrivò da Vicen-za: la sede per la votazione era l’ufficio parrocchiale, che sarebbe rimasto a disposizione tutti i giorni fino al 29 maggio. Il nostro cronista non riportò i risultati locali di questa che fu per i Valdagnesi la prima storica consultazione di massa, risultati che comunque conosciamo da altre fonti15. 56.328 Vicenti-ni espressero la volontà di immediata unione allo Stato sabaudo, 520 dopo la partenza degli Austriaci. Da questo computo è esclusa la zona di Bassano e solamente l’Altopiano di Asiago si smarcò da questa decisione, deliberando di restare con la Repubblica di San Marco.
La scelta era, per la precisione, tra la «immediata unione agli Stati Sardi» e la «dilazione del voto». La votazione nel distretto di Valdagno fu un plebi-scito per l’unione immediata al Piemonte, scelta che raccolse 3941 voti; una persona solamente, appartenente alla parrocchia di San Clemente, si espresse per la dilazione della scelta istituzionale e non è da escludere che sia stato proprio il nostro cronista, il cui disincanto verso i convulsi eventi storici della prima guerra d’Indipendenza era già evidente. I risultati, divisi per par-rocchie, furono i seguenti:
Recoaro 544 / 0; Rovegliana 156 / 0; Fongara 16 / 0; Valdagno 813 / 1; Ca-stelvecchio 215 / 0; Piana 187 / 0; Cerealto 39 / 0; Novale 275 / 0; Cornedo 421 / 0; Muzzolon 89 / 0; Cereda 141 / 0; Brogliano 130 / 0; Quargnenta 210 / 0;
15. Archivio di Stato di Vicenza, Proclami del Comitato provvisorio Dipartimentale di Vicenza, 1 giugno 1848.
40 41
Castelgomberto 366 / 0; Trissino 218 / 0; Selva di Trissino 121 / 0.Vicenza rimaneva sotto tiro degli Austriaci e dopo i vani tentativi del 20 e
24 maggio, quanto la città si difese eroicamente e respinse gli attacchi sulle barricate, il feldmaresciallo Radetzky si avvicinò alla città con un esercito di 40.000 uomini, sorretto da una potente artiglieria. Il 10 giugno, alle 4 del mattino, sferrò l’attacco decisivo. Alla sera, a battaglia perduta, i Vicentini cominciarono la conta dei 1500 caduti nel corso dei furiosi combattimenti di Monte Berico. Vicenza tornava, dopo meno di tre mesi, sotto la dominazione austriaca e ci resterà per un altro ventennio, fino al 1866.
A Valdagno la notizia arrivò dopo mezza giornata e la Cronaca del Soster riporta laconicamente:
«Addì 11 Giugno, domenica di Pentecoste, alla mattina nessuna no-tizia; dopo mezzodì venne recata questa tristissima, che cioè Vicenza ha capitolato, la qual cosa fu in generale sentita con forte dispiacere. Venne tosto da qui spedito un espresso a Recoaro, onde avvertire del doloroso fatto i nostri volontari che erano partiti l’altrieri per le montagne e consigliarli a ritornare a casa. Nella notte infatti furono qui tutti.Addì 12 Giugno, in giorno di Lunedì, seconda festa di Pentecoste, fu deliberato prudentemente di sciogliere la Guardia civica e di chiude-re il locale che serviva di corpo di guardia. In tutta la giornata regnò in tutti una grande tristezza, dispiacere ed avvilimento. Quelli che portavano distintivi italiani di Libertà li levarono».
Nella medesima giornata, passata la buriana, Giovanni Soster riportò alcu-ni aneddoti riferiti ai giorni della ‘rivoluzione’ appena terminata, annotazioni di colore, ma non privi di importanza:
«Durante la passata epoca di Libertà, Luigia Mistè, moglie di Dome-nico Avancini, diede alla luce una bambina, alla quale venne impo-sto il nome di Italia Libera. E Domenica Scocco, moglie di Andrea Randon, partorì un figlio, al quale fu dato il nome di Carlo Alberto.Nel tempo suddetto di Governo Libero si è fatto generale l’uso di portare i mustacchi e la barba lunga».
Il 14 giugno era già tornato nel suo ufficio a Valdagno l’imperial regio commissario e le aquile imperiali furono rimesse in tutti i luoghi pubblici. Era anche l’ora delle fughe, degli esili forzati, delle requisizioni:
40 41
«Addì 24 giugno, in giorno di Sabato, ore 10 della mattina sono ar-rivati qui un corpo di militari Cacciatori, parte Tirolesi e parte delle nostre province: sono circa 120 uomini con 10 soldati di cavalleria ed andarono ad alloggiare in casa del signor Giobatta Bevilacqua-Mastini, un tempo convento dei padri Francescani. Essendosi qui potuto sapere qualche ora prima che arrivassero questi militari, i no-stri capi della guardia civica e quelli che sono stati Crociati, fuggiro-no subito dal paese ed andarono a nascondersi per i monti. Antonio Fiori, membro del Comitato e capo dei rivoluzionari, si è nascosto al Castello in casa dei Magaraggia. I giovani signori Gaetano Orsini, Fiori Giovanni e Soster Angelo partirono per la Toscana. Fiori An-tonio, Zenere Antonio, Dalle Ore Luciano, Bordignon Giuseppe e Rella Giovanni fuggirono a Venezia.Appena qui arrivati li suddetti militari Cacciatori, fu dal comandante pubblicato un avviso affisso per tutte le contrade del paese per la requisizione di tutte le armi da fuoco e da taglio, le quali dovranno essere consegnate in caserma alle ore 7 della sera; e pel giorno 25 a mezzodì in punto dovranno essere consegnate tutte quelle dei co-muni del nostro Distretto, sotto pena della legge marziale o giudizio statario per chi gli si fosse trovata un’arma in casa. Il numero delle armi consegnate ammonta ad ottocento, e sono state trasportate a Vi-cenza sopra quattro carretti il detto giorno 25 alle ore 5 pomeridiane, scortate da due soldati per carretto. Nel breve tempo che furono qui questi soldati, uno disertò. Il capitano domandò più volte del signor Francesco Tomba e di alcuni altri che facevano parte dei Crociati, ma erano già fuggiti per timore di essere arrestati».
La prima guerra di Indipendenza, nella sua fase del 1848, continuò fuori Vicenza. Arrivarono i rinforzi austriaci chiesti dal feldmaresciallo Radetzky ed il 25 luglio l’esercito piemontese venne sconfitto a Custoza; il 9 agosto venne firmato l’armistizio con l’Austria.
A questo punto la cronaca del Soster torna a riempirsi di notizie locali, dei suoi sfoghi personali contro qualche patriota valdagnese di primo piano (ce l’aveva in modo particolare con Andea Fiori), del tempo e dei prezzi dell’uva e delle gallette. Si riportano solo alcuni esempi.
Nel settembre 1848 ripresero i lavori per la costruzione del nuovo palazzo comunale, interrotti dagli avvenimenti bellici; ci fu poi l’interruzione inver-nale, si ricominciò ai primi maggio del 1849 ed i lavori vennero definitiva-mente ultimati nel novembre 1850.
Il 2 luglio 1849 si diede inizio alla demolizione del vecchio ospedale di
42 43
San Lorenzo, presente a Valdagno e documentato già dal XV secolo.Il 1 gennaio 1849 arrivò a Valdagno il primo giornale francese: LE
JOURNAL DES DÉBATS, quotidiano politico che si stampava a Parigi al quale si era abbonata la farmacia Orsini: ogni sera, i migliori esponenti dell’ intellighenzia valdagnese - scrive Soster - «passano alcune ore in amichevole conversazione».
Nell’economia di questa ricerca su Valdagno nella prima guerra d’Indi-pendenza, l’anno 1849 ha indubbiamente un peso inferiore al 1848. I teatri di guerra, di insurrezione, di esperienze repubblicane o di strenua resistenza nel 1849 erano lontani dal nostro territorio: a marzo la guerra riprese, ma si chiuse in 2 giorni con la disastrosa sconfitta di Novara; in agosto Venezia fu l’ultima ad arrendersi all’assedio austriaco.
A Valdagno, il ritorno alla normalità comunque non fu semplice. Le autori-tà austriache, nel tentativo di instaurare un rapporto meno teso con le popola-zioni tornate in loro dominio, proclamarono amnistie e perdoni, richiedendo in cambio il ritorno dei disertori e la consegna delle armi.
Il problema dei disertori e soprattutto quello della renitenza alla leva erano infatti una spina sul fianco per gli Austriaci ed un fenomeno alquanto diffuso nei nostri paesi, soprattutto quelli di collina. Per quanto riguarda specifica-tamente Valdagno, la cronaca del Soster, lungo i mesi del 1849, contiene parecchi riferimenti a questo e qui si riporta solo qualche accenno.
Le autorità austriache, quando vedevano che un paese non effettuava con successo la leva e non forniva il numero di soldati stabilito, interveniva im-mediatamente inviando truppe (che bisognava alloggiare), comminando multe severissime ed esigendo che altri giovani sostituissero i renitenti. Scri-veva il Soster:
«Addì 16 Gennaio, in giorno di Martedì, ad un ora di notte sono arrivati a Valdagno 120 militari Croati per prendere i soldati in per-messo, i quali sono fuggiti per non volersi presentare. (…) Nessuno dei soldati in permesso si è presentato e perciò il comandante ha imposta al nostro Comune una multa di Austriache lire diecimila; ma la Deputazione si è interposta ed ottenne dal Comandante di ridurla in Austriache lire 6000, che prontamente fu pagata in austriache lire effettive. Dopo di che i militari partirono da Valdagno alle ore 3 pomeridiane del giorno 17, diretti per Vicenza. Alcuni dei nostri gio-vani si sono allontanati dal paese in questi due giorni che furono qui i militari, per timore di essere presi e fatti soldati. Il comandante fece chiamare in casa del sig. Cengia-Bevilacqua, ov’era alloggiato, il re-
42 43
verendo arciprete don Annibale Pozzan ed Antonio Fiori fu Andrea, il primo perché debba, dopo letti i proclami dall’altare, aggiungere raccomandazioni ed eccitamenti alle famiglie perché si presentino i militari in permesso ed i disertori, il secondo perché debba regolarsi per l’avvenire di non parlare contro il governo».
Una decina di giorni dopo si doveva effettuare l’estrazione dei coscritti, ma l’operazione incontrò subito grosse difficoltà:
«Oggi 27 gennaio dovea aver effetto l’estrazione a sorte dei coscritti, ma i giovani che doveano presentarsi non sono intervenuti, a motivo che si trovavano ancora qui i soldati Croati. (…) Addì 29 gennaio, in giorno di Lunedì, dovea seguire l’estrazione dei coscritti che non ha avuto luogo il dì 27 corrente, ma neppure in questo giorno è stata eseguita, benché si siano presentati i coscritti, i quali, invece di estrarre, fecero una formale dichiarazione che essi saranno pronti ad estrarre il numero quando si presenteranno anche gli assenti. Così si licenziarono senza estrarre».
La situazione si profilava senza via d’uscita ed incombevano le multe, oltre all’obbligo di alloggiare truppe di cento e più Croati che puntualmente arri-vavano. Riporta la Cronaca:
«Addì 5 Febbraio, giorno di Lunedì, nell’oratorio annesso alla chiesa parrocchiale fu tenuta un’adunanza di tutti i capi di famiglia di Val-dagno per deliberare intorno alle misure da prendersi, per fare che si presentino nel tempo stabilito i militari in permesso ed i disertori; e fu conchiuso di persuaderli possibilmente mediante un’offerta in denaro per cadauno perché si presentino, e questa somma metterla a carico del Comune; il quale poi riceverebbe di ritorno le Austriache lire 6000 che ha già pagato di multa, e non andrebbe soggetto ad una seconda multa del doppio.(…) Addì 7 febbraio, giorno di mercoledì, per la terza volta fu de-stinato di estrarre il numero dei coscritti della leva 1848, ma si sono rifiutati per le stesse ragioni dell’altra volta».
Verso la fine del mese di Febbraio, il quarto tentativo riuscì, almeno in parte:
«Addì 24 Febbraio, giorno di Sabato, alle ore 4 pomeridiane, sono
44 45
venuti a Valdagno 150 Croati da Vicenza, e furono alloggiati nei locali medesimi dell’altra volta.Addì 25 Febbraio, giorno di Domenica, hanno dovuto venire a Val-dagno tutte le Deputazioni Comunali del nostro Distretto (eccettuata quella di Recoaro) coi loro reverendi parrochi, per assistere all’estra-zione dei coscritti della leva 1848; e l’estrazione ebbe effetto in uf-ficio dell’imperial regio commissario distrettuale. Essendovi com-parsi pochissimi dei coscritti, per gli assenti entrassero il numero l’autorità militare. Nella notte alcuni picchetti di soldati girarono pel paese, accompagnati dalle nostre guardie di Sicurezza e da altre ve-nute in sussidio da Vicenza, alcune delle quali girarono pei monti, onde arrestare i militari in permesso che non vogliono presentarsi ed i disertori; e non trovandoli arrestarono o il padre o il fratello del disertore, o coscritto assente. In queste stesse notti arrestarono anche dei malviventi del paese e anche quelli che volevano bastonare le guardie di Sicurezza la prima sera di Quaresima per un arresto che le medesime avevano fatto l’ultima sera di Carnevale; e che appunto per questo arresto le guardie hanno dovuto allontanarsi dal paese; ma vi sono poi ritornate, accompagnate dai Croati».
L’azione repressiva e di meticolosa perlustrazione del territorio da parte degli Austriaci si faceva sempre più pressante, a Valdagno e in tutta la valle:
«Addì 4 Marzo, giorno di Domenica, alle ore 10 antimeridiane, fu-rono qui di ritorno i militari da Recoaro. Questa visita a Recoaro dei soldati fece l’effetto che i Recoaresi pagarono le pubbliche contri-buzioni che per lo passato non hanno voluto pagarle. In questa stes-sa mattina, all’ora medesima, arrivarono qui 150 militari Cacciatori provenienti da Castelgomberto, ma divisi parte pei monti di Cornedo e parte per quelli della Piana, ove fecero delle perquisizioni per le case per trovare armi.Addì 5 marzo, giorno di Lunedì, alle 6 di mattina, ripartirono da Valdagno i militari Cacciatori, conducendo seco due arrestati, uno di Castelgomberto e l’altro di Valdagno, contrà Stupenda, per avere a questo ultimo trovato in casa un calcio di schioppo. Presero la strada di Castelvecchio per recarsi nella valle di Altissimo. Oggi stesso si sono presentati a Vicenza i coscritti della leva 1848, in sostituzione dei militari in permesso o disertori che non vogliono presentarsi».
Questi ultimi erano evidentemente quelli che avevano accettato l’offerta
44 45
in denaro dal comune, stufo di pagare multe salatissime. Ma le difficoltà ad effettuare una coscrizione regolare non cessarono: il 9 marzo arrivò un’altra multa di 10.000 Lire austriache ed arrivarono altri 130 militari Croati. In questa circostanza il deputato Francesco Marzotto e il consigliere comunale Francesco Rottigni, presentatisi a Vicenza, riuscirono a fare sospendere il provvedimento.
Tempo una settimana e la cosa tornò a ripetersi: questa volta gli ammi-nistratori di Valdagno tentarono un’azione preventiva, che però non ebbe effetto, anzi mandò su tutte le furie le autorità militari cittadine:
«Addì 16 Marzo, giorno di Venerdì, venne la notizia che i milita-ri che si trovano in Arzignano a riscuotere una multa di austriache Lire 5000 imposta a quel Comune, possano poi passare a Valdagno. Pertanto la mattina del Sabato 17 Marzo partirono per Arzignano il signor Marzotto Francesco deputato ed il Signor Francesco Rottigni, per verificare questa notizia. Sulla sera sono ritornati e purtroppo hanno riscontrato esser vero che i militari sarebbero venuti a Valda-gno. In conseguenza li predetti signori Marzotto e Rottigni il giorno 18 andarono a Vicenza a presentarsi al colonnello per ottenere la so-spensione della venuta dei soldati. Intanto alla mattina medesima arrivarono qui 150 Cacciatori. Alla sera ritornarono da Vicenza li signori Rottigni e Marzotto, i quali non hanno potuto ottenere nulla; anzi il colonnello disse loro, molto adirato, che Valdagno è un paese rivoluzionario, degno di castigo e che, se succederanno nuovi disor-dini, manderà anche la cavalleria».
Puntualmente, il giorno successivo arrivò una multa di Lire austriache 5000: ormai il comune non aveva più denaro in cassa e dovette contrarre un debito con i 30 valdagnesi più ricchi.
Nell’estate del 1849, il problema dei disertori e dei renitenti era ancora all’ordine del giorno. Lo sappiamo, in questo caso, da documenti ufficia-li, che peraltro sono conservati grazie a Giovanni Soster. Il 21 luglio 1849, su sollecitazione del commissario regio di Valdagno, il comando militare di Vicenza inviò a Valdagno una truppa di militari «onde tentare l’arresto dei disertori e male intenzionati». Contestualmente tutte le deputazioni comu-nali del distretto vennero invitate a collaborare: «Al presentarsi della forza militare in luogo siano ad essa offerte in via riservata opportune e concrete facilitazioni per facilitare l’arresto delle piccole bande di disertori, che tratto tratto si lasciano vedere nei rispettivi comuni. Pertanto attiveranno caute ri-
46 47
cerche allo scopo contemplato». Alcuni elementi di queste «piccole bande di disertori» provenivano da
Roma, dove avevano combattuto per la Repubblica Romana e da dove era-no stati allontanati con un lasciapassare rilasciato dall’ambasciata bavarese, subito dopo l’occupazione della città da parte dei Francesi, avvenuta nei pri-missimi giorni di luglio 1849. Questo si evince da una lettera dell’imperial regio commissario provinciale Piombazzi inviata al sottoposto di Valdagno, Cardin, invitati a sottoporre a stretta sorveglianza i disertori in arrivo:
«Dopo l’occupazione di Roma per parte delle truppe francesi, tutti i forestieri in servizio militare comune, fra i quali si trovava un nu-mero considerevole di Lombardi e di Veneti, ebbero l’ordine di rim-patriare. In conseguenza di ciò, molti dei medesimi vennero muniti dalla regia ambasciata bavarese - la quale accorda la propria prote-zione ai sudditi austriaci ivi dimoranti in seguito allo scioglimento dell’imperiale regia ambasciata austriaca a Roma - dei passaporti con l’indicazione “pour se rendre de retour dans sa patrie”. Tali in-dividui ritornando in patria dovranno, previa energica ammonizione mediante processo verbale, essere regolarmente tenuti in evidenza e sottoposti a possibilmente esatta sorveglianza»16.
Nell’ottobre del 1849 venne rinnovata l’amnistia per disertori e renitenti, e l’imperial regio commissario di Valdagno comunicò alla deputazione comu-nale le grazie concesse ad alcuni disertori valdagnesi:
«Si sospenderà immediatamente l’esazione della taglia a carico dei sotto indicati disertori, essendo gli stessi nella grazia del per-dono generale: Bicego Domenico, Franceschi Giambattista, Za-rantonello Giacomo, Bicego Giuseppe, Zenere Luigi, Marchesini Gerolamo»17.
Il controllo poliziesco diventava, anche nella Valle dell’Agno, sempre più rigido e ossessivo. Il delegato provinciale Antonio Piombazzi, dopo un non ben precisato «fatto grave» successo a Quargnenta, inviò pattuglie per ef-fettuare retate e accentuare la sorveglianza; ordinò ripetutamente di porre «taglie» sulla testa dei disertori e arrivò ad inviare a tutti i sindaci della valle, tramite il commissario distrettuale di Valdagno, proclami che arrivavano a
16. BBV, ms. DO 56.17. Ibidem.
46 47
sfiorare il ridicolo. Uno di questi, che anche i parroci del valdagnese do-vettero leggere dal pulpito, proibiva ai contadini di portare con loro, alla domenica e alle altre feste comandate, «gli strumenti dei quali si servono per coltivare le viti e gli alberi»; seguiva, in perfetto stile austriaco, un dettaglia-to elenco: «falci, falcetti, potatoj, coltelli adunchi, coltelloni, coltellaccini, roncoletti, roncoloni».
Indizio significativo di come ormai le notizie relative alla situazione mili-tare, politica e istituzionale non rivestissero più grande importanza per Gio-vanni Soster è la laconicità con cui riportò la notizia della resa di Venezia, ultima città d’Italia ad essere presa dagli Austriaci, notizia liquidata in due righe senza commento:
«Addì 23 Agosto, giorno di Giovedì, il Governo provvisorio di Ve-nezia ha dovuto capitolare e rendersi all’Austria».