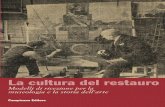Tommaso Gnoli
Transcript of Tommaso Gnoli
Tommaso Gnoli
' I ^ommaso Gnoli (che dal 1914 iniziò a fir-. . marsi abitualmente Tomaso e usò occa
sionalmente anche Tom) nacque a Roma il 18 licembre 1874 dal conte Domenico (Roma 6 :-.ovembre 1838-Roma 12 aprile 1915), letterato, professore e dal 1° ottobre 1881 Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, r da Giuseppina Angelini (Perugia 25 aprile ì843-Roma 11 novembre 1896). Primo figlio maschio dopo due sorelle (Ester e Maria), di quattro anni maggiore di Umberto, lo storico dell'arte, fu sempre legatissimo al padre, di cui sentiva di dover seguire le orme e di cui difese sempre la memoria e la fama.
Dopo gli studi secondari al Liceo "Ennio Quirino Visconti", dove fu compagno di Eugenio Pacelli, i l futuro Pio X I I , frequentò la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, laureandosi in Lettere nel novembre 1899, dopo un'interruzione dovuta al servizio militare, in irtiglieria. Dal 1° dicembre 1900 venne nominato assistente del Gabinetto archeologico della Facoltà, diretto da Emanuele Loewy, lavorando i l Museo dei Gessi e frequentando nel frattem-00 il corso di perfezionamento per gli studi di storia dell'arte medievale e moderna avviato nel 1901 da Adolfo Venturi, che era fra l'altro molto amico del padre.
Già da studente aveva cominciato a collaborare a varie riviste letterarie con alcune poesie (il debutto è forse Fiesole, pubblicata su «Roma letteraria» del 15 luglio 1894), che raccoglierà nel 1898 nel volumetto Prime rondini edito a Firenze dal Bemporad (ma stampato a Roma), e articoli di critica letteraria e artistica, tra i quali la presentazione della traduzione di Pirandello delle Elegie romane di Goethe, sulla «Rassegna settimanale universale» (1896), e i l breve saggio sulle Myricae del Pascoli uscito sul «Fanful-la della domenica» (1897). Collaborava inoltre alla redazione della «Rivista d'Italia», fondata dal padre nel 1898. Dell'ambiente letterario romano intorno alla fine del secolo pubblicò poi due rievocazioni, incentrate sulla cerchia di Ugo Fleres e sul salotto di Ludovico Muratori.
Preparandosi insieme a Luigi de Gregori, di cui era già amico, prese parte al concorso per sottobibliotecario nelle biblioteche governative bandito nel luglio 1902, classificandosi al sesto posto. I l bando prevedeva tre posti e la copertura delle ulteriori vacanze che si verificassero entro l'anno e quindi due mesi dopo le prime nomine dei vincitori anche lo Gnoli venne chiamato a prendere servizio, dal 1° luglio 1903, come sottobibliotecario reggente, destinato a Roma alla Biblioteca Angelica. Con la fine dell'anno
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
accademico 1902/03 lasciò quindi i l posto di assistente all'Università. Nello stesso anno uscì anche i l suo volume sulle Satire di Giovanni Gi-raud, dedicato all'amico Ettore Romagnoli.
Conseguita i l 1° agosto 1904 la nomina a sottobibliotecario di 4* classe, fu addetto in questo periodo alla catalogazione per autori e per soggetti, occupandosi anche del censimento dei manoscritti e delle edizioni petrarchesche, collaborando agli acquisti e reggendo la direzione della Biblioteca nei periodi di assenza di Gennaro Buonanno. Dal 1° gennaio 1906 venne trasferito, per esigenze di servizio, alla Biblioteca Alessandrina, ed esattamente un anno dopo alla Biblioteca Casanatense, allora diretta da Ignazio Giorgi, dove fu responsabile inizialmente dell'ufficio acquisti, collaborando anche alla catalogazione, e poi dal marzo 1908 del prestito.
In quegli anni i suoi interessi si orientarono definitivamente verso la cultura tedesca, a cui era del resto legato anche per circostanze personali. I l 18 luglio 1898 aveva sposato una gentildonna di famiglia tedesca che viveva a Roma, Gabriella von Tettenborn (Marsiglia 3 agosto 1872-Milano 19 marzo 1934), e i l 24 febbraio 1900, a Roma, sua sorella Ester (Roma 25 giugno 1868-Monaco di Baviera 13 novembre 1922) aveva sposato i l filologo Karl Vos-sler, molto legato in Italia a Benedetto Croce. Da Gabriella ebbe cinque figli: i l primogenito Adolfo morto di pochi mesi (Roma 17 agosto 1899-Roma 12 gennaio 1900), poi Aldo (Roma 19 gennaio 1901-Roma 16 settembre 1968), Marina Jacovella (Roma 6 giugno 1906-As-sisi 8 gennaio 2001), Giulio (Roma 3 maggio 1909-Milano 8 marzo 1988), che sarà professore di filosofia e traduttore, e Maria Teresa (Roma 25 ottobre 1913-Roma 14 dicembre 2000), che seguirà la carriera del padre e del nonno arrivando a dirigere la Biblioteca Casanatense.
Vossler aveva recensito benevolmente i l volume di Tommaso su Giraud e quando, per interessamento di Croce, Laterza decise di pubblicare un'edizione italiana del suo volume Positivismus und Idealismus in der Sprachwis-
senschaft Tommaso si volle assumere i l compito della traduzione, che vide la luce dopo parecchie traversie e ritardi nel 1908. In seguito, oltre ad altri due volumi del cognato, lo Gno-h tradusse - ricorrendo spesso all'aiuto della moglie, che ringraziò al principio del Leopardi di Vossler - anche novelle, romanzi e biografie, per Mondadori e altri editori, e alcune delle sue versioni sono tuttora ristampate. Ma mentre quest'attività era motivata soprattutto dall'esigenza di integrare lo stipendio e sostenere la famiglia, particolarmente dopo la morte del padre e del marito della sorella Maria, i suoi interessi andavano alle traduzioni poetiche (da Eduard Mòrike, Emanuel Geibel, Richard Dehmel. Cari Spitteler, Heine e soprattutto Goethe), che iniziò a pubblicare dal 1910 su varie riviste e in volume, spesso accompagnandole con interventi critici. Interessi letterari e rapporti familiari lo condussero anche a vari soggiorni in Germania (a Heidelberg, Monaco, Berlino, ecc.), nell'autunno del 1905, alla fine del 1907 e poi ancora almeno nell'autunno 1921.
Nel 1910 chiese di essere trasferito alla Biblioteca "Vittorio Emanuele", per ampliare la sua esperienza e la sua preparazione in vista degh esami di abilitazione a bibliotecario, a cui intendeva concorrere, e la sua domanda venne appoggiata da Giuliano Bonazzi, che aveva sostituito Domenico Gnoli alla direzione della Nazionale e avrebbe voluto affidare a Tommaso i l completamento del catalogo per materie, lavoro interrotto da qualche tempo e adatto a un funzionario della sua levatura culturale, che per esigenze di servizio era invece addetto, nella Casanatense, alle attività più routinarie del prestito. La richiesta di trasferimento non ebbe esito ma dal marzo 1911, pur restando alla Casanatense, lasciò i l servizio del prestito per occuparsi della catalogazione della raccolta di stampe e della revisione del catalogo generale per autori, reggendo anche la direzione della Biblioteca nei periodi di assenza del Giorgi.
Nell'estate del 1911 venne bandito l'esame di abilitazione all'ufficio di bibliotecario, al-
322
Tommaso Gnoli
[ora molto severo e impegnativo, che si svolse nel maggio 1912 e in cui risultò quarto dei cinque idonei, seguendo Giulio Coggiola, Gaetano Burgada e Domenico Fava e precedendo questa volta l'amico De Gregori. Per la promozione alla categoria superiore, che poteva avvenire solo via via che si liberavano dei posti, dovette però attendere più di tre anni.
Con lo scoppio della guerra (luglio 1914) e fino all'intervento italiano svolse insieme al padre, a Cesare De Lollis e ad altri amici un'attiva propaganda per la neutralità e per i l mantenimento di buone relazioni con la Germania, intervenendo sul «Giornale d'Italia», collaborando al quotidiano «La concordia» e al settimanale «Italia nostra» e dirigendo, con P. S. Rivetta e Adriano Tilgher, la collanina di opuscoli «La guerra e l'Italia».
I l 1° luglio 1915 venne finalmente nominato bibliotecario di 5"" classe, ma già dal 10 maggio era stato incaricato di dirigere la Biblioteca Lancisiana, dove non molti anni prima era stato per qualche tempo "parcheggiato" suo padre al momento della sua rimozione, nel 1909, dalla direzione della Biblioteca Nazionale. Dopo i l "purgatorio" alla Lancisiana Domenico era stato trasferito alla direzione dell'Angelica e a seguito della sua morte i l Ministero, nel maggio 1915, aveva spostato dalla direzione della Lancisiana a quella dell'Angelica Domenico Ciampoli. Tommaso - caduta nell'estate del 1915 la sgradita ipotesi ventilata dal Ministero di nominarlo alla direzione dell'Universitaria di Pisa — seguirà lo stesso percorso tre anni dopo, assumendo la direzione dell'Angelica i l 17 agosto 1918, mentre Ciampoli tornò alla Lancisiana a concludere la carriera.
Con la riforma delle qualifiche, nel 1920, venne inquadrato come bibliotecario e poi, dal 1° gennaio 1924, trasferito alla direzione della Biblioteca Casanatense, liberatasi in dicembre per i l pensionamento di Giorgi. Per ottenere la direzione della Casanatense, dove a suo dire i l Giorgi avrebbe voluto invece che fosse nominato De Gregori, aveva rivolto pressanti istanze al
Ministro Gentile, che a seguito di ulteriori sue insistenti richieste relative a movimenti di personale lo aveva richiamato a un comportamento più disciplinato. Presso la Casanatense aveva sede («provvisoria» secondo i l R.D.L. 2 ottobre 1919, n. 2074, che aveva istituito le soprintendenze bibliografiche) la Soprintendenza per gli Abruzzi e i l Molise, affidata al Direttore della Biblioteca, ma a seguito della sostituzione di Giorgi i l Ministro preferì trasferirla, dal 1° febbraio 1924, presso l'Alessandrina (R.D. 7 febbraio 1924, n. 233), conferendo di conseguenza l'incarico di Soprintendente a Guido Calcagno, più anziano ed esperto dello Gnoli. I l 22 febbraio Gnoli passò quindi le consegne e l'archivio della Soprintendenza a Calcagno, senza averne mai esercitato le funzioni.
Con la nuova riforma delle carriere del 1923, nel maggio 1925 venne inquadrato come bibliotecario capo, dal 1° dicembre 1923, e subito dopo promosso per merito comparativo, con decorrenza 1° gennaio 1924, a bibhotecario-di-rettore di 2^ classe (gr. VII ) . Insieme a questa promozione, però, i l Ministero gli comunicava il suo trasferimento alla direzione della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, dal 1° settembre 1925, per l'esigenza di assegnare la direzione delle biblioteche maggiori ai funzionari di grado più elevato. Gnoli insistè in ogni modo per far revocare questo trasferimento, interessando anche i l Presidente del Senato Tittoni e minacciando di chiedere i l collocamento a r i poso, per le difficoltà familiari ed economiche a cui andava incontro, ma i l Ministero fu irremovibile e concesse soltanto un breve rinvio. In effetti trasferimenti così sgraditi non erano, fino a quel tempo, molto frequenti, ma probabilmente i l carattere e i modi dello Gnoli avevano già alimentato nel Ministero una disposizione poco favorevole, che segnò da lì in poi la sua carriera.
Assunta i l 21 ottobre 1925 la direzione della Braidense, dal 1° novembre venne nominato anche Soprintendente bibliografico per la Lombardia. Non trasferì però a Milano la famiglia, sperando, come scriveva scherzosamente (e
323
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
poco Opportunamente) al Ministro Fedele, che avessero deciso di tenerlo h solo per «qualche mese»; verrà raggiunto dai figli minori, uno alla volta, probabilmente alla conclusione degli studi liceali (nell'estate 1926 Jacovella, che si iscrisse all'Università Cattolica, due anni dopo Giulio e nell'ottobre 1931 Maria Teresa), e solo al principio del 1932 dalla moglie, già gravemente malata, mentre resterà a Roma i l primogenito Aldo.
Pochi giorni dopo il suo arrivo, i l 6 novembre 1925, scriveva a Luigi de Gregori: «La città, col suo lusso americano, sembra irridere ad un povero travet quale è di fatto i l Direttore d'una Nazionale in camera mobiliata. Ci sarebbero, è vero, occasioni di facili guadagni, ma tu conosci la mia inettitudine pratica e d'altronde sinora non ho avuto un minuto di respiro in ufficio, che è in uno stato pietoso, dopo tre anni d'interregno e i l periodo antecedente della guerra, che l'hanno rovinato: cataloghi con antichi sistemi, mancanza d'inventari, locali pubblici mal tenuti e peggio distribuiti; un baraccone, insomma, da riprendere dalle fondamenta».
La sua carriera a Milano fu piuttosto tormentata, almeno a partire dal 1929. La città era la capitale dell'antiquariato librario italiano, allora ancora fiorente, e Gnoli come Soprintendente aveva la delicata responsabilità sia di vigilare sul commercio del libro antico e sulle esportazioni (particolarmente nella vicina Svizzera) sia di valutare l 'opportunità di fare acquisti o esercitare i l diritto di prelazione per conto dello Stato, nell'ambito della politica di rilancio del prestigio delle biblioteche italiane imboccata dalla nuova Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, costituita nel giugno 1926. Tra i primi, importanti e discussi acquisti vi fu, nel 1927, in un'asta parigina tramite la Libreria antiquaria Hoepli, l'incunabolo miniato della Commedia allora attribuito a Pietro da Pigino (sul quale scrisse un saggio per i l primo fascicolo della nuova rivista ministeriale «Accademie e biblioteche d'Italia»), mentre non venne concluso nello stesso anno l'acquisto del frammento del
le Meditazioni della Passione di Cristo, ritenuto da Haebler i l più antico libro stampato a caratteri mobili in Italia, che Gnoli fu incaricato d; esaminare e trattare, probabilmente con la mediazione di Hoepli, portandolo anche in visione a Enrico Rostagno alla Laurenziana e ad altri esperti a Roma. Molti altri acquisti vennero compiuti negli anni successivi e con la Libreria Hoepli si stabilì una consuetudine di continui contatti, soprattutto pet esaminare ed eventualmente selezionare i l materiale prima delle aste-e di doni per la Biblioteca di Brera.
Le responsabilità milanesi lo portarono a sviluppare interessi, fino a quel momento mai coltivati, pet i l libro antico, l'illustrazione e la legatura d'arte, di cui divenne tra i maggiori espertL In occasione del Congresso geografico italiano tenuto a Milano nel settembre 1927 organizzò una mostra di manoscritti, edizioni antiche e materiale cartografico, a cui seguirà in occasione del Congresso mondiale delle biblioteche dei 1929 una mostra destinata a offrire ai visitato-una scelta del materiale di maggiore pregio dei.i Braidense in tutti i settori, mantenuta poi come esposizione permanente.
Nel dicembre 1929 il Ministero dispose un'ispezione sulla sua attività di Soprintendente e gli ispettori Alfonso Gallo e Ugo Costa formularono dei rilievi sulla cura posta nell'accert:-re la provenienza di alcuni manoscritti e di uni raccolta di miniature sciolte venduti dallo Hoepli e sulla vigilanza sopra la biblioteca Melziana. depauperata dai proprietari di alcuni pezzi, imputando allo Gnoli insufficiente rigore nei confronti della libreria antiquaria, che i l suo comportamento avrebbe favorito. Gnoli contestò analiticamente, a più riprese, gli addebiti - marginali e poco realistici, se si confrontano l'entità dell'ambito su cui vigilare con i mezzi modestissimi e gh scarsi poteri del Soprintenden:r - senza però ottenere alcuna soddisfazione ds-Ministero, evidentemente maldisposto nei suoi confronti. Sui problemi del controllo del commercio antiquario, i difetti delle norme vigenti e le relazioni da tenere con le principali case
324 I
Tommaso Gnoli
-^Line lo Gnoli aveva presentato al Congresso ^ : -diale del 1929, in collaborazione con Amal i ago, un'importante relazione, con varie pre--:.c proposte (pur non tutte praticabili), e certa-- r-:e conosceva le questioni molto meglio dei
runzionari ministeriali. Nello stesso anno, . ;^.iito della segnalazione un po' allarmistica . r i dispersione di una biblioteca privata mila-- r i c . era intervenuto su «La bibliofilia» per ret--care le informazioni e soprattutto per spie-
: ._-r ^'importanza dello sviluppo delle collezioni - -̂e anche dal punto di vista della conser--z-:ne del patrimonio nazionale: uno svilup-
- rsr i l quale - scriveva - «è necessario i l senso i r „ i libertà» e che andava accompagnato non l i ..-npraticabili e inefficaci minacce di interse;:] coercitivi dello Stato ma da un parallelo - - _ppo della «coscienza dei cittadini» che con-..;_~se, come in altri paesi e soprattutto negli
Uniti, a diffondere la pratica dei lasciti e i t^r donazioni delle collezioni più significative ac -;tituti pubbhci. Ma probabilmente fin dal
^ pesavano a sfavore di Gnoli nel Ministero - : • azioni politiche, essendo notori i suoi le-
con Croce e più in generale col liberalismo _-^ ;̂̂ cista. I l 19 novembre 1925 aveva scritto
: -1 a De Gregori: «Debbo cominciare a te-- :-- .he tu e Genuardi abbiate ragione e che si
: rendere impossibile la vita a chi non fac-, - erta professione di fascismo. Pure mi pa-- lì stare al mio posto, non al di sopra, ma
- : : -.tori della mischia, come si conviene a una la di studio; anzi simpatizzante sulle pri-
- ; _ 1 regime, poi piuttosto agnostico e indiffe-- " 1 ? . quantunque sempre deferentissimo. T i fo
j ^ o sfogo perché se tu avessi occasione di ve-. rr : il Ministro o i l Direttore Generale gli fac-,^ lenno delle mie preoccupazioni finanziarie e Lrr_; mia amarezza pel modo come sono stato - e mi si seguita a trattare».
.ostante gli esiti non favorevoli dell'ispe-. - del 1929-1930, sulla base della conside-
e che le riserve emerse riguardavano non - _ j di Direttore ma la funzione aggiuntiva
_ : - jrintendente, venne promosso dal Con
siglio di amministrazione del Ministero del 13 giugno 1930 (con decorrenza dal 1° luglio) bibliotecario direttore di prima classe (grado VI) , prevalendo di stretta misura nella valutazione di merito comparativo su Luigi de Gregori. Insieme alla promozione, però, i l Ministro Balbino Giuliano i l 20 giugno 1930 gli annunciava l'intenzione di trasferirlo, a seguito dei risultati dell'ispezione, a un'altra sede, offrendogli la scelta tra la Nazionale di Palermo e l'Universitaria di Bologna; Gnoli si dichiarò disponibile ad accettare i l trasferimento solo a una biblioteca romana, anche di minore importanza, e alla fine, probabilmente per l'intervento del Direttore Generale Salvagnini sul Ministro, si decise di soprassedere, per i l momento, pur essendo la sua posizione diventata ormai molto precaria. Nel maggio 1930 la Direzione Generale avvertì i l Gabinetto del Ministro che era opportuno evitare di conferire onorificenze allo Gnoli, ancora soltanto Cavaliere nonostante i l suo grado, e un po' paradossalmente due anni dopo, nell'ottobre 1932, fu lui ad avvertire i l Min i stero di essere stato nominato Cavaliere Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, su proposta diretta del capo del Governo; non ricevette però ulteriori onorificenze fino alla caduta del fascismo. Ì-Ì'- i :> r<'»i>
In questi anni, essendo uno dei direttori di biblioteca più autorevoli, prese parte ai principali eventi d'interesse professionale, dal "convegno itinerante" organizzato dalla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche nel 1928 al Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia del 1929, dove presentò la relazione cui si è accennato su Antiquariato ed esportazione, accogliendo inoltre i partecipanti in gita a Milano il 3 luglio alla mostra bibliografica organizzata nella Braidense. Nel 1930 fece parte del Comitato promotore dell'Associazione dei bibliotecari italiani ma non venne poi nominato nel Consiglio direttivo; partecipò al primo Congresso nazionale dell'Associazione, tenuto a Roma nel 1931, e a tutti quelli successivi fino alla guerra, intervenendo spesso nelle discussioni.
325
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
Nel 1931, SU richiesta del Ministero, aderì all'Associazione fascista della scuola, ricoprendo anche per due anni la carica di fiduciario regionale della nuova Sezione Bibliotecari; nel 1933, quando a tutti i direttori venne chiesto di iscriversi al Partito nazionale fascista, preparò la domanda d'iscrizione, appoggiata da due accademici d'Italia, che però poi - probabilmente per riluttanza più che per trascuratezza - non presentò entro i termini.
I l 1932 aveva portato un altro piccolo incidente, l'irritazione di Mussolini per le gajfes sfuggitegli nelle conversazioni con Emil Ludwig, sfogata in parte sulla qualità della traduzione, opera proprio dello Gnoli, traduttore di fiducia dello scrittore tedesco presso Mondadori. I l duce fece intimare all'editore di non r istampare i l volume dei Colloqui «senza che io l'abbia ritradotto in comprensibile lingua italiana, poiché quella del testo attuale sarà tedesca, croata, greca, giudaica, ostrogota ma non italiana». I l testo fu fatto correggere a più riprese da Mussolini, sia per la prima edizione che per le successive, non solo per espurgarlo ma anche per ritoccarne la forma, e in effetti parecchie delle correzioni segnate dal duce, fatte conoscere in un'edizione speciale del dopoguerra, evidenziano senza pietà che i l traduttore — probabilmente per la fretta dell'operazione e perché i l testo non doveva ispirarlo - se l'era cavata molto mediocremente. Ma probabilmente proprio agli incidenti di questa traduzione Gnoli dovette - secondo i l tipico agire ambiguo e contorto di Mussolini - i l conferimento della già ricordata onorificenza, in contemporanea con l'uscita dell'edizione espurgata, d'iniziativa del capo del Governo e senza nemmeno informare i l Min i stero dell'Educazione Nazionale.
Un altro incidente politico coinvolse indirettamente lo Gnoli l'anno successivo: nel marzo 1933, infatti, i l genero Gioacchino Malavasi, che aveva sposato nel luglio 1932 sua figlia Jacovella, venne arrestato a seguito di una riunione di un gruppo di giovani cattolici antifascisti da lui organizzata due giorni prima e i l 30 gen
naio 1934 fu condannato dal Tribunale special; a cinque anni di prigione, insieme a Piero Mai-vestiti, anche se pochi mesi dopo - a quante pare per intervento di padre Tacchi-Venturi -ottenne la grazia e venne scarcerato. In quel periodo, i l 19 marzo 1934, lo Gnoli perse, dop: una lunga malattia, la moglie Gabriella. NeL; stesso anno pubblicò con uno pseudonimo ur volumetto di poesie presentate come di un gic-vane alle prime prove, una sorta di replica minima del "mistero di Giuho Orsini" di trent'an-prima, in cui era stato anche lui tra i complic-del padre.
I l problema della sua mancata iscrizione a_ Pnf si pose ancora nel 1934 e nel 1935 e il Ministero stesso intervenne, senza esito, per orti-nere che venisse fatta un'eccezione alla chiusura delle iscrizioni del luglio 1933. Ma in quali conto Gnoli fosse ormai tenuto dall'ammin-strazione lo può indicare anche i l fatto che, p- : essendo tra i funzionari più alti in grado, non venne sentito nemmeno per cortesia o per informazione quando si liberarono a Roma ur posto di Ispettore superiore, conferito nell'ag:-sto 1934 a Nella Vichi Santovito, entrata ne-la carriera dieci anni dopo di lui, e poi, per morte nel novembre dello stesso anno di Federico Ageno, quello di Direttore della Bibliotee. "Vittorio Emanuele" (che peraltro, come scrisse all'amico De Gregori, non avrebbe accettar: anche per i pesanti ricordi paterni).
Verso i l 1936 si legò ad Ada Buttner, che speserà il 23 luglio 1937, chiedendo ad Alessandri Casati di fargli da testimone. La Buttner, nati il 1° agosto 1896, aveva sposato nel 1918 a Zurigo un commerciante ebreo, Karl Dub, da O H aveva avuto i l 7 giugno 1919 una figlia, Myrrhi Dagmar; i due si erano però separati dopo jxt-chi anni e la Buttner, ottenuto i l divorzio, si en trasferita a Milano con la figlia, che si dedicò a studi artistici e, dopo vicende personali alquanto movimentate, sarebbe diventata in Brasile un'apprezzata artista sperimentale, con i l nome di Mira Schendel, assunto con i l secondo matrimonio. Probabilmente per incoraggiamenn»
326
Tommaso Gnoli
dello Gnoli Myrrha si iscrisse nel 1936 alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica, dove avevano studiato anche i suoi figli, ma - in quanto figlia di padre ebreo e di madre non italiana, anche se cattolica - dovette lasciarla nel 1939 per le leggi razziali (che proibivano, tra l'altro, anche i l matrimonio dei dipendenti pubblici con persone di nazionalità straniera) e poco dopo, per i pericoli incombenti, firggire dall'Italia. Tornerà nel nostro paese verso la fine della guerra, con i l primo marito e con passaporto croato, ospiti entrambi per qualche mese di Ada e Tommaso a Milano.
Nel 1937, dopo i l ritorno dal congedo matrimoniale, la sua posizione a Milano precipitò. A i primi di settembre un giovane bibliotecario già suo dipendente alla Braidense, Tommaso Bozza, con cui aveva avuto accesi diverbi e di cui aveva quindi ottenuto i l trasferimento, presentò alla Direzione Generale un esposto in cui accusava lo Gnoli di apprezzamenti negativi sul regime e dipingeva la biblioteca come una sorta di covo clandestino dell'antifascismo milanese, in cui fra l'altro si acquistavano le pubblicazioni contrarie al regime boicottando quelle fasciste. I l quadro era evidentemente molto esagerato per ostilità personale, come emerse chiaramente dall'ispezione subito svolta da Francesco Pel-lati e dal solito Alfonso Gallo, ma non si poteva negare che Gnoli fosse personalmente legato a Croce, a Casati, a Gallatati Scotti e ad altri personaggi in vista del liberalismo milanese e non, che frequentavano almeno occasionalmente la Braidense e i l suo Direttore. Inoltre nelle biblioteche statali erano stati confinati vari docenti allontanati per motivi politici dall'insegnamento, senza che vi fossero elementi per provvedimenti più gravi, e alla Braidense lavoravano allora Elena "Valla e Bianca Ceva, professoresse di ginnasio, rispettivamente vedova e sorella dell'ingegnere Umberto Ceva morto suicida a Regina Coeli la notte di Natale del 1930 dopo gli arresti del gruppo di "Giustizia e Libertà". La tragedia aveva lasciato un'enorme impressione nell'ambiente intellettuale lombardo e le due
professoresse erano circondate dall'affetto e dalla stima di colleghi e conoscenti.
Dall'indagine non emerse nessun fatto rilevante da contestare allo Gnoli ma i l Ministro Bottai, letta la relazione conclusiva degli ispettori, vi annotò di suo pugno: «Penso che, senza far chiasso, lo si possa, alla prima occasione, confinare in centro meno politico; dove, quindi, la sua qualità di pesce in barile faccia meno senso che a Milano». E l'occasione non tardò: sul «Popolo d'Italia» del 4 dicembre 1937 uscì un articolo sul neonato Centro nazionale di studi manzoniani, in cui si riportavano dichiarazioni di Gnoli riguardo all 'opportunità di collocare i l Centro stesso in un'area del palazzo di Brera che si stava liberando. Lo stesso Gnoli inviò l'articolo al Ministero, anche perché a suo dire sulle idee esposte si era assicurato in precedenza i l consenso del Direttore Generale Scar-damaglia, ma la tempesta era già scoppiata appena i l giornale si era diffuso e i l Ministro aveva immediatamente colto l'occasione per decidere i l suo allontanamento da Milano, dal 1° gennaio 1938, con destinazione l'Estense di Modena, il cui Direttore, Paolo Nalli, l'avrebbe sostituito alla Braidense. Si disse che le dichiarazioni di Gnoli avessero irritato i l podestà di Milano, ma soprattutto - non si capisce quanto ingenuamente (senza escludere l'ipotesi di un vero tranello, dato che le dichiarazioni erano state sollecitate dal giornale, organo del Pnf) - la sortita del Direttore della Braidense si era inserita nei grandi piani che Gentile, commissario del Centro, e i l Ministro Bottai andavano allora sviluppando, con l'avallo personale di Mussolini, per dare al nuovo istituto un forte rilievo anche propagandistico. Questi piani prevedevano di recuperare come sede del Centro la casa del Manzoni e spostarvi anche i l materiale della Sala Manzoniana della Braidense, di cui Gnoli aveva dichiarato invece che «per decisione del Governo deve restare come è e dove è». Gnoli intervenne anche alla riunione pubblica convocata da Gentile a Palazzo Marino i l 14 dicembre, ma era inevitabile che i l vaso di coccio ve-
327
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
nisse stritolato, senza che si desse alcun ascolto alle sue proteste di aver agito in buona fede e ai suoi tentativi, sia con Gentile che con Bottai, di ricucire lo strappo. Allontanato il Direttore seguì subito la spoliazione della Biblioteca, che potè ottenere la restituzione della raccolta manzoniana solo nel dopoguerra, quando Presidente del Centro era Alessandro Casati.
Negli oltre dodici anni di direzione della Braidense lo Gnoli aveva soprattutto curato la sua riorganizzazione e i l suo aggiornamento come biblioteca di alti studi in ambito umanistico: oltre a numerose migliorie ai locali, agli impianti e agli arredi, venne riorganizzata e aggiornata la sala di consultazione (inaugurata nell'ottobre 1933) e furono incrementati gli acquisti di pubblicazioni moderne nelle principali lingue europee. Durante la sua direzione, inoltre, la Braidense acquisì i l lascito della biblioteca dello scienziato e filosofo Eugenio Rignano, scomparso nel 1930.
Come Soprintendente bibliografico per la Lombardia Gnoli, quando furono finalmente stanziati fondi appositi a seguito della creazione della Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche (R.D. 7 giugno 1926, n. 944), compì numerose ispezioni sul territorio, impegnando in quest'attività anche una colta e capace bibliotecaria della Braidense, Amalia Vago (formalmente nominata ispettiice nel 1932), e occasionalmente altri impiegati. La leva principale di cui le soprintendenze disponevano era la concessione di contributi, soprattutto agli enti locali, e Gnoli l i indirizzò a sostenete le biblioteche dei capoluoghi che ne avevano maggiore esigenza (Mantova, Sondrio, Varese) e quelle di altri centri di una certa importanza (p. es. Lodi, Crema, Voghera, Lecco, Monza), con interventi più occasionali per biblioteche minori ma dotate di rilevanti fondi antichi (come la Morcelliana di Chiari e la Collegiata di Broni) ed eccezionalmente per istituti specializzati (come l'Accademia Carrara di Bergamo e la Virgiliana di Mantova). I sussidi della Soprintendenza erano destinati principalmente all'acquisto di pub
blicazioni moderne o alle spese straordinarie per trasferimenti di sede, riordinamenti e riaperture al pubblico (p. es. per Treviglio, Viadana e Gal-larate), più di rado a interventi di restauro (p. es. alla Queriniana di Brescia). In questo periodo la Soprintendenza seguì in particolare i l trasferimento e la riorganizzazione della Biblioteca comunale di Sondrio in una nuova sede, inaugurata i l 28 ottobre 1930 con un discorso di Gnoli e intitolata a Pio Rajna, la cui biblioteca pervenne l'anno successivo, alcuni mesi dopo la morte dello studioso, che Gnoli aveva tenuto informato della ripresa della Biblioteca dopo un periodo di gestione molto trascurata da parte del Comune che aveva fatto temere che l ' importante lascito potesse non venire confermato. Inoltre la Soprintendenza cercò di promuovere i l coordinamento degli acquisti e della specializzazione delle raccolte tra le maggiori biblioteche di Milano e della regione.
Per quanto riguarda le biblioteche popolari la Soprintendenza svolse nel 1935 un'indagine su tutti i comuni della Lombardia, individuando quelli privi di una biblioteca di carattere popolare (o di una biblioteca civica che svolgesse anche servizi di quel tipo) e sollecitandone l'istituzione con una circolare a tutti i podestà, predisposta e inviata con la collaborazione della sede di Milano dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche. Gnoli sollecitò inoltre l'attività dei numerosi ispettori onorari nominati dal M i nistero e intervenne personalmente presso alcuni comuni di maggiore importanza ottenendo l'istituzione di nuove biblioteche o sezioni popolari. Nello sresso anno segnalò alla Direzione Generale che parecchie biblioteche popolari erano state assorbite dall'Opera nazionale dopolavoro, provocando l'intervento del Ministro presso l'ente per assicurare che i l servizio rimanesse accessibile a tutti, e non solo ai soci, e soggetto alla vigilanza della Soprintendenza.
Inoltre, come si è visto, la Soprintendenza fu molto impegnata nella vigilanza sul commercio antiquario e nelle attività connesse e dovette impiantare al principio del 1932 un proprio
328
Tommaso Gnoli
Ufficio di esportazione per i l materiale bibliografico, non potendo più appoggiarsi a quello della Soprintendenza alle belle arti. A partire dal 1935 si dedicò anche a ispezioni sistematiche alle tipografie del capoluogo e della provincia per verificare la regolarità dei registri e gli altri adempimenti previsti dalla legge del 1932 sul deposito obbligatorio delle pubblicazioni.
Oltre che nell'attività della Soprintendenza Gnoli coinvolse Amalia Vago anche nella preparazione dell'antologia poetica di Goethe pub-olicata presso Mondadori nel centenario della morte (1932), con traduzioni sue o della stessa \'ago oppure scelte tra le tante versioni di illustri scrittori italiani, da Domenico Gnoli a Croce e da D'Annunzio a Pirandello. Nella stessa occasione Gnoli allestì nella sala di consultazione riservata della Braidense una piccola ma intelligente mostra/vetrina goethiana, che univa Fesposizione di cimeli e illustrazioni alla possibilità di consultare le più importanti edizioni delle sue opere, in lingua originale e in traduzione. La fiortunata operazione editoiiale realizzata per Goethe venne ripetuta tre anni dopo per Heine, ancora riunendo traduzioni originali e • ersioni preesistenti, con introduzione di Gno-j e note della Vago. Più tardi, nel 1944, Gnoli a i tò per Garzanti un'ampia raccolta delle opere di Goethe, anche in prosa, con versioni sue, del figlio Giulio e di Vincenzo Errante, e nel 1947 indusse i Colloqui di Eckermann.
Ai primi del 1938 lo Gnofi si trasferì a Modena, prendendo le consegne della Biblioteca Estense e della annessa Soprintendenza bibliografica per l'Emilia dal Nalli i l 4 febbraio c tornando a Milano i l 14 per le consegne della Braidense al suo successore. Nel nuovo e più rranquillo incarico, a parte le difficoltà pratiche ed economiche del trasferimento, potè dedicarsi maggiormente al campo del libro antico e della -cgatura artistica e ai suoi interessi letterari. Per d centenario della nascita di Domenico Gno-i i ne pubblicò un profilo su «L'Italia che scrive», con lo pseudonimo quasi anagrammatico ci Manlio Tosi che aveva già usato per due arti
coli pure relativi agli scritti del padre; in precedenza aveva curato una raccolta postuma di poesie (1923) e aiutato i l figlio Aldo a pubblicare, sulla «Nuova Antologia» e poi in volume, vari suoi saggi storici inediti {La Roma di Leon X, Milano, Hoeph, 1938).
Per invito del senatore Treccani degli Alfieri progettò e diresse i l delicato rifacimento della legatura della Bibbia di Borso d'Este, eseguito all'Estense da Rolando Gozzi, insieme a interventi di restauro, sulla base di alcuni elementi conservati della legatura originale, dei dati documentari e dell'esempio della legatura analoga del Messale. Prendendo spunto da quest'occasione organizzò un'importante mostra di legature di pregio, individuate e selezionate nei fondi dell'Estense (come già aveva fatto alla Braidense, creando un apposito settore) e di altre biblioteche e archivi del Modenese, che venne inaugurata i l 4 giugno 1939 e rimase aperta per alcuni mesi.
Ma i l periodo di relativa tranquillità durò poco. Nel dicembre 1939, avendo compiuto 65 anni, venne informato dal Direttore Generale Scardamaglia che sarebbe stato collocato a riposo, pur non avendo ancora raggiunto i 40 anni di servizio, in quanto non iscritto al Partito fascista, e sollecitato a presentare lui stesso la domanda, come era d'uso per evitare che i l provvedimento figurasse preso d'autorità. Per evitare i l pensionamento Gnoli ripresentò la domanda d'iscrizione al Partito e i l Ministero tenne in sospeso per vari mesi i l provvedimento.
Nel frattempo, con l'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno 1940), Gnoli fu impegnato nelle operazioni, accuiatamente predisposte in anticipo, per lo sfollamento del materiale di maggiore pregio delle biblioteche in ricoveri di sicurezza: i l 24 e 25 giugno ben 255 grandi casse con i cimeli dell'Estense vennero trasportate all'Abbazia di Torrechiara, in provincia di Parma, dove confluì anche i l materiale della Palatina e dell'Universitaria di Bologna e quello consegnato da altri enti alle due Soprintendenze dell'Emilia e della Romagna, con una sorve-
329
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
glianza organizzata a turno dal personale delle tre biblioteche governative.
A settembre però i l Ministero avvertì Gnol i che non poteva più mantenere in sospeso il suo caso e che avrebbe dovuto collocarlo a riposo col 1° ottobre. Gnoli continuò ad insistere, anche col Ministro Bottai, per ottenere un rinvio, adoperandosi nel frattempo presso i l Partito, col sostegno del Ministero, per ottenere la tessera in extremis, e così i l provvedimento scivolò di mese in mese fino a diventare definitivo, d'ufficio, con i l 1° febbraio 1941. Lo stesso giorno, come lo informava i l Direttore Generale, prendeva servizio nelle biblioteche, tra i vincitori dell'ultimo concorso, la figlia Maria Teresa, destinata alla Biblioteca Nazionale di Roma.
Tra i motivi che Gnoli aveva addotto per ottenere un rinvio c'era l'ordinamento in corso della raccolta libraria della "Casa del ridere" di Formiggini, pervenuta all'Estense, che lo Gnoli stesso curava d'intesa con la vedova dell'editore, e i l Ministero gli concesse di portare a termine i l lavoro, in forma straordinaria e con un compenso ad hoc, anche dopo essere cessato dal servizio, con le consegne della Biblioteca e della Soprintendenza passate verso la fine di febbraio a Guido Stendardo. Gnoli si trattenne quindi per diversi mesi a Modena, tornando poi a vivere a Milano.
Nel 1941 venne festeggiato i l centocinquan-tenario della nascita di Giuseppe Gioacchino Belli e al poeta romano Gnoli dedicò vari contributi, di carattere soprattutto biografico e aneddotico, riallacciandosi alle ricerche di inediti e notizie che aveva già esposto nel 1928 al I Congresso nazionale di studi romani.
Dopo la caduta del regime, i l 1° agosto 1943, presentò al nuovo Ministro Severi un'istanza in cui chiedeva di venire riassunto in servizio, in quanto collocato a riposo d'autorità peiché non iscritto al Partito, e di essere destinato nuovamente a Milano. A l Ministero però, ricostruendo la sua situazione, si titenne che, per vari motivi, la sua domanda non potesse essere accolta e, dopo lunghe revisioni e limature del testo, che comunque non ne cambiavano la sostanza.
la risposta negativa di Severi partì da Roma i l 7 settembre. Quando arrivò nelle mani di Gnoli, quindi, i l governo dei quarantacinque giorni si era già dileguato.
Subito dopo la Liberazione di Milano, nel maggio 1945, i l C L N della Lombardia nominò Gnoli commissario straordinario del Cen-tto nazionale di studi manzoniani — una sorta di contrappasso, dato che proprio le mene del Centro avevano provocato i l suo allontanamento dalla Braidense - e poco tempo dopo Marino Parenti, troppo compromesso con il fascismo, dovette dimettersi da conservatore e lasciare definitivamente l'istituto. Gnoli venne quindi nominato anche conservatore del Centro, nell'agosto 1945, e dovette assumere interamente la responsabilità della sua conduzione, ottenendo i primi finanziamenti, liberando con difficoltà gran parte dei locali, occupati da altri uffici durante lo sfollamento del Centro a Me-rate, riportando in sede il materiale allontanato per proteggerlo dai bombardamenti e riordinandolo, così da poterne riaprire al pubblico la consultazione il 1° marzo 1946. Riaprì inoltre le visite ad alcuni ambienti della casa dello scrittore e a un piccolo museo e impiantò una nuova sezione della biblioteca, dedicata agli epigoni del Manzoni e in genere al Romanticismo lombardo. Nonostante l'appoggio dell'amico De Gregori e del sottosegretario Marazza, però, non riuscì a ottenere dal Ministero, a quanto sembra, un riconoscimento ufficiale del suo incarico, che lasciò probabilmente nell'autunno del 1946, dopo aver pubblicato una relazione sull'attività svolta e sollecitato un'ultima volta la Direzione Generale a confermargli l'incarico stesso o comunque a definire in altro modo la condizione e i l futuro del Centro.
Tornò per qualche tempo a Roma nei primi mesi del 1947, dopo la morte del fratello Umberto, e ancora nel '48, frequentando la Biblioteca Angelica, allora diretta da Francesco Barberi, in cui preparò i l contributo per gli studi in memoria di Luigi de Gregori sulla recente acquisizione delle carte e delle opere a stampa del poe-
330
Tommaso Gnoli
ta romanesco (e bibliotecario) Giggi Zanazzo e a cui donò poi, nel 1950, i l carteggio di suo padre.
Negli ultimi anni pubblicò due volumetti di versi vecchi e nuovi — / dodici mesi ( 1949) e Io non posso morire (1953) — mentre non ebbe seguito i l proposito di una nuova edizione rimaneggiata dei Canti di sogno annunciato già nel 1939; la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma conserva però una copia dell'edizione del 1926, inviata a Enrico Falqui nel luglio 1947, in cui aveva segnato le variazioni e i tagli che intendeva apportare. Nello stesso periodo si rivolse anche a Croce, che a suo tempo aveva molto apprezzato i l volumetto, chiedendogli una prefazione per la nuova edizione, ma il filosofo declinò la proposta - come scrisse ad Alessandro Casati i l 28 ottobre 1947 — «anche perché renderei al suo libro di versi un pessimo servigio, eccitandogli contro i giornali e giornaletti letterari italiani». Anche i l progetto di pubblicare una raccolta scelta e definitiva dell'opera poetica del padre, accarezzato già dagli anni Trenta e ripreso nel dopoguerra, rimase senza esito. Nel 1951 stese una sorta di cronaca della sua lunga amicizia col Vossler, intessuta di citazioni dalle sue lettere, che sarà poi pubblicata postuma dal figlio Aldo.
Continuò a vivere per lo più a Milano fino al febbraio 1958 quando, secondo il necrologio del «Corriere della sera», «conscio della prossima fine, decise di tornare alla sua città natale ad attendervi la morte», assistito dalla figlia Maria Teresa. Morì infatti a Roma i l 27 marzo 1958.
L'articolo del quotidiano milanese, richiamata la sua carriera e i suoi studi e lavori letterari, ne lasciava questo ricordo: «Devoto alla libertà e alla democrazia, nel periodo fascista si diceva di lui che col Croce e col Vossler costituisse i l "triangolo della resistenza dello spirito" alle dittature».
Bibliografia di Tommaso Gnoli
1896 Nuova versione deW'Elegie romane", «Rassegna sertimanale universale», 1, n. 17 (26 apr. 1896), p. 8-10; 1897 Le "Myricae" di Giovanni Pascoli, «FanfuUa della domenica», 19, n. 14 (4
apr. 1897), p. 1-2; 1898 Prime rondini, Firenze: Bemporad, 1898; L'Esposizione nazionale di belle arti in Torino, «FanfuUa della domenica», 20, n. 22 (29 mag. 1898), p. 1-2, e n. 24 (12 giù. 1898), p. 2; Rassegna di belle arti {Il concorso per le carte-valori; Per il centenario del Bernini), «Rivista d'Italia», 1 (1898), n. 11, p. 556-560; 1901 Sull'arte di Pergamo: conferenza del prof. Loewy, «11 popolo romano», 29, n. 132 (14 mag. 1901), p. 2; 1903 Le satire di Giovanni Giraud, per la prima volta edite, con uno studio biografico critico di Tommaso Gnoli, Roma: Loe-scher, 1903; 1910 Dal tedesco di Eduard Mori-ke, «Le cronache letterarie», n. 29 (6 nov. 1910), p. 3 (traduzione di alcune poesie, poi ripubblicate nel volume del 1923, con una premessa); 1911 Emanuele Geibel (critica e versioni), «Le cronache letterarie», n. 38 (8 gen. 1911), p. 1; 1912 Riccardo Dehmel e la lirica simbolistica in Germania: critica e versioni, «Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti», fase. 967 (1° apr. 1912), p. 399-416 (ripubblicato nel volume di Dehmel del 1914); 1915 La poesia della guerra in Germania e il "Canto dell'odio contro l'Inghilterra" di Ernst Lissauer, «La concordia», 2, n. 20 (20 gen. 1915), p. 3; 1916 Parole dette nelprimo anniversario della morte di Domenico Gnoli dal figlio Tomaso offendo alla "Lazio" il busto del poeta, Roma: [s.n.], 1916; 1919 Carlo Spitteler (critica e versioni), «Rivista d'Italia», 22 (1919), n. 11, p. 357-368; 1920 Lettere inedite di Giosuè Carducci a Domenico Gnoli, annotate da Tomaso Gnoh, «Rivista d'Italia», 24 (1921), n. 7, p. 241-254; 1923 Giulio Orsini (Domenico Gnoli), I canti del Palatino, Nuove solitudini, ed. postuma a cura di T.G., Milano: Fratelli Treves, 1923 (con una Nota siglata T G . a p. [VII]) ; // Libro del Paradiso dal "Divano" di Volfango Goethe, «Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti», fase. 1236 (16 set. 1923), p. 108-127 (con alcune versioni con note); 1926 Canti di sogno, Roma: Bardi, 1926 (ma uscito nel novembre 1925); Le biblioteche italiane, «Italica: bulletin of the American Association of Teachers of Ita-lian», 3 (1926), n. 4, p. 77-80; 1927 Catalogo
331
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
ragionato della Mostra geografica retrospettiva della Biblioteca Braidense, in: Atti del X Congresso geografico italiano (Milano 6-15 settembre 1927), Appendice seconda: Cataloghi delle mostre, Milano: Touring club italiano, 1927, p. 145-185 (a cura e con introduzione di Gnoli); // "Dante"di Piero da Pigino, «Accademie e biblioteche d'Italia», 1 (1927/28), n. 1, p. 22-35; Carte geografiche antiche, ivi, n. 3, p. 58-65; Il testamento della religione della natura di W Goethe, «Nuova Antologia», fase. 1328 (16 lug. 1927), p. 166-169 (con versione e note); 1929 Biblioteca Nazionale di Brera, Catalogo descrittivo della Mostra bibliografica: manoscritti e libri miniati, libri a stampa rari e figurati dei secc. XV-XVI, legature artistiche, autografi, Milano: Sperling & Kupfer, [1929] (a cura e con Prefazione di Gnoli); Gli anni di sodalizio di G. G. Belli coi parenti Mazio (1837-1850) (dapoesie e nota biografica inedite), in: Atti del 1° Congresso nazionale di studi romani, Roma: Istituto di studi romani, 1929, voi. 2, p. 345-354; Le sorti della Biblioteca Silvestri di Milano, «La bibliofilia», 31 (1929), n. 11, p. 424-426; Le biblioteche italiane, «Minerva-Zei-tschrift», 5 (1929), n. 6/7, p. 99-104; Gli anni di sodalizio di G. G. Belli coi parenti Mazio ('837-'850), «Rivista italiana di letteratura dialettale», 1 (1929), n. 2/3, p. 73-82; 1930 LI lascito Rignano alla Biblioteca nazionale di Milano, «Accademie e bibhoteche d'Italia», 4 (1930/31), n. 2, p. 187-188 (non firmato); La Biblioteca civica "Pio Raina" [!] di Sondrio, ivi, n. 3, p. 218-225; "Brera" e il piano regolatore delle biblioteche, «Corriere della sera», 55, n. 258 (30 ott. 1930) (non firmato ma ispirato e probabilmente steso da Gnoli); 1931 Tomaso Gnoli - Amalia Vago, Antiquariato ed esportazione, in: Primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia, Roma-Venezia, 15-30 giugno MCMXXIX-a. VU: atti, voi. 4, Roma: Libieria dello Stato, 1931, p. 25-34; Per una vita di G. G. Belli, «Rivista italiana di letteratura dialettale», 3 (1931), n. 1, p. 61-66 (con lo pseudonimo Manlio Tosi); Ancora del lascito Rignano alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano, «Accademie e biblioteche
d'Italia», 4 (1930/31), n. 6, p. 590-591 (sigk:: T.G.); 1932 {Discorso di inaugurazione de. Mostra bibliografica della Biblioteca nazion.: Braidense\, in: Primo Congresso mondiale deui biblioteche e di bibliografia cit., voi. 1, 1932. r 285-288; Una mostra goethiana alla Bibliotecii : Brera, «Accademie e biblioteche d'Italia>i. ~ (1931/32), n. 6, p. 538-542; Una ricca bibliou-ca di lingue e letterature neo-latine: il dono di P:: Rajna alla Biblioteca comunale di Sondrio, ivi. ; (1932/33), n. 2, p. 153-159; 1933 Mostra : -bliografica della R. Biblioteca nazionale Braidc di Milano, in: Primo Congresso mondiale delle : blioteche e di bibliografia cit., voi. 6, 1933- : 359-412; R. Soprintendenza bibliografica per _ Lombardia, in: Ministero dell'Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, Le accademie e le biblioteche d'Ir.: . nel sessennio 1926127-1931132: relazione a S i il Ministro, Roma: Istituto poligrafico dello Stiro, 1933, p. 425-452 (non firmata e limanes-giata da Ettoie ApoUonj al Ministero); Seri-. -contemporanei di cose romane: Domenico Gnc. : la sua opera su Leone X e la Roma del Rinascimi^ to, «Archivio della R. Società romana di src r , pania», 53/55 (1930-1932), p. 385-395 (stirpato nel 1933); 1934 Ldilli erotici ed altre Un. passatistiche, Milano, Convivio letterario, 1 " -(con lo pseudonimo Bruno Baldi); 1935 [Ir.:r venti], in: // terzo Congresso della Associaz:. italiana per le biblioteche: Bari, 20-23 ot::. -1934-XIL Roma: Biblioteca d'arte, [1935?: : 136-138 e 142 (anche in «Accademie e bibhc».^ che d'Italia», 8 (1934), n. 6, p. 652-654 e 6-^ -// caso Orsini e la poesia di Domenico Gr. . «Convivium», 7 (1935), n. 2, p. 263-267 • lo pseudonimo Manlio Tosi); Un cenacolo i ^ : ^ -rario: Fleres, Pirandello & C, «Leonardo-, t (1935), n. 3, p. 103-107; [recensione a] Aup. Jandolo, Memorie di un antiquario, Milano. . schina, 1935..., ivi, n. 12, p. 500-502; l°'yt Prefazione, in: Ugo Aschieri, La Biblio:,:. . Brera illustrata, Milano: Rizzoli, 1936, p. "-fe 1938 Domenico Gnoli: per il centenario delL scita, «LItalia che scrive», 21 (1938), n. 12,
332
Tommaso Gnoli
329-330 (con lo pseudonimo Manlio Tosi), r ipubblicato in opuscolo col suo nome, Roma: [s.n.], 1938 (stampa 1939); 1939 Mostra delle legature artistiche esistenti a Modena, Modena: Società tipografica modenese, 1939; La legatura della Bibbia di Borso e le legature artistiche esistenti a Modena, «Accademie e biblioteche d'Italia», 14 (1939/40), n. 2, p. 103-107; 1941 Giuseppe Gioacchino Belli: nel 150° anniversario della nascita, «Popoli», 1 (1941), n. 10, p. 332-334; Il Belli e la cuginetta Orsola Mazio-Balestra, «L'Urbe», 6 (1941), n. 10, p. 6-10 (ripubblicato nel volume del 1942); G.G. Belli a Milano e Carlo Porta, «Nuova Antologia», fase. 1671 (1° nov. 1941), p. 80-84; 1942 Un'amica ed ispiratrice del Belli; La cuginetta Orsola Mazio-Balestra, in: Giuseppe Gioacchino Belli, Roma: Fratelli Palombi, 1942, p. 216-226 e 227-233; 1946 // Centro di studi manzoniani e la casa del Manzoni, Milano: [s.n.], 1946; 1946 Lirica e gnomica dell'ultimo Goethe, «L'Italia che legge», 2 (1946), n. 3, p. 5 (recensione al volume di Ferruccio Amoroso, Bari: Laterza, 1946); 1949 / dodici mesi: 24 liriche, Roma: Staderini, [ 1949] ; Giggi Zanazzo e le sue opere edite ed inedite alla Biblioteca Angelica, in: Studi di bibliografia e di argomento romano in memoria di Luigi De Gregori, Roma: Fratelli Palombi, 1949, p. 183-191; 1951 Un salotto letterario a Roma sui primi del Novecento, «Convivium», (1951), n. 3, p. 399-403; 1953 Io non posso morire: liriche, Genova: Typis, 1953; 1962 Lettere inedite di Carlo Vossler, «Palatino», 6 (1962), n. 7/8, p. 133-138, e n. 9/12, p. 215-221. « : '
Traduzioni (di cui si indica solo la prima edizione): 1908 Karl Vossler, Positivismo e idealismo nella scienza del linguaggio, Bari: Laterza, 1908 (con Avvertenza del traduttore, p. 5-6); 1914 Richard Dehmel, Poesie scelte, versione ritmica e saggio introduttivo su Riccardo Dehmel e la lirica simbolista in Germania di Tomaso Gnoli, con un'appendice bibliografica. Lanciano: Carabba, 1914, in parte già pubbl. nella «Nuova Antologia», fase. 967 (1° apr. 1912), 992 (16 apr. 1913) e 1015 (1° apr.
1914); 1916 Karl Vossler, Letteratura italiana contemporanea: dal Romanticismo al Futurismo, Napoli: Ricciardi, 1916 (stampa 1915), 2» ed. con numerose aggiunte e correzioni dell'autore, ivi, 1922; 1920 Eduard Mòrike, Novelle, Ferrara: Taddei, 1920 (con i l saggio Edoardo Morike e la scuola sveva, p. 5-11); Josef Rue-derer, // principe Djem, ivi, 1920 (con i l saggio Giuseppe Ruederer e il cenacolo monachese, p. 7-14); 1923 Eduard Mòrike, Liriche scelte, tradotte da Tomaso Gnoli, Poemetto, tradotto da Ettore Romagnoli, Firenze: Le Mounier, 1923 (con i l saggio Eduardo Morike e l'idillio lirico, p. VII -XVl ) ; 1925 Karl Vossler, Leopardi, Napoli: Ricciardi, 1925; 1930 René Fulòp-Miller, // santo diavolo: Rasputin e l'ultimo zar, Milano: Mondadori, 1930; Eduard Mòrike, Mozart in viaggio per Praga, La storia della bella Lau, LI tesoro, ivi, 1930 (con una Nota di Gnoli, p. 251-257); 1932 Johann Wolfgang von Goethe, Liriche scelte dalle migliori traduzioni italiane, IL cura di Tomaso Gnoli e Amalia Vago, ivi, 1932 (con Lntroduzione di Gnoli, p. VII-XX) , in parte già pubbl. nella «Nuova Antologia», fase. 1116 (16 lug. 1918), 1236 (16 set. 1923) e 1328 (16 lug. 1927); Emil Ludwig, Goethe: storia di un uomo, ivi, 1932; Emil Ludwig, Colloqui con Mussolini, ivi, 1932; 1935 Heinrich Heine, Antologia lirica, dalle migliori traduzioni italiane, a cura di Tomaso Gnoli e Amalia Vago, ivi, 1935 (con Introduzione di Gnoli, p. VII-XV) ; Jakob Wassermann, Gli anni perduti: Eugenio Faber: romanzo, Milano: Corbac-cio, 1935; 1944 Goethe, introduzione e scelta di Tomaso Gnoli, versioni di T. Gnoli e V. Errante, Milano: Garzanti, 1944 (Voi. 1: Werther, Poesie, Divano, Viaggio in Italia, con Introduzione di Gnoli, p. VII-XXXV; Voi. 2: Wilhelm Màster, Faust, Torquato Tasso); 1947 Johann Peter Eckermann, Colloqui con Goethe, Firenze: Sansoni, 1947 (con Nota e Prefazione del traduttore, p. V I - X V I , e note); 1953 L'eredità di Roma, saggi di Cesare Foligno e altri, a cura di Cyril Bailey, ttaduzione di Tommaso Gnoli e Sergio Rossi, Milano: Vallardi, 1953; 1954
333
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
Johann Wolfgang von Goethe, Le esperienze di Guglielmo Meister, Milano: Rizzoli, 1954 (con una Nota di GnoU, p. 5-17).
Non sono compresi i componimenti poetici pubblicati a partire dal 1894 in varie riviste («Roma letteraria», «Rassegna settimanale universale», «Rassegna contemporanea», «L'illustrazione italiana», «Roma: rassegna illustrata della esposizione del 1911», «La sampogna», «Convivium», «Strenna dei romanisti», e probabilmente altre ancora) o in plaquettes private di poche pagine e, se non accompagnate da un testo critico, le traduzioni poetiche - spesso anticipazioni da volumi di prossima pubblicazione - uscite nella «Nuova Antologia» o in altri periodici.
Fonti arciiivistiche
Roma, ACS, MPI , DGAB (1926-1948), b. 33 e 299 (fase, personale); b. 132 e 136 (Protezione antiaerea); b. 454, 456, 459 e 460 (Soprintendenze bibliografiche), b. 489 e 492 (Epurazione); DGAB (1950-1980), vers. 1959, b. 240 (Soprintendenze bibliografiche).
Roma, Archivio dell'Associazione italiana biblioteche. Carteggio di Luigi De Gregori.
Bibliografia su Tommaso Gnoli
1904 R. [Rodolfo Renier], Tommaso Gnoli, Le satire di Giovanni Giraud..., «Giornale storico della letteratura italiana», 44 (1904), n. 130/131, p. 248-252; Karl VoEler, Tommaso Gnoli, Le satire di Giovanni Giraud..., «Ar-chiv fiir das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 58. Jahrgang, 112. Band (1904), p. 470-475; 1907 Teodoro Rovito, Dizionario bio-bibliografico dei letterati e giornalisti contemporanei, Napoli: Tipografia Melfi & Joele, 1907 (stampa 1908), p. 126; 1922 Giovanna Chroust, Tomaso Gnoli, in Saggi di letteratura italiana moderna: da Carducci al futurismo: con note biografiche bibliografiche e dichiarative, Wiirzburg: Kabitzsch & Mònnich, 1922, p. 432-436; Teodoro Rovito, Letterati e giornali
sti italiani contemporanei: dizionario bio-bibliografico, 2^ ed. rifatta ed ampliata, Napoli: Rovito, 1922, p. 202 e 448; 1928 Mostra di cimeli geografici in Milano, «Accademie e biblioteche d'Italia», 1 (1927/28), n. 2, p. 90; Chi e^ Dizionario degli italiani d'oggi, Roma: A. E Formiggini, 1928, p. 256; 1- ed., ivi, 1931, p. 372; 3̂ ed., ivi, 1936, p. 448; 4^ ed., Roma: Cenacolo, 1940, p. 466; 5̂ ed., Roma: FUippo Sca-rano, 1948, p. 456; 6̂ ed., ivi, 1957, p. 268; 1933 Le accademie e le biblioteche d'Italia nel sessennio 1926/27-1931/32... cit.; 1934 Giovanni Casati, Dizionario degli scrittori d'Italia (dalle origini fino ai viventi), voi. 3, Milano: Ghirlanda, [1934], p. 207; 1937 // Centro Manzoniano ha iniziato i lavori, «Il popolo d'Italia», 24, n. 337 (4 die. 1937), p. 5 (Cronaca di Milano); 1938 Centro di studi manzoniani, «Scienza e tecnica», 2 (1938), n. 1, p. 49-50; 1942 Ministero dell'Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, Le biblioteche d'Italia dal 1932-X al 1940-XVIII, Roma: FrateUi Palombi, 1942; 1950 Arnoldo Mondadori, Breve cronistoria della genesi della prima e della seconda edizione dei "Colloqui con Mussolini", in: Emil Ludwig, Colloqui con Mussolini, Riproduzione delle bozze della prima edizione con le correzioni autografe del duce, Milano: Mondadori, 1950, p. "VTI-XXVII; 1956 Enrico M . Fusco, Scrittori e idee: dizionario critico della letteratura italiana, Torino: SEI, 1956, p. 288; Panorama biografico degli italiani d'oggi, a cura di Gennaro Vaccaro, Roma: Curcio, 1956, p. 757; 1958 Si è spento ieri a Roma il conte Tommaso Gnoli, «Il nuovo Corriere della sera», 83, n. 76 (29 mar. 1958), p. 7; E.C.P [Emma Coen Pirani], Tommaso Gnoli, «Notizie A.I.B.», 4 (1958), n. 1/2, p. 41; 1967 Vittoria Agano-or. Lettere a Domenico Gnoli (1898-1901), a cura di Biagia Marniti, Caltanissetta-Roma: Sciascia, 1967, passim; 1969 Benedetto Croce, Epistolario, Voi. 2: Lettere ad Alessandro Casati (1907-1952), Napoli: Istituto italiano per gli studi storici, 1969, p. 143 e 268; 1975 Renzo Frattarolo, Dizionario degli scrittori italiani
334
Tommaso Gnoli
contemporanei pseudonimi (1900-1975), Ravenna: Longo, 1975, p. 48; 1980 Stefano Micco-lis. Una lettera inedita di Croce a Karl Vossler, «Rivista di studi crociani», 17 (1980), n. 3, p. 314-316; 1981 Democrazia al lavoro: i verbali del CLN lombardo 1945-1946, a cura di Gaetano Grassi e Pierangelo Lombardi, Firenze: Le Mounier, 1981, voi. 1, p. 140 e 421, e voi. 2, p. 406-408; 1991 Carteggio Croce-Vossler, 1899-1949, Napoli: Bibliopolis, \')')\, passim; 1993 Enrico Decleva, Arnoldo Mondadori, Torino: UTET, 1993, p. 166-172; 1999 Giorgio de Gregori, Gnoli, Tommaso, in: Giorgio de Gregori — Simonerta Buttò, Per una storia dei bibliotecari italiani del XX secolo: dizionario bio-bibliografico 1900-1990, Roma: Associazione italiana biblioteche, 1999, p. 103-104; 2001 Riccardo D'Anna, Gnoli, Domenico, in: Dizionario biografico degli italiani, voi. 57, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2001, p. 454-458 (con notizie anche su Tommaso); Piero Scapecchi, Subiaco 1465 oppure [Bondeno 1463]?: analisi del frammento Parsons-Scheide, «La bibliofilia», 103 (2001), n. 1, p. 1-24; 2003 Alberto Petrucciani, Storie di ordinaria dittatura: i bibliotecari italiani e il fascismo (1922-1942), «BoUertino AIB», 43 (2003), n. 4, p. 417-442; 2004 Be
nedetto Croce - Giovanni Laterza, Carteggio, a cura di Antonella Pompilio, Roma-Bari: Laterza, 2004-2009, all'indice (partic. nel voi. 1, 1901-1910); 2005 Natalia Inchingolo, Tomaso Gnoli: bibliotecario, poeta, traduttore: con edizione delle sue lettere a Luigi de Gregori (1921-1947), tesi di laurea specialistica in Scienze archivistiche e biblioteconomiche. Università di Pisa, a.a. 2004/05, relatore Alberto Petrucciani; 2006 «Annuario della nobiltà italiana», n.s., 30 (2006); 2007 Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale: il caso italiano, a cura di Andrea Capaccioni, Andrea Paoli, Ruggero Ranieri, Bologna: Pendragon, 2007, p. 95-96 e 262; 2010 Alberto Petrucciani, Licenziamenti per motivi politici o razziali nelle biblioteche nel periodo fascista (1938-1943): appunti e ricerche, in: Dalla bibliografia alla storia: studi in onore di Ugo Rozzo, a cura di Rudj Gorian, Udine: Forum, 2010, p. 217-240.
Ringraziamenti
Claudio Gnoli, Anna Manfron, Andrea Paoli, Giuliana Zagra.
Alberto Petrucciani
335
LAVORO e TERRITORIO
MIN ISTERO PER I BENI E LE A T T I V I T À C U L T U R A L I
D I R E Z I O N E G E N E R A L E PER IL PAESAGGIO , LE BELLE ARTI , L ' A R C H I T E T T U R A E L 'ARTE C O N T E M P O R A N E E
C E N T R O STUD I PER LA S T O R I A D E L L A V O R O E D E L L E C O M U N I T À TERR ITOR IAL I
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SOPRINTENDENTI BIBLIOGRAFICI
( 1 9 1 9 - 1 9 7 2 )
Bononia University Press
HoliDilia University Press Via l'arini 37, 40124 Bologna (el. (+39) 051 232 882 lax (+39) 051 221 019
« : ) 2 0 1 1 Bononia University Press
ISBN 978-88-7395-659-4
www.huponline.com e mail: [email protected]
I i l i i i i i i di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziali iol i qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Ptogedo grafico e impaginazione: DoppioClickArt, San Lazzaro di Savena (BO)
Si .uiip . i : Olficine ( J i a l R J i e l.ilosci (Raslignano - Bologna)
IVmia t-dizione: din'iiibrc 2 0 1 I
M I N I S I l RO l 'I 'R I B 1 : N I i ', I I-, A T I I V I T A ( 'AILI DRALI
l ) I R i : / K ) N I ' C l 'NI 'RAl . l ' , l ' I 'R 11, PAIvSAGCIO, LK B l ' ILb . ARTI ,
L'ARCHI TETrURA E L'ARTE CONTEMPORANl ' , ! ' ,
CENTRO S T U D I PER LA STORLA D E L LAVORO E DELLE C O M U N I T À TERRITORIALI
Dizionario biografico dei Soprintendenti bibliografici
(1919-1972)
Bononia University Press
l'.NI [ l ' R O M O I O I U
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Paes^gio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee AtiloHÌa Pasqua Recxhia
C'entro Studi per la Storia del Lavoro e delle Comunità Territoriali Alludo Vanii
l'.N 11; S O S T E N I T O R E
l'ondazione Cassa di Risparmio di Imola Sci)(io Santi
( A Ì M I I A I O S C I E N T I F I C O
Maria (ìrazia Bernardini, Simonetta Buttò
C ; < ) O R D I N A M E N T O S C I E N T I F I C O
Simonetta Buttò
S l C K l I E R I A ORGANIZZATIVA
Maria Cristina Guardata
Iti V I S I O N E S C I E N T I F I C A T E S T I
Simonetta Buttò, Andrea Paoli
Iti V I S I O N E BIBLIOGRAFICA E R E D A Z I O N A L E
Andrea Paoli
I t ic iRci iE D ' A R C H I V I O
Maria (Sistina Guardata, Sabrina Lamarra
R i N G K A / . I A M E N T I
Kruiio De Santis, ex Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, lArchitettura e lArte Contempo-l a r K c , elle ha promosso l'avvio della pubblicazione dei Dizionari dei Direttori Generali, dei Soprintendimi Archeologi, Architetti e Bibliografici.
M.irio Guarany, Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, che ha sostenuto e portato a termine l'iniziativa.
Si ringraziano tutti i direttori delle biblioteche pubbliche statali un tempo sedi di Soprintendenza per aver messo a disposizione degli autori i loro archivi storici; Agostino Attanasio, Maurizio Fallace, Marina ( ii.iiinilio, Akio ( i . Ricci che hanno costantemente sostenuto l'iniziativa; gli Uffici regionali che cons c i v.mo la documentazione più recente delle Soprintendenze bibliografiche e quanti a vario titolo hanno i oll.ilioiaio alla m i s e ila della pubblicazione. Si I ingraziano inoltre, per i loto siiggerinieiili e la fattiva collaborazione: Maria Gaia Raliiil. Antonio Rla-si, Giovanna Di ( liovine, M.iria I.clizia Sagti, Sielania Stefani, Mariella Ttirella.
Autori
h'iiiesin Bellezza I uea Bellingeri ^ ìary^herita Maria Breccia Fratadocchi I aura Businaro Simonetta Buttò Patrizia Caccia Luciano Carcereri Rossano De Laurentiis Andrea De Pasquale l'itola Di Giacomo Bozza Paola Di Pietro Silvio Falcone Flisabetta Francioni Antonio Giardullo Carla Giunchedi
Lida Maria Gonelli Simona Inserra Elisabetta Fugato Maria Gabriella Mansi Sofia Maresca Andrea Paoli Alberto Petrucciani Vittorio Ponzani Franca Porticelli Vincenzo Trombetta Stefano Trovato Anna Rosa Venturi Giuliana Zagra Laura Zumkeller
Indice
Prefazione Flavia Cristiano
Elenco dei Soprintendenti bibliografici in ordine cronologico
BIOGRAFIE Federico Ageno 29 Beniamino D'Amato
Luigi Balsamo 36 Angela Daneu Lattanzi
Francesco Barberi 45 Giorgio de Gregori Maria Belsani Roche 57 Luigi de Gregori Marina Bersano Begey 63 Giuseppe D'Elia
Guido Biagi 73 Maria Diaz Giuliano Bonazzi 86 Arturo D i Cesare Antonio Boselli 95 Maria Teresa Escoffier Tommaso Bozza 101 Domenico Fava Giovanni Bresciano 109 Mariano Fava Nerina Broglio Alessio 113 Luigi Ferrari Bianca Bruno 116 Tullia Gasparrini Leporace Angelo Bruschi 124 Ignazio Giorgi Gaetano Burgada 132 Alberto Giraldi Guido Calcagno 141 Tommaso Gnoli Arnaldo Capra 147 Eugenia Covi Francesco Carta 150 Alberto Guarino Antonio Caterino 165 Guerriera Guerrieri
Andrea Cavadi 168 Giuseppe Guh Maria Luisa Cavalli Arcamone 174 Sara Guzzardi Lastella Maria ( '.ecaro 179 ( ladano ludica Fannia ( loen Pirani 18-1 li-resa Lodi
I , i K Ì n i i : i M a n e lisi ("risali 377 Ilnrico Rosiagno 516 ( i i i g l i r l i i K ) M a i i l i v 384 Anna Saitta Revignas 522 l'iiiidio Marliiii 387 Filippo Salveraglio 529 Aiiionio Mciidogni Anita MondoKo
401 Giuseppe Salvo Cozzo d i Pietraganzili 535 Aiiionio Mciidogni Anita MondoKo 403 Sergio Samek Lodovici (Ludovici) 538 Salomone Morpurgo 411 Enza Santoro Fioroni 548 Paolo Malli 1 i i i s a Moiri
419 Maria Schellembrid Buonanno 555 Paolo Malli 1 i i i s a Moiri 428 Maria Sciascia 564 l ' idro Murra 433 Giovanni Semerano 567 K c i i a l o l ' a p ò 451 Guido Stendardo 573 ( Guglielmo Passigli 467 Antonio Tamburini 576 l''Mer i ' a s l o i c l l o 478 Gino Tamburini 582 1 c i i / i a IVeoiella Vergnano 485 Giampietro Tinazzo 593 < i i i i l i a i i a Peisichelli Nibaldi 493 Luigi Torri 600 1 u i| ; i a ((lina) Risoldi Candoni 495 Antonio Toschi 607 I l l e s a Rogledi Manni 508 Nella Vichi Santovito 609
l a i g e n i o R o s s i 514 Pietro Zorzanello 622
I . V
i
1 ' •
Tavola delle abbreviazioni
ACS = Archivio Centrale dello Stato AFG = Archivio della Fondazione Giovanni Gentile AGRT = Archivio della Giunta Regionale della Toscana AIB = Associazione italiana biblioteche / ASBO = Archivio di Stato di Bologna BEUMO = Biblioteca Estense Universitaria Modena BNB = Biblioteca Nazionale Braidense di Milano BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze BNCR = Biblioteca Nazionale Centrale di Roma BUB = Biblioteca Universitaria Bologna BUP = Biblioteca Universitaria di Pisa BUS = Biblioteca Universitaria di Sassari CEB = Comunità Ebraica di Bologna. Archivio DGAB = Direzione Generale Accademie e Biblioteche ERP = European Recovery Program (Piano Marshall) IBC = Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna IBC-B = Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. A della Soprintendenza bibliografica di Bologna IBC-M = Istituto Beni Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. A della Soprintendenza bibfiografica di Modena MBAC = Ministero per i Beni e le Attività Culturali MBAC"-AD = Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio Deposito MB("A = Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ,,51,,
MI'.N = Ministero dell'Educazione Nazionale Ml ' l Ministero della Pubblica Istruzione